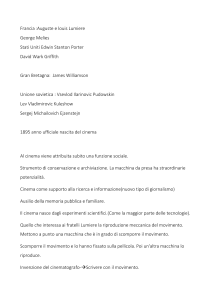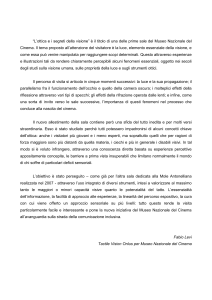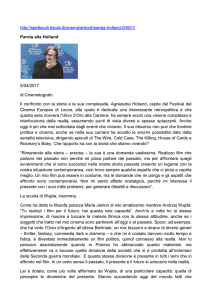caricato da
common.user1583
Dal Neorealismo al Postmoderno
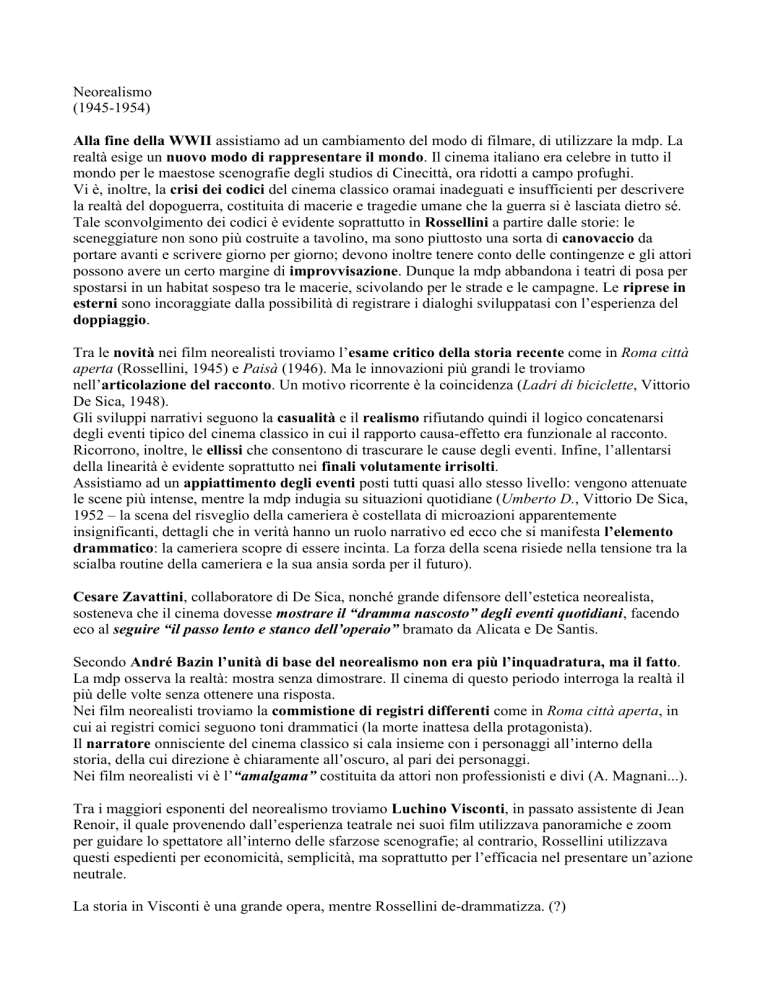
Neorealismo (1945-1954) Alla fine della WWII assistiamo ad un cambiamento del modo di filmare, di utilizzare la mdp. La realtà esige un nuovo modo di rappresentare il mondo. Il cinema italiano era celebre in tutto il mondo per le maestose scenografie degli studios di Cinecittà, ora ridotti a campo profughi. Vi è, inoltre, la crisi dei codici del cinema classico oramai inadeguati e insufficienti per descrivere la realtà del dopoguerra, costituita di macerie e tragedie umane che la guerra si è lasciata dietro sé. Tale sconvolgimento dei codici è evidente soprattutto in Rossellini a partire dalle storie: le sceneggiature non sono più costruite a tavolino, ma sono piuttosto una sorta di canovaccio da portare avanti e scrivere giorno per giorno; devono inoltre tenere conto delle contingenze e gli attori possono avere un certo margine di improvvisazione. Dunque la mdp abbandona i teatri di posa per spostarsi in un habitat sospeso tra le macerie, scivolando per le strade e le campagne. Le riprese in esterni sono incoraggiate dalla possibilità di registrare i dialoghi sviluppatasi con l’esperienza del doppiaggio. Tra le novità nei film neorealisti troviamo l’esame critico della storia recente come in Roma città aperta (Rossellini, 1945) e Paisà (1946). Ma le innovazioni più grandi le troviamo nell’articolazione del racconto. Un motivo ricorrente è la coincidenza (Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948). Gli sviluppi narrativi seguono la casualità e il realismo rifiutando quindi il logico concatenarsi degli eventi tipico del cinema classico in cui il rapporto causa-effetto era funzionale al racconto. Ricorrono, inoltre, le ellissi che consentono di trascurare le cause degli eventi. Infine, l’allentarsi della linearità è evidente soprattutto nei finali volutamente irrisolti. Assistiamo ad un appiattimento degli eventi posti tutti quasi allo stesso livello: vengono attenuate le scene più intense, mentre la mdp indugia su situazioni quotidiane (Umberto D., Vittorio De Sica, 1952 – la scena del risveglio della cameriera è costellata di microazioni apparentemente insignificanti, dettagli che in verità hanno un ruolo narrativo ed ecco che si manifesta l’elemento drammatico: la cameriera scopre di essere incinta. La forza della scena risiede nella tensione tra la scialba routine della cameriera e la sua ansia sorda per il futuro). Cesare Zavattini, collaboratore di De Sica, nonché grande difensore dell’estetica neorealista, sosteneva che il cinema dovesse mostrare il “dramma nascosto” degli eventi quotidiani, facendo eco al seguire “il passo lento e stanco dell’operaio” bramato da Alicata e De Santis. Secondo André Bazin l’unità di base del neorealismo non era più l’inquadratura, ma il fatto. La mdp osserva la realtà: mostra senza dimostrare. Il cinema di questo periodo interroga la realtà il più delle volte senza ottenere una risposta. Nei film neorealisti troviamo la commistione di registri differenti come in Roma città aperta, in cui ai registri comici seguono toni drammatici (la morte inattesa della protagonista). Il narratore onnisciente del cinema classico si cala insieme con i personaggi all’interno della storia, della cui direzione è chiaramente all’oscuro, al pari dei personaggi. Nei film neorealisti vi è l’“amalgama” costituita da attori non professionisti e divi (A. Magnani...). Tra i maggiori esponenti del neorealismo troviamo Luchino Visconti, in passato assistente di Jean Renoir, il quale provenendo dall’esperienza teatrale nei suoi film utilizzava panoramiche e zoom per guidare lo spettatore all’interno delle sfarzose scenografie; al contrario, Rossellini utilizzava questi espedienti per economicità, semplicità, ma soprattutto per l’efficacia nel presentare un’azione neutrale. La storia in Visconti è una grande opera, mentre Rossellini de-drammatizza. (?) Teoria dell’autore Nel dopoguerra si tornò sul dibattito culturale riguardante la soggettività e lo statuto dell’autore. Il concetto romantico dell’artista come genio creatore entrava in conflitto con una tecnica, quella cinematografica, che ne condizionava fortemente l’operato con la presenza di una pluralità di figure coinvolte nel processo produttivo, limitando così l’autonomia dell’artefice. Fin dalla metà degli anni ’40, registi e sceneggiatori francesi avevano discusso su chi potesse a buon diritto essere considerato l’auteur (l’autore) di un film. Il sonoro era considerato “l’era dello sceneggiatore”, ma l’opinione di alcuni critici come André Bazin era che la fonte principale del valore di un film fossero registi come Orson Welles, Willi Wyler e altri cineasti americani. Si esprime in tale direzione il saggio sulla caméra-stylo pubblicato nel 1948 da Alexandre Astruc, secondo cui il cineasta avrebbe potuto impiegare la mdp come lo scrittore faceva con la penna. Il cinema moderno sarebbe stato personale e la tecnologia così come il cast tecnico e artistico sarebbero stati semplici strumenti nel processo creativo dell’artista. Nel 1951 Jacques Doniol-Valcroze fondò il mensile “Cahiers du cinéma” e Bazin ne divenne presto la colonna portante. I più giovani tra i critici dei “Cahiers” – Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard e François Truffaut – iniziarono a forzare l’idea di auteur fino alla provocazione. Nel 1954 Truffaut attaccava i film della tradizione di qualità come opere di sceneggiatori prive di originalità e dipendenti dai classici letterari: per Truffaut lo sceneggiatore del cinema di qualità riduceva il ruolo dell’autore a metteur en scène, a quello cioè di un semplice esecutore. Per lui gli autori erano registi come Renoir, Bresson, Cocteau, Tati e altri che scrivevano da soli le storie e il dialogo. I “Cahiers du cinéma” esaltavano quei registi che scrivevano le sceneggiature dei loro film. Altri si spinsero oltre, sostenendo che i grandi registi di Hollywood erano riusciti a esprimere la loro visione della vita senza poter intervenire sulle sceneggiature. Anche altrove si diffuse la cosiddetta politique des auteurs e grazie a essa si corrobora la figura del regista, non più soltanto parte dell’ingranaggio industriale cinematografico ma “autore”, su cui la New Hollywood punterà per riuscire a risollevarsi dalla dura crisi che ha attraversato negli anni ’60, dando fiducia a tutta una schiera di registi emergenti, i cosiddetti “movie brats”. Il regista è pertanto il solo “autore” del film. Il singolo film è considerato una tappa all’interno del percorso artistico del regista, il quale deve cercare sempre di esprimere una sua visione personale del mondo e della vita. Inoltre, la filmografia di un autore presenta temi dominanti e ricorrenti. Punto cardinale della teoria dell’autore era la tesi di Renoir, secondo la quale un cineasta si limita a fare e rifare uno stesso film. Un autore utilizza quindi soggetti, argomenti, immagini, scelte stilistiche e situazioni narrative ricorrenti che finiscono per dare coerenza e continuità a tutta la sua opera. Infine, un autore possiede uno stile filmico distintivo: l’arte dell’autore si rivela non solo in cosa dice, ma anche in come lo dice; dunque il cineasta doveva avere il controllo del mezzo e sfruttarlo in modi sorprendenti e innovativi. Quest’idea di autore si sposò felicemente negli anni ’50 e ’60 con la maturazione del cinema come arte. Allora le firme di questi “autori” attestavano una differenza della loro opera dalla massa del cinema “comune”. Ad autori come Hitchcock, Bergman, ma anche Fellini e Antonioni va riconosciuto il merito di aver arricchito il linguaggio cinematografico esprimendo al contempo una personalissima visione della vita; le loro opere hanno esercitato – e tutt’ora esercitano – una profonda influenza su altri cineasti. Nouvelle Vague (1958-1967) La cosiddetta “Nuova Ondata”, in Francia, rappresenta la nuova generazione di cineasti e critici cinematografici caratterizzata da una profonda consapevolezza della storia del cinema, maturata grazie alla Cinémathèque Francaise. Tra i loro “padri spirituali” troviamo registi come Jean Renoir, Hitchcock, Fritz Lang, Yasujirō Ozu, ma soprattutto Rossellini da cui raccolgono in eredità l’estetica neorealista. Prende avvio un modo innovativo di fare cinema reso possibile dalle innovazioni tecnologiche (mdp più leggere, pellicole più sensibili) che tra le altre cose consentono di girare con luce scarsa, esplorando le strade delle città, velocemente e con budget ridotti, e di registrare in presa diretta i rumori. Tutto ciò non fa altro che avvicinare il cinema alla realtà quotidiana. Tra le innovazioni stilistiche troviamo un montaggio frammentario, discontinuo e irregolare, che trova il suo apice nel jump cut, ovvero l’eliminazione di fotogrammi interni a una stessa inquadratura, caratteristico dei film di Jean-Luc Godard e dei suoi “seguaci” emulatori. A tale montaggio “sincopato” si affiancano sequenze lunghe, talvolta veri e propri piani sequenza (scena risolta in un’unica inquadratura). Espediente incoraggiato dalle mdp sempre più leggere che ha come effetto una dilatazione temporale propedeutica/utile a cogliere la banalità della realtà. Difatti per Jean-Luc Godard l’obiettivo della Nouvelle Vague è “catturare lo splendore del vero”. Per tutti gli anni ’60 riprese con teleobiettivo, montaggio discontinuo e i movimenti di macchina elaborati soppiantarono le dense composizioni in profondità introdotte da Orson Welles in Quarto potere. L’eredità del Neorealismo si palesa nell’utilizzo di attori poco conosciuti o non professionisti, riprese in ambienti reali, nell’abbandono della sceneggiatura di ferro cui si sostituisce un canovaccio che lascia spazio all’improvvisazione degli attori, infine nel racconto aperto il quale alimenta l’ambiguità. D’altra parte, il rifiuto del realismo oggettivo rende forma e stile autoreferenziali: il cinema ripiega su di sé in un circolo di citazioni e omaggi. I “giovani turchi” erano avidi lettori di riviste di cinema, ma soprattutto cinefili che frequentavano cineclub e cinema d’essai. Il loro padre spirituale è senz’altro André Bazin. I principali esponenti erano critici presso i “Cahiers du Cinema” e poterono intraprendere la carriera di registi grazie al sostegno statale in quegli anni. Erano fedelissimi alla Politique des Auteurs, la quale affermava che il regista dovesse esprimere attraverso la sua opera la sua personale visione del mondo. Agli estremi della Nouvelle Vague troviamo Francois Truffaut (I 400 colpi, 1959) e Jean-Luc Godard (Fino all’ultimo respiro, 1960). [Molti film rispondevano alle limitazioni finanziarie dei produttori, per cui erano girati: - in ambienti reali, en plein air - con attrezzatura leggera - con attori poco noti - con troupe ridotte all’osso - potevano essere ultimati in fretta e con metà del budget abituale ] Il loro successo era in gran parte dovuto al forte legame con il loro pubblico giovane e metropolitano. Questi autori privilegiano trame costituite da eventi casuali o digressioni. Inoltre, troviamo la tendenza al finale aperto: nel finale de I 400 colpi un fermo immagine del protagonista sottolinea una situazione irrisolta. Il cinema del passato viene visto come un patrimonio culturale da far rivivere nei film (citazioni): in Fino all’ultimo respiro il protagonista imita il personaggio di Humphrey Bogart; in Paris nous appartient viene proiettato Metropolis di Fritz Lang; ne I 400 colpi il protagonista ruba una foto di scena di Monica e il desiderio. Effetti ottici visivi come la chiusura a iride sono chiaramente un omaggio al cinema delle origini. Troviamo infine la trasgressione delle norme consolidate dal cinema hollywoodiano come la dedrammatizzazione, in aperto contrasto con il cinema classico. Non si cerca più di far immergere lo spettatore, ma di renderlo consapevole di stare guardando un film. Mentre il cinema classico si preoccupava di nascondere la mdp, qui la sua presenza è manifesta: in Fino all’ultimo respiro durante un monologo il protagonista guarda in macchina; in Questa è la mia vita Godard per riprendere i dialoghi rifiuta il classico schema del campo controcampo e muove manualmente la mdp da un personaggio all’altro. Dal momento che i “Cahiers du Cinema” promuovevano un cinema personale, non c’è da stupirsi che la Nouvelle Vague non si sia coagulata in un movimento compatto nello stile. Il successo della Nouvelle Vague durò soltanto pochi anni. Nonostante ciò, il cinema francese degli anni ’60 fu uno dei più ammirati e imitati in tutto il mondo. Cinema italiano anni ‘60 All’inizio degli anni ’60 l’Italia è il centro di produzione più forte nell’Europa occidentale e a poco a poco inizia a staccarsi dal Neorealismo per affrontare tematiche più esistenziali quali l’alienazione e l’incomunicabilità. Michelangelo Antonioni diviene un autore di riferimento per il cinema tout court. Tra le opere cardine della sua poetica troviamo Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966), riflessione sulla base illusoria della fotografia che ne suggerisce l’inefficacia in quanto strumento per la ricerca della verità. Il film ha evidentemente influenzato registi come Francis Ford Coppola (La conversazione, 1974) o Brian De Palma (Blow Out, 1981). [riflessione sul tema dello sguardo] Federico Fellini è il regista che più di ogni altro racchiude ogni aspetto del reale e del surreale in una dimensione favolistica. I suoi sono film colmi di riferimenti onirici. Alcune scene dei suoi film sono divenute icone della storia del cinema: pensiamo ad Anita Ekberg che ne La dolce vita (1960) si cala nella Fontana di Trevi. Nel 1963 vede la luce il visionario 8½, autobiografia immaginaria dello stesso regista, che analizza svariati temi come l’arte, la memoria e infine la morte. Un regista che si oppone ai costumi dell’epoca è Pier Paolo Pasolini. I suoi film esplorano l’ambiente del sottoproletariato e sono spesso attaccati per la radicalità e vivacità del suo pensiero. L’uso di una sintassi filmica sgrammaticata e di attori che erano “ragazzi di strada” fa di Accattone (1961) e Mamma Roma (1962) gelide analisi della povertà urbana. Bernardo Bertolucci rappresenta l’equivalente italiano della Nouvelle Vague francese. In questi anni si sviluppa la “commedia all’italiana” (espressione coniata parafrasando il titolo di uno dei più grandi successi dei primi anni di questo genere cinematografico, Divorzio all’italiana del regista Pietro Germi), pungente satira che colpisce la società industriale e i suoi valori e suscita nello spettatore “risate amare”. Alcuni film prendono di mira i costumi del “Boom economico”: Dino Risi ne Il sorpasso (1962) mescola comicità e serietà culminando in un finale drammatico. Questo filone si concluderà verso la metà degli anni ’70 con due film amari: C’eravamo tanto amati (Ettore Scola, 1974) e Amici miei (Mario Monicelli, 1975). Anche il cinema commerciale è molto attivo in questo periodo, prendendo ispirazione dai generi americani dei quali accentua i tratti violenti, sessuali ecc. I generi di maggior successo sono quello mitologico che si ispira ai colossal hollywoodiani come Ben-Hur (Willi Wyler, 1959) e Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963); l’horror tra cui citiamo i nostri Dario Argento e Lucio Fulci; il poliziesco che si ispira invece a pellicole come l’Ispettore Callaghan. Tuttavia il genere più acclamato anche a livello internazionale è sicuramente lo “spaghetti western” mutuato dal western americano di cui esalta la cruda violenza perpetrata solitamente da un antieroe solitario, cinico e senza scrupoli, che fa fuori i suoi avversari nel corso di roboanti sparatorie. I maestri di questo genere sono Sergio Leone e Sergio Corbucci che assieme a stelle ascendenti come Clint Eastwood e Franco Nero hanno ottenuto risultati straordinari nonostante i budget ridottissimi grazie soprattutto al loro ingegno: per fare un esempio, villaggi disabitati a causa della mancanza di comparse danno una sfumatura in più alle storie. Lo stile inconfondibile di Sergio Leone affiancato dalle colonne sonore del maestro Ennio Morricone fanno delle sue opere delle pietre miliari del cinema tout court. New Hollywood Verso la fine degli anni ’60 si assiste a una vera e propria rinascita del cinema americano in seguito alla dura crisi che questo ha attraversato. L’avvento della New Hollywood è segnato dall’uscita e dal dirompente successo di tre film: - Gangster Story (Bonnie and Clyde, Arthur Penn, 1967) - Il laureato (Mike Nichols, 1967) - Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) In questi anni nasce il “film d’arte americano” inteso come opera capace di superare le regole formali, narrative e ideologiche tipiche del cinema classico. D’altro canto, i primi film di questo periodo rappresentano una prospettiva ideologica fortemente in sintonia con le istanze più eversive della società americana e rappresentano il prodotto del tumultuoso contesto storico-sociale che ha caratterizzato l’America in quel frangente. Si è trattato del momento di massima contestazione nei confronti dell’autorità dai tempi della depressione. Sono gli anni dei movimenti per i diritti civili, delle rivolte razziali, della controcultura giovanile, dell’opposizione alla guerra del Vietnam, dei drammi e degli scandali politici. Questa serie straordinaria di eventi finisce ovviamente per offuscare il mito dell’America come terra di libertà e democrazia. La vera struttura profonda, sottesa in pratica a tutti i film che in qualche modo sono ascrivibili a una vera e propria poetica della violenza, è la sfiducia nelle istituzioni e nei valori tradizionali sia della società che del cinema americano passato. Il confronto del ribelle con le istituzioni diventa regolarmente occasione di voyeurismo, sguardo che elimina la propria violenza delegandola all’altro. Tale modello a ben vedere rientra nella mitologia folk del fuorilegge inteso come rappresentante delle istanze popolari; quel che vi è di più è la spettacolarizzazione della trasgressione e delle sue conseguenze. I temi dell’alienazione e della contestazione giovanile sono centrali nei film della New Hollywood. Bonnie and Clyde presenta una vicenda reale degli anni ’30, tuttavia i due “eroi” evocano il desiderio di libertà ed evasione di molti giovani contestatori degli anni ’60. Mentre Il laureato affronta in maniera più esplicita il tema dell’alienazione da cui sono afflitti i giovani, i quali provano a scappare dal mondo consumistico dei quartieri ricchi e da quello ipocrita dei genitori. In questi anni si impone una nuova generazione di attori che non rispecchiano esattamente i canoni della bellezza hollywoodiana e che incarnano/interpretano personaggi incerti e crepuscolari, autentici “antieroi”. Veri e propri “born losers”, immagine tipica dell’uomo anonimo prodotto dalla società dell’industria e del capitale, cresciuta sul terreno dell’individualismo, ma in realtà spietata produttrice dell’uomo-massa. Il personaggio-chiave è pertanto vittima non tanto di una violenza tangibile, riconoscibile a occhio nudo, ma di quella, ben più surrettizia, delle istituzioni, delle abitudini, dei doveri socialmente imposti, o magari delle tacite leggi del proprio specifico gruppo. Easy Rider narra di personaggi vittime della violenza insita in una parte retrograda della società americana ma è anche una celebrazione della vita hippy “on the road”. In questo film è più esplicito il tema della controcultura. [Inoltre] i tre film che aprono la New Hollywood si inscrivono nel solco di mitologie che già le tradizioni narrative e di genere del cinema classico avevano ampiamente divulgato: Gangster Story e Easy Rider riprendono il vecchio mito della conquista della frontiera; mentre Il laureato riprende l’antichissimo mito del principe che deve salvare la principessa prigioniera. In Easy Rider il vagabondaggio dei personaggi non è senza meta ma è diretto, da ovest a est, in senso opposto a quello della conquista dei pionieri e per questo diventa quasi un ritorno alle origini in cerca di un’America autentica, non ancora corrotta dal sospetto reciproco o degradata dall’industrializzazione. L’obiettivo principale dei registi della New Hollywood, sulla scorta del cinema d’arte europeo, era quello di smascherare e scardinare le convenzioni cinematografiche attraverso la rivisitazione e la decostruzione dei generi. Pensiamo ad Arthur Penn che ribalta il modello del gangster e fa dei suoi banditi, Bonnie e Clyde, degli eroi con cui potersi identificare senza traumi o complessi di colpa. Altri tratti tipici sono l’utilizzo del finale aperto, ossia del rifiuto di imporre al racconto un esito chiaro; l’inserimento di flashback improvvisi o senza spiegazione iniziale; l’uso del flashforward per creare bruschi cambi di scena; un uso insistito dello zoom; l’uso del grandangolo panoramico con effetto deformante. Infine, troviamo il rifiuto del continuity system il quale suggerisce l’idea di un mondo ordinato, “spontaneo” e comprensibile in cui lo spettatore può agilmente entrare. Il cinema della New Hollywood riesce a introdurre delle innovazioni stilistiche mutuate dalla Nouvelle Vague e dal cinema d’autore europeo, ma non abbandona mai del tutto la grammatica del cinema classico. Fattore determinante per la rinascita di Hollywood fu l’ondata di successi della nuova generazione di registi, i cosiddetti “movie brats”, che con budget tutt’altro che faraonici danno vita a capolavori indimenticabili. Nel 1972 Il padrino (F. F. Coppola) inaugurò un’era di incassi strepitosi, mentre nel 1975 Lo squalo di Steven Spielberg dà inizio alla stagione estiva caratterizzata dall’uscita dei blockbusters. Tuttavia ogni record di incasso fu battuto da Guerre stellari (George Lucas, 1977). Il film deve i suoi maggiori profitti al mercato secondario dell’home video, dei diritti televisivi, ma soprattutto del merchandising, dal momento che il film era rivolto ad un pubblico di teenager. I blockbusters ottengono quindi una “seconda vita” oltre la sala grazie alla vendita in tutto il mondo delle videocassette. [Da Guerre stellari il merchandising divenne una strepitosa fonte di guadagno per i produttori.] I blockbusters rappresentano un cinema d’evasione in un tempo di guerra e scandali politici. Se Star Wars ci proietta in un passato e una galassia lontani, film come Indiana Jones e Ritorno al futuro offrono un nostalgico tuffo nel passato. Questi film consolideranno la pratica dei prequel e sequel (Lo squalo 2, Rocky II, Il padrino pt. II). Grazie al successo di questi film i registi ottengono un controllo maggiore sulle loro opere e i budget cominciano a lievitare consentendo la realizzazione di film ambiziosi (Apocalypse Now, F. F. Coppola, 1979), ma che troppo spesso si rivelavano dei flop clamorosi al box office. Molti registi viaggiarono sui binari dei generi ormai consolidati e sulle orme di registi venerati: sotto molti aspetti la New Hollywood si affermava facendo riferimento al passato. Tuttavia lo stile risentiva di una notevole consapevolezza. Registi come Spielberg e De Palma hanno preso spunto in maniera evidente dall’opera di Hitchcock (zoom + carrello; splitscreen) o da quella di Orson Welles e Wyler (obiettivo grandangolare). [Con_] Si fa strada il genere fantascientifico: 2001: Odissea nello spazio (Stanley Kubrick, 1968) fu il principale precursore; i film di questo periodo perdono la fiducia nel progresso per cui ecco comparire le macchine che si ribellano (Westworld). Anche l’horror prende sempre più piede sulla scia di ciò che Hitchcock aveva iniziato con Psyco [Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968), Halloween (John Carpenter)]: ricordiamo i film tratti dai best seller di Stephen King Carrie (Brian De Palma, 1976) e Shining (Stanley Kubrick, 1980). In più il clima di guerra fredda alimenta il genere catastrofico nelle cui trame ricorrono disastri nucleari. E ancora, il passato di Hollywood viene riletto in chiave parodistica: pensiamo a Prendi i soldi e scappa (Woody Allen, 1969), parodia del film di rapina, e Frankenstein Junior (Mel Brooks, 1974). Registi come F. F. Coppola e Sam Peckinpah hanno glorificato la violenza. [Inoltre] Hollywood ha quindi costantemente incrementato la presenza della sessualità, della violenza e degli effetti speciali propri dei blockbusters al fine di attirare un pubblico sempre più desensibilizzato. Spettacoli di mezzanotte attraevano un vasto pubblico giovanile e permisero a pellicole come Rocky Horror Picture Show, Eraserhead, Alien, Shining di riscuotere un grande successo. Per Lucas e Spielberg la rivisitazione della tradizione hollywoodiana era un atto di nostalgia, con la volontà di ricreare il divertimento semplice della fantascienza (Guerre stellari), dei film di avventura (I predatori dell’arca perduta) e delle fantasie disneyane (E.T. l’extraterrestre; Incontri ravvicinati del terzo tipo). George Lucas in American Graffiti descrive con nostalgia il mondo della sua adolescenza, gli anni del rock’n’roll e dei giri in macchina, con le crisi che accompagnano il passaggio all’età adulta. I film di Martin Scorsese devono molto alla tradizione hollywoodiana ma sono contemporaneamente ispirati al cinema d’arte europeo e oltretutto si basano su elementi autobiografici. Mentre altri movie brats creano spettacolari effetti speciali di alta tecnologia, Scorsese attira lo spettatore con il suo stile dinamico ed eclettico. Mentre i movie brats si affermarono all’inizio degli anni ’70, altri registi della stessa età emersero più tardi (Michael Cimino, David Lynch). Caratterizzati da una consapevolezza matura della storia del cinema e della sua influenza nella cultura contemporanea. Postmoderno Il Novecento, definito “secolo breve”, è stato caratterizzato dal crollo delle ideologie e dei riferimenti, nonché dalla crisi della ragione. Non esistono più le grandi narrazioni. Assistiamo, invece, al ritorno della favola, supportata dalle tecnologie digitali (visual effects) e all’affermarsi del cinema d’evasione, di fuga dalla realtà. Quest’ultima è divenuta mutevole e frammentaria, e produce, in ambito artistico, la logica del collage, dell’accumulo, della citazione e dell’eclettismo. Tra gli elementi caratteristici del cinema postmoderno troviamo: - un metalinguaggio pervasivo, che raggiunge il suo apice nei “film museo”; - la destrutturazione narrativa caratterizzata dalla disgregazione del nocciolo della fabula e dalla perdita della linearità. Tutto questo sfocia in un “film labirinto” dove lo spettatore deve mettere ordine tra i flashback e i flashforward (C’era una volta in America, Sergio Leone) nel tentativo di ricostruire il puzzle della storia (come d’altronde tenta di fare il protagonista di Memento, Christopher Nolan, 2000); - una dimensione immersiva in cui mondo reale e virtuale si confondono (Matrix) [multiverso]; una dimensione amplificata dal piano sequenza realizzato tramite la steadicam, una sorta di protesi cibernetica che rende l’operatore un ibrido, un cyborg, in grado di scivolare per i corridoi più stretti fino agli ambienti più ampi in modo fluido e continuo (Shining); - il finale coincide con i titoli di coda, senza rivelazioni o insegnamenti morali. Il metalinguaggio culmina nel citazionismo fetish, caratteristico di registi come Quentin Tarantino, il quale sfrutta i richiami per riplasmare un genere, rivitalizzare il cinema (soprattutto i B-Movie). Pulp Fiction (1994) è un mosaico ironico e splatter di scene già viste altrove. Nonostante l’eterogeneità dei riferimenti il suo stile rimane costante e riconoscibile, un mix di humour, azione, crudezza e violenza esibita, ma soprattutto di dialoghi brillanti privi di gerarchia tra cultura alta e pop, e infine una narrazione contorta ricca di salti temporali. Parliamo di revival quando si cerca di imitare uno stile del passato. Un regista avvezzo a questo genere di espediente è certamente Woody Allen, che nel suo film Interiors richiama Bergman, mentre Stardust Memories è un’aperta rielaborazione di 8½ di Fellini. Un ulteriore autore postmoderno è senz’altro Brian De Palma che con Blow Out (1981) rielabora il capolavoro di Antonioni (Blow Up, 1966), mentre con Gli Intoccabili cita Scarface (1932) e rende omaggio ad Ejzenstejn nella scena della scalinata e della carrozzina. Un altro dei temi postmoderni è lo sconfinamento della finzione nella realtà, quest’invasione nel campo dello spettatore è evidente ne La rosa purpurea del Cairo. Il discorso cinematografico diventa dunque un reticolo di connessioni, una forma ipertestuale che negozia attraverso i termini dell’ironia e della citazione. Assistiamo a un ritorno alle origini, a un “cinema delle attrazioni”. Con la complicità dello spettatore che si offre di mettere in gioco la propria enciclopedia di competenze intermediali e intertestuali, per partecipare a questo gioco di rimandi. Infine, attraverso la sospensione dell’incredulità lo spettatore accetta di immergersi completamente nello spettacolo. Molti critici e studiosi si sono chiesti se si possa ancora parlare di cinema postmoderno. Per la maggior parte non si può più parlare di postmoderno dopo la tragedia dell’11 settembre 2001, evento che ci messo di fronte a quella realtà che era stata messa da parte, in secondo piano, dal postmoderno. Si parla dunque di New Realism: occorre fare i conti con quella realtà dura e complessa. Con la diffusione dei mezzi di ripresa (fino ai moderni smartphone) sembra potersi realizzare l’utopia vertoviana dei kinoki, ossia quella moltiplicazione dei punti di vista garantita dai cittadini nella loro nuova veste di “prosumer”. Assistiamo, inoltre, alla rinascita del documentario, definito come “cinema del reale”, fortemente debitore delle nuove tecnologie. D’altra parte le tecnologie si muovono anche nella direzione opposta: grazie alla CGI si può realizzare un prodotto che prescinde (almeno in apparenza) dal mondo, poiché necessita comunque di un referente reale, un “modello”, che presti la propria performance al personaggio in computer grafica che i tecnici andranno poi ad animare (grazie alla tuta mocap).