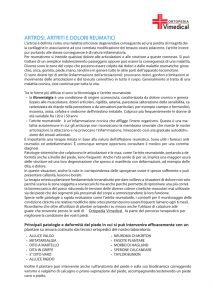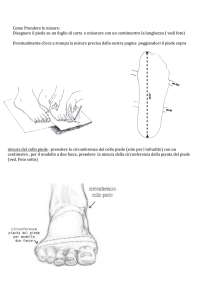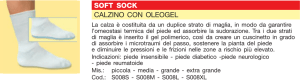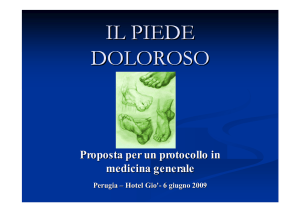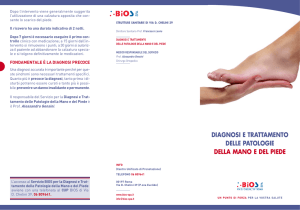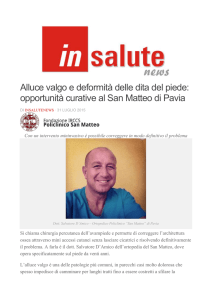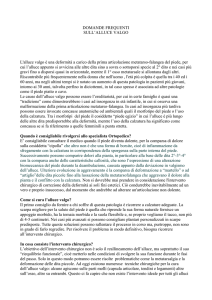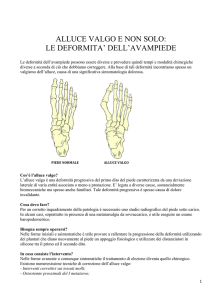caricato da
common.user995
Tesi su Istologia e Anatomia Funzionale del Piede e Alluce Valgo

INDICE RINGRAZIAMENTI pag.1 INTRODUZIONE pag.3 CAPITOLO 1 - Istologia e anatomia funzionale del piede pag.6 1.1 Istologia dei tessuti della regione plantare del piede pag.1 1.2 Anatomia funzionale del piede pag.13 1.2.1 Struttura ossea e legamentosa pag.13 1.2.2 Struttura muscolare pag.23 1.2.3 Meccanica delle articolazioni pag.26 1.2.4 Le funzioni del piede pag.33 CAPITOLO 2 - La postura e il sistema tonico posturale pag.55 2.1 Il controllo dinamico della postura pag.56 2.2 La postura ideale pag.60 2.3 Le azioni muscolari pag.62 2.4 Le catene muscolari pag.64 2.5 La necessità e le difficoltà di una buona postura pag.67 2.6 Le anomalie podaliche come principali fattori nello squilibrio posturali pag.69 2.7 Le alterazioni nel piede e le conseguenze posturali pag.77 2.7.1 Il piede piatto valgo pag.77 2.7.2 Il piede cavo varo pag.78 2.7.3 Il piede a doppia componente pag.79 CAPITOLO 3 - L’ALLUCE VALGO pag.81 3.1. Classificazione pag.83 3.2 Epidemiologia pag.87 3.3 Eziologia e Genesi della disfunzione osteopatica pag.88 3.4 Anatomia disfunzionale pag.92 3.5 Clinica pag.95 3.6 Trattamento conservativo pag.98 3.7 Trattamento chirurgico pag.102 3.7.1 Complicanze pag.102 CAPITOLO 4 - SQUILIBRI ENERGETICI E PIEDI pag.105 4.1 I piedi in un approccio psicosomatico pag.105 4.2 Il piede nella storia pag.106 4.3 Riflessologia e M.T.C. pag.109 4.4 La lettura energetica pag.114 4.5 La sacralità della malattia pag.117 4.5 La resilienza e la malattia pag.120 4.6.1 La resilienza e la crisi generata dalla malattia pag.121 4.6.2 La forza interiore, la resilenza e la malattia pag.122 CAPITOLO 5 - CLINICA pag.125 5.1 Il Metodo E.T.R. pag.125 5.2 La Baropodometria, cos’è e quali informazioni può darci pag.129 5.2.1 L’analisi baropodometrica pag.130 5.3 Trattamento e analisi dei dati pag.132 5.3.1 Trattamento con metodo E.T.R. pag.135 5.3.2 Esame baropodometrico e analisi del passo pag.145 5.3.3 Sintesi dei dati dei restanti soggetti esaminati pag.158 CONCLUSIONI pag.168 BIBLIOGRAFIA pag.170 SITOGRAFIA pag.171 Allegati a questa tesi possono essere consultati gli esami baropodometrici completi per ciascun soggetto da noi analizzato, sia prima che dopo il ciclo di trattamenti. RINGRAZIAMENTI “ Per voi che siete stati il mio sostegno, la mia energia, il mio aiuto…” Con poche righe vorrei citare tante persone che sono state parte integrante di questo percorso…mi perdonerete ma non riuscirò a fare i nomi di tutti. Ringrazio i miei docenti che hanno reso preziosi questi tre anni, un pensiero speciale va al professor Roberto Menghini e al professor Franco Casella, Enzo Isopo, Nora Veronese, Marco Gaudenzi e Danilo Bonometti, per avermi avvicinato ad una nuova dimensione della vita, rendendomi veramente consapevole della mia identità e per avermi avvicinato in questo mondo, trasmettendomi, con umiltà e conoscenza, una vera passione, sperando, nei prossimi anni, di poter contare ancora su di loro. “Per sapere chi siamo dobbiamo essere consapevoli di ciò che sentiamo” Alexander Owen Ringrazio i miei genitori Giovanna e Luigi per avermi sostenuto in ogni momento della mia vita, mia sorella Alessandra, per l’allegria che ci trasmette. Ringrazio Elena Pianti, per il suo supporto, per le sue parole, per la sua presenza. 1 Impossibile non citare la mia amica Franceschina per la forza che dimostra di avere, ogni giorno. L’ultimo saluto va ai miei compagni con i quali ho condiviso momenti straordinari e tante risate. In particolar modo ringrazio i miei compagni di appartamento, Alberto Castellan, Marco Franceschini, Luca Andreotti e non ultimo, il grande Anton Roy Fernandez. 2 INTRODUZIONE Ricordo la prima volta che ebbi dolore all’alluce. Successe così, all’improvviso, su un campo da calcio. Dico all‘improvviso perché sucesse senza nessun apprente motivo, senza traumi, senza sovraccarichi di cui potessi accorgemi; anzi ricordo con piacere un particolare stato di forma fisica ritrovato dopo gli anni sedentari dell’università e qualche infortunio di troppo avuto durante l’adolescenza. Ricordo come ieri i miei pensieri a riguardo perché non mi capacitavo di quelllo strano dolore, profondo, sordo, un dolore che inziava al primo passo al mattino e mi abbandonava soltanto quando chiudevo gli occhi la notte. Ricordo bene quel dolore, perché ha segnato la mia vità, nel bene e nel male; nel male perché presto mi impedì di svolgere qualsiasi attività fisica che comportasse la deambulazione. Mi sentivo imprigionato in un disturbo che non volevo accettare e a cui non volevo arrendermi. Nel bene perché ha cambiato la mia vita in meglio proprio perché non mi sono arreso nel cercare una soluzione al mio problema. Dopo aver subito 4 interventi chirurgici in seguito a delle complicanze post operatorie la dolorosità al piede era sì diminuita, ma non così come prometteva la “propaganda” pre-operatoria del chirurgo. 3 Proprio questa ricerca della verità mi ha fatto arrivare qui ora. Qua, dove ho molte delle armi che prima non conoscevo. Le armi che mi permettono di indagare oltre quelo che appare noto. In questa tesi ho voluto ragguppare molta della la letteratura inerente l’alluce valgo, considerando diversi punti vista: il punto di vista della chirurgia, della posturologia, della fisioterapia, della riflessologia plantare, quindi una lettura energetica e infine il punto di vista della medicina psicosomatica. Nel mutamento paradigmatico sviluppatosi negli ultimi decenni relativo al concetto di “cura” della persona è palese dover considerare la persona come un sistema unico e irripetibile interagente, nello spazio e nel tempo, con l’ambiente e le altre realtà, non solamente quindi una somma di parti ed entità separate (organi, apparati, tratti caratteriali, ideologici, eccetera). Sul piano degli strumenti conoscitivi l’approccio olistico considera, oltre a ciò che viene comunemente riconosciuto dall’oggettività e verificabilità scientifica, tutte le possibili forme di conoscenza (empatica, intuitiva, emozionale, metafisica) di cui dispone il genere umano. Ritengo che a questo scopo sia fondamentale un percorso fondato su un intervento multidisciplinare che utilizzi stimoli e tecniche per una percezione, una comprensione ed uno sviluppo contemporaneo di tutte le componenti fondamentali della persona: quella corporea, quella emotiva, quella mentale, relazionale e spirituale. 4 Se tali competenze sono culturalmente riferibili a quanto era inteso nell’antichità come ϑεραπεία (therapeía): cura, guarigione, il ruolo dell’operatore non può né deve essere quello peculiare di risolvere aspetti specifici di quanto viene definito patologico o malato ma quello di riorientare la persona affinché possa sviluppare, semmai ne necessiti, anche una domanda più consapevole in ambito medico, psicologico, fisioterapico, energetico o spirituale Gli operatori olistici osteopatici sono le figure professionali che mostrano una rara sensibilità ed esigenza ad ampliare le loro già diversificate capacità di approccio e intervento di ambito psicosomatico ed olistico. 5 CAPITOLO 1 ISTOLOGIA E ANATOMIA FUNZIONALE DEL PIEDE Il piede è una struttura altamente specializzata ed ha diverse caratteristiche che sono peculiari della specie umana. Presenta molte analogie strutturali con la mano, ma essa non è così specializzata in termini di anatomia macroscopica. Attraverso l’evoluzione, il piede ha modificato la sua struttura perdendo le funzionalità prensili (come l’opponibilità del primo dito), e sviluppando una complessa funzionalità antigravitaria, intesa come attitudine al controllo delle forze ambientali, tra le quali primeggia appunto la gravità. Nella stazione eretta e nella camminata il piede svolge, infatti, la tripla funzione d’interfaccia informativa con l’ambiente, di base di appoggio attraverso la quale è scaricato l’intero peso del corpo e di leva per mezzo della quale viene respinto il suolo. Il piede infatti non è solamente un organo deputato al movimento: è un organo complesso che esplica la sua funzione fornendo informazioni al cervello sotto forma di sensazioni e ricevendo da questo ordini motori. Il controllo che regola il contrasto tra funzione recettoriale e funzione effettrice, ne fa alternare le condizioni di rilasciamento e irrigidimento. Nella prima, tramite i recettori sensoriali sparsi su tutta la sua superficie, il piede si “informa” delle caratteristiche del suolo. Le terminazioni nervose percepiscono la temperatura e la morfologia del terreno su cui camminiamo, la pressione 6 esercitata sul piede e le sollecitazioni che provocano dolore su di esso. I movimenti, piccoli e grandi, che costituiscono la deambulazione sono la conseguenza di ordini provenienti dal cervello, che provvede a muovere in sincronia i muscoli del piede, facendoli contrarre o rilasciare in funzione della necessità. Viene da se che funzioni così complesse necessitino di una forte precisione strutturale. La connessione intersegmentaria del piede e, conseguentemente, la tutela della integrità della struttura podalica, sono compiti delle formazioni legamentose ed aponevrotiche, nonché di quelle muscolari. Disfunzioni o deformazioni di queste delicate “impalcature”, compromettono pesantemente l’efficienza e la funzionalità di questo meccanismo (descritto drammaticamente in l’ultimo dettaglio anello della in seguito), catena modificando antigravitaria: la distribuzione delle pressioni a livello plantare. Inoltre le anomalie strutturali sono anche di ostacolo alla ricezione corretta della stimolazione ambientale: il funzionamento dei recettori gravitari risulta alterato, essendo anomali la disposizione dei tessuti che li ospitano. Ciò compromette il meccanismo antigravitario a monte della forma che il piede riceve istruzione di assumere: captando stimolazioni parziali o scorrette e inviandole al cervello, il piede assume conformazioni o esegue movimenti non adatti alla reale situazione ambientale in cui si trova. Un classico esempio, è quello del piede neuropatico: il soggetto, avendo una parziale o assente ricezione nervosa, non si rende conto che i movimenti che sta eseguendo per camminare, o la postura che fa assumere al piede, gli stanno procurando ferite a livello plantare. È evidente quindi la fondamentale 7 importanza di ricorrere a dispositivi che impediscano la formazione di picchi pressori nel caso di neuropatie, o che prevengano o correggano le anomalie dell'appoggio plantare e quindi posturali. Figura 1.0 Immagine indicativa della distribuzione delle pressioni a livello plantare durante le fasi del passo 8 1.1.Istologia dei tessuti della regione plantare del piede L’interfaccia tra il piede e il suolo è costituita da tessuti specializzati nel sopportare i pesanti scambi di forze tra le due parti rigide (ossa e suolo). Figura 1.1 Sezione di tessuto epiteliale della pianta del piede Deformandosi elasticamente, questi sono in grado di ammortizzare le tensioni locali che si sviluppano nei punti di contatto con il terreno e di conservare la loro integrità. La pelle del piede è simile a quella della mano, ma molto più spessa. Lo strato più esterno è costituito da un epitelio cheratinizzato fortemente cornificato (figura 1.1). I numerosi strati di cellule dell’epidermide, infatti, si riproducono continuamente spostandosi verso livelli più esterni, formando numerosi strati e garantendo un costante ricambio. Superficialmente si presentano quindi più strati di cellule morte, prive di nucleo e ridotte a piastre appiattite e strettamente ancorate alla matrice proteica. Nelle zone soggette a maggior carico, cioè in corrispondenza del 9 tallone e della testa del primo metatarso, lo strato esterno di cheratina ha uno spessore maggiore di quello di tutte le altre zone del corpo. L'epidermide non contiene vasi sanguigni e viene nutrita per diffusione. Una membrana basale la lega al derma che risulta costituito da tessuto connettivo, con funzione di ammortizzatore per i traumi meccanici della pelle. Il derma ospita molte terminazioni nervose di tipo meccanorecettoriale, che forniscono la sensibilità tattile e termica. Essi sono per lo più barocettori, capaci di percepire variazioni di pressione con una sensibilità di 0,3 g. Il suo strato più profondo è composto da fibre di collagene, reticolari ed elastiche, che conferiscono alla resistenza La disposizione in direzioni preferenziali di alle trazioni. pelle l'elasticità, l'estensibilità e la queste fibre conferisce alla pelle una forte anisotropia. Lo strato più profondo della pelle, chiamato ipoderma, è costituito da cellule rotondeggianti piene di lipidi, circondate da una fitta rete di vasi arteriosi e venosi; in questa sede esso funge soprattutto da ammortizzatore, ma ha inoltre funzioni isolanti e favorisce la mobilità della pelle rispetto alle strutture più profonde. Lo spessore del sottocutaneo è variabile sotto il piede: poiché i cuscinetti adiposi svolgono un ruolo importante nel sostenere il peso del corpo, essi sono maggiormente sviluppati nelle aree soggette a maggior carico pressorio, quindi, come già detto, in corrispondenza del calcagno, dell’ avampiede e delle teste dei metatarsi. Lo spessore medio del cuscinetto calcaneale negli adulti sani varia dai 14 mm ai 19 mm. In queste zone, i cuscinetti adiposi plantari presentano una 10 configurazione che li rende specializzati nel sostenere carichi senza sviluppare eccessive deformazioni in senso trasversale, che li renderebbero inutili. Il tessuto adiposo è infatti attraversato da numerosi fasci connettivali molto sottili, che complessivamente però costituiscono una robusta impalcatura che vincola la cute e limita lo spostamento della materia molle, migliorando le qualità meccaniche (plasticità ed elasticità) di questi cuscinetti. L’orientazione di questi fasci fibrosi corrisponde alla direzione delle sollecitazioni meccaniche prevalenti (Bojsen-Moller et Flagstad, 1979) (fig.1.2). Inoltre le cellule di adipe sono molto compatte e tra loro non scorre alcun fluido, rendendole così fortemente viscose. Figura 1.2 Sezione in cui si nota la disposizione delle fibre verticali e i diversi livelli di spessore del tessuto adiposo 11 Figura 1.3 Immagine dell’aponeurosi plantare e del cuscinetto calcaneare La parte intermedia, più robusta e spessa delle altre, posteriormente è più stretta ed è fissata alla tuberosità del calcagno, mentre avanzando diventa più larga e sottile. Portandosi in avanti essa si divide in cinque nastri, che rimangono connessi tramite fasci trasversali e obliqui fino al punto di divisione, in corrispondenza delle teste dei metatarsi. A questa altezza, lo strato superficiale di ciascun nastro si fissa al derma mediante legamenti cutanei che garantiscono la connessione tra la cute, la parte ossea e quella legamentosa. 12 L’aponeurosi plantare, tendendosi con la flessione dorsale delle dita, collabora infine con i muscoli intrinseci nell’aumentare la concavità dell’ arcata plantare quando il tallone viene sollevato dal suolo durante la deambulazione (fig.1.4). Figura 1.4 Immagine computerizzata che illustra come la flessione dorsale delle dita (implicata dalla fase di spinta del passo) tenda l’aponeurosi plantare. 1.2. Anatomia funzionale del piede 1.2.1. Struttura ossea e legamentosa La struttura scheletrica del piede è composta di 26 ossa (fig.1.5) e si può dividere topograficamente in tre porzioni: 1) avampiede, che comprende le ossa delle falangi e dei metatarsi; 2) mesopiede, con i tre cuneiformi, il cuboide e lo scafoide (o navicolare); 3) retropiede, composto da astragalo e calcagno. Durante la stazione eretta il peso del corpo viene distribuito sui due piedi, anche se in diverse persone il peso grava di più sul piede sinistro. Il peso 13 che si scarica su ciascun piede viene distribuito attraverso l’astragalo nel tallone e nell’avampiede ed in particolare nella parte laterale dove avviene il contatto con il suolo (fig.1.6) . Ciò si verifica perché la parte media della pianta del piede è fatta ad arco concavo in basso, più accentuato nel lato mediale e meno sviluppato lateralmente. Figura 1.5 Visione dorsale e plantare delle ossa del piede Dal punto di vista strutturale, l’astragalo è costituito da un corpo, un collo e una testa. Il corpo si articola mediante la superficie superiore con la superficie distale della tibia che gli trasmette la forza peso. Sui lati si articola con i malleoli mediale e laterale. Le linee lungo le quali si trasmette il peso sono schematizzate in figura. Le linee di scarico del peso, sono dirette obliquamente, e ciascuna di esse può essere scomposta in due risultanti, una verticale e una orizzontale. 14 Quella verticale rappresenta la pressione del peso sul terreno, ed è bilanciata dalla forza di reazione trasmessa dal suolo, mentre quella orizzontale avrà tendenza ad appiattire l’arco longitudinale del piede, ed è invece bilanciata dall’attrito e dalla tensione di aponevrosi, legamenti e muscoli della pianta del piede. Figura 1.6 Immagine che schematizza l’andamento delle linee di distribuzione del carico durante la stazione eretta La posizione della verticale abbassata dal centro di gravità corporeo cade più avanti dell’articolazione della caviglia. La linea della gravità deve infatti intersecare l’apice dell’arco tra i punti di contatto col suolo, ossia il calcagno e l’avampiede perché il peso venga adeguatamente distribuito. Infatti usualmente essa passa tra il tubercolo del navicolare sul lato mediale, e la base del quinto metatarsale sul lato laterale. Dunque la linea che rappresenta la pressione esercitata attraverso la tibia non è verticale, ma 15 leggermente obliqua, in quanto passa per il baricentro del corpo (figura 1.6). La testa dell’astragalo è diretta in avanti, e si articola col navicolare sul lato mediale del piede. Da questo punto la linea di distribuzione del peso passa attraverso i tre cuneiformi e raggiunge i capitelli dei tre metatarsali mediali. L’osso del tallone è il calcagno. La parte anteriore di quest’osso è diretta lateralmente, ove si articola col cuboide sulla parte laterale del piede. A sua volta il cuboide si articola direttamente coi due restanti metatarsali. La linea di distribuzione del peso verso l’avampiede raggiunge i metatarsali 1° 2° e 3° attraverso astragalo, navicolare e cuneiformi, mentre passa attraverso astragalo, calcagno e cuboide per raggiungere i metatarsali 4° e 5°. Sebbene la distribuzione delle pressioni scaricate al suolo al livello del piede sarà un argomento trattato nel dettaglio in seguito, è importante sottolineare in questa sede come, nella stazione eretta,il 60% delle pressioni sia scaricato nel calcagno e il 30% a livello delle teste metatarsali (fig.1.7). Il 10% delle pressioni rimanente risulta distribuito tra le dita e la fascia del mesopiede. 16 Figura 1.7 Distribuzione, in un soggetto sano durante la stazione eretta, della pressione (%) a livello plantare I cuneiformi intermedio e laterale hanno forma di cuneo, e il più acuto dei loro angoli è diretto plantarmente. Per la loro disposizione l’avampiede presenta un marcato arco trasversale (fig.1.8). La tensione di quest’arco dipende soprattutto da potenti legamenti interossei. Per sfruttare il miglior braccio di leva, quindi queste ossa si articolano tra loro per mezzo di artrodie che risultano il più possibile vicine al dorso del piede. Esse consistono in una tipologia di articolazione in cui le due superfici articolari sono pianeggianti e consentono solo movimenti di scivolamento relativo delle due parti, non consentono movimenti angolari. Poiché la capsula di un'articolazione a superfici piane è sempre tesa, il movimento concesso è limitato ma multi direzionale. Le cavità articolari sono rivestite soltanto dorsalmente da una capsula molto sottile. Sulla superficie plantare l’intera area non articolare presenta i legamenti interossei. Questa disposizione consente di neutralizzare la tendenza dell’arco ad appiattirsi, 17 senza l’intervento attivo di fasci muscolari. L’arco trasversale è sostenuto anche dal tendine del peroneo lungo, quando il muscolo è contratto. Figura 1.8 Sezione che evidenzia l’arco trasversale formato dalle ossa metatarsali Le articolazioni e i legamenti a livello delle basi metatarsali sono disposte in modo da replicare la disposizione esistente tra i cuneiformi. Dorsalmente vi sono artrodie, plantarmente robusti legamenti interossei che coprono l’intera area disponibile. Le cinque ossa metatarsali divergono un po’ nella parte anteriore. Sono unite alle rispettive ossa del tarso da robusti legamenti situati plantarmente. Sono connesse tra loro anche anteriormente da robusti legamenti interossei inseriti sul collo di queste ossa lunghe. Grazie a questa disposizione, la pressione sull’avampiede si distribuisce normalmente su tutti e cinque i metatarsali, scaricando su di essi il peso del 18 corpo. Il capitello del primo metatarsale è separato dal suolo per interposizione di una coppia di ossa sesamoidi tra i due tendini del flessore breve dell’alluce. Ciò significa che non ci sono cinque, ma sei strutture che trasmettono il peso del corpo dall’avampiede al pavimento. Il peso è distribuito più o meno uniformemente su tutti e sei, quindi circa due sesti (1/3) del peso scaricato sull’avampiede è trasmesso al suolo dal più robusto metatarsale dell’alluce,ed un sesto per mezzo di ciascuno degli altri. L’arco longitudinale mediale si estende dal tallone al capitello del metatarsale dell’alluce ed ai metatarsali 2° e 3°. È composto da calcagno, testa dell’astragalo, navicolare, ossa cuneiformi, tre ossa metatarsali mediali che assorbono 4/6 del peso esercitato sull’avampiede. 19 Figura 1.9 Illustrazione dei tendini e legamenti in una visione plantare Le ossa del piede sono legate saldamente tra loro dai potenti legamenti interossei situati plantarmente (fig.1.9), ad eccezione della testa dell’astragalo che non è legata direttamente né al calcagno né al navicolare. Il collo dell’astragalo sta sopra la parte del calcagno che è chiamata “sustentaculum tali”. Tale processo sporge medialmente come una mensola, e funge da blocco. Il margine anteriore del sustentaculum è congiunto al navicolare dal robusto legamento calcaneonavicolare plantare, o legamento 20 molla. La testa dell’astragalo poggia sulla superficie superiore di questo legamento, superficie che è rivestita dalla cartilagine articolare. Questo legamento svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’arco longitudinale mediale. Nel caso che questo si danneggi o sia congenitamente lasso, la testa dell’astragalo viene spinta tra il calcagno e il navicolare dal peso del corpo, e l’arco potrà abbassarsi del tutto, fenomeno patologicamente noto con il nome di “piede piatto”. L’arco longitudinale laterale invece è compreso tra il tallone e i capitelli dei metatarsali 4° e 5°. È formato da calcagno, cuboide e queste due ossa metatarsali. Quando è soggetta all’azione della forza peso, la base del 5° metatarsale può sfiorare il suolo. Il calcagno è sede di molti legamenti: degno di nota è il legamento biforcato, il cui tronco è inserito sul calcagno e le cui braccia vanno in avanti, divaricate, per inserirsi sul navicolare e sul cuboide. Sulla superficie plantare, il calcagno e il cuboide, che fanno parte dell’arco laterale, sono uniti dal legamento plantare breve (calcaneo-cuboidale). L’arco è sostenuto anche da un altro legamento, il plantare lungo, posto superficialmente al plantare breve. Nella parte posteriore è inserito su una vasta superficie del calcagno, e in quella anteriore è inserito sul cuboide e sulle basi delle ossa metatarsali, specialmente dalla parte laterale del piede. Questi legamenti svolgono l’azione di contrastare la tendenza degli archi longitudinali ad allungarsi e appiattirsi sotto l’azione del peso corporeo. Questa tendenza è contrastata anche dall’aponevrosi plantare (illustrata in seguito) che s’inserisce sul calcagno e su una vasta area dell’avampiede, 21 compresa la base delle dita. Poiché occupa una posizione decisamente superficiale, ha un miglior effetto di leva rispetto ai legamenti plantari lungo e breve. Anche i muscoli intrinseci ed estrinseci disposti longitudinalmente lungo la pianta del piede e capaci di forti contrazioni svolgono un’azione, in questo caso attiva, di contrasto all’appiattimento dell’arco. I muscoli peronieri (breve e lungo) e il tibiale posteriore inviano robusti tendini che dalla loggia posteriore della gamba si inseriscono sul piede rispettivamente al lato esterno ed al lato interno della caviglia, passando sotto i rispettivi malleoli (fig.1.10). La loro funzione è di stabilizzazione e flessione plantare del piede durante il cammino, la corsa ed il salto. Altro tendine degno di nota è quello d’Achille: è il robusto tendine che si inserisce sul calcagno originando dai muscoli della loggia posteriore della gamba; esso ha il compito di trasmettere la forza originata da tali muscoli allo scheletro ed è implicato costantemente durante la deambulazione, la corsa ed il salto. Per diminuire l’attrito durante il movimento, esistono delle strutture che si interpongono tra osso e tendine chiamate “borse”. 22 Figura 1.10 Illustrazione dei tendini visibili lateralmente nel piede In condizioni statiche il sostegno degli archi dipende esclusivamente dai legamenti. In condizioni dinamiche invece, il piede sopporta un considerevole aumento della tensione che chiama in causa l’azione dei muscoli. 1.2.2.Struttura muscolare I muscoli del piede sono, come nella mano, molto numerosi. Questi molteplici “motori” sono gli effettori di due tipi di azioni: quelle inviate direttamente dal cervello (ad esempio responsabili dei movimenti propri dell’atto del camminare) e quelle reattive ai segnali ricevuti dalle terminazioni nervose della pianta del piede, che compiono innumerevoli piccole stabilizzazioni dell’impalcatura su cui grava tutto il peso del corpo. Patologie in cui questo controllo retroattivo non funzioni adeguatamente 23 (come la neuropatia diabetica), compromettono pesantemente, se non completamente la funzionalità del piede e la sua struttura. In questa sede non si ritiene opportuno fornirne una esaustiva descrizione anatomica, preferendone una più agile di carattere funzionale. Da un punto di vista istologico, si nota innanzitutto che i muscoli del piede sono costituiti per la maggior parte da fibre rosse. Le contrazioni di tali fibre, in antitesi con quelle relative alle fibre bianche, sono lente, a metabolismo anaerobico e a basso costo energetico. I fusi muscolari sono i recettori della stimolazione ambientale, mentre le fibre extra-fusali fungono da effettori, essendo connesse alle formazioni legamentose. Nel meccanismo antigravitario, l’intervento dei muscoli è limitato ad un’azione di controllo, che si svolge in genere decelerando il movimento e svolgendo un’azione stabilizzatrice della parti in gioco. L’economicità dell’azione muscolare a livello del piede è determinata da diversi fattori: in primo luogo la contrazione muscolare è favorita dal fatto che il muscolo si trova disteso per azione della gravità, spesso, inoltre, un muscolo controlla due o più articolazioni (muscoli poliarticolari). In letteratura, già dagli anni ’70, si vedono registrati potenziali inferiori a quelli propri della contrazione tetanica (attività muscolare acceleratrice). I movimenti del piede sono attuati sia da muscoli intrinseci (cioè situati completamente nel piede) che da muscoli estrinseci (che hanno cioè origine nella gamba). Questi ultimi esercitano la loro azione sui tendini che s’inseriscono sulle ossa del piede: sono responsabili della dorsoflessione, della flessione plantare, dell’inversione e dell’eversione del piede. Quelli intrinseci sono invece 24 responsabili della flessione, estensione, abduzione e adduzione delle dita del piede (fig.1.11). Nella regione dorsale del piede vi è l’estensore breve delle dita, un muscolo appiattito ed allungato che concorre all’estensione delle dita del piede, e, per la sua obliquità corregge l’obliquità in senso contrario dei tendini dell’estensore lungo delle dita. Nella regione plantare del piede, i muscoli hanno una disposizione simile a quelli della mano, con alcune differenze dovute alla mancanza di opposizione e di capacità prensile del piede. Si raggruppano in tre masse: Figura 1.11 Immagini dei gruppi muscolari presenti nella pianta del piede - Gruppo mediale , che comprende tre muscoli: muscolo abduttore 25 dell’alluce, muscolo flessore breve dell’alluce, muscolo adduttore dell’alluce. - Gruppo laterale, costituito da tre muscoli: muscolo abduttore dell’alluce del mignolo, muscolo flessore breve del mignolo, muscolo opponente del mignolo - Gruppo intermedio, formato dal muscolo flessore breve delle dita, dal muscolo quadrato della pianta, dai muscoli lombricali, dei muscoli interossei dorsali e dai muscoli interossei plantari. Questi ultimi sono ricoperti dall’aponeurosi plantare e hanno principalmente la funzione di mantenere la concavità delle arcate plantari. Il loro indebolimento porta come conseguenza quella deformazione nota come piede piatto. 1.2.3 Meccanica delle articolazioni La possibilità di adattamento alla superficie di appoggio e di adeguamento nei confronti delle richieste funzionali derivano dalle molteplici libertà di movimento delle articolazioni podaliche nel loro complesso. L’arto inferiore possiede ben 29 gradi di libertà, a cui corrispondono le azioni di 48 muscoli diversi. Complesso peri-astragalico: 26 Figura 1.12 Complesso astragalico, visione frontale e laterale interna Poiché l’irrigidimento podalico è ottenuto per mezzo di rotazioni relative dell’avampiede e del retro piede che interessano il piano frontale, a valle di rotazioni sul piano trasverso che avvengono a livello sovrapodalico, è intuibile che esista un dispositivo di trasmissione del moto tra i due piani tra loro perpendicolari. Questo compito è svolto sia in sede sottoastragalica sia a livello dell’articolazione tibio-peroneo-astragalica, in quello che è chiamato “complesso peri-astragalico” (fig.1.12). L’astragalo (o Talo), centro nevralgico di questo sistema, è privo di inserzioni muscolari. Le sue superfici sono fortemente cartilaginizzate, ed il suo compito è di stabilire il rapporto tra le varie parti concorrenti (ossa della gamba, calcagno, scafoide), per mezzo delle sollecitazioni che gli provengono dai corpi adiacenti, unica fonte del suo moto. L’astragalo è quindi considerabile osso del piede quando ruota con i segmenti sottoastragalici in flessione plantare ed estensione dorsale, e osso della 27 gamba quando, seguendo le strutture soprapodaliche, trasmette al piede le rotazioni della gamba (fig.1.13). La troclea astragalica è una superficie a forma di cono. Le facce trocleari dei malleoli vi si accoppiano perfettamente, tanto da non consentire spostamenti dell’astragalo sul piano frontale. Le piccole traslazioni laterali di quest’ultimo, utili ai fini di ammortizzazione, sono dovute a altrettanto modeste rotazioni peroneali. La conicità della troclea fa sì che alle escursioni flesso-estensorie del piede si accompagnino rotazioni sul piano trasverso: in particolare, alla flessione plantare si connette una rotazione interna e all’estensione dorsale una esterna . Figura 1.13 Schematizzazione dei movimenti consentiti dalle atricolazioni centrate sull’astragalo Quando il piede è sotto carico, e soprattutto nelle fasi del passo in cui il piede compie movimenti di flessione ed estensione rispetto alla gamba, questo meccanismo risulta particolarmente importante. Il suo intervento 28 infatti contribuisce a potenziare la già presente intra-rotazione della gamba in fase di flessione plantare, ed extra-rotazione in concomitanza alla estensione dorsale. Nell’arco della fase portante l’ampiezza media della flesso-estensione della tibio-tarsica è di 24°, e le rotazioni dell’arto nel piano trasverso sono di un’ampiezza media di 11°. A livello sotto-astragalico invece sono distinguibili due articolazioni: quella tra astragalo e calcagno e l’astragalo scafoidea. La superficie concava plantare dell’astragalo accoglie la testa del calcagno, mentre la testa astragalica è alloggiata nella concavità dello scafoide. L’interfaccia astragalo-calcagno è particolarmente interessante: è costituita dal legamento interosseo che, trattandosi di una tenace formazione fibrosa, torcendosi connette sempre più strettamente le due ossa, nel corso dell’irrigidimento antigravitario. Il movimento proprio della sotto-astragalica è la prono-supinazione, un complesso movimento triplanare composto da: flessione-estensione (piano sagittale), adduzione- abduzione (piano trasverso), inversione-eversione (piano frontale). Questo movimento è mediamente stimato di 20° in supinazione e 10° in pronazione. La complessità di questa articolazione si accentua con il fatto che durante il movimento avvengono reciproci scivolamenti dell’astragalo sul calcagno, e che quest’ultimo varia il suo rapporto col piano di appoggio tramite rotolamento sulla superficie di contatto. Nel corso dell’irrigidimento antigravitario, a causa di queste non linearità, varia la collocazione spaziale dell’asse articolare, che assume quindi carattere momentaneo, attenuandosi progressivamente la sua 29 obliquità (stimata mediamente a 16° verso l’interno rispetto al piano sagittale) ed accentuandosi la sua elevazione (42° rispetto al piano trasverso). Il rapporto tra le rotazioni trasversali sovrapodali e le conseguenti rotazioni prono- supinatorie dell’astragalo-calcaneare esprime la conformazione articolare dei singoli soggetti. In un soggetto sano, a 1° di rotazione sul piano trasverso, corrispondono in media 0.5° di prono-supinazione. Tramite questo rapporto è quindi possibile interpretare quantitativamente difetti di rilasciamento (caso del piede cavo) e di irrigidimento (caso del piede piatto). Il trasferimento del moto nei piani interessati avviene, come già accennato, tramite il cono astragalo-calcaneare, a livello del quale i moti attorno all’asse meccanico dell’arto (giacenti sul piano trasverso), vengono trasmessi in piani intermedi, perpendicolari all’asse momentaneo di rotazione, fino a manifestarsi sul piano frontale con la prono-supinazione. Sono tuttavia da considerare sia la centralità dell’astragalo nell’indurre torsioni della gamba quando viene sollecitato da spostamenti del calcagno (piede che ricerca e si adatta al suolo), che la sua tendenza a trasmettere le rotazioni delle gamba e quindi ad indurre prono-supinazioni del piede quando vi si carica il peso del corpo (piede come leva) 30 Articolazione medio-tarsica: A B Figura 1.14 Rappresentazione dell’elica podalica tramite sezioni successive. (A) . i segmenti in rosso indicano l’inclinazione delle ossa in ogni sezione. Si nota come a livello delle dita sia orizzontale, inclinandosi mano a mano che ci si avvicina al retropiede, dove raggiunge la verticalità (B). È costituita dall’insieme delle due articolazioni astragalo-scafoidea e calcaneo-cuboidea. È la sede di separazione tra retropiede e avampiede. In questa sede si giocano le rotazioni relative che creano il contrasto retroavampodalico in fase di carico: il retro piede tende a verticalizzarsi sotto l’azione dei segmenti soprapodalici, mentre l’avampiede è sollecitato all’eversione dalla reazione del suolo, rispetto al quale si rende più aderente. In fase di rilasciamento invece avviene l’inverso. Proprio per questo avvolgimento, che avviene sul piano frontale, il piede può essere assimilato ad un’”elica a passo variabile” (figura 1.14), in sede di unione a 31 1/3 posteriore e 2/3 anteriore: all’irrigidimento corrisponde l’avvolgimento (e quindi un accorciamento del passo), al rilasciamento uno svolgimento (che allunga il passo dell’elica). Articolazione tarso metatarsale In questa sede si definisce l’adattamento dell’avampiede alla superficie d’appoggio: le sollecitazioni provenienti dalla superficie, agendo sulle teste metatarsali, ne modificano la disposizione. Grazie alla mobilità tarsometatarsale ed al suo comportamento a “ventaglio”, questo meccanismo svolge anche l’azione di ammortizzazione. Nel meccanismo di avvolgimento dell’elica podalica, la supinazione del calcagno, attraverso il cuboide, sollecita il 4° e 5° metatarso a spingere sulla superficie d’appoggio. Questa sollecitazione è massima per il 4°, in quanto il 5°, con la sua tuberosità laterale, è finalizzato a stabilizzare l’appoggio ed impedire un improponibile rollio del piede. L’avampiede fa così perno sul 4°metatarso, che resta aderente al suolo, mentre i metatarsi mediali, tramite le connessioni con le ossa tarsali che seguono il movimento dell’astragalo, s’innalzano, mantenendo contatto col suolo tramite i capitelli. Le ossa tarsali assumono così una posizione sempre più verticalizzata, disponendosi in serie sul cuboide. Sul primo metatarso agisce come fattore di stabilizzazione il muscolo lungo peroneo. La seconda articolazione cuneo-metatarsale è la meno mobile della serie, ed assume il ruolo di elemento di riferimento nei rapporti tarso-metatarsali. Per questo motivo per asse longitudinale del piede si intende la linea immaginaria che dal centro del calcagno arriva alla metà del capitello del 32 secondo metatarso. Articolazioni metatarso-falangee ed interfalangee Le articolazioni metatarso-falangee, sede di rotazioni che avvengono sia sul piano trasverso che sagittale, avviano un meccanismo ad “argano: l’avvolgimento delle digitazioni della aponeurosi plantare, determinato dalla estensione dorsale delle dita, tende la stessa aponeurosi, realizzando l’ultimo grado di irrigidimento podalico. Nella fase di rilasciamento, al contrario, le dita si adagiano ed ampliano la superficie di appoggio, distendendo l’aponeurosi. 1.2.4 Le funzioni del piede Generalmente si tende a dare scarsa importanza al piede, considerato spesso e semplicisticamente, come qualcosa che serve per muoversi sul terreno. Esso invece rappresenta una delle cause più frequentemente all’origine di quadri patologici su base posturale. Raramente si pensa, infatti, che questo “organo” è chiamato a sopportare notevoli sollecitazioni, specialmente nello sport, come brusche accelerazioni, arresti repentini, ripetuti slittamenti, violente ricadute e cambi di direzione. In queste situazioni il carico di lavoro può essere elevatissimo e le articolazioni sono costrette a sopportare forze pari a multipli del peso corporeo. Alcuni calcoli hanno mostrato, ad esempio, che per una distanza di 1.500 metri in un soggetto di 70 Kg, ogni piede sopporta più di 60 tonnellate durante la marcia normale, e 110 tonnellate durante la corsa a 12 33 Km/h! L’azione “biomeccanica” del piede è quindi essenziale e consiste nell’assorbire l’energia meccanica generata nell’impatto con il suolo, immagazzinarne parte sotto forma di energia elastica e nel trasmettere, nella fase di spinta, la forza generata dai muscoli: una sorta, insomma, di ammortizzatore biologico. Il piede, nel corso dell'evoluzione che dura da circa 350 milioni di anni, per le esigenze sorte nell'assunzione della stazione eretta e della deambulazione bipodale, ha acquisito, quale caratteristica umana peculiare e differenziale, l'attitudine all'irrigidimento ovvero alla coesione intersegmentale. Tale coesione podalica è realizzata dalle formazioni capsulo-legamentose e aponeurotiche a cui si aggiungono le formazioni muscolari con funzioni di "legamenti attivi" e posturali. Questi muscoli, in particolare quelli intrinseci del piede, sono a prevalenza di fibre rosse (fibre ad attività lenta ed energeticamente economica), in stato contrattile pressochè ininterrotto in stazione eretta e in rapporto topografico e funzionale con le formazioni capsulo-legamentose (in sede di inserzione ossea si osserva, in alcuni di loro, una notevole abbondanza di fibre collagene espanse e non raccolte come al solito; ciò ricorda le formazioni legamentose e aponeurotiche). Anche se l'intervento muscolare globale nella realizzazione della coesione interossea sembra comunque essere meno rilevante rispetto alla funzione di controllo e regolazione della funzione antigravitaria, la complessità dell'azione podalica richiede una polivalenza funzionale. Inoltre, la podo- 34 meccanica antigravitaria è cosparsa di interventi muscolari che coinvolgono due o più aricolazioni. I muscoli poliarticolari infatti offrono particolari vantaggi ai fini dell'economia energetica in quanto sono in grado di sviluppare tensioni notevoli con modici accorciamenti. Tali muscoli frequentemente agiscono stabilizzando l'articolazione prossimale favorendo così i movimenti dell'articolazione particolare dei segmenti relativa). economia distali (e quindi la rotazione L'indagine elettromiografica conferma energetica realizzata dai muscoli in la fase antigravitaria: vengono infatti realizzati potenziali inferiori a quelli propri della contrazione tetanica (caratteristica dell'attività dei muscoli a fibre bianche o acceleratori). L'insieme delle formazioni muscolari che interessano il piede, quali effettori nel sistema di controllo gravitario, rappresentano le forze interne in "contrasto" con le forze esterne ovvero ambientali. Il piede umano quindi si evolve da una forma prensile alla forma stabilizzatrice antigravitaria conservando la complessità della propria muscolatura; all'afferramento prensile si sostituisce l'aggrappamento antigravitario. Il piede è così il dispositivo di gran lunga più valido che l'uomo possiede per il controllo dell'ambiente sottoposto alle legge di gravità. L'informazione genetica conferisce alla struttura podalica la modellatura di fondo. L'informazione ambientale confluisce nella genetica che la memorizza gradualmente, nel corso delle generazioni, potenziando la genesi delle prerogative antigravitarie. Il fattore culturale però interferisce su tale sviluppo alterando 35 l'informazione ambientale (creando terreni e scarpe inadeguati) causando così un ritardo evolutivo. In biomeccanica, nessuna forza interna a un corpo, ossia che si esaurisce nell'ambito del corpo (rappresentata dai muscoli nel caso dell'uomo), è in grado di spostarlo nello spazio. Affinchè il corpo si muova è necessaria una forza esterna. Le forze esterne ambientali per eccellenza sono: la gravità, la reazione dal suolo e l'attrito. L'uomo moderno ha nei piedi i più efficaci strumenti per prelevare dalla gravità le energie necessarie per la locomozione. Non vi è dubbio che quella "gravitazionaria" è l'attività senso-motrice di gran lunga più importante e il movimento che la esprime può essere concepito come il fattore determinante al fine della vita dell'uomo, quale essere più esposto alle "aggressioni" ambientali. Il corpo umano è un sistema di equilibrio instabile; l'altezza del centro di gravità (idealmente anteriore alla terza vertebra lombare) rispetto a una base ristretta e la struttura composta da una successione di segmenti articolati, sono fattori di instabilità. Solo un vigile controllo (sistema tonico posturale) riesce, in tale condizione, a ricercare l'equilibrio dinamico stabile nella stazione eretta e l'equilibrio dinamico instabile durante la locomozione (che consente la trasformazione dell'energia potenziale in energia cinetica). Ciò avviene soprattutto grazie a un servizio informativo (esterocettori cutanei e propriocettori) talmente preciso e tempestivo da consentire risposte validissime con interventi energeticamente economici (non rilevabili elettromiograficamente) da parte di muscoli con prevalenza di fibre rosse. Si tratta della manifestazione informativa più importante in quanto fornisce all'uomo il privilegio di 36 adattarsi alle più svariate condizioni ambientali. Il piede è un diaframma interposto tra forze esterne (ambientali) e forze interne (muscolari), che in esso si incontrano, si contrastano e infine si fondono per l'affermazione della condizione di equilibrio. Il piede è una struttura "spaziale" ossia atta ad assorbire e smistare le forze, relativamente agli infiniti piani dello spazio. Il piede, nel suo ruolo di "base antigravitaria", in un primo tempo prende contatto con la superficie di appoggio adattandosi ad essa rilasciandosi, successivamente si irrigidisce, divenendo una leva per "respingere" la superficie stessa. Il piede deve quindi alternare la condizione di rilasciamento con la condizione di irrigidimento. L'alternanza di lassitàrigidità giustifica l'analogia con l'elica a passo variabile. Retropiede e avampiede si dispongono infatti in piani che si intersecano in modo variabile. Nella condizione ideale, il retropiede è disposto verticalmente e l'avampiede orizzontalmente (su una superficie di appoggio orizzontale). A piede sotto carico la torsione tra retropiede e avampiede si attenua nel rilassamento (il piede diviene una piattaforma modellabile) e si accentua nell'irrigidimento (il piede diviene una leva). La disposizione ad arco è in realtà apparente essendo espressione del grado di avvolgimento dell'elica podalica. Il piede quindi non ha il significato di un arco o volta reale ma apparente, che si alza durante l'avvolgimento e si abbassa durante lo svolgimento dell'elica. L'avvolgimento dell'elica, con la conseguente accentuazione dell'apparente disposizione ad arco, corrisponde al suo irrigidimento. Lo svolgimento dell'elica, con conseguente 37 attenuazione dell'arco apparente, è il rilasciamento. La torsione (avvolgimento) dell'elica podalica è connessa alla rotazione esterna (extrarotazione) dei segmenti sovrapodalici (gamba e femore). L'astragalo ruotando all'esterno solidalmente con le ossa della gamba, sale sul calcagno chiudendo in tal modo l'articolazione mediotarsica; il retropiede si verticalizza. L'avampiede aderente tenacemente al suolo reagisce alle forze torcenti applicate sul retropiede; il piede è quindi irrigidito. Occorre tener presente che in biomeccanica sono presenti numerosi meccanismi elicoidali in quanto, fungendo come piani inclinati, consentono di agire con sforzi minimi su rilevanti resistenze. Nella biomeccanica del piede il "dispositivo centrale" di controllo della gravità è il complesso articolare peri-astragalico(retropiede) composto da: 1. articolazione tibio-peroneo-astragalica; 2. articolazione sotto-astragalica posteriore (astragalo-calcaneare) 3. articolazione sotto-astragalica anteriore(astragalo-scafoidea) 38 4. articolazione medio-tarsica o di Chopart (astragalo-scafoidea + calcaneo-cuboidea) L'astragalo, osso con cui non prende rapporto diretto nessun muscolo (non presenta inserzioni muscolari), si muove a seguito delle forze trasmesse dalle ossa adiacenti. L'astragalo è un osso del piede in quanto è solidarizzato al calcagno e allo scafoide nelle rotazioni sul piano sagittale (flesso-estensione) ed è osso della gamba in quanto è solidarizzato con la tibia e al perone, tramite la pinza bimalleolare, nelle rotazioni dei segmenti sovrapodalici Il movimento sul piano proprio trasverso (intra-extrarotazioni). dell'articolazione sottoastragalica è la prono- supinazione (eversione-inversione) che avviene intorno all'asse noto come "asse di compromesso". L'asse di compromesso è in realtà un asse "momentaneo", in quanto varia la sua collocazione nello spazio durante il passaggio dalla fasi di irrigidimento (in cui accentua la sua elevazione) a quella di rilasciamento del piede; i valori angolari a cui si fa riferimento vanno pertanto intesi come intermedi di un range di normalità (al di fuori del quale si va nella disfunzione osteopatica). L'articolazione astragalocalcaneare(sotto-astragalica posteriore) è divisa in una regione anteromediale e una postero-laterale da una tenace formazione fibrosa, il legamento interosseo, che torcendosi connette sempre più tenacemente astragalo e calcagno durante l'irrigidimento antigravitario. L'articolazione medio-tarsica o di Chopart è costituita dalle due articolazione astragalo-scafoidea e calcaneo-cuboidea. Essa è la sede di separazione tra retropiede e avampiede nonchè il luogo dove converge il 39 contrasto retro-avampodalico durante l'elicazione del piede. Da questa articolazione l'azione procede chiamando in articolazioni distali ossia causa le dell'avampiede. L'avampiede assume il significato, oltre che di "adattatore" alla superficie di appoggio (fase di rilasciamento), di "reattore" in quanto sede di applicazione della reazione al suolo ossia della spinta propulsiva che nell'arco dell'irrigidimento migra in direzione calcaneo-digitale; le sue articolazioni sono: 1. articolazione tarso-metatarsale o di Lisfranc 2. articolazioni metatarso-falangee 3. articolazioni falangee L'intervento dell'articolazione tarso-metatarsale o articolazione di Lisfranc nella meccanica podalica determina il comportamento del ventaglio costituito dai metatarsi. Nell'articolazione di Lisfranc si definisce l'adattamento dell'avampiede alla superficie di appoggio, per via delle sollecitazioni di quest'ultima sulle teste metatarsali. Le articolazioni metatarso-falengee, tramite la flessione dorsale delle dita, avviano il meccanismo dell'argano nel periodo ultimo e definitivo dell'irrigidimento podalico (propulsione), durante la deambulazione. L'estensione dorsale delle dita tende la aponeurosi plantare realizzando il grado estremo di irrigidimento; L'avvolgimento delle singole digitazioni dell'aponeurosi plantare attorno al capitello del relativo metatarso realizza una condizione meccanica simile a un argano (elica --> leva --> argano). Nella fase di rilasciamento, al contrario, le dita si adagiano e ampliano la 40 superficie di appoggio e l'aponeurosi plantare è detesa. Oltre alla funzione meccanica, al piede spetta un altro fondamentale compito: quello di informare sulle sollecitazioni alle quali è sottoposto e sulla natura del terreno sul quale viene ad operare. L’esterocettore plantare permette di situare l’insieme della massa corporea in rapporto all’ambiente, grazie a delle misure di pressione a livello della superficie cutanea plantare. Essa è ricca in recettori e possiede una soglia di sensibilità molto elevata (i baropressori percepiscono le pressioni anche di 0,3 gr); fornisce informazioni sulle oscillazioni dell’insieme della massa corporea e si comporta dunque come una piattaforma stabilometrica. Le informazioni plantari sono le uniche a derivare da un recettore fisso direttamente a contatto con un ambiente immobile rappresentato dal suolo. Le terminazioni nervose stimolate durante la stazione eretta e il movimento, infatti, fanno del piede un organo “posturale” ed uno straordinario informatore del cervello. I nervi sensitivi trasmettono ad esso tutte le informazioni recepite, principalmente al livello della cute, dei tendini e delle articolazioni: sensazioni tattili, vibratorie, spaziali e traumatiche. Grazie a queste informazioni, associate a quelle provenienti da altre fonti quali occhi, labirinto, mandibola, il cervello formula una risposta motoria modulata, estremamente importante, in quanto rappresenta uno degli elementi principali di salvaguardia della integrità di tutto l’apparato 41 locomotore. Nella stazione eretta comoda la linea gravitaria (G = asse gravitario, M = asse mecanico, A = asse anatomico, C.G. = centro di gravità) cade ventralmente rispetto all'articolazione L'articolazione sottoastragalica si tibio-trasica trova in posizione (caviglia) intermedia tra pronazione e supinazione. L'articolazione medio-tarsica è disposta in pronazione rispetto al retropiede. La serie delle teste metatarsali si adatta alla superficie di appoggio. Si tratta in realtà di una condizione momentanea in quanto, passando la linea gravitaria davanti all'articolazione tibiotarsica, il peso applica su di essa momenti rotatori che sollecitano il corpo in avanti; la migrazione ventrale della linea gravitaria è ragione di 42 accentuazione della torsione retroavampodalica (irrigidimento podalico). Il compito della muscolatura podalica e del tricipite della sura in particolare (gastrocnemio e soleo), in funzione antigravitria, è quello di neutralizzare tali momenti rotatori, oltre quelli che inducono oscillazioni sul piano frontale. La stazione eretta è infatti in realtà non un equilibrio statico ma un "movimento su base stazionaria" (equilibrio dinamico stabile); le oscillazioni, sia pure minime (verificabili tramite esame stabilometrico), che la caratterizzano circolatorie e respiratorie. sono I riflessi dovute alle spinali assumono attività cardioqui un ruolo fondamentale. La verticalità infatti si verifica prevalentemente per mezzo di meccanismi estero-propriocettivi(compresi quelli visivi e vestibolari). A differenza di tutti gli altri mammiferi quadrupedi, che stanno in piedi e camminano in modo corretto poco tempo dopo la nascita, l'uomo deve attendere circa 6 anni per ottenere una postura stabile (e una maturazione degli atti di deglutizione e masticazione). A circa dodici mesi di vita si ha il passaggio graduale al bipodalismo ma è solo all'età di 5-6 anni che si formano e si stabilizzano le curve vertebrali (lordosi lombare e cervicale e cifosi dorsale) e ciò avviene grazie alla maturazione estero- propriocettiva del piede (il piede è fisiologicamente piatto fino all'età di 43 circa 4 anni per poi trasformarsi gradualmente in una struttura elicoidale a passo variabile). E' quindi il piede il responsabile delle modificazioni delle curve vertebrali in posizione eretta (ortostatismo); la fisiologica lordosi lombare si forma e si stabilizza a partire dalla formazione di una fisiologica e stabile volta plantare, a 5-6 anni di età, che libera il tronco cefalico da uno stato di ipertonicità, regolando così anche la cifosi dorsale e la lordosi cervicale. Prima di questa età, a partire da circa 1 anno, è normale che il piede sia un pò pronato e piatto, che le ginocchia siano un pò valghe e che vi sia una leggera iperlordosi lombare. Mentre nel neonato e fino a circa 8 mesi, è fisiologica la presenza di ginocchia vare e piede in supinazione. Tutti gli studi hanno confermato che la formazione delle curve parte dal basso. Va però aggiunto che a circa 6 anni, con la comparsa dei primi molari, deglutizione, masticazione, equilibrio occlusale giungono contemporaneamente a completa maturazione. Il completamento dello sviluppo della funzione posturale (sistema tonico posturale) avviene abitualmente verso gli undici anni e resta poi stabile sino a circa 65 anni (contemporaneamente alla stabilizzazione della funzione visiva sensoriale e motoria). La formazione e l'accrescimento del sistema muscolo-fascialescheletrico e del piano occlusale sono il risultato della complessa e personale azione antigravitazionale dell'individuo. Il piede, assieme alla lingua (per quanto riguarda le ossa del cranio), rappresenta un conformatore organo-funzionale di primaria importanza. La deambulazione (marcia o 44 cammino) bipodale dell'uomo è condizionata dal sollevamento del centro di gravità e dalla esiguità della base di appoggio, rispetto al quadrupedismo. E' un atto complesso risultante dalle interazioni fra forza interne ed esterne dirette da un mirabile sistema di controllo posturale e dell'equilibrio, che regola attimo per attimo, tramite i muscoli, i rapporti fra le forze. La maggior parte dei gruppi muscolari degli arti inferiori sono attivi durante la deambulazione (l'arto inferiore possiede ben 29 gradi di libertà di movimento a cui corrispondono 48 muscoli). La locomozione umana è una combinazione di ritmica propulsione in avanti ed elevazione del corpo in alto. Il baricentro corporeo in deambulazione ha un andamento sinusoidale sul piano sagittale raggiungendo il punto più basso nell'appoggio doppio (bipodalico) e la massima altezza in appoggio monopodalico, con un'escursione di 4-5 cm. Dal punto di vista strettamente meccanico, la progressione del corpo nello spazio è il risultato della combinazione di rotazioni articolari. Esattamente come i movimenti circolari delle ruote si traducono nel movimento in avanti del veicolo, movimenti rotatori (cerchi parziali) degli arti o di parti di essi si traducono nel movimento in avanti di tutto il corpo. Grazie al posizionamento alto del baricentro corporeo, l'accelerazione del nostro corpo è sostanzialmente di genesi gravitaria (energia potenziale che si trasforma in energia cinetica). Solo in misura modesta entrano in gioco contrazioni muscolari acceleranti ed è questa la ragione del fatto che l'uomo può protrarre il suo cammino molto a lungo. Si può infatti affermare che nella deambulazione il lavoro muscolare è richiesto solo nella risalita periodica del centro di gravità. 45 Il ciclo della deambulazione è compreso fra i due appoggi calcaneari dello stesso piede ed è costituito da una fase portante (60% dell'intero ciclo) e una fase oscillante (40% dell'intero ciclo). • Fase portante (Stance phase) A. Appoggio calcaneare (ricezione, fase frenante / initial contact) Al contatto del calcagno con la superficie di appoggio (ricezione), l'elica si rilascia per consentire la lassità del piede atta ad ammortizzare il peso del corpo e ad adattarsi alla superficie stessa. A tal fine l'arto inferiore ruota internamente, l'astragalo, ad esso solidale, ruota quindi anch'esso internamente supinando, il calcagno prona, ruotando esternamente. L'assunzione del peso da parte del piede è graduale ed è massima nel momento in cui la linea gravitaria cade nel centro della superficie podalica. B. Appoggio totale (contatto / midstance): Quando tutta la superficie plantare è a contatto con la superficie, la rotazione interna dell'arto si 46 trasforma bruscamente in rotazione esterna. Ciò fa scattare il meccanismo che ha come sede l'articolazione sotto-astragalica. Seguendo la rotazione dell'arto, l'astragalo ruota sul piano trasverso esternamente (per ca. 12° mediamente) pronando e risalendo al di sopra del calcagno (allontanandosi dal legamento calcaneo-scafoideo-plantare). A sua volta il calcagno ruota internamente, supinando attorno all'asse di compromesso: il retropiede si verticalizza tramite l'avvitamento reciproco astragalo-calcaneare. Il cuboide, tenacemente collegato al calcagno, migra plantarmente assumendo "sulle sue spalle" la serie dei cuneiformi. L'avampiede si dispone in contrasto rotatorio con il retropiede per la reazione al suolo. Si ha così l'avvolgimento dell'elica podalica e il conseguente "inarcamento" del piede: l'articolazione medio-tarsica è bloccata e si ha il contemporaneo passaggio del peso sul IV e V metatarso per eversione dell'avampiede non ancora rigido. Il muscolo peroniero lungo (lungo peroneo) richiama a contatto col suolo la testa del I metatarso eseguendo un lavoro di stabilizzazione facendo si che il peso sia ora distribuito su tutte le teste metatarsali (ventaglio metatarsale); il piede si trasforma da elica in rigida "barra di leva". C. Appoggio digitale (propulsione, fase propulsiva / terminal stance) Il calcagno si solleva dal terreno. Le dita dopo essersi 47 adattate tenacemente alla superficie di appoggio si flettono dorsalmente. Ciò fa sì che la aponeurosi si accorci tendendosi di ca. 1 cm (le digitazioni dell'aponeurosi plantare raggiungono le falangi basali corrispondenti, connettendosi al periostio, nei segmenti adiacenti alle articolazioni) innescando il meccanismo dell'argano che completa la coesione intrapodalica. Il centro di gravità del corpo migra ventralmente e il corpo si avvia a cadere in avanti. L'intervento del controllo muscolare, in particolare del muscolo tricipite surale, formato da gastrocnemio e soleo (oltre al tibiale anteriore, tibiale posteriore, peroneo lungo e flessori dorsali) e il tempestivo contatto controlaterale, esercitano azione da freno. Nella fase propulsiva le forze agenti sul piede sono pari a 3-4 volte il peso del corpo. In situazione di corretta fisiologia il piede si comporta a elica in modo tale che la proiezione a terra del baricentro corporeo resti perlopiù centrata ossia passi lungo il proprio asse, che corrisponde all'incirca all'asse podalico, asse passante centralmente al retropiede e al centro tra II e III dito. 48 • Fase oscillante (Swing phase) La fase oscillante si verifica tra il distacco delle dita dal suolo e il successivo l’appoggio del tallone dello stesso piede. Essa rappresenta la provvidenziale preparazione per la fase portante. La rotazione interna dell'arto, attorno all'asse meccanico, che inizia in questa fase, è indispensabile premessa per la successiva rotazione esterna. E' grazie a questa alternanza di rotazioni che l'energia potenziale si trasforma nel corpo umano in energia cinetica. Le fasi oscillanti e portanti sono pertanto legate relativamente alla continuità della progressione. Il pendolo podalico è in realtà un pendolo portante. Il complesso neuro-muscolare vigila su questo reciproco passaggio di consegne stabilizzandolo, modulandolo e caratterizzandolo quale espressione tipica dell'individualità. Alla nascita sono già presenti i circuiti nervosi predisposti alla deambulazione, essi però, al fine di consentire l'adeguato e indispensabile sviluppo muscolo-scheletrico, sono temporaneamente inibiti dai centri superiori. La postura quale atto volontario diviene così un fenomeno 49 maturativo e di apprendimento. Il lattante, grazie allo sviluppo muscolare estensorio, assume la posizione assisa (seduta) e successivamente quella eretta a 4 mesi. A circa un anno inizia la deambulazione dapprima appresa e in seguito automatizzata. Solo a circa due anni di età, a seguito dello sviluppo delle strutture relative, il controllo automatico è efficiente. La maturazione finale posturale avviene a 11-12 anni (contemporaneamente alla stabilizzazione della funzione visiva sensoriale e motoria). E' quindi nel piano trasverso che la moderna biomeccanica individuato l'elemento prioritario nella statica ha spaziale e nella dinamica dell'uomo. Difatti è dalla rotazione nel piano trasverso che scatta il meccanismo antigravitario, il quale consente la migrazione del baricentro verso l'alto. L'altezza del baricentro carica il sistema di energia potenziale, ovvero di instabilità che però, come abbiamo detto, si trasforma in indispensabile energia cinetica nella dinamica, consentendo così la progressione nello spazio con un modesto consumo di energia muscolare. Relativamente all'arto inferiore, le articolazioni in cui si compie il movimento nel piano trasverso sono, a catena cinetica chiusa, la coxofemorale (articolazione dell'anca) e la sottoastragalica. In particolare, l'articolazione coxofemorale e l'articolazione astragalo-scafoidea sono analogamente strutturate e corrispondentemente disposte. I movimenti 50 essenziali nella meccanica antigravitaria dell'anca sono l'estensione e la concomitante rotazione esterna e viceversa (flessione-intrarotazione). Nel trasferimento dalla flessione all'estensione quindi il femore ruota verso l'esterno riflettendosi nel meccanismo di rilasciamento-irrigidimento podalico. E' questa quindi una condizione anatomo-funzionale che favorisce la nostra antigravitarietà. E' ancora da chiarire con precisione il ruolo delle masse muscolari nella stabilizzazione dell'arto inferiore nel piano trasverso. Si ritiene che i muscoli chiamati in causa siano gli adduttori dell'anca, i flessori del ginocchio, lo psoas, il piccolo e medio gluteo, ma il muscolo determinante sembra essere il grande gluteo (estensore, abduttore ed extrarotatore dell'anca). Il grande gluteo è considerato il più potente stabilizzatore dell'anca nel piano trasverso. La sua attività di estensore contribuisce validamente al mantenimento del centro di gravità (o baricentro) al di sopra dei centri di rotazione delle anche. La sua prevalente attività stabilizzatrice esplica una funzione essenziale nella deambulazione e la sua azione si estende all'articolazione del ginocchio tramite il tratto ileo tibiale. L'analisi delle caratteristiche morfologiche e funzionali dell'arto inferiore relativamente al piano trasverso apre un grosso capitolo di disfunzione osteopatica strutturale che contempla le anomalie di rotazione femorotibiale e le ripercussioni sulla funzionalità podalica e viceversa. Si getta in tal modo un robusto ponte che connette sempre più il piede ai segmenti corporei soprastanti, in particolare, col cingolo pelvico, col cingolo scapolo-omerale, con la cerniera cervico-occipitale fino all'articolazione 51 temporomandibolare, nel contesto della biomeccanica e della patomeccanica. Ricapitolando… Si definisce ciclo del cammino o “gait cycle” il periodo che intercorre tra due appoggi successivi dello stesso arto al terreno. Si suddivide tale intervallo in due fasi distinte. Fase di stance, o fase d’appoggio, durante la quale il piede rimane a contatto con il terreno. Nella normo-deambulazione occupa circa il 60% del ciclo del passo, si accorcia sensibilmente con la corsa, riducendosi fino al 37% nella corsa veloce. Fase di swing, o fase di trasferimento. L’arto viene portato avanti per prepararsi all’appoggio successivo. Le suddette fasi sono suddivise a loro volta dal punto di vista funzionale in otto sottofasi, cinque riferite alla fase di stance e tre a quella di swing La fase di stance è usualmente suddivisa in cinque sottofasi. Initial contact, è una fase molto breve che va dallo 0% al 2% del ciclo del passo. Il piede proiettato in avanti tocca il suolo con il tallone. Loading response, coinvolge circa il 10% del ciclo del passo. Il piede si appoggia per intero al terreno e la caviglia ha una leggera flessione dorsale in risposta al carico sull’arto del peso corporeo. Mid stance time, si estende dal 10% al 30% del ciclo del passo. Inizia con lo stacco del piede contro laterale (termina la fase di doppio supporto) e 52 termina quando il piede è interamente supportato dal calcagno, dalle ossa del metatarso e dalle dita. Il ginocchio è mantenuto in estensione dalla contrazione del quadricipite, mentre la caviglia si flette per azione del tibiale anteriore. Terminal stance time, si estende dal 30% al 50% del ciclo del passo. Termina quando l’arto contro laterale tocca il suolo. L’arto ha superato la verticale e il corpo comincia a cadere in avanti, il ginocchio si flette lievemente sotto il suo peso e il centro di gravità si abbassa. Pre swing, si estende dal 50% al 60% del ciclo del passo. Termina con lo stacco dal terreno delle dita dell’arto di interesse. E’ la fase di trasferimento del peso. I muscoli posteriori della gamba entrano in contrazione e producono l’estensione della caviglia e delle articolazioni metatarsofalangee, fornendo una spinta verso l’alto e in avanti. La fase di swing è usualmente suddivisa in tre fasi. Initial swing, si estende dal 60% al 73% del ciclo del passo. Comporta lo spostamento in avanti dell’arto inferiore di interesse subito dopo lo stacco conseguente alla flessione di anca, ginocchio e contemporanea leggera dorsi- flessione del piede. Mid swing, si estende dal 73% al 87% del ciclo del passo. Coinvolge lo spostamento dell’arto interessato da una posizione posteriore al tronco ad una anteriore. Simultaneamente la caviglia si flette per azione del tibiale anteriore e recupera l’estensione che aveva spinto il corpo in avanti alla fine dell’appoggio. Terminal swing, copre l’ultimo intervallo del ciclo del passo. Si ha la continuazione del movimento progressivo dell’arto di 53 interesse ed il completamento dell’estensione del ginocchio e della caviglia in preparazione al successivo contatto con il suolo. 54 CAPITOLO 2 LA POSTURA E IL SISTEMA TONICO POSTURALE La postura è essenzialmente la posizione assunta dalle varie parti del corpo le une rispetto alle altre (sistema di coordinate egocentriche) e rispetto all’ambiente circostante (sistema di coordinate exocentriche). Il terzo sistema di riferimento è quello del campo gravitazionale (sistema di coordinate geocentriche). L’orientamento di una parte del corpo può essere descritto rispetto ad uno di questi sistemi di riferimento a seconda del particolare contesto comportamentale. Per esempio, la conoscenza della posizione del capo rispetto all’ambiente è importante per stabilizzare la visione, mentre la conoscenza della sua posizione rispetto alle altre parti del corpo lo è per il mantenimento della postura eretta. La regolazione della postura rispetto alla forza di gravità è naturalmente fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio posturale, che può essere definito come quella condizione in cui tutte le forze che agiscono sul corpo sono bilanciate, quindi il corpo rimane nella posizione che intende assumere (equilibrio statico) o è in grado di eseguire il movimento che intende compiere senza perdere l’equilibrio (equilibrio dinamico). (Kandel 2003) E' possibile localizzare infatti, un punto in cui si può applicare una singola forza che equivale, per intensità, al peso del corpo e che agisce verticalmente verso l'alto, in modo da conferire al corpo equilibrio in ogni posizione. Questo punto è detto centro di gravità o baricentro, che può essere descritto come il punto in cui si pensa sia concentrato tutto il peso 55 del corpo. La postura standard in stazione eretta è rappresentata dal prolungamento della linea verticale o di gravità all’interno del piano di appoggio (data da un poligono di forma quasi trapezoidale costituito dal profilo laterale dei piedi e dalle due linee che costituiscono rispettivamente la parte anteriore e posteriore dei piedi) passante sul piano sagittale e frontale (fig. 1). Attorno alla linea di gravità il corpo è ipoteticamente in una posizione di equilibrio che implica una distribuzione uniforme del peso del corpo ed una posizione stabile di ogni articolazione. FIG. 2.1 2.1 Il controllo dinamico della postura L’Uomo non fa altro che “stare dietro” al proprio equilibrio, manifestando la tendenza a tornare verso la propria “posizione di equilibrio”, creando così una propria stabilità posturale (Gagey, 1988). 56 FIG. 2.2 Secondo il “modello biomeccanico del pendolo invertito” (fig. 2) l’Uomo in situazione posturale eretta presenta movimenti oscillatori anteroposteriori. La postura eretta può essere mantenuta anche con posizioni differenti del corpo o di alcuni segmenti corporei, purchè il baricentro (centro di gravità) si proietti a terra nell’area del poligono di sostentamento (fig. 1). 57 Il controllo della postura eretta può organizzarsi in due modalità principali che, in condizioni naturali, si integrano: 1. Controllo dell’allineamento verticale dei segmenti corporei rispetto alla verticale gravitaria, lungo l’asse immaginario che unisce il capo all’area d’appoggio plantare, con rispetto della geometria corporea. 2. Controllo della posizione del baricentro, senza rispetto della geometria corporea. Queste modalità corrispondono a quanto descritto da Nashner, ovvero le strategie di caviglia e d’anca: • Quando il soggetto in stazione eretta viene perturbato in avanti oppure indietro dallo spostamento della superficie di supporto nella direzione opposta (ad esempio quando inizia a muoversi il tram), l’attivazione muscolare origina nei muscoli dell’articolazione delle caviglie e si irradia in sequenza verso i muscoli inferiori del tronco. Questo pattern viene chiamato strategia di caviglia, perché corregge le oscillazioni esercitando una torsione rispetto alla superficie di supporto e una rotazione del corpo verso l’indietro, primariamente attorno alle articolazioni di caviglia. La strategia usa la torsione attorno alle articolazioni della caviglia per resistere alla forza di gravità e ruotare il corpo come una massa relativamente rigida. La torsione attiva sulla caviglia muove il centro di gravità in distanze relativamente lunghe verso una nuova posizione di equilibrio. Poiché il momento di inerzia del corpo sulle caviglie è relativamente grande, solo movimenti lenti del centro di gravità possono 58 essere eseguiti usando la strategia di caviglia. • Quando il soggetto è in piedi su una superficie d’appoggio più corta della lunghezza dei piedi, o quando il centro di gravità si localizza in prossimità dei limiti di stabilità, oppure quando la perturbazione dell’equilibrio del soggetto è troppo ampia o veloce (ad esempio una spinta), si attivano inizialmente i muscoli inferiori della schiena in modo da opporsi allo spostamento del corpo. Questo pattern si chiama strategia di bacino. Essa corregge le oscillazioni esercitando una forza contro la superficie d’appoggio e ruotando il corpo primariamente attorno alle articolazioni delle anche. Questa strategia usa rotazioni rapide orizzontali attorno alle anche per generare forze transienti orizzontali. Poiché il momento d’inerzia del tronco è piccolo rispetto al corpo, a livello pelvico la strategia di bacino produce movimenti rapidi in avanti ed indietro del centro di gravità. Le distanze lungo le quali può essere mosso il centro di gravità con questa strategia sono relativamente piccole, in confronto a quelle prodotte dalla strategia di caviglia. L’utilizzo di una strategia piuttosto che dell’altra è funzione delle condizioni e dei compiti posturali. In età avanzata, in patologie del movimento o dell'equilibrio può prevalere la strategia d'anca, ma questo è poco "economico" dal punto di vista energetico e poco vantaggioso per l'equilibrio. E' bene chiarire che non esiste una postura ma un numero infinito di posture: esse corrispondono a qualsiasi "posizione in equilibrio". Per ogni 59 individuo la postura ideale è quella nella quale i segmenti corporei sono equilibrati nella posizione di minimo impegno e massima stabilità. 2.2 La postura ideale FIG. 2.3 Nella veduta laterale, la linea di riferimento standard rappresenta la proiezione della linea di gravità nel piano frontale, che divide ipoteticamente e asimmetricamente il corpo in una porzione anteriore e in una posteriore di peso equivalente come segue: • parte dal trago in prossimità dei condili occipitali sino a toccare l’apofisi odontoidea di C2, la testa si presenta eretta in posizione ben equilibrata senza tensioni muscolari. 60 • passa davanti alla colonna dorsale, leggermente convessa posteriormente con le scapole ben allineate e appiattite contro il torace. Si mantiene in una posizione che favorisce la funzione ottimale degli organi della respirazione, influenzata dalla struttura della colonna lombare e del bacino che è indice di buon allineamento dell’addome, del tronco e degli arti inferiori. • incrocia la colonna lombare a livello di L3, leggermente convessa anteriormente. • passa dietro le ultime vertebre lombari, davanti al sacro. • leggermente indietro rispetto la cavità cotiloidea con le anche né flesse né estese. Si prende in considerazione la posizione delle spine iliache antero-superiori che devono essere allineate sullo stesso piano orizzontale e sul piano verticale con la sinfisi pubica. • segue l’asse del femore e passa davanti all’articolazione del ginocchio (né flesso né iperesteso), della tibia e dell’articolazione tibiotarsica in avanti rispetto al malleolo esterno con la gamba perpendicolare alla pianta del piede. • termina a livello dell’articolazione calcaneo-cuboidea. Nella veduta posteriore la linea di riferimento standard rappresenta la proiezione della linea di gravità nel piano sagittale, che divide ipoteticamente e simmetricamente il corpo in due porzioni laterali come segue: 61 • passa nel piano antero-posteriore lungo la linea mediana del cranio, dello sterno, delle apofisi spinose della colonna. • le spalle non sono elevate né depresse e le scapole hanno i margini mediali paralleli ed equidistanti. • Proseguendo attraversa la linea mediana del bacino che rimane orizzontale, con le spine iliache postero-superiori sullo stesso piano trasversale. • le anche non sono né addotte né abdotte. • gli arti inferiori sono dritti senza valgismi o varismi. • termina a metà distanza tra i due appoggi podalici. La statica normale può essere definita secondo questi criteri di valutazione. Solo un 10% circa della popolazione però rientra in questi parametri, ed è rappresentata da quei soggetti che manifestano raramente sintomatologia dolorosa. 2.3 Le azioni muscolari La più recente e completa classificazione suddivide i muscoli in tre categorie: stabilizzatori locali (più profondi), stabilizzatori globali e mobilizzatori globali (più superficiali). • Gli stabilizzatori locali hanno la funzione principale di mantenere una forza minima continua in tutte le posizioni dell’ampiezza di movimento dell’articolazione e in tutte le sue possibili direzioni. Questa attività serve a controllare l’eccessivo movimento fisiologico e traslatorio. L’attività di questi muscoli aumenta, in modo anticipatorio, già prima di un carico o di 62 un movimento, consentendo così di proteggere e sostenere l’articolazione. La loro contrazione non produce movimento: hanno un’attività indipendente dalla direzione del movimento e continua durante tutto il movimento, fornendo un input propriocettivo sulla posizione articolare e il movimento stesso. • Gli stabilizzatori globali hanno la duplice funzione di generare movimento, provvedendo al controllo eccentrico dell’escursione articolare durante tutto il range anatomo-fisiologico, e alla decelerazione dei movimenti con carico minimo (rotazione), particolarmente a livello del tronco e dei cingoli. La loro attività non è continua ed è dipendente dalla direzione del movimento. • I mobilizzatori globali hanno la funzione principale di produrre ampiezza di movimento; la loro contrazione produce una variazione di lunghezza e un’accelerazione concentrica del movimento (flessione/estensione); contribuiscono inoltre ad assorbire lo choc da carico. La loro attività non è continua ed è dipendente dalla direzione del movimento. Lo studio sulle effettive competenze dell’attività muscolari risulta significativo per l’impostazione di un corretto esercizio terapeutico , che per essere veramente funzionale deve rispettare la fisiologia dei gruppi muscolari e correggere in modo più esatto e senza compensazioni le anomalie di tonicità e di lunghezza muscolare che il soggetto presenta. 63 2.4 Le catene muscolari La priorità dell’uomo è essenzialmente quella di assumere e mantenere per lungo tempo la stazione eretta nel modo più economico e confortevole possibile. Esaminando la posizione della linea di gravità a livello cefalico (passante attraverso il foro occipitale e con il peso distribuito per i 2/3 in avanti e 1/3 dietro) e a livello plantare (passante per il cuboide), si nota un netto squilibrio da cui possiamo dedurre che l’uomo in stazione eretta non è mai in equilibrio, ma in sbilanciamento anteriore con continue oscillazioni e aggiustamenti posturali. Occorreranno forze maggiori per perdere l’equilibrio indietro, e lo squilibrio anteriore produrrà anche una padronanza migliore delle instabilità laterali, rimandando le tensioni statiche alla parte posteriore del soggetto. Nel normotipo i muscoli anteriori e posteriori inseriti sul bacino lo mantengono in allineamento, i muscoli addominali tirano verso l’alto e i flessori dell’anca verso il basso. Posteriormente i muscoli dorsali tirano verso l’alto e gli estensori dell’anca verso il basso, di conseguenza gli addominali e gli estensori lavorano in sinergia inclinando il bacino posteriormente, mentre i lombari e i flessori dell’anca agiscono insieme inclinando il bacino anteriormente. Da alcuni principi della statica apprendiamo che esiste sia un equilibrio statico, che permette di mantenere il corpo in una posizione statica, sia un equilibrio dinamico che consente ai segmenti corporei di raggiungere una condizione di stabilità. La difficoltà di mantenere un buon equilibrio dipende molto dal rapporto tra l’altezza del 64 baricentro e l’ampiezza della base d’appoggio podalico. I 2/3 della nostra muscolatura più fibrosa, resistente, più in profondità, di forte tono, è costituita da muscoli della statica o tonici (antigravitari o posturali) che ci garantiscono, con la loro continua contrazione, la stabilità in stazione eretta e negli spostamenti. I muscoli della dinamica o fasici (deputati al movimento), più superficiali e con scarsa resistenza allo sforzo, invece, non sono indispensabili per il mantenimento della postura in quanto, terminata la loro contrazione, ritornano nel loro stato di quiete. Per questo motivo nei casi di deviazioni o deformazioni vertebrali una delle cause principali è sicuramente una differenza di tensione fra i muscoli statici e mai tra quelli dinamici. I muscoli sono fra loro embricati, organizzati in catene muscolari ed in relazione con il tessuto connettivale, formando un unico sistema miofasciale. FIG. 2.4 65 Correlazione fra le diverse catene: Catene muscolari del tronco. • La catena statica posteriore. • Le catene rette anteriori che producono la flessione. • Le catene rette posteriori che producono l’estensione. • Le catene crociate anteriori che producono le torsioni anteriori (fig. 5). • Le catene crociate posteriori che producono le torsioni posteriori (fig. 7). Queste catene muscolari del tronco sono in relazione con quelle degli arti inferiori. • La catena statica continua fino alla volta plantare. • Le catene rette anteriori diventano catene di flessione. • Le catene rette posteriori diventano catene d’estensione. • Le catene crociate anteriori diventano catene di pronazione o di chiusura. • Le catene crociate posteriori diventano catene di supinazione o di apertura (fig. 6, fig. 7). Tutte le catene muscolari si allacciano a livello del diaframma (L. Busquet). 66 FIG. 2.5 FIG. 2.6 FIG. 2.7 Per riuscire a mantenere la stazione eretta per tempi prolungati, il corpo, utilizza le soluzioni statiche più economiche. Le catene muscolari ci permettono di programmare il movimento nel soggetto, ma per ottenere un buon funzionamento di esse, è necessario la presenza di unità del corpo, intesa come funzionalità globale per assicurare il riequilibrio intorno alla linea di gravità. Non c’è un equilibrio perfetto. La “torre umana”(Souchard) è infatti in squilibrio anteriore: questo determina tensioni statiche alla parte posteriore del soggetto. 2.5 La necessità e le difficoltà di una “Buona Postura” L’assunzione di una postura corretta è una buona abitudine che contribuisce al benessere della persona. La struttura e la funzione del corpo forniscono tutte le potenzialità per il raggiungimento ed il mantenimento di una 67 postura appropriata. Viceversa, l’assunzione di una postura scorretta è una cattiva abitudine, la cui incidenza tra la popolazione è purtroppo alta. I difetti posturali hanno origine dall’impiego non corretto delle potenzialità del corpo e non dalla struttura e funzione di un corpo normale. Se la postura difettosa fosse solo un problema estetico, ci si potrebbe limitare a preoccuparsi dell’aspetto. Tuttavia, la persistenza di questi difetti posturali può determinare l’insorgenza di disagio, dolore o invalidità, a seconda della durata o della gravità di tali problemi. I modelli culturali della civiltà moderna si aggiungono agli stress già a carico delle strutture fondamentali del corpo umano, imponendo un’attività sempre più specializzata e limitata. E’ necessario creare delle influenze che compensino questa situazione in modo da raggiungere una funzione ottimale nelle condizioni imposte dal nostro stile di vita. Negli adulti, l’incidenza di difetti posturali è legata a questa tendenza verso un modello di attività altamente specializzata o ripetitiva. La correzione di queste condizioni dipende dalla comprensione delle influenze che ne sono la causa e nell’attuazione di un programma di misure di prevenzione ed informazione. La buona postura è quindi rappresentata da un buon equilibrio muscolare e scheletrico che protegge le strutture portanti del corpo da una lesione o da deformità. In queste situazioni i muscoli lavorano in modo efficace e gli organi toracici e addominali si trovano in posizione ottimale, al contrario di 68 quanto accade in una postura scorretta, dove le relazioni tra le parti del corpo sono alterate e producono aumenti di tensione. Possiamo sintetizzare il costrutto di postura con le parole di Kendall: “Generalmente, la postura viene definita come la disposizione delle parti del corpo. Una buona postura è quello stato di equilibrio muscolare e scheletrico che protegge le strutture portanti del corpo da una lesione o da una deformazione progressiva malgrado la posizione in cui queste strutture lavorano od oppongono resistenza. In queste condizioni i muscoli lavoreranno in modo più efficace. La postura è cattiva quando si ha una relazione scorretta delle varie parti del corpo che produce un aumento di tensione sulle strutture portanti e quando l’equilibrio del corpo sulla sua base di appoggio è meno efficiente.” 2.6 Le anomalie podaliche come principali fattori nello squilibrio posturale Il piede è il punto fisso al suolo su cui grava l'intero peso del corpo. Esso si trova alla base del sistema di controllo antigravitario (sistema posturale o di 69 equilibrio) che consente all'uomo di assumere la postura eretta e di spostarsi nello spazio. Il piede è sia un effettore sia un ricettore ossia riceve ed esegue dei comandi (risposta motoria), tramite i muscoli, e, nel contempo, interagisce col resto del corpo sia attraverso il sistema miofasciale sia fornendo costanti cutanei presenti informazioni sulla sua provenienti pianta e dagli esterocettori dai propriocettori dei suoi muscoli, tendini e articolazioni. Gli esterocettori cutanei del piede sono ad alta sensibilità (0,3 g) e rappresentano l'interfaccia costante tra l'ambiente e il sistema tonico posturale o dell'equilibrio. Le informazioni plantari infatti sono le uniche a derivare da un recettore sensoriale fisso a diretto contatto col suolo. Il riflesso plantare (flessione delle dita al graffiamento della pianta), legato alle stimolazioni cutanee della pianta del piede, è in grado di attivare e modulare riflessi molto complessi con funzioni posturali di notevole importanza. Pertanto il piede è considerato il principale organo di senso e di moto antigravitario del corpo umano, come si denota nelle rappresentazioni motorie e sensitive dell'homunculus. Per questo motivo il piede, nelle popolazioni dei paesi sviluppati che vivono su un terreno poco fisiologico quale è il terreno piano, è normalmente l'origine dello squilibrio posturale. Nello stesso tempo esso è anche l'elemento adattativo che tampona, meglio che può, gli squilibri alti, in genere discendennti dall'apparato stomatognatico (denti e articolazione temporomandibolare) e/o dagli occhi e/o dal vestibolo. Nella disfunzione osteopatica podomeccanica l'assimilazione piede- elica costituisce sempre il riferimento di base ai fini di un'adeguata 70 elaborazione diagnostica e programmazione terapeutica. Nel prendere contatto con la superficie di appoggio, infatti, il piede acquisisce il significato di dispositivo ammortizzante, in grado di assorbire e neutralizzare le forze e i momenti di forza applicati istantaneamente sotto forma di urto, al fine di tutelare la propria integrità. Il piede riesce a realizzare ciò grazie al suo svolgimento elicoidale graduale; mentre avvolgendosi realizza l'azione antigravitaria. Si tratta di interventi che impegnano al massimo il piede, prova ne è la frequenza delle manifestazioni podo-patologiche da ipersollecitazione (metatarsalgia, neuroma di Morton, spina calcaneare, callosità ad esempio), per gradi anche modesti di alterazione posturale che rendono il piede inadatto a regolare il rapporto fra forze interne ed esterne. Quanto più è rapido l'impatto tanto più è probabile il danno alla struttura podalica (da cui l'inadeguatezza di attività quali la corsa o i salti prolungati nel tempo). Rivolgendo l'attenzione alle superfici (terreni piani) e agli involucri (scarpe) con cui il piede viene a contatto, fin dai primi passi e per tutta la vita, spesso inadatti ma che la civiltà e la moda ci impongono (per la forma senza riguardi per la sostanza ovvero per la salute), il rapporto fra informazione genetica, rivelata dalla morfostruttura originaria, e l'informazione ambientale, invece di un armonico incontro assume gli aspetti di una disputa alla quale, nelle età successive, si risale attraverso i segni lasciati nel piede e nella postura. L'insufficienza gravitaria primaria scaturisce da anomalie dell'integrazione informativa genetica-ambientale e si esprime usualmente come inattitudine dell'elica podalica a svolgere 71 fisiologicamente il suo compito. Il piede piatto (ritenuto fisiologico fino a circa 6 anni di età), risulta abitualmente da una carenza di irrigidimento per difetto di rotazione dei segmenti anteriori all'astragalo (l'elica podalica si avvolge in maniera insufficiente) dando luogo, in successione cronologica, a cedevolezza nel piede infantile, piede valgo-piatto nell'adolescenza e piede piatto artrosico nell'adulto. Al contrario, nel piede cavo avremo un eccesso di rotazione (pronazione) dei segmenti anteriori all'astragalo (e quindi un difetto di rilasciamento e un'eccessiva elicatura podalica). Occorre considerare che l’organismo reagisce di norma sul terreno piano cercando di aggrapparsi ad esso cavizzando il piede (lo stesso motivo favorisce l'alterazione in dita a martello o a griffe o ad artiglio). Data la comune asimmetria posturale, si riscontrano di frequente atteggiamenti diversi dei due piedi. La baropodometria, in statica e in deambulazione, risulta uno strumento di estrema importanza per la corretta valutazione del piede piatto/cavo. Ulteriore frequente disfunzione osteopatica podalica è l'alluce valgo, che è accompagnata da lussazione dei relativi ossi sesamoidi ed esostosi laterale della I testa metatarsale (ricoperta da callosità per il continuo sfregamento con la calzatura). Le cause dell'alluce valgo sono da ricercarsi nei carichi squilibrati sul piede, in modo particolare sull'avampiede durante la fase propulsiva del passo, a cui si aggiunge il contributo di scarpe inadeguate (tacchi alti, punta stretta) e della predisposizione genetica. Non va trascurato il fatto che il piede è anche un organo di senso, ossia 72 porta di ingresso degli stimoli ambientali. Di conseguenza, le anomalie strutturali del piede non solo rendono precaria la risposta motoria (ovvero l'avvolgimento dell'elica) ma sono anche ragione di ostacolo alla ricezione corretta della stimolazione ambientale. La ricettività dei recettori gravitari, presenti in gran numero nei muscoli e nelle formazioni articolari e aponeurotiche del piede, risulta alterata essendo anomali la disposizione e la condizione circolatoria dei tessuti che li ospitano. I legamenti (legamento deltoideo, legamento calcaneo-scafoideo plantare, legamento interosseo ecc.) e le formazioni muscolo-tendinee(nel piede piatto ovvero nel difetto di avvolgimento dell'elica podalica, in particolare, il tibiale posteriore, il flessore lungo dell'alluce e il flessore lungo delle dita, essendo strutture che controllano la pronazione), infatti, sono sollecitati da tensioni abnormi. Come conseguenza di ciò, il circuito di controllo della gravità risulta almeno parzialmente occluso. Risulta chiaro che un appoggio non corretto può far sentire le conseguenze a caviglia, ginocchio, anca, tutta la colonna vertebrale, fino a interessare il posizionamento del cranio e quindi il apparato occlusale (stomatognatico). Normalizzando la ricezione dell'informazione ambientale, ne risulterà potenziata l'integrazione informativa genetica-ambientale favorendo così l'iter evolutivo. E' evidente la fondamentale importanza della posturologia e di plantari. calzature e pavimenti ergonomici quale supporti idonei a prevenire e correggere le anomalie dell'appoggio plantare e quindi posturali. Il 90% degli individui infatti, presenta un atteggiamento posturale viziato. 73 Si possono notare meglio questi squilibri analizzandoli nei tre piani dello spazio: il piano antero posteriore, il piano frontale e il piano orizzontale. 1) NEL PIANO ANTERO POSTERIORE Sono da prendere in esame 5 parametri principali: • Piano scapolare • Piano gluteo • Freccia cervicale (da 6 a 8 cm dal piano posteriore) • Freccia lombare (da 4 a 6 cm dal piano posteriore) • Distanza occipite/piano posteriore (non più di 2 dita trasverse) FIG. 2.9 Solo la figura A è considerata normale; mentre quattro sono considerati gli squilibri statici principali: 74 a) piano scapolare e glutei allineati con aumento frecce b) piano scapolare posteriore c) piano scapolare anteriore d) piano scapolare e glutei allineati con diminuzione delle frecce In associazione con le anomalie podaliche: a) L’aumento delle curve (B) è il compenso dei piedi valghi b) La diminuzione delle curve (E) è il compenso dei piedi vari c) Il piano scapolare posteriore (C) è il riflesso dei piedi piatti d) Il dorso piatto, piano scapolare anteriore (D) è quello dei piedi a doppia componente 2) NEL PIANO FRONTALE Si noteranno più facilmente squilibri a livello dei cingoli scapolare e pelvico. Generalmente il disequilibrio del cingolo scapolare nel destrimane risulta con un’inclinazione verso l’alto dalla parte sinistra, mentre nel mancino avviene l’esatto contrario (fig. 14). Inoltre, solitamente, un’anomalia podalica causativa provoca uno squilibrio del bacino inverso a quello delle spalle. 75 FIG. 2.10 3) NEL PIANO ORIZZONTALE Si notano rotazioni delle spalle e del bacino con tensioni in rotazione o in torsione. Si parla quindi di: • ileo anteriore o posteriore • scapola anteriore o posteriore La lateralità del cingolo scapolare è fortemente influenzato dalla lateralità (fig. 15), mentre per ciò che concerne le rotazioni di bacino, esse possono presentarsi nello stesso senso di quelle delle spalle o in senso opposto (fig. 16). FIG. 2.11 FIG. 2.12 2.7 Le alterazioni nel piede e le conseguenze posturali 76 Una deformazione o un’asimmetria qualsiasi si ripercuoterà sempre a monte e come conseguenza ci sarà un adattamento del sistema posturale. Il piede è il punto d’unione tra uno squilibrio d’origine alta e il suolo: esso si adatterà sempre per riarmonizzare l’appoggio come tampone terminale del sistema posturale. Nell’ambito delle problematiche posturali, il piede può presentarsi in tre modi diversi: • come elemento causativo: quando è responsabile dello squilibrio posturale che provoca la sua disfunzione osteopatica. • come elemento adattativo: quando tampona uno squilibrio che viene dall’alto (generalmente dagli occhi e dai denti); in un primo tempo l’adattamento è reversibile poi si fissa, alimentando lo squilibrio posturale sottostante. • come elemento misto: quando presenta contemporaneamente un versante adattativo e un versante causativo. Tra le anomalie podaliche più frequenti troviamo il piede piatto valgo, il piede cavo varo e il piede a “doppia componente”: 2.7.1 Il piede piatto valgo E’ caratterizzato da un indebolimento, da un cedimento e da una caduta dell’arco plantare interno, provocati essenzialmente da una lassità legamentosa anomala. Si associa a valgo calcaneare, ad una rotazione interna della gamba e della 77 coscia, ad un’apertura del bacino, ad un antiversione iliaca e ad un aumento delle curve fisiologiche del rachide. Si presenterà quindi un accorciamento delle catene muscolari posteriori e il rilasciamento di quelle anteriori. Questo tipo di piede sarà accompagnato, come detto, da una iperlordosi lombare e da una ipercifosi dorsale: quindi, più il piede sarà piatto e più il piano scapolare tenderà a posteriorizzarsi. FIG. 2.13 2.7.2 Il piede cavo varo È caratterizzato da un talo varo con caduta astragalo-calcaneare esterna, che provoca una rotazione esterna degli assi tibiale e femorale, con tendenza al ginocchio varo e iperpressione rotulea. Si associa a varo calcaneare, ad una rotazione esterna della gamba e della coscia e quindi del femore, ad un a retroversione iliaca e ad una diminuzione della lordosi lombare. 78 FIG. 2.14 2.7.3 Il piede a doppia componente Rappresenta il piede dell’uomo moderno ed è caratterizzato da uno squilibrio del sistema posturale che si manifesta clinicamente. Nella statica può risultare patologico oppure no, ma lo è sempre nella sua dinamica: il piede, durante il passo, appoggia prima sul bordo esterno del tallone e cade immediatamente in valgo. Si associa essenzialmente a dorso piatto e ad un piano scapolare anteriore, con una proiezione anteriore del centro di gravità. 79 FIG. 2.15 Non sempre si verifica però, simmetria nell’atteggiamento posturale dei piedi. E’ possibile, infatti, trovarsi di fronte ad un’asimmetria o a una disarmonia tra i piedi di uno stesso soggetto: il primo caso si verifica quando appunto, manca simmetria tra i due piedi, ovvero la componente di valgismo o varismo è più accentuata da un lato rispetto all’altro; compaiono quindi solitamente, a livello posturale, bascule e rotazioni. Nel caso della disarmonia tra i due piedi, invece, osserviamo caratteristiche opposte: da un lato notiamo valgismo, mentre al contro laterale è apprezzabile varismo, o viceversa; compaiono quindi, a livello posturale, antiflessione iliaca dal lato valgizzante e estensione dal lato varizzante. Generalmente nei destrimani la tendenza valgizzante è a sinistra, la tendenza varizzante è a destra, mentre nel mancino avviene il contrario. 80 CAPITOLO 3 L’ALLUCE VALGO Il termine “alluce valgo” fu introdotto per la prima volta da Carl Hueter nel 1871 che definì altrimenti l’alluce valgo come la sublussazione della prima articolazione metatarso-falangea associata alla deviazione in valgismo del primo dito con conseguente sintomatologia dolorosa e limitazione della funzionalità del piede. Si definisce valgo l’alluce i cui assi, interfalangeo o metatarso-falangeo, presentano un angolo aperto all’esterno superiore ai limiti considerati fisiologici. L’alluce valgo è una deformità dell’articolazione metatarso-falangea del primo raggio e rappresenta una delle patologie più diffuse del piede. La mole di letteratura sull’argomento è dispersiva e impedisce un’univoca interpretazione e uno schematico inquadramento dell’alluce valgo. Tuttavia ai fini espositivi ritengo utile la seguente classificazione: a) Interfalangeo (o distale) b) Metatarso-falangeo (o prossimale) c) Dell’infanzia d) Dell’adulto L’alluce valgo è classificato come interfalangeo o metatarso-falangeo per differenziare topograficamente il valgismo intervenuto ai due livelli articolari dell’alluce. L’alluce valgo interfalangeo, è caratterizzato da valgismo della falange distale sulla prossimale. Per il disassamento 81 all’esterno dei tendini a inserzione distale (flessore lungo ed estensore proprio) si può avere secondariamente un alluce valgo metatarso-falangeo con sovrapposizione delle due deformità. L’alluce valgo è classificato come dell’infanzia o dell’adulto per differenziare cronologicamente quadri intervenuti prima o dopo la pubertà considerato che ad essa corrisponde il limite superiore dell’infanzia. L’alluce valgo dell’infanzia è molto più raro, quasi sempre bilaterale. Clinicamente, l’alluce è abdotto ma non è pronato a differenza di quanto avviene nell’alluce valgo dell’adulto. Sono state formulate tre ipotesi per spiegare l’eziologia di questa disfunzione osteopatica giovanile: la teoria embriopatica, la teoria fetopatica e la teoria osteogenica. La teoria embriopatica sostiene che la deformità potrebbe essere causata da un’inserzione anomala più dorsale del capo falangeo dell’abduttore dell’alluce e da un’ipoplasia della cresta intersesamoidea. In questo caso la maggior potenza esercitata dal capo falangeo dell’abduttore dell’alluce retratto, associata alla ridotta resistenza ossea opposta dalla cresta ipoplasica, porterebbe al valgismo dell’alluce e al varismo del primo metatarso. La teoria fetopatica fa dipendere la deformità da un viziato atteggiamento intrauterino che porterebbe a un anomalo rapporto della prima articolazione metatarso-falangea, determinando così un alluce valgo primitivo. Questo sarebbe poi responsabile sia della tipica deformità a sella della prima testa metatarsale che del varismo metatarsale causa della deformazione a cuneo dell’epifisi prossimale del metatarso. La teoria della lesione osteogenica attribuisce la genesi della deformità a due possibili 82 meccanismi patogenetici che potrebbero anche coesistere tra loro. Nella prima ipotesi la lesione osteogenica provocherebbe una maggiore crescita (enostosi) laterale, a cuneo, della cartilagine di accrescimento prossimale del primo metatarso, determinando così il varismo del primo metatarso e il valgismo dell’alluce. La seconda ipotesi postula la presenza di un nucleo epifisario accessorio distale. Questa deformità verrebbe così a essere la causa del valgismo dell’alluce e, in un secondo momento, elemento dinamico di spinta in varo del primo metatarso. E’ difficile stabilire quale tra queste condizioni in realtà si realizzi perché non è possibile valutare, con la radiografia, la morfologia del nucleo di accrescimento del primo metatarso prima dei tre anni e anche perché non sempre il quadro radiografico corrisponde al quadro anatomo-patologico. Il termine “alluce valgo”, senza significazione topografica o di periodo di vita, è di comune riferimento all’alluce valgo metatarso-falangeo dell’adulto, senza dubbio il più frequente. Nel corso di questa tesi sarà trattato elettivamente quest’ultimo. L’alluce valgo classico è caratterizzato da: a) varismo del primo metatarso (superiore a 8°) b) deviazione in valgo della falange prossimale del primo dito (superiore a 14°) c) pronazione dell’alluce. 3.1 Classificazione Esiste una classificazione radiografica dell’alluce valgo che lo divide in tre 83 classi di gravità crescente. I criteri radiografici che vengono presi in considerazione sono l’angolo metatarso-falangeo (HVA) e l’angolo intermetatarsale tra primo e secondo metatarso (IMA). L’angolo metatarso-falangeo o angolo di valgismo dell'alluce è formato dall'intersezione dell'asse longitudinale della falange prossimale e il primo metatarso; un angolo di valgismo inferiore ai 15° è considerato normale. L'angolo intermetatarsale tra il primo e il secondo metatarso è formato dall'intersezione dell'asse longitudinale del primo e secondo metatarso; un angolo inferiore ai 9° è da considerarsi normale. Sulla base di queste misurazioni si pu definire: a) Alluce valgo lieve (HVA < 20° e IMA ≤ 13°). b) Alluce valgo moderato (HVA ≥ 20° e < 40° e IMA >13° e ≤20°). c) Alluce valgo grave (HVA ≥40° e IMA >20°). Un secondo aspetto che deve essere considerato a fine prognostico è il grado di artrosi dell’articolazione metatarso falangea. La classificazione radiografica di Coughlin e Shurnas è la più utilizzata per quantificare il grado di artrosi dell’articolazione metatarso falangea. Vengono individuati 5 gradi di artrosi di gravità crescente: • Grado 0: articolazione normale. • Grado 1: osteoaddensamenti, riduzione dello spazio articolare (<50%), osteofiti dorsali e leggero appiattimento della testa metatarsale. • Grado 2: riduzione dello spazio articolare (>50%), osteoaddensamenti, osteofitosi circonferenziale, aspetto irregolare 84 dei sesamoidi • Grado 3: anormalità come nel grado 2 ma con una maggiore riduzione dello spazio • articolare e con la presenza di cisti. • Grado 4: completa scomparsa dell’articolazione metatarso falangea. Un’altra classificazione utile ai fini del trattamento distingue l’alluce valgo come congruente o incongruente. La congruenza della prima metatarso-falangea viene valutata tracciando le linee che sottendono rispettivamente le superfici articolari della testa del primo metatarsale e della base della prima falange. Secondo i criteri di Pigott, se le linee sono parallele, l’articolazione viene definita congruente; se sono convergenti nello spazio intermetatarsale, si definisce deviata; se sono convergenti nella metatarso-falangea si definisce lussata (Fig. 3.1). Un’articolazione congruente è un obiettivo chirurgico indispensabile per giungere ad un buon risultato funzionale. . Fig. 3.1Congruenza 3.1 della MTF1 Vi sono poi numerosi altri angoli che possono essere calcolati nella 85 valutazione dell’alluce valgo. Un’ultima classificazione utile a inquadrare l’alluce valgo riguarda la posizione dei sesamoidi. In base al rapporto tra asse del primo metatarso e sesamoide mediale si distinguono quattro posizioni: • Posizione 1: quando il sesamoide si colloca medialmente all’asse metatarsale. • Posizione 2: quando il sesamoide si colloca medialmente e tangenzialmente all’asse metatarsale. • Posizione 3: quando il sesamoide è attraversato dall’asse metatarsale. • Posizione 4: quando il sesamoide si colloca lateralmente all’asse metatarsale. La posizione 1 e la posizione 2 sono normali, mentre 3 e 4 sono posizioni patologiche, determinate da una progressiva lussazione dei sesamoidi, condizione che si associa ad alluce valgo (Fig. 3.3). 86 Fig. 3.2 Classificazione radiografica dei sesamoidi. 3.2 Epidemiologia Anche se l’alluce valgo ha attirato grande attenzione nella letteratura sia storica che recente, numerosi autori hanno sottolineato la difficoltà di definire con precisione la vera prevalenza di questa disfunzione osteopatica nella popolazione. Negli Stati Uniti è stato stimato che circa lo 0.9% della popolazione generale, indipendentemente dall’età, è affetta da alluce valgo. In Inghilterra invece è stata riportata una prevalenza del 28,4% nella 87 popolazione adulta. Uno studio condotto da Menz e collaboratori nel 2001 mostra una prevalenza del 74% nella popolazione anziana. La disfunzione osteopatica colpisce principalmente la popolazione femminile e anziana ma a causa dell’elevata diffusione della disfunzione osteopatica e del fatto che non tutti i soggetti affetti da tale disfunzione osteopatica si sottopongono a cure mediche è difficile stimare con esattezza la prevalenza della disfunzione osteopatica nella popolazione. Nel 2010 in una meta-analisi pubblicata su Journal of Foot and Ankle Research è stata fatta una revisione di 78 articoli indicizzati su Pubmed considerati rilevanti per fare una stima della prevalenza dell’alluce valgo nella popolazione. I risultati di questo studio mostrano che la prevalenza di alluce valgo nella popolazione compresa tra 18 e 65 anni è del 23% ed è maggiore di 2.3 volte nelle femmine (30%) rispetto ai maschi (13%). Roddy E. e collaboratori nel 2008 riportano una prevalenza del 28,4% nella popolazione compresa tra 40 e 80 anni. Anche in questo caso è stata dimostrata una netta prevalenza nelle donne in cui la disfunzione osteopatica è presente in circa il 38% della popolazione contro il 21% della popolazione maschile. Inoltre è statisticamente significativo che il 21,2% della popolazione generale femminile l’alluce valgo è bilaterale mentre solo nel 17% è monolaterale. Nei maschi invece la prevalenza dell’alluce valgo bilaterale è pressappoco sovrapponibile a quella monolaterale (11% contro 9.3%). 88 3.3 Eziologia e Genesi della disfunzione osteopatica L’alluce valgo metatarso-falangeo dell’adulto riconosce cause estrinseche e intrinseche; tra le prime ricordiamo soprattutto il ruolo delle calzature, infatti l’incidenza di alluce valgo è maggiore in popolazioni abituate ad indossare scarpe, rispetto a popolazioni che non le indossano e la forma delle calzature da donna può spiegare la netta preponderanza di questa disfunzione osteopatica nel sesso femminile. In genere, la forma della scarpa maschile rispecchia quella del piede dell’uomo e questo non causa compressione dell’avampiede, come invece capita nelle calzature femminili, la cui forma non rispecchia le dimensioni del piede e sono in media 1 o 2 cm più strette dell’avampiede. Inoltre, più aumenta l’altezza dei tacchi, più aumenta il carico sull’avampiede spingendo l’alluce sempre più all’interno della punta della scarpa, provocando così una deviazione all’esterno del primo dito e all’interno del quinto. Il primo e il quinto dito quindi spingono le dita centrali, che per mancanza di spazio si lussano dorsalmente e si deformano. E’ stato dimostrato che l’aver portato per lungo tempo scarpe con tacco alto in età giovanile-adulta può dare dei problemi in età avanzata. Tra le cause intrinseche, geneticamente determinate, invece sono state nel tempo citate la familiarità. La morfologia della superficie articolare della testa metatarsale ha un ruolo nello sviluppo di alluce valgo: una testa appiattita è più stabile e resiste maggiormente alle forze deformanti, mentre una testa arrotondata è più suscettibile allo sviluppo di alluce valgo. Il primo metatarso varo per molti autori si sviluppa contestualmente alla 89 deformità ma in alcuni casi può essere considerato il primum movens. Il primo metatarso breve comporta un allargamento del ventaglio metatarsale e quindi facilita lo sviluppo di alluce valgo. Il piede egizio, cioè quel piede in cui l’alluce è più lungo del secondo dito, sembra essere maggiormente soggetto a sviluppare valgismo dell’alluce. Il piede in “cavismo” presenta una più spiccata pronazione del I metatarso mentre, poiché è di solito un piede più rigido, minore è il varismo; il contrario appare nel piede in “piattismo”, di solito associato ad avampiede lasso. Uno dei principali fattori predisponenti all’alluce valgo è la presenza di avampiede addotto, cioè quel piede in cui l’asse longitudinale del retropiede forma con l’asse longitudinale del secondo metatarso un angolo superiore a 15°. Secondo Dragonetti, Root e collaboratori l’anomala pronazione della sottoastragalica, tipica di deformità come il piede piatto e il piede cavo valgo, è la causa principale dell’insorgenza di alluce valgo; l’ipermobilità della prima articolazione cuneo-metatarsale o l’orientamento obliquo di tale articolazione per un incremento dell’angolo metatarsale predispongono all’alluce valgo. Inoltre hanno un’incidenza significativa tutte le anomalie torsionali dell’arto. Ad esempio l’extrarotazione tibiale comporta un compenso in varo del I metatarso poiché questo si traduce sul piano orizzontale in una rotazione interna compensatoria del piede. Secondo alcuni autori anche l’antiversione dell’anca potrebbe cercare compenso nel valgismo dell’alluce; lo specifico assetto torsionale dell’arto inferiore della donna, 90 condizionato anche da diverso assetto del bacino e del rachide può giustificare, forse al di là di altri fattori variamente invocati, la maggior incidenza di alluce valgo nel sesso femminile. Vengono definiti come secondari gli alluci valghi insorti successivamente a disfunzione osteopatica di altre dita, o ad altra disfunzione osteopatica dell’avampiede o sovrasegmentaria. Più propriamente dovrebbero essere definiti “valgismi dell’alluce”. Patologie neuromuscolari (paralisi muscolari, contratture, spasticità) possono provocare la comparsa di alluce valgo determinando l’anomala pronazione del piede così come le malattie genetiche dei tessuti mesenchimali (Sindrome di Marfan, la malattia di Ehlers-Danlos, la lassità legamentosa generalizzata, la sindrome di Down); in queste condizioni un ruolo fondamentale è svolto dalla lassità legamentosa e dalla compromissione delle strutture capsulari. I traumi possono essere causa di alluce valgo secondario come esito di fratture. Per quanto riguarda le patologie di altre dita, la deviazione in valgo dell’alluce può intervenire secondariamente a deformità a martello del 2° dito o a una sua griffe congenita o acquisita (2° dito lungo in un piede “greco”): in entrambi i casi il dito tende a portarsi spontaneamente sovraddotto e l’alluce tende a disporsi al di sotto di esso avviando una secondaria deformità in valgo. Analogo processo si può sviluppare come complicanza nell’amputazione del II dito di cui l’alluce va a occupare il vuoto residuo. 91 A distanza dalla formazione di un valgismo dell’alluce, post traumatico o ex vacuum, si sviluppa anche il varismo del metatarso; con la deviazione in valgo del primo dito, la trazione del muscolo adduttore dell'alluce provoca una deviazione laterale della base della falange prossimale sulla testa del metatarso, che spinge il primo metatarso in varo. La capsula mediale s’indebolisce e le strutture laterali si retraggono. Il legamento metatarsale trasverso ancora i sesamoidi al secondo metatarso e per questo i sesamoidi rimangono in posizione durante i movimenti mediali della testa del primo metatarso, appiattendo la cresta. Il risultato è un’alterazione meccanica della prima articolazione metatarso-falangea, con formazione di un’eminenza mediale prominente, sublussazione laterale della base della falange prossimale, dissociazione del complesso metatarsosesamoidi, pronazione dell’alluce e aumento dell’angolo compreso fra il primo e il secondo metatarso. 3.4 Anatomia disfunzionale L’anatomia disfunzionale dell’alluce valgo fa riferimento a lesioni scheletriche, articolari e delle parti molli (tendini, legamenti, capsula, cute e sottocute) alle quali si possono aggiungere lesioni associate alle altre dita. Le lesioni scheletriche sono rappresentate dall’esostosi e dalla deviazione, assiale e rotatoria, del 1° metatarso e della falange basale dell’alluce. L’esostosi è sviluppata alla faccia mediale del 1° metatarso, in corrispondenza dell’inserzione del legamento laterale interno dell’articolazione metatarso-falangea, come rilievo più o meno voluminoso 92 costituito da osso rimaneggiato talora comprendente formazioni geodiche ripiene di tessuto fibro-adiposo che possono essere coperte da neocartilagine irregolare. La prominenza mediale della testa metatarsale, oltre che dal tessuto esostosico, è anche dovuta all’ipertrofia della parte mediale della testa che non è più coperta da parte della falange basale dell’alluce, sublussata lateralmente; un solco ben evidente, che chirurgicamente rappresenta il limite della buniectomia, la separa dal versante cartilagineo cefalico del 1° metatarso. La falange basale dell’alluce, pronata e valga, rispecchia il quadro clinico, come il varismo del 1° metatarso rispecchia il quadro radiografico. I sesamoidi sono disposti lateralmente alla testa del 1° metatarso, talora il laterale è interposto nello spazio tra 1° e 2° metatarso. E’ la cosiddetta “lussazione dei sesamoidi”: in effetti non sono i sesamoidi a muoversi, ma è la testa metatarsale che ha perso il rapporto di congruenza dislocandosi in varo e la migrazione intermetatarsale del sesamoide laterale è da considerarsi “ex vacuo”. Secondaria è la retrazione delle strutture di stabilizzazione del sesamoide laterale; la lisi di questo dal collo del metatarso è pertanto tempo chirurgico indispensabile al recupero dei normali rapporti metatarso-sesamoidei. Inferiormente al condilo interno della testa del 1° metatarso e sulle superfici articolari sesamoidee è possibile mettere in evidenza alterazioni degenerative ed usura della cartilagine di rivestimento. Le superfici articolari metatarso-falangee con il tempo sviluppano gravi lesioni degenerativo-strutturali. Anche se il quadro anatomo-patologico 93 delle lesioni scheletriche tende nel tempo ad aggravarsi, evolvendo di solito nel volgere di anni, talora può manifestare un brusco peggioramento, espressione di disfunzione osteopatica degenerativa capsulo-legamentosa o di insufficienza muscolare (peroneo lungo). Le lesioni osteoarticolari si accompagnano a importanti alterazioni delle parti molli (tendini, capsula, legamenti, cute e sottocute). Il tendine dell’estensore proprio dell’alluce è dislocato lateralmente, disposto a corda tra i due segmenti scheletrici in valgo e appena ancorato medialmente da qualche bandelletta fibrosa traccia delle strutture di stabilizzazione; parimenti i tendini che s’inseriscono sulla glena sesamoidea (adduttore, abduttore, flessore breve dell’alluce) e il flessore lungo dell’alluce, solidale con la glena, sono tutti disassati lateralmente. Il disassamento anatomico all’esterno dell’apparato tendineo proprio del 1° raggio, fa in modo che i muscoli corrispondenti diventano tutti concorrenti alla valgizzazione dell’alluce. Questo processo rappresenta un componente fondamentale nel circolo vizioso che interviene all’aggravamento della deformità. L’apparato capsulo-legamentoso dell’articolazione metatarso-falangea dell’alluce è accorciato e retratto lateralmente mentre appare disteso e assottigliato medialmente, in particolare in corrispondenza dell’inserzione del legamento collaterale Fig.3.4 Azione dei patogenesi e dell’alluce interno. 94 muscoli legamenti valgo. A livello dell’esostosi la cute, per frizione con la calzatura, si presenta ispessita e discheratosica; una callosità è spesso presente al bordo interno della falange distale dell’alluce per la pronazione del dito. A questo livello può essere presente una borsite che, da semplice reazione congestizia può acquisire caratteristiche d’infiammazione cronica. Spesso è presente, come lesione associata la griffe del 2° dito o dito a martello. A livello cutaneo si osserva callosità e discheratosi in corrispondenza dell’articolazione interfalangea e plantarmente callosità tipiche dell’alluce valgo con sovraccarico metatarsale. alla sua falange distale. In questi casi è quasi sempre presente sovraccarico sulla testa del 2° metatarso con ipercheratosi e callosità in corrispondenza della superficie plantare della testa stessa (Fig. 3.5) Nel 2° dito in griffe la falange prossimale del dito è sublussata o lussata dorsalmente, con retrazione dei tendini di estensore comune delle dita e pedidio; l’apparato capsulo-tendineo metatarso-falangeo presenta un aspetto degenerativo con sinovia ipertrofica, ispessita e grigiastra. Le superfici articolari possono apparire degenerate e la base della falange deformata dall’usura del suo versante articolare inferiore. 3.5 Clinica L’alluce valgo è una disfunzione osteopatica a evoluzione progressiva. Il quadro clinico è caratterizzato da tre componenti che intervengono come modificazioni assiali e 95 Fig.6 Abduzione pronazione e dell’alluce, rotatorie a livello della articolazione metatarso-falangea: abduzione e pronazione dell’alluce e varismo del 1° metatarso (Fig. 3.6). Il valgismo dell’alluce, fisiologico entro i 15°, può superare i 40°-45°; in casi estremi l’alluce è disposto trasversalmente a cavaliere delle altre dita. La pronazione può essere di 45° in rapporto al piano di appoggio. Medialmente è evidente la prominenza paracefalica del 1° metatarso sovente ricoperta da cute discheratosica e talora con formazione borsitica, anche ulcerata. Spesso si associa un sovraccarico sulla testa dei metatarsi laterali legati a insufficienza varismo del 1° metatarso. Nel tempo si sviluppano deformità a carico del 2° dito, diverse in rapporto al fatto che l’alluce venga a disporsi ventralmente o dorsalmente ad esso. Nel primo caso (2° dito sovraddotto) la falange prossimale del 2° dito si verticalizza mentre la media e la distale si orizzontalizzano, ponendosi su di un piano più dorsale rispetto alle altre dita; il polpastrello riposa sul versante laterale dell’alluce pronato. Nel secondo caso invece (2° dito infraddotto) le falangi media e distale sono flesse ed è il polpastrello dell’alluce che appoggia su di esse. In entrambi i casi comunque si ha nel tempo la progressiva lussazione dorsale, presto irriducibile, del 2° dito. Sulla base delle alterazioni morfo-strutturali sopraelencate il quadro clinico che si delinea è dominato dal dolore e dalla deformità. Il dolore soggettivamente riferito a livello esostosico, è di solito inizialmente legato all’uso di calzature; successivamente può essere costante e talora acuto per il sovrapporsi di componente infiammatoria da 96 borsite reattiva. Talora la deambulazione è limitata e precauzionale, con piede in supinazione. Alla sintomatologia dolorosa sulla testa del 1° metatarso può accompagnarsi anche dolore in corrispondenza della callosità mediale alla falange distale dell’alluce (pronazione dell’alluce), dolore all’articolazione interfalangea prossimale del 2° dito (sovraddotto), al polpastrello di 2° dito (infraddotto) e sulla superficie plantare delle teste dei metatarsi centrali (sovraccarico). L’avampiede diventa più largo per la deviazione in varo del 1° metatarso e più alto per la deformità a martello del 2° dito; questo, associato alla sintomatologia dolorosa, crea un piede che mal si adatta alle comuni calzature in commercio. Spesso in questi soggetti il problema estetico è ben più importante delle manifestazioni dolorose, specialmente nelle giovani donne. Infatti, mentre alcuni soggetti tollerano anche psicologicamente la loro deformità adattando a essa la calzatura, molti mal sopportano di non poter utilizzare calzature legate a un particolare tipo di vita lavorativa o sociale. Abbiamo stimato che un’alta percentuale di donne giovani vanno incontro all’intervento in assenza o con modesto dolore, lo scopo della chirurgia in questi casi è esclusivamente estetico. Trattandosi di una disfunzione osteopatica a carattere evolutivo, è possibile suddividere l’alluce valgo in quattro stadi clinici: Nel primo stadio si ha una sublussazione laterale della falange prossimale dell’alluce rispetto alla testa del primo metatarso. L’alluce valgo è riconoscibile solo mediante radiografia. E’ asintomatico ma talvolta si 97 possono riscontrare delle lievi ipercheratosi. Nel secondo stadio si ha l’abduzione dell’alluce visibile anche clinicamente oltre che radiograficamente. L’alluce spinge contro il secondo dito fino a che questo ne limita l’abduzione. Talvolta si riscontra un’unghia incarnita. Il dolore è raro. Questo stadio segue o si sviluppa in maniera contemporanea con il primo. Il terzo stadio è caratterizzato da un marcato varismo del primo metatarso. L’eminenza mediana della prima metatarso-falangea appare dolente, arrossata e tumefatta. Compare la metatarsalgia da trasferimento dovuta al sovraccarico delle teste metatarsali nel periodo propulsivo quando la prima metatarso-falangea è incapace di sostenere il carico. In questa fase è presente la sublussazione dei sesamoidi. È possibile che sia presente mononeurite o neuropatia associata alla compressione della branca mediale del nervo cutaneo dorso-mediale nel suo passaggio al di sopra della faccia dorso-mediale della testa del primo metatarso (dolore e parestesie). Infine nel quarto stadio si ha una dislocazione dell’alluce sulla prima testa metatarsale. Il secondo dito perde tutta la sua capacità di sostegno contro l’abduzione dell’alluce. L’alluce spinge verso il terzo dito dal momento che il secondo si è sublussato e non oppone più resistenza. Nei casi più gravi l’alluce si sposta al di sotto delle dita centrali o più raramente vi si sovrappone. 3.6 Trattamento conservativo Il trattamento conservativo ha lo scopo di diminuire la sintomatologia 98 dolorosa ma non è in grado né di correggere la deformità né di modificarne l’evoluzione. Il trattamento correttivo dell’alluce valgo è di tipo prettamente chirurgico. Sono state descritte negli anni più di 150 tecniche chirurgiche ma ancora non esiste un trattamento di scelta. La deformità anatomica si può correggere solo ripristinando i giusti rapporti articolari tra le componenti ossee. Tuttavia, si possono effettuare trattamenti preventivi o semplicemente conservativi con lo scopo di alleviare la sintomatologia clinica o, al massimo, di rallentare l’evoluzione di questa particolare affezione. Generalmente, un trattamento conservativo iniziale è intrapreso in maniera autonoma dal soggetto quando la sintomatologia interferisce con le normali attività quotidiane. Consiste nell’utilizzo di calzature larghe, spesso aperte sull’avampiede e dall’applicazione di cuscinetti. Il primo approccio terapeutico comprende l’educazione del soggetto, l’analisi della storia naturale del disordine, la valutazione del tipo di calzatura e le eventuali terapie precedenti. Il trattamento conservativo inizia con la prescrizione di una calzatura adatta che può alleviare i sintomi. Nel soggetto anziano la calzatura deve essere leggera, confortevole e stabilizzante. Altra caratteristica da tenere in considerazione è il volume, considerando che né scarpe strette né larghe giovano alle alterazioni già presenti. Quindi, prima dell’acquisto della calzatura, è necessario che i piedi siano misurati, anche in prospettiva dell’inserimento di eventuali ortesi plantari, dato che spesso i soggetti anziani tendono ad introdurle in 99 qualsiasi calzatura causando ulteriori iperpressioni. Spesso vengono utilizzati materiali termoformabili che permettono di avvolgere il piede deforme, evitando delle compressioni. Le cuciture sia della tomaia che della fodera vanno realizzate in modo da impedire sfregamenti nei punti critici di flessione del piede. L’allacciatura dovrà essere maneggevole, spesso è realizzata in velcro per permettere una chiusura graduata, facile e veloce. La suola deve essere costituita da materiale ammortizzante con profilo antiscivolo, per compensare l’atrofia del pannicolo adiposo plantare dovuta all’età. Il tacco deve essere basso e largo per favorire la distribuzione equa del peso. Molto utili sono i dispositivi di ortopedia correttiva, o ortesi, al fine di svolgere una funzione protettiva della zona dolente che si vuole trattare. Le ortesi più utilizzate sono in silicone e sono controindicate in caso di micosi cutanee o di macerazione interdigitale. Le ortesi utilizzate nel trattamento dell’alluce valgo si distinguono in ortesi plantari e ortesi digitali. L’ortesi plantare è un dispositivo medico rappresentato da una soletta ortopedica concepita con la finalità di ridurre al minimo gli squilibri posturali e i picchi di pressione a cui il piede è soggetto durante la fase del passo. Infatti, uno degli scopi principali del plantare nell’alluce valgo durante la funzione del passo, è quello di assorbire l’onda di shock durante l’impatto del tallone al suolo e quello di aiutare a stabilizzare il piede nella fase di appoggio totale per poi distribuire e ridurre al minimo l’impatto traumatico dell’avampiede. Anche le ortesi plantari non possono essere standardizzate ma devono essere costruite per quello specifico soggetto. Al 100 fine di realizzare un plantare funzionale e ben tollerato devono essere valutati una serie di fattori come l’età, le dimensioni del piede, il peso corporeo, la sudorazione, eventuali malattie sistemiche come il diabete, attività lavorativa e velleità sportive e infine le caratteristiche morfologiche del piede, per esempio un piede piatto pronato necessita di ortesi completamente differenti da quelle di un piede cavo con avampiede addotto. Le ortesi digitali in silicone, vengono utilizzate come dispositivo compensatorio nei casi di alluce valgo. All’inizio rallentano l’evoluzione dell’alluce valgo poi, quando la mobilità delle dita lo consente, rappresentano un’ottima soluzione per riallineare le dita interessate dalla deformità in griffe o a martello. Si dividono in protettive e correttive. Le ortesi protettive hanno lo scopo di eliminare il conflitto con la calzatura, con il piano d’appoggio (suola) o con le dita adiacenti. Il conflitto è dato da un sovraccarico, cioè da una pressione eccessiva su una superficie ridotta. Per ridurre il sovraccarico si riduce la pressione o si aumenta la superficie. Le ortesi protettive distribuiscono la pressione su una superficie più vasta. Le ortesi correttive hanno lo scopo di ridurre la deformità senza la pretesa di eliminarla. In definitiva, sebbene non ci sia evidenza scientifica a sostegno dell’efficacia di un trattamento ortesico in caso di alluce valgo, in alcuni soggetti questo può recare un certo sollievo dai sintomi. Inoltre nei soggetti molto anziani, esclusi dall’indicazione chirurgica per età avanzata o per patologie sistemiche associate, l’impiego delle ortesi resta l’unico 101 espediente in grado di alleviare anche parzialmente il dolore. 3.7 Trattamento chirurgico Gli obiettivi principali del trattamento chirurgico sono la risoluzione del dolore, il ripristino del bilanciamento morfologico e della funzionalità del primo raggio e la correzione del problema estetico. I numerosi interventi di correzione descritti in letteratura indicano che non esiste una procedura applicabile universalmente per tutte le deformità. La scelta della tecnica chirurgica deve dipendere dalle alterazioni anatomiche e dalle caratteristiche del soggetto (età, stile di vita, aspettative…). Nonostante questo inquadramento generale del soggetto sia condiviso da pressoché la totalità degli autori il tipo di tecnica da utilizzare nei diversi casi è ancora molto discusso in letteratura. 3.7.1 Complicanze Le complicanze che possono verificarsi nella chirurgia percutanea sono sovrapponibili a quelle della chirurgia aperta. I ritardi di consolidazione e le pseudoartrosi sono diagnosticabili radiograficamente, per il persistere del dolore a livello dei focolai osteotomici. In caso di ritardo di consolidazione si procede prolungando l’utilizzo dei bendaggi contenitivi post-operatori per periodi più lunghi, fino alla guarigione dell’osteotomia. Le pseudoartrosi possono causare 102 deformità e disturbi funzionali, come ad esempio metatarsalgia da trasferimento, necessitando quindi d’interventi correttivi. Sono descritte pseudoartrosi asintomatiche, in questi casi non è consigliato intervenire. Le infezioni, superficiali o profonde, si trattano come di consueto mediante drenaggio e antibioticoterapia mirata. Talvolta una permanenza nel sottocute di tessuto osseo da “debris”, non adeguatamente lavato, comporta una reazione da corpo estraneo con secrezione che pu persistere anche alcune settimane. Le lesioni vascolari o nervose sono rare e riguardano essenzialmente vasi e nervi dorsali delle dita del piede e quindi non compromettono in modo significativo né la vascolarizzazione del singolo dito né la sensibilità. La complicanza neurologica più fastidiosa, è la comparsa di parestesie nella regione dorso-mediale del piede dovuta a lesione del nervo cutaneo dorsomediale che si può avere quando l’accesso percutaneo è praticato troppo dorsalmente. La necrosi avascolare è particolarmente rara, soprattutto se la tecnica chirurgica viene rispettata. L’alluce rigido è una delle complicanze più frequenti in seguito ad osteotomie distali del 1° metatarso. Una certa diminuzione dell’escursione articolare è spesso presente. Secondo Roots e collaboratori l’escursione articolare in dorsiflessione dell’articolazione metatarso falangea necessaria per effettuare in maniera fisiologica il passo è di 65°-75°. Un alluce la cui escursione articolare scende sotto questi valori comporta delle anomalie posturali e del passo e quindi nel breve o lungo termine complicanze per il 103 soggetto. Le cause ricercate per spiegare questa complicanza sono il ritensionamento dei tessuti molli, la rotazione in plantarflessione della testa, un processo d’infiammazione della sinovia e delle parti molli che può essere causata anche dall’accumulo di detriti di osso in seguito all’azione della fresa utilizzata per l’osteotomia. Il sovraccarico sui metatarsi centrali è una complicanza frequente e fastidiosa che si associa spesso agli interventi di correzione dell’alluce valgo. È inoltre, nella maggioranza delle casistiche riportate in letteratura, la causa più frequente di reintervento in seguito a tecnica di correzione percutanea secondo Reverdin-Isham. Casi di sindrome dolorosa regionale complessa sono riportati in letteratura. 104 CAPITOLO 4 SQUILIBRI ENERGETICI E PIEDE 4.1 I piedi in un approccio psicosomatico I piedi da un punto di vista psicosomatico rappresentano il modo in cui noi ci muoviamo nella vita e nel mondo: rappresenta il "nostro andare avanti"; sono un simbolo di venerazione in molte religioni proprio perché sono in relazione con lo sviluppo della coscienza spirituale di una persona. Chiaramente anche come una persona cammina ha una importanza fondamentale: la sua andatura rappresenta proprio il mondo di sentirsi parte dell’Universo e della Terra. Il piede ci permette di spingere in avanti e di conseguenza di avanzare, come pure di bloccare i nostri appoggi e, conseguentemente, di rimanere sulle nostre posizioni. Il piede rappresenta quindi il mondo delle posizioni, l'estremità manifesta della nostra relazione con il mondo esterno. Simboleggia i nostri atteggiamenti e le nostre posizioni affermate riconosciute, il nostro ruolo ufficiale. Non si mette forse il piede tra la porta per bloccarla? Rappresenta i nostri criteri di vita, se non addirittura i nostri ideali. Si tratta della chiave simbolica dei nostri sostegni relazionali, il che spiega l'importanza della vita del lavacro dei piedi in tutte le tradizioni. Esso purificava la relazione dell'uomo con il mondo, con il divino. I piedi dei grandi maestri spirituali sono venerati, e di fatto in tal modo, si onora il loro progresso spirituale. 105 I piedi, la camminata esprimono il modo in cui una persona avanza nella vita. Infine sono simbolo di libertà in quanto consentono i movimento. I piedi indicano la possibilità di ricongiungersi alle "terre interiori" è un ritorno al grembo, a quel grembo da cui il bambino era uscito molto tempo prima. I piedi riassumono e sintetizzano tutto ciò che c’è nel nostro corpo: infatti, nei piedi, si trovano tutte le terminazioni dei meridiani e, per questo, chi si occupa di "cure energetiche" spesso lavora sui piedi. Ci sono agopuntori che intervengono esclusivamente a livello piedi e operatori vari che rimettono in moto le energie bloccate massaggiando e manipolando i piedi. 4.2 Il piede nella storia Un tempo i piedi erano molto venerati; nella tradizione cristiana non possiamo dimenticarci del Cristo che lava i piedi agli apostoli e, in questo gesto simbolico mostra la possibilità di lavare tutte le ferite "spirituali". L’alluce è la parte più umana del corpo umano, nel senso che nessun altro elemento di questo corpo è così differenziato dall’elemento corrispondente della scimmia antropoide (scimpanzé, gorilla, orangutango o gibbonet). Questo deriva dal fatto che la scimmia è arboricola, mentre l’uomo si sposta sulla terra senza aggrapparsi ai rami, essendo diventato lui stesso un albero, cioè elevandosi dritto nell’aria come un albero, e tanto più bello se la sua erezione è corretta. Così la funzione del piede umano consiste nel dare una base ferma a questa erezione di cui l’uomo è tanto fiero (l’alluce, cessando di essere utile alla prensione eventuale dei rami, si adatta al suolo 106 sullo stesso piano delle altre dita). Ma qualunque sia il ruolo svolto nell’erezione dal piede, l’uomo, che ha la testa leggera, cioè elevata verso il cielo e le cose del cielo, lo guarda come uno sputo col pretesto che egli ha questo piede nel fango. Benché all’interno del corpo il sangue scorra in uguale quantità dall’alto in basso e dal basso in alto, il favore va a ciò che si eleva e la vita umana è erroneamente considerata come una elevazione. La divisione dell’universo in inferno sotterraneo e in cielo perfettamente puro è una concezione indelebile, il fango e le tenebre essendo i principi del male come la luce e lo spazio celeste sono i principi del bene: i piedi nel fango ma la testa quasi nella luce, gli uomini immaginano ostinatamente un flusso che li eleverebbe senza ritorno nello spazio puro. La vita umana comporta infatti la rabbia di vedere che si tratta di un movimento di va e vieni dall’immondo all’ideale, e dall’ideale all’immondo, rabbia che è facile scaricare su un organo così basso come un piede. Il piede umano è comunemente sottomesso a supplizi grotteschi che lo rendono deforme e rachitico. E stupidamente destinato ai calli, ai duroni e agli occhi di pernice e, se si tiene conto degli usi che sono ora in via di sparizione, alla sporcizia più disgustosa: l’espressione paesana “avere le mani sporche come i piedi” che non è più valida oggi per tutta la comunità umana lo era ancora nel XVII secolo. Lo spavento segreto causato all’uomo dal suo piede è una delle spiegazioni della tendenza a dissimulare il più possibile la sua lunghezza e 107 la sua forma. I talloni più o meno alti a seconda del sesso tolgono al piede una parte del suo carattere basso e piatto. Inoltre questa inquietudine si confonde frequentemente con l’inquietudine sessuale, e ciò colpisce in particolare nei Cinesi che, dopo aver atrofizzato i piedi delle donne, li collocano nel punto più lontano delle loro rimozioni. Il marito stesso non deve vedere i piedi nudi di sua moglie e, in generale, e scorretto e immorale guardare i piedi delle donne. I confessori cattolici, adattandosi a questa aberrazione, chiedono ai loro penitenti cinesi “se hanno guardato i piedi delle donne“. La medesima aberrazione si ritrova presso i Turchi (Turchi del Volga, Turchi dell’Asia centrale) che considerano come immorale mostrare i piedi nudi e si coricano persino con le calze. Niente di simile può essere citato per l’Antichità classica (a parte l’uso curioso delle altissime suole nelle tragedie). Le matrone romane più pudiche lasciavano vedere costantemente i loro alluci nudi. Per contro, il pudore del piede si è sviluppato eccessivamente nei tempi moderni e non è scomparso che nel XIX secolo. Salomon Reinach ha lungamente esposto questo sviluppo nell’articolo intitolato “Piedi pudichi”, insistendo sul ruolo della Spagna, dove i piedi delle donne sono stati oggetto dell’inquietudine più angosciosa e anche causa di delitti. Il semplice fatto di lasciar vedere il piede calzato oltre l’orlo della gonna era considerato indecente. In nessun caso era possibile toccare i piedi di una donna, essendo questa licenza, salvo un’eccezione, più grave di qualsiasi altra. Beninteso, il piede della regina era l’oggetto 108 della proibizione più terrificante. Cosi, secondo Mine d’Aulnov il conte di Villamediana essendo innamorato della regina Elisabetta pensò di appiccare un incendio per avere il piacere di portarla tra le sue braccia: tutta la casa, che valeva centomila scudi, bruciò quasi interamente, ma egli se ne trovò consolato allorquando approfittando di una occasione cosi favorevole prese la sovrana tra le braccia e la portò per una piccola scala. Là le rubò alcuni favori e, cosa che fece molto scalpore in quel paese, le toccò anche il piede. Un paggetto lo vide, riportò la cosa al re e questi si vendica uccidendo il conte con un colpo di pistola …” Questo bellissimo saggio di Georges Bataille illustra come il movimento di copertura imposto al piede lungo i secoli, abbia formalmente contribuito a crearne il pudore. Da qui l’assunto: “Ciò che vive nascosto, va tenuto nascosto”. Al pari della sessualità, che si pratica in abbondanza, ma di cui si parla pochissimo (per sessualità intendiamo educazione sessuale, non provocazione sessuale, il piede vive una vita ascosa agli occhi del mondo nelle sue tenere scarpine di pelle, e molte persone si frenano stupite, all’idea che si possa ristabilire l’equilibrio psicofisico comprimendo parti del piede. 4.3 Riflessologia e MTC Suddividendo, come sempre si fa in reflessologia, il piede in tre parti, quindi anteriore, mediano e posteriore, avremo la possibilità di riconoscere se vi siano carichi energetici che possono provocare disequilibrio, e dove 109 questi siano distribuiti nella nostra personale visione del mondo. Al tallone corrispondono le radici, la base, la struttura, descrive da dove si proviene e proprio personale bagaglio di esperienze. Alla parte mediana, ovvero all'arco plantare, corrisponde la capacità di mediare tra il proprio passato e il modo in cui si affronta il futuro, ovvero le occasioni che la vita ci propone. Come intuibile, la parte anteriore del piede rappresenta il modo di procedere nella vita, l'azione. Descrive la direzione che prendo, il modo in cui mi comporto per raggiungere i miei obiettivi. La parte anteriore che comprende una parte plantare e le dita che rappresentano l’avanzare nella vita che deve cambiare a seconda della consapevolezza e degli ideali: per correre, saltare e camminare, bisogna infatti appoggiare bene la parte anteriore, ma anche per dirigere la vita si devono comunque spostare ed appoggiare i piedi. La parte centrale o mediana del piede (Luna) rappresenta il passaggio tra ciò che si è acquisito ( tallone = Giove) e il modo in cui si utilizzeranno le esperienze (Nettuno = consapevolezza). Il tallone che rappresenta il radicamento nella vita, le basi, le risorse, le sicurezze e ciò che si è accumulato (Giove); camminare troppo sui talloni indica un bisogno di radicamento e di appoggio. Il tallone è anche legato a ciò che abbiamo acquisito sotto forma di esperienza dal passato. Nel "linguaggio del corpo" proprio ai piedi vengono collegate le nostre capacità di direzionarci; avere i piedi in fuori indica una difficoltà nello scegliere la direzione da prendere nella vita: sono proprio i piedi a darci la "direzione della testa" e, nel caso in cui le punte dei piedi siano rivolte 110 verso l’esterno indica una doppia anima, una lotta tra la parte. Il dolore ai piedi è spesso collegato con l'impressione di non procedere, di rimanere sul posto, al fatto che ci si può sentire bloccati in ciò che si desidera fare oppure, indicano che i nostri atteggiamenti abituali, le posizioni che assumiamo che abbiamo, mancano di affidabilità, di stabilità o di sicurezza. Di qualcuno che non è tranquillo, che ha paura o che non osa affermare le sue opinioni o le sue posizioni, non diciamo forse che sta sulle spine? O più semplicemente, di qualcuno che fa uno sbaglio danneggiando se stesso, che si dà la zappa sui piedi? Infine, di qualcuno che non sa quale atteggiamento prendere in una data situazione (relazionale chiusa), non diciamo che tiene il piede in due staffe? Le problematiche relative al piede ci riconducono ad un significato premio di interesse se vogliamo indagare la natura dell'uomo. I piedi piatti sono caratterizzati dall'indebolimento dell'arco plantare. I bambini che nascono con i piedi piatti hanno spesso una mamma che non si è sentita abbastanza sostenuta durante la gravidanza. L'esperienza personale di chi scrive, è molto forte in questo senso. Le persone che hanno piedi piatti hanno bisogno di acquisire fiducia il loro stesse e nella vita per lasciare andare ciò che, per loro, rappresenta una ancora di salvataggio, generalmente la madre per i bambini, e il padre per le 111 femminucce. Potranno allora vivere esperienze che consentiranno loro di crescere lungo la via dell'evoluzione. Il piede cavo è caratterizzato da un'impronta plantare che non lascia quasi alcun segno dell'arco. L’incavato esagerato dell'arco plantare ricorda un embrione in posizione fetale; questo è tipico di persone che, spesso, si ripiegano su se stesse per bisogno di sicurezza e protezione, che hanno tendenza essere sempre di fretta, che non si concedono mai il tempo di posare i piedi per terra. Trascinare i piedi può essere segno di timidezza, ma anche indice del fatto che non possediamo il gusto di avanzare nella vita; camminare con i piedi rivolti verso l'interno denota una natura che attraversa il rifiuto di crescere, si tratta di qualcuno che vorrebbe rimanere bambini in eterno. L'alluce valgo è una deviazione del primo osso metatarsale e dell'alluce. Colpisce coloro che hanno difficoltà prendere il proprio posto, perché si sentono obbligati a soddisfare i desideri e le aspettative altrui. Tutte queste lesioni o condizioni del piede, possono suggerire al praticante, altrettante interazioni per il miglioramento della salute psicofisica. Per interpretare correttamente un sintomo è necessaria una visione distaccata ed esterna, non scordiamoci, infatti, che il contenuto che esso trasporta è già stato rifiutato dalla coscienza, altrimenti non sarebbe 112 necessario che il corpo lo manifesti. Una volta integratone completamente il contenuto conflittuale, qualsiasi malattia è in grado di guarire, ed il corpo ritorna al suo equilibrio abituale. E' interessante notare che qualsiasi interpretazione data ad un soggetto e da questi accettata di buon grado, o non è corretta o è troppo superficiale! L'interpretazione corretta è relativa a un aspetto di sé che il soggetto non vede, che tenderà quindi a negare più o meno aspramente qualora gli si presenti davanti (così come tenderà ad essere particolarmente irritato da quelle persone che lo manifestano apertamente nella propria vita: meccanismo dello specchio). Per riuscire a interpretare i nostri sintomi dobbiamo chiederci che cosa mi fanno fare (che in condizioni normali non farei) e che cosa mi impediscono di fare (che in condizioni normali farei), in questo modo troviamo la finalità e dunque il messaggio. Mi ammalo sempre al mio compleanno, oppure prendo il raffreddore dopo un periodo di grande fatica al lavoro. O forse mi è venuta una malattia dopo un lutto o un evento particolarmente stressante. Siamo sicuri che la malattia è solo un sintomo da curare e non qualcosa di più? Restando in ambito reflessologico l'alluce, rappresenta la testa. In un'ipotesi di trattamento, andremo a lavorare questo binario, unitamente ai riflessi dello stomaco, del nervo vago, del sistema parasimpatico e simpatico, oltre che approfondire talmente il rene che è la sede dell'energia ancestrale dell'uomo. 113 Volendo suggerire un'ipotesi a base di fiori di Bach, potremmo indicare PIN per il senso di colpa, SCL per l'indecisione, WHC per il tormento mentale, WIL per il risentimento. Non bisogna inoltre scordare che anche le dita del piede veicolano un messaggio: • L'alluce rappresenta la personalità dell'individuo, la capacità di governare sul suo territorio personale. • Il secondo dito, rappresenta la direzione della nostra vita, l'autorità che abbiamo nel proporci all'esterno. • Il terzo dito, rappresenta la sessualità, la creatività e il piacere. • Il quarto dito, è il campo affettivo, l'unione con ciò che amiamo. • Il quinto dito, rappresenta l'ascolto di se stessi, la capacità di introspezione, l'intuizione. 1 Dalla raccolta di tutti questi dati è comprensibile come l'operatore di reflessologia sia in grado di capire il cliente semplicemente osservando i suoi piedi. 4.4 La lettura energetica Nel caso di questa disfunzione osteopatica gli aspetti del Primo Chakra, che sono la sicurezza e tutto ciò che rappresenta, come il denaro, la casa e il lavoro, la sopravvivenza, il rapporto con la madre, sono enfatizzati dal fatto 114 che la disfunzione osteopatica riguarda l'alluce, cioè il primo dito del piede. Nella lettura energetica dei sintomi le dita degli arti corrispondono ai primi cinque Chakra; in questo caso, dunque, l'alluce rappresenta la sicurezza nel campo del lavoro, della casa e del denaro. Il secondo dito del piede indica la sicurezza nella sessualità e nel permettersi di sentire le emozioni; il terzo è la sicurezza del potere personale o della libertà di essere se stessi; il quarto la sicurezza nella percezione dell'amore e il quinto nell'espressione. In questo caso si tratta di una paura che riguarda proprio gli aspetti che dovrebbero invece rendere la persona sicura. Se poi c'è una manifestazione della disfunzione osteopatica anche nel secondo dito del piede, il cosiddetto "dito a martello", significa che la tensione, e quindi l'insicurezza, si estende anche agli aspetti del Secondo Chakra, dunque nelle aree del sesso, del cibo e delle emozioni. Dovremmo, come sempre, verificare la polarità yin-yang e che cosa la disfunzione osteopatica impedisce di fare al soggetto per avere un ulteriore dettaglio della lettura energetica. L'esito finale della malattia è non permettere la deambulazione: potremmo porci domande come: "da quale situazione il soggetto vorrebbe allontanarsi, e non lo fa per paura?" oppure: "Perchè non si regge sulle sue gambe per quanto riguarda la sicurezza e (se è coinvolto il secondo dito del piede) della sessualità?" Consiglio energetico: la persona affetta da alluce valgo si sta immobilizzando per la paura. Per ovviare a questa tensione deve riconnettersi con la fonte primaria di sicurezza, costituita dal Primo Chakra. Lo stato di questo centro energetico indica come lei si sente a stare sulla Terra. Nella meditazione dei Colori, pertanto, la persona porrà particolare 115 attenzione al Colore Rosso , e all'immagine della Terra che ha sotto i piedi: se è un terreno inospitale, arido o dove un albero non potrebbe radicarsi, deve cambiarlo e visualizzare una terra ricca e fertile, così si sentirà nutrita e accolta. Un testo illuminante: “Attendere la comparsa dei segni di una malattia per poi guarirla è come forgiare una spada dopo aver dichiarato guerra o cominciare a scavare un pozzo quando si ha sete. Il grande terapeuta stronca la malattia prima della sua apparizione, mentre il piccolo mediconzolo si affanna a curare i sintomi che non ha saputo prevedere“. Huangdi Nei Jing, Libro dell’Interno, 475-221 a.C Un approccio completo ha come obiettivo l'educazione alla salute e al benessere dell'uomo nella sua globalità, nel suo essere corpo-mente-spirito inscindibile, dentro il suo ambiente di vita e di relazioni. Ogni intervento deve agire favorendo le capacità dell'organismo di reagire e ripristinare il suo equilibrio interno, alterato dallo stress, dai ritmi di vita frenetici, dall'alimentazione sregolata. Secondo il medico e psicologo George W. Groddeck, la malattia è segno di una forza vitale debole, segno che non si dà spazio all'ES, cioè alla Forza Vitale che in ogni momento dentro di noi fa funzionare ogni cellula del 116 corpo. La forza vitale è indebolita quando la nostra vita non segue ritmi e dimensioni naturali, quando la mente razionale predomina e siamo sommersi da pensieri, appuntamenti, programmi, idee fisse... La salute è lo stato normale in cui vive e può vivere l’uomo. Ogni malattia origina da uno squilibrio globale della persona, a livello sia fisico che mentale o emotivo e l'intervento dell’operatore interviene a sostegno del riequilibrio, in modo naturale, affinchè il corpo possa recuperare la sua capacità di autoguarigione. E’ necessaria la rieducazione a una dimensione di vita naturale in sintonia con i propri tempi e desideri oltre il dover insegnare ad ascoltare i segnali del corpo, ad esserne consapevoli. Nell'approccio olistico alla malattia, per star bene sono quindi determinanti le abitudini personali e lo stile di vita della persona, che diventa così protagonista della propria salute e non un soggetto passivo. 4.5 La Sacralità della malattia La malattia, dice Hamer, è un simultaneo squilibrio a livello psichico, cerebrale e organico dovuto ad un trauma emotivo. Senza conflitto non vi è malattia: rendersene conto è il primo passo verso la guarigione. Se analizziamo la parola ‘malattia’ e la sezioniamo in due parti, ci rendiamo conto che è formata dalla parola ma = madre e lat = latte. La malattia assume, allora, significato di LATTE MATERNO, alimento che nutre e che tiene in vita preparandoci ad affrontare l’esistenza, non solo 117 da un punto di vista strettamente fisico e materiale, ma contemporaneamente da un punto di vista emotivo, psichico e spirituale. Grazie al nutrimento (latte) il neonato, per altro in modo del tutto istintivo, cresce e si trasforma, allo stesso modo in cui grazie alla malattia tutti noi cresciamo e ci trasformiamo. La malattia può allora essere vista come mezzo per trasformarci e crescere, per comprendere che qualcosa non sta procedendo nella giusta direzione, quella che il nostro sé vorrebbe per noi. Prima che sopraggiunga la ‘malattia’, dal profondo del cuore emergono sensazioni di straniamento, insoddisfazione, tristezza, nervosismo, apatia, sbalzi umorali, depressione, paura: questi sono i messaggi che potrebbero farci cambiare rotta senza bisogno di ‘cadere’ nella rete della malattia. Ma, spesso cerchiamo di minimizzare i segnali, o addirittura di metterli a tacere, con anestetici di ogni natura: chimica, fisica, emotiva. “TUTTO IL NOSTRO CORPO PENSA, QUINDI ANCHE IL NOSTRO CUORE” Uno dei maggiori contributi alla riunificazione della dicotomia umana in medicina, è dovuto al lavoro e alla visione pionieristica di Candace Pert, neurofisiologa, direttrice dell’istituto di biochimica cerebrale del NIMH – National Institute for Mental Health - la quale ha scoperto le endorfine e un vasto numero di neuropeptidi, le molecole che trasmettono le informazioni nel sistema nervoso. Ha, inoltre, evidenziato che i neuropeptidi sono i mediatori sia delle 118 informazioni che delle emozioni e sono attivi praticamente in tutte le cellule del corpo: nel sistema nervoso, nel sangue, nel sistema immunitario e nell’intestino. Dunque, è possibile affermare che: Ogni stato d’animo è fedelmente riflesso da uno stato fisiologico del sistema immunitario. Con le scoperte della Pert la concezione puramente meccanicistica del corpo umano è stata scardinata completamente. Innanzitutto, i neuropeptidi devono essere considerati delle ‘molecole psichiche’ in quanto non trasmettono solo informazioni ormonali e metaboliche ma emozioni e segnali psicofisici. Ogni stato emotivo (gioia, ansia, paura, piacere, terrore) con le sue moltitudini sfumature chiamate sentimenti, è veicolato nel corpo da specifici neuropeptidi. Contrariamente alle aspettative scientifiche, questi neuropeptidi e i loro recettori sono stati rinvenuti in ogni parte del corpo, e non soltanto nel sistema nervoso: L’INTERO CORPO PENSA / OGNI CELLULA, O PARTE DEL CORPO, “SENTE” E PROVA EMOZIONI, ELABORA LE PROPRIE INFORMAZIONI PSICOFISICHE e le trasmette ad ogni parte attraverso una fittissima rete di comunicazioni di estrema varietà. TUTTO IL CORPO È VIVO, INTELLIGENTE E COSCIENTE / OGNI CELLULA PROVA PIACERE O DOLORE ed elabora strategie metaboliche per il benessere collettivo. Questo concetto può apparire sfuggente alla nostra normale comprensione e a quella coscienza umana, così intrisa di concetti razionali, seppur scientificamente opinabili. Ma, talvolta è facile perdersi nel bicchiere 119 d’acqua dell’ovvietà. Le malattie ed i sintomi altro non sono che messaggi inviati dal corpo ad una mente che si rifiuta di comprendere gli insegnamenti della vita. Quando parla il corpo non mente mai e ciascuno di noi è in grado di comprenderne intuitivamente il linguaggio, poiché parla con una lingua antichissima, esistita da sempre e destinata a non morire mai: quella dei simboli. L'interpretazione in chiave simbolica, psicosomatica, delle malattie consente di integrarne il messaggio profondo a livello della coscienza, in questo modo si può eliminare la vera causa di un disagio ed il corpo può guarire. Viceversa se eliminiamo solo l'effetto di uno squilibrio interiore, cioè il sintomo, questo è destinato a ripresentarsi nello stesso organo o in un altro situato più in profondità (vicariazione regressiva). 4.6 La Resilienza e la malattia La malattia nella visione olistica è la manifestazione di un disequilibrio. Sta di fatto che questa manifestazione crea un'anomalia che a sua volta innesca una reazione. È nella qualità di quella reazione che si entra nella dimensione della resilienza. Introspezione, indipendenza, interazione, iniziativa, disposizione di spirito sono tutte componenti di quel concetto più grande che è la resilienza. Introspezione come inshight, capacità di autopercepirsi, porsi domande e farlo con una certa sincerità verso se stessi. Indipendenza invece intesa come distacco, abilità di creare un sano distacco tra quel che accade e il mondo emozionale e fisico che abitiamo. 120 L'interazione è l'abilità di creare energie, sinergie, connettere, costruire ponti tra umani, connettersi in modo soddisfacente. L’iniziativa è l'abilità di far fronte ai problemi, reagire non in modo impulsivo ma ponderato, stando in quell'ambiente di pace interiore che è dato solo da un allenamento alla calma della mente. Vi sono poi tre fattori ulteriori di cui uno è la creatività concepita come il fare ordine, il darsi obiettivi partendo dal caos, dal vasto orizzonte delle molteplici intenzioni: si aggiunge lo spirito dell'allegria, una certa forza vitale che si esprime nel vedere le cose con la giusta dose di relatività e ottimismo concreto. A tutto questo si unisce una morale condivisa, fatta dei valori della società di appartenenza. 4.6.1 La resilienza e la crisi generata dalla malattia Quando subentra la notizia di una malattia, cosa accade nell'andamento generale delle nostre azioni, siano esse o meno già condotte da uno spirito di resilienza puro? Come resiste il sistema ai cambiamenti prodotti dall'esterno? Ci si chiede in termini di resilienza adattata a tanti ambiti, dal tessile all'informatico e persino nella resilienza ecologica. In questo ambito la variazione viene da dentro, dal corpo di chi si ammala o porta una malattia cronica. Si verifica sempre una crisi che solo successivamente può dar spazio a una ristrutturazione. All'inizio qualcosa viene sconvolto, l'equilibrio e l'armonia si modificano. Non si può cercare subito un sanguinamento minore della ferita, occorre stare con quel dolore mentre, in modo simultaneo, si attivano le risorse che 121 serviranno come benzina per reagire una volta che si è attinto alla propria disciplina interiore. 4.6.2 La forza interiore, la resilienza e la malattia Tutta la vita è un imparare a prendere l'esistenza stessa, coglierla, saperla valorizzare. In questo senso la morte assume la valenza di un'amica, come in molte tradizioni spirituali. Un'amica, un faro, una grande luce di ricordo, ovvero ricordarsi di sé, avere nel cuore chi si è. La malattia subentra e non è un evento scelto o desiderato, apre il varco all'incertezza. Molte delle discipline che si praticano attualmente, dallo yoga al tai chi, servono per allenarsi al disequilibrio, senza temerlo, senza fuggirne. In questo senso la meditazione è una potentissima risorsa per fluire nell'esistenza. Ci si trova di colpo di fronte alla limitatezza dell'essere umano. In questo senso il termine resilienza può esser definito come un “saltare indietro per prendere un’altra posizione” secondo Rundy Paush, brillante informatico colpito da una malattia degenerativa, per descrivere il grado in cui una struttura metallica o mentale è capace di resistere a un urto. La vittima è soggetta a un doppio dolore, il trauma e la sua rappresentazione successiva che consente di rivalutare la sofferenza, integrandola nella propria storia personale. Miliardi di testi spiegano e contribuiscono a dare un'idea di quella che è la forza interiore ma preferisco ricorrere alle parole di Paush, tanto eloquenti quanto veritiere, contenute nel suo straordinario libro “La vita spiegata da un uomo che muore”. 122 Queste parole sono una vera e propria risorsa per chiunque: "Ogni ostacolo, ogni muro di mattoni, è lì per un motivo preciso. Non è lì per escluderci da qualcosa, ma per offrirci la possibilità di dimostrare in che misura ci teniamo. I muri di mattoni sono lì per fermare le persone che non hanno abbastanza voglia di superarli. Sono lì per fermare gli altri." Antonella Delle Fave, docente di Psicologia all’Università Statale di Milano- Ospedale Sacco, spiega così la resilienza: "All’interno delle definizione di resilienza è implicito il fatto che ci sia una cosiddetta"condizione estenuante o estrema". In sintesi, viene richiesto di accedere a un maggior numero di risorse, per far fronte a una necessità che in questo caso è la malattia. La forza interiore serve per innescare una vera e propria ripresa evolutiva. Quando lo stato di energia cala, arriva un momento in cui si decide di far fronte, attivare le risorse, riprendersi la vita. Come un sistema, l'organismo tutto partecipa a riprendersi le proprie condizioni di equilibrio, ripristinarle, renderle ancora più strutturate. Nonostante gli antichi avessero ben compreso lo stretto legame tra corpo e mente, la medicina moderna ha sempre più rafforzato la tendenza a separare nettamente gli aspetti fisici da quelli mentali. Questa insistenza nel distinguere gli eventi organici da quelli psichici, accompagnata da una sempre più intensa specializzazione, ha portato la medicina a separare tra loro addirittura gli stessi aspetti fisici. È solo a partire dagli anni 50 del Novecento che, grazie ai lavori di Franz 123 Alexander, si è insinuato un differente orientamento di pensiero, il quale si opponeva alla frammentazione specialistica, proponendo, in una visione olistica, la ricomposizione dell’unità psicofisica dell’uomo, servendosi di sistemi concettuali che cogliessero aspetti organici e psichici allo stesso tempo. 124 CAPITOLO 5 CLINICA Alla luce di quanto argomentato fino ad ora, lo scopo della tesi è dimostrare che con l’osteopatia sia possibile riequlibrare la persona a tal punto da dimostrare che la disfunzione osteopatica non è altro che l’aggravarsi e lo stabilizzarsi di di un forte disequilibrio che colpisca il corpo , quindi la struttura, ma anche altri piani dell’essere umano come corpo e mente. Nel caso specifico, oggetto del nostro studio, vogliamo dimostrare attraverso l’applicazione del Metodo E.T.R. che si possa giungere ad una riducibilità del dolore dell’alluce e un relativo e stabile equilibrio. 5.1 Metodo E.T.R. E’ un metodo di lavoro, un sistema di lavoro dinamico che ti permette di dialogare col corpo. Il metodo E.T.R. ti permette di circumnavigare il corpo nei suoi livelli fondamentali: • Stutturale: ossa, muscoli e connettivo • Viscerale: organi, visceri e biochimica • Sistema cranio sacrale: motilità…respirazione cellulare • Neurovegetativo: modi per localizzare ed individuare il livello di profondità di un disagio interiore. 125 Attraverso questa esplorazione il corpo ti guiderà verso la causa primaria del suo disturbo perché è esso stesso che ti indica cosa fare, una volta che si è imparato a comunicare con lui, a esplorare le sue vie, trovare il punto di snodo e solo allora applicare la tecnica giusta per eliminare il problema. NON IL SINTOMO, ma l'origine, la vera spina irritativa, ciò che identifichiamo come CAUSA PRIMARIA. Questa ricerca sequenziale NON E' PROTOCOLLABILE, perché si plasma e adatta alla persona. Ogni soggetto richiede un intervento esclusivo e mirato. Occorre, quindi, imparare a connetterti, ascoltare e rincorrere l'informazione che ti darà la possibilità di compiere l'azione specifica. Il significato della sigla E.T.R: • ESPLORA: attraverso il dialogo col corpo • TROVA: la primarietà • RISOLVI: utilizzando la tecnica giusta Ovvero, la possibilità di una scanerizzazione velocissima, per trovare la primarietà altrimenti detta spina irritativa o restrizione di mobilità, eliminarla per mezzo della sua tecnica specifica e consolidare il risultato finale tramite esercizio fisico. Tutto questo, naturalmente, è stato possibile anche a seguito delle grandi scoperte fatte nel corso degli anni da eminenti scienziati studiosi della cellula e microscopisti, soprattutto nell’ambito del tessuto connettivo e in particolare della cellula chiamata fibroblasto. Essi furono in grado di 126 dimostrare scientificamente che il tutto è interconnesso e dialoga costantemente attraverso un substrato che ha la stessa origine, tutt’altro che amorfo, come un tempo si pensava, piuttosto vivo ed intelligente e al quale fanno riferimento tutti gli approcci manuali: il “sistema mio-fasciale”. Il metodo richiede un costante e quotidiano allenamento, ciò che rende ogni operatore un ricercatore ed uno studioso a sua volta. Grazie al metodo e alle sue incredibili potenzialità e possibilità (dettate dall’ascolto sensibile di chi riceve sulla scorta di chi trasmette) è possibile un connubio tra segnali di input ed output che possono portare alla realizzazione e anche all’invenzione di tecniche inedite. Non solo, ma anche di esercizi di supporto o di consolidamento del nuovo equilibrio raggiunto, da somministrare alla persona con la quale si è lavorato. Da tali postulati si possono estrapolare due concetti importanti: un lavoro persona mirata, ed esercizi al bisogno sempre persona mirati. NO PROTOCOLLI UGUALI per TUTTIII!!! Inoltre senza tralasciare tutto ciò che riguarda l’aspetto normativo in tema di medicine complementari, bionaturali, rispetto alla legge vigente sul territorio italiano. Il Metodo E.T.R. è un “passepartout” utilizzabile da qualsiasi professionista che lavori con le persone, per l’operatore olistico specializzato in tecniche osteopatiche in particolare è una possibilità orientativa unica ma, soprattutto, è priva del benché minimo rischio per la persona che si affida alla ricerca di una soluzione del suo o dei suoi problemi spesso già presi in considerazione anche da altri...... E’ un metodo efficacissimo e 127 potenzialmente tanto dinamico che il suo miglioramento è inarrestabile!!! Con queste parole, l’inventore del metodo, Franco Casella, ci ha mostrato una via che se esplorata e conosciuta nelle sue innumerevoli e direi “infinite” possibilità, può fare la differenza rispetto a tutti i metodi di lavoro principalmente conosciuti, per la plasmabilità di tale approccio alle diverse entità, considerate come corpo, mente e spirito. Personalmente, penso che un approccio alla persona come quello che avviene con il metodo E.T.R., porti ad una più profonda conoscenza della persona a tutti i suo livelli e quindi ad una più veloce e puntuale risoluzione della spina irritativa nonché, una totale sicurezza nell’effettuare delle tecniche e nella gestione degli effetti del post-trattamento che con altri approcci possono verificarsi. Quello che invece non possiamo misurare attraverso l’osservazione visiva è se tale riassetto “posturale” permetta un migliore carico podalico. Essendo il dolore riferito soprattutto durante la deambulazione, è ipotizzabile che un riequilibrio che rimuova tutte le spine irritative ci porti verso un miglior carico podalico, sia in misurazione statica, che in quella dinamica. Non potendo utilizzare il semplice feedback ricevuto dai soggetti come test attendibile scientificamente, abbiamo deciso di studiare 6 persone attraverso il test baropodometrico e analisi dinamica del passo, prima dell’inizio del ciclo di trattamenti somministrati esclusivamente con metodo E.T.R. . 128 Primo passo per ulteriore futuro studio con un significativo campione di soggetti. Abbiamo utilizzato il tendine centrale come test primario insieme allo studio delle oscillazioni e test fasciale della gamba dura per trovare la primarietà o lesione primaria o spina irritativa e l’allineamento dei reperi e lo studio delle oscillazioni per orientarci sulla primarietà e come indice visivo di verifica di riuscita del trattamento, in caso di assenza di oscillazioni. E’ stato annotato il diario di ogni seduta, dai feedbacks ai reperi, congestione dei tessuti col test del tendine centrale, oscillazioni e tecnica utilizzata, ad ogni “giro”, tutto per la futura analisi delle statistiche oggetto del nostro studio. 5.2 La Baropodometria, cos'è e quali informazioni può dare Con il termine baropodometria, di origine greca, si intende letteralmente “misura della pressione del piede”. Con questo termine è comunemente definita la somma di tutte le forze attive in uno specifico sistema di interesse. Il carico di un corpo umano o di una struttura di esso in particolare, ha un significato clinico diretto: se una determinata parte è in sovraccarico (caricata cioè oltre certi limiti per esempio dopo un trauma o per un sovraccarico cronicizzato), questa struttura sarà prima o poi danneggiata. In clinica, il carico delle estremità inferiori è abitualmente verificato dall’osservazione (esame obiettivo), del soggetto in posizione statica o in deambulazione. Le anormalità, come per esempio una chiara asimmetria nella deambulazione, possono essere 129 descritte solo qualitativamente. Tuttavia, un rapporto quantitativo inerente gli schemi motori e/o di carico basati sull’osservazione del soggetto è dubbio e potrebbe portare a conclusioni approssimative. Il controllo di parametri oggettivi, definiti e comparabili porta con sé parecchi vantaggi per l’uso clinico: la comparazione di più dati dello stesso soggetto, investigazioni sullo stesso soggetto a lungo termine, creazione di database oggettivi e riduzione dei dati cartacei. Per ottenere parametri quantitativi, devono essere utilizzati metodi quantitativi per l’analisi del passo e del movimento. La baropodometria permette di valutare anatomicamente e funzionalmente il piede, con il rilievo delle pressioni che esso esercita al suolo nella stazione eretta e nella deambulazione. Trattasi di metodica innovativa, innocua e non invasiva che permette di evidenziare una disfunzione osteopatica con documentazione grafica (anche tridimensionale), gestita da un computer con possibilità di valutazioni obiettive non eseguibili con nessun altro sistema. 5.2.1 L’analisi baropodometrica L'analisi baropodometrica risulta fondamentale nella determinazione delle variazioni ambientali, capaci di guidare in maniera controllata, il baricentro generale corporeo, sia in statica che durante la deambulazione: il ristabilimento continuo di un equilibrio dinamico stabile garantisce conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita. L’esame baropodometrico è un mezzo indispensabile per lo studio sia del 130 piede, ma anche della postura del nostro corpo; viene svolto sia in statica che in dinamica. L'analisi fornisce diverse informazioni sulle pressioni scambiate tra piede e terreno, sulla stabilità, sulla distribuzione del peso corporeo, sui sovraccarichi metatarsali, retropodalici e digitali. Individua inoltre le proiezioni a terra dei vari baricentri e le distribuzioni del carico del corpo in statica e nella deambulazione; evidenzia la curva di svolgimento del passo (andamento del baricentro generale del corpo durante il passo). Il tutto al fine di individuare anomalie del piede ed eventuali complicazioni che possano riflettersi sulla struttura corporea o sulla postura stessa. In sintesi l'esame baropodometrico si suddivide in: a) Esame Statico: b) Distribuzione delle pressioni con zone di ipercarico c) Visualizzazione della proiezione del baricentro corporeo e dei centri di pressione dei due singoli piedi d) Percentuali di carico rispetto al baricentro Esame Dinamico: a) Immagini complessive del/i passo/i b) Curva di trasferimento del carico c) Corse del baricentro d) Punto virtuale dell'applicazione del carico e) Visualizzazioni pressioni, tempi e percentuali di contatto nelle fasi d’appoggio. 131 Il tipico output di un esame baropodometrico è rappresentato da una mappa in scala di falsi colori 5.3 Trattamento e analisi dei dati Sono stati somministrati 4 trattamenti distanziati tra loro di una settimana e gli esami baropodometrici sono stati eseguiti primadell’inizio della prima seduta di trattamento e alla fine, dopo la quarta seduta. Sarebbe stato più corretto testare con test fasciale anche la frequenza dei trattamenti ma per questioni di tempo di stesura della tesi e difficoltà nell’accordarsi con i soggetti per svolgere gli esami e rispettare esattamente la data degli appuntamenti, abbiamo deciso di adottare tale format. L’analisi dinamica fornisce delle statistiche registrando per qualche minuto una camminata tipo del soggetto oggetto di esame. Da questo tipo di esame possiamo estrapolare una serie di dati come le zone d’ipercarico, analizzando la media dei passi dell’intera camminata registrata (visualizzata visivamente), la lunghezza del passo, tempo del passo, la swing phase o fase aerea, la rotazione del piede. Quello che cerchiamo, da uno studio di questo tipo, è un cambiamento e una redistribuzione nel carico podalico ovvero, una distribuzione più uniforme e più fisiologica per il soggetto dopo averlo trattato “esclusivamente” con metodo E.T.R. Come già enunciato, l’attuale scarsità del campione in termini quantitativi e la non sufficiente quantità di tempo affinchè avvenga un più fisiologico riadattamento dell’organismo ad un lavoro così puntuale e profondo ma 132 “educato e gentile con il corpo” come quello ottenuto con il metodo E.T.R., non ci consente di sbilanciarci sull’esito dell’esperimento perché servirebbe un campione considerevole e, sarebbe doveroso domandare al corpo, con test fasciale, la frequenza delle sedute e, probabilmente, occorrerebbe affinare una serie di accorgimenti in sede di rilevazione dei dati durante l’esame baropodometrico. Detto ciò, visto e considerato che nulla costa, in questa sede, trarre delle seppur fievoli considerazioni e conclusioni sull’esito del nostro esperimento con 6 soggetti e quattro sedute di trattamento completate in un mese. Di seguito riportiamo la sintesi dei dati delle rilevazioni baropodometriche per ogni soggetto osservato, prima e dopo il trattamento e i dati relativi ad ogni seduta, in particolare modo, abbiamo riportato lo studio delle primarietá, vero fulcro della nostra ricerca per cercare di capire se il piede sia adattivo o causativo della “disfunzione osteopatica”. La difficoltà di riuscita di tale prova è giustificata dal fatto che l’ipotesi che sta alla base del nostro studio è che il percorso lesionale che conduce al manifestarsi di tale sofferenza dell’alluce che va a divenire “disfunzione osteopatica”, è un percorso “strutturato” da tempo considerevole Analizzeremo, di seguito, in maniera descrittiva un soggetto dei 6 del nostro studio e spiegheremo in maniera dettagliata l’esame baropodometrico e le differenze dell’analisi prima del ciclo di sedute a cui il soggetto è stato sottoposto sia in analisa statica che in quella dinamica, analizzando il passo in tutte le sue componenti. E’ stato analizzato lo studio delle primarietà trovate con il metodo E.T.R. 133 per ogni seduta, al fine di trarre delle conclusioni sulla causalità o adattività del piede in uno schema lesionale e riadattivo del corpo che poi ha sfociato nel disturbo preso in esame. Gli esami degli altri soggetti del nostro studio, per motivi pratici, riportati in allegato della presente tesi ma verrà stilata una sintesi per ogni soggetto preso in esame 134 5.3.1 Trattamento con Metodo E.T.R. Trattamento del 02-10-2017: 1° SEDUTA I pallini rossi nella figura umana schematizzata indicano, come da metodo E.T.R., le dismetrie dei punti di repere che prendiamo in considerazione e, cioè, masse laterali dell’occipite, tubercoli trapezioidali delle scapole, le sips e le basi sacrali. 1° Giro Oscillazioni: Movimento a otto, si ferma in craniosacrale. Tendine centrale: Alto strutturale non accorcia. Gamba rigida: Sx 135 Ricerca primarietà: scarico surrene sx 2° Giro Oscillazioni: Movimento ad 8, si ferma in craniosacrale. Tendine centrale: Alto strutturale non accorcia. Gamba rigida: Sx Ricerca primarietà: Trapezio superiore Dx 136 3° Giro. Primarietà: Rene dx in aptosi di 2 grado. 137 4° Giro Primarietà: Vescica 138 Trattamento del 09-10-2017 : 2° SEDUTA 1° Giro Oscillazioni: si ferma in strutturale Tendine centrale: Alto strutturale non allunga. Gamba rigida: Sx Ricerca primarietà: membrane a tensione reciproca (Grande falce del cervello e tentorio del cervelletto) 139 2° Giro Oscillazioni: Si ferma in strutturale. Tendine centrale: Alto strutturale non accorcia. Gamba rigida: Sx Ricerca primarietà:Paracervicale dx. 140 3° Giro. Oscillazioni: Si ferma in craniosacrale Ricerca primarietà: Osso sacro 141 Trattamento del 13-10-2017 : 3° SEDUTA 1° Giro Oscillazioni: Si ferma in strutturale. Tendine centrale: Medio non accorcia. Gamba rigida: dx 142 Ricerca primarietà: K4 sx in superiorità. 2° Giro Oscillazioni: Si ferma in strutturale. Tendine centrale: Alto strutturale non accorcia. Gamba rigida: Sx Ricerca primarietà: Paracervicale sx 143 Trattamento del 19-10-2017 : 4° SEDUTA 1° Giro Oscillazioni: Movimento ad 8, si ferma in craniosacrale. Tendine centrale: basso non allunga. Gamba rigida: Sx Ricerca primarietà: Ascolto del cranio 144 Per una questione di spazio nella stesura della presente tesi, i dati relativi ai restanti 5 soggetti verranno sintetizzati ma verranno riportati in allegato i relativi esami baropodometrici, per un confronto esaustivo.In questa sede verrà riportato per ciascun soggetto lo studio delle primarietà o spine irritative, al fine di un confronto statistico. 5.2.1 Esame baropodometrico e analisi del passo SOGGETTO #1 Tabella 5.1 – analisi statica – prima dei trattamenti E.T.R. 145 Tabella 5.2 – analisi statica – dopo ciclo di trattamenti E.T.R. 146 Tabella 5.3 – analisi statica – prima del ciclo di trattamenti E.T.R. La tabella presenta al primo esame una dislocazione delle forze tendenti al lato sinistro con un ipercarico retro podalico del piede SX. Si può osservare come il baricentro o Centro di forza o COP si deviato 147 orizzontalmente di 7,8 mm a sx e deviato verticalmente di 12mm in alto. I parametri riguardanti l’ellisse ci descrivono le oscillazioni con il soggetto in statica e qui si può osservare come esso stia oscillando leggermente. 148 Tabella 5.4 – analisi statica – dopo ciclo di trattamenti E.T.R Come si evince dal confronto delle due tabelle, il soggetto presenta ora un assetto più normale con forze tendenti a valori di normalità (48% sul piede sx e il 52% circa sul piede dx). 149 Il COP indica una normalizzazione orizzontale del centro di forza che passa da 7,8mm sx a 1,7mm sx e un significativo cambio della deviazione verticale da 12mm superiore a 12,9mm inferiore. Tabella 5.5 – analisi dinamica 150 Tabella 5.6 – analisi dinamica – prima del ciclo di trattamenti E.T.R La tabella 5.6 rappresenta un report con il ciclo completo del passo (Gait Cicle), visualizzato in arto sinistro e arto destro. Risposta di carico, ampiezza, attacco del tallone, stacco dell’alluce, fase statica, supporto singolo, doppio supporto, ecc. 151 Tabella 5.7 – analisi dinamica – dopo ciclo di trattamenti E.T.R 152 Tabella 5.8 – analisi dinamica – prima del ciclo di trattamenti E.T.R Il grafico denominato “Butterfly” rappresenta la cosiddetta “simmetria laterale”, cioè la ricapitolazione grafica di decine di passi consecutivi (tabella 5.10 e 5.11) al fine di evincere eventuali dominanze tra arto destro e sinistro. Si può notare come le ali della cosiddetta “BUTTERFLY” o 153 farfalla non siano tra di loro simmetriche e questo sta ad indicare una notevole diversità tra il passo sx e il passo dx in tutte le sue componenti. Tabella 5.9 – analisi dinamica – dopo ciclo di trattamenti E.T.R 154 Dal confronto delle due tabelle del grafico “BUTTERFLY” si nota come non ci sia dominanza di un piede sull’altro Ciò è visibile da una rapida osservazione delle ali della farfalla diventate in seconda misurazione pressochè identiche rispetto alla prima misurazione “prima del ciclo dei E.T.R.” dove l’ala sx è più piccola rispetto a quella destra. Tabella 5.10 e 5.11 – analisi dinamica, confronto dei passi prima e dopo ciclo di trattamenti E.T.R Dal confronto nel riquadro “Average” del prima e post trattamento, si può osservare una redistribuzione del carico podalico nell’avampiede soprattutto nel piede sx. 155 Tabella 5.12 – analisi dinamica – prima del ciclo di trattamenti E.T.R 156 Tabella 5.13 – analisi dinamica – dopo ciclo di trattamenti E.T.R 157 5.3.3 Sintesi dei restanti soggetti analizzati SOGGETTO #2 Riassunto analisi dei dati esame baropodometrico Il confronto è tra l’esame iniziale del 25/09/2017 ed il finale del 06/11/2017. L’esame statico mostra una distribuzione migliore dei carichi, ripartiti più equamente. Il baricentro è ben stabilizzato. La fase dinamica non mostra particolari differenze, con un marcato ipercarico soprattutto in corrispondenza della teste metatarsali. In dinamica si puù notare una leggera instabilità nell’area compresa tra mesopiede ed avampiede. Risulta comunque importante la pressione esercitata al momento dello stacco del I dito a sx. Studio delle primarietà Trattamento del 11-10-2017 : in ordine: surrene sx, dura madre compressa, duodeno, surrene sx Trattamento del 18-10-2017 : in ordine: surrene sx, diaframma buccale. Trattamento del 25-10-2017 : in ordine: surrene sx,. Trattamento del 3-11-2017: IL soggetto non necessitava di un trattamento. 158 SOGGETTO #3 Il soggetto riferisce dolorabilità all’alluce sx e insensibiltà sulla punta dell’alluce sx. Riassunto analisi dei dati esame baropodometrico Il confronto è tra l’esame iniziale del 09/11/2017 ed il finale del 06/12/2017. L’analisi statica iniziale mostra una dislocazione delle forze tendenti al lato destro con un ipercarico sull’avampiede del piede DX. Si può osservare come il baricentro o Centro di forza o COP sia deviato orizzontalmente di 21,8 mm a dx e deviato verticalmente di 15,8mm in basso. Esso indica una discreta instabilità con continui e ripetuti spostamenti laterali, posteriori e anteriori. Dopo il ciclo di trattamenti si può osservare una normalizzazione orizzontale del centro di forza che passa da 21,8mm dx a 1,6mm sx e un cambio della deviazione verticale da 15,8mm superiore a 12,3mm inferiore Come si evince dal confronto delle due tabelle in analisi statica, il soggetto presenta ora un assetto più normale con forze tendenti a valori di normalità (48,7% sul piede sx e il 51,3% circa sul piede dx rispetto alla misurazione iniziale che indicava 47,2% sul piede sx e il 52,8% circa sul piede dx). La dinamica mostra un ipercarico in quasi tutta la zona metatatrsale (tranne sul I metatarso bialterale), con una tendenza a pronare il retropiede e supinare l’avampiede bilateralmente. Dal confronto delle due tabelle del grafico “BUTTERFLY” si nota come nella sconda misurazione non ci sia dominanza di un piede sull’altro 159 Ciò è visibile da una rapida osservazione delle ali della farfalla diventate in seconda misurazione pressochè identiche rispetto alla prima misurazione “prima del ciclo dei E.T.R.” dove l’ala sx è più piccola rispetto a quella destra. Nella tabella di pag.6 dell’analisi dinamica si può osservare vi sia un più equo carico su tutto il gate cycle con una pressione più uniforme su entrambi i piedi mentre nella misurazione iniziale il carico pressorio era sbilanciato sul retropiede e avampiede del piede sx. Studio delle primarietà Trattamento del 11-11-2017 : in ordine: ascolto del cranio, osso sacro in craniosacrale, paracervicale dx Trattamento del 17-11-2017 : in ordine: aponeurosi lombare, esofago in inspiro, duodeno Trattamento del 23-11-2017 : in ordine: trapezio alto dx, scapola dx. Trattamento del 30-11-2017: controllo soggetto, nessuna primarietà da trattare. Il Soggetto riferisce la scomparsa del dolore e un netto miglioramento dell’insensibilità della punta dell’alluce sx. 160 SOGGETTO #4 42 anni. Lamenta una lieve dolorabilità sull’alluce sx ed una lieve sciatalgia sulla gamba sx. Il confronto è tra l’esame iniziale del 10/10/2017 ed il finale del 27/10/2017. L’analisi statica iniziale mostra una dislocazione delle forze tendenti al lato destro con un ipercarico sul retropiede del piede DX. Si può osservare come il baricentro o Centro di forza o COP sia deviato orizzontalmente di 17,2 mm a dx e deviato verticalmente di 35,5mm in basso. L’ellisse e il relativo gomitolo indicano una leggera instabilità con leggere oscillazioni anteriori e verso l’avampiede dx di 20,2 gradi. Dopo il ciclo di trattamenti si può osservare una normalizzazione orizzontale del centro di forza che passa , quindi, da 17,2mm dx a 2,6mm dx e un cambio della deviazione verticale da 35,5mm superiore a 21,9mm inferiore Come si evince dal confronto delle due tabelle in analisi statica, il soggetto presenta ora un assetto più normale con forze tendenti a valori di normalità (47,6% sul piede sx e il 52,4% circa sul piede dx rispetto alla misurazione iniziale che indicava 45,4% sul piede sx e il 54,6% circa sul piede dx). La dinamica, nella rilevazione iniziale, mostra un ipercarico in quasi tutta la zona metatatrsale (soprattutto sul 3° metatarso dx) con una tendenza a pronare il retropiedebilateralmente e supinare l’avampiede a dx. Nella seconda misurazione si può osservare una redistribuzione del carico 161 che passa da una situazione di ipercarico delle prime teste metatarsali ad una situazione dove l’ipercarico lo troviamo sulla 3° e 4° a dx e sulla 4° e 5° testa metatarsale sul piede sx. Si osserva un miglior appoggio sul retropiede in entrambi i piedi. Quello che salta maggiormente da un’analisi visiva è come non ci sia più un carico massimo così gravoso sulle teste metatarsali, soptattutto sulle prime. Dal confronto delle due tabelle del grafico “BUTTERFLY” si nota come nella sconda misurazione i passi siano più simili l’uno con l’altro e lo si può osservare dalla vicinanza dellle linee che quasi si sovrappongono rispetto alla prima misurazione che denota una incertezza e diseguaglianza e instabilità dei passi e, questo lo si può osservare dalla distanza delle linee che quasi mai si sovrappongono. Si osserva inoltre dal confronto delle due tabelle un cambio del vertice basso e del vertice basso dell’ala della farfalla di dx che indica come il passo inizi più medialmente nel retropiede e vado cmq a gravare sulla 3° testa metarsale. Studio delle primarietà Trattamento del 11-10-2017 : in ordine: C1 sx, massetere sx, osso sacro in craniosacrale, K8 sx in superiorità (riferisce in seguito di averla fratturata nel parto), consolidamento con tecnica di scarico del surrene sx. Trattamento del 19-10-2017 : La signora riferisce la scomparsa totale del dolore all’alluce e della 162 sciatalgia fino a due giorni fa. Ora riferisce una lieve sciatalgia e la somparsa del dolore all’alluce. Primarietà: dura madre compressa, scarico surrene Trattamento del 3-11-2017 : Non riferisce dolore. I reperi sono ben allineati e non oscilla. Da test fasciale, non necessita di trattamento odierno. SOGGETTO #5 40 anni. Il soggetto lamenta una discreta dolorabilità sull’alluce sx Il confronto è tra l’esame iniziale del 30/08/2017 ed il finale del 02/10/2017. L’analisi statica iniziale mostra una dislocazione delle forze tendenti al lato sinistro sul retropiede mediale e sul avampiede sulla 3° testa metastarsale sia a sx che a dx ma, con un leggero ipercarico. Quello che salta all’occhio dall’osservazione in analisi statica è il totale piattismo del piede dx. Si può osservare come il baricentro o Centro di forza o COP sia deviato orizzontalmente di 13,6 mm a sx e deviato verticalmente di 0,3mm in basso. L’ellisse e il relativo gomitolo indicano una leggera instabilità con leggere oscillazioni anteriori e verso l’avampiede sx. Dopo il ciclo di trattamenti si può osservare una normalizzazione orizzontale del centro di forza che passa , quindi, da 17,2mm dx a 2,6mm dx e un cambio della deviazione verticale da 35,5mm superiore a 21,9mm inferiore Come si evince dal confronto delle due tabelle in analisi statica, il soggetto 163 presenta ora un assetto più normale con forze tendenti a valori di normalità (47,6% sul piede sx e il 52,4% circa sul piede dx rispetto alla misurazione iniziale che indicava 45,4% sul piede sx e il 54,6% circa sul piede dx). La dinamica, nella rilevazione iniziale, mostra un ipercarico in quasi tutta la zona metatatrsale (soprattutto sul 3° metatarso dx) con una tendenza a pronare il retropiedebilateralmente e supinare l’avampiede a dx. Nella seconda misurazione si può osservare una redistribuzione del carico che passa da una situazione di ipercarico delle prime teste metatarsali ad una situazione dove l’ipercarico lo troviamo sulla 3° e 4° a dx e sulla 4° e 5° testa metatarsale sul piede sx. Si osserva un miglior appoggio sul retropiede in entrambi i piedi. Quello che salta maggiormente da un’analisi visiva è come non ci sia più un carico massimo così gravoso sulle teste metatarsali, soptattutto sulle prime. Dal confronto delle due tabelle del grafico “BUTTERFLY” si nota come nella sconda misurazione i passi siano più simili l’uno con l’altro e lo si può osservare dalla vicinanza dellle linee che quasi si sovrappongono rispetto alla prima misurazione che denota una incertezza e diseguaglianza e instabilità dei passi e, questo lo si può osservare dalla distanza delle linee che quasi mai si sovrappongono. Si osserva inoltre dal confronto delle due tabelle un cambio del vertice basso e del vertice basso dell’ala della farfalla di dx che indica come il passo inizi più medialmente nel retropiede e vado cmq a gravare sulla 3° testa metarsale. 164 Studio delle primarietà Trattamento del 04-09-2017 : Oscillazione: misto avanti- rotazione, si ferma in craniosacrale. Tendine centrale: medio viscerale non allunga. Primarietà: esofago bloccato in superiorità. 2° Giro: oscillazione leggermente in avanti e si ferma in strutturale Primarietà: riequilibrio del sacro. 3° Giro: Oscillazione : si ferma in craniosacrale Primarietà: lingua, sfenoide bloccato in estensione 4° giro: Primarietà: Muscolo trasverso dell’addome dx, Psoas sx, massetere sx. 5° Giro: oscillazione minima in avanti e si ferma in viscerale. Primarietà: dura madre in craniosacrale 6° Giro Oscillazione: si ferma in strutturale Primarietà: suboccipitali a sx. 7° Giro: Oscillazione si ferma in viscerale Primarietà:colon discendente bloccato in superiorità 8° Giro: Oscillazione: si ferma in craniosacrale 165 Primarietà: scarico surrene sx 9° Giro: Oscillazione: si ferma in viscerale Primarietà: scarico surrene sx 10° Giro: Oscillazione: si ferma in craniosacrale Primarietà: core link Trattamento del 11-09-2017 : 1° Giro: oscillazione: si ferma in viscerale Primarietà: lunghissimo del collo 2° Giro: Oscillazione : si ferma in strutturale Primarietà: Parevertebrale lombare dx 3° giro: Primarietà: Muscolo trasverso dell’addome dx, Psoas sx, massetere sx. 4° giro: Oscillazione: si ferma in craniosacrale Primarietà: diaframma cupola dx. 5° Giro: Primarietà: processo xifoideo 6° Giro: Primarietà: quadricipite dx da allungare 7° Giro: 166 Primarietà: trapezio dx da allungare. 8° Giro: Riequilibrio sacrale Trattamento del 19-09-2017: Primarietà: In ordine: Polmone dx(lobo inferiore cloccato in inspiro; Atm dx; Muscolo stilo faringeo; scarico surrene sx; Esofago bloccato in inspiro; Decompressione mandibola; diaframma stiloioideo; Muscolo faringopalatino; scarico surrene sx. Trattamento del 25-11-2017 : Primarietà: in ordine: Vescica in inferiorità, paracervicale sx da allungare; serrato posteriore da allungare; trapezio allungare; Paravertebrale lombare. 167 CONCLUSIONI Con l’esperimento da noi eseguito abbiamo dimostrato come una disfunzione osteopatica come l’alluce valgo possa essere affrontata con l’osteopatia, Il Metodo E.T.R. ci ha aiutato nell’affrontare i nostri casi studio con una consapevolezza diversa senza preconcetti o schemi terapeutici prefissati, esplorando il corpo e facendoci guidare da esso. Il risultato ottenuto è estremamente positivo ha dimostrato come sia possibile, attraverso il suo corretto utilizzo, un notevole “RIEQUILIBRIO” del sistema corpo mente spirito , riequilibrio che poi è stato tradotto in un maggior benessere e in un deciso miglioramento della dolorabilità del piede. Come possiamo osservare dai risultati ottenuti negli esami baropodometrici, una redistribuzione del carico podalico dove non ci siano dei picchi pressori così forti, come quelli che abbiamo analizzato su tutti i soggetti al primo esame, si traduce in un miglioramento della dolorabilità sia in statica che in dinamica. Dopo il ciclo di trattamenti, tutte le persone dai noi analizzate riferiscono, inoltre, una maggiore stabilità e una maggiore consapevolezza del proprio corpo e una miglior postura. Osservando lo studio delle primarietà, siamo andati a risolvere primarietà per lo più discendenti. Maggiori considerazioni a riguardo possiamo trarle, a mio avviso, soltanto quando avremo un numero considerevole di soggetti per avere un campione 168 statisticamente attendibile. Lo scopo di questa tesi è inoltre quello di porre le basi per un’analisi futura per un più dettagliato studio con i canoni che ho descritto precedentemente. Per quel che riguarda il nostro piccolo esperimento, possiamo considerarci soddisfatti per i risultati ottenuti e ancora una volta possiamo confermare la grandezza e potenza del Metodo E.T.R. 169 BIBLIOGRAFIA: • Souchard Ph.E. Gymnastique classiche - Rééducation Posturale Globale: les raisons du • Jivorce. - Rééd. Post. Glob. ed Le Pousoé, 1983.5-13. • Morelli V. Bienfat M. Aromonizzazione statica globale. Metodo delle tre squadre • Marrapese editore Roma 1990 • Souchard Ph.E. Il diaframma. Marrapese editore Roma 2 edizione 1995 • Souchard Ph.E. La respirazione. Marrapese editore Roma 1996 • Bousquet L. Le catene muscolari vol.2 tronco e colonna. Marrapese editore Roma • Godelieve D.S. Il manuale del mezierista vol.1 Marrapese editore Roma1996. • Souchard Ph.E. Il campo chiuso. Marrapese editore Roma 1994 • Souchard Ph.E. RPG Rieducazione Posturale Globale. Marrapese editore Roma 1994 • Kapandji A. Fisiologia Articolare vol. 3 Manduzzi editore 1994 • Netter F.H. Atlante Anatomia Umana Elsevier editore IV edizione 2011 • Bricot B. La Riprogrammazione Posturale Globale Marrapese editore Roma 1999 • Wilmore J.H Costill D.L Fisiologia dell’esercizio fisico e dello sport Calzetti Mariucci 170 • editore Perugina 2005 • Aparecida M.M, Macher R., De Castro M, Amoroso B.L. Efeito de un programa de alongamento muscolar pèlo metodo RPG. Journal Brasieliro de Pneumologia.2007 • "Il pudore del Piede" Da Georges Bataille, “Documents”, trad. it. S. Finzi, Edizioni Dedalo, 1974. • Claudia Rainville - Metamedicina, ogni sintomo è un messaggio- Ed. Amrita • Michel Odoul - Dimmi dove ti fa male e ti dirò perché - Ed. Il punto d'incontro SITOGRAFIA • www.fisiobrain.com • www.rpg.com • www.pubmed.it • www.centrodiformazionelaglia.it 171