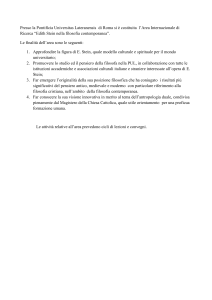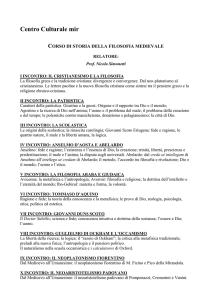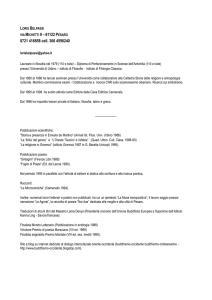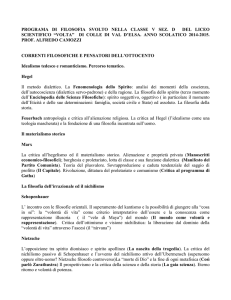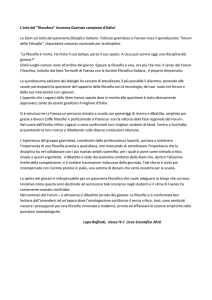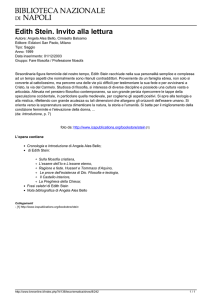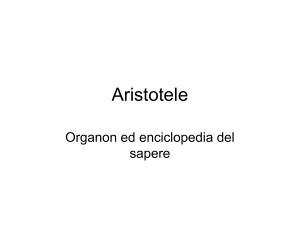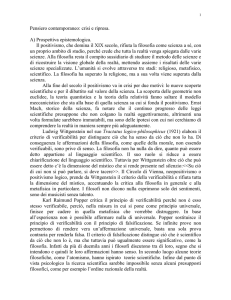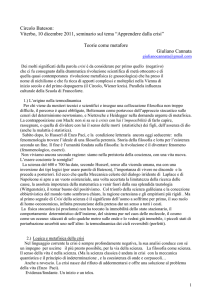RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XXII
NUOVA SERIE - N. 66 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2008
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento e dello stesso Dipartimento.
Parte di questa pubblicazione rientra nel Progetto di Rilevante Interesse Nazionale su “Fenomenologia, narrazione, riflessione etico-politica: testi e temi
del pensiero francese del Novecento”, a cui partecipano le Università di Bari,
Lecce, Roma Tre, Sassari e Verona.
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce), Antonio
Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio
Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo, Lucia
De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali, Università degli Studi – Via M. Stampacchia – 73100 Lecce – tel.
(0832) 294627/8; fax (0832) 294626. E-mail: [email protected]
Questa rivista è anche sul sito: siba2.unile.it/ese
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto I, 51
73016 San Cesario di Lecce – Tel. 0832/205577 – 0832/200373. Iscritto al n.
389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo:
Italia t 30,00, Estero t 45,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni
s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo t 12,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nel settembre 2008 - per conto di Piero Manni s.r.l.
SOMMARIO
5
María Zambrano
ANTONIO MACHADO, HOMBRE PENSATIVO
22
Orlando Todisco
LA VOLONTÀ COME RESPONSABILITÁ IN G. DUNS SCOTO
47
Letizia Santangelo
NICHILISMO E NUOVE POSSIBILITÀ.
HEIDEGGER E ARENDT
59
Veronica Natella
L’ESILIO DAL RUOLO SOCIALE IN CASA DI BAMBOLA DI IBSEN NELL’INTERPRETAZIONE DI EDITH STEIN E ANTONIO GRAMSCI: UN CONFRONTO
76
Santo Arcoleo
NEL MAGMA DELL’ESISTENZA.
UN PERCORSO TEORETICO AL SEGUITO DI M. CONCHE
84
Filippo Palumbo
K E LA NON-DOMANDA
93
Patrizia Manganaro
ANTI-EGOLOGIA DELLA RAGIONE
ED ESPERIENZA ETERO-CENTRATA.
NOTE SUL CONTRIBUTO DELLA FENOMENOLOGIA
ALLA FILOSOFIA DELLA MISTICA
102
Cosimo Caputo
LA DIMENSIONE SIGMA
115
Pierandrea Casto
LA FAMIGLIA TRA LA COSTITUZIONE
E I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ
130
Recensioni
3
4
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano.
Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo può essere inviato anche su floppy disk, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Si può utilizzare preferibilmente l’email: [email protected]. Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
“Segni e comprensione” è disponibile in edizione telematica sul sito http://siba2.unile.it/ese,
alla pagina Publications. Ogni numero sarà scaricabile due mesi dopo la pubblicazione cartacea della rivista.
ANTONIO MACHADO, HOMBRE PENSATIVO
Nota introduttiva di Benedetto Mento
Il pensiero di María Zambrano intende coniugare due ambiti talora ritenuti
antinomici dalla filosofia classica: la ragione e la poesia. La prima è stata il fondamento della logica e dunque della speculazione filosofica occidentale, mentre la seconda appartiene all’ambito dell’immaginazione, dell’arte e delle emozioni guidate dai sentimenti.
La filosofa spagnola ricerca la verità allargando l’orizzonte speculativo all’integrità dell’animo umano, non solo alla mente ma anche e soprattutto a
tutto ciò che è stato trascurato dal pensiero moderno: la congiunzione tra
mente e anima, tra mondo maschile e femminile, l’unione degli opposti, lo
scandaglio dell’oscurità, del nulla, del silenzio e del mistero della vita. Tutti
nuclei tematici, questi, non di rado trascurati dalla filosofia occidentale. La
scrittura dell’autrice risente dunque dell’insegnamento poetico e solo l’incontro tra filosofia e poesia, fra la logica deduttiva e l’irrazionalità dei sentimenti, può condurre ad un nuovo modo di conoscere e conoscersi, può prendere sul serio la complessità di quell’esistenza i cui diversi ambiti sono stati assunti quale oggetto di distinte discipline teoriche. Ella auspica quindi una
contaminazione proficua della filosofia con la vita, permettendo a quella di allontanarsi dal pensiero astratto per rendersi finalmente significativa, necessaria alla vita di ognuno.
María Zambrano fu appassionata lettrice di uno dei maggiori poeti spagnoli del suo tempo, Antonio Machado, poeta-filosofo, per lei compiuta ipostasi di
hombre pensativo. La poetica di Machado è basata sulla concezione dell’arte
come espressione di un mondo affettivo ed essenzialmente aliena dagli eccessi dell’intellettualismo. Essa è caratterizzata da un attitudine fondamentale del
sentimento la quale alimenta la meditazione su ciò che costituisce la sfera affettiva dell’uomo:
L’intelletto non ha mai cantato, non è la sua missione. Serve, ciononostante, alla poesia, segnalandole l’imperativo della sua essenzialità. Perché
neppure esistono poesie senza idee, senza visioni dell’essenziale. Le idee
del poeta però non sono categorie formali, capsule logiche, bensì intuizioni dirette dell’essere che diviene, della sua propria esistenza; sono dunque temporali, mai elementi esistenzialisti acronici, nelle quali il tempo
raggiunge un valore assoluto. Inquietudine, angoscia, timori, rassegnazione, speranza, impazienza che il poeta canta, sono segni del tempo e, in
ugual maniera, rivelazioni dell’essere nella coscienza umana1.
SAGGI
di María Zambrano
5
L’incontro della filosofa con Machado risale alla sua adolescenza: nel 1919
suo padre, Blas Zambrano, conobbe il poeta e strinse con lui una sincera amicizia, tanto che quest’ultimo, molti anni dopo, gli avrebbe dedicato una composizione per commemorarne la scomparsa.
María Zambrano tributa grande attenzione alla poesia di Machado, che non
è mai intesa come un fantasticare fine a se stesso, ma quale mezzo per indagare il mondo circostante al di là degli stereotipi, attraverso la sperimentazione delle parole, della frase e del linguaggio, piegando la logica dei significati e
della sintassi, al fine di rendere la poesia aderente alla sua funzione chiarificatrice, esemplare e magistrale.
In un poemetto della raccolta Galerías, Machado afferma:
L’anima del poeta
Si orienta verso il mistero2.
Una dialettica serrata, tra il mistero e la coscienza di esso, attraversa l’opera di Machado; pertanto, non bisogna lasciarsi vincere dalla suggestione di ciò
che è indefinibile, ma cercare di penetrarvi con un costante lavorio poetico. In
una lettera del 1904, Miguel de Unamuno gli scrive:
6
Tutti i nostri sforzi devono tendere verso la luce, verso la coscienza… la
bellezza non risiede tanto nel mistero, piuttosto nel desiderio di penetrarlo3.
Nelle prime raccolte, influenzato dal simbolismo, Machado esprime questo
mistero metaforicamente con il “mare” e con il carattere enigmatico della realtà che il poeta ha il compito di svelare, trasformando in parole la voce inespressa del mondo, il suo silenzio. Si viene formando in tal modo la figura del poeta come ermeneuta di un universo di segni e voci inespresse, che assurge a
poeta-profeta, inteso nel senso che ne dà Miguel de Unamuno: profeta non è
colui dotato del dono della premonizione bensì colui che si arrischia a rivelare
ciò che gli altri tacciono o fingono di non vedere per il timore di lasciarsi travolgere dall’ignoto. Così, alla dialettica coscienza-mistero si affianca quella di silenzio-parola:
Non disdegnate la parola
Il mondo è rumoroso e muto;
Poeti, solo Dio parla4.
L’unità tra poesia e filosofia si mantiene lungo tutto l’arco della sua opera,
e nella vita del poeta Machado vi è una lenta e ininterrotta evoluzione in senso spirituale, un progressivo sforzo di accostarsi al vero. Negli ultimi anni egli
continuerà a ribadire le sue posizioni: così, ad esempio, nella poesia Sobre las
imagenes de la lirica, dove polemizza con l’avanguardia fine a se stessa, meramente ludica, sostenendo invece la poesia attenta alla soggettività, per rivendicare il momento logico-discorsivo a fianco di quello intuitivo e magico.
La nuova oggettività verso la quale si indirizza oggi l’arte e che io perseguo da vent’anni non può consistere nella lirica – ora lo vedo molto chiaramente – ma nella creazione di nuovi poeti – non nuova poesia – che
cantino di voce propria5.
E, per bocca di Juan de Mairena, egli afferma:
Ogni poeta presuppone una metafisica; persino ogni poesia dovrebbe
avere la sua – implicita – ovviamente – mai esplicita –, e il poeta ha il dovere di esporla, separatamente, con concetti chiari. La possibilità di fare
ciò distingue il vero poeta dal mero signorino che compone versi6.
SAGGI
Posizioni, queste, che l’autore confermerà nelle Reflexiones sobre la lirica, nel
Discurso de ingreso alla Accademia de Espana e nelle riflessioni poetiche in
Juan de Mairena. Machado a tal riguardo scrive:
Machado infonde nella sua poesia una metafisica che espone a sua volta
nei suoi scritti teorici con assoluta coerenza e onestà intellettuale. María Zambrano riprenderà sovente il suo insegnamento e troverà nel poeta una guida
nel silenzio del nulla:
Solo nel silenzio, che è, come diceva il mio maestro, ‘l’aspetto sonoro del
nulla’, può il poeta godere pienamente del grande regalo fattogli dalla divinità, affinché diventi cantore, scopritore di un mondo di armonie7.
Il pensiero di María Zambrano intende essere ‘guida’ allo sviluppo del pensiero e dei sentimenti con il sostegno concreto della poesia, e dunque non può
che attingere da un autore che ravvisa nella parola poetica l’organon della scoperta del mondo, così da rischiarare il percorso dell’uomo.
UN PENSATORE
Appunti8
di María Zambrano
[Frontespizio dattiloscritto. Fotocopia di un dattiloscritto recante delle correzioni a mano]
Mostrami, o Dio, la prodigiosa mano che fece l’ombra: la lavagna oscura
ove si scrive il pensiero umano9.
7
(Abel Martín, eteronomo di Antonio Machado, Los complementarios)
Leggendo un giorno luminoso
i miei beneamati versi,
ho visto nel profondo
specchio dei miei sogni
che una verità divina
tremando sta di paura,
ed è un fiore che vuole
spargere al suo aroma al vento10.
(Galerías, Introduzione)
Se un granello del pensare ardere potesse,
non nell’amante, nell’amore sarebbe
la più profonda verità ciò che si vedrebbe11.
(Da un Cancionero apócrifo, CLXVII)
8
Un pensatore, ma di un pensiero unico che esige, come è legge per ciò che
è unico, molteplicità di forme o di “generi”, e anche pluralità di persone in cui
darsi. L’uomo inabitato da un pensiero unico, talvolta a immagine e somiglianza della divinità, ha bisogno, oltre alla persona che porta il suo nome proprio e
manifesta il suo essere individuale, di altre persone che non sempre l’essere
così inabitato giunge a “creare”, a dare vita e forma a un essere al modo umano oppure che si voglia sovrumano. Poeta, per questo solo, è colui che vi riesce, come è il caso prodigioso di Antonio Machado. Poeta, anche se non avesse mai scritto poesie. Antonio Machado ci appare immediatamente come poeta sin dal principio; ma vediamo che cosa egli stesso intenda per “essere poeta”. Lo afferma in modo netto nella maturità quando, detto per inciso, tra gli elementi – “radici dell’essere” li chiamò il loro scopritore, Empedocle – il fuoco ha
gradualmente preso il sopravvento sugli altri nel suo pensiero: innanzitutto sulla terra, sull’aria e anche, senza evitarla, sull’acqua. Non ha evitato nessuno di
questi, ma l’acqua corre per le vene della sua poesia come se fosse il suo stesso sangue. Quel sangue che ogni parola deve avere senza cessare di essere
acqua: “Dí, per quale segreto canale,/ acqua, vieni sino a me,/ sorgente di vita nuova/ ove mai bevvi?”12, invoca allorché albeggia la sua maturità.
È nel Cancionero apócrifo (Juan de Mairena), nel capitolo “La metafisica di
Juan de Mairena” che leggiamo: “Ogni poeta – dice Juan de Mairena – presuppone una metafisica: forse ogni poesia dovrebbe avere implicita la sua – ovviamente mai esplicita – e il poeta ha il dovere di esporla, separatamente, in
concetti chiari. La possibilità di farlo distingue il poeta dal mero signorino che
compone versi”, citando dal Trattato di metafisica “Los siete reversos” [“I sette
‘a rovescio’”].
Ma questa metafisica risulta essere teologia, una singolare teologia della
quale sarebbe troppo semplice dire che inverta i termini dell’atto creatore secondo la teologia ebreo-cristiana: “Quando l’‘Essere che è’ creò il nulla” – dice
all’inizio del sonetto “Al gran Cero” [“Al grande zero”] di Abel Martín, che Mairena proclama “immortale” allorché lo commenta.
Ha, dunque, un duplice commento il sonetto rivelatore della sua singolare
SAGGI
teologia. Singolare perché non si tratta di muoversi in un pensiero all’interno di
una tradizione, codificandola o alterandola, ma del concepire l’essere divino
traendoselo fuori dalle viscere del sentire dell’uomo, di questo uomo, Antonio
Machado, minacciato egualmente dall’essere e dal nulla. E apertamente come
poeta, e non solo semplicemente come uomo, gli appaiono irrinunciabili sensazione e modi di sentire, e di pensare, diremmo prima di tutto. Modi di pensare che nascono dall’unico pensiero, dal suo fondo insondabile e che giungono ad essere un sentire proprio del pensiero. Poiché tale pensiero è proprio di
un essere finito, minacciato, ed anche ferito. Una specie di astro nell’universo.
Monade? Abel Martín ravvisa in Leibniz il filosofo dell’avvenire, quando esige
la restituzione all’universo della sua intimità.
Pura intimità è tale pensiero e non “interiorità dell’uomo”, agostinianamente. Sebbene dica “guardando un giorno luminoso13/ i miei beneamati versi/ ho
visto nel profondo/ specchio dei miei sogni/ che una verità divina tremando/ sta
di paura”. Il profondo specchio dei sogni riflette la verità divina, la mostra tremando. Manifesta forse il dentro del divino, che trema per offrirsi in uno specchio?
E questa verità divina “è un fiore che vuole spargere il suo aroma al vento”.
Al poeta dovrebbe bastare il vederla tremolare nello specchio dei suoi sogni e
assisterla, poiché ha paura, darle il suo alito di vita affinché effonda il suo aroma al vento. Ciò basterebbe forse a tutta una concatenazione di poeti, a tutta
una tradizione poetica, forse basterebbe alla poesia tutta. Ma ad Antonio Machado, poeta prima di tutto, no. Ciò vuole dire che la poesia tutta non gli basta.
Non si accontenta della verità divina, benché essa sia quella che chiede, quella che vuole effondere, come un fiore, il suo aroma al vento, nulla di più. Ma a
lui chiede di pensare affinché [si] compia il suo chiedere. E pensare, per quello che vediamo, è giungere sino a Dio stesso, sapere di lui, comprendere la
sua creazione per inserirsi in essa, così come spetta all’uomo-poeta. Fare
qualcosa o farsi dentro questa divinità?
E questa esigenza ultima di comprendere Dio viene ad essere in Machado
come ciò che è in Nietzsche, in Hölderlin, in Novalis – Unamuno non vi giunge
– un concepire Dio nella intimità del pensiero e dell’essere, quasi un ricrearlo.
E, sebbene sia solo come enunciato, diciamo che non cessa di essere alquanto sorprendente che si studino le “concezioni del mondo” mentre restano
fluttuanti queste concezioni di Dio o del divino che a partire dal Romanticismo
tedesco – Goethe per primo – giungono a darsi in poeti-filosofi e in filosofi-poeti, incluso Hegel14. La loro profondità, prossima o remota è, senz’alcun dubbio,
il Dio che il mistico concepisce, o il Dio per il quale egli muore nel concepirlo.
Eckhart, Böhme, san Giovanni della Croce. Ciò non vuole dire che quei poetifilosofi o filosofi-poeti seguano la stessa via del mistico inteso quale archetipo.
Al contrario, di Abel Martín, Mairena dice che ha scarsa simpatia per i mistici a
causa di questo separarsi dal mondo, dalla sensazione, dai sentimenti, dal
sensibile insomma. Rimane in piedi unicamente questo concepire il divino nell’intimità del pensare e sentire umano, questa ricerca dell’intimità insieme alla
divinità, dell’uomo e dell’universo intero.
E in questa ricerca più che dell’intimità, del dentro del divino, universale e
9
10
umano, l’eros è agente ineludibile, talora creatore. Abel Martín, nel quale l’eros
si stabilisce più che in chiunque altro dei suoi eteronomi, è un grande erotico,
ma non si rivela a noi platonicamente, a causa della bellezza, piuttosto in modo metafisico, poiché l’essere è eterogeneo. Da parte nostra aggiungiamo che
tale eros non entra dentro le profondità della carne. E non viene a mancare un
parallelismo tra il rifiuto del dio creatore giudeo-cristiano, quello di “Genesi”, e
questa assenza totale dell’eros carnale, del quale non vediamo apparire neanche un accenno nella poesia di Machado, né nella metafisica dei suoi eteronomi e neppure, per quanto lievemente, nei suoi Complementarios. E ciò appare in tale purezza che neppure si dà a vedere questa assenza della passione
della carne che chiede di riprodursi, di generare e… essere rigenerata nella resurrezione, che tanto fiammeggia nel pensiero di Miguel de Unamuno.
Questa assenza della passione della carne è agente di trasparenza tra Dio
e l’uomo. Le viscere dell’uomo non chiamano né reclamano; la loro inesistenza dà senz’altro luogo all’essere e al non essere, al pensare e al pensiero.
Questo essere non sogna di incarnarsi. Si direbbe che il mistero cristiano dell’Incarnazione non lo tocchi, né quello della passione o del dolore divino tocca
l’umano; “Non posso cantare né voglio/ quel Gesù del legno/ ma colui che andò per mare”15. Non chiede, allora, né accetta l’umanizzazione di Dio. Non esige di esistere. Non chiede neppure tempo. Di quale Dio si tratta? Poiché è rivelatore della divinità che si concepisce o si chiede di concepire, ciò che l’uomo le chiede: la supplica e la successiva offerta.
Abbiamo detto che ci offrono due generi di commento il sonetto “immortale” “Il gran Cero” e inoltre due poesie nei quali si approfondisce e, insieme, si
chiarisce: quella del suo autore Abel Martín e quella del suo discepolo Mairena. Notiamo appena che se non troviamo tracce di ansia di generazione né ansia esistenziale, per converso la relazione di Martín e di Mairena ci appare come una sorta di generazione del pensiero; dei modi di sentire e di pensare.
Una genesi del pensiero unico, il che rafforza la convinzione che si tratti di un
pensiero che desidera concepire e generare. Poiché deve essere un pensiero
d’amore.
***
Un pensiero unico, che prende tutta una vita umana, deve essere un certo
modo di essere pensiero o dell’essere del pensiero, che potrebbero e anche
dovrebbero fissarsi “a priori”. Ci appaiono immediatamente tre “a priori” di tale
pensiero unico: essere indistruttibile; possedere senza fare del soggetto in cui
si dà un “posseduto”; e, poiché prende per sé tutta la vita, darla. Essere allora
un pensiero che è vita. E, nell’essere pensiero veritiero, essere universale, trascendente. Contenere in sé qualche aspetto irrinunciabile della condizione
umana. Un imperativo che non necessariamente si enunci come tale, che andrà enunciandosi nel processo del suo compiersi, a seconda che vada manifestandosi non solo nel pensare, ma nel modo di vivere, di questo soggetto che
esso governa, e che tanto più docilmente lo seguirà quanto più andrà dimorando nella libertà. Ed egli stesso, l’uomo, Antonio Machado, andrà facendosi vi-
SAGGI
sibile, andrà manifestandosi. La sua più recondita intimità verrà a darsi, e non
soltanto nella parola e nella condotta, ma andrà piuttosto facendo di lui una figura inequivocabile, una forma indelebile e vivente, come se fosse nato intero
dal capo di Zeus come Pallade Atena, e armato come lei. Tanto inerme che vi
si vedeva che era nato. Poiché lungi dal cancellare l’essere della nascita, la
creatura nata, questa figura consona alla storia che non passa, la rivela o la fa
tralucere. Quel suo andare vacillante, cercando di non pesare sulla terra, sfiorava appena il terreno con i suoi piedi, e seduto si raccoglieva e si ritraeva, pure, tendendo a cancellarsi; poiché non occupava spazio si sentiva che era così. La sua “goffaggine”(torpeza) nei movimenti non era altro che resistenza all’occupare dei luoghi, a dire “qui sono io”. Corpulento, scivolava via andando
tra le genti, si affilava come per attraversare un labirinto. Soltanto quando parla della “polis” e più in là di essa, si direbbe che, dinanzi a un occhio invisibile
che lo guardava, si ergeva e rimaneva saldo, scoperto, “quasi nudo” come uno
dei “figli del mare”, e ancor prima di salire a bordo di qualsiasi nave.
Un pensiero indistruttibile, dunque, che se distrugge lo farà concentrando,
distillando (alquitarando) e – qualora osassimo – diremmo purificando in
un’ascesi non dichiarata, come se l’azione senza posa di un fuoco sottile, dello stesso pensiero, si esercitasse di per sé all’oscuro del soggetto, che così
conserva il suo candore guadagnando in saggezza. “Cuore maturo di ombra e
di scienza”16.
Quanto maggiore sia l’indistruttibilità di questo pensiero, tanto più ce ne sarà bisogno per pensarsi e viversi al contempo. Ciò che potrebbe forse essere
un atomo, una figura enigmatica, solo una parola, richiede più modi di manifestazione, di espressione. Anche perché questo pensiero non giunge a darsi nel
servire da espressione a un individuo, nel soddisfare una passione mediocre.
Chiede verità e realtà a un tempo, come un essere che è già di per se stesso.
E offre pienezza dentro la quale colui che l’arreca può rimanere seminascosto,
senza apparire compiutamente, quasi anonimo, come avvenne a Miguel de
Cervantes. Il cuore stesso è la sua dimora e il pensare il suo ufficio indispensabile, e persino richiederebbe il sangue, e lo chiede, in effetti, quando deve
inverarsi, facendo dello spargersi del sangue qualcosa di universale. E se apre
qualche ferita è la ferita dell’uomo senz’altro; cancella le caratteristiche individuali, si alimenta di esse, per così dire, o le lascia sotto un velo che accentua
il mistero ultimo di questa vita singolare e, tra tutti insieme, si fa in uno solo e
gli conferisce solitudine essendo in principio per tutti gli uomini. E perciò è veramente pensiero. È una proposizione ineludibile dell’umano, un teorema, in
certo modo, che si rende vero facendo dell’uomo un uomo vero.
Un pensiero, allora, dotato di vita propria che fa dell’uomo ove abita, prima
che un filosofo o un saggio o un poeta dispiegato, un pensatore, un meditativo, un essere pensante a ogni ora, fin nei sogni, come è in Antonio Machado,
archetipo di questa specie di esseri pensanti.
E poiché da secoli di “cultura occidentale”, allorché si tratta di pensare si intende che deve esserci soltanto o, meglio, essere soltanto colui che pensa;
che, insomma, deve essere un esistente, bisogna mostrare in seguito che questa specie di pensatore non sarà mai sola, sebbene ci dica da subito delle sue
11
12
“solitudini”. Ciò in quanto queste solitudini non provengono da quel genere di
solitudine dell’uomo senza mondo e senza dio, senza essere e senza sogni. E
nemmeno dal dubbio alla maniera cartesiana. Bisogna intendere tali solitudini
come una pienezza di un essere balbuziente che si affaccia, con un’innocenza che non perderà mai, all’universo. E che sa con immediatezza del suo luogo proprio, e della sua condizione nel pensiero. Sta sotto l’ombra e al fianco
del pensiero vivo: dentro l’essere pensante e senza distaccarsi da esso, configurandolo, imprimendovi il sigillo, proprio come alcune creature non umane ci
appaiono, con un marchio nella loro pelle o nel loro guscio o nelle figure del
piumaggio di certi uccelli e che pure, a volte, si mostrano nelle nuvole.
E così: “Olivo solitario/ lontano dall’uliveto,/ olivo ospitale/ che dai la tua ombra a un uomo pensoso/ ed a un’acqua trasparente”17 leggiamo in “Olivo del
Camino”, che apre Nuevas Canciones. Tutto è rivelatore: l’olivo non è solo, ma
è ospitale come un’anima vivente. Parallelamente a “E tutta la campagna un
momento/ rimane muta e ombrosa/ meditando”18 delle prime poesie del suo
primo libro Soledades. Può sentirsi solo chi sente la campagna meditare? Solitudini e non solitudine, stati dell’essere come “muto” e “ombroso”, come “solitario”, sentiti immediatamente nelle campagne, nell’albero, come la trasparenza è sentita e vista nell’acqua.
Sì, sappiamo già che tali espressioni vengono chiamate metafore o trasposizioni e, più conformemente con la terzultima estetica, “proiezione sentimentale”. Ciò in quanto la mentalità moderna ha rotto con l’immediato eccetto l’immediatezza del soggetto attraverso il suo dubbio, in ciò in cui non vi è più immediatezza. E non può accettare il sentire diretto di un modo di essere umano
originato in una realtà che non giunge all’essere; realtà, certamente sì, ma senza essere, e se si tratterà di esseri, se si percepiscono e vivono tali realtà come ciò che sono (esseri), allora il problema appare ben diverso.
D’altra parte, l’accusa o almeno la diagnosi di “panteismo”, salterebbe fuori senza sforzo se ci collocassimo negli schemi del pensare occidentale: è l’uomo e soltanto lui il pensante, è soltanto lui ad avere relazione diretta con la divinità. E sentire il divino e ciò che definisce l’umano così come è il pensiero,
dunque in identità, se non è metafora è panteismo. Poiché il pensiero divino
così considerato sarebbe divino senza esistere più. Non ve n’è, almeno.
Ma avviene che il pensiero originale, originario, e al pari universale, non
procede dai modi qui indicati, il suo procedere è altro. Esistenzialmente, esistenzializzando il soggetto in questione? Ma per definirlo così non vi sarebbe
altra difficoltà se non il fatto che non si tratta dell’esistere del soggetto, ma di
qualche altra cosa che se si pone in relazione con l’esistere è per giungere al
suo opposto, il dis-esistere. L’uomo in cui tale soggetto del pensiero unico si
annida va rimanendo libero per farsi responsabile in modo immediato, moralmente e anche politicamente, per l’azione, se fosse necessario un giorno che
egli non ha previsto.
Si potrebbe anche dire, cedendo alle ultime formulazioni, che questo pensiero “struttura” il soggetto, l’uomo stesso. E per esso non si presenta maggiore ostacolo che il rendersi conto che quest’uomo che si presenta già in pienezza non è strutturato, ma configurato, conformato. E che si tratta del fatto che il
***
E l’amore è innanzitutto e oltre tutto un pensiero d’amore. Un pensiero e
non un luogo come abbiamo cercato di indicare; la campagna, l’olivo e anche
l’ospitalità. E misteriosamente e soprattutto: sogno.
Il pensiero d’amore sfiora la “verità divina” che sta tremando. E non è il
semplice tremito che avvertiamo anche nella campagna, è il venire meno, una
specie di tremito nel proprio cuore tra il risveglio e il sonno: “…Il limone fiorito,
il cipresseto dell’orto, il sole, il campo, l’arcobaleno-l’acqua nei tuoi capelli –. E
tutto nella memoria si perdeva come una bolla di sapone al vento”20.
Ma il perdersi, che non giunge a essere oblio, nel cuore-memoria è qualcosa di cosmico. Il più lontano da un pensiero.
Il pensiero d’amore nasce compiuto (entero). Solo con tale pensiero si potrebbe vivere, il che vuole dire che solo tale pensiero prenderebbe tutta una vita. Ma forse quando il pensiero d’amore si è dato – Dante, Petrarca, Quevedo… – è stato soltanto ciò che si intende per amore, amore tra uomo e donna? Tra “gazzella e leone”, come analogamente a ciò che si crede stabilito riguardo al pensare e al suo soggetto umano, con l’amore accadrebbe pure. Ovvero, come se l’Amore, esso, vivesse di per se stesso mentre si crede, e oggi
con ostinazione, che l’evento dell’amore potrebbe darsi soltanto in termini psicologici e sociologici, senza un “a priori”, senza un pensiero che germina in un
essere. Come se qualsiasi uomo si potesse innamorare di Guiomar (compreso lo stesso Antonio Machado in un’altra stagione del suo essere) senza che
il pensiero d’amore lo abbia a ciò disposto. E così, la identificazione di Guiomar con l’esistenza reale di una donna amata viene a essere accessoria rispet-
SAGGI
dispiegarsi del suo pensiero dischiuda le possibilità di pensare e di essere in
attivo, mentre il soggetto intimo si va avvicinando come purificato dalle acque,
che mai vengono a mancare, in cui si bagna alla semplicità prima e ultima,
quella di essere creatura vivente e, quindi, quella di essere senz’altro, nel nulla. In un nulla – come si è visto – che non lo divora, né gli resiste, e nemmeno
lo culla, come se stesse per portarselo di nuovo. In un nulla che viene a essere l’ospitalità del creatore.
È così l’uomo pensoso (pensativo) è protetto dall’olivo solitario, “olivo della
via”, che è andato a stare da solo, proprio per essere sull’orlo della via ove passano gli uomini, le bestie, la polvere e la via stessa.
E protetto da tale ombra buona (non dimentichiamo che Antonio Machado
era dell’Andalusia, ove l’ombra e il fatto che sia buona è qualcosa di molto rilevante) l’uomo che pensa è in sé poiché è nel luogo del suo pensiero.
È ospitale l’olivo solitario. Ospitale la locanda (venta) o la donna come in
Cervantes – sia detto per inciso: “Bianca locanda/ cella del viaggiatore,/ con
l’ombra mia”19 CLIX (Canciones).
La bianca locanda equivale all’olivo ospitale della via, che dà la sua ombra.
Ma qui, l’ombra è la sua, è lui che dà la sua ombra, questa ombra misteriosa
che lo accompagna sempre; la sua a volte, o quella di altri: di altri o di uno, talvolta quella del più profondo se stesso.
13
14
to a quel pensiero d’amore, senza il quale quell’amore concreto non sarebbe
esistito o si sarebbe dato in forma differente. E perché questo pensiero d’amore, che non discutiamo per nulla, potesse giungere a incarnarsi, era indispensabile Abel Martín. Fu a partire da lui, tramite lui e con lui, se l’uomo reale Antonio Machado giunse a vivere questo amore concreto che sarebbe conferma
(corroboración), risposta (se realmente così gli si diede).
Ma, come è stato possibile? Poiché nella metafisica erotica di Abel Martín
sembra che l’amata sia impossibile, sarà forse quella che “non accorse all’incontro”? Leggiamo: “Nella metafisica intrasoggettiva di Abel Martín fallisce
l’amore, ma non la conoscenza o, per meglio dire, è la conoscenza la ricompensa dell’amore. Tuttavia, l’amore in quanto tale non trova oggetto; detto liricamente: l’amata è impossibile”. E prima: “ ‘L’occhio che tutto vede a vedersi esso stesso’ è, certamente, un occhio dinanzi alle idee in attitudine teorica,
di visione a distanza; ma le idee non sono che un alfabeto o un insieme di segni omogenei che rappresentano le essenze che costituiscono l’essere […].
Figlie dell’amore, e in un certo senso, del fallimento dell’amore. Mai sarebbero concepite senza di esso, poiché è l’amore stesso, o conato dell’essere per
superare la propria limitazione, colui che le proietta sul nulla o zero assoluto
che il poeta chiama anche zero divino, come vedremo in seguito. Dio non è il
creatore del mondo – secondo Martín – ma il creatore del nulla. Le idee, dunque, non hanno realtà essenziale, ‘per sé’ sono mere trascrizioni […]. Queste
essenze non possono separarsi dalla realtà, se non nella loro proiezione illusoria, e neppure – secondo Martín – si dà appetizione dell’una verso l’altra,
piuttosto tutte le idee aspirano congiuntamente e indivisibilmente all’altro, a
un essere che sia il contrario di ciò che è, di ciò che esse sono. Insomma: all’impossibile”.
E così la vera conoscenza corre l’alea dell’amore, come figlia del suo fallimento. Rimane in piedi risplendendo come una colonna di luce ormai senza
fuoco, diremmo, questa aspirazione delle idee congiuntamente e indivisibilmente verso l’altro, come attratte magneticamente da tale impossibile loro contrario, aspirano, diciamo, alla loro stessa distruzione. Poiché “Non è neppure
per Abel Martín la bellezza il grande sprone dell’amore, ma la sete metafisica
dell’essenzialmente altro”. L’altro di chi ama, l’altro di chi pensa, l’altro di chi
guarda. O l’altro in se stesso, come suggerisce, benché qualifichi questa
espressione come iperbolica, “come un appassionato culto per la donna”, il fatto che “La donna è il dritto dell’essere”, che non potremmo senz’altro interpretare come il non-essere in questa forma di pensiero che non si attiene alle premesse e che, con ancora maggiore decisione, dissolve i contrari o li assoggetta all’eterogeneità dell’essere. Che cosa sarebbe, ci chiediamo, questo “dritto
dell’essere”? Un assoluto, impensabile, ci sovviene.
E che sia impensabile non presuppone ineluttabilmente la sua inesistenza, ma
la donna rimarrebbe allora come un assoluto? E l’assoluto può forse essere uno
che ammetta l’altro? O sarà un più in là dell’essere, giacché l’essere non sussiste
prima del nulla, del nulla divino. Sarebbe dunque la donna per l’uomo anticamera della verità ultima raggiunta dal pensiero nella metafisica di Abel Martín. Ma, si
potrebbe vivere? Lo si potrebbe anche come questo “dis-essere” (deseerse) che
SAGGI
annuncia, come via negativa tanto della mistica come di tutta la vita. “Ma nessuno riuscirà ad essere quello che è se prima non riesce a pensarsi come è”.
E questa via Abel Martín, attraverso Machado, la espone con nitida chiarezza nel fare con tratti concisi la critica del pensare che ancora patiamo. “La concezione meccanica del mondo – aggiunge Martín – è l’essere pensato come
pura inerzia, l’essere che non è per sé, immutabile e in perpetuo movimento e
un turbinio di ceneri che agita, non sappiamo perché e a quale fine, la mano di
Dio”. E commenta così questo pensiero originario di Martín. “Quando questa
mano palese anche nel ‘colpetto’ (chiquenaude) cartesiano, non è tenuta in
conto, l’essere è già pensato come quello che assolutamente non è. Gli attributi della sussistenza sono già, in Spinoza, gli attributi del puro nulla. La coscienza giunge, per ansia dell’altro, al limite del suo sforzo, a pensarsi come
non è, a dis-essere sé. Il tragico erotismo di Spinoza condusse a un limite invalicabile la desoggettivazione del soggetto.
Ed è qui che ci è data la soluzione, l’uscita dall’aporia e dal suo interminabile labirinto poiché egli continua esponendo subito dopo, e separato nel testo
solo da un punto, il pensiero decisivo di Martín, la sua rivelazione: “E come non
tentare di restituire a ciò che è la sua stessa intimità?” Questa impresa fu tentata da Leibniz – filosofo dell’avvenire, aggiunge Martín – ma può essere consumata dalla poesia, che Martín definisce come “aspirazione alla coscienza integrale”. Ma se la poesia, a sua volta, ci viene detto, è figlia del fallimento dell’amore, ho qui una figlia che consegue ciò che la metafisica, la conoscenza
non può. Si tratta, allora, di creare o almeno di scoprire qualche creazione possibile, una creazione non dell’altro essere, ma di una congiunzione tra pensare e amore. Forse questa: “Se un granello del pensare ardere potesse, non
nell’amante, nell’amore, sarebbe la più profonda verità [ciò] che si vedrebbe”.
E solo il vederla, diciamo, ci basterebbe? Ci basterebbe, sebbene la sua azione immediata ci viene enunciata così: “e lo specchio di amore si romperebbe,
rotto il suo incantesimo”21.
“Vuole dire Abel Martín che l’amante rinuncerebbe a quanto è specchio nell’amore, perché comincerebbe ad amare nell’amata ciò che per essenza non
potrà mai riflettere la sua stessa immagine”. Il che ci consegna la chiave del
pensiero che l’uomo Antonio Machado, rinchiuso nei confini delle circostanze
sociali, intellettuali e storiche, non poté manifestare da se stesso. Come avrebbe potuto dirsi, senza allontanarsi dalla sua via, non soltanto a se stesso, e
meno ancora a se stesso, un pensiero, quello centrale di tutta la mistica e segnatamente della più limpida di questo Occidente? – quella di Master Eckhart,
che appare in ognuno dei passi del suo pensiero, un pensiero unico, se ce ne
sono stati. Scegliamo questo perché semplice e adeguato: “Nessuna immagine ci dischiude la divinità né l’essere di Dio. Se qualche immagine o somiglianza permane in te, mai giungerai a essere uno con Dio” – “Sermo surrexit autem Saulus”22.
Non poteva Antonio Machado formulare così per sé questo pensiero e neppure mediante Abel Martín. Come poeta gli è irrinunciabile l’odore, il sapore, il riflesso. Come pensatore, l’ombra e, come metafisico dell’amore, l’eterogeneità
dell’essere – della donna, come uomo. Come abitante di un Paese, di una sto-
15
16
ria, di anima e spirito irrinunciabile (e, sia detto di passaggio, soltanto quando così accade si ha una patria, anche se la si perde). E attraverso tutto ciò è passato Antonio Machado affermando, al pari della sua vita, questa specie di “Ars
Amandi” della quale osiamo dire che contiene la metafisica e, pertanto, l’etica di
Martín e Mairena. Ma può darsi che differisca dalla mistica di Eckhart – uomo attivo, attento al suo dovere storico nel suo tempo – l’azione che trasmuterebbe
tutto al rivelare la “più profonda verità”. “Se un granello del pensare ardere potesse/ non nell’amante, nell’amore”. Per quanto si sappia, una tale azione divina,
umana, o umana e divina insieme, non è stata mai proposta né qualcuno ha affermato di averla sognata. Si tratta di qualcosa di inedito. Un pensiero d’amore
inedito che reclama il suo luogo proprio là nella costellazione dei pensieri unici,
al modo degli astri e indelebili come loro, indistruttibili finché la vita umana non
si smentisce, non si disdice, cosa che oggi non bisogna dare per impossibile.
E possiamo permetterci di identificare questa verità (“il più profondo ciò che
si vedrebbe”) con “la verità divina tremando di paura” nel profondo specchio
dei suoi sogni, vista quando un giorno limpido guardò i suoi beneamati versi?
La verità divina trema, ci chiediamo, perché si sta riflettendo nello specchio? E se, come insinuavamo nel riferirci ad esse, ci chiede qualcosa di più
dell’essere vista, se forse trema per qualcosa proprio dell’uomo essendo divina, se la verità è un essere divino che richiede l’uomo. Ed è allora la verità dell’amore che si realizza quando ciò che è uno – l’uno23 – si fa l’altro,
chiedendo all’altro o agli altri che si facciano uno, degli uno nell’amore, salvandosi così dall’eterogeneità dell’essere e degli esseri. E se è così, nel caso dell’amore uomo-donna si darebbe che questo “dritto” (anverso) dell’essere che è la donna chieda enigmaticamente all’uomo che la segua più di
quanto egli capisca nel modo spontaneo proprio dell’uomo, che si neghi trascendendosi, e persino inabissandosi. “Grazie, Petenera mia/ nei tuoi occhi
mi sono perduto/ era ciò che volevo”24. Poiché trema anche questa verità divina per fluttuare nel sogno umano. Trema al risveglio dentro il sogno umano? E allora tremerebbe della storia che procede dai sogni umani, e richiederebbe una storia limpida, una storia creatrice e trasparente, quella che
“l’uomo pensoso” crea unificando l’ombra che ricopre il suo capo e l’acqua
trasparente che senza ombra la accompagna, al margine del cammino, del
cammino storico mentre ancora serpeggia.
E così, sebbene conservi qualcosa della sua stessa immagine, giunge a
pensare e amare insieme, nell’intimità dell’essere e della storia. E la storia
stessa si farà intima, l’intimità della storia si farà verità manifesta e non vi sarà
contrapposizione tra l’agire e il pensare.
La Petenera è anche una figura della storia che ci guarda.
Il pensiero unico contiene o forse è contenuto nella visione data al poeta
Antonio Machado (il suo vero punto di partenza, motore della sua poesia) nella “verità divina” vista nei suoi “Beneamati versi”. Nel “profondo specchio dei
miei sogni” che così come specchio si rivela dandogli i suoi sogni. Ottenere la
rivelazione dei propri stessi sogni dalla poesia e quindi in essa per diretta visione, è sostanza di poesia e di conoscenza insieme. Ma sarebbe forse possibile una poesia che non sarebbe conoscenza in se stessa, pensiero visibile,
SAGGI
pensiero nato, cresciuto come un fiore, come si dice di tale “verità divina”. E
così la dialettica tra il vedere e il guardare, tra l’occhio e il vedere ha la sua radice o fondamento divino ed è cosa d’amore, come è saputo. “L’amore è l’occhio con il quale l’amante vede l’amato”, enuncia precisando Plotino.
Precisando non solo la tradizione platonica, ma come ogni pensiero sicuro –
unico – rende il sentire diffuso e trattandosi di amore particolarmente confuso, che
sostiene il cuore umano che non è giunto a essere “maturo di ombra e di scienza”.
Non troviamo indizi che Machado-Martín-Mairena si siano abbeverati in
questo pensiero di Plotino. Ma la filiazione di un pensatore o di un pensare non
dipende, come si sa e si dimentica, dalla conoscenza dei testi che, d’altra parte, possono essere stati conosciuti un giorno e approfondirsi nel fondo creatore della memoria.
L’unità indistruttibile del pensiero unico di Antonio Machado si mostra anche
nell’avvio comune delle sua poesie e della metafisica di Abel Martín, il primo
dei suoi eteronomi, “poeta e filosofo” che scrisse nella prima pagina del suo libro di poesie Los complementarios: “I miei occhi nello specchio/ sono occhi
ciechi che guardano/ gli occhi coi quali li vedo”25. E di seguito: “In una nota,
Abel Martín fa osservare che furono questi i primi versi che compose, e che li
pubblica nonostante la loro apparente ovvietà o la loro marcata banalità, poiché da essi trasse, in seguito, per riflessione e analisi, tutta la sua metafisica”.
E non è cosa che debba stupirci il fatto che la poesia propriamente detta inizi
o si origini in una rivelazione, e che pure la metafisica si dischiuda o si origini in
una rivelazione, ma negativa: “I miei occhi nello specchio” che danno a conoscere l’esistenza – ineludibile – dello specchio che ogni visione trova ancorché non
sia nei beneamati versi, risponde qui a una domanda che, pur non formulata, non
manca di essere determinante. Ha posto i suoi occhi nello specchio e dunque lo
guardano ciechi, si guardano ciechi essi stessi in una identità frustrata.
Dell’identità, asse di ogni verità metafisica, e di ogni vero amore. Non vi è
metafisica che non vada facendosi filosofia in modo ineludibile, intrepido, persino eroico, non in cerca dell’identità dell’essere e del pensiero, del soggetto e
dell’oggetto, ma integralmente, di se stesso e del tutto, della vita e dell’essere,
dell’amore uno e molteplice, di ciò che vede e ciò che è visto dell’amore. Del
centro e della circonferenza.
E per giungere almeno alle porte dell’identità o anche soltanto vederla come possibile – sentendola già – è stato sempre indispensabile eliminare qualcosa della semplice vita e del semplice, dato pensare. Si presenta almeno una
scissura: un abisso o una sola linea, limite; il limite che il pensiero umano deve stabilire, foss’anche soltanto per fare il vuoto indispensabile o la cavità ove
corra la via.
Quella via al cui lato si erge l’“olivo solitario” come suo guardiano, l’olivo
ospitale che dà la sua ombra all’uomo che pensa alla sua ombra come nel luogo proprio, vicino a un acqua trasparente, rappresentazione del Pensare stesso quando si compie. Tale figura poetica del luogo del pensiero unico – a sua
volta, l’olivo unico – ci si rivela come un metodo. E la metafora contenuta in parole tanto concise appare a noi perfetta. Poiché la via è una separazione in un
territorio che prima era unito, un’apertura nell’indifferenziato.
17
18
Sentiamo che tale rivelazione negativa che rende possibile la metafisica, il
pensare umano, si origina nientemeno che in un atto divino. Lo enuncia poeticamente Abel Martín e lo commenta, lo rende ancor più esplicito “La Metafisica de
Juan de Mairena”. E più compiutamente, poiché in soli quattro versi appare la
congiunzione dello sguardo con l’atto creatore del nulla: “Disse Dio: Sorga il nulla./ E alzò la mano destra,/ sino a nascondere il suo sguardo,/ E rimase creato il
nulla”26. Gli occhi ciechi che guardano non nello specchio, ma dietro lo specchio
del nulla, “lavagna scura nella quale si scrive il pensiero umano”? E dunque, dacché esiste tale lavagna, specchio, dacché prorompe il “Fiat umbra” da dove “sorse il pensare umano”, potrà esserci visione, la visione desiderata dall’amore che
è l’unica identità possibile che questo pensiero ci mostra?
E dice così egli, questo “egli” unico che progressivamente formano Abel
Martín e Juan de Mairena. Giacché se Mairena è altro lo è perché era chiamato a essere maestro del pensare in un’aula semivuota che è andata riempiendosi di innumerevoli uditori e, come succede di solito, da costoro saranno usciti e usciranno alcuni veri discepoli come lui, splendidi e che trasudano ironia:
l’ironia indispensabile che suggella l’unità tra ragione e Pietà – la Pietà grande, sebbene sia data in piccole quantità (al menudeo).
E così tra la metafisica di tali eteronomi non vi è che complementarietà. Machado spiega questi quattro versi: “Così Mairena simboleggia, seguendo Martín, la creazione divina, mediante un atto negativo della divinità, mediante un
volontario accecarsi del grande occhio che tutto vede al vedere se stesso”.
Dio come il “grande occhio che tutto vede al vedere se stesso”era stato enunciato prima. E prosegue: “Si domanderà: come, se non vi è Problema di ciò che
è, dato che l’apparente e il reale sono una e la stessa cosa […] può esservi una
metafisica?” E Mairena risponde: “Proprio il rendere aproblematico l’essere, il
quale postula l’assoluta realtà dell’apparente, pone ipso facto al tappeto il problema del non essere. E questo è il problema di ogni futura metafisica”.
Al porre il problema del non-essere, si libera il pensiero poetico, diciamo,
come si dimostra precisamente nello stesso Abel Martín, colui che “trasse” tutta la sua poesia metafisica dai suoi tre primi versi, ovvero da una intuizione e
un sentire poetico (i miei occhi nello specchio/ sono occhi ciechi che guardano/ gli occhi con i quali li vedo), Abel Martín il teologo-poeta, emanazione e rivelazione all’umano, del pensiero poetico come pensiero divino. Commentando subito il suo sonetto che è alla base del suo teologizzare, “Al gran cero”, dice: “Dio dona all’uomo il grande zero, il nulla o zero integrale, lo zero integrato da tutte le negazioni di quanto è. Così la mente umana possiede un concetto di totalità, la somma di quanto non è, che serva logicamente da limite e frontiera alla totalità di quanto è”. E ripete: “Fiat umbra. Sorse il pensiero umano”.
“Si intenda: il pensare che rende omogeneo – non il poetico che è già pensiero divino”.
Si dà nell’uomo, grazie al poeta, il pensiero divino. Ma, e il vedere? Quale
alea corre?
E che di vedere si tratta e, pertanto, di un Dio della visione, lo mostrerebbe
a sufficienza la supplica dell’uomo. Poiché, come già scorgiamo, si può identificare il dio in cui l’uomo crede mediante la supplica che non può mettere a ta-
(traduzione dallo spagnolo di Nunzio Bombaci)
SAGGI
cere l’essere questo dio il suo. E la troviamo precisamente nel componimento
poetico offerto in qualità di Abel Martín (i complementari ove si offre ancora una
volta la rivelazione negativa): “Mostrami, oh Dio! La prodigiosa mano/ che fece l’ombra: la lavagna oscura/ ove si scrive, il pensiero umano”.
E questa supplica, al modo di quasi tutte le suppliche nate dal più profondo, rimane nel testo senza commento. Curiosamente, nella poesia, nella metafisica stessa, in tutto quello che l’uomo “crea” ed esprime, ciò che più rivela
rimane senza spiegazione, così come succede nei sogni. La verità intima, il
motore della profondità ultima, è già molto che appaia. La verità profonda (entrañable) rimane qui come abbandonata, come se uscisse da sé stessa. Poiché la verità è cosi imparentata con il sogno che si fonde in esso. La verità
umana che l’uomo grida al suo dio, o soltanto a se stesso se non ha o non crede di avere dio, è come un sogno. Il suo sogno originario. La sua verità.
E prima, nel periodo che diremmo ingenuo della poesia di Antonio Machado, prima che Mairena e Martín fossero nati o prima che si mostrassero, troviamo… Ma ancora prima, nelle non molto frequenti apparizioni della luce,
“Luz en sueños” (Galerías), la luce, medio della visione diretta, della visione
vera, immediata è forse nei sogni? Troviamo in Nuevas canciones in “Iris en la
noche” [“Arcobaleno nella notte”] una vera preghiera della visione. “E tu, Signore, per il quale tutti/ vediamo e che vedi le anime, / di’ a noi se tutti un giorno,/ dobbiamo vederti il volto”27.
Sarà questa forse la “più profonda verità”, rotto lo specchio che mantiene
ammaliato l’amore? Amore che muore per vedere e che trema per essere visto.
E questo amore deve continuare così? Il pensiero poetico, che è “pensiero
divino”, non lo ha riscattato perché è cosa di visione. E vi è solo la visione oltre lo specchio, sia quello dei sogni o della lavagna oscura che il dio cieco per
sua volontà tese all’uomo che deve riflettere. Dovrebbe verificarsi un’azione divina, o forse umana, se fosse possibile all’uomo disporre di un granello di pensare interamente divino, interamente pensare. Non appare alcun riferimento al
“pensiero di pensiero” del Dio di Aristotele il cui atto è vita, pensiero puro che
non è creatore come il Dio della tradizione ebraico-cristiana che Martín rifiuta.
Ma il nulla, esisterebbe senza questo atto creatore? È ben certo che tale nulla di Martín-Mairena non è il nulla propriamente detto, ma uno specchio, una
lavagna, un luogo dato al pensare umano. E dal pensare divino, poetico nell’uomo, è dove giunge come possibile il riscatto. Deve accadere qualcosa di
straordinario, quasi impensabile, perché si verifichi la congiunzione pensierovisione, senso della visione e dell’amore insieme, dunque vita. Ed è unicamente l’amore il luogo ove può darsi. Ha aspetto di preghiera, e di recondita preghiera timida e ardente, un arcano che infine si dischiude, quel sonetto ove leggiamo: “Se un granello del pensare ardere potesse/ non nell’amante, ma nell’amore”, si romperebbe l’incantesimo dello specchio e sarebbe la più profonda verità quella che si vedrebbe. Si vedrebbe veramente. E veramente si amerebbe. Sarebbe veramente vita, noi diciamo. E l’amore non tremerebbe. Farebbe ardere e arderebbe senza estinguersi.
19
“Poética”, in A. MACHADO, Poesías Completas, Espasa Calpe, Madrid 2006, p. 76.
Ivi, p. 126.
3 M. DE UNAMUNO, Obras Completas, Ed. Aguado, Madrid 1959-1964, pp. 1156-57.
4 ID., Ivi, “Nuevas canciones”, CLXI, n. 44, p. 289.
5 Brano tratto dal discorso di ingresso alla Real Academia de la Lengua Española, pronunciato da Machado il 24 marzo 1927.
6 A. MACHADO, op.cit., p. 353.
7 Ibidem, p. 349.
8 Scritto contenuto nella lettera inviata ad Agustín Andreu il 3 agosto 1975, in M. ZAMBRANO,
Cartas de La Pièce (correspondencia con Agustín Andreu), Pre-Textos, Universidad Politécnica de
Valencia, Valencia 2002, pp. 260-274. Il frontespizio è dattiloscritto e il testo, pure dattiloscritto,
contiene delle correzioni autografe. [Tutte le note, meno la nota 7, sono del traduttore].
9 “Muéstrame, ¡oh Dios! La portentosa mano che hizo la sombra: la pizzarra oscura donde se
escribe el pensamiento humano”.
10 “Leyendo un claso día / mis bien amados versos, / he visto en el profundo / espejo de mis
sueños / que una verdad divina / temblando está de miedo. / Y es una flor que quiere / echar su
aroma al viento”.
11 “Si un grano del pensar arder pudiera, / no en el amante, en el amor, sería / la más honda
verdad que lo se viera”.
12 “Dí ¿Por qué acequia escondida, / agua, vienes hasta mí, / manantial de nueva vida / en
donde nunca bebí?”.
13 Qui, diversamente dall’esergo, l’autrice cita in modo erroneo “Mirando un claro dia” anziché
“Leyendo un claro dia”.
14 Cfr. G. F. LESSING, Estudios Filosoficos y Teólogicos, Anthropos, Barcelona 1990, pp. 402
ss. [*Gesammelte Werke. Philosophische und Teologiche Schriften, Bd. 8, Aufbau-Verlag, Berlin 1956; segnalo la più recente edizione italiana: Opere filosofiche, UTET, Torino 2006], ove Jacobi attribuisce, scandalizzato, a Lessing l’opera poetica Prometeo, la cui concezione della divinità è spinoziana. Ed è curioso che un uomo come Jacobi credesse ormai inutile occultare e
ostacolare lo spinozismo dopo che Diderot aveva pubblicato certe cose, e che Leibniz aveva
pubblicato il Nuovo Sistema della Natura [Das neue System (Système nouveau de la nature et
de la communication des substances, aussi bien que l´union qu´il y a entre l´ame et le corps,
1695), in G.W. LEIBNIZ, Kleine Schriften zur Metaphysik. Philosophische Schriften, Bd. 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1965; edizione italiana in Scritti filosofici, UTET, Torino 1967, 1979,
1986, 2000]. Pertanto Jacobi vedeva in Leibniz l’ombra del nefando ebreo. Se lo sapessero certi leibniziani! [N. d. A.]
15 “No puedo cantar ni quiero / a ese Jesús del madero / sino al que anduvo en la mar”.
16 “Corazón maduro de sombra y de ciencia”.
17 “Olivo solitario, / lejos del olivar, junto a la fuente, / olivo hospitalario / que das tu sombra a
un hombre pensativo / a un agua transparente”.
18 “Y todo el campo un momento / se queda mudo y sombrío, / meditando”.
19 “Blanca hospedería, / celda del viajero, / con la sombra mía”.
20 “…El limonar florido, el cipresal del huerto, el sol, el campo, el iris – el agua en tus cabellos. Y todo en la memoria se perdía como una pompa de jabón al viento”.
21 “y el espejo de amor se quebraría, roto su encanto”.
22 Cfr. la conversione di Paolo di Tarso nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli dove però non il
termine Sermo.
23 “lo uno – el uno”.
24 “Gracias, Petenera mía: / en tus ojos me he perdido / era lo que yo quería”. Abel Martín scrive in realtà “por tus ojos…” anziché “en tus ojos…” La petenera è un canto andaluso di carattere
melanconico e sentimentale, la cui denominazione costituisce una corruzione del nome di una
cantante, La Petenera, originaria di Paterna de Rivera, presso Cadice. La parola designa inoltre
un ballo eseguito esclusivamente da donne, accompagnato per lo più dal suono delle nacchere.
1
2
20
SAGGI
Un componimento poetico di matrice popolare ravvisa nella Petenera una donna crudele con gli
uomini. Riferimenti alla Petenera si colgono anche nell’opera di Federico García Lorca.
25 *“Mis ojos en el espejo / son ojos ciegos che miran / los ojos con que los veo”.
26 *“Dijo Dio: Brote la nada. / Y alzó la mano derecha, / hasta ocultar su mirada, / Y quedó la
nada hecha”.
27 *“Y tú, Señor, por quien todos / vemos y que ves las almas, / dinos si todos un día, / hemos
que verte la cara”.
21
LA VOLONTÀ COME RESPONSABILITÀ
IN G. DUNS SCOTO
di Orlando Todisco
22
È arduo ammettere che un pensatore medievale abbia potuto porre in cima
alle sue preoccupazioni filosofico-teologiche il primato della libertà, imbastendo la sua costruzione teoretica “ut salvetur libertas in homine”1. Eppure, è così. Fuori di tale prospettiva si rischia di fraintendere la proposta di Scoto. Non
pare possibile render conto dei suoi passaggi più arditi, senza far ricorso alla
libertà, perfezione primaria e semplice, fondamento rigoroso e fecondo. Mettendosi da un diverso punto di vista, la storiografia è stata per lo più reticente
e critica nei riguardi della prospettiva complessiva di Scoto. Infatti, non sono infrequenti né irrilevanti le obiezioni che di solito vengono mosse alla sua costruzione filosofico-teologica, tutte provenienti da una concezione che, ritenendo la
volontà strumento della ragione, non può non screditare una prospettiva che
invece fa della ragione lo strumento della volontà. Nel “Discorso di Ratisbona”,
Benedetto XVI addita Scoto tra i responsabili della flessione, registrata nel tardo Medioevo, tra ragione e fede, o meglio tra spirito greco e spirito cristiano.
Alla luce della distinzione tra voluntas ordinata e voluntas absoluta, la prima
manifestata attraverso la creazione e la redenzione, la seconda allusiva a ciò
che Dio potrebbe fare con o senza alcun riferimento a ciò che ha fatto, è detto che l’immagine di Dio, che si verrebbe definendo, sarebbe quella di un “DioArbitrio, che non è legato neanche alla verità e al bene. La trascendenza e la
diversità di Dio vengono accentuate in modo così esagerato che anche la nostra ragione, il nostro senso del vero e del bene, non sono più un vero specchio di Dio, le cui possibilità abissali rimangono per noi eternamente irragiungibili e nascoste dietro le sue decisioni effettive”2.
Se l’obiezione di Benedetto XVI rappresenta quel fascio di riserve, di solito
avanzate all’impostazione del pensare scotista per quanto concerne il rapporto tra fede e ragione, filosofia e teologia, l’obiezione del filosofo Claudio Leonardi ben compendia quelle critiche, molto più diffuse, relative al taglio filosofico-politico di segno dispotico, di cui il ‘volontarismo scotista’ sarebbe per molti versi alimento e giustificazione. Con riferimento alla riforma di Gregorio VII
(1073-1085), la cui lotta per le investiture può dirsi il primo tentativo da parte
della Chiesa di sottrarsi alla tutela dello Stato in vista di un rapporto di mutuo
rispetto, alla domanda, come e perché tale equilibrio non abbia retto all’urto del
tempo, il filosofo ha risposto che questo è avvenuto “per via di una certa teologia francescana che tentò di imporre l’assoluto primato della volontà divina
sulla volontà umana. Duns Scoto e soprattutto G. d’Occam, estremizzando il
pensiero di Bonaventura, finirono con il sopprimere lo spazio della ragione e
della storia. E il panvolontarismo divino distrugge l’uomo”3. Sono rilievi che si
SAGGI
inscrivono in quella storiografia che pone la verità a fondamernto della libertà,
che Scoto ha inteso appunto scuotere ponendo la verità scoperta dalla ragione al servizio della libertà, non però dell’arbitrio, che è la degenerazione della
libertà. Porre alle radici la volontà comporta, forse, lo sradicamento delle creature, la loro dispersione nell’oceano dell’essere, quasi fascio di fiori metafisici,
senza linfa e senza profumo (metaphysiche Scnittblumen – G. Anders)? No. La
libertà è fondamento esigente e forza coesiva affidabile.
Questa l’articolazione dell’intervento: 1. primato della volontà come primato della libertà, fondato sull’ontologia della libertà; 2. equivalenza di libertà e responsabilità, rispetto a cui risulta strumentale la funzione della ragione, non determinante, ma non per questo irrilevante; 3. il binomio potentia ordinata e potentia absoluta sostegno della trascendenza divina e conferma dell’inesauribilità della sorgente dell’inedito. La conclusione sarà la conferma del primato della libertà – ogni essere umano è come il vento del quale si sente la voce, ma
non si sa né da dove venga né dove vada (Gv 3, 8) – interpretato come spazio dell’’altro’, nel cui contesto pare legittimo parlare della modernità antimoderna del pensatore francescano.
1. Primato della volontà come primato della libertà
La volontà e l’intelletto4 “sunt nobilissimae potentiae, et maxime voluntas”5,
nel senso che la volontà è primaria e qualificante, perché nulla è davvero in nostro potere quanto la stessa volontà6. Tutte le altre potenze sono al suo servizio7. Infatti, la volontà è in grado di porre o sospendere la volizione, può interrompere l’azione intrapresa, come anche modificarne il corso. La volontà può
volere il contrario di ciò che vuole nel momento stesso in cui vuole. Il che non
significa che la volontà possa volere simultaneamente due contrari, ma, nel
momento in cui ne vuole uno, conserva la potenza di volerne un altro, senza
che soggiaccia a una qualche successione o mutazione8. Oltre che qualificare
l’atto, la libertà segna in profondità la volontà come facoltà causale, qualunque
sia l’area in cui opera o l’azione con cui si esprime.
Con questo assunto Scoto vuole affermare il primato della libertà. La volontà soltanto è libera – scrive categoricamente. Rispetto a qualunque atto, positivo o negativo, finito o infinito, la volontà resta libera, e non si dà alcunché che
possa assoggettarla9. Qui non c’è spazio per l’arbitrio. Qualunque ragione diventa ‘motivo’ dal momento in cui la volontà l’accoglie, non prima o di per sé,
perché non si dà alcunché che vincoli la volontà. La libertà non vien meno neanche davanti al bene assoluto10. È una perfezione semplice – è un termine il
cui significato è univoco – tale nell’uomo come in Dio, anche se nell’uno in modo imperfetto, nell’altro in modo perfetto11 – è determinante per Scoto la dottrina dei ‘modi di essere’. Solo la volontà è libera, nel senso che può esprimersi
in un modo o nel suo contrario o non esprimersi affatto. Le altre potenze non
sono ‘indeterminate’, ma soggiacciono al ritmo della natura o, come nel caso
dell’intelletto, alla forza obbligante della cosa, così come viene intesa in seguito all’esplorazione12. L’intelletto è una ‘potenza naturale’. Una tesi, che confer-
23
24
ma che l’obiettivo di Scoto è di sottrarre l’uomo a qualunque forma di necessità, compresa la conoscenza che, in quanto tale, è l’espressione, alta e nobile,
del nostro essere, in nome appunto della volontà quale sua caratterizzazione
primaria. L’esaltazione della libertà è tale che ogni altra potenza vien detta
umana in quanto rientra, in modo immediato o mediato, nell’arco della volontà, suprema forma di umanizzazione13.
La trascendenza della volontà è tale su tutta la linea. Nulla vale a limitarla.
Infatti, è in suo potere scegliere o non scegliere, scegliere un atto conforme o
un atto difforme rispetto alla sua inclinazione14. E il motivo sta nel fatto che non
è posseduta, ma possiede se stessa, autonoma, al punto che le scelte fondamentali non siano addebitabili ad altro. Si è al nucleo formale del concetto di libertà, che è quella perfezione grazie a cui il soggetto muove se stesso, non è
mosso d’altro. E sotto questo aspetto, il carattere finito o infinito non è decisivo,
ma è successivo e allude a qualcos’altro e cioè all’intensità della sua realizzazione. Per questo, Scoto non esita a ribadire con sant’Agostino che “nihil est
tam in potestate nostra quam ipsa voluntas”15. Dunque, nessun atto in noi dipende con altrettanta radicalità da noi quanto la volizione16. Per dirne il primato, si pensi che se l’intelletto si rapporta alle cose rappresentandole – l’intelletto evoca e giudica – la volontà invece si riversa in ciò che vuole, lasciandosi
prendere da quella ricchezza – la volontà si abbandona, non porta l’altro a sé,
ma sé all’altro. E così, nella visione beatifica l’amare è ben superiore al conoscere, perché colui che ama si lascia investire dal calore infinito di Dio – è questo la sua misura – mentre colui che conosce rappresenta l’altro secondo la sua
capacità – l’intelletto si conferma giudice17. L’atto deve dirsi perfetto in rapporto
alla ricchezza dell’oggetto, con il conseguente privilegiamento dell’amare sul
conoscere18. Lungo questo percorso si comprende, ad es., perché la conoscenza intuitiva, che raggiunge l’oggetto nella sua ricchezza singolare, venga considerata superiore a quell’astrattiva. Dunque, la volontà eccelle su qualunque altra potenza, perché l’oggetto non costituisce un motivo di distinzione o contrapposizione, ma di arricchimento, suo nutrimento, più che sua misura19.
Per dissipare l’ombra incombente dell’arbitrio, Scoto ribadisce il carattere
primario e radicale della libertà, le cui espressioni si sottraggono al principio
fondamentale della prospettiva razionalistica, secondo cui ‘non si dà nulla senza una ragione sufficiente’. Se per arbitrio si intende la violazione del carattere universale del principio di ragion sufficiente, si fa riferimento a un aspetto
reale della prospettiva di Scoto, che però non ha nulla in comune con quanto
per lo più si intende con ‘arbitrio’. Colui che rivendica come inviolabile il principio di ragion sufficiente mette in crisi la libertà come potestas ad opposita o potere dei contrari, risolvendola nella pura spontaneità. La libertà come ‘cominciamento’, come ‘inizio di qualcosa di nuovo’ o, anche, come scelta di un percorso, non prolungamento di ciò che già si dà, né riconducibile a quanto in qualunque modo è stato pensato e fatto, questo capitolo non pare facilmente conciliabile con l’assunto che non si dà effetto senza una causa proporzionata, tradotto per lo più come “principio di ragion sufficiente”. Chi resta fermo a questo
principio non s’avvede che cancella il capitolo del ‘nuovo’, agganciando troppo
strettamente la prospettiva cristiana alla prospettiva pagana, sostanzialmente
SAGGI
circolare, quale rigorosa esemplificazione del principio di ragion sufficiente. Ciò
che si fatica ad ammettere è che si possa dare un atto libero della volontà, radicalmente imprevedibile, perché non pretedeterminato dai suoi antecedenti
causali, né riconducibile ad alcun principio universale. È bene ribadire che la
posizione razionalistica è propriamente naturalistica, nel senso del collegamento tra ciò che accade e ciò che è accaduto, risolvendo la volontà nella funzione di aggancio e di collegamento. Si è al binomio di atto e potenza, con cui
vien resa l’armonia greca, secondo cui accade solo ciò che può accadere, o all’istante che nella concezione aristotelica del tempo aggancia il prima al poi.
Cos’è la difesa del principio di ragion sufficiente se non l’inviluppamento di tutte le cause nella rete della razionalità, con una piega inevitabilmente riduzionistica, che nella storia assumerà le forme più varie, da quella evoluzionistica a
quella economicistica, tutte conclusivamente scientistiche?
Nel quadro del primato della libertà come barriera ultima che non è possibile sottopporre alla logica della ragione senza mortificarla come libertà, è bene accennare al ruolo insostituibile dell’intelletto, senza però elevarlo a tribunale supremo o a causa prima. Scoto non esita a dire che l’intelletto rientra nel
processo causale della volontà in quanto da questa diretto nella scelta dell’area da esplorare. È conseguente che l’intelletto sia ‘causa subserviens’, come il lume con il quale il servo precede il padrone, perché non inciampi20. Per
rompere l’incertezza della scelta del campo da esplorare – le cose da conoscere sono infinite – l’intelletto ha bisogno della volontà21 o, meglio, della sua assolutezza – dipende dalla volontà ciò che conosciamo, non però il modo. Perché servizievole, l’intelletto presenta il risultato alla volontà, che può condividerlo o disattenderlo nel quadro della sua progettazione esistenziale – ecco
l’inviolabile libertà. Perché sia libera, la scelta non deve essere in contrasto con
quanto la ragione propone, quasi che sia l’originalità della scelta a definirne la
libertà. La scelta è libera perché espressione della volontà, nel senso che si dà
perché voluta, in accordo o in contrasto con il referto della ragione. Prima del
contenuto, si impone la scelta, la quale è tale in quanto voluta. Sta qui la parte essenziale della libertà come responsabilità, e cioè nel fatto che una cosa si
dà perché voluta. È il nucleo del volontarismo di Scoto. La scelta o è espressione di libertà o è prolungamento inevitabile del filo di razionalità, che ci imparenta e tiene insieme le cose. Non ci sono alternative. A questa prima fase
fa seguito la seconda, e cioè la volontà offre ciò che ha scelto all’intelletto, perché non solo lo registri, ma lo illumini ulteriormente. Alla luce del circolo, secondo cui la volontà spinge la ragione a esplorare una certa area, e la ragione
le offre i risultati conseguiti, si impone il ruolo della ragione ma non a discapito del ruolo primario della volontà che apre e chiude il circolo, nel senso che
accetta o respinge ciò che le viene presentato, sollecitando la ragione a un’ulteriore ponderazione, in vista della sua messa in atto. In questo contesto, parlare di arbitrio, come assenza di ponderazione, è del tutto fuori posto22. Si aggiunga che l’uomo, sia che ripercorra sentieri battuti sia che ne apra di nuovi,
intraprende un capitolo con esigenze oggettive da esplorare, in rapporto a cui
l’azione verrà detta perfetta o imperfetta. Il consorzio tra ragione e volontà è
profondo e ininterrotto, con la puntualizzazione che la riflessione critica ha luo-
25
26
go sempre ‘a posteriori’ rispetto alla scelta compiuta, con l’intento di chiarirne
le implicazioni, e dunque di ‘giustificarla’. Non si è né nell’ambito del ‘pre-logico’ o del ‘pre-razionale’, né in quello del tutto e soltanto ‘logico’ o ‘razionale’. Si
è nel cuore della volontà, fonte creatrice e, in quanto espressione di libertà,
spazio di senso23. Ecco la circolarità della volontà e dell’intelletto, cono di luce
e spazio dell’inedito. All’intelletto non può spettare il primo posto, per il carattere necessitario della sua attività24 che, riflettendosi sull’intera condotta umana, metterebbe fuori gioco la libertà – ‘totus processus esset de causa naturali”25 – anzi, “volitio non esset nisi quaedam inclinatio, sicut gravis ad centrum”26.
Scoto combatte il primato dell’intelletto, non per la luce che reca, ma per la libertà che mortifica27. Il fatto che la condotta umana sia imputabile conferma
questa impostazione, nel senso che la volontà, cui sono funzionali tutte le altre facoltà28, è titolare di quanto accade, sicché nessun atto può essere riprovato, anche solo materialmente, se non perché e in quanto comandato dalla
volontà. La fonte della responsabilità è la volontà29. La finitezza della cosa scelta – la causa prossima – non rende conto della libertà della volontà. Scoto lo
ribadisce, e cioè l’atto può dirsi valutabile “quia libere elicitus”, e cioè scaturisce dalla volontà. Il che vale nel bene come nel male, nell’area del finito come
in quella dell’infinito, perché, nel caso non sia liberamente voluto, quell’atto non
può dirsi né biasimevole né lodabile, perché o inevitabile o casuale30. Con questa condizione, Scoto si affretta a sottolineare che l’atto, che intendiamo realizzare, deve avere tutti i requisiti possibili. L’uomo deve agire da artista, e cioè
armonizzando tutti gli elementi – oggetto, tempo, fine, luogo, modo – in breve,
deve seguire la retta ragione, che di tutto ciò è voce autorevole31. Con il primato della volontà si mette in luce il tratto primario e qualificante dell’atto, nel senso che conferma che qualcosa si dà perché voluto e si dà ciò che la volontà ha
voluto, nel quadro dei suoi progetti, nella cui luce prendono volto i molti elementi che compongono ciò che decide di fare e la sua realizzazione, in rapporto alle epoche storiche e alle culture entro cui si vive e si opera. Storia c’è stata, altra è possibile. Il mondo non è il carcere dell’uomo, ma il teatro e l’alimento delle sue creazioni. Ciò che chiamiamo ‘mondo’ non è la totalità dei dati di
fatto. Esso è l’insieme delle limitazioni cognitivamente significative, entro cui
pensiamo, con il compito però di spostare il confine sempre più in là. In fondo,
l’unica obiezione è la persuasione che tutto sia scritto – in cielo o in terra – per
cui non ci resterebbe che il compito di decifrare ciò che si dà – primato dell’intelletto – e di portarlo a esecuzione – subordinazione della volontà. Razionalismo e necessitarismo stanno però insieme.
2. La libertà fonte dell’essere, unica salvaguardia della contingenza
Scoto applica tale discorso all’atto creativo originario, nel senso che la nostra libertà non è illusoria a condizione che la fonte dell’essere sia libera. La libertà o è fontale – e allora lo spazio del nuovo è assicurato – o, altrimenti, si
risolve in una costruzione fittizia, senza sostegni perché senza radici. La concezione fondazionista medievale induce Scoto a pensare che possiamo dirci li-
SAGGI
beri perché e se Dio è libero, nel senso che poteva non fare ciò che ha fatto o
farlo diversamente. Se non si dà l’inedito, il non-giustificabile o il non prevedibile, quasi che tutto scaturisca da ciò che è, entro cui sarebbe virtualmente
iscritto, il discorso della libertà neppure si pone non per Dio né per l’uomo. La
libertà è la potenza del nuovo, in mancanza del quale non si dà se non l’evoluzione come attuazione di ciò che è virtualmente presente in ciò che già è. Il
che significa che il mondo e quanto è in esso rinviano a un gesto originario di
libertà, solo se potevano non essere o essere diversi da come sono. Il che
equivale a dire che è la contingenza la spia della libertà di Dio riguarda al mondo, dell’uomo riguardo alla storia. Perché, e solo se contingenti, mondo e storia sono espressione di libertà. La contingenza è il prezzo della libertà.
Sembra che il circolo sia inevitabile: il mondo è contingente se Dio è libero,
e Dio è libero se il mondo è contingente. Altrettanto si dica della storia, la quale poteva non aver luogo o aver luogo diversamente se l’uomo è libero, e l’uomo è libero se la storia poteva non aver luogo o aver luogo diversamente. Per
quanto concerne Dio, la prova della trascendenza – descrizione della sua indole oltre che della sua esistenza – ha l’obiettivo di frenare il circolo. Per quanto concerne l’uomo è l’esperienza che gioca un ruolo rilevante, sicché diciamo
che gli atti sono nostri, in quanto e perché voluti32. È inconfutabile l’esperienza? A parere di Scoto, quanti dubitano del suo significato ‘exponendi sunt tormentis’, perché, chiedendo di interromperli, confermano la loro contingenza.
Ora, se contingente, l’azione a cosa rinvia? “La contingenza nell’azione si riduce al principio non ‘naturalmente’, ma ‘liberamente’ attivo, cioè alla volontà”33,
all’infuori della quale tutto accade perché deve accadere, a meno che non partecipi in qualche modo della logica della volontà34. Contingenza e libertà, contingenza perché c’è libertà. Il nesso è inviolabile. “Nessuna contingenza potrebbe esservi nell’operazione di qualsiasi causa seconda rispetto al proprio effetto, se la causa prima non operasse in modo contingente”35. Dunque, la contingenza del mondo naturale rinvia alla libertà di Dio e la contingenza del mondo storico alla libertà dell’uomo. Su questo sfondo, l’assunto è che la categoria che rivela l’origine di tutto è la libertà, quella divina, originaria e fondante,
quella umana, derivata e fondata. La libertà è una sorgente, prosciugando la
quale si è preda della razionalità, senza smagliature se non provvisorie, e la
storia ‘un cimitero di errori’, significativo in quanto indica in quale direzione non
c’è la verità (Popper). Con la libertà tutto diventa più luminoso e dignitoso, anche l’errore, il quale non solo sollecita a evitare un certo percorso, ma rinvia alla libertà, del cui smarrimento è la cifra. L’orizzonte complessivo riceve una
scossa generale di alleggerimento, nel senso che, caduta la necessità come
tratto essenziale, il rapporto di Dio al mondo e dell’uomo al mondo e a Dio è
percepito e proposto all’insegna della libertà, contro “il mito delle leggi di natura ontologicamente necessarie”36, entro cui la visione pagana aveva imprigionato Dio, il mondo e l’uomo. La libertà è la barriera oltre la quale si dà la luce
del mistero, non il baratro del nulla, purché identificata con la capacità creativa di ciò che prima non era affatto37.
Il rilievo, valido sul piano generale, ha una piega immediatamente polemica, con riferimento all’Aquinate, per il quale il contingente trova spiegazione
27
28
nella causa seconda o immediata38. Ma è possibile, si chiede Scoto, render
conto della contingenza di un effetto, rapportandolo solo alla causa prossima?
Stante la necessità della causa prima – cioè della scienza divina – non si compromette forse la contingenza degli effetti? Non è improprio cogliere presente
tra le righe di questo discorso la concezione pagana della libertà, più vicina all’imperfezione che alla perfezione. Identificata con il fare o il non-fare una certa cosa – dunque con la contingenza – la libertà non può dirsi presente in Dio,
nel quale vi è “libertà senza contingenza” 39. Scoto ritiene che, se la libertà non
qualifica la fonte, il contingente in senso plenario non può sorgere. Il principio
è: “L’ordine intero delle cause, fino all’ultimo effetto, sarebbe di segno necessario se il rapporto della Causa Prima alla seconda fosse necessario”40. Tommaso non avrebbe ben distinto, a parere di Scoto, il ‘contingente’ dal ‘possibile’. Ciò che l’Aquinate dice ‘contingente’ è in effetti il ‘possibile’, cui conviene
quella povertà ontologica, propria del possibile, e che consiste nella perfetta indifferenza a essere o a non-essere, escludendo per un verso la contraddizione e per l’altro la necessità. Di tale possibile si ha solo una conoscenza congetturale41. Ciò che non è, ma può essere – il possibile – è presente come tale nella scienza divina, senza che la sua possibilità esiga altra causa all’infuori dell’intelletto divino, il quale, pensandolo, lo produce nell’essere possibile: la
sola necessità che consegue è quella della sua possibilità che, non essendo di
ordine ontico, non pregiudica la libertà divina. Infatti, Dio non è in alcun modo
costretto a produrre in atto tutti o alcuni tra i possibili, i quali possono restar tali, se non interviene la volontà.
Il contingente però è altra cosa rispetto al possibile. Presuppone il possibile, ma non si risolve nella pura possibilità. “Si dice contingente ciò che, mentre
accade, potrebbe non accadere o accadere diversamente”42. La contingenza
non è legata all’essenza, presupposta ma non distintiva, bensì all’esistenza
della cosa contingente, ed esprime una relazione sia alla causa della possibilità in quanto tale, sia alla causa che opera il passaggio dalla potenza all’atto.
Scoto dissente su entrambi i versanti da Tommaso. Se alla domanda circa la
possibilità di creare un mondo diverso dall’attuale, la risposta di Tommaso è
che Dio poteva non creare affatto – il possibile – ma una volta deciso, non poteva che creare il mondo che ha creato, perché il più proporzionato, e cioè la
migliore espressione della razionalità divina nel tempo, allora, il contingente è
tale in quanto finito e insieme è necessario in quanto il più razionale. Scoto è
contro qualunque lembo di necessità, sia nell’atto creativo divino che nella cosa creata, sicché la causa prima va considerata libera di dare e di non dare
l’esistenza, e dunque in grado di conferirla in modo contingente – non solo la
cosa ma anche il modo devono essere contingenti. Senza un principio supremo, che crea in modo contingente, avremmo una sequenza di effetti e di cause, tutte di segno necessitario. Tommaso, dunque, ritiene sufficiente la causa
prossima – la finitezza della creatura – Scoto al contrario esige la causa prima,
perché è con questa che inizia la serie delle cause, attraverso cui passa la necessità o la contingenza a tutta la serie delle cause43. Questa tesi è corroborata dalla priorità ed eminente causalità della causa prima rispetto alle cause seconde44, alla cui luce si spiega pienamente la contingenza del mondo, varia-
3. Libertà alterità responsabilità
Non vi è libertà se non dove vi è alterità, e viceversa. Chi muove dal carattere ‘naturale’ dell’essere considera tutto ciò che è, dispiegamento della necessità. È la libertà il trascendimento della ‘naturalità’ e la condizione della pluralità. L’alterità è la spia della libertà, nel senso che la libertà si esprime nell’alterità. Il che vale per l’infinito come per il finito. “Le Persone divine sono relative”49, anzi il mistero trinitario, in quanto attività pura di conoscenza e d’amore,
è l’insieme delle relazioni, non sostanza statica. Con ardimento Scoto scrive
che ogni persona divina è sempre in divenire (est in fieri), nel senso che ha
l’essere ricevendolo e lo riceve donandolo, in un’alterità costitutiva50. È ardito,
ma legittimo il dire che la Trinità è tale grazie alla libertà, unica garanzia di pluralità. Penetrando nell’intrigo relazionale, Scoto non esita a porre in luce la volontà, cifra dell’amore, a partire dal rapporto del Padre al Figlio, non senza rilevare che l’atto di volontà accompagna la generazione del Figlio, nel senso
che il Padre genera il Figlio volendolo. È la potenza dell’amore, che si esprime
generando, sicché occorre dire che ‘Deus charitas est’51, produzione continua
nell’Atto puro di donazione reciproca. Lo Spirito, che è il vincolo d’unità, è
l’esplosione infinita della volontà amante52. Per dissipare qualunque ombra circa la libertà infinita come volto essenziale di questo gioco di relazioni divine,
Scoto non esita a dire che qui la necessità è il sigillo della libertà e dunque il
volto del carattere infinito della libertà. L’amore è il vincolo di necessità che tiene in libertà le tre persone della Trinità53. Se ogni amore tende all’unità del-
SAGGI
mente esperita45. Dunque, la causa prima va intesa come principio attivo volontario, il che mostra l’indole di ciò e del come chiama all’essere ciò che potrebbe non essere, perché senza alcun diritto, sicché la spiegazione conclusiva della sua decisione non è nella cosa. Dio ‘vult quia vult’, barriera ultima, suo
volto intrascendibile. La volontà – finita e infinita – è il luogo originario della
contingenza46. E questa l’alternativa: o si è presi nell’ingranaggio della catena
della necessità, di cui la razionalità è l’espressione più convincente, o si è con
il peso della responsabilità nella libertà dell’essere. Tutto dipende dall’immagine che si ha della Causa prima. La causa prossima vive di luce riflessa. Il volto di Dio è essenzialmente libero perché trascendente tutto ciò che è.
L’attenzione non deve cadere sulla ‘dimensione arbitraria’ o dispotica47,
bensì sulla libertà che non ha limite alcuno, in alcuna direzione, né prima né
dopo la creazione. Il regno del fattibile è il regno della libertà48. Il che deve indurre a non imprigionare la libertà, la quale non viene meno neppure se chiamata a esprimersi nel campo della necessità, come nel mistero trinitario, dove
la vita delle Persone è a un tempo libera e necessaria. Nell’infinito libertà e necessità si identificano. E così, la stessa visione beatifica rimane libera e insieme, a causa del soggetto di riferimento, necessaria. Dunque, i due principi sono naturale e libero, e gli esseri si distinguono in esseri la cui vita è determinata ab intrinseco – sono naturali – e in esseri liberi – la cui vita prende il volto
che il soggetto decide di imprimerle.
29
30
l’amante e dell’amato, l’amore infinito non tende all’unità, ma è la stessa unità,
intesa come spazio infinito della libertà creativa. “La libertà originaria non si duplica, tanto meno si divide, perché l’essere che è posto è pur sempre l’essere
della libertà”54. La libertà, spazio dell’avvento dell’altro, è costitutivamente posizione di alterità.
In quest’onda creativa va collocato l’uomo, espressione di alterità, di segno
finito, rispetto a Dio, e fonte a sua volta di alterità. È nella libertà l’imparentamento dell’uomo a Dio. Siamo alla duplice biforcazione della libertà, quella divina e quell’umana, con cui viene espunta o indebolita la prospettiva di segno
necessitario, logica nascosta di tutte le prospettive panteistiche e dunque conclusivamente monistiche.
Se il mistero della Trinità è l’esplosione infinita della libertà, il mondo è l’epifania finita della libertà infinita di Dio, oltre che della sua sapienza o della sua
potenza. Il mondo creato è l’espressione del suo volere assoluto, non l’unica
possibile. Se si nega il carattere primario e fondante della libertà, Dio non può
rapportarsi in alcun modo al mondo55, a meno di rilanciare l’espediente greco
della serie di cause frapposte tra il motore immobile e il mondo sublunare, con
il compito di diluirne il potere causale, rendendo così conto dell’imperfezione
dell’effetto56. Fuori di questo espediente, non si ha che l’assunzione della libertà, come volto di Dio, vanificando per questa via la necessità di immutabilità
come la necessità di inevitabilità, non essendovi alcun ostacolo perché una
causa, che può liberamente produrre il primo effetto dal nulla, possa produrre
con eguale libertà e immediatezza tutti gli altri effetti57. Perché altro da Dio, il
mondo è dono, e perché dono è altro da Dio. In quanto autenticamente altro e
dono, il mondo lascia in ombra il donatore, nel senso che resta nascosto, perché il dono sia davvero dono e dunque altro. Il dono sequesta tutta l’attenzione e offusca la propria provenienza, inducendo a pensare che si tratti di un dato neutro e casuale, riportato a un orizzonte di razionalità, il cui spessore assurge a oggetto privilegiato di ricerca, in rapporto a quanto è accaduto o a
quanto accadrà. In quanto autentico artista, l’autore si nasconde dietro l’opera, che affida alla cura dell’uomo, perché ne divenga la voce. È uno dei significati della kenosi divina nel tempo. In questo contesto, nel quale cioè il dono
è dono se il donatore rimane nell’ombra, si impone come prioritario il compito
di raccordare il dono al donatore, dissipando l’ombra che avvolge la provenienza58. È un passaggio nodale, non esplorando il quale si passa dall’autonomia
del mondo all’autosufficienza. È abissale la differenza tra l’alterità – autonomia
– e l’autosufficienza come negazione di dipendenza in quanto un tutt’uno con
la sorgente. Pensandola come necessaria, la causa prima o è frenata nel suo
potere causale dalle cause seconde o è destinata a replicare se stessa, rendendo conto dell’imperfezione degli effetti e insieme rispettando il potere causale delle cause seconde, esercitato però più per render conto dei limiti che di
quanto vi è di positivo59. Alla luce della ragione umana e dell’esperienza, i filosofi non hanno potuto immaginare altro. Per contrasto, si rilevi che il tratto che
qualifica l’idea ‘proprie theologice’ di Dio è che “potest in omnem effectum et
quodcumque possibile”60, perché è il Dio della libertà, con un potere senza alcun limite. Sullo sfondo di siffatto potere, quale il rapporto tra la libertà causa-
SAGGI
le di Dio e il potere causale delle cause seconde? Dio, sommamente libero,
coesiste con le cause seconde – è il senso dell’alterità del mondo – le quali,
causando, rendono omaggio a colui che ha voluto la loro libertà. L’attribuzione
alle creature del ruolo di cause efficienti, in libertà, dà a intendere che Dio non
è geloso del potere causale e che dunque l’uomo è il suo rappresentante nel
tempo. Creando un essere a sua volta libero – l’uomo – giunge a compimento
l’alterità del mondo. Anzi, sembra che la creazione senza libertà sarebbe una
creazione a metà, perché “l’essere creato non sarebbe che l’esistenza del creante (verità del panteismo)”61. Qui l’uomo non è da intendere solo theilardianamente come il vertice e il compendio di tutti i momenti predecessori della creazione, ma colui senza del quale il mondo non sarebbe ‘altro’ rispetto a Dio. L’alterità si ha con la libertà del soggetto, il quale ne conferma il significato diventando a sua volta sorgente di alterità. Da qui il ruolo significativo dell’uomo, autentico punto d’approdo del senso della creazione, perché libero e pertanto autonomo. “Non c’è allora creazione senza l’uomo. Senza l’uomo non vi sarebbe
intervallo, non vi sarebbe colui che a nome del creato sta di fronte al creatore.
Prima dell’uomo l’universo è in un regime panteistico, non una vera creazione.
Ed è solo di fronte ad un’altra libertà che la libertà originaria si confronta con
quell’alterità che le apre uno sconfinato spazio per esercitarsi” 62. Solo nello
spazio della libertà ha luogo l’alterità e questa solo nella libertà può esprimersi. E l’uomo, essere libero, è chiamato a custodire e a dilatare tale alterità, creando a sua volta, in fedeltà all’indole del suo essere. Come ha ricevuto, così è
chiamato a dare63. L’arbitrio qui non ha posto. Qui ha posto la responsabilità
come creatività in vista del compimento dell’essere, o anche in vista della manifestazione dell’essere nella pluralità delle dimensioni, orientate alla pienezza
dell’intero. “L’agire secondo verità […] si dispiega nel dare forma a ciò che nello spazio delle cose che appaiono è degno di permanere”64. La libertà, sorretta dalla logica creativa divina, si afferma come sinonimo di responsabilità, sia
nei riguardi del mondo, di cui è voce, che nei riguardi di Dio, e sia nel rispetto
del senso autentico del creato in quanto ‘inizio’ o cominciamento. Infatti, il creato ‘finito’ non va visto solo come limite, ma anche come cifra del cominciamento, e cioè come conferma di qualcosa di nuovo nel tempo. Abituati a leggere la
finitezza in termini di ‘limite’, facciamo fatica a intenderla come ‘cominciamento’, e cioè come il dar vita a qualcosa nel tempo, e dunque come riscatto dalla finitezza come limite. Come ha luogo siffatto riscatto? Rilevando, anzitutto
che la creazione non è ‘principium’, arché, e cioè evento unico, totale, puntuale, chiuso in sé, nel qual caso sarebbe irrimediabilmente una sorta di carcere.
La creazione è espressione di un gesto creativo, e dunque come un’’ondata di
inizi’, che esigono sviluppo e rinnovata creazione. È il tema delle ‘rationes seminales’ di Bonaventura65 e, prima, di Agostino, il quale nel De Genesi ad litteram parla di ‘rationes causales’, ma anche di ‘primordia seminum’. La lezione,
estesa al mondo finito nel suo insieme, è che ‘sentirsi’ nella creazione è esser
partecipi della sua logica, e dunque esser creativi, non nati per morire, ma per
nascere e far nascere, seminatori di vita, non di morte. È la creazione come
genesi, premessa e conclusione della libertà creativa, assunta a fondamento
della verità; o anche, la traduzione di questa forza irruttiva che è nel fondo del
31
finito in quanto finito. Cos’è la storia se non il compendio delle forme, attraverso cui si è espressa la libertà creativa dell’uomo? Qui lo spirito dispotico che la
prospettiva intellettualistica denuncia latente nella proposta di Scoto, è del tutto fuori luogo.
4. Dalla subordinazione alla coordinazione delle cause
32
Scoto introduce il tema della causalità complessiva come frutto del concorso reciproco di cause parziali – non dunque cause totali subordinate – sicché
è possibile parlare delle cause seconde, indipendentemente dalla causa prima. Cade la subordinazione, legata alla premozione fisica, intesa questa come trasmissione dell’efficienza causale da parte della causa prima nella causa seconda, e si afferma l’idea della causalità come frutto di più cause, come
accade all’atto della scrittura, effetto di due cause simultaneamente, il cuore
e la mano66. Pur qualificandola come inferiore, la causa seconda non riceve,
ma dispone di una propria forza causale, senza la quale parrebbe difficile sottrarla alla logica della causa strumentale. Sia pure inferiore, la causa seconda è causa, titolare dell’effetto, perché dotata della propria causalità. La causa prima, pur disponendo della causalità delle cause inferiori, fa spazio alle
cause seconde, non degradandole a cause puramente recettive e dunque
strumentali. Il tema dell’autonomia e della libertà risulta qualificante. A parere
di Scoto, la causa meno perfetta dà un suo specifico contributo alla produzione dell’effetto, come nel caso della scrittura, la quale ha bisogno di più cause
per essere, compresa la mano. Dunque, su un piano generale, anche la causa meno perfetta dà un suo specifico contributo, senza del quale l’effetto non
sarebbe o sarebbe meno perfetto67. È il punto di rottura con la concezione
neoplatonica, dal momento che la causa seconda e la causa prima sono considerate come cause parziali e distinte, nel senso che l’una non fa a meno dell’altra, ed entrambe causano, a livelli diversi, l’effetto. La superiorità della causa prima rispetto alla causa seconda non sta nel dare l’essere, ma in quella
influenza, grazie alla quale la conserva nell’essere. L’azione conservativa non
consiste nell’imprimere una qualche forma o qualcosa di nuovo nella causa
inferiore, quasi che questa sia sfornita di un proprio potere causale. Quello
che è proprio della causa prima è l’assistenza generale, grazie a cui sono
conservati nella loro natura gli esseri naturali e gli esseri liberi, senza che ciò
esiga che si proceda alla subordinazione delle cause inferiori a quella superiore, perché la conservazione è altra cosa rispetto alla premozione causale.
Il tema della subordinazione, che ben si attaglia alla gerarchizzazione medievale, risulta estraneo alla letteratura francescana in genere. Infatti, questa influenza “est ordo”, cioè si rivela creando e rispettando l’ordine, senza commistione e sovrapposizione tra le cause, le quali agiscono simultaneamente,
ognuna a proprio modo e al proprio livello. Nel circuito entra il termine chiave
di ‘ordine’, che dà luogo alla coordinazione, non più alla subordinazione, e
dunque al rispetto del potere causale delle cause e alla loro titolarità. Ma in
cosa consiste tale ‘ordine’? nell’attuale congiunzione delle cause attive, da
SAGGI
cui, così collegate e nella salvaguardia preconcetta delle rispettive attività,
scaturisce l’effetto comune, cui è funzionale l’attività causale delle singole
cause68. Per meglio intendere il discorso, si prenda in esame una qualche attività, come, ad es., la generazione dell’uomo o la conoscenza. Ebbene, utilizzando l’immagine di Aristotele, secondo cui ai fini della generazione di un
uomo è necessaria l’azione congiunta dell’uomo e del sole, e che Scoto evoca di frequente69, si comprende l’indole del concorso delle due cause, nel senso che l’influsso dell’una non si dà al seguito dell’influsso dell’altra, bensì l’influsso di entrambe le cause sull’effetto – la generazione – ognuna per proprio
conto. Il sole non agisce nell’azione generativa dell’uomo – non dona né l’essere, né il movimento. L’influsso del sole va direttamente nell’effetto cui termina l’azione dell’uomo, e cioè la generazione di un nuovo essere. Altrettanto si
dica dell’attività conoscitiva, la quale ha luogo grazie all’intelletto e alla cosa
conoscibile: sono due cause – intelletto e oggetto – che agiscono in modo autonomo nella produzione dell’effetto – la conoscenza – sullo sfondo della “sola generalis influentia divina”, richiesta per la produzione di qualunque effetto.
Nella spiegazione di questa attività occorre mettere da parte ogni specifica influenza, distinta da quella generale (circumscripta omni speciali influentia).
Dunque, Scoto non ritiene adeguata la spiegazione secondo cui la causa superiore muoverebbe la causa inferiore, di modo che l’inferiore non agirebbe
che in quanto e perché mossa dalla causa superiore, come un bastone che
respinge la palla in quanto e perché mosso dalla mano. La spiegazione che
invece ritiene compossibile con il libero arbitrio è quella del concorso simultaneo di più cause che si muovono a livelli diversi, sicché ognuna per la sua
strada raggiunge l’effetto. È la via che Scoto privilegia, perché riflette meglio
vialità e complessità, e salvaguarda il nostro potere, oltre che dirne il limite.
L’uomo è ‘viator’, che non può rivestirsi di altri panni, quasi che possa uscire
da questa condizione di mendicante e peregrino, né deve ripudiare siffatta
condizione a detrimento della sua prerogativa, la libertà70.
Dio, dunque, coagisce semplicemente, grazie all’influenza generale, con la
causa seconda, qualunque sia l’atto che la volontà voglia porre, unica imputata. A Dio Scoto riserva il ruolo della conservazione nell’essere e della co-azione
attraverso l’influenza che si deve a qualunque creatura. Il che, per quanto concerne l’uomo, è compendiato nell’affermazione, secondo cui la volontà è la causa totale delle volizioni71, non perché Dio non contenga in modo eminente tutta
la causalità e non possa fare da sola ciò che fa con le creature. La ragione di
fondo della sua auto-limitazione è che Dio vuole che la creatura dia prova del
suo potere causale. L’attività causale delle cause seconde – sia naturali che razionali – è espressione della volontà di Dio. L’uomo agisce dando prova della
sua libertà perché Dio vuole che sia libero. Siamo nella logica della causa efficiente, autonoma e responsabile, sottratta all’ombra di quella strumentalità rispetto alla causa prima, cui pare riconduca l’impostazione tomista72. Su un piano più generale, si nota un’autonomizzazione delle creature rispetto a Dio con
la conseguente crisi della strutturazione gerarchica delle cause, propria del medioevo, attraverso cui non è arduo intravvedere la modernità di Scoto.
33
5. Potenza ordinata e potenza assoluta ovvero della creatività
34
Nel contesto del volontarismo di Scoto, il binomio potenza ordinata-potenza assoluta assolve a un ruolo strategico, quale forma indiretta dell’esaltazione della creatività, sia divina che umana, e attestato inaggirabile della libertà
creativa come responsabilità. Esso copre l’area sia divina che umana, politica
e giuridica. Sotto un profilo nozionale, la potenza ordinata riguarda l’area già
tracciata, entro cui muoversi e operare, mentre la potenza assoluta l’area non
ancora definita, dunque, l’una riguarda il fascio di norme esistenti, a cui attenersi, l’altra nuove norme da proporre, aprendo altre strade. I soggetti delle
due potenze sono Dio e l’uomo.
Anzitutto Dio, creatore di un progetto, che conserva nell’essere – operando
con potenza ordinata – ma che può modificare o anche disattendere, in tutto o
in parte – potenza assoluta. Con potenza ordinata, dunque, si allude a quel
complesso di disposizioni che Dio stesso ha voluto e a cui si attiene – è un’autolimitazione – mentre con ‘potenza assoluta’ si allude all’orizzonte infinito,
senza vincoli, che è da sempre l’orizzonte di Dio. È uno spartito di grande respiro, perché conferma che quanto è divino non è per questo assolutamente
vincolante, nel senso che non esprime l’infinità di Dio, a meno che non si condivida l’idea bruniana, secondo cui il mondo è l’epifania di Dio73. Il Dio sovrano
può andare oltre la trama di relazioni e leggi, che costituiscono il mondo che
ha scelto di creare. Il tratto positivistico di sacralizzazione della legge, qui non
ha supporto alcuno. Il che non è poco. Cosa può fungere da misura per colui
che è la sorgente di ogni legge e di ogni norma? La potentia ordinata convive
con la potentia absoluta.
Il fatto che ciò che è non si imponga a Dio come una necessità, ma esprima
solo ciò che ha voluto, ci induce a pensare che la potenza (assoluta) di Dio va
ben oltre le cose create. Le possibilità effettive, non meramente logiche, sono
infinite. È l’orizzonte divino. Se infatti l’atto creativo con l’intreccio delle relazioni costituisce un ‘ordo’, questo non trascende Dio, ma è sua creatura, che conserva se vuole e come vuole. Nel contesto dell’assoluta trascendenza della sua
potenza creatrice occorre solo prendere atto di ciò che ha fatto e ha detto, senza chiuderlo nella cornice della necessità che, per quanto sontuosa, è sempre
infinitamente angusta. Non ci sono obiezioni che tengano. Non quella del disordine, perché ogni ordine è tale in quanto è traduzione di disposizioni divine, né
quello della razionalità, perché l’orizzonte divino è senza limiti, né quello dell’immutabilità, perché nessuno è a parte del suo piano74. È qui che appare puro e
trasparente il tema della libertà come radicale trascendenza divina, contro tutti
gli sforzi umani di circoscriverla per soggiogarla – l’approdo delle versioni intellettualistiche: Dio può fare solo il meglio, cui sarebbe vincolato75. Qualunque ordine, comunque pensato e arricchito, non ha validità autonoma rispetto al volere di Dio, e cioè non possiamo ritenerlo vincolante Dio stesso, senza con ciò
stesso perdere l’infinità di Dio. Non si trascuri – è fondamentale – che prima che
la volontà decida, tutto è indifferente – il possibile può essere o non essere, dunque senza alcun diritto a essere – sicché il senso e il valore di ciò che viene all’essere sorgono dal momento in cui Dio accoglie ciò che l’intelletto propone. La
SAGGI
scelta è libera e insieme razionale, sottomessa in ultima analisi alla volontà che
l’eccede, perché può volere altro o in altro modo.
Questo duplice potere – agire in linea con il ritmo attuale delle cose o fuori o contro – Scoto non lo riserva a Dio. Esso appartiene a tutti gli esseri liberi, in conformità a quanto i giuristi dicono circa ciò che di fatto è possibile, nel
senso della trasgredibilità della normativa in atto, a favore di altri percorsi, e circa ciò che il diritto vigente consente: è la distinzione tra il “facere de facto”, nel
senso delle riserve di potere, in grado di portarci oltre o contro la normativa vigente – Scoto parla di potentia absoluta sua – e il “facere de iure”, nel senso
del rispetto delle leggi codificate76. Se per quanto concerne Dio la potenza ordinata allude a una sorta di auto-limite, nel senso che non fa ciò che ha deciso di non voler fare, mentre la potenza assoluta o pienezza di potere rinvia all’immenso scenario che si apre a causa della sua infinità, per quanto concerne l’uomo si dà in modo analogo una potenza relativa a quanto già normato e
una potenza che va ben oltre, in negativo e in positivo, con una diversa legittimazione, non essendo padrone di tutto, come invece è Dio. Dunque, ogni essere dotato di volontà – in grado di poter e voler fare – o si attiene alla norma,
o si scontra con essa, andando oltre o violandola, perché gode di una potenza ordinata e di una potenza assoluta, il che si dica di qualsiasi individuo, come del paterfamilias, del papa, del re, rispetto agli ambiti di pertinenza. È il
trionfo della libertà, non dell’arbitrio. È scontato il potere del re di intervenire
sulla legge, concedendo la grazia al condannato. Chi ha mai messo in discussione la riserva di potenza assoluta, non regolamentata dal sistema di leggi,
cui il re si richiama in periodo di guerra, di carestia, di disordini civili…? È la logica della sovranità – papale o regia – che funge da supporto dell’assunto. Qui
la libertà è autentica responsabilità, non arbitrio.
La potenza assoluta contiene in sé la potenza ordinata, nel senso del meno nel più. La cosa non risulta strana perché il paterfamilias ha più potere del
figlio, quella del capo del governo più del capo di famiglia, quella del papa più
dei fedeli, quella di Dio più tutti, perché sopra tutto. È una scala di poteri assoluti o di potentiae absolutae, analoga alla scala delle potentiae ordinatae. “Ciascun sistema appare sospeso alla volontà di colui o coloro che rispetto ad esso hanno facoltà di dispensatio (facoltà che viene direttamente dal potere di
costituzione del sistema), con un movimento discendente che – da Dio all’uomo – restringe via via gli ambiti di disposizione. Il potere di ciascun livello della scala degli esseri razionali (di coloro che agiscono liberamente) è composto
dalla somma delle azioni legittimamente possibili al soggetto tanto de potentia
ordinata che de potentia absoluta”77. Al centro è la responsabilità e dunque la
perspicacia dell’occhio di chi sa che l’andamento delle cose dipende in qualche modo dalle sue decisioni e che comunque le sue scelte possono qualificarlo arricchendolo o impoverendolo.
Se appartiene a tutti gli esseri razionali, questa duplice potenza spetta in
modo difforme a Dio e agli uomini, nel senso che se l’ordo ut nunc non è l’ordo ut semper – il che vale per tutti – Dio ne è padrone, ma non l’uomo se e in
quanto rientra in tale ordo. Che sia di origine divina non vuol dire che tale ordo sia a sua volta divino, e cioè immodificabile e inviolabile, a meno che Dio
35
36
stesso non lo abbia rivelato. È quanto Scoto dice in merito alla prima tavola
mosaica – esiste un solo Dio che è da onorare – e ovviamente in merito al contenuto della Rivelazione78, da interpretare però – è una parola che va ascoltata e intesa in modo corretto – con quanto ciò comporta, contro tutte le posizioni fondamentaliste, che sono sempre letteraliste. Per il resto, si è visto che l’ordo è la traduzione in atto da parte della volontà divina del progetto dell’intelletto, dunque uno tra gli infiniti possibili, difficile da ricostruire, ma certamente non
irrazionale. Il principio è che se “est in potestate agentis lex et rectitudo legis”,
tutto è permesso79, con l’ovvio impegnativo compito di precisare quale legge
non sia nelle mani dell’uomo. È un programma, più che un ordine o anche, un
orizzonte, da tracciare sempre da capo. Il Dio libero che crea l’uomo libero non
può volere la mortificazione della sua libertà – da qui lo sforzo di potenziarla,
ampliarla, non circoscriverla o, peggio, mortificarla. Il vero problema è dunque
la libertà come responsabilità, con l’implicito interrogativo cosa effettivamente
protegga tale libertà, se un fascio di leggi già emanate e codificate o, invece,
leggi da immaginare ancora e codificare o, comunque, da interpretare, nel primo caso si tratterebbe di confermare la libertà come responsabilità, nel secondo di rafforzarla su un terreno ancora da disegnare e realizzare.
Se sono definite in rapporto a un ‘ordo’ o progetto, le potenze (ordinata e
assoluta) sono concetti relativi, da precisare volta per volta in rapporto all’ordo
in questione, da esplorare con attenzione, onde stabilire se conservarlo o se
modificarlo, dando prova di intelligenza creativa. Più che segno di arbitrio e di
tracotanza, queste due potenze sono inviti a prestare attenzione all’ordo in atto
per decidere se attenersi alle sue implicazioni, o se disattenderle per andare oltre o contro, misurando di volta in volta i progetti alla luce degli ordines, frutto e
compendio di quanto riceviamo in dono dal passato, non senza interrogarci se
trasmetterli immutati o arricchiti o modificati. Il che comporta un’impegnata operazione di decostruzione, vòlta a individuare ciò che funge da pilastro e ciò che
ruota intorno, immaginando combinazioni non contraddittorie, quale area del
nostro ardimento creativo. È il fecondo tema del ‘paradigma’, con la sua forza
aggregante, che segna le epoche storiche. Il senso del ‘non-definitivo’, che accompagna la valutazione dell’ordinatio, autorizza un approccio operativo sia
che si rispetti, sia che si introduca un nuovo ordine, arricchendo il precedente o
creando qualcosa di totalmente nuovo. Le rivoluzioni non sono contro Dio, ma
contro determinati ‘ordines’, con l’intento di farne nascere di nuovi. L’arbitrio qui
non c’entra se non come pretesto per bloccare la libertà.
6. Modernità antimoderna di Scoto
Ma la potentia absoluta, come intervento sempre incombente sull’ordo attuale, non ha forse un esito scettico, paralizzante la ricerca, se letto dal punto
di vista di Dio, e un esito dispotico e arbitrario se visto dal punto di vista dell’uomo, nel primo caso inducendo l’uomo ad abbandonarsi a Dio, padrone delle creature e del loro ritmo, nel secondo mettendo tutto nelle mani dell’uomo
forte, secondo cui auctoritas, non veritas, facit legem? Fuori della verità e dun-
SAGGI
que del primato dell’intelletto, non si intravede un futuro, appannaggio dell’arrogante? Quale lo spazio del vero e del bene? Non occorre, forse, uscire dal
primato della volontà e dunque della libertà e approdare al campo del vero e
del bene, oggettivi e sacri, unica barriera contro il sopruso e l’arbitrio? Siamo
all’obiezione più diffusa ma non per questo la più efficace.
Certo, la potentia absoluta non allude solo ai mondi possibili, ma anche all’ipotetico intervento di Dio sull’ordinamento attuale del mondo80. Va, infatti, ribadito che per Scoto Dio, al pari di ogni essere razionale, possiede l’effettiva
possibilità di fare cose diverse da quelle che fa, a conferma della finitezza e
provvisorietà di tutto ciò che viene all’essere, essenzialmente contingente. Sono note le molte infrazioni alle leggi attraverso ciò che chiamiamo ‘miracolo’.
Dal nostro punto di vista – esseri finiti – si tratta di disordine, come, ad es., il
fatto che un ramo bruci senza consumarsi o che dei bambini escano indenni
da una fornace ardente. Sono eventi che però non creano particolari problemi
grazie alla categoria ‘miracolo’ con cui il medioevo cristiano ha isolato il meraviglioso, riportandolo a un unico autore, Dio, ma anche teorizzando una specifica potenza, quella ‘assoluta’, ben distinta da quella ‘ordinata’. È la via per non
parlare della ‘libertà creativa’ come tratto qualificante e primario, e introdurre
una sorta di ‘ortodossia del meraviglioso’81, barriera protettiva dell’ordinario rispetto al resto, che rientra nell’ambito dello ‘straordinario’. Ma l’eccezione non
è frutto forse della potentia absoluta?
Certo, l’immagine del Dio onnipotente, con i suoi risvolti di immediatezza e
di possibile intervento – è un potere de facto – potrebbe risultare fonte di dispotismo e comunque sua giustificazione. Sotto questo profilo potrebbe risultare un passo indietro rispetto al concetto tradizionale della potenza infinita della causa prima, necessitata a esercitare in un certo modo la sua causalità, dunque prevedibile e controllabile82. Eppure, Scoto dichiara momento qualificante
della rivelazione cristiana l’immagine del Dio onnipotente e libero, con cui appaiono piuttosto mitiche le leggi di natura ontologicamente necessarie, di origine aristotelica, diventate presto modelli e concetti, da correggere, modificare o
soppiantare, in base ai suggerimenti dell’esperienza e dell’esperimento83. Con
la ragione si dimostra che il primo efficiente ha in sé “potentiam effectivam eminentiorem potentia cuiuscumque alterius causae effectivae”, da cui però non è
possibile dedurre che dunque, tale primo efficiente possa agire in modo immediato nella produzione dell’effetto proprio della causa seconda – “ordo enim
causarum inferiorum hoc non concedit”84. Ciò che la causa superiore può assieme a una causa inferiore non è detto che lo possa da sola85. Fin qui la filosofia pagana. Solo la rivelazione biblica guadagna l’immagine di un Dio che
può tutto, libero di agire come e quando vuole, dotato della potenza di produrre l’effetto con e senza il concorso delle cause seconde: “Haec propositio:
quod quidquid Deus potest per causam efficientem mediam, potest per se immediate, tantum credita est”86. Dunque, l’immagine del Dio che può tutto come
e quando vuole, Scoto la ritiene frutto della rivelazione divina, conquista di alto profilo87. Ora, la pagina biblica, oltre che mettere in luce l’onnipotenza, pone
al centro l’amore di Dio per la creatura, che è stata voluta, e dunque l’attenzione per il suo recupero e la sua elevazione. Quale altra via più significativa per
37
38
indicare il percorso lungo il quale Dio fa valere il suo potere? L’amore che ha
per l’uomo non è l’amore di un impotente, ma l’amore dell’onnipotente, rispettoso della sua libertà progettuale, sua creatura prediletta, chiamata a sua volta a dar prova di un amore analogo a favore dei suoi simili. Quale il metro,
l’obiettivo, sacro e inviolabile, da porre in alto, se non la libertà creativa di tutti, da sostenere e alimentare? E cos’è la storia se non storia di libertà, tra cadute e risurrezioni, tra involuzioni e progressi?88
Dunque, la dottrina della doppia potenza – ordinata e absoluta – è una
grande conquista, non un equivoco o un arretramento, il cui merito sta nell’aver
sciolto Dio da vincoli che ne hanno offuscato l’immagine, e l’uomo tratto fuori
dalla ‘caverna’, in cui costantemente ricade, intimorito dalla sua stessa libertà,
e dunque da educare al calore del sole e alla luce dell’‘aperto’. Siamo alla fonte dei problemi, ma anche alla loro soluzione. La libertà è la sorgente primaria,
in grado di alimentare l’esistenza sotto il profilo sia problematico che risolutorio. Scoto ha avuto l’ardire di proclamarlo in modo forte e inequivocabile, invitando a dischiudere tale scenario, senza lasciarsi paralizzare dalla paura delle sue conseguenze.
È indubbio il collegamento tra valore, volontà e potere nel contesto della libertà creativa. Finché il discorso ha riguardato Dio la saggezza era implicita,
legata alla sua presenza, quale legislatore benevolo e supremo, nel contesto
di quella titolarità che sottrae il discorso a quello sfondo neutrale, proprio della
prospettiva greca, per la quale il bene è bene non perché voluto ma perché tale da sempre. Nella risposta di Socrate, le leggi valgono di per sé, esista o meno un responsabile, il quale può al più vigilare circa la loro osservanza, non garantirne la validità. È la filosofia dell’intelligibile in sé e per sé. L’ombra mobile
del tempo può velarlo, non però fondarlo. Qui il realismo come protezione dell’universale, ritenuto più perfetto e ricco dell’individuale, si impone, senza perplessità alcuna – le idee per Platone, la sostanza per Aristotele e, prima dell’uno e dell’altro, l’essere immutabile per Parmenide. Ebbene, Scoto facendo
un’inversione di marcia pone al centro un legislatore, dal quale dipende tutto,
senza con questo perdere l’ordine e l’armonia greca. Infatti, essendo infinito,
tale nomoteta si esprime con sapienza, eliminando la distinzione tra leggi valide per natura, perciò immutabili, e leggi istituite. Secondo la dottrina creazionistica-volontaristica tutto è ‘istituito’, perché nulla si impone a Dio. Libertà e
sapienza non sono dissociabili. Scoto eleva un inno alla trascendenza suprema di Dio.
Ora, accanto a questo capitolo di esaltazione della libertà creativa divina
Scoto colloca il capitolo relativo all’uomo, voluto libero da Dio, sostenuto per
un verso dalle pagine bibliche relative alla creazione dell’uomo, a immagine e
somiglianza di Dio, e dalle pagine relative al dramma del peccato e della salvezza. Siamo fuori dal clima filosofico greco, grazie al primato dell’individuale
sull’universale e alla libertà come responsabilità, oltre la necessità oggettiva.
L’aver attribuita importanza alla volontà divina porta ad attribuire analoga importanza alla volontà dell’uomo, dapprima come risposta alla volontà divina,
che nei suoi comandamenti interpella la volontà più che qualunque altra potenza umana; poi, sempre più come attributo qualificante dell’uomo. Le suggestio-
SAGGI
ni che vengono dalla natura umana e quanto Dio ha rivelato costituiscono un
insieme di norme che orientano il cammino dell’uomo che liberamente fa spazio e accoglie quel dettato, a un tempo naturale e rivelato. Ma se l’uomo è libero e creatore, perché tante norme? Se sono la forma che la libertà legislativa ha assunto, le norme rivelate occorre interpretarle assimilandone il carattere creativo, e cioè osservandole in quanto forma di quell’onda creativa che ci
raggiunge, perché ognuno apra nuovi capitoli in rapporto alle nuove situazioni.
Quale allora il problema?
Finché Dio è rimasto al centro, il discorso ha retto all’urto delle obiezioni.
Quando però la sua forza legislativa entra in crisi, rimane in piedi l’uomo e la
sua volontà creativa. Nella modernità l’uomo non prende forse il posto di Dio?
Indubbiamente, all’uomo moderno giunge accresciuto, centrale e incensurabile, il potere creativo, che un tempo era di Dio. “Fu questo l’effetto potenzialmente dirompente della svolta determinata dal confluire di scotismo e nominalismo, che segnò il pasaggio dal Medioevo all’Età moderna”89. Sembrerebbe che con la morte di Dio e la crisi del realismo, siamo sospinti verso la volontà di potenza di Nietzsche, al di là del bene e del male, con un epilogo paradossale di misconoscimento di qualunque norma. Il primato della volontà
sembrerebbe che conduca all’equivalenza baconiana tra potere e sapere;
l’imperativo categorico kantiano se per un verso – dovere per il dovere: universalismo – rinvia al primato del vero, per l’altro è la traduzione del primato
della volontà o ragion pratica. La frammentazione poi contemporanea pare un
epilogo obbligato dell’emarginazione della ragione universale e della sua funzione veritativa. Posto nei termini della filiazione della modernità dal primato
della volontà creatrice e dal conseguente primato dell’individuo, cui porta il
nominalismo, paiono obbligate le critiche sia per quanto concerne lo scollamento tra ragione e fede, sia per quanto concerne l’affermazione delle versioni dispotiche e arbitrarie in campo politico. È l’effettivo cammino della storia,
non però scotista-occamiano90.
Più che generare un atteggiamento scettico, la duplex potentia (ordinata e
assoluta) aiuta 1. a trasformare la necessità assoluta delle leggi fondamentali
in necessità condizionata, risolvendo lo spessore legale delle cose in un insieme di relazioni oggettive, e a pensare il mondo come un fascio di rapporti fra
le res, con una volontà istituente, sia divina che umana. Il mondo non è senza
un titolare. Questo stile interpretativo non impedisce di ritenere che tali relazioni siano oggettive, bensì che siano pregiudizialmente assolute e pertanto inviolabili. 2. Inoltre, la duplice potentia aiuta a immaginare altri mondi e altri modi
di pensare gli eventi; 3. e a ipotizzare altri modi di moralità, non prolungamento necessario dei precetti in atto. 4. Ciò che davvero conta, e che andrebbe
esaltato, è che tale duplice potentia induce a ritenere parziale e approssimativo il tentativo ricorrente di esaurire con la metafisica la trama del reale divino
e naturale. Non è difficile intravvedere sullo sfondo un movimento liberatorio di
energie e possibilità, che fa dell’uomo un autentico procreator ossia un artista
in grado di ‘immutare rerum naturam’, fonte di valore e di norme, e dunque
soggetto e insieme titolare di storia91.
L’assolutismo è un frutto necessario o una deliberata distorsione? Il nesso
39
40
che si è stabilito, quasi fatalmente, in una corrente della storiografia, fra contesto nominalista e potentia absoluta divina ha portato a fare del Dio cristiano e
biblico un tiranno capriccioso e incomprensibile. È l’epilogo cui conduce quella storiografia che assume come primario il vero oggettivo e come qualificante
l’intelletto, nella falsa persuasione che le cose siano state dette una volta per
tutte – il vero oggettivo – e che il nostro compito è quello di leggerle per come
sono – adequatio rei et intellectus – senza apportare alcuna modifica. Scoto –
la scuola francescana – privilegia la libertà creativa, di cui la distinzione tra potentia ordinata e potentia absoluta è solo una conferma, non una smentita92.
Per riproporne il contenuto, è necessario individuare l’origine di quelle forme
dispotiche e totalitarie, che hanno abbrutito la storia, e riporla nel primato della verità, da alcuni rivendicata contro altri, squalificati come vittima dell’errore.
Finché non si perviene alla tesi che la verità è la forma che assume la libertà
creativa, da giudicare in base alla sua capacità di ampliare gli spazi dell’essere, si riterrà sacra l’obiezione secondo cui il volontarismo di Scoto è prologo
inevitabile al dispotismo. La libertà creativa è possibile riassumerla a fondamento del pensare e dell’operare a condizione che venga percepita e vissuta
come donata e dunque da donare a propria volta. Finché non sorge questo circolo virtuoso, qualunque percorso risulta ostruito dal macigno del potere fine a
se stesso, di cui la verità è il mascheramento più paludato.
In tale ottica si comprende il ruolo significativo della potentia absoluta, fonte critica di qualunque atteggiamento positivistico rispetto alle leggi volute dalla potentia ordinata, e motivo di distanziamento dalla prospettiva tomista, secondo cui la sapienza divina comprende in sé l’intera facoltà della potenza93,
sicché potentia ordinata e potentia absoluta non sarebbero divise, diventando
un puro espediente umano, vòlto a considerare l’onnipotenza divina eccedente nelle sue possibilità i limiti dell’ordine stabilito. In Tommaso questa ‘ordinatio’ appare come il principio dell’agire divino, al quale non corrisponde alcun
concetto complementare o correttivo di potentia absoluta. L’unità degli attributi fa tutt’uno con l’unità della sua essenza, al di qua d’ogni possibile distinzione. Scoto al contrario si inoltra sulla via della distinzione, al fini di far prevalere un’idea, e cioè l’idea della trascendenza di Dio su tutto ciò che è – è questo
il significato della duplice potentia. La legge, che indica il fondamento della potenza ordinata di Dio, non è forse frutto della potenza assoluta, dal momento
che prima non era? Ciò che conta ribadire è che, a parere di Scoto la legge è
giusta, se voluta dalla volontà di Dio, con cui vien meno qualunque atteggiamento positivistico, corroso dal concetto di libertà creativa, segno di responsabilità, non di arbitrio. Colui che è dotato di intelletto e volontà può agire in conformità alla legge oppure oltre o, come nel caso dell’uomo, contro di essa, ponendo l’insolubile problema dell’oggettività e immutabilià della legge, con il
conseguente interrogativo circa l’ambito della libertà creativa e dunque della
misura della libertà.
Ordinatio (=Ord) IV, d. 49, q. 4 (q. ex latere), n. 16.
BENEDETTO XVI, Fede ragione e università. Ricordi e riflessioni, in AA. VV., Dio salvi la ragione, Siena, Cantagalli 2007, p. 18.
3Radici cristiane), 4 (2006) p. 68.
4 De Primo Principio (= Pr.Pr.), cap. IV, sexta via (ed. Müller p. 109): “Voluntas nostra potest
omni finito aliquid maius appetere vel amare, sicut et intellectus intelligere”.
5 Reportationes Parisienses (=Rep. Par.) II, d. 25, q. u., n. 2.
6 Ord. II, d. 25, q. u., n. 2
7 Ivi: “voluntas utitur omnibus aliis potentiis”.
8 Ord. I, d. 39, q. u., n. 16: “Istam libertatem concomitatur una potentia ad opposita manifesta”.
9 Ord. IV, d. 49, q. 10, n. 10: “Quando accipitur quod illud, in quo non est defectus boni, vel ratio mali, est necessario volitum, dico quod falsa est propositio, quia voluntas respectu cuiuscumque actus est libera, et a nullo obiecto necessitatur”.
10 Ivi: “In pluribus habet actum volendi sed non necessarium aliquem actum, sed potest se suspendere ab omni actu ostensa beatitudine”.
11 Ord. II, d. 44, q. u., n. 2: “Dico quod libertas absolute est perfectio simpliciter, unde formaliter ponitur in Deo (…)¸in nobis limitata […]; ita dico quod haec voluntas huius speciei, quae est in
nobis, includit libertatem, quae est perfectio simpliciter”. Occorrerebbe evocare qui la metafisica
dell’univocità per intendere il senso scotista della ‘libertà’, sia che venga predicata di Dio che dell’uomo; e, soprattutto, il capitolo dei ‘modi di essere’ o ‘prima divisio entis’, costituita dai modi finito-infinito, per non essere costretti a qualificare la volontà umana come ‘infinita’, come pare sia costretta la scuola tomista, altrimenti preda della logica del principio del ‘quidquid movetur ab alio movetur’, con cui la libertà risulta motificata. Si veda quanto scrive D. Sacchi nel bel saggio Lineamenti di una metafisica di trascendenza, Roma, Studium 2007, p. 170: “Non per nulla s. Tommaso dichiara libero il volere umano solo perché sa di poterlo dichiarare infinito, sia pure di un’infinità che non è tale in ogni ordine”.
12 Quodlibetales (=Quodl.) q. 16, n. 6: “Et ratio differentiae est, quia intellectus movetur ab
obiecto naturali necessitate, voluntas autem libere se movet”.
13 Ord. II, d. 42, q. 4, n. 19: “Potentia motiva est in potestate voluntatis […] et similiter potentiae sensitivae, et etiam vegetativae, quatenus dependent a motiva […]. Unde Augustinus XI De
Trinitate, cap. 8, dicit quod quia operatio palpebrarum necessario requiritur ad visionem, et motus
localis palpebrarum obedit animae, eatenus visio est in potestate voluntatis. Appetitus noster, in
quo convenimus cum brutis, est liber et rationalis per partecipationem, non autem per actum suum,
sed per actus alterius potentiae, scilicet voluntatis cui subest”.
14 Ord. III, d. 17 q. u., n. 3: “Dicitur [voluta] libera in quantum in potestate eius est ita elicere
actum oppositum inclinationi, sicut conformem, et non elicere, sicut elicere”.
15 Ord. II, d. 25, q. u., n. 22.
16 Ivi: “Igitur ex hoc potest haberi quod nulla actio in nobis est ita a nobis sicut volitio voluntatis”.
17 Situando la beatitudine nella sfera della volizione, Scoto rompe con una tradizione millenaria che aveva concepito il fine ultimo come forma di conoscenza.
18 Ord. I, d. 1, n. 187: “Frui est amore inhaerere alici propter se, ut dicit Augustinus […]; sed
sic viator inhaeret Deo; ergo potest frui Deo”.
19 Ord. IV d. 49, q. 4, (q. ex latere), n. 13: “Nulla ignorantia Dei etiam infidelitatis potest esse
ita odibilis, sicut odium Dei, si posset voluntati inesse. Actus non est perfectior nisi quia coniungit
obiecto perfecto; actus autem voluntatis coniungit rei in se; actus autem intellectus nonnisi rei, ut
obiectum est in cognoscente”.
20 Ord. IV, d. 49, q. 4 (q. ex latere) n. 16: “Voluntas imperans intellectui est causa superior actus eius. Intellectus autem si est causa volitionis, est causa subserviens voluntati”.
21 Quodl. q. 2, n. 26: “Essentia mere intellectualis non est principium alicuius productionis, nisi ut coincidit cum memoria et voluntate”.
1
SAGGI
2
41
42
22 Ord. I, d. 39, n. 24: “Utrolibet istorum modorum ponatur intellectum divinum cognoscere existentiam rerum, patet – secundum utrumque – quod est determinatio intellectus divini ad illud existens ad quod determinatur voluntas divina, et certitudo infallibilitatis (quia non potest voluntas determinari quin intellectus determinate apprehendat illud quod voluntas determinat); et immutabilitas […] Et tamen cum istis stat contingentia obiecti cogniti, quia voluntas determinate volens hoc,
contingenter vult hoc”.
23 Ord. I, d. 39, n. 7: “Rationes cognoscendi terminos alicuius complexionis non sufficienter
causant notitiam alicuius complexionis, nisi illa nata sit cognosci ex terminis, quia tunc non tantum
esset necessaria, sed etiam prima et immediata […]. Praeterea, eodem modo sunt ideae possibilium sicut futurorum, quia ista differentia ‘possibilium non futurorum a futuris’ non est nisi per actum voluntatis divinae”.
24 Ord. II, d. 6, q. 2, n. 11: “Non est in potestate intellectus moderari assensum suum veritati
quam apprehendit”.
25 Quodl. q. 16, n. 6. Con la conseguenza che, se il mondo non esistesse, neppure Dio esisterebbe: “Sed si necessariam habitudinem habet ad primum causatum, [Deus] illo causato non existente, non esset; igitur, non habet ad illum necessariam habitudinem” (Ord. I, d. 8, n. 280).
26 Ord. IV, d. 49, q. 4 (q. ex latere), n. 17.
27 Ord. II, d. 49, q. ex latere (Utrum potentia sit nobilior, intellectus an voluntas), n. 17: “Quod
autem intellectio non sit totalis causa volitionis patet, quia cum prima intellectio causetur a causa
mere naturali, et intellectio non sit libera, ulterius simili necessitate causaret quidquid causaret, et
sic quomodocumque circuli fierent in actibus intellectus et voluntatis, totus processus esset mere
necessitate naturali; quod cum sit incoveniens, ut salvetur libertas in homine, oportet dicere posita intellectione, non habere causam totalem volitionis, sed principaliorem respectu eius esse voluntatem quae sola libera est”.
28 Ord. II, d. 49, q. ex latere, n. 16 (in corpore): “et hoc modo voluntas imperans intellectui est
causa superior respectu actus eius”.
29 Ord. II, d. 42, q. 4, n. 1-2: “Ex quo sequitur quod in cogitatione, sermone et opere, non est
peccatum formaliter et primo, sed hoc est in solo actu voluntatis”.
30 Ord. II, d. 40, q. u., n. 3: “neque enim actus est laudabilis, nec vituperabilis nisi sit a voluntate”.
31 Ord. I, d. 17, q. 2, n. 16: “Dici potest quod sicut pulchritudo non est aliqua qualitas absoluta
in corpore pulchro, sed est aggregatio omnium convenientium tali corpori, puta magnitudinis, figurae et coloris, et aggregatio omnium respectuum qui sunt istorum ad corpus et ad se invicem; ita
bonitas moralis actus est quasi quidam decor illius actus includens aggregationem debitae proportionis ad omnia.
32 Ord. I, d. 3, p. 1, q. 4, n. 238: “De actibus nostris dico quod est certitudo de multis eorum
sicut de principiis per se notis… Et sicut est certitudo de vigilare, sicut de per se noto, ita etiam
de multis aliis actibus qui sunt in potestate nostra ut de me intelligere, de me audire et sic de
aliis”.
33 Quodl. 16, n. 8: “Contingentia in agendo reducitur ad principium non naturaliter activum, sed
libere”.
34 Ord. I, d. 2, q. 1-2, n. 81: “Nullum est principium operandi contingenter nisi voluntas vel aliquid concomitans voluntatem, quia quodlibet aliud agit ex necessitate naturae, et ita non contingenter”.
35 Ord. I, d. 39, q. u., a. 2, n. 14: “Nulla causatio alicuius causae secundae potest salvare contingentiam nisi Causa Prima ponatur immediate contingenter causare”.
36 H. A. OBERMAN, Via antiqua e via moderna. Preambolo tardo medievale alle origini teoriche
della riforma, in Sopra la volta del mondo. Onnipotenza e potenza assoluta di Dio tra medioevo e
età moderna, Bergano, Lubrina 1986, p. 60.
37 Ord. II, d. 1, q. 2, n. 91: “Voluntas Dei – qua vult hoc et pro nunc – est immediata et prima
causa, cuius non est aliqua alia causa quaerenda: sicut enim non est ratio quare voluit naturam
humanam esse in hoc in individuo et esse possibile et contingens, ita non est ratio quare hoc voluit nunc et non tunc, sed tantum ‘quia voluit hoc esse, ideo bonum fuit illud esse’; et quaerere
huius propositionis – licet contingentis immediate – aliam rationem, est quaerere rationem cuius
non est ratio quaerenda”.
38 J. MARITAIN, Ragione e ragioni, Milano, VeP 1982, p. 33: “In Dio vi è libertà senza contingenza, vale a dire che tutta la contingenza sta dalla parte dell’oggetto creato voluto o non voluto da
SAGGI
Dio, e che l’atto divino invece, libero riguardo a tale oggetto, è in se stesso necessario, in quanto
identico all’essenza divina”.
39 Summa Theologiae (=ST) I, q. 14, a. 13, ad 1um: “Licet causa suprema sit necessaria, tamen
effectus potest esse contingens propter causam proximam contingentem: sicut germinatio plantae
est contingens propter causam proximam contingentem, licet motus solis, qui est causa prima, sit
necessarius. Et similiter scita a Deo sunt contingentia propter causas proximas, licet scientia Dei,
quae est causa prima, sit necessaria”. Il problema non è tuttavia riducibile alla distinzione tra il carattere infinito dell’atto con cui Dio vuole qualcosa e il carattere finito di ciò che vuole. Scoto non esita a sottolinearlo, dicendo che se nel mistero trinitario è infinito tutto ciò che le singole persone vogliono, per quanto concerne il mondo se l’atto divino con il quale è voluto è infinito, ciò che è voluto è invece finito: “Talis voluntas (divina), habens tale obiectum praesens, est principium communicandi naturam divinam, quia principium producendi amorem productum infinitum; talis enim amor
productus proportionatur proportionatur tam potentiae quam obiecto, – non ita quando voluntas infinita respicit bonum amabile finitum, quia licet ibi actus sit infinitus quantum est ex parte voluntatis
divinae, non tamen est infinitus quantum est ex parte obiecti”. (Ord. I, d. 10, q. u., n. 49).
40 Ord. I, d. 39, q. u., n. 12: “Tota ergo ordinatio causarum, usque ad ultimum effectum, necessario produceret si habitudo Primae Causae ad sibi proximam causam sit necessaria”.
41 STh, ivi: “Et sic consideratur ut futurum, et ut contingens nondum determinatum ad unum:
quia causa contingens se habet ad opposita. Et sic contingens non subditur per certitudinem alicui cognitioni. Unde quicumque cognoscit effectum contingentem in causa sua tantum, non habet
de eo nisi coniecturalem cognitionem”. Qui non solo c’è il problema della conoscenza congetturale, ma soprattutto la riduzione del contingente a possibile.
42 Pr. Pr., cap. 4, quarta concl.: “Non dico hic contingens quodcumque non est necessarium
nec sempiternum, sed cuius oppositum posset fieri quando istud fit; ideo dixi: aliquid contingenter
causatur, non: aliquid est contingens”.
43 Ord. I, d. 39, n. 12: “Quod probatur, breviter, ex hoc quod causa movens – in quantum mota – si necessario movetur, necessario movet; quaelibet ergo causa secunda quae producit in
quantum mota a prima, si necessario movetur a prima, necessario movet proximam sibi vel producit effectum suum. Tota ergo ordinatio causarum, usque ad ultimum effectum, necessario producet si habitudo primae causae ad sibi proximam causam sit necessaria”.
44 Ivi: “Praeterea, causa prior prius naturaliter respicit effectum suum quam causa posterior: ergo in illo priore, si habet necessariam habitudinem ad ipsum, dabit sibi esse necessarium. In secundo autem instanti naturae non potest causa propinque dare sibi esse contingens, quia iam praeintelligitur habere a causa prima esse, repugnans contingentiae… Praeterea, quidquid producitur
a causius posterioribus, posset immediate produci a prima – et tunc haberet eandem entitatem
quam modo habet, et tunc esset contingens sicut modo est contingens; habert ergo contingentiam
suam etiam modo a causda prima, et non tantum a causa proxima. Praeterea, Deus multa produxit immediate […] et tamen omnia contingenter”.
45 Ord. I, d. 39, n. 14: “Supposito igitur isto tamquam manifeste vero, quod aliquod ens est contingens”.
46 Ivi: “Primum autem est causans per intellectum et voluntatem, et si ponatur tertia potentia
exsecutiva (alia ab istis), non iuvat ad propositum, quia si necessario intelligat et velit, necessario
producit. Oportet igitur contingentiam istam quaerere in intellectu divino, vel in voluntate divina.
Non autem in intellectu ut habet actum primum ante omnem actum voluntatis, quia quidquid intellectus intelligit hoc modo, intelligit mere naturaliter et necessitate naturali – et ita nulla contingentia potest esse in sciendo aliquid quod non scit, vel intelligendo aliquid quod non intelligit tali intellectione prima. Primam ergo contingentiam oportet quaerere in voluntate divina”.
47 Ord. III, d. 33, q. u.: “Non humane bene agit nisi intelligendo illud propter quod agit”, cit. dall’antologia di A. WOLTER, Duns Scotus on the Will and Morality, Washington 1986, p. 344.
48 Ord. I, d. 38, q. u., n.9: “Quando igitur arguis si voluntas non possit non velle intellectum speculari, ergo non est summe libera, non sequitur quia libertas eius non est ad intrinseca (quae quasi praecedunt actum eius), sed libertas eius est ad omnia factibilia, et ideo necesse est ponere primam determinationem in voluntate respectu factibilium; non sic autem esset si intellectus voluntatem praedeterminaret, immo proprie libertas non posset salvari in voluntate respectu factibilium
(sed nec contingentia aliqua), quia intellectus necessario praedeterminaret eam mere necessitate
naturali et voluntas necessario conformaretur intellectui…”.
43
44
49 Ord. I, d. 28, q. 3, n. 93: “Ad quaestionem istam cui non placet ultima opinio de personis absolutis potest dici tenendo communem viam, supponendo scilicet personas esse relativas”.
50 Quodl. q. 12, n. 6: “Productio personae divinae semper est in fieri, quia numquam ista persona potest habere esse nisi accipiendo actualiter a producente”.
51 Rep. Par. I, d. 6, q. 2, n. 5: “Proprie Pater volens generat Filium, non tantum concomitantur
ita quod productio Filii sibi placet, sed voluntate quodammodo antecedente: quia licet intelligere
Patris praecedat velle, velle tamen praecedat dicere, sic ut et intelligere, quia dicere non est intelligere, ut probatum est, sicut spirare non est velle, tamen sequitur ipsum dicere”. Ord. II, d. 3, n.
251: “Unde propter bonitatem suam communicandam, ut propter suam beatitudinem, plura in eadem specie produxit”. Rep. Par. II, d. 37, q. 1, n. 1: “Quidquid Deus causat extra, causat ordinatissime et ex maxima charitate”.
52Ord. I, d. 10, q. u., n. 9: “sicut voluntas creata est principium producendi amorem creatum
tantum […] ita illa voluntas est principium producendi amore tantum quanto ipsa nata est amare
obiectum infinitum”.
53 Ord. I, d. 20, q. u., n. 40: “Unde necessitas huius consequentiae ‘si Pater vult hoc, Filius vult
hoc’ non est contra libertatem volitionis Filii, sicut nec contra libertatem volitionis meae est ista consequentia ‘si volo, volo’, ita nec ibi ‘si Pater vult a, Filius vult a, quia velle est Patris et Filii”.
54 C. CIANCIO, Libertà e dono dell’essere, in G. Ferretti, a cura di, Il codice del dono, cit. p. 95.
55 Ord. I, d. 8, n. 255: “Itaque concordant Aristoteles et Avicenna in sequentibus ex uno principio falso – in quo concordant – scilicet quod Deus necessario se habet ad quodlibet quod est extra se”. Se non libera, la causa agisce ‘secundum ultimum potentiae suae’, producendo un effetto
che le è proporzionato, infinito se infinita, finito se finita.
56 Ord. I, d. 42, n. 10: “Et hoc maxime ponerent philosophi, quiam non posuerunt causam secundam necessario concurrentem propter aliquam perfectionem addendam effectui, sed quasi
propter imperfectionem addendam; sed magis, causalitas primae causae est immediate perfecte,
et ideo posuerunt eam non posse immediate ese causam alcuius effectus imperfecti”.
57 Quodl. q. 7, n. 26: “In neutro autem istorum concordat cum eo theologus; quia ponit quod
Deus per voluntatem libere et contingenter se habet ad quodcumque causabile extra, et hoc non
exclusa necessitate, non solum immutabilitatis, sed etiam inevitabilitatis”. Si noti che immutabilmente necessario è ciò che non può non essere, né può essere diverso da come è; mentre inevitabilmente necessario è ciò che non può non aver luogo, e cioè si verifica immancabilmente perché già determinato ad esistere nella sua causa, a sua volta predeterminata ad agire necessariamente.
58 E qui occorrerebbe fare spazio al ‘pensiero dell’origine’, che si è inclini a lasciare nell’ombra,
a causa del carattere rivelativo e insieme occlusivo della finitezza, da porre all’origine dell’oblio dell’immemoriale. Scrive P. Ricoeur: “L’incarnazione fa globalmente la parte dell’otturatore; essa è la
tentazione della dissimulazione del fondamento; la tentazione soltanto: non la colpa. Il senso dell’incarnazione rimane ambiguo: da un lato il mio corpo mi apre al mondo, alla realtà nel suo inmsieme; ma allo stesso tempo mi suggerisce di definirmi tramite il mio esserci, tramite il mio essere al
mondo; proprio ciò che mi apre al dato mi dissimula il pensiero dell’origine” (Negatività e affermazione originaria, nella raccolta Storia e verità, Lungro di Cosenza, Marco Editore 1994, pp. 321-22).
59 Quodl. q. 7, n. 18: “Nunc autem si Deus posset immediate in quodlibet causabile, quodlibet
dependeret totaliter et praecise ab eo, et per consequens necessario quodlibet causaret, et tunc
sequitur multiplex inconveniens, scilicet, quod causae secundae privarentur actionibus suis”.
60 Ord. I, d. 42, q. u, n. 9.
61 C. CIANCIO, op. cit., p. 99.
62 Ibidem.
63 T. TODOROV, La letteratura in pericolo cit., p. 17: “Siamo tutti fatti di ciò che ci donano gli altri: in primo luogo i nostri genitori e poi quelli che ci stanno accanto; la letteratura apre all’infinito
questa possibilità di interazione con gli altri e ci arricchisce, perciò, infinitamente”.
64 F. TOTARO, Inattualità dell’intero e fondazione della prassi in (a partire da) Bontadini, in C. Vigna, a cura di, Bontadini e la metafisica, Milano, VeP, 2008, p. 78.
65 J. DE VINCK, Two Aspects of the Theory of the ‘rationes seminales’ in the Writings of Bonaventure of Bagnoregio, in AA. VV., S. Bonaventure (1274-1974), Collegio san Bovanentura, Grottaferrata (Roma) 1973, vol. III, pp. 307-316.
66 Ord. I, d. 36, q. u., n. 65: “Concedo quod quando sunt duae causae ordinatae, ambae cau-
SAGGI
sant effectum – et aliter, quia superior plus causat; et ita si cor est causa superior et manus inferior respectu litterarum, utraque causat (tam cor quam manus), non tamen prius cor quam manus
producit litteras in aliquo vero esse et postea manus addit eis quendam respectum!”.
67 Ord. I, d. 3, p. 3, q. 2, n. 496: “non tamen imperfectior recipit suam causalitatem a causa perfectiore, nec tota illa causalitas est eminenter in causa perfectiore, sed aliquid addit causa imperfectior, in tantum quod effectus esse perfectior a causa perfectiore et imperfectiore quam a sola
perfectiore”.
68 Ord. II, d. 3, p. 2, q. 1, n. 281: “virtus assistentia sive influentia – quocumque modo nominetur – non est impressio alicuius formae vel cuiuscumque inhaerentis in causa inferiore vel superiore, sed tantum est ordo et actualis coniunctio talium causarum activarum, ex quibus, sic coniunctis
et suis propriis activitatibus praesuppositis coniunctioni, sequitur effectus communis ambarum
causarum”.
69 Ord. I, d. 3, p. 3, q. 2, n. 503.
70 Quaestiones miscellaneae de formalitatibus, q. 5 (Utrum perfectissimus conceptus possibilis haberi de Deo a viatore ex puris naturalibus sit conceptus entis infiniti): “Per viatorem intelligo
hominem nihil in se habentem nec simpliciter nec pro aliquo instanti quod repugnet statui viae vel
ponat hominem extra statum viae. Per cognitionem autem possibilem haberi ex puris naturalibus
intelligo praecise per pura naturalia causas naturales et naturaliter activas respectu intellectionis,
cuismodi sunt intellectus […] circumscripta omni speciali influentia, stante sola generali influentia,
quae requiritur ad omnem effectum inferiorem causae secundae”.
71 Rep. Par. II, d. 37, q. 2, n. 3: “Igitur videtur quod voluntas sit tota causa immediata. Deus tamen conservat voluntatem et coagit per influentiam generalem cuicumque actui, quem voluntas
eligit”. Si fa interprete di questa linea, criticandola, Leibniz, per il quale questi autori “parlant de ce
concours, ne l’ont voulu que général, de peur de faire du tort à la liberté de l’homme et à la sainteté de Dieu. Il semble qu’ils prétendent que Dieu, ayant donnée aux créatures la force d’agir, se
content de la conserver” (Essais de Théodicée I, par. 27).
72 Summa contra gentiles III, cap. 70: “Patet etiam quod non sic idem effectus causae naturali et divinae virtuti attribuitur quasi partim a Deo, et partim a naturali agente fiat, sed totus ab utroque secundum alium modum: sicut idem effectus totus attribuitur instrumento, et principali agenti
etiam totus”.
73 Ord. I, d. 44, q. u., n. 3: ”In omni agenti per intellectum et voluntatem, potente conformiter
agere legi rectae et tamen non necessario conformiter agere legi rectae, est distinguere potentiam
ordinatam a potentia absoluta; et ratio huius est, quia potest agere conformiter illi legi rectae, et
tunc secundum potentiam ordinatam (ordinata enim est in quantum est principium exsequendi aliqua conformiter legi rectae), et potest agere praeter illam legem vel contra eam, et in hoc est potentiam absolutam, excedens potentiam ordinatam”.
74 Ord. I, d. 44, q. u., n. 6: “Unde dico quod multa alia potest agere ordinate […]. Ideo sicut potest aliter agere, ita potest aliam legem rectam statuere […]: non quidem fieret ordinate sercundum
istum ordinem, sed fieret ordinate secumdum alium ordinem, quem ordinem ita posset voluntas divina statuere sicut potest agere”.
75 Pur esaltando il privilegiamento della razionalità, Leibniz rimprovera Abelardo di un errore,
e cioè il non aver distinto potere e volontà, con i rispettivi oggetti: i possibili, oggetto del potere, le
cose esistenti, oggetti della volontà, sicché pare scorretto affermare che “tutto ciò che Dio non ha
fatto non è conveniente e quindi Egli non ha voluto farlo e per conseguenza non ha potuto farlo”.
“Anche Wycliff – aggiunge Leibniz – ha fatto lo stesso errore, per cui fu poi condannato a Costanza”. Per questi e analoghi rilievi cfr. M. DAL PRA, Introduzione a P. ABELARDO, Conosci te stesso o
Etica, Bari, Laterza 1976, pp. X-XXII.
76 Ivi, n. 3: “Et ideo non tantum in Deo, sed in omni agente libere… est distinguere inter potentiam absolutam et ordinatam; ideo dicunt iuristae quod aliquis hoc potest facere de facto, hoc est
de potentia absoluta sua, vel de iure – hoc est de potentia ordinata secundum iura”.
77 E. RANDI, Il sovrano e l’orologiaio. Due immagini di Dio nel dibattito sulla ‘potentia absoluta’
fra III e XIV secolo, Firenze, La Nuova Italia 1987, p. 65. Uno studio esauriente su una tematica
passibile di letture contrastanti.
78 Ord. I, d. 44, q. u. n. 4: “Omnes qui subsunt legi divinae, si non agunt secundum illam, inordinate agunt”. Ma quali sono le ‘leges divinae’? È agevole scioglierle dall’impasto storico?
79 Ivi, n 5.
45
46
80 Si ricordi la prop. 23, che nel 1277 St. Tempier condanna: “Quod Deus non potest irregulariter, id est alio modo quam movet, movere aliquid, quia in eo non est diversitas voluntatis”; e la
prop. seguente (24): “Quod Deum necesse est facere quidquid immediate fit ab ipso. Error, sive
intelligatur de necessitate coationis, quia tollit libertatem, sive de necessitate immutabilitatis, quia
ponit impotentiam aliter faciendi”. È l’ordine proposto R. HISSETTE, Enquête sur lers 219 articles
condamnés à Paris le 7 mars 1277, Paris, Publications Universitaires 1977. Tutti gli articoli del ‘Sillabo’ sono ripubblicati, secondo la numerazione del Cartularium Universitatis Parisiensis, da D. PICHÉ, La condamnation parisienne de 1277 (Sic et Non), Paris, Vrin 1999.
81 J. LE GOFF, Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, Bari, Laterza 1983, p. 17.
82 Rep. Par. I, d. 42, q. 1, n. 1: “Contra, Philosophi utentes ratione naturali non concesserunt
Deum esse omnipotentem, quia non concesserunt ipsum esse causam alcuius contingentis”.
83 OBERMAN, op. cit., p. 60. Il fatto che Aristotele venga definito ‘pagano’ non è dispregiativo. Tale
qualifica consentì “di perseguire ipotesi alternative [….]. La desacralizzazione nominalista del filosofo non è gretta iconoclastia, ma va seriamente considerata come ricerca dell’Aristotele storico”.
84 Ord. I, d. 42, n. 9.
85 Quodl. q. 7, n. 19: “Quia ordo causalitatis non concludit, quod superior possit sine inferiori in
effectum, in quem potest cum inferiori”.
86 Rep. Par. I,d. 42, q. 2, n. 7.
87 Quodl. q. 7, n. 19: “De tertio tenendum est secundum communem sententiam theologorum,
Deum sic esse omnipotentem, quod sine quocumque alio agente possit causare quodlibet causabile, nec tamen istud potest demonstrari demonstratione quia”.
88 L’idea stessa di creazione viene storicizzata, nell’ambito ebraico-cristiano, nel quadro della
storia della salvezza, con un taglio propriamente redentivo.
89 H. JONAS, Elementi ebraici e cristiani nella filosofia: il loro contributo alla nascita dello spirito moderno, nella raccolta Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Bologna, Il Mulino 1991, p. 93.
Siamo alle obiezioni più sopra richiamate.
90 P. HADOT, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura, Torino, Einaudi 2006, pp. 312-3: “due atteggiamenti di fondo verso i segreti della natura: l’uno volontarista, l’altro contemplativo. Abbiamo
visto il primo sotto il patrocinio di Prometeo che, ponendosi al servizio degli uomini, ruba i segreti
divini, con l’astuzia o la violenza. Questo atteggiamento ha peraltro rivendicato assai presto la sua
legittimità, affermando il diritto dell’uomo a dominare la natura – conferito all’uomo dal Dio del Genesi – e a sottometterla, se necessario, a un procedimento giudiziario, e perfino alla tortura, per
strapparne via i segreti: è questa la metafora celebre di Francesco Bacone, ripresa poi da Kant e
da Cuvier”.
91 CFR. E. KANTAROWICZ, La souveraineté de l’artiste, in Mourir pout la patrie, Paris, PUF 1984.
Su questa linea T. TODOROV, op. cit.
92 M. T. FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, Le bugie di Isotta. Immagini della mente medievale, Bari, Laterza 2002, p. 85.
93 I, q. 25, a. 5: “divina sapientia totum posse potentiae comprehendit”.
NICHILISMO E NUOVE POSSIBILITÀ.
HEIDEGGER E ARENDT
Nell’accingersi a dar vita a qualcosa non potrebbe esserci migliore inizio,
inizio più promettente che confrontarsi con un nulla, una vastità vuota da
riempire di senso. È questa una tra varie possibilità. Eppure il termine nichilismo, divenuto una delle categorie più utilizzate nel dibattito pubblico per descrivere un tratto peculiare della cultura occidentale contemporanea, evoca
in prima istanza una vertigine esistenziale, un abisso insondabile in cui il
senso di ogni cosa e della vita stessa, cadendo, si frantuma irrimediabilmente. Nichilismo in effetti non significa semplicemente “nulla”, esso richiama
piuttosto, con un’implicita, ma chiara, avvertenza di pericolo, un atteggiamento intellettuale e morale disincantato, frustrato e depresso per il quale
ogni sforzo di dare un senso alla vita sia destinato a non trovare una risposta, bensì il nulla. Perché il pensiero del nichilismo associato alla cultura occidentale evoca una potenza distruttrice e nullificatrice di ogni costruzione di
senso? Non potrebbe l’esperienza del nulla immettere piuttosto in un’attitudine aperta alla creazione di significati e in un’attesa carica di promesse?
Confrontandoci con il pensiero di Heidegger e di Arendt cercheremo una risposta a questi interrogativi.
Il primo passo da fare per mettersi sul cammino in direzione di una risposta alle nostre domande è definire cosa si intende per nichilismo. Ci imbattiamo così immediatamente in una prima difficoltà: “il nichilismo […] fa ormai parte dell’aria stessa che respiriamo. La sua presenza ubiqua e multiforme lo impone alla nostra considerazione con un’evidenza che è pari solamente alla difficoltà di abbracciarlo in una definizione chiara ed univoca” 1.
In effetti è possibile rintracciare il termine nichilismo in diversi punti della
storia del pensiero occidentale in cui il problema del nulla è stato posto e
pensato, oppure accantonato come un falso problema, e si può ritrovare il
pensiero del nulla come topos della letteratura e della poesia dell’Ottocento
e del Novecento2.
Il concetto di nichilismo ha dunque una sua storia, ma è soprattutto a partire da Nietzsche che esso è stato messo a tema nella meditazione filosofica e si è diffuso nella cultura comune come un termine indicante la crisi dei
valori e delle certezze tradizionali. Nel porsi la domanda “che cos’è il nichilismo?”, Nietzsche rispondeva infatti “Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché”; che cosa significa nichilismo? Che i valori supremi si svalutano”3.
L’esistenzialismo, sia letterario sia filosofico, si è confrontato con il pen-
SAGGI
di Letizia Santangelo
47
48
siero del nulla e con il nichilismo quasi per vocazione. Infatti, pure nella varietà delle strade percorse dai singoli pensatori, ciascuno di essi si è sentito
chiamato ad interpretare il sentimento di profonda crisi, culturale e storica,
che lacerava l’Europa nei primi decenni del secolo scorso, un sentimento paragonabile alla desolazione del sentirsi soli in mezzo al nulla. I disastri delle
due guerre mondiali, le abiezioni morali che le avevano accompagnate e
l’esperienza dei regimi totalitari avevano reso drammaticamente manifesta
l’inconsistenza dell’ottimismo romantico, che per tutto l’Ottocento aveva dispensato garanzie circa l’essere in atto di un progresso sicuro e inarrestabile come senso e fine intrinseco del divenire storico. Persi nell’orizzonte vuoto di una landa desolata, chiamati a pensare nel nulla, gli esistenzialisti tornano al filosofo della “morte di Dio”.
Martin Heidegger, che dedicò anni di studio al pensiero di Nietzsche, pubblicò nel 1967 un estratto del suo “Nietzsche” dal titolo “Il nichilismo europeo”.
Secondo Heidegger, Nietzsche per primo4 diede al termine nichilismo una connotazione storica ed un ambito geografico determinato: “Nietzsche parla del
‘nichilismo europeo’ […] ’europeo’ ha qui un significato storico e vuol dire lo
stesso che ‘occidentale’. Nietzsche adopera il nome ‘nichilismo’ per indicare il
movimento storico da lui riconosciuto per la prima volta ma che domina già i
secoli precedenti e che darà l’impronta al prossimo, e di cui egli compendia l’interpretazione più essenziale nella breve sentenza ‘Dio è morto’ […]. Il nichilismo è il processo storico attraverso il quale il ‘soprasensibile’ viene meno e vede annullato il suo dominio, e di conseguenza l’ente stesso perde il suo valore ed il suo senso”5.
Il nichilismo come ‘mancanza di senso’ che subentra quando viene meno la forza vincolante dei supremi valori tradizionali – Dio, il Bene, la Verità
– che davano una risposta ai perché dell’esistenza e indicavano il fine della vita, è dunque l’esito di un processo storico, “addirittura il processo fondamentale della nostra storia occidentale” 6, che vede nel momento del suo
compimento proprio il tramonto degli stessi valori tradizionali. Tuttavia Heidegger sottolinea che “con questa caratterizzazione non si è deciso se il nichilismo esaurisca in ciò la sua essenza”7. In effetti il fulcro dello studio di
Heidegger è proprio un ripensamento profondo che mira a catturare l’essenza del nichilismo, affinché questa non venga frettolosamente identificata
con il “sintomo”, ormai acclarato, di una generalizzata crisi dei valori e perdita dei punti di riferimento.
Come Michelangelo liberava la forma dal marmo togliendo la materia eccedente la figura, Heidegger svolge il suo pensiero attraverso un domandare e un domandarsi critico che, passo dopo passo, sgretola la fallace evidenza di presupposti erroneamente dati per scontati, lasciando intravedere i lineamenti di una risposta. Un esempio di tale metodo, funzionale alla nostra
trattazione, è la riflessione sul “Niente”.. Posto che la radice del termine nichilismo risiede nel latino nihil, nel “nichilismo si tratta comunque del Niente
e quindi, in un modo particolare, dell’ente nel suo non essere”8. Ma poiché
“non possiamo trattare del Niente quale opposizione essenziale a tutto ciò
che è, se non dicendo: il Niente ‘è’ questo e quest’altro”9, Heidegger si chie-
SAGGI
de che cosa significhino ‘essere’ ed ‘è’. “In quelle indicazioni apparentemente acute, così evidenti e già alquanto trite e ritrite sull’impossibilità di dire
qualcosa del Niente senza con questo dichiararlo già un ente, si dà ad intendere che l’essenza dell’‘essere’ e dell’‘è’, che nel discorrere sul Niente sarebbe erroneamente attribuita a quest’ultimo, sia la cosa più lampante e meglio
chiarita e meno problematica del mondo […]. Certo, questa opinione […]
contribuisce a formare il fondamento su cui riposa tutta la metafisica”10. La
stessa forma argomentativa utilizzata da Heidegger nel passaggio appena
citato suggerisce che, secondo l’autore, l’essenza dell’essere e dell’è non è
affatto chiara, come d’altronde viene esplicitato più avanti nel testo da cui è
tratta la precedente citazione: “l’essere è ciò che più è dimenticato, così smisuratamente dimenticato che anche questa stessa dimenticanza resta risucchiata nel proprio vortice. Noi tutti corriamo costantemente all’ente, quasi mai
nessuno pensa l’essere”11.
Proseguendo nella sua riflessione Heidegger mostra che, in quelle affermazioni “trite e ritrite” di cui nel passo sopra citato, il Niente è stato concepito logicamente come la negazione dell’ente e questa asserzione logica è stata trasposta immediatamente e implicitamente su un piano di realtà12. Tale operazione, di negazione logica e di trasposizione immediata su un piano diverso, implica una svalutazione del Niente e, con esso, del nichilismo: “Se il Niente è
niente, se il Niente non c’è, allora non può nemmeno darsi che l’ente sprofondi mai nel Niente e che tutto si dissolva nel Niente; allora non ci può essere il
processo del diventare-niente. Allora il nichilismo è un’illusione”13. Ma a questo
punto Heidegger si domanda “se l’essenza più intima del nichilismo e la potenza del suo dominio non consistano proprio nel ritenere il Niente qualcosa di
nullo e il nichilismo un idolatrare il mero vuoto, una negazione che può essere
controbilanciata con una vigorosa affermazione”14. Si delinea già nella domanda la sua risposta: “forse l’essenza del nichilismo consiste nel non prendere sul
serio la domanda del Niente”15.
In Che cos’è metafisica? Heidegger ripropone la domanda sul Niente: Che
ne è del Niente? Sgombrato il campo ancora una volta dalla mera valutazione
logico-formale che porta all’assoluta negazione logica del Niente – “da parte
nostra affermiamo che il Niente è più originario del ‘non’ della negazione”16 –
Heidegger si chiede dove si cerca e come si trova il Niente e giunge alla conclusione che l’esperienza “originaria” di esso accade nello “stato d’animo fondamentale dell’angoscia”17. L’oggetto che scatena tale stato d’animo è il Niente inteso come “l’essenziale impossibilità della determinatezza”18. Il Niente si
svela nell’angoscia “non come ente e tantomeno come oggetto… Il Niente si
manifesta espressamente con l’ente e nell’ente in quanto questo si dilegua nella sua totalità”19.
In particolare, l’essenza del Niente è un’azione: la nientificazione. Il Niente in quanto tale respinge, per cui, nello stato d’animo dell’angoscia, l’esserci indietreggia davanti al Nulla che, in questa azione di respingere, rinvia, “facendolo dileguare, all’ente nella sua totalità che sprofonda”20. È come se nell’epifania del Niente si offrisse all’esser-ci una insolita prospettiva di distacco
e distanza dall’ente, che permette di vedere quest’ultimo nella sua totalità,
49
50
esperienza straordinaria poiché per lo più “noi in certo modo ci perdiamo
completamente nell’ente” e “il Niente ci è occultato”21. “Il nientificare non è
un’occorrenza qualsiasi, ma in quanto è un rinviare, respingendolo, all’ente
nella sua totalità che si dilegua, esso rivela questo ente, nella sua piena e fino allora nascosta estraneità, come l’assolutamente altro – rispetto al Niente”22. È come se il Niente fosse un fondo nero che fa risaltare le forme chiare degli enti. Definita l’essenza del Niente non rimane che chiudere il cerchio:
“Essere e niente fanno tutt’uno”23, l’argomentare di Heidegger mostra infine
che l’essere è nulla.
A questo punto si può chiarire perché per il pensatore il nichilismo è l’esito del processo fondamentale della storia occidentale, ossia il compimento
della metafisica. La metafisica si interroga intorno all’essere dell’ente ma non
pone la domanda sulla verità dell’essere. Non la pone in quanto pur nominando l’essere, si riferisce all’ente in quanto ente. Chiusa nell’ente e nella
negazione logica del Niente, la metafisica è la storia dell’oblio dell’essere,
dell’“indifferenza rispetto all’essere in mezzo alla suprema passione per l’ente”24. In questo senso quindi il nichilismo è la conseguenza estrema, ossia
l’ultima che si dà nella storia della metafisica, del non prendere sul serio la
domanda del Niente. Ecco perché Nietzsche, pur annunciando la fine della
metafisica, rimane un pensatore metafisico, l’ultimo. “Poiché Nietzsche riconosce, sì il nichilismo come movimento proprio della storia occidentale moderna, ma non è capace di pensare l’essenza del Niente perché non è in grado di cercarla domandando, egli deve divenire nichilista classico25 che esprime la storia che sta accadendo ora”26.
La meditazione di Heidegger giunge a considerare il nichilismo come una
tappa del destino del mondo occidentale, un tappa importante in quanto
coincide con la fine della metafisica e quindi di un percorso che, iniziato con
Platone, è durato circa duemila anni. La fine della metafisica non significa
tuttavia la fine della storia, essa apre piuttosto ad una nuova era segnata
dall’oltrepassamento della metafisica stessa. All’andare oltre la metafisica
corrisponde “lo sforzo di imparare a prestare attenzione all’oblio dell’essere, per farne esperienza e per assumere questa esperienza nel riferimento
dell’essere dell’uomo e lì custodirla” 27. In quanto destino, il nichilismo non
può essere fuggito, ma deve essere portato e sopportato fino all’esaurimento di tutte le sue possibilità essenziali. Heidegger spinge se stesso e il lettore a rimanere nel pensiero del nichilismo e a prestare attenzione all’oblio
dell’essere, offrendo questo come un atteggiamento di “stasi costruttiva”, alternativa autentica al vuoto affannarsi alla ricerca di soluzioni ottimistiche,
ma troppo “frettolose” e quindi, molto probabilmente, inutili. Questa stasi
corrisponde ad un rimanere in ascolto dell’essere e ad un’attesa di un nuovo pensare che “si attui in modo corrispondente al riferimento dell’essere ad
esso”28. Solo attuando tale riferimento all’essere, il pensiero rinnovato si può
situare “da sé nell’unico agire ad esso appropriato” 29 e può dunque promuovere un nuovo, autentico agire. In conclusione, la soluzione del nichilismo si
darà nella storia dell’esistenza come esito di una nuova disposizione del
pensiero nei confronti dell’essere.
SAGGI
Allieva e amante di Heidegger, Hannah Arendt ebbe con lui un rapporto
conflittuale. Ella non potè fare a meno di confrontarsi e di misurarsi con il pensiero di Heidegger, a volte approvandone i contenuti, a volte criticandolo aspramente. Tuttavia Arendt aveva una personalità forte e degli interessi ben diversi da quelli del maestro, per cui nel suo pensare riuscì a districarsi dal profondo legame con il pensiero di Heidegger e ad indagare numerosi temi con pienezza e maturità, unite ad un caratteristico tratto di originalità, asistematicità e
grande indipendenza di giudizio.
Rispetto ad Heidegger, Arendt è attratta maggiormente dalla vita pratica,
dal tema dell’agire e dalla teoria politica. Di conseguenza ella sviluppa assunti teoretici relativi alla definizione dell’identità umana che mirano alla rivalutazione dell’agire, contro il primato scientifico-cognitivo attribuito all’uomo dalla
tradizione filosofica e contro il primato del pensiero sostenuto in ultimo dallo
stesso Heidegger. Da queste istanze nasce Vita activa. D’altrocanto Arendt
non rimane estranea al tema del pensare a cui dedica la sua opera finale e incompiuta, La vita della mente, in cui denuncia l’impoliticità costitutiva del pensiero nella tradizione filosofica occidentale e reclama la necessità che la facoltà del pensare non rimanga disgiunta dalle facoltà del giudizio e del volere.
L’estremizzazione del pensiero inteso come facoltà logico-formale infatti ha
portato, secondo la pensatrice, all’ideologia e all’azione di massa dell’epoca
del totalitarismo: abbandonando “la libertà implicita nella capacità di pensare
per la camicia di forza della logica…l’uomo può farsi violenza con la stessa
brutalità usata da una forza esterna”30.
Dato il peculiare interesse pratico del suo pensare, Arendt, a differenza di
Heidegger, non affrontò il nichilismo in termini onto-teologici e, comunque, il tema del nichilismo non fu uno dei temi centrali della sua riflessione. D’altra parte non ne fu del tutto assente. In Che cos’è la filosofia dell’esistenza?, nella sezione dedicata ad Heidegger, Arendt afferma che “il nichilismo moderno […] è
il prezzo del tentativo ibrido di inserire a forza le nuove domande e i nuovi contenuti nel quadro della vecchia ontologia”31.
Sebbene non venga indicato contestualmente il contenuto delle “nuove domande” cui fa riferimento l’autrice, dalla lettura del saggio nella sua interezza
emerge che le nuove “urgenze”, in termini di domande e spunti di pensiero, imposte dalla filosofia moderna sono individuate da Arendt nella divaricazione tra
essere ed esistenza, nella scissione tra universale e particolare e nel conseguente senso di spaesamento dinanzi all’inspiegabilità dell’esistere al singolare: “la filosofia moderna comincia con il riconoscimento che il che cosa non è
mai in grado di spiegare il che […] la verità oggettiva della scienza è priva di
interesse, perché rimane neutrale di fronte alla questione dell’esistenza, e la
verità soggettiva, la verità di colui che esiste, è paradossale, poiché essa non
può mai divenire oggettiva e valida universalmente”32. Un’altra questione della
filosofia moderna, posta e lasciata insoluta da Kant, è relativa alla libertà dell’uomo: “l’uomo di per sé libero, è consegnato senza speranza al corso della
natura che gli è estraneo, vale a dire ad un destino che gli è contrario e che distrugge la sua libertà”33.
L’ontologia “vecchia”, nel senso di obsoleta, sorpassata, e quindi inutile,
51
52
cui si riferisce Arendt è quella tramandataci dal pensiero greco e fondata sulla distinzione tra il sensibile e il sopra sensibile. Nella fine della metafisica e
della filosofia e nella morte di Dio, ciò che giunge alla fine e muore è proprio
tale distinzione, “insieme con la nozione, risalente a Parmenide, che tutto ciò
che non è dato ai sensi – Dio, l’Essere, i Principi Primi e le Cause, le Idee –
sia più reale e più vero, trovandosi non solo al di là della percezione sensoriale, ma al di sopra del mondo dei sensi”34. Il pericolo di nichilismo insito in
tale processo è indubbio: in una rappresentazione del mondo essenzialmente duale, che si reggeva sull’equilibrio, precario, tra due termini, la scomparsa di un termine, il soprasensibile, implica anche la scomparsa della sua antitesi polare, il mondo delle apparenze. Perduto l’equilibrio, “l’intero sistema
di riferimento entro il quale il nostro pensiero era abituato ad orientarsi va in
pezzi”35.
La tensione tra l’ingombrante “datità dell’essere” della vecchia ontologia
e l’affermazione della libertà dell’uomo che vuol imporsi come “Signore dell’Essere” porta al nulla e alla nientificazione teorizzate da Heidegger: “Se
l’essere, che non ho creato io, dipende da un Essere che non sono io e che
neanche conosco, allora ciò forse significa che per l’uomo l’ambito in cui potersi sentire veramente libero non è l’essere ma il nulla”36. Nondimeno Arendt
sostiene che “il fascino speciale che il pensiero del nulla ha esercitato sulla
filosofia moderna non è necessariamente indice di nichilismo. Consideriamo
il problema del nulla nel nostro contesto, quello di una filosofia in rivolta contro la filosofia intesa come pura contemplazione […]: il pensiero che l’essere
è in fondo il nulla presenta allora un vantaggio immenso. Sulla sua base l’uomo può immaginare che il proprio rapporto con l’essere donatogli sia nient’altro che quello del creatore prima della creazione del mondo – creato com’è noto, a partire dal nulla”37.
Se il pensiero del nulla può spingere ad un’attività creativa, propositiva e vitale, e non al nichilismo, a condizione che le domande e le esigenze poste dalla filosofia moderna non siano tematizzate all’interno della vecchia ontologia,
ciò vuol dire che il nichilismo, che per Heidegger è un destino, per Arendt è solo una possibilità.
In particolare, l’uomo contemporaneo può scegliere tra l’abisso nichilistico e un nuovo inizio, una nuova storia, poiché, secondo Arendt, la fine della
millenaria e pesante tradizione metafisica presenta anche dei vantaggi. Da
una parte, la possibilità di guardare al mondo da una prospettiva nuova e libera dai condizionamenti del passato consente di “disporre di un patrimonio
enorme di esperienze immediate, senza essere vincolati da alcuna prescrizione sul modo di trattare simili tesori”38. Dall’altra parte, poiché la fine del
mondo soprasensibile ha portato con sé la morte di una visione elitaria della
filosofia come dominio di quei pochi capaci di staccarsi dal mondo delle apparenze per frequentare la trascendenza, si è aperta a tutti, anzi si “esige”
da ciascuna “persona sana, indipendentemente dalla sua istruzione o ignoranza, dalla sua intelligenza o stupidità eventuali”39, l’esercizio dell’attitudine
a pensare, facoltà che immette direttamente nell’attitudine a discernere ciò
che è giusto da ciò che è sbagliato.
SAGGI
Mentre il vantaggio come possibilità creativa insita nella liberazione dai
vincoli della tradizione è di comprensione intuitiva, quello offerto da una “democratizzazione” dell’esercizio dell’attitudine a pensare necessita di un ulteriore approfondimento. Ne La banalità del male l’autrice tematizza l’“assenza di pensiero”, concetto chiave del pensiero arendtiano, che viene riproposto sia in Vita activa sia in La vita della mente. La “mancanza di pensiero” intesa come “l’incurante superficialità o la ripetizione compiacente di ‘verità’ diventate vuote e trite”40 può essere considerata, all’interno del pensiero di
Arendt, la manifestazione più evidente della crisi dei valori che si accompagna al nichilismo contemporaneo. È assenza di pensiero, non malvagità,
quella che Hanna Arendt individuò in Eichman, spietato carceriere nazista:
“restai colpita dalla evidente superficialità del colpevole, superficialità che
rendeva impossibile ricondurre l’incontestabile malvagità dei suoi atti a un livello più profondo di cause o motivazioni”41. In Eichman la distanza, apparentemente inspiegabile, tra le sue intenzioni, non malvagie, e gli esiti delle
sue azioni, sciagurati, è colmata dalla mancanza di pensiero. Arendt vede in
Eichman un individuo “atrocemente” normale, un padre di famiglia piccoloborghese che ha trovato una nicchia naturale in un’organizzazione, il partito
nazista, a cui ha ceduto la propria libertà di pensiero e la propria capacità di
giudizio. Ecco perché Arendt considera un vantaggio della fine della metafisica la rottura del “monopolio” del pensiero attribuito tradizionalmente al filosofo: ogni uomo, anche il normale padre di famiglia piccolo-borghese, è chiamato a pensare e a giudicare delle cose.
Rimane da individuare, indagando tra i concetti chiave del pensiero di
Arendt, dove si situi la strada per cogliere i vantaggi della fine della metafisica
e per superare il nichilismo, cosa che, tradotta in termini heideggeriani, equivarrebbe ad un oltrepassamento della metafisica stessa.
Un presupposto cardine della speculazione arendtiana è espresso nell’affermazione che “gli uomini, non l’Uomo abitano la terra” 42. Con questo si
intende che ciò che caratterizza la condizione umana non è un’aprioristica
idea universale di Uomo, che si realizza, attraverso una moltiplicazione ripetitiva, nella moltitudine degli esseri umani, ma piuttosto la pluralità degli
esseri umani, ciascuno dei quali è ab initio un individuo distinto dagli altri e
irripetibile. Alla condizione di pluralità corrisponde, secondo Arendt, l’azione:
“l’azione sarebbe un lusso superfluo, una capricciosa interferenza con le
leggi generali del comportamento, se gli uomini fossero semplicemente illimitate ripetizioni riproducibili dello stesso modello, la cui natura o essenza
fosse la stessa per tutti e prevedibile come quella di qualsiasi altra cosa. La
pluralità è il presupposto dell’azione umana perché noi siamo tutti uguali,
cioè umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico ad alcun altro che
visse, vive o vivrà”43. Lo schiudersi alla pluralità degli uomini avviene con la
nascita, momento in cui ciascuno appare al mondo mostrando non che cos’è, la sua essenza, ma chi è, cioè la propria unica, nuova, irripetibile identità che si svolge nel corso dell’esistenza di ogni uomo. La nascita inoltre
fonda la possibilità di un agire che, per Arendt, è da intendersi come “prendere un’iniziativa (come indica anche la parola greca archein, “incomincia-
53
54
re”, “condurre”, e anche “governare”), mettere in movimento qualcosa (che
è il significato originale del latino agere)”44. Ed ancora: “il fatto che l’uomo
sia capace di azione significa che da lui ci si possa attendere l’inatteso, che
è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità… L’azione come cominciamento corrisponde al fatto della nascita”.45
In Vita Activa Arendt, a partire dalla pluralità e dall’azione, intese come categorie fondanti della condizione umana, costruisce il primato dell’agire contro
il primato del pensiero contemplativo sostenuto dalla precedente tradizione filosofica. Nella categoria di nascita, poiché essa dà senso e misura all’esistenza al singolare e quindi alla pluralità, come insieme di individui distinti, e poiché fonda l’agire, come sopra definito, può essere individuata la categoria centrale su cui si costruisce l’impianto logico del pensiero arendtiano: “poiché
l’azione è l’attività politica per eccellenza, la natalità, e non la mortalità può essere la categoria centrale del pensiero politico in quanto si distingue da quello
metafisico” 46.
La posizione della centralità della nascita nel pensiero arendtiano è un’operazione che ha degli importanti risvolti teoretici. In tal modo infatti si apre un
nuovo orizzonte filosofico all’interno del quale le due domande della filosofia
moderna, che poste all’interno della vecchia ontologia conducevano ad esiti nichilistici, possono essere reindirizzate verso esiti non nichilistici.
In primo luogo siamo in grado di dare una soluzione alla domanda irrisolta
della filosofia moderna relativa alla constatazione che “il che cosa non spiega
più il che”, ossia alla constatazione della divaricazione tra essenza ed esistenza. Infatti, venuto meno il pensiero duale del mondo proprio della metafisica
tradizionale, che spiegava l’esistenza con l’essenza e il particolare con l’universale, l’esistenza non può che spiegarsi da sé, “dispiegandosi” a partire dalla nascita come svolgimento di una identità unica e irripetibile che agisce e interagisce nel mondo con esiti che non sono prevedibili a priori. Nascita, identità, pluralità conferiscono il senso proprio alla diversità costitutiva di ciascun
individuo.
La categoria di nascita, nella sua doppia accezione di venire al mondo dell’individuo e di cominciamento di ogni opera umana, permette inoltre di compiere una vera e propria inversione nella rappresentazione che il pensiero filosofico tradizionale offriva del filosofo, della “vera vita” e del pensiero stesso.
Secondo Arendt infatti la raffigurazione duale del mondo, in termini di divisione tra essere e divenire, tra verità e apparenza, tra eternità e caducità, trova
il suo fondamento nella centralità della categoria di morte. Come ella spiega
ne La vita della mente, c’è una forte “affinità tra la filosofia e la morte”47. “I filosofi – scrive Arendt – sostengono che coloro che vogliono godere e vivere
piacevolmente debbono o filosofare o allontanarsi dalla vita, giacché tutto il
resto sembra solo vuota chiacchera o insensatezza”48. Il “‘vero filosofo’, colui
che destina tutta la sua vita al pensiero”49 per realizzare il bisogno di trascendimento dei dati visibili e sensibili, tipico del pensiero stesso, “metaforicamente scompare da questo mondo; il che dall’angolo visuale di ciò che è natura-
Il viaggio nel pensiero dei due autori ha risposto ai nostri interrogativi iniziali. La dissoluzione dei fondamenti ultimi e della loro impositività provoca nell’uomo un profondo senso di smarrimento. Questo è un carattere ineliminabile
e un lascito ineludibile della fine della metafisica. Heidegger ci conduce, con
una certa consequenzialità, al Niente, che si coglie – non caso – in uno stato
d’animo che tale smarrimento ricorda: l’angoscia. Arendt ci mostra, con una
certa asistematicità, che tra le ceneri della vecchia ontologia si può trovare una
chance per iniziare una storia diversa e del tutto nuova.
La diversità nello stile argomentativo e concettuale dei due autori – che si
riflette anche nell’andamento delle due parti di questo lavoro, per l’appunto più
consequenziale nella prima parte e meno sistematico nella seconda – offre di
per sé una importante indicazione. Mentre la strada al nichilismo è stata già
tracciata e percorsa, e possiamo quindi riassumerne le tappe, la via verso un
pensiero vitale del nulla, è tutta da costruire. Diverse domande sorgono dinanzi alla posizione di un primato dell’agire. Prima tra tutte: come agire? Cioè co-
SAGGI
le e del nostro ragionamento di senso comune, può essere interpretato come
l’anticipazione della dipartita finale, della nostra morte”. Nella categoria di
morte è centrato il pensiero “metafisico” che si compie nella solitudine della
vita contemplativa50.
La posizione del primato della nascita, dell’esistere, della pluralità e dell’azione impone dunque un rovesciamento del concetto di “vera vita” – non più
contemplativa, bensì “activa”. Inoltre, in quanto rivolto all’agire nel mondo, il
pensiero non può più esaurirsi in una facoltà logico-formale, e non può più essere disgiunto dal giudicare e dal volere. Tali due facoltà, pur dipendendo dalla riflessione preliminare del pensiero sui loro oggetti, non si lasciano mai irretire nell’astrazione dalle apparenze. Gli oggetti del giudicare e del volere infatti “consistono in particolari con una fissa dimora nel mondo che appare, dal
quale la mente che vuole o che giudica si allontana solo temporaneamente e
con l’intenzione di farvi successivamente ritorno”51. La natalità in quanto apertura al mondo che lo accoglie senza trascenderlo è il perno di un pensare “politico” che, in quanto distinto dal pensiero metafisico, si rivolge alla pluralità degli uomini e al mondo e in esso si compie.
Con la fine del mondo soprasensibile e spostando la “vera vita” nell’agire e
nell’interagire con la pluralità degli uomini, si scioglie di fatto anche l’antinomia
relativa alla libertà dell’individuo poiché egli, agendo nel mondo, si fa iniziatore di processi dei quali non può controllare gli esiti ma nei quali imprime se
stesso, la propria identità52.
In conclusione la posizione della categoria di nascita, intesa in senso particolare come il venire al mondo di ogni nuovo individuo e in senso generale,
metaforicamente, come la possibilità di ogni nuovo inizio, consente da una parte di ridare senso e consistenza all’esistere, ormai orfano dell’essere, e dall’altra di suturare la scissione tra pensare e agire, conferendo all’agire e alla libertà dell’individuo una nuova dignità. In tal modo, all’interno del pensiero di
Arendt, le urgenze poste dalla filosofia moderna vengono reindirizzate e collocate in un’orizzonte sgombro da esiti necessariamente nichilistici.
55
me si può dare un pensiero etico post-metafisico, quindi non fondativo? Ma è
proprio camminando “dentro” queste domande alla ricerca di una risposta che
si traccia la nuova storia. La tensione vitale e propositiva che permea il pensiero di Arendt e che si traduce nell’insistere sui concetti di inizio, di pluralità, di
agire, mostra che il cantiere della nuova storia si è aperto all’interno dell’esistenza al singolare, ossia che ciascun individuo oggi è chiamato, indipendentemente dalla sua eventuale fede in Dio e in valori supremi, a dare un senso
al proprio particolare esistere.
VOLPI, 2005 p. 4.
Per una indagine storiografica sul concetto di nichilismo cfr. Volpi, 2005.
3 Cit. in HEIDEGGER, Il Nichilismo europeo, p. 45.
4 Heidegger fa riferimento all’utilizzo del termine di nichilismo in Turgenev, Jean Paul, Dostoevskij.
5 Il Nichilismo europeo, p. 29.
6 Ivi, p. 46.
7 Ivi, p. 46.
8 Ivi, p. 52.
9 Ivi, p. 53.
10 Ivi, p. 53-54.
11Il Nichilismo europeo, p. 360. Secondo Heidegger la metafisica classica, da Platone e Aristotele
fino a Hegel e a Nietzsche ha cercato l’essere indagando gli enti. Identificando l’essere con l’oggettività, ossia con l’esser-presente degli enti, la metafisica ha perso, obliato, il rapporto con l’essere e poi
ha obliato di aver obliato. In Che cos’e la filosofia, pag. 27, Heidegger afferma: “La filosofia è alla ricerca di ciò che l’essente è in quanto è. La filosofia è in cammino verso l’essere dell’essente, cioè verso l’essente rispetto all’essere”. Il pensiero pre-filosofico, ovvero pre-platonico, secondo il Heidegger,
aveva invece un contatto diretto con l’Essere. Per Eraclito ancora “l’Essere è l’essente. Qui l’è parla
transitivamente e vuol dire qualcosa come ‘raccoglie’. L’Essere è la raccolta – Lógoj. Ogni essente è
nell’essere”, p. 23 (la metafisica invece cerca l’essere nell’essente = l’essere è nell’essente). Inoltre
per i pensatori pre-filosofici “nell’apparire dell’Essere si manifesta l’essente”, p. 25. Essi avevano concepito l’Essere come la fúsij, la natura delle cose (da fúw che significa generare, venire alla luce), intendendo che l’essere si schiude, viene alla luce negli enti (cfr. p. 264 de Il nichilismo europeo). Come
dice bene Hannah Arendt la “fúsij secondo i Greci era la totalità delle cose non fatte dall’uomo né
create da un fattore divino, ma venute all’essere da sé medesime: ed Eraclito affermava di questa
fúsij che essa ‘ama nascondersi’, cioè celarsi dietro le apparenze” (La vita della mente, p. 233).
12 Vedi anche Che cos’è metafisica?, pp. 43-44.
13 Il Nichilismo europeo, p. 54.
14 Ivi, p. 55.
15 Ivi, p. 55.
16 Che cos’è metafisica?, p. 45.
17 Ivi, p. 49.
18 Ivi, p. 50.
19 Ivi, pp. 52-53.
20 Che cos’è metafisica?, p. 54.
21 Ivi, p. 57.
22 Ivi, p. 54.
23 Ivi, p. 63.
24 Il nichilismo europeo, p. 314.
25 “Il nichilismo classico si svela come quel compimento del nichilismo in cui quest’ultimo si ritiene sollevato dalla necessità di pensare proprio ciò che costituisce la sua essenza: il nihil, il nulla – in quanto velo della verità dell’essere dell’ente”, ne Il nichilismo europeo, p. 41.
1
2
56
Ivi, p. 57.
Che cos’è metafisica, p. 99.
28 Ivi, p. 99.
29 Ivi, p. 99.
30 Citaz. da Le origini del totalitarismo in Che cos’è la filosofia dell’esistenza, p. 31.
31 Che cos’è la filosofia dell’esistenza, p. 67. Vedi anche La vita della mente, p. 93 “parlare di
nichilismo […] non significa forse che riluttanza a separarsi da concezioni e prospettive di pensiero estinte effettivamente già da tempo, anche se il loro decesso è stato pubblicamente ammesso
solo di recente”.
32 Ivi, pp. 53-54.
33 Ivi, p. 57.
34 La vita della mente, p. 91.
35 Ivi, p. 93.
36 Che cos’è la filosofia dell’esistenza, p. 67.
37 Ivi, p. 66.
38 La vita della mente, p. 94.
39 Ivi, p. 95.
40 Ivi, p. 5.
41 La vita della mente, p. 84.
42 Vita Activa, p. 7.
43 Ivi, p. 8.
44 Ivi, pp. 128-129.
45 Ivi, p. 129.
46 Ivi, p. 8.
47 La vita della mente, p. 167.
48 Ivi, p. 168.
49 Ivi, p. 167.
50 Cfr. Vita Activa, p. 8.
51 Ivi, p. 176.
52 Riteniamo che, in una prospettiva filosofica fondata sulla nascita, il problema di sostenere
un rapporto con l’essere inteso come dato e, contemporaneamente, salvaguardare la libertà e la
dignità umane, cessa di esistere. L’essere e l’universale sono stati definitivamente messi da parte
a vantaggio dell’esistere e della singolarità che assumono consistenza e si impongono con evidenza con il nascere dell’individuo al mondo e nel mondo. La libertà dell’individuo adesso viene in primo piano. Con la nascita intesa come venire al mondo in mezzo ad altri uomini e come cominciamento di ogni cosa e di ogni progetto l’uomo realizza la propria libertà nell’azione. Ci rendiamo
conto che l’argomento non è privo di difficoltà e meriterebbe una trattazione più approfondita e problematica che tuttavia qui non è possibile condurre. Pertanto a sostegno ma anche come limite da
porre a questa nostra riflessione, che prende spunto dal pensiero di Arendt e all’interno di esso
vuole mantenersi, vale la pena citare alcuni passaggi delle ultime pagine scritte dall’autrice prima
della sua morte improvvisa. Nelle conclusioni de La vita della mente, a proposito del problema della libertà Arendt scrive “La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non
certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita. Sono del tutto consapevole che […] l’argomento resta in un certo qual modo trasparente, che non sembra dirci null’altro
che siamo condannati ad essere liberi in ragione dell’essere nati, non importa se la libertà ci piace o aborriamo la sua arbitrarietà o preferiamo fuggire la sua responsabilità tremenda scegliendo
una qualunque forma di fatalismo. Questa impasse, se è veramente tale, può essere superata solo facendo appello a un’altra facoltà della mente, non meno misteriosa della facoltà di cominciamento, la facoltà del Giudizio, un’analisi della quale, forse, può almeno dirci che cosa sia implicato nei nostri giudizi ‘mi piace’ o ‘non mi piace’”, p. 546. Tuttavia Arendt non ebbe il tempo di proseguire la propria riflessione nella direzione appena indicata.
26
SAGGI
27
57
Bibliografia
ARENDT, H., Che cos’è la filosofia dell’esistenza, Jaca book, Milano 1998.
ARENDT, H., La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1987.
ARENDT, H., Vita Activa, Tascabili Bompiani, Milano novembre 2004.
HEIDEGGER, M., Il nichilismo europeo, Adelphi, Milano 2003.
HEIDEGGER, M., Che cos’è metafisica, Adelphi, Milano 2001.
HEIDEGGER, M., Che cos’è la filosofia, il Melangolo, Genova 1981.
VOLPI, F., Il Nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2005.
58
di Veronica Natella
1. Autenticità ed apparenza. Il personaggio di Nora in Casa di bambola1 –
opera del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen risalente al 1879 – la donnabambola che si anima in una casa teatro di giochi, vezzeggiando con adulti e
bambini, inventando e adattando un copione giorno per giorno, ha raggiunto la
fama letteraria grazie al notevole impatto sul grande pubblico, raccogliendo consensi e alimentando dispute, facendo altresì proliferare molteplici ed eterogenei
giudizi critici, da Groddeck a Slataper a Lou-Salomé2, per citarne solo alcuni.
L’affascinante ingenuità della signora Helmer che, spinta dalla dedizione alla
causa dell’amore – convinzione che nutre in segreto sino alla fine del dramma –
falsifica una firma commettendo un’imprudenza disonorevole per le leggi della
società nonché penalmente perseguibile, si contrappone ai rigidi schemi morali
del marito Torvald Helmer: nell’un caso, l’avventata risoluzione per salvare la vita del coniuge minacciata dalla malattia, cela una moralità fragile, ma fondata
sull’impulso generoso del cuore; nel secondo, una dignità personale da difendere non tanto per se stessa, ma per le apparenze, fa emergere un altrettanto fragile senso morale. Ne consegue un’insanabile tensione dialettica, espressa in un
dialogo in cui la decisione personale di Nora di lasciare casa e marito, opponendosi alla limitante visione del coniuge condizionata dal paradigma sociale, s’intreccia con i grandi temi dell’educazione, della maturazione individuale di esperienze significative, del confronto critico con le convenzioni dilaganti.
Nora: Devo cercare di educare me stessa e tu non sei uomo da aiutarmi.
Devo farlo da me. Perciò ti abbandono.
[…]
Helmer: Oh, creatura inesperta e accecata!
Nora: Devo far di tutto, Torvald, per acquistare esperienze.
Helmer: Lasciare la tua casa, tuo marito e i tuoi figli! Pensa: che cosa dirà la gente?
Nora: Questo non può riguardarmi. So soltanto che per me è necessario.
Helmer: […] Il senso morale, almeno, lo avrai. Oppure, rispondi, non hai
neppure questo?
Nora: Ecco, Torvald, non è facile darti una risposta. Non lo so assolutamente. Sono sconcertata. […]
Helmer: Tu parli come una bambina. Non comprendi la società nella
quale vivi.
SAGGI
L’ESILIO DAL RUOLO SOCIALE IN
CASA DI BAMBOLA DI IBSEN
NELL’INTERPRETAZIONE
DI EDITH STEIN E ANTONIO GRAMSCI:
UN CONFRONTO
59
Nora: Non la comprendo… È vero. Ma ora mi riprometto di vederla da vicino. Devo scoprire chi abbia ragione, se la società o io3.
60
Ecco quella che, nella brillante e sagace recensione al testo di Ibsen,
Gramsci definisce “la rappresentazione di un urto necessario tra due mondi interiori, tra due concezioni, tra due vite morali”4 come presupposto di ogni dramma, prima di addentrarsi nel vivo della critica, con l’originale intento di ricorrere ai tradizionali concetti di spirito, anima, atto morale, proponendoli in una forma rivisitata, sottraendoli cioè alla matrice religiosa di stampo cattolico5. In particolare, la contrapposizione tra l’abito morale tradizionale della borghesia e
una tradizione diversa, in linea con la morale universale, vale a dire una morale umana non appannaggio esclusivo della classe dominante, ed anzi maggiormente aderente ai costumi del proletariato, consente a Gramsci di sviluppare
– a partire dal testo teatrale6 – la tesi secondo cui ad una morale di schiavi divenuti padroni, stretti nella morsa delle convenzioni sociali cui ci si sottomette
con elegante ipocrisia, fa da contrappeso la morale delle anime nobili, alla continua ricerca della propria personalità, della pienezza di vita interiore, senza assecondare per vile obbedienza i dettami del costume borghese.
In tale quadro va collocata propriamente la tematica dell’emancipazione
femminile7: se per la morale borghese la donna non è altro che “la femmina
che nutre di sé i suoi nati, la bambola più cara quanto più è stupida, più diletta ed esaltata quanto più rinunzia a se stessa”8, nel mondo del proletariato non
è ardua impresa incontrare donne che hanno scelto di abbandonare casa, marito e figli per “rintracciare nella profondità del proprio io le radici robuste del
proprio essere morale, per adempiere ai doveri che ognuno ha verso se stesso prima che verso gli altri”9.
La medesima condanna dell’ambiente della civiltà moderna, incline alla sterile apparenza formale, riecheggia nel ritratto, lucido e vibrante ad un tempo,
che di Nora fornisce Edith Stein10, in comparazione con altre figure letterarie
femminili quali Ingunn di Undset ed Ifigenia di Goethe. Il metodo espositivo
prescelto si fonda non sull’argomentazione filosofica delle tesi a sostegno della specificità dell’anima femminile11, bensì su un percorso alternativo – l’analisi di testi letterari – nella convinzione che “scrutare e rappresentare l’anima
umana è una funzione caratteristica della poesia”12. I tratti comuni delle donne
descritte, scelte ad emblema di tipicità di caratteri femminili, evidenziano profonde lacune nella formazione individuale: Ingunn, fin dalla tenera età, “non è
costretta a un’attività regolata, non conosce una disciplina esteriore o interiore”13, la sua anima è “come un campo che non è mai stato solcato dall’aratro”14;
Nora appare come una bambola, viziata un tempo dal padre ed ora dal marito, non preparata ad assumere decisioni responsabili (“Il suo intelletto è sveglio, quantunque non abbia avuto una formazione sistematica”15); Ifigenia, condotta presso un popolo straniero e strappata alle cure dei familiari, pur rappresentando un ideale supremo di anima pura, “ha bisogno che il suo essere, tanto maturo ed elevato, possa diventare amore che redime, come esige la sua
vocazione”16. Il contrasto tra la realtà esterna e la propria interiorità diviene
dramma allorché le circostanze esterne, costrittive e vincolanti, divengono per
2. L’azione educativa della formazione. In Edith Stein, il processo di maturazione per la piena e consapevole estrinsecazione della propria personalità
implica non solo un’intima volontà di progresso e l’attivazione delle energie necessarie allo scopo, quanto un’attenta, accurata e continua opera di formazione ed auto-formazione24, variamente declinata come Bildung, Selbstbildung,
Gemütsbildung25. L’anima assolve ad una funzione conoscitiva in cooperazione con l’intelletto e la volontà: “ove manca la formazione dell’intelletto e l’educazione della volontà, la vita affettiva – Gemütsleben – viene a essere un movimento senza direzione”26, come testimoniano le eroine letterarie nel momento in cui la vita le colloca di fronte a scelte drammatiche. Di qui la necessità ineludibile di un’adeguata opera di formazione, per evitare deviazioni e degenerazioni che offuschino la capacità conoscitiva dell’anima e la sua possibilità di
azione. L’educazione nella sua completezza forgia l’anima consentendole una
limpida azione conoscitiva27; tale azione non si arresta sul piano teorico: il discernimento del bene si traduce nella ricerca e nell’attuazione del bene, facendo conseguire significativi progressi alla singola persona, ma anche e soprattutto alla collettività sociale. È importante sottolineare il rapporto dinamico e
complementare tra formazione ed auto-formazione perché, nell’ambito del processo educativo e pedagogico, la Stein considera il soggetto non “una materia
inerte, senza vita, che può essere plasmata e conformata dall’esterno, come
l’argilla in mano all’artista o come la pietra sottoposta agli influssi del clima; si
tratta di una radice vitale che ha in sé le energie per svilupparsi in una deter-
SAGGI
le tre protagoniste motivo di lacerazione intima. Tale conflitto interiore è, però,
produttivo: dagli abissi del dolore e della solitudine emerge una nuova prospettiva di vita, al servizio di un ideale superiore. “Poiché nulla si muove spontaneamente e sembra quasi che dietro la maschera sociale non vi sia nulla, ella
tenta da se stessa di aprirsi a forza la strada verso se stessa, verso il suo vero essere”17: questa la scelta di Nora, considerata dalla Stein “non certo inverosimile o impossibile”18. Al conseguente interrogativo ‘qual è il vero essere?’
riferito alla posizione morale di Nora, ma anche di Ingunn e Ifigenia, Edith Stein
lega emblematicamente la domanda fondamentale sulla condizione femminile
universale: “Che cosa siamo noi e che cosa dobbiamo essere?”19, nella consapevolezza che l’autentico, intimo bisogno della donna sia “far dispiegare e maturare nel modo migliore la propria umanità addormentata”20. Non a caso, le
eroine letterarie succitate esprimono tutte simbolicamente, sebbene in contesti e ruoli diversificati, l’anelito femminile ad una realtà superiore: Nora mediante la ricerca del suo vero essere, Ingunn attraverso la liberazione dal dominio
dei sensi, Ifigenia con una forma di amore oblativo.
In maniera non dissimile, Gramsci nella sua recensione contrappone “un’altra tradizione, superiore, più spirituale, meno animalesca”21 all’“ipocrita mascheratura dell’animale uomo”22 ravvisabile nel mondo borghese; ed è proprio
in nome di tale tradizione spirituale, sebbene poco diffusa, che la donna può –
secondo l’autore – vedere riconosciuti anche dall’esterno bisogni interiori specifici, ineliminabili, in direzione della ricerca e dell’espletamento di “una personalità umana tutta sua e una dignità di essere indipendente”23.
61
62
minata direzione”28. L’immagine metaforica utilizzata, propria di una consolidata tradizione pedagogica, è quella che compara l’anima alla pianta, la cui evoluzione dal seme fecondo è condizionata da fattori esterni ed interni29. In tale
direzione, “per l’esplicazione delle energie superiori, è necessaria la guida e la
direzione; è questo l’ambito caratteristico dell’educazione, dell’insegnamento,
del lavoro formativo conscio, libero ed eventualmente pianificato”30. È fondamentale, per maturare in crescente autonomia retti giudizi di valore, essere inizialmente guidati da educatori all’altezza del loro compito. Costoro dovranno
porre tra i compiti educativi la capacità di distinzione tra apparenza e realtà, sia
nella vita esteriore che in quella interiore, esaltando il bene rispetto al male, ponendo in luce sentimenti elevati in contrasto con atteggiamenti vili. Al riguardo,
la vicenda di Nora nell’interpretazione della Stein potrebbe essere letta – a mio
avviso – come un concatenarsi di azioni appiattite sul livello dell’apparenza: il
mondo esterno risulta costruito su presupposti fantasiosi, distanti da ogni giudizio logico e, ancor più, da giudizi di valore rettamente orientati. L’apporre una
firma fasulla, in virtù del fine nobile, agli occhi di Nora riscatta l’azione da ogni
colpevolezza: l’azione appare degna di essere compiuta da parte di una moglie devota al marito. Tale contraddizione etico-morale pone in risalto la necessità di favorire nel sistema educativo “oltre alla critica della ragione, anche la
prassi”31. L’esplicazione dell’attività pratica, infatti, rappresenta il punto di congiunzione tra il discernimento valoriale e la sua coerente concretizzazione, finalizzati alla crescita personale e comunitaria. Una formazione completa, in
grado di far sviluppare tutte le potenzialità, non solo provvede ad una “retta
educazione del sentimento”32, ma ad essa affianca – integrandola – un concreto programma di esercizio dell’intelletto e della volontà, orientato “ad una serena organizzazione della vita, a un’azione fruttuosa”33. Onde evitare “quel tipo
di donna che conduce una vita di sogno e di apparenze, che di fronte ai compiti oggettivi si sottrae, oppure si abbandona tutta a sentimenti ed emozioni prive di valore”34, la scuola tedesca moderna ha il merito – riconosce Edith Stein
– di aver inserito nei programmi d’insegnamento femminili discipline quali la
matematica, le scienze naturali, le lingue antiche, tradizionalmente appannaggio delle menti maschili, con il duplice, ammirevole risultato di consentire
l’esercizio metodico della volontà35, della memoria, dei processi di analisi e sintesi, favorendo al contempo l’accesso delle donne alle attività professionali extradomestiche. Dal momento che il progresso economico e tecnologico ha
semplificato le attività domestiche, numerose donne hanno ravvisato nel lavoro un campo utile ove poter incanalare le proprie energie operative. “Il movimento femminile radicale reclamava che le donne fossero ammesse a tutte le
professioni e potessero accedere a tutti i gradi di istruzione. Con accese battaglie, esso è riuscito a conquistare terreno passo dopo passo, finché da noi in
Germania la rivoluzione ha portato quasi improvvisamente ad esaudire tutte
queste richieste”36.
Eguale attenzione per la tematica dell’istruzione quale base imprescindibile
per l’emancipazione umana, e femminile in particolare, è riscontrabile nella Lettera 189 di Gramsci, datata 4 maggio 1931: “Oggi nel nostro paese all’attività
femminile sono fatte condizioni molto sfavorevoli fin dalle prime scuole, come
3. Il singolo e la collettività. Sul rapporto individuo – collettività è possibile
operare un ulteriore confronto tra i due pensatori, confronto giovevole a ricondurre coerentemente le interpretazioni della figura di Nora da essi proposte alle rispettive posizioni teoriche. Avendo sinora tentato un insolito accostamento
tra le argomentazioni addotte intorno alle medesime tematiche, mi limiterò di
seguito ad enucleare un punto di incolmabile distanza tra i due autori, attraverso il quale – a mio avviso – risulterà agevole far emergere nella duplice immagine di Nora, da un lato un credo religioso, dall’altro un credo politico.
SAGGI
per esempio l’esclusione delle giovinette da molte borse di studio ecc. per cui è
necessario nella concorrenza che le donne abbiano qualità superiori a quelle
domandate ai maschi e una maggior dose di tenacia e di perseveranza”37. Nella parte iniziale dell’epistola, si specifica che tenacia e perseveranza non sono
soltanto doti naturali, rappresentando piuttosto il frutto di un’attenta opera di
educazione della volontà: “Mi pare importante la forza di volontà, l’amore per la
disciplina, per il lavoro, la costanza nei propositi, e in questo giudizio tengo conto, più che del bambino, di quelli che lo guidano e che hanno il dovere di fargli
acquistare tali abitudini”38. Ove tale azione educativa risultasse deficitaria o intrapresa con superficialità, la formazione femminile ne risulterebbe compromessa, a vantaggio di una scarsa capacità decisionale e professionale. Non desti
meraviglia, pertanto, se già in un’epistola precedente, la Lettera 159 (datata 28
luglio 1930), in riferimento alla educazione della piccola Mea, una bambina di
appena dieci anni, Gramsci individuasse con estremo rigore i rischi di una degenerazione della personalità femminile, se non opportunamente guidata: “Mi
pare che Mea sia troppo puerile per la sua età, che non abbia altre ambizioni
che quella di fare belle figure apparenti e che non abbia vita interiore, che non
abbia bisogni sentimentali che non siano piuttosto animaleschi (vanità, ecc.).
Forse voi l’avete viziata troppo e non l’avete costretta a disciplinarsi”39.
Nel dettaglio dei metodi e dei programmi didattici, in cui si riflette chiaramente una determinata impronta teorica, così si pronuncia Gramsci sui rischi
di un sistema educativo che propone con marcata nettezza la separazione tra
attività intellettuale e manuale40: “La scuola unitaria o di formazione umanistica o di cultura generale dovrebbe proporsi di immettere nell’attività sociale i
giovani dopo averli portati ad un certo grado di maturità e capacità, alla creazione intellettuale e pratica, e di autonomia nell’orientamento e nell’iniziativa”41.
Analoga la posizione di Edith Stein, secondo cui l’opera di formazione femminile, lungi dal proporre esclusivamente nozioni teoriche dei vari campi culturali in forma di compendio, ha il dovere di “presentare occasioni di attività pratica, la quale è poi una formazione alla vita sociale”42, mediante momenti di lavoro, di studio e di ricreazione svolti in gruppo. “L’esplicazione delle capacità
pratiche e creative è perciò parte essenziale del processo educativo. […] Noi
educheremo donne capaci nell’attività pratica, energiche, precise, pronte al sacrificio, se già durante il periodo scolastico le faremo operare”43. Tale linea programmatica risponde alla visione secondo cui la donna, per natura, è più incline al concreto che all’astratto; non solo, l’esecuzione materiale di compiti concreti e pratici costituisce un valido contributo all’educazione della volontà.
63
64
Nello scritto di Edith Stein, la figura di Nora è il simbolo della creatura la
cui anima “aveva avuto una certa formazione per influssi occasionali e per
interventi dilettantistici, ma non certo quella che sarebbe stata adatta per
lei”44; di qui l’ampia dissertazione – contenuta nel paragrafo centrale del saggio, denominato ‘Formazione della donna’ – sul valore e il fine dell’arte educativa, cui sopra si è accennato con riferimento al sistema di istruzione45.
Che, dunque, Nora rappresenti una tipologia di donna piuttosto diffusa non
v’è dubbio alcuno. La grandezza di Ibsen nella lettura della Stein consiste
nella scelta ultima della protagonista che, consapevolmente, riesce a “strappare la rete che la imprigiona e prendere in mano la propria vita e la propria
formazione”46. Si motiva in tal modo la ricerca della “particolare impronta individuale”47, l’ansia di conoscere e scoprire “il bene, il bello, il nobile, il santo, quei valori specifici che si addicono a ogni anima in quanto tale e alle qualità individuali di ciascuna”48.
Il ripetuto riferimento al tema dell’individualità peculiare di ciascuno, ascrivibile alla tradizione cattolico-cristiana e non solo49, diviene chiaro esempio di
come, al di là di ogni tipologia dal valore simbolico, la singola umanità non viene offuscata ed anzi chiamata ad esprimere se stessa. Del resto, tra i compiti
dell’educatore, la Stein annovera “ conoscere chiaramente il materiale che ha
in mano, cioè le potenzialità di questi individui umani che deve educare: la natura dell’anima in generale, la particolare natura dell’anima muliebre e le caratteristiche individuali delle sue alunne”50. L’attenzione al tema dell’individualità
ritorna in altri saggi, con pari efficacia espressiva: “Le donne, come gli uomini,
sono essenze individuali e questa individualità deve venir tenuta presente nel
lavoro educativo”51; ed ancora: “Ogni anima umana è creata da Dio, ognuna riceve da lui un’impronta che la distingue da tutte le altre; e questa individualità
è per l’educazione un valore che deve venire sviluppato”52.
Inversamente, in Gramsci, la condizione del singolo è specchio di una classe sociale ben definita. “Il dramma di Nora Helmer lo possono comprendere,
perché lo vivono quotidianamente, le donne del proletariato, le donne che lavorano. […] Lo comprendono, per esempio, due donne proletarie che io conosco, due donne che non hanno avuto bisogno né del divorzio né della legge
per ritrovare se stesse, per crearsi il mondo dove fossero meglio capite e più
umanamente se stesse”53. La personale scelta di vita delle donne menzionate
coincide emblematicamente con la scelta morale del gruppo sociale cui esse
appartengono: i confini del singolo si dissolvono nella classe proletaria in un
processo di identificazione reciproca. Nora è, quindi, definita – nelle righe conclusive della recensione – una “sorella spirituale”54 del proletariato femminile.
Pesa inevitabilmente la polemica gramsciana contro la nozione di ‘individuale’
professata dal cattolicesimo: “Tutte le filosofie finora esistite può dirsi che riproducono questa posizione del cattolicismo, cioè concepiscono l’uomo come individuo limitato alla sua individualità e lo spirito come tale individualità”55. Non
che venga annullata la categoria del singolo, ma – come si evince in diversi
punti della riflessione di Gramsci – esso è sempre rapportato ad un’alterità
omogenea, totalizzante: “Occorre riformare il concetto di uomo. Cioè occorre
concepire l’uomo come una serie di rapporti attivi (un processo) in cui se l’in-
SAGGI
dividualità ha la massima importanza, non è però il solo elemento da considerare. […] Il singolo può associarsi con tutti quelli che vogliono lo stesso cambiamento e, se questo cambiamento è razionale, il singolo può moltiplicarsi per
un numero imponente di volte”56.
Il riferimento al sistema educativo e scolastico, considerato in connessione
al rapporto tra individualità e collettività, consente di sviluppare un ulteriore argomento comparativo. In Edith Stein, a coronamento dell’azione formativa si
colloca l’educazione religiosa: “Il primo e vero formatore dell’uomo non è l’uomo, ma Dio. È lui che dà la natura individuale e pone in quelle circostanze di
vita nelle quali essa deve svilupparsi”57. Nell’essere umano coesistono la natura in senso generale e l’impronta individuale specifica, da sviluppare seguendo una determinata vocazione. Affinché il singolo operi una scelta coerente
con le proprie inclinazioni naturali, risulta della massima importanza attuare un
intervento educativo mirato, programmato con rigore e sensibilità, da parte di
educatori attenti essi stessi allo sviluppo dei propri talenti personali. Tale pianificazione, tuttavia, appare insufficiente qualora non fosse adeguatamente completata dall’istruzione religiosa, mediante la quale gli insegnanti educano al
rapporto intimo tra uomo e Dio, rapporto fecondo di risposte per quella condizione di vita che si delinea di giorno in giorno come la chiamata di ciascuno a
servire il Regno dei cieli. “Come la natura umana generica anche l’individualità ha importanza in rapporto al tempo e all’eternità. Non si limita ad assegnare all’uomo il suo posto nella società terrena, bensì anche nella gerarchia celeste”58.
Ritorna, variamente declinata in diversi testi, la metafora della pianta che
evolve dal seme59: “La vocazione naturale dell’essere umano, come di ogni altra creatura, è che noi si dispieghi e si porti allo sviluppo, in purezza e conformemente all’ordine stabilito da Dio, ciò che il Creatore ha posto in noi come seme”60. La dimensione teleologica di tale evoluzione viene evidenziata nel saggio Sull’idea di formazione ove, oltre a dedicare un paragrafo specifico al parallelo tra anima e pianta, con esplicito riferimento alla filosofia aristotelico-scolastica, Edith Stein lega lo sviluppo naturale al fine soprannaturale: “Secondo
la nostra fede il cammino di formazione dell’uomo è cammino della provvidenza divina. Dio ha dato all’uomo la sua impostazione naturale, e gliel’ha data
sotto forma di un seme”61. Si potrebbe obiettare che lo sviluppo umano, allora,
non avviene nel segno della libertà, ma di una disciplina educativa la cui finalità ha origini divine; parimenti, potrebbero emergere legittime perplessità in
merito a coppie di concetti non letti in opposizione reciproca, quali fede – ragione, sviluppo dell’individualità – abbandono in Dio. Di tali obiezioni sembra
tener conto la pensatrice nel momento in cui afferma: “La fede viva è propria
dell’intelletto e del cuore, è atto di volontà e azione. Chi cerca di suscitarla in
sé, educa tutte le proprie energie”62; nel tracciare un legame profondo non solo tra fede e ragione, ma anche tra fede e azione, l’educazione religiosa non
agisce esclusivamente nell’intimo della coscienza: si riflette all’esterno, nelle
dinamiche relazionali e professionali63, si traduce in energia operativa e attività pratica alla luce della chiarezza intellettuale, collima – condividendone le
elevate finalità – con tutte le tappe della formazione umana. L’autorealizzazio-
65
66
ne può, quindi, configurarsi come risposta alla chiamata divina64 nel momento
in cui questa non è vissuta come limitante e coercitiva, viceversa tesa a far dispiegare le energie umane per una piena espressione di vita; secondo le parole stesse di Cristo: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”65. Tale pienezza, definita anche autenticità, segna ancora una volta il carattere individuale del soggetto educante, in un processo evolutivo in cui
fede e ragione, affettività e volontà, concorrono in egual misura alla formazione complessiva della personalità: “ Il bambino è stato condotto sulla via giusta
se l’abbiamo condotto sino a voler vivere nella sequela di Cristo, cioè a rinunziare alla propria volontà e a porre le redini della propria vita nelle mani di Dio.
A prima vista pare che in questo modo si rinunzi anche all’individualità. Ma non
è affatto così. […] Chi pone la propria vita nelle mani di Dio, e questi soltanto,
può star sicuro che diverrà in tutto se stesso”66.
Il legame di fusione tra pedagogia e politica esaminato da Gramsci si estende al di là del rapporto scolastico tra docente e allievo ed investe tutta la società, stabilendosi “tra ceti intellettuali e non intellettuali, tra governanti e governati,
tra elites e seguaci, tra dirigenti e diretti, tra avanguardie e corpi di esercito. Ogni
rapporto di egemonia è necessariamente un rapporto pedagogico”67. Di qui, seguendo l’itinerario della filosofia della praxis68, il vivo incoraggiamento dell’autore a formare – attraverso il rinnovamento del sistema scolastico – un ceto intellettuale in senso ampio, specializzato sul versante umanistico e tecnico, in grado di guidare le masse e di imprimere una direzione al flusso storico. Tale funzione egemone va esercitata non come strumento di dominio, bensì mediante il
consenso della popolazione; nell’organizzazione interna, i diversi gruppi sociali –
espressione di attività professionali distribuite in vari livelli – attribuiscono il ruolo-guida ad uno o più dirigenti: si possono, così, distinguere ‘intellettuali di tipo urbano e di tipo rurale’69, gli uni legati al mondo industriale, gli altri attivi nell’amministrazione statale e locale. All’intellettuale-politico spetta il compito di attuare
una mediazione tra il mondo produttivo nelle sue varie sfaccettature e lo Stato,
non certo per iniziativa personale, ma all’interno del sistema di partito.
Per sottolineare la necessità di un sistema educativo finalizzato alla formazione integrale di abilità intellettive ed operative, per evitare altresì il rischio di
una netta contrapposizione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, Gramsci
sostiene che “ogni uomo, all’infuori della sua professione, esplica una qualche
attività intellettuale, è cioè un filosofo, un artista, un uomo di gusto, partecipa
di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta morale,
quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo”70.
Nella realtà sociale, tuttavia, si generano conflittualità e divisioni, spesso insormontabili, nonché cristallizzazioni dei ruoli, per cui si richiede un sistema
d’istruzione effettivamente democratico e teso all’uguaglianza: “La tendenza
democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un operaio manovale diventa qualificato, ma che ogni cittadino può diventare governante e che
la società lo pone, sia pure astrattamente, nelle condizioni generali di poterlo
diventare”71. Tale mobilità può essere compiutamente realizzata con l’elevazione sociale da un lato e, in senso politico, con l’egemonia del proletariato.
Oltre al sistema pubblico d’istruzione e all’esperienza professionale, l’intellet-
SAGGI
tuale-politico compie il suo apprendistato nella cosiddetta “scuola di partito”, ove
– con altri militanti – condivide il perseguimento di finalità contingenti, di ordine socio-economico, contribuendo congiuntamente ad un’intensa e sistematica opera
di diffusione culturale, nel convincimento che “male sarebbe se il movimento operaio diventasse campo di preda o strumento di esperienza per la sufficienza di
male accorti pedagoghi, se esso perdesse i suoi caratteri di appassionata milizia
per assumere quelli di studio oggettivo e di cultura disinteressata. Né uno studio
oggettivo, né una cultura disinteressata possono aver luogo nelle nostre file, nulla quindi che assomigli a ciò che viene considerato come oggetto normale di insegnamento secondo la concezione umanistica, borghese, della scuola”72.
Come si può dedurre dalle citazioni su riportate, in Gramsci l’intreccio tra
modelli pedagogici, programmi d’istruzione e finalità politiche è collegato al tema dominante della questione operaia e della lotta di classe: l’azione del singolo si articola propriamente all’interno di una dimensione collettiva, al punto
che l’autore utilizza al riguardo l’espressione “uomo collettivo”73.
4. Verso una nuova identità. Prelude alla decisione ultima di sciogliere il vincolo coniugale74, dominando la parte finale del III e conclusivo atto della rappresentazione, l’intenso scambio di battute tra Nora e Torvald, rivelatore della
inconciliabile diversità tra due mondi morali75.
Helmer: Nora, non potrò mai essere di nuovo per te più che un estraneo?
Nora: (prende la valigia) Oh, Torvald, allora dovrebbe avvenire il più grande miracolo…
Helmer: Dimmelo, questo grande miracolo!
Nora: Dovrebbe avverarsi in noi due un tale mutamento che…ah, Torvald, non credo più ai miracoli.
Helmer: Ma ci voglio credere io. Finisci la frase. Un tale mutamento che…
Nora: …che la nostra convivenza possa diventare matrimonio. Addio!
(Esce dall’anticamera)76.
La negazione del miracolo induce al percorso individuale di formazione.
Quando il miracolo77 non irrompe sulla scena, quando ad esso viene negata
ogni possibilità di esistere, perfino nei termini di pensabilità78, allora decade anche la moglie bambola. Nora non attende più il miracolo, quantomeno non più
dagli altri; la bambola-burattino recide consapevolmente i fili e non affida a condizioni esteriori il rinnovamento miracoloso della sua condizione79. L’invocato,
agognato miracolo, suggerito nel finale, ma incompiuto sulla scena, è che la
convivenza possa essere condivisione autentica di atti morali, detto altrimenti,
comunanza piena di valori e sentimenti, non un legame di fatua apparenza per
la società. La condivisione coniugale implica, tuttavia, una preesistente formazione individuale e, dunque – suggerisce Nora mediante l’esilio volontario –
prima l’essere umano, di poi la moglie e la madre. Tale scelta non costituisce
una fuga dal ruolo: entrambi gli autori pongono in evidenza il mutamento interiore che induce a liberarsi dalla maschera sociale; il conseguente direzionarsi verso una rinnovata identità è, tuttavia, segnata da alcune differenze che
tenterò – in conclusione – di sintetizzare.
67
68
In Gramsci, l’esilio rappresenta di per sé la conquista decisiva, il traguardo
del nuovo sé in soluzione di continuità col passato: è qualificato come atto “essenzialmente morale”80, in quanto traduce in essere la “pienezza di vita interiore, escavazione profonda della propria personalità”81. Affermandosi in fulgida
opposizione con il perbenismo di superficie della classe borghese entro cui, un
tempo, la stessa Nora – quale prototipo della bambola gaia – era ciecamente
avviluppata, l’esilio diventa l’emblema di un modello sociale non convenzionale, scelta in cui si riflette un nuovo valore di classe.
Secondo Edith Stein, invece, l’autentica vita di Nora era già “nascosta dietro la bambola viziata”82, ma ella non ne aveva consapevolezza. L’esilio indica
qui lo stadio iniziale di ricerca individuale per “diventare ciò che si deve essere”83, l’avvio di un processo intimo di scoperta dell’interiorità, affinché da essa
promani luce sul mondo esterno, attraverso il ruolo identitario coerentemente
vissuto dal singolo nella quotidianità privata e nel tessuto sociale.
La cesura fondamentale tra le due posizioni è rappresentata propriamente
dalla radice interiore della scelta dell’esilio.
In Gramsci, la motivazione intima foriera del dissolvimento del legame coniugale trapassa istantaneamente dal piano della morale individuale al piano
della organizzazione sociale della classe proletaria. Come si è evidenziato fin
dalle pagine iniziali di questo contributo, la lettura gramsciana – tesa alla celebrazione virtuosa del mondo proletario secondo categorie innovative, per non
dire rivoluzionarie – non considera in nessun punto l’azione del singolo come
di per sé significativa. Né, d’altra parte, recensire il testo di Ibsen ha soltanto
l’ovvio e scontato significato di scardinare la sacralità del legame sponsale difesa dalla morale cattolica: se – per Gramsci – Nora è un’eroina, una donnasimbolo, lo è esclusivamente all’interno di una classe dalle caratteristiche ben
definite. Ciò dimostra che il nuovo patrimonio valoriale ed educativo, il mutato
modello sociale di cui la protagonista del dramma teatrale si fa portavoce, si
rendono possibili attraverso l’estensione di intenti morali attuata nell’ambito del
proletariato, in linea con la condivisione del fine politico-economico propria dell’organizzazione di partito. Sullo sfondo è sempre presente, infatti, il duplice
movimento osmotico: dalla base collettiva ai vertici del partito e viceversa, in
un confronto costante: “Solo da un lavoro comune e solidale di rischiaramento, di persuasione e di educazione reciproca nascerà l’azione concreta di costruzione. Lo Stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale caratteristici della classe lavoratrice sfruttata. […] Il Partito deve continuare a essere l’organo di educazione comunista, il focolare della fede, il depositario della dottrina”84. Ciò spiega perché Gramsci non disdegna di elaborare le
sue riflessioni politiche muovendo da una vicenda privata, sebbene ascrivibile
all’arte letteraria. Che sia vita reale o che sia produzione simbolica non fa differenza: la condizione di schiavitù, da cui Nora coraggiosamente si divincola,
non è che l’espressione della sottomissione del proletariato al dominio della
borghesia.
In realtà, nella visione gramsciana, è la borghesia che vive inconsapevolmente in uno stato di schiavitù, caratterizzato dalla “sottomissione all’ambiente”85; in particolare, “la donna della famiglia borghese rimane come prima la
SAGGI
schiava, senza profondità di vita morale, senza bisogni spirituali, sottomessa
anche quando sembra ribelle”86. La svolta morale di Nora, configurandosi come allontanamento dal costume borghese, “costume che ha importanza nella
storia attuale, perché è il costume della classe che è della storia stessa protagonista”, comporta che l’esilio non rappresenta solo un’aurora di libertà individuale, quanto l’avvento dell’affermazione di una nuova morale, “profondamente umana perché fatta di spiritualità più che di animalità, di anima più che di
economia”87, nonché di “un altro costume in formazione, quello che è più nostro, perché è della classe cui apparteniamo noi”88. Alle spalle della morale adveniente, aleggia pur sempre la profezia socio-politica della dittatura universale del proletariato sul modello della organizzazione russa post-rivoluzionaria, sì
che la scelta d’azione dell’individuo si congiunge alla storia collettiva, significa
un processo evolutivo, tende ad un fine universale di natura terrena: “La vita
politica russa è indirizzata in modo che tende a coincidere con la vita morale,
con lo spirito universale della umanità russa”89; detto in misura più incisiva: “Volontà, marxisticamente, significa consapevolezza del fine, che a sua volta significa nozione esatta della propria potenza e dei mezzi per esprimerla nell’azione. […] Carlo Marx è per noi maestro di vita spirituale e morale, non pastore armato di vincastro”90. Ne consegue che la dimensione spirituale aderisce pienamente alla dimensione terrena scevra da categorie metafisiche: in tal
modo la politica, accogliendo l’anelito di libertà delle masse proletarie91, si afferma come una nuova religione, apice del discrimen rispetto alla filosofia della storia steiniana.
Come mirabilmente espresso dalla pensatrice nel saggio Formare la gioventù alla luce della fede cattolica92, a commento dell’enciclica papale Divini illius
magistri93: “Bisogna qui distinguere un doppio fine: il fine ultimo e sommo che
norma tutto il pellegrinaggio terreno, la vita eterna in contemplazione del Signore; questo può darlo Dio soltanto. Gli è subordinato il fine terreno, alla realizzazione del quale è dato agli uomini di collaborare coll’educazione: cioè la formazione dell’uomo, il modo in cui egli deve essere e in cui deve condurre la propria esistenza in questo mondo”94. Onde evitare posizioni dogmatiche, Edith
Stein chiarisce nella premessa il criterio metodologico adottato nella stesura del
saggio: riconoscere nell’enciclica il Magistero della Chiesa quale espressione
del sommo rappresentante di Cristo, ma al contempo “ampliare la nostra ricerca su ciò che qui appare sotto forma di formule concise”95, ricorrendo all’“uso
delle fonti dalle quali essa stessa attinge, per cavarne ulteriori lumi”96.
Nel testo, numerose riflessioni sono dedicate al Sacramento del matrimonio, al ruolo dei genitori rispetto all’educazione dei figli, alla famiglia intesa come “comunità pedagogica”, infine al compito educativo della Chiesa. Se ne deduce il costante sforzo di legare il singolo alla comunità ecclesiale, secondo il
Magistero cattolico di ispirazione divina: “Trovare Dio, essergli uniti nell’amore,
agire sotto la sua guida in questo mondo: ecco la pienezza, ecco il fine per il
quale l’uomo deve essere formato. […] E questo ha luogo nella Chiesa”97.
E tuttavia, pur riconoscendo la rilevanza di un rapporto reciproco tra il singolo e la comunità ecclesiale, l’autrice sottolinea la presenza di un luogo privilegiato per l’autentica libertà dell’individuo: “La perfezione nel senso del magiste-
69
ro di Cristo è una disposizione dell’anima: il giusto tiene totalmente le redini della sua anima, è signore di se stesso; non vi è nulla in lui, e nulla nel creato intorno a lui, che abbia facoltà di tenerlo in suo potere”98. È proprio quanto ricerca la coscienza di Nora, nel momento in cui appaiono vane le rassicurazioni del
marito: “Quando il pericolo dello scandalo sociale è passato ed egli le vuol perdonare tutto e riportare tutto alla situazione di prima, lei non può più tornare indietro”99, segno che è giunto il tempo, non più procrastinabile, di intraprendere
la ricerca della propria anima. In tale prospettiva, ritornando al tema centrale del
presente lavoro, quale valore può assumere la scelta dell’esilio?
L’interpretazione di Edith Stein suggerisce di oltrepassare la figura simbolica di Nora per assumere la donna contemporanea e, in generale, la persona,
quale soggetto della ricerca. Il partire rappresenta, allora, non un dovere incompiuto, bensì il volgersi verso un nuovo impegno, per adempiere ad un compito formativo in cui fine soprannaturale e fine terreno s’intersecano: “È una
delle verità di fede cattoliche, che ogni singola anima sia stata creata da Dio e
continui ad esistere in forma personale per tutta l’eternità. […] Dio ha creato
ogni singolo essere umano secondo una sua propria idea, a propria gloria e
gioia”100. Solo quando l’anima ha compiuto un valido percorso educativo, “regna la quiete, la limpidezza, la pace, ed essa è armonicamente formata”101, avvalorando le parole del Salmo: “Solo in Dio riposa l’anima mia”102.
70
1 Nel presente lavoro si farà riferimento alla seguente edizione: H. IBSEN, Casa di bambola,
trad. it. a cura di E. Pocar, A. Mondadori, Milano 1991.
2 Cfr. G. GRODDECK, Il teatro di Ibsen: tragedia o commedia?, Guida, Napoli 1985; S. SLATAPER,
Ibsen, Bocca, Torino 1916; A. L. SALOMÉ, Figure di donne. Le figure femminili nei sei drammi familiari di Ibsen, Iperborea, Milano 1997.
3 H. Ibsen, op. cit., pp. 163-165.
4 A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, Roma 1987, p. 344. La recensione è
datata 22 marzo 1917.
5 Per una panoramica sul rapporto tra Gramsci e la religione cattolica, dagli scritti giovanili sino alle opere della maturità, cfr. B. DESIDERA, La lotta delle egemonie. Movimento cattolico e partito popolare nei Quaderni di Gramsci, Il Poligrafo, Padova 2005. La questione di un possibile dialogo tra marxisti e cristiani è al centro della relazione di L. Lombardo Radice nel volume Il marxismo italiano degli anni Sessanta e la formazione teorico-politica delle nuove generazioni, (Atti del
convegno promosso dall’Istituto Gramsci, Roma 23-25 ottobre 1971), Editori Riuniti, Roma 1972.
Tra gli altri, si segnalano i contributi di V. Gerratana, G. Vacca, G. Napolitano, L. Villari, B. de Giovanni.
6 Sulla fusione in Gramsci tra critica del costume e critica estetica, si veda E. SANGUINETI, Introduzione a A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, cit., pp. XVI-XVII. In riferimento alla dittologia “nazionale e popolare”, dal momento che il teatro di Ibsen viene considerato da Gramsci una
forma corrispondente al romanzo popolare per la straordinaria capacità di interpretare la psicologia popolare, Sanguineti si sofferma sull’analisi gramsciana di una produzione letteraria e, quindi,
intellettuale, radicata nella realtà storico-sociale e, al tempo stesso, capace di superare sia i residui municipali e regionali, sia gli angusti confini elitari, per rappresentare il costume nazionale evitando derive nazionalistiche.
7 Non va, tuttavia, sottaciuto che un filone della critica contemporanea prende le distanze dal
“consueto e consolidato profilo di una Nora protomartire della causa del femminismo”, come sottolinea R. Alonge nella sua Introduzione a H. IBSEN, op. cit., p. 22.
8 A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, cit., p. 345.
SAGGI
9 Ivi, p. 343. Le espressioni utilizzate da Gramsci ricalcano le parole del III atto rivolte da Nora a Torvald, mentre questi la istruisce sui doveri più sacri di una donna, quali la cura del marito e
dei figli: “Ho altri doveri che sono altrettanto sacri. I doveri verso me stessa” (H. IBSEN, op. cit., p.
164).
10 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, in Id., La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia, tr. it. di O. M. NOBILE VENTURA, pref. di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 20075. Lo scritto Christliches Frauenleben comprende testi di conferenze tenute da Edith Stein a Zurigo nel gennaio del
1932, presso l’Organizzazione delle donne cattoliche. Anche Edith Stein, come Gramsci, lega
l’opera di Ibsen alla questione femminile: “Nora è descritta da un uomo che si vuol porre tutto dal
punto di vista della donna, che ha fatto propri gli interessi di lei, gli interessi del movimento femminile. Sotto questo punto di vista, egli sceglie un’eroina e la rappresenta con analisi acutissima: non
è un semplice frutto del suo arbitrio, ma è costruita con molta intelligenza” (ivi, pp. 106-107).
11 Cfr. E. STEIN, Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, tr. it.
di A. M. Pezzella, pref. di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1999.
12 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 102.
13 Ibidem.
14 Ivi, p. 104.
15 Ibidem.
16 Ivi, p. 108.
17 Ibidem.
18 Ivi, p. 107.
19 Ivi, p. 100.
20 Ivi, p. 108.
21 A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, cit., p. 344.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. 345.
24 Cfr. E. STEIN, Sull’idea di formazione, in ID., La vita come totalità. Scritti sull’educazione religiosa, tr. it. di T. Franzosi, Introduzione di L. Gelber, Città Nuova, Roma 1999. Il saggio costituisce
il testo della conferenza tenuta da Edith Stein agli insegnanti cattolici del Palatinato, nell’ottobre
del 1930.
25 Sulla ricchezza semantica del termine Bildung, si veda E. STEIN, Sull’idea di formazione, cit.,
p. 21, Nota del traduttore.
26 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 112.
27 Cfr. A. M. PEZZELLA, Il problema educativo nella filosofia di Edith Stein, «Per la filosofia», n.
39, 1997.
28 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 113. Si noti la sorprendente affinità lessicale oltreché
concettuale con la posizione di Gramsci (cfr., infra, la nota 9).
29 Ibidem. Anche Gramsci, in relazione ai temi pedagogici, utilizza la medesima metafora (cfr.,
infra, la nota 46).
30 Ivi, pp. 113-114.
31 Ivi, p. 120.
32 Ibidem.
33 Ivi, p. 121.
34 Ibidem. Tale descrizione rimanda alla consueta immagine della donna-bambola: è applicabile, quindi, anche alla figura di Nora.
35 L’esplicito riferimento al concetto di una volontà da educare compare nei tratti iniziali della
descrizione di Nora proposta dalla Stein: “Anche la sua volontà, del resto, non ha avuto una formazione sistematica” (ivi, p. 104).
36 Ivi, p. 122. Nel prosieguo del testo citato e, con particolare acume, nel saggio Problemi dell’educazione della donna, in E. STEIN, La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia, cit.,
pp. 157-160, l’autrice affronta il tema dell’evoluzione del movimento femminile in connessione diacronica con le problematiche socio-economiche emerse nella storia tedesca, quali la ricerca del lavoro non come autorealizzazione, ma come necessità dettata dalla crisi economica. Tra le professioni femminili del quarto stato, vissute come costrizione, viene citato anche il lavoro in fabbrica. Il
saggio costituisce l’insieme delle lezioni tenute da Edith Stein presso l’Istituto tedesco per la pedagogia scientifica, nel semestre estivo del 1932.
71
72
37 A. GRAMSCI, Lettere dal carcere, in Id., L’alternativa pedagogica, La Nuova Italia, Firenze
1972, p. 180. Nell’antologia, curata da M. A. Manacorda, vi è una nutrita selezione di testi di taglio
critico imperniati sul rapporto tra pedagogia e politica, sulla varietà ed efficacia dei metodi educativi, sulla formazione professionale ed intellettuale. La lettera citata appartiene al periodo di reclusione in isolamento, in cui diviene progressivamente più fitta la corrispondenza con la cognata Tatiana, non solo su argomenti familiari, ma su specifiche questioni di letteratura, linguistica, storia,
pedagogia: cfr. A. GRAMSCI, T. SCHUCT, Lettere 1926-1935, a cura di A. Natoli e C. Daniele, Einaudi, Torino 1997.
38 Ibidem.
39 Ivi, p. 175. La descrizione sembra riprodurre i tratti futuri della donna-bambola (cfr., infra, la
nota 34).
40 Al riguardo, celebre la critica di Gramsci alla riforma scolastica gentiliana. Sull’argomento si
veda almeno A. GRAMSCI, La formazione dell’uomo. Scritti di pedagogia, a cura di G. Urbani, Editori Riuniti, Roma 1974, pp. 261 ss.
41 A. GRAMSCI, L’organizzazione della scuola e della cultura, in Id. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Editori Riuniti, Roma 20003 (ed. riv. sulla base dell’ed critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana), p. 127. La nota, contenuta nei Quaderni del carcere (Q 12), è stata titolata dallo stesso Gramsci.
42 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 121.
43 E. STEIN, Fondamenti dell’educazione della donna, in Id., La donna, cit., p. 143. Il saggio è
il testo di una conferenza tenuta da Edith Stein a Bendorf, nel 1930, presso la Federazione delle
donne cattoliche.
44 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 112.
45 Numerose pagine sono state dedicate da Edith Stein ai metodi educativi e all’articolazione
del sistema scolastico, sia pubblico che privato: cfr. Problemi dell’educazione della donna, cit., pp.
238 ss.
46 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 107. La rete che imprigiona è, in realtà, il secolare
retaggio per cui il ruolo della donna è vincolato ai diritti naturali concepiti nella loro assolutizzazione. A tal proposito, si legge in J. J. ROUSSEAU, Giulia o la Nuova Eloisa, trad. it. di P. Bianconi,
Rizzoli, Milano 1994?, p. 607: “Madri di famiglia! Quando vi lagnate di non essere assecondate,
quanto male conoscete il vostro potere! Siate ciò che dovete essere, e vincerete tutti gli ostacoli: costringerete tutti a compiere il proprio dovere se compite bene tutti i vostri. I vostri diritti non
sono forse quelli della natura? Nonostante le massime del vizio, saranno sempre cari al cuore
umano. Ah! Siate donne e madri, e il più dolce impero della terra sarà anche il più rispettato!”. Tali dichiarazioni rappresentano la risposta di Saint-Preux alle affermazioni di Giulia: “Io allevo figli
e non ho la presunzione di formare degli uomini. Spero che mani più degne si incaricheranno di
così nobile compito. Sono donna e madre, so stare al mio posto. Torno a dire che la funzione di
cui sono incaricata non è di educare i miei figli, ma di prepararli a essere educati” (ivi, p. 600).
L’intera epistola (parte V, lettera III, pp. 579-608) costituisce una mirabile sintetica trattazione dei
metodi pedagogici ed educativi considerati più efficaci da Rousseau. Sulla validità di tali metodi
secondo Gramsci, in prospettiva di una concezione meno spontaneistica e libertaria, si veda A.
Gramsci, L’alternativa pedagogica, cit., pp. 172 -175; nel medesimo volume, nella Lettera 123 del
22 aprile 1929, p. 130, l’autore esprime con metafora naturalistica i suoi dubbi iniziali circa la posizione da assumere in merito a contrapposte teorie pedagogiche: “I semi hanno tardato molto a
sortire in pianticelle. […] A me ogni giorno viene la tentazione di tirarle un po’ per aiutarle a crescere, ma rimango incerto tra le due concezioni del mondo e dell’educazione: se essere roussoiano e lasciar fare la natura che non sbaglia mai ed è fondamentalmente buona o se essere volontarista e sforzare la natura introducendo nell’evoluzione la mano esperta dell’uomo e il principio d’autorità”. Sulle concezioni della moderna pedagogia da Rousseau in poi, sia in merito alla
scelta tra un metodo educativo libero o strutturato, sia in relazione al tema dell’individualità, si veda E. STEIN, Verità e chiarezza nell’insegnamento e nell’educazione, in Id., La vita come totalità,
cit., p. 42. Il saggio è il testo di una conferenza tenuta da Edith Stein a Spira, cui è stata attribuita la data del 1926.
47 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 108.
48 Ivi, p. 114. Segue l’esplicitazione dei passi della Sacra Scrittura incentrati sull’esortazione al
riconoscimento e al conseguente potenziamento delle qualità individuali: “Che poi ci sia un fine
SAGGI
educativo individuale, lo troviamo espresso nella parabola dei talenti e nell’insegnamento dell’Apostolo sui doni diversi; quale sia questo fine educativo non si può dire in generale, lo si deve ricercare caso per caso” (ivi, p. 116).
49 Sulla fondazione di una ‘teoria della persona’ a partire dalla riflessione fenomenologica, così C. Conni in Identità e strutture emergenti. Una prospettiva ontologica dalla Terza ricerca logica
di Husserl, Bompiani, Milano 2005, p. 142, dopo aver diffusamente trattato in via preliminare della nozione di identità riferita agli oggetti ordinari e reali: “In quanto configurazioni di momenti individualmente determinati, la struttura ‘persona’ emerge necessariamente come proprietà individualizzata. Non è possibile essere una persona senza realizzare un comportamento e manifestare
proprietà individualizzate”. Intendendo distinguere con vigore l’identità personale dell’individuo dagli oggetti materiali e dagli animali, nelle pagine conclusive l’autore sottolinea la struttura olistica
dell’identità: “in questa nozione entra sempre in gioco il tutto o l’intero di una entità, cui sono riferibili proprietà essenziali, costitutive dell’identità stessa in quanto proprietà dell’intero individuo (ivi,
p. 220, corsivo mio). La tripartizione natura materiale, natura animale e mondo spitrituale consente a A. Masullo, in Lezioni sull’intersoggettività. Fichte e Husserl, Editoriale scientifica, Napoli 2005,
p. 96, di specificare il concetto di persona secondo Husserl: “La costituzione del mondo spirituale
implica una presa di posizione personalistica, un punto di vista cioè rivolto all’oggettività degli oggetti, quale essa è in rapporto con l’ambiente culturale e quindi con la concreta intenzionalità di comunità storiche, là dove appunto l’io è persona e vive in un mondo personale, in quanto vive come soggetto nel mondo dei soggetti”. In stretta connessione al tema del mondo spirituale ed alla
sua costituzione specifica vengono, quindi, esaminate le nozioni di Einfühlung, solipsismo, intersoggettività (pp. 115 ss.). Per un valido approfondimento delle tematiche suaccennate, cfr. A. ALES
BELLO, L’universo nella coscienza. Introduzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Edith
Stein, Hedwig Conrad-Martius, ETS, Pisa 2003, in particolare pp. 124 -142 (il testo comprende altresì un’accurata bibliografia); si veda anche A. M. PEZZELLA, Edith Stein e la questione antropologica, in «Per la filosofia», n. 49, 2000. Sull’itinerario intellettuale e spirituale di Edith Stein, segnato dall’evoluzione dal metodo fenomenologico alla teologia cristiana, cfr. E. STEIN, La ricerca della
verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1997;
Id., Natura persona mistica. Per una ricerca cristiana della verità, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1997. L’itinerario formativo di Edith Stein è ripercorso da M. Paolinelli, in La ragione salvata. Sulla filosofia cristiana di Edith Stein, Franco Angeli, Milano 20077, in particolare nei capp.
VI-VII dedicati al rapporto tra filosofia e fede.
50 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 115.
51 E. STEIN, Fondamenti dell’educazione della donna, cit., p. 148.
52 E. STEIN, Problemi dell’educazione della donna, cit., p. 220.
53 A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, cit., p. 346.
54 Ibidem.
55 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, (Q 10, cap. II, § 54), in Id., Le opere. La prima antologia
di tutti gli scritti, a cura di A. A. Santucci, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 301. Per sottolineare l’intreccio tra politica e cultura nel pensiero gramsciano, così V. Gerratana ne Una lettera all’editore:
“Si potrebbe dire che la sua era una politica che si nutre di cultura, e una cultura che si nutre di
politica. Su questa base Gramsci dà le sue risposte ai problemi del suo tempo” (ivi, p. XII). L’edizione integrale dell’opera, raccolta in 4 voll., è ora in A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, ed. critica
dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 2007.
56 Ivi, pp. 302-303. Sul piano pedagogico tale posizione risulta così formulata: “La coscienza
del fanciullo non è alcunché di ‘individuale’ (e tanto meno di individuato), è il riflesso della frazione di società civile cui il fanciullo partecipa, dei rapporti sociali quali si annodano nella famiglia, nel
vicinato, nel villaggio” (A. GRAMSCI, Per la ricerca del principio educativo, in L’organizzazione della
scuola e della cultura, cit., p. 136. La nota, contenuta nei Quaderni del carcere (Q 12, § 2), costituisce una sintetica trattazione critica del sistema italiano d’istruzione).
57 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 125. Sul percorso di crescita inteso come percorso
spirituale, cfr. E. Stein, La mistica della croce. Scritti spirituali sul senso della vita, a cura di W. Herbstrith, Città Nuova, Roma 19985, in particolare pp. 19-41.
58 E. STEIN, La vocazione della donna, in Id., La vita come totalità, cit., p. 116. Il saggio, risalente al 1931, costituisce il testo di una conferenza tenuta da Edith Stein nell’ambito di un congresso pasquale svoltosi in Baviera, organizzato dall’Associazione delle insegnanti cattoliche.
73
Cfr., infra, la nota 29.
E. STEIN, La vocazione della donna, cit., p. 114.
61 E. STEIN, Sull’idea di formazione, cit., p. 34.
62 E. STEIN, Fondamenti dell’educazione della donna, cit., p. 144.
63 Cfr. E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., § III (Attività della donna), pp. 125-131. In tale conclusiva sezione del saggio, l’autrice procede ad una limpida esposizione delle attività professionali considerate propriamente femminili.
64 Cfr. E. STEIN, Vocazione dell’uomo e della donna secondo l’ordine della natura e della grazia, in Id., La donna, cit, pp. 67-99. Il saggio, al quale è stata attribuita la data del 1931, esamina
nella parte iniziale la valenza polisemantica del termine Beruf sulla base di argomenti filologici.
65 Gv 10, 10.
66 E. STEIN, Verità e chiarezza nell’insegnamento e nell’educazione, cit., pp. 42-43.
67 A. GRAMSCI, L’alternativa pedagogica, cit., pp. 3-4.
68 Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., Q 11.
69 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere (Q 12, § I), in Id., Nel mondo grande e terribile. Antologia
degli scritti 1914-1935, a cura di G. Vacca, Einaudi, Torino 2007, p. 265.
70 A. GRAMSCI, L’alternativa pedagogica, cit., p. 12.
71 A. GRAMSCI, Per la ricerca del principio educativo, cit., p. 142.
72 A. GRAMSCI, La scuola di partito, in Id., La formazione dell’uomo. Scritti di pedagogia, cit., p.
138. L’articolo, apparso sulla rivista «L’Ordine Nuovo», di cui Gramsci è stato con Togliatti uno dei
fondatori nel maggio del 1919, reca la data 1 aprile 1925.
73 A. GRAMSCI, Nel mondo grande e terribile, cit., p. 281. L’uomo collettivo non è che l’espressione di una “volontà collettiva” (ibidem).
74 Per non incorrere nella censura, per assecondare altresì il giudizio morale di alcune interpreti, lo stesso Ibsen compose un finale alternativo onde evitare liberi adattamenti suggeriti dai registi del suo tempo. Helmer: Bene, allora va. Ma prima devi vedere i tuoi figlioli per l’ultima volta!
Nora: Non li voglio vedere! Non li posso vedere! Helmer: […] Domani, quando si svegliano e chiamano la mamma, domani sono orfani. Nora: Orfani! Commetto peccato contro di me, ma non li
posso abbandonare. (Il testo è tratto da H. IBSEN, Casa di bambola, cit., Appendice, p. 186).
75 Cfr., infra, la nota 4.
76 H. IBSEN, Casa di bambola, cit., pp. 170-171.
77 Nella trad. it. di E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 104, il termine ‘miracolo’ è reso con
l’espressione ‘la cosa meravigliosa’.
78 Il momento di “supremo disinganno” (ivi, p. 105), in cui Nora avverte con crescente sgomento un senso di estraneità rispetto al coniuge, è introdotto da un dialogo anfibologico: il dramma interiore di Nora non è compreso da Helmer se non come una farsa artificiosa. Helmer: Disgraziata…cos’hai fatto? Nora: Lasciami andare! Non devi scontare tu per me. Non addossarti tu la colpa! Helmer: Non facciamo la commedia! Adesso rimani qui e rispondi. Hai un’idea di ciò che hai
fatto? Rispondi! Ne hai un’idea? Nora (lo guarda fisso e parla irrigidendosi): Sì, adesso incomincio a capire. (ivi, p. 154).
79 Sul concetto di miracolo, riferibile sia al corso degli eventi naturali, sia ai mutamenti interiori per effetto della grazia divina, cfr., E. STEIN, Sull’idea di formazione, cit., p. 34. “Dio può trasformare la natura e influenzare così dall’interno il processo formativo in un modo che, dall’esterno, risulta sorprendente, stupefacente, innanzitutto per colui che di tale mutamento è oggetto” (ibidem).
80 A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, cit., p. 346.
81 Ibidem.
82 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 108.
83 Ibidem.
84 A. GRAMSCI, Democrazia operaia, in Id., Le opere. La prima antologia di tutti gli scritti, cit.,
pp. 63-64. L’articolo, pubblicato sulla rivista «L’Ordine Nuovo» il 21 giugno 1919, è stato definito
dallo stesso autore – in un successivo articolo del 1920 dal titolo Il programma dell’Ordine Nuovo
– “un colpo di Stato redazionale”, in quanto pone l’accento sulla necessità in Italia di una vasta
azione di propaganda rivoluzionaria a vari livelli, sull’esempio della rivoluzione bolscevica.
85 A. GRAMSCI, Letteratura e vita nazionale, cit., p. 344.
86 Ivi, p. 345.
87 Ivi, p. 346.
59
60
74
Ibidem.
A. GRAMSCI, Utopia, in Id., Le opere. La prima antologia di tutti gli scritti, cit., p. 57. L’articolo, pubblicato in «Avanti!», è datato 25 luglio 1918.
90 A. GRAMSCI, Il nostro Marx, in Le opere. La prima antologia di tutti gli scritti, cit., p. 49. L’articolo, datato 4 maggio 1918, è stato pubblicato in «Il Grido del Popolo», per celebrare il centenario della nascita di Karl Marx.
91 Nel già citato articolo del 1920, Il programma dell’Ordine Nuovo, in A. Gramsci, Le opere. La
prima antologia di tutti gli scritti, cit., pp. 103-104, l’autore precisa al riguardo, con intento polemico nei confronti dei compagni dissidenti tra cui Tasca: “Perché gli operai amarono l’Ordine Nuovo?
Perché negli articoli del giornale ritrovavano una parte di se stessi, la parte migliore di se stessi;
perché sentivano gli articoli dell’Ordine Nuovo pervasi dallo stesso loro spirito di ricerca interiore:
«Come possiamo diventar liberi? Come possiamo diventare noi stessi?»”.
92 Il saggio, testo della conferenza tenuta il 5 gennaio 1933 nell’ambito del congresso del Deutsches Institut für wissenschaftliche Pädagogik, è in E. STEIN, La vita come totalità, cit., pp. 209229.
93 L’enciclica sull’educazione cristiana della gioventù è stata composta da Pio XI.
94 E. STEIN, Formare la gioventù alla luce della fede cattolica, cit., p. 214.
95 Ivi, p. 210.
96 Ivi, p. 211.
97 Ivi, p. 226.
98 Ivi, p. 219. Così seguita il passo citato: “Ma egli è padrone di sé soltanto per consegnarsi a
un altro padrone, al suo Padrone, Dio”.
99 E. STEIN, Vita muliebre cristiana, cit., p. 105.
100 E. STEIN, Formare la gioventù alla luce della fede cattolica, p. 221.
101 E. STEIN, Sull’idea di formazione, cit., p. 29.
102 Sal 62, 2.
88
SAGGI
89
75
NEL MAGMA DELL’ESISTENZA.
UN PERCORSO TEORETICO AL SEGUITO DI M.
CONCHE
di Santo Arcoleo
76
Le suggestioni del recente saggio di Marcel Conche1 si collegano a vari momenti ed a diversi aspetti della sua biografia umana ed intellettuale, obbediscono a differenti registri e toccano le corde di una profonda interiorità, da cui
emerge solida la statura e la personalità dell’autore.
Sullo sfondo gli Essais di Montaigne si rivelano, senza dubbio, guida privilegiata («Descartes è invecchiato, Montaigne è sempre così giovane»2) in questo lungo, faticoso, ma affascinante percorso di vita, vero “breviario laico” di
questo pensatore senza tentennamenti, che se ha attinto dall’opera montaigneana ispirazione e rigore, ha contribuito, forse più di ogni altro, a renderne
attuali i risvolti e le riflessioni.
Questo saggio si può considerare anche quasi un giornale intimo, nato dal
“cammino verso le proprie origini in alcuni giorni, senza premeditazioni né seguito”, ed è tanto più apprezzabile quanto più va oltre le mode o le suggestioni dell’immediato.
Conche non si rivolge pateticamente al passato e non insegue il fascino o
il richiamo temporis acti: le sue riflessioni o la sua presa di coscienza sono talmente ricondotte all’attualità e alla quotidianità da risultare, soprattutto per il futuro, fonte indispensabile per quanti tenteranno una ricostruzione storico-teoretico-psicologico-sociale del nostro presente.
L’opera comprende ben LXXXIV riflessioni, per lo più enunciate in qualche
pagina; solo il riferimento ad eventi, che consentono una maggiore conoscenza di momenti personali o che li caratterizzano in modo emblematico, supera
le 5 pagine; la natura dello scritto richiede la brevità e la concisione, tanto più
difficili da rispettare quanto meno banali sono gli argomenti trattati.
Per comodità consideriamo l’opera suddivisa in tre grandi tematiche: a) richiamo ad eventi che trattano il vissuto biografico e ne mettono in luce i risvolti caratterizzanti; b) riproposizione di episodi che enunciano riflessioni filosofiche, in un contrapporsi dialettico fra il passato ed il presente; c) enunciati e tesi di carattere storico-politico-religioso che esplicitano l’interesse e l’attenzione
per gli avvenimenti che scuotono la vita contemporanea. Questi elementi si intersecano fra loro ed evidenziano anche un respiro letterario che ben si “converte” con la trattazione filosofica.
M. Conche è un uomo gaio, sensibile, pronto alla battuta caustica; negli incontri è molto compito e ama ascoltare più che parlare. È l’erede della saggezza di Socrate, degli Scettici, di Montaigne: l’adagio “vivi nascosto” si addice alla sua persona. Non ama il proscenio e con molta difficoltà si lascia persuadere a partecipare ad incontri o dibattiti in cui è al centro dell’attenzione; la prima
La vera vita non vuole la felicità ma si allontana dalla felicità […]. La scelta delle saggezza tragica non è una conseguenza necessaria né della
metafisica del non essere né della metafisica della natura. Per Conche la
saggezza è libera. Implica un salto fuori dalla filosofia, che può essere
compiuto solo nella e per la libertà.
Bisogna scegliere come vivere. La scommessa tragica è una scelta fra il
razionale e il ragionevole; è la scelta di Conche, la scelta del filosofo. Resta aperta la questione, qualsiasi decisione si prenda. Questo spirito libero potrà ancora sorprenderci?4
In effetti questo “strano giornale” – così suona il sottotitolo: bilancio ed
esposizione di alcuni momenti importanti del secolo appena trascorso e dei primi anni del nuovo –, può suscitare una certa sorpresa per il metodo con il quale l’Autore ci conduce a ripercorrere il lungo cammino della sua complessa esistenza, all’interno della non semplice realtà nella quale è vissuto e vive. Nelle
significative osservazioni dedicate alla vecchiaia, nella riflessione XXXI “Si l’on
est vieux”5, si legge: «se si è vecchi, lo si è per gli altri… La vecchiaia non s’annuncia. Arriva insensibilmente. Per conoscerla bene, occorre che Io ricordi chi
ero. Le emozioni erano più forti, più vive ed avevano, in più, gravi conseguenze. M’indignavo con tutte le mie forze, ero in collera, con lo spirito correvo alle
barricate; mettevo continuamente alla prova il mio spirito prudente. Sono giunto sino ad impegnarmi sconsideratamente? Sì, a due o tre riprese: ma non ritenevo necessario che lo si sapesse». La vecchiaia trasforma inesorabilmente
il sentire esperienziale, le qualità del corpo, che pur restano fondamentali per
le relazioni con gli altri. Ma non trasforma lo spirito, l’anima filosofica «è con la
serietà più profonda che accolgo un’anima filosofica, la ascolto e cerco di essere capace della parola che la sveglierà, che la eleverà maggiormente e la
renderà migliore». Questa attitudine socratica, questa maieutica intesa come
vocazione e dedizione alla verità, sorregge la più recente fatica di Conche, cronaca filosofica della vita ordinaria di un filosofo, ma soprattutto manuale e guida al difficile mestiere di vivere.
Di queste “riflessioni”, la prima “Si ma mère eût vécu” e la seconda “Si la
guerre de 1870 n’eût pas lieu”6 sono dedicate al ricordo della madre e del padre, la prima deceduta poco dopo il parto e il cui ricordo d’amore si prolunga
nella presenza di un’assenza, mai del tutto irragiungibile, ma reinventata, ricreata e rievocata nella figura di Marceau (Marcella era il suo nome) nella più
assoluta fedeltà e senza cadere mai nella finzione (i brani dedicati a questo
amore-dolcezza sono numerosi); il secondo, quantunque lontano, severo, distaccato, considerato un esempio fortificante, che (lo) ha trattenuto da ogni cedimento o debolezza7i; i suoi crudi racconti sulla vita di trincea e le drammatiche vicissitudini del dopo guerra hanno rafforzato il pacifismo, vocazione perseguita e rivendicata in molte pagine8:
SAGGI
editrice delle sue opere, fino agli anni ’80, è rimasta nascosta e lontana, sconosciuta rispetto a quelle più famose. Pilar Sánchez Orozco, che ne ha tracciato una pregevole monografia3, sottolinea, nella sua appassionata trattazione, che si potrebbero mettere in bocca a Conche le parole di Nietzsche:
77
Kant mi forniva una formula per ciò che io avevo già in me in tutta evidenza. Perché da sempre mi sembrava chiaro che appartenesse ad ogni
uomo chiamato a combattere dire no a quest’assurdità, dunque sottrarsi
all’arruolamento, e al preteso “dovere”, che nulla ha a che fare con il dovere morale 9.
Questi motivi ricorrono nelle riflessioni XXII “Si mon père avait été mon confident” e X “Si j’avais eu le sentiment d’avoir quelque dette”10 in cui si enunciano le tesi fondative del pacifismo, solidamente radicato nella realtà contadina.
Il mondo contadino che ho conosciuto viveva nella rassegnazione […] Prima non diceva mai “no” allo stato, alla chiesa, alle istituzioni, agli ordini venuti dall’alto […] Io non sono un contadino come gli altri. Non avendo mai
creduto che il crimine collettivo fosse giustificato, ho detto “no” alla guerra
e quando dico “no” è “no”. Il mio atavismo si traduce in me in un pacifismo
radicale. Mi sento enormemente distante dai filosofi piccolo borghesi dell’ambiguità. Sartre, Merleau-Ponty mi hanno deluso nel 193911.
78
Altri familiari – la nonna e le zie materne – sono ricordate a grandi linee e
in funzione del loro ruolo affettivo, mentre per il ruolo formativo, accanto ai
classici del pensiero, concorrono le dottrine e gli scritti di Schopenhauer, Marx,
Nietzsche, Lenin, Lagneau, Bergson, Alain, Cavaillès, Nizan e, a vario titolo, i
protagonisti della cultura del periodo della seconda guerra mondiale, dall’estero Aron e Wahl, dalla Francia – spesso mettendo in pericolo la propria vita –,
Canguilhem, Desanti, Vernant, Politzer, Lautman, cui si aggiungeranno nel
tempo, E.Weil, Belaval, Bouveresse ed i tanti filosofi di nazionalità non francese che spesso incontriamo nelle sue opere, fra di essi Heidegger12. All’interrogativo se i “filosofi resistenti” abbiano agito da filosofi, risponde chiaramente:
«certamente erano partecipi di uno spirito di libertà inseparabile dalla filosofia.
In più c’era una antinomia tra la filosofia, dedicata in quanto tale all’universale,
e l’ideologia nazista, nemica di ogni forma di universalità»13.
Le annotazioni biografiche non seguono la cronologia degli eventi ma si coniugano in un’ampia visione della storia e della ricerca filosofica, perché «se si guarda alla storia (Geschichte) come luogo degli eventi di consistenza debole, dei
quali il tempo ha rapidamente ragione e che lascia andare verso il nulla, non si
può che inchinarsi all’indifferenza nei confronti dell’agitazione degli uomini e delle
assemblee, dei sommovimenti diversi e delle guerre… Al filosofo si chiede di essere anistorico e di riflettere astrattamente sulla propria situazione concreta». La
filosofia non genera la violenza, che le è incompatibile, essendo la violenza nonfilosofia. «So bene che la filosofia non mi avrebbe portato alla violenza contro l’occupante, ma solo al vivo desiderio che abbandoni il suolo di Francia»14.
La biografia umana-intellettuale di Conche si compie con l’incontro con la moglie, Marie-Thérèse, Mimi nel linguaggio affettuoso, al cui ricordo l’Autore ha dedicato le delicate pagine di Ma vie antérieure15, nelle quali vivi sono l’atmosfera
e la rievocazione dei momenti dell’incontro e della loro vita felice. A questa felicità Conche fa allusione nella riflessione XXIII “Si je veux être heureux”16, che descrive una delle giornate di Mimi, ormai fragilizzata dalla malattia. Il ricordo è in-
Essere un grande filosofo o essere un vero filosofo sono due cose differenti. Che un filosofo sia grande lo si vede dalla sua influenza e da essa
si può immaginare una misura oggettiva: il numero di libri o di articoli che
gli sono dedicati. Ma misurare l’influenza di un filosofo ha un interesse
preminentemente sociologico […] Per il filosofo “vero” non ci si preoccupa che della verità, le credenze collettive sono lettera morta […] Se un filosofo è “grande”, lo si può apprezzare obiettivamente. Se è “vero”, non
lo si può apprezzare obiettivamente. Perché il giudizio che si porta su un
filosofo come essente, realmente o meno un filosofo, dipende dalla propria filosofia […] Direi che Bergson mi sembra un filosofo più “reale” o più
vero di Husserl e di Heidegger, perché ha primieramente il senso della
verità come io la intendo, ossia del discorso che si deve fare riguardo al
Tutto della realtà.
Ma che sia fra i filosofi del secolo scorso il più vero non impedisce che
sia il più grande, se si considera la sua grandezza per il numero delle tesi, delle memorie, degli articoli o dei libri dedicati a lui. Pertanto c’è qui un
criterio incerto. Tuttavia, teniamo conto che è il più vero, e si potrà dire
che è il più grande, ma in senso filosofico19.
Compito del filosofo è anche il tentativo o lo sforzo di entrare in sintonia con
i classici del passato ai quali chiedere una risposta sullo stato presente della
filosofia la quale, come alle origini, “parla in greco”20 ed è con le categorie e le
coordinate razionali del pensiero greco che bisogna affrontare i problemi della
filosofia, dedicandosi, come già nel pensiero greco, all’analisi della Natura21,
nella sua immediatezza e fluidità. «Perché la filosofa non è storia, ma risposta
personale all’enigma del mondo e della vita che ci assilla tutti i giorni, anche se
noi non lo vogliamo sapere»22.
SAGGI
tatto, meticoloso oserei dire e ripercorre tutte le incombenze di un giorno passato al capezzale della malata; riaffiorano sentimenti delicati che si manifestano nei
vari momenti della settimana e si concludono nella sera serena della domenica:
«la domenica sera guardavamo un film, spesso un poliziesco, che non divertiva
che me, ma Mimi era felice di essere accanto a me, al cinema»17.
Questo saggio ripropone ricordi, ma l’Autore non vive per essi. Nelle imprescrutabili vie del destino, due figure si stagliano oltre la quotidianità e l’effimero, oltre l’egoismo e la dedizione: Marceau e Mimi, figure che a diverso titolo
ne influenzano e illuminano il cammino. Questo filosofo schivo con questo
scritto sembra aver superato e lasciato da parte anni di silenzio e di solitudine
volontaria, per gridare con il suo gesto d’amore il valore ed il significato di ciò
che è puro, trasparente, luminoso. Guardando una fotografia che ritrae Marceau “seria” auspica, lui agnostico, di poterne finalmente vedere, nell’eterno, il
sorriso, mentre Mimi resta «inseparabile dal mio essere ed anche dalla conoscenza che ho di me stesso, perché per lei sola io sentivo di essere veramente quello che sono, gli altri mi vedono solamente per qualche aspetto… Mimi
non può essermi portata via, perché è della stessa mia sostanza. Al contrario,
mia madre non mi è mai stata data»18.
Le riflessioni prettamente filosofiche muovono dalla contrapposizione fra
“grande” e “vera filosofia”:
79
80
Conche si rivela anche “poeta della Natura” che, con metodo sicuro ed appassionato, descrive in molte pagine, ricordando lo “stupore” di Mimi, davanti
ai pini, al castagno, ai fiori, alle nocciole, ai prugni, alle nespole, all’“albero dei
filosofi”, amorosamente accuditi nell’appezzamento di Tréffort; ed è anche la
sinfonia odorosa delle composizioni floreali, l’odore delle rose sotto le finestre
e la tavola apparecchiata secondo un gusto ed un’abitudine atavica che ci conduce al di là di ogni analisi teorica della Natura, avvertendo che «la scienza è
principio d’illusione, per quanto i sapienti si abbandonino a credere che essa
offra loro, più che visioni limitate, il Reale stesso, la Natura infinita, assolutamente irriducibile alla conoscenza»23.
Per tutto il corso della sua “vita vivente” Conche ha voluto aggiungere qualcosa al mondo, con l’insegnamento, la pubblicazione di opere, l’amore; ha comunicato verità che non sono tramontate con gli anni perché la fiamma e la verità del suo pensiero illuminano potentemente la realtà presente. Alla filosofia
ha affidato anche un alto messaggio morale che, prendendo le mosse dalla
teodicea, si estende ai problemi della giustizia, in rapporto al soggetto e alla
società, alla guerra e al militarismo, tenendo presenti i doveri-diritti dell’individuo e la violenza dell’oppressione sociale, espressa con accenti di grande severità nei confronti dell’ingiustizia contro l’infanzia. «Il cuore s’indurisce non diciamo per il peccato, trasgressione della legge divina, ma per la colpa, trasgressione della legge morale. Il cuore del soldato s’indurisce perché il soldato uccide. Consiste in questo il fatto che gli umani perdono ai suoi occhi, il carattere umano e non sono che oggetti»24.
Conche non è un filosofo politicamente engagé e tuttavia le non poche riflessioni politiche, enunciate in queste pagine, sono dettate dalla sua concezione olistica dell’uomo, in cui non è possibile separare la politica dall’etica.
Le sue prese di posizioni contro l’assolutismo e la tirannia, già conosciute, si
condensano nella Riflessione LXXXIV “Si La Boétie revenait parmi nous”25,
nella quale è analizzata la tirannia, non quella del potere statale – quasi
scomparsa – ma quella delle abitudini, particolarmente evidente nella prassi
tirannica delle forze armate. «Tutta l’armata funziona tirannicamente […] gli
uomini sono talmente abituati ad obbedire che si sono visti dei soldati commettere i peggiori abominii perché erano stati comandati […]. L’obbedienza
è il primo dovere del soldato». Tirannie sottili, fondate sul “dovere” e sulla
psicologia del terrore, talvolta si convertono nella abbacinante idea di un dovere religioso, che non di rado inganna le coscienze. «L’equipaggio del bombardiere B 29, che fece cadere la bomba “Fat Man” su Nagasaki, era stato
benedetto dal cappellano della base di Tinian […] Truman, a sua volta, aveva ringraziato Dio […]. È veramente stupefacente il grado di falsità a cui può
giungere l’uomo».
La preoccupazione per la Costituzione europea, che agita politici, faccendieri, sindacati, media, è lo schermo che oscura preoccupazioni più profonde,
esigenze vitali.
Che importa l’Europa quando la volontà d’Europa non è che la volontà di
potenza, volontà che l’Europa sia un blocco potente di fronte a due blocchi potenti… Quando la storia si accanisce a staccarci dalla nostra esistenza quieta,
unisce razionalità ed irrazionalità. Mescola giudizio dogmatico e giudizio
propriamente morale. Ha sempre preso il partito dei deboli, dei sofferenti, degli affamati […]. Ha condannato le guerre, la guerra del Kuweit, la
guerra dell’Irak; ha denunciato e compianto l’oppressione del popolo palestinese… Le guerre hanno continuato come prima sotto il suo pontificato […]. Il papa ha creduto nell’uomo creatura di Dio, nell’uomo divino. Per
quanto illusoria sia stata la sua fede nella sua espressione fantastica e
simbolica, in sostanza, nella sua sostanza umana, era vera. Il papa Giovanni Paolo II è vissuto nella verità27.
La riflessione sul religioso sembra risentire della tradizione hegeliana quando afferma che «la religione non esiste che come fede collettiva, che va da sé,
puramente ingenua ed irrazionale. Non è ancora arrivato il momento della riflessione»28. Sembra importante sottolineare che tutto ciò che si connette con
la religione si rivela nella gioia della tradizione collettiva: il prete, il matrimonio,
l’amicizia fra famiglie, i battesimi, le cresime, le festività in genere sono manifestazioni della gioia di vivere, di quella felice ignoranza che fa da collante al
sentimento religioso29.
La filosofia è vocazione alla felicità.
È legata all’esercizio, al funzionamento stesso della ragione. L’incapacità
degli umani per la filosofia, che è assai generale, è dovuta al loro poco interesse per la verità, quando non è considerata che per se stessa, al di fuori di ogni
servizio. Ognuno è preoccupato per ciò che si collega ai propri progetti ed ai
significati che lo riguardano, molto sussidiariamente al grande problema del significato dell’uomo, ed è accaduto spesso perché la religione, avendogli dato
la risposta, gli risparmia di porsi il problema30.
SAGGI
è necessario scendere nell’arena e giocare il nostro ruolo, ricordandoci che
siamo cittadini e che abbiamo dei doveri verso lo stato ed i suoi figli26.
Il primato dell’etica investe non solo la prassi politica ma anche il sentimento religioso; Conche focalizza il suo interesse verso la tradizione cattolica, nella quale distingue le luci e le ombre che hanno accompagnato il pontificato di
Giovanni Paolo II, con il quale si dichiara d’accordo, “non proprio in ogni caso”.
Il Pontefice
81
82
1 M. CONCHE, Avec des «si». Journal étrange, PUF, Paris 2006, 340 pp. L’Autore illustra, in poche battute, il significato fondamentale di questo scritto, quando afferma: «vedete questi Avec des
“si”: si tratta di piccoli sviluppi che presuppongono soltanto, ciascuno, che io mi conceda qualche
ora di vita. É forse questa una debolezza, cioè il non impegnarsi in un compito che supporrebbe
che io viva dei lunghi anni? Non lo credo: una tale restrizione dell’attività è ragionevole; perché è
ragionevole mettere dalla propria parte le più grandi chances di dare significato a ciò che si fa conducendolo in porto» (p. 112). Fra i filosofi francesi contemporanei Marcel Conche é uno dei più importanti. Professore ordinario di Filosofia all’Università Paris I – Pantheon, professore emerito della medesima università, membro corrispondente dell’accademia di Atene, laureato dell’Académie
française ha sviluppato un coerente sistema filosofico nel quale ha posto le basi per un rinnovato
significato della Natura, muovendo dall’analisi delle esperienze esterne ed interne dell’uomo. Ha
approfondito i sistemi filosofici più compiuti del mondo antico, del mondo moderno e di quello contemporaneo, formulando una interessante dottrina antropologica nella quale sottolinea il primato
della problematica morale. Alcune sue opere sono state tradotte in inglese, spagnolo, polacco; non
esiste, per il momento, alcuna traduzione italiana.
2 Ivi, p. 64.
3 P. SÁNCHEZ OROZCO, Actualité d’une sagesse tragique. La pensée de Marcel Conche, Les Cahiers de l’Egaré, Le Revest-les-Eaux 2005.
4 M. CONCHE, Avec des «si». Journal étrange, cit., p. 321.
5 Ivi, pp. 131-134.
6 Ivi, pp. 9-12 e pp. 13-16.
7 Cfr. ivi, p. 12.
8 Nella Riflessione LIV “Si Georges Krassovsky me surprend” (ivi, pp. 225-227), afferma: «è
noto che mi sono ben guardato dall’impegnarmi nelle azioni violente che la Seconda guerra mondiale implicava. Ciascuno deve essere, quatomeno, pacifista per proprio conto». E nella riflessione LXVII “S’il est une chose certaine” (ivi, pp. 277-279) precisa che alla domanda: «conviene combattere un regime totalitario, ingiusto e sterminatore… con la guerra o con un altro modo?» occorre rispondere: «con un altro modo… La debolezza della posizione del pacifista è tutta qui. Egli sa
che la massima della sua inazione è universalizzabile, nel senso kantiano: se tutti gli uomini – amici e nemici – rifiutassero la guerra, la guerra non avrebbe luogo».
9 Ivi, p. 16. Cfr. l’episodio, un po’ rocambolesco, del suo mancato arruolamento nel 1944, esposto nel capitolo 7 “Si je n’avais pas été si fort emmailloté” (pp. 35-36).
10 Ivi, pp. 87-93 e pp. 41-43.
11 Ivi, pp. 129-130.
12 Oltre ai saggi: Heidegger résistent ed Heidegger inconsidéré, pubblicati per le éd. de Mégare, rispettivamente nel 1996 e 1997, e a numerosi riferimenti nelle varie opere, cfr. la Riflessione
LII (M. CONCHE, Avec des «si». Journal étrange, cit., pp. 217-219) dal titolo “Si Heidegger eût été
national-socialiste” che sottolinea che «quantunque fosse nazionalista, germanomaniaco e negatore dei valori della Rivoluzione francese, Heidegger realmente non fu affatto nazista». E, nella Riflessione XLIII “Si l’histoire est aussi verité” (ivi, pp. 179-183), continua: «nessuno fra gli intellettuali tedeschi più autenticamente filosofi, quali Hartmann, Gadamer, Husserl, Jaspers, Theodor
Litt, si impegnò in una resistenza attiva, quale che fosse la loro ostilità al regime nazista. Heidegger si impegnò ma su di un errore di interpretazione del fenomeno nazista… non fu nazista, la sua
adesione al partito fu puramente formale».
13 Ivi, p. 182.
14 Riflessione XLIII “Si l’histoire aussi est vanité” (ivi, pp. 179-183). Cfr. anche la Riflessione
LXVIII “S’il y a un sens de l’histoire” (ivi, pp. 281-283).
15 M. CONCHE, Ma vie antérieure, postf. par C. Collobert, Encre marine, La Versanne 1998.
16 M. CONCHE, Avec des «si». Journal étrange, cit., pp. 95-102.
17 M. Conche è un amatore appassionato di cinema: le sue attrici preferite sono Greta Garbo
e Eva Marie Saint. Per la Garbo cfr. la Riflessione XXV “Si elle est celle que l’on peut rencontrer”
(ivi, pp. 107-110); per la seconda, la Riflessione LVII “Si Eva Marie Saint est ma préferée” (ivi, pp.
SAGGI
235-239). Cfr. anche la critica molto severa al film Hiroshima, mon amour nella Riflessione LXXIII
“S’il est un titre obscène” (ivi, pp. 299-302).
18 Riflessione LX “S’il faut que je m’explique” (ivi, pp. 249-251).
19 Riflessione XV “Et si Bergson était le plus grand” (ivi, pp. 63-65).
20 M. CONCHE, La raison philosophique vers son avenir grec, in ID. Quelle philosophie pour demain?, PUF, Paris 2003, pp. 73-113.
21 M. CONCHE, Présence de la Nature, PUF, Paris 2001. Sostiene Conche che si può ipotizzare un avvenire per la filosofia, se è conveniente pensare allo stesso modo dei Greci, ossia «pensando piuttosto che guardandosi pensare… allora la lezione degli Antescratici, e specialmente di
Eraclito, è quella che risponde alla “domanda filosofica” di oggi» (p. 26).
22 Riflessione XXVI “Si de ce que l’on fait il faut voir la fin” (M. CONCHE, Avec des «si». Journal
étrange, cit., pp. 111-113).
23 Riflessione LV “Si un savant veut philosopher” (ivi, pp. 229-231).
24 Riflessione L “Si l’humanité ne régresse pas en dureté de coeur” (ivi, pp. 207-211).
25 Ivi, pp. 333-336).
26 Riflessione XXXVIII “S’il est douceur plus grande” (ivi, pp. 161-164).
27 Riflessione XXXIII “Si un grand cadeau m’a été fait” (ivi, pp. 139-141).
28 Riflessione XIX “Si j’avais vécu au temps des Carolingiens” (ivi, pp. 77-79).
29 «La religione non esiste che come fede collettiva, che va da sé, puramente ingenua ed irriflessa. Ancora non si pensa. Il prete ha il rispetto che gli è dovuto. Celebra la messa nel tardo mattino, la messa cantata ed i Vespri la domenica. Insegna il catechismo ai bambini, visita i malati,
amministra i sacramenti; sotto il baldacchino che sostengono quattro uomini conduce le processioni. Dal pulpito la domenica richiama ognuno ai propri doveri, soprattutto gli sposi. I legami del
matrimonio sono perpetui. Se capita un adulterio per effetto del semplice gusto carnale, è punito
con la vergogna pubblica» (Riflessione XIX, ivi, p. 79).
30 Riflessione IX “Si j’avais eu quelque aptitude particulière” (ivi, pp. 39-40).
83
K E LA NON-DOMANDA
di Filippo Palumbo
La risposta è sì!
Ma quale sarà mai la domanda?
84
Nel 1920 Kafka scrive un breve racconto, L’esame, il cui protagonista è un
cameriere domestico che si ritrova senza lavoro e che passa le giornate a girarsi nel letto o a guardare dalla finestra. A volte però va alla taverna dove di
solito l’oste gli serve un bicchiere di birra amara e imbevibile. Ma un giorno, il
suo posto è occupato da uno sconosciuto; preso dallo sconforto il domestico
decide di andarsene. Imprevedibilmente, però il cliente gli fa segno e lo invita
a sedersi.
“Perché vuoi andartene? Siediti e bevi. Offro io”. Il cliente rivolge alcune domande al suo interlocutore, domande alle quali egli non sa cosa rispondere e
che per la verità neppure capisce: “Ora forse ti penti di avermi invitato. È meglio che vada”. Tuttavia, lo sconosciuto lo fa sedere di nuovo e dice: “Resta,
non è che un esame. Solo chi non risponde alle domande supera l’esame”.
Questo testo è fondamentale perché ci permette di accedere immediatamente ad uno degli aspetti più misteriosi della poetica kafkiana sul quale ci soffermeremo nelle pagine seguenti.
In Kafka, la domanda non cerca mai la risposta. La domanda non si propone né di soddisfare la curiosità di colui che la formula né di testare l’interlocutore. Nell’opera di Kafka, non si fa altro che domandare, esiste solo la necessità della domanda, di una domanda che tuttavia non ha alcun contenuto.
L’unico scopo della domanda è di poter essere formulata. Di conseguenza, essa non serve a nulla. È fine a se stessa. Ma se la domanda non serve a nulla
allora, quale è il senso dell’esame? L’esame messo in scena da Kafka è un
non-esame perché si sottrae alle nozioni di scopo, ragione e senso.
Come vedremo tra breve, la caratteristica principale degli scritti di Kafka, è
che, in essi, è del tutto superfluo cercare il senso nascosto o chiedere il “perché” delle cose in quanto le cose non hanno nessun senso e capitano senza
un motivo preciso.
Consideriamo La metamorfosi a titolo di esempio: come mostra Kundera
nell’Arte del romanzo, quando la mattina Gregor Samsa si sveglia e si ritrova
trasformato in un grosso scarafaggio, non si pone la domanda essenziale,
“perché mi capita tutto ciò”? È come se il tentativo di capire quello che gli succede fosse a priori inutile. Gregor ha una sola preoccupazione: «come poter
arrivare puntuale in ufficio in questo stato?». Gregor ha in testa solo l’obbedienza e la disciplina che la sua professione gli ha insegnato. Le circostanze
che hanno prodotto la sua metamorfosi in insetto rimangono sconosciute.
Perché Gregor si è trasformato in scarafaggio? Che cos’ha fatto di male?
Gregor si è trasformato in scarafaggio senza ragione.
SAGGI
L’invito a rendere ragione, il tentativo di stabilire il perché delle cose, la ricerca della verità nascosta degli eventi; nulla di tutto ciò ha diritto di cittadinanza nel mondo di Kafka. L’opera di Kafka è congegnata in modo tale che nessuna ricostruzione causale potrà mai spiegare perché le cose sono “così” – e
neppure questo è del tutto sicuro.
Come scrive Kundera, la kafkaità è la dimensione del «senza ragione», del
«senza perché», cioè dell’“è così”, anche se non c’è nessun motivo per cui
debba necessariamente essere così.
Per esempio, supponiamo che qualcuno aggiunga alla Metamorfosi un capitolo introduttivo in stile Harry Potter. La strega dice a Gregor: “se bevi questo
filtro ti trasformerai in scarafaggio”. Gregor non crede alle parole della strega e
beve il filtro magico. La mattina Gregor si sveglia e si trova trasformato in scarafaggio, ecc… È esattamente la stessa storia, nulla è stato modificato, non
una riga, non una virgola. Eppure non è più Kafka, perché i testi di Kafka si definiscono in base alla mancanza del nesso causale tra gli eventi. Kafka inizia
La metamorfosi a partire dal secondo capitolo. Infatti, manca il capitolo suscettibile di fornire la spiegazione causale di ciò che capita a Gregor.
Nel mondo di Kafka le cose funzionano secondo una logica diversa rispetto a quella causale. Il pensiero occidentale si fonda su un principio apparentemente molto semplice, che fu formulato da Leibniz nel XVII secolo. Si tratta del
Principio di ragione. Il principio di ragione dice che nulla esiste senza una ragione. In altri termini, tutto ciò che esiste ha una causa ed è sempre possibile
risalire dall’effetto alla causa che lo ha prodotto. L’uomo dei tempi moderni ha
bisogno di trovare il senso di tutto ciò che lo circonda, e considera vero o accettabile solo ciò che ammette una spiegazione razionale.
Come ricorda Heidegger nel suo saggio fondamentale dedicato a Leibniz,
l’uomo realizza la propria essenza attraverso un domandare che cerca il senso nascosto delle cose. “Noi non possiamo rimanere gli esseri che siamo, senza pretendere che ci venga fornita la ragione di ciò che siamo”. L’essenza dell’uomo, (Dasein) per Heidegger è la domanda. L’uomo è essenzialmente un
domandare che non si soddisfa di nessuna risposta dogmatica.
In Kafka però non abbiamo nulla di tutto questo. In Kafka, la richiesta di una
spiegazione razionale rimane lettera morta. La letteratura kafkiana distrugge la
pretesa tipicamente moderna in virtù della quale, per tutto ciò che accade è necessario fornire una ragione. Kafka costruisce un universo letterario in cui gli effetti sono separati dalle loro cause, nel quale è impossibile trovare il motivo che
ci permetterebbe di giustificare logicamente o razionalmente ciò che ci capita.
Nel Processo, ad esempio, due uomini qualsiasi e senza alcuna importanza
“sorprendono un mattino Joseph K. nel suo letto, gli dichiarano che è in arresto
e mangiano la sua colazione”. Perché Joseph K. è arrestato? Che cos’ha fatto
di preciso? In realtà, Joseph K. è arrestato “così”, senza ragione. Per quanto
egli cerchi di capire di cosa precisamente si sia reso colpevole, quale sia precisamente l’imputazione, il suo interrogare rimane senza risposta. Joseph K. cerca di risalire alla causa del suo arresto, dunque alla sua colpa. Ma in realtà la
sua unica colpa è proprio quella di essere stato arrestato. Joseph K. è arrestato perché è arrestato. La causa dell’arresto è l’arresto stesso.
85
86
Nel Castello, K. arriva in un villaggio in cui è stato “preso” come agrimensore a servizio del conte. Tuttavia, non esiste alcun documento ufficiale che
fornisca la prova del fatto che l’amministrazione del conte ha assunto un agrimensore. Joseph K. è “preso” ma non è assunto (analogamente nel Processo,
l’arresto di Joseph K. non comporta alcun dovere, alcuna restrizione significativa delle sue libertà. Joseph K. è arrestato ma è libero).
K. è un conformista. Ha ricevuto l’ordine di presentarsi al villaggio per entrare in servizio in qualità di agrimensore e vuole obbedire. Tuttavia, il problema è che quest’ordine non è mai stato formulato. L’autorità alla quale K. è soggetto, l’autorità senza nome che lo avviluppa nella tela trasparente della sua
burocrazia, emette degli ordini contradditori. Come obbedire ad un ordine contraddittorio? Se qualcuno ci dicesse: Uscite da questa stanza ma soprattutto rimanete seduti e non muovetevi, che cosa faremmo?
K. cerca di capire le ragioni della sua presenza al villaggio. Tuttavia, la domanda “perché sono qui?”, presuppone che K. sia stato altrove – oppure che
egli possa essere altrove. Eppure, K. prima del villaggio non è da nessuna parte. Egli non è e non è mai stato in nessun altro luogo se non in quello in cui si
trova nel momento in cui il romanzo inizia. L’esistenza di K. si giustifica solo in
base ad un hic et nunc che non ammette né prima né dopo. Di conseguenza,
chiedere le ragioni della sua presenza al villaggio è del tutto insensato. Analogamente nel Processo, il “perché sono arrestato?” che Joseph K. lancia all’indirizzo degli sconosciuti che penetrano, un mattino, nella sua camera, è una
non domanda, perché essa è motivata dal sospetto che in realtà le cose – al
suo risveglio – avrebbero potuto essere altrimenti. Ma in Kafka non esiste nessun “altrimenti”. Le cose stanno come stanno senza alcun motivo, senza alcuna ragione.
Come dicevo prima, noi siamo abituati a pensare in termini di causa ed effetto ad esempio, sappiamo che ogni volta che piove o nevica, esistono delle
ragioni meteorologiche precise che ci permettono di stabilire perché piove o
nevica. A tale proposito, numerosi commentatori di Kafka hanno sostenuto che
se l’agrimensore K. si trova al Castello o se Joseph K. è arrestato ci deve essere per forza un motivo. Secondo Max Brod, amico, erede e interprete di Kafka, Joseph K. non ama nessuno, non sa far altro che fornicare con le donne;
di conseguenza deve essere condannato à morte. La ragione per cui Joseph
K. è arrestato, secondo Brod, è che egli fornica con le donne. Se egli non avesse flirtato con Leni, o con le altre cameriere dei Giudici del Tribunale, non sarebbe stato tradotto in giustizia. Per Brod, il protagonista del Processo avrebbe potuto non essere arrestato ed è del tutto accidentale che lo sia stato. Tutto dipende dal fatto che si è comportato molto male. Non avrebbe mai dovuto
correre dietro alle sottane delle donne.
Come mostra Kundera, Brod è un uomo generoso pronto a sacrificarsi per
gli amici. A Brod noi dobbiamo l’opera completa di Kafka. È lui ad averla salvata da Kafka stesso il quale gli aveva chiesto di distruggere una buona parte
dei suoi scritti. Ma Brod purtroppo ha un piccolo problema. Non capisce nulla
di arte moderna e soprattutto non capisce nulla dell’arte del suo amico.
A Kafka, infatti, non interessa minimamente che Joseph K. sia colpevole o
La cosa strana è che quando uno si sveglia al mattino ritrova sempre le
cose alla stesso posto che avevano la sera. Eppure nel sonno e nel sogno uno si è trovato in uno stato essenzialmente diverso dalla veglia e
occorre un’infinita presenza di spirito per cogliere tutto, nell’aprire gli occhi, allo stesso posto dove uno le ha lasciate la sera prima.
Il processo è come spiega Roberto Calasso, la storia di un risveglio forzato. “Joseph K. è colui per il quale più nulla tornerà al suo posto”. Gli sconosciuti che penetrano nel suo appartamento, lo sorprendono nel sonno, il mattino,
al momento del risveglio e lo alienano, letteralmente gli fanno subire l’Entfremdung. Lo rendono estraneo a se stesso, gli fanno perdere il contatto con la sua
origine, con la sua ragione di essere. È necessario tuttavia precisare che non
abbiamo a che fare all’“estraniazione” concepita in quanto processo progressivo, polarizzato verso uno scopo qualsiasi (economico, politico, ecc…); quello
che è in gioco nel Processo è piuttosto la forma compiuta dell’alienazione, il
suo risultato finale. L’esistenza “precedente” di Joseph K., è cancellata, il suo
SAGGI
innocente oppure che si sia macchiato del grande crimine di fornicazione. Nel
Processo come in altri scritti, Kafka si preoccupa piuttosto di costruire un mondo in cui non si può mai risalire dall’effetto alla causa. Nel mondo dell’autore,
abbiamo l’effetto ma non abbiamo mai la causa che lo ha prodotto. Kafka singolarizza l’effetto e lo libera dalla necessità della relazione causale. Qualunque
sia la causa, l’effetto rimane sempre uguale a se stesso perché ha un’esistenza indipendente, autonoma. In altre parole, Joseph K. è arrestato perché è arrestato, indipendentemente dalle circostanze esterne. Che egli abbia commesso o meno un crimine poco importa. Che abbia fornicato o meno, non è certo
questa la preoccupazione dell’autore. In Kafka, se piove, non è perché il vapore acqueo condensato cade dalle nuvole, sotto forma di precipitazione. Che ci
siano le nuvole o il sole o che non ci sia nulla, piove e basta, senza nessuna
ragione precisa, determinabile, quantificabile. Nel mondo di Kafka la proposizione per cui a cause diverse corrispondono effetti diversi è falsa. L’effetto è
autonomo e produce se stesso senza bisogno di una causa esterna.
C’è una parola tedesca che descrive perfettamente questa situazione. Si
tratta del termine Entfremdung. È una delle parole che si incontrano più spesso in Kafka, “Entfremdung” viene dal verbo Entfremden che in italiano significa “rendere estraneo”, alienare, perdere il rapporto con l’origine, cioè dimenticare la propria essenza, la propria ragione di essere, la propria causa. Ma esso significa anche sorprendere. L’alienazione in Kafka è sempre associata ad
un certo coefficiente di sorpresa.
Per esempio, nella versione iniziale del Processo, Kakfa aveva incluso alcune righe – che furono poi tolte dal testo pubblicato – in cui il rapporto tra i
due significati del termine Entfremdung (sorpresa e alienazione) appare chiaramente. Facciamo riferimento alla scena iniziale, quando Joseph K. inizia a
parlare con le guardie che lo arrestano. Allora egli ricorda che qualcuno un
giorno gli ha detto che il risveglio è il momento più rischioso. È il momento della sorpresa e se per qualche miracolo uno riesce a superarlo senza essere trascinato via dal suo posto allora può stare tranquillo per tutta la giornata.
87
88
cervello “formattato” – nello stesso modo in cui si potrebbe formattare il disco
fisso di un computer – e ri-programmato in funzione del processo che un’organizzazione misteriosa gli farà subire. Le cose per lui non sono più, per lo meno in linea generale, là dove egli le aveva lasciate la sera, prima di addormentarsi. Non esiste più nessuna “sera prima di addormentarsi”.
A partire dal momento del risveglio per Joseph K. essere in arresto, essere
l’imputato di un processo che è una specie di enorme campana di vetro calata sulla realtà per ridurla al silenzio, costituisce la normalità e non l’eccezione.
Si tratta di una seconda natura acquisita.
Ormai, l’unica ragione di essere, per il protagonista del Processo, consisterà nel farsi processare e sgozzare da una banda di sconosciuti. Joseph K. è
letteralmente avvolto dalla tela di ragno della Legge. Egli si lascia docilmente
aspirare all’interno di una macchina giudiziaria che trova in se stessa le ragioni e le garanzie del proprio funzionamento e che non ammette di essere giudicata dall’esterno, perché essa stabilisce a partire dall’interno di se stessa il proprio criterio di validità e di riuscita. Si tratta di una macchina che ingloba tutto.
Joseph K. non è altro che uno dei pezzi di questa macchina, di questo ingranaggio che si auto-programma, che si auto-corregge ed il cui unico scopo è
l’auto-conservazione.
All’interno della campana di vetro della Legge – nella sua “gabbia d’acciaio
per utilizzare un’espressione weberiana – la domanda circa la causa dell’alienazione, dell’Entfremdung non può essere formulata (è una non-domanda).
Cercare la causa dell’alienazione significherebbe rinchiudersi in un’aporia: si
dovrebbe infatti uscire dalla campana di vetro per poterne osservare il funzionamento dall’esterno e, nello stesso tempo, si dovrebbe rimanere imprigionati
all’interno.
Colui che riuscisse a penetrare nel “fuori” non sarebbe più alienato; di conseguenza, non potrebbe più assumere l’alienazione come oggetto della propria
indagine. Non potrebbe più conoscersi in quanto oggetto dell’Entfremdung.
Non ci sarebbe più nulla da conoscere. D’altra parte, colui che rimanesse invischiato irrimediabilmente nelle tela di ragno della Legge, si precluderebbe la
possibilità di conoscerla. Non potrebbe far altro che subirla, senza capirne il
funzionamento.
L’impressione generale che gli scritti di Kafka sembrano suscitare, è che
tutto si svolga a circuito chiuso. Nel mondo di Kafka non si diventa alienati. Lo
si è fin dapprincipio. L’alienazione non rinvia a un Io puro che si smarrisce nelle tenebrea della burocrazia labirintica del mondo moderno. L’alienazione non
è il luogo, oppure il paese straniero in cui ci si inoltra e ci si perde, ma l’elemento in cui si nasce e che ci costituisce. È il modo essenziale attraverso il
quale si prende coscienza di sé. Ciò che distingue Kafka dai surrealisti, o dal
teatro dell’assurdo, è che in Kafka l’alienazione non è qualcosa a cui ci si deve sottrarre, ma l’elemento attraverso cui ci si muove, ciò in cui si è “presi”,
“gettati” e soprattutto ciò da cui non si potrà mai uscire, in quanto come vedremo tra breve, il desiderio di un’esteriorizzazione integrale scatena forze che ci
spingono verso una regressione distruttrice (a tal proposito, si potrebbe sostenere che in Kafka, l’alienazione è una struttura regolatrice che sembra “lavora-
SAGGI
re” per il bene dell’uomo. Ad esempio, nel Processo, l’ispettore comunica a Joseph K. che egli è arrestato “per il suo bene”).
Come diceva Aristotele nel trattato Sull’anima, è difficile capire che cos’è
l’acqua quando si nuota da sempre nella stessa acqua. L’acqua è ciò che il pesce non vedrà mai. Perché il pesce vede grazie all’acqua, attraverso l’acqua.
Ma se si toglie l’acqua al pesce, questi non solo smette di vedere ma smette
anche di vivere.
Ritorniamo ai romanzi Il processo ed Il castello. Joseph K., cerca di ricostruire la catena logica degli eventi che spiegherebbero eventualmente perché
egli è “preso” come agrimensore nel bel mezzo di nessun dove. Joseph K., a
sua volta, cerca di capire il motivo del suo arresto. Entrambi sono come quel
pesce aristotelico che non conosce l’acqua in cui nuota e che tuttavia cerca di
uscire dal suo elemento per vederlo dall’esterno. Nel momento in cui formula
la domanda fondamentale “perché sono qui?” K. presuppone che avrebbe potuto restarsene tranquillamente a casa sua davanti alla tv con un sacchetto di
pop corn in mano invece di impegnare generazioni intere di ricercatori a riflettere sul suo caso.
Come dice Blanchot nell’Entretien infini, il domandare è ciò che rende le cose “possibili”, è ciò che le innalza drammaticamente verso la possibilità di essere altrimenti, di essere ciò che esse non sono. La domanda è apertura, ricchezza. In altri termini la funzione della domanda è precisamente di aprire la
dimensione del non essere, cioè della possibilità. In Kafka, come abbiamo potuto constatare, il domandare non apre nulla; anzi si trasforma nell’esperienza
claustrofobica dell’impossibilità di una risposta adeguata.
Per esempio, in uno dei suoi scritti più tardi, che si intitola Ricerche di un
cane, Kafka racconta la storia di un cane scienziato che conduce delle ricerche sul cibo. Il cane osserva che i suoi simili hanno l’abitudine di fare dei gran
salti per cercare di afferrare un tipo particolare di cibo che vola a mezz’aria - il
cibo inviato dall’alto, o cibo celeste. Il suo soggetto di ricerca consiste allora nel
determinare la causa in virtù della quale il cibo celeste viene dispensato ai cani. A tal proposito, il cane organizza diversi esperimenti. Dapprincipio si tratta
di stabilire se esiste un nesso logico tra le invocazioni e l’invio del cibo stesso.
Tuttavia, questo esperimento produce solo incertezza. Infatti, quando il cane
chiama il cibo rivolgendosi verso l’alto, i risultati sono insoddisfacenti: egli riceve raramente il cibo sollecitato. Il cielo non risponde alle sue domande. Solo il
caso sembra regnare. Tuttavia, non appena egli prova a ripetere la medesima
invocazione con la testa infilata in un buco scavato per terra, a quel punto, si
produce un fenomeno miracoloso: il cibo lo segue volteggiando a mezz’aria,
come se si decidesse infine a rispondere alla sua richiesta, come se aspettasse solo un segno per infilarsi nelle sue mascelle. Eppure, nel momento in cui
egli cerca di afferrare le delizie celesti, queste cambiano direzione e scappano. Il cane allora organizza un altro esperimento. Per costringere il cibo a scendere, si mette a digiunare. All’inizio del racconto si trattava di trovare la ricetta
per rendere la vita canina migliore attraverso il progresso della conoscenza.
Ma alla fine il cane si condanna all’isolamento ed alla morte di fame. Il digiuno
diventa fine a se stesso e si trasforma in supplizio inutile dato che il rifornimen-
89
90
to di cibo non arriva. L’esperimento fallisce. È impossibile stabilire qual è la ragione che fa sì che i cani si nutrano; ed in mancanza di una teoria precisa che
spieghi perché si mangia, allora si deve smettere di mangiare e abbandonare
una pratica (l’alimentazione) che non è fondata scientificamente.
Il cane di Kafka è come il pesce di Aristotele. È spinto da una volontà compulsiva di sapere. Per sottrarsi all’Entfremdung e per conoscere l’elemento che
lo nutre e che garantisce il suo sostentamento, si vede costretto a privarsene
per osservarlo dall’esterno; egli si condanna in questo modo al peggiore dei
supplizi.
Ma c’è un altro animale in Kafka che spinto da un’enorme ed incontrollabile volontà di conoscenza corre verso la propria rovina. Si tratta della talpa protagonista del racconto La tana. Questa talpa scava un gigantesco labirinto sotterraneo per proteggersi dagli attacchi improvvisi. Tuttavia, nonostante le infinite precauzioni e le innumerevoli misure di sicurezza prese per ingannare i
nemici, la talpa si sente al sicuro solo nel momento in cui esce dal labirinto per
osservare l’entrata dall’esterno e per controllare la circolazione, cioè solo nel
momento in cui si espone al pericolo di un attacco.
Anche in questo caso l’ironia consiste nel fatto che nel momento in cui si
esce dall’elemento che ci protegge per conoscerlo e apprezzarne il funzionamento ci si espone precisamente a ciò che si voleva evitare. La talpa non può
proteggersi se non mettendosi al servizio di forze che la spingono verso una
regressione nichilista e suicida. L’autodistruzione sembra la conseguenza necessaria del culto della purezza assoluta; paradossalmente, essa si conferma
la forma determinante della conservazione di sé.
Come abbiamo cercato di mostrare, nel mondo di Kafka, abbiamo gli effetti ma non è possibile risalire alle cause che li producono. L’interdizione della
causa, cioè l’impossibilità di svelare ciò che si nasconde dietro lo spettacolo
persistente di ciò che esiste – è il significato stesso del termine Entfremdung.
L’alienazione è il fatto di essere abbandonati, gettati in un mondo inspiegabile,
contraddittorio in cui nulla potrà mai essere giustificato, in cui si è perso il contatto con il mondo luminoso delle cause.
Da questo punto di vista forse l’opera più importante di Kafka, è Parole di
carta o Foglietti di conversazione. Alla fine della sua vita (1921), Kafka, malato di tubercolosi non può più parlare, né mangiare né bere. Egli si trova costretto a rispondere su dei bigliettini di carta alle domande degli amici. Questi bigliettini, o foglietti, sono stati conservati dall’amico e medico personale Robert
Klopstock e formano oggi un’opera in cui troviamo le risposte di Kafka senza
che si possa risalire alle domande che le hanno suscitate. Quest’opera invita il
lettore a costruire le domande. Ma nello stesso tempo lo avverte che la pretesa di accedere alla verità del testo, la pretesa di restituire il senso originale della parola dell’autore è irragionevole perché nessun miracolo ci permetterà mai
di risalire alla causa reale dalla quale la parola che ci è trasmessa ha tratto la
sua origine. Questo testo di Kafka è come il Cherubino che si erge di fronte alla porta del paradiso con la spada fiammeggiante alzata in segno di monito a
tutti gli interpreti in cerca della verità del testo. Le parole di carta significano, in
virtù della loro natura stessa, (in virtù del fatto che sono risposte senza doman-
Bibliografia
G. BATAILLE, La littérature et le mal, Gallimard, Paris 1990.
M. BLANCHOT, L’entretien infini, Gallimard, Paris 1969.
De Kafka à Kafka, Gallimard, Paris 1981.
M. CACCIARI, Icone della legge, Adelphi, Milano 1985.
R. CALASSO, K., Adelphi, Milano 2005.
SAGGI
de, oppure frasi sparse tolte dal contesto in cui sono nate) l’ironia tragica di cui
è vittima ogni interpretazione rivolta verso la causa, la verità, il senso.
La causa non c’è, la domanda che cerca il senso non è possibile formularla se non per gioco e la lettura che cerca di risalire alla verità di un testo è come il fuoco che lo brucia (e non a caso in questi foglietti Kafka che muore arso dalla sete, chiede agli amici di annaffiare le sue piante, come se si trattasse di rimediare ad innumerevoli incendi che la pubblicazione dei suoi scritti ha
prodotto).
Ma la lettura che brucia il testo, distrugge se stessa perché non rimane che
la cenere. Essa diventa al limite lettura di se stessa, auto-lettura che cerca di
trovare in se stesse le ragioni del proprio fallimento e la traccia di ciò che è
scomparso irrimediabilmente.
La conseguenza è che il commento più fedele al testo è quello che si mantiene ad una distanza di sicurezza, che ne accetta il carattere inaccessibile. Il
commento più fedele è quello che formula domande non per ottenere risposte
ma per il gusto di formulare domande, per gioco, … domande che sono dunque non-domande. (A questo proposito si potrebbe ricordare un simpatico dialoghetto zen: “Ti porrò una domanda” disse il re Milinda al Venerabile Nagasena. “Puoi rispondere?” Disse Nagasena: “Poni pure la tua domanda.” Disse il
re: “Ho già chiesto.” Disse Nagasena: “Ho già risposto”. Disse il re: “Che cosa
hai risposto?” Disse Nagasena: “Che cosa hai chiesto?” Disse il re: “Non ho
chiesto niente.” Disse Nagasena: “Non ho risposto niente”).
Immaginiamo che, ad un esame universitario, un candidato inizi a parlare
senza attendere la domanda dell’esaminatore; e che alla fine del discorso egli
inviti l’esaminatore a formulare la domanda che potrebbe trasformare le sue
parole in una risposta (forse gli esami dovrebbero essere così! E poi il candidato dovrebbe promuovere o bocciare l’esaminatore!).
Ma questo è proprio ciò che succede in letteratura; l’interprete (l’esaminatore) non può mai sperare di dirigere il testo nella direzione che egli preferisce
perché è il testo stesso che lo guida e che spesso gli fa perdere la bussola.
Un giorno Rabbi Nahaman di Bratislava disse: “Non chiedere mai il tuo
cammino a qualcuno che lo conosce perché in questo caso non potresti smarrirti”. Mi sembra che ciò si applichi magnificamente in letteratura al lavoro dell’interpretazione e della lettura in generale.
91
G. DELEUZE, F. GUATTARI, Kafka. Pour une littérature mineure, Les Éditions de minuit, Paris 1975.
Mille Plateaux, Les Éditions de minuit, Paris 1980.
F. KAFKA, Il processo, Rizzoli, Milano 2007.
Il castello, Rizzoli, Milano 2005.
La colonia penale ed altri racconti, Datanews, 2005.
Storie di animali, Sellerio, Palermo 2005.
Tutti i racconti, Newton & Compton, Milano 2005.
M. KUNDERA, L’art du roman, Gallimard, Paris 2004.
Testaments trahis, Gallimard, Paris 1993.
M. A.OUAKNIN, C’est pour ça on aime les libellules, Calmann-Lévy, Paris 1998.
92
di Patrizia Manganaro
Prendo spunto da una pregevole pubblicazione sul pensiero di Gerda Walther1 per tornare a riflettere sulla possibilità di un’indagine filosofica dell’esperienza mistica e sui suoi criteri metodologici. Ritengo infatti il contributo dell’analisi fenomenologica non solo peculiare, ma necessario e persino irrinunciabile per la configurazione della filosofia della mistica quale disciplina costitutiva e autonoma, con un suo proprio statuto epistemologico. Svolgerò questa
tesi con una sintetica Introduzione, a sua volta articolata in due punti: a) il nesso tra antropologia e mistica; b) il significato di un’epistemologia analitica dei
vissuti. Con rapidi colpi di sonda, metterò poi l’accento sui seguenti nodi teorici: il rapporto tra filosofia, fenomenologia e mistica; il significato di quella che
definisco una pratica non-egologica della ragione2 in riferimento all’esperienza
etero-centrata, noi-centrica, di unione e di comunione; l’esperienza del distacco, dell’abbandono, del vuoto, attestata in modo trasversale in varie tradizioni
spirituali; la questione filosofica dello spirito e dell’anima; e infine, uno sguardo
sulla mistica del Sé e sulle vie dell’interiorità nel confronto con l’Oriente.
1. Antropologia e mistica. Sin dal titolo, lo studio di Marina Pia Pellegrino
sulla Walther mette in evidenza il nesso tra antropologia e mistica, con particolare riferimento alla descrizione fenomenologica della dimensione interiore e
alla “possibilità ideale”, per usare l’espressione propria di Husserl, dell’esperienza mistica. Se per il maestro il correlato oggettivo del vissuto mistico rimane problematico, è noto che due sue allieve lo hanno scandagliato a fondo, e
in verità Gerda Walther ancora prima della più nota Edith Stein. La sua Phänomenologie der Mystik risale infatti al 1923, poi rivista ed ampliata nel 1955. Rispetto alla Stein, si osserva che l’esperienza mistica non è studiata all’interno
di una specifica tradizione, ma colta nella sua universalità, nel suo senso proprio, con un’apertura al dialogo interculturale e interreligioso da un lato e agli
aspetti esoterici del pensiero religioso dall’altro. L’antropologia fenomenologica è fortemente legata alla mistica3, emergendo dallo scavo analitico sul nucleo o essenza fondamentale della persona e su Dio come fondamento di tale
nucleo; in tal senso, la Walther si trova perfettamente in linea con il lavoro husserliano sul tema della “costituzione”, come anche con quello della Stein, in
una sorta di corale archeologia fenomenologica dell’essere umano. Si tratta
però di superare almeno due scogli o pregiudizi, che ostacolano la ricerca: a)
che il mistico sperimenti solo se stesso e non l’altro da sé (che cada cioè vittima di un’illusione, di un inganno, di una proiezione); e b) che non sia possibile conoscere ciò che non “passa” attraverso la sfera sensibile.
SAGGI
ANTI-EGOLOGIA DELLA RAGIONE
ED ESPERIENZA ETERO-CENTRATA.
NOTE SUL CONTRIBUTO DELLA FENOMENOLOGIA
ALLA FILOSOFIA DELLA MISTICA
93
94
2. Significato di un’epistemologia analitica dei vissuti. L’istanza di radicalità
della fenomenologia husserliana, la sua vocazione all’originario, si trova al
contempo in continuità e in frattura con la tradizione occidentale – continuità:
la centralità del soggetto o io, ovvero il primato della coscienza; frattura: il capovolgimento di prospettiva che, attraverso la sospensione di ciò che è ovvio
e spontaneo, costringe a un rinnovata modalità d’approccio al mondo circostante, agli altri esseri umani, al divino e, come cercherò di mostrare, a se stessi. Ciò consente di parlare di una vera e propria epistemologia analitica dei vissuti. Nella mia prospettiva, metterò in rilievo soprattutto la rottura della fenomenologia con la tradizione occidentale, per tentare di cogliere il novum e le sfide che essa porta con sé.
L’Erlebnis mistico costituisce uno straordinario documento che getta luce
sul senso e sulla complessità dell’umano; le diverse stratificazioni messe in
evidenza dall’analisi e soprattutto l’individuazione della fonte o sorgente altra
dalla quale i vissuti mistici scaturiscono, permettono l’ulteriore chiarimento di
nodi filosofici cruciali – la questione della costituzione, il binomio identità-alterità, l’insediamento, il vuoto, l’abbandono (Verlassenheit), il sentire spirituale,
l’anima, l’irruzione del divino (del sacro? del numinoso? della potenza? del mistico? Si tratta di una forza impersonale o personale? La Walther, infatti, parla
a più riprese di “Es”), ecc. –, tutti legati al significato dell’esperienza etero-centrata. La quale, beninteso, non è presente soltanto nei vissuti propriamente mistici, ma anche nell’empatia (si pensi alla distinzione tra originarietà e non-originarietà del vissuto e alla consapevolezza del vissuto nell’analisi di Edith
Stein) e nella telepatia (Erlebnis nel quale si è impregnati dell’aura di un altro
io, che in un certo senso invade e riempie il nostro territorio in modo inconscio,
latente, senza che vi sia una percezione esterna: il “qui” e “ora”, il presente riguarda non l’ego “ricevente” ma l’alter-ego “trasmittente”, che lo vive in prima
persona, come ha ben rilevato Gerda Walther).
Anche i vissuti in qualche modo “occulti” sono secondo la Walther “percezioni spirituali”, ma di grado inferiore a quelle mistiche, anzi del tutto diverse,
ma pur sempre più vicine ai vissuti mistici che alle percezioni esterne o sensibili. Insomma: l’esperienza etero-centrata è strettamente legata alla sfera spirituale e mostra tutta la sua forza e pregnanza proprio nel vissuto mistico; grande attenzione è quindi posta verso i vissuti non-egologici, che non provengono cioè in prima istanza dall’io, ma da dietro, a sua insaputa. Lo strumento fenomenologico si mostra al riguardo particolarmente prezioso, perché riesce a
descrivere la presenza viva, reale, concreta di cui parlano i mistici e le mistiche, senza tuttavia confonderla con una semplice percezione esterna.
3. Fenomenologia della mistica, filosofia della mistica, filosofia e mistica. I
nodi teorici di cui sopra richiamano anche un’ulteriore questione di fondo. La
stessa Pellegrino4 ne fa cenno, concludendo il suo testo con una considerazione che merita di essere affrontata in questa sede: l’opera della Walther Phänomenologie der Mystik è un’opera di filosofia della mistica, senza che “filosofia”
e “mistica” possano essere confuse (unità nella distinzione).
Si tratta allora di precisare: a) il senso del binomio filosofia e mistica, ovve-
3.1. Filosofia e mistica. Tenterò di inoltrarmi in questo complesso territorio cominciando dal rapporto tra filosofia e mistica. La mistica non s’identifica con la
filosofia – esse non sono lo stesso – ma non ne costituisce l’opposto – così come l’irrazionale (è il contrario) del razionale. Il loro rapporto si profila di difficile
declinazione. La mistica è l’altro del pensiero, l’oltre del pensiero, il trascendimento stesso del pensiero, e si configura come quel momento di non-pensiero o di non-filosofia che viene tuttavia considerato il vertice del pensiero e della filosofia (la cosiddetta “mistica speculativa”: ein einig ein, “un unico uno”, secondo il dire di Eckhart, il quale utilizza anche la formula ohne mittel, “senza
mediazione”). Una filosofia della mistica dovrebbe in prima istanza pensare,
scavare, interrogare questo non. Persino nell’esperienza dell’unione o, meglio,
della comunione mistica, l’essere umano rimane sempre il non Dio e il non di
Dio, pur essendo il “luogo” e/o il “dove” della manifestazione diretta del divino5
(risuonano forti le parole di Agostino: «E se vuoi trovare un luogo alto, un luogo santo, offriti a Dio come tempio nel tuo intimo. Santo, infatti, è il tempio di
Dio che siete voi. Vuoi pregare nel tempio? Prega dentro di te; ma cerca prima
di essere tempio di Dio, affinché egli possa esaudire chi prega nel suo tempio»). In tal senso, è agevole scorgere il suo legame con la filosofia della religione, ma anche, rispetto a questa disciplina, l’ulteriore incursione nel mistero,
nell’ardito, nell’inaudito, nel paradosso che scioglie l’antinomia: ciò significa
che la mistica non è il contrario della ragione, ma il suo “non”. In un certo senso, la sua trasfigurazione. Ecco perché essa non è l’altro dal, bensì l’altro del
pensiero. L’identità che si svuota di sé, che rinuncia a sé, che si libera dalle catene dell’io empirico, chiama in causa la possibilità stessa di un io non-egocentrato, e dunque di una ragione parimenti non-egologica, svuotata. L’esperienza etero-centrata va certamente di pari passo con una pratica non-egologica
della ragione, che scardina l’autoreferenzialità. Qui sta il legame e insieme la
frattura della fenomenologia con la tradizione occidentale, contraddistinta da
una sorta di malattia mortale: l’ipertrofia dell’ego.
4. Per una pratica non-egologica della ragione. L’abbandono e il vuoto. Lo
spirito e l’anima. Il punto è che proprio la filosofia fenomenologica offre uno
straordinario esempio di pratica anti-egologica della ragione, anzi del lógos, se
vogliamo restare fedeli alla dizione adottata dal maestro. Dunque il suo contributo alla filosofia della mistica è davvero irrinunciabile e ora tenterò di mostrarlo attraverso l’esame schematico di alcuni di quei nodi teorici sopra soltanto accennati.
NOTE
ro quale valenza attribuire alla congiunzione che le lega nella costitutiva differenza: dialettica, speculativa, antinomica, reciprocamente relazionale, ecc.; e
b) il significato di “fenomenologia della mistica” e di “filosofia della mistica”, con
particolare riguardo al loro rapporto: se esse cioè coincidano, se s’inscrivano
l’una nell’altra, se confinino, se il compito della filosofia della mistica si esaurisca con l’attivazione dello strumento metodologico offerto dalla fenomenologia
oppure presenti un’ulteriore eccedenza, ecc.
95
96
La nozione fenomenologica di esperienza è pensabile come etero-centrata, come un attraversare e un essere attraversati dalla differenza (ex-per-iri).
Qui ben emerge la distinzione tra il momento soggettivo e oggettivo dell’esperienza mistica, il punto dolente per Husserl, come anche tra la fase “attiva” e
“passiva” del vissuto. Avviene uno spostamento del centro esperienziale da sé
all’altro da sé, nel dinamismo del nesso tra identità personale e relazionale.
Il momento intersoggettivo, comunitario (si pensi allo studio degli atti sociali presente tanto nella Walther – la sua Ontologia delle comunità sociali è del
1923 – quanto nella Stein), viene spinto sino all’analisi dell’alterità maiuscola,
cioè dell’esperienza dell’Altro che è Dio e/o il Divino, la quale consente di comprendere il senso di una trascendenza interiore, nozione che potrebbe altrimenti provocare un cortocircuito6. Quando avviene l’irruzione del divino, il punto visuale è eterno, dalla parte di Dio: si tratta di una visuale ultraterrena ma
non “esterna”, del “vedere con l’occhio di Dio”.
Esperienza + Alterità = Esperienza etero-centrata + trascendenza interiore
L’esperienza dell’abbandono e del vuoto, attestata in modo trasversale in
diverse tradizioni religiose, che la fenomenologia spiega con il passivo essere
riempiti dalla potenza estranea, sottolineando che l’origine del vissuto può anche non scaturire dal proprio io, ma appunto provenire da un “altro”, da “altrove”, da un’ulteriorità o da un’eccedenza. Che questo “altro-altrove” sia poi il sacro, il numinoso, il mistico, la luce divina, l’Assoluto, l’Infinito, se sia personale
o impersonale (come ricordavo sopra, la Walther parla di “Es”, senza nome), è
tutto da vedere. Nell’esperienza di abbandono descritta dalla Walther si potrebbe dire che l’io è puro e basta, è cioè privo di contenuto: è desto, vigile, libero,
ma tutta la sua consapevolezza riguarda soltanto tale saper-si abbandonato. È
un io contemplante, altamente con-centrato. In tale Erlebnis dell’abbandono l’io
tocca la sua vuotezza, rimane sospeso, senza dimora e senza legami. Completamente distaccato, giunge alla radice profonda del suo vivere: tale vuoto,
infatti, è anche la sua purezza più cristallina, quale sorgente dell’erleben privo
di qualità. Qui ben emerge, tra l’altro, che l’io non è l’anima. Nonostante l’abbandono, non vi è annullamento ontologico: l’io è ancora libero e, se si deciderà per il divino, il suo tendere e volere spogli di egocentrismo si scioglieranno
in invocazione7. Invocare significa sapere di non poter “costringere” il divino a
manifestarsi riempiendo il vuoto (si tratta insomma di un evento gratuito, di un
dono). Tuttavia, quando ciò avviene, ein Etwas, Qualcosa come un caldo mare di luce avvolge l’io e lo inonda in tutti i suoi strati: nell’anima, nello spirito,
nel sé, nell’io-centro. Chiarissima, qui, l’affinità con la mistica della luce. Da notare altresì che l’io è e rimane libero, e che non solo non coincide con l’essenza fondamentale, ma può decidersi “per” o “contro” di essa: secondo la Walther, Lucifero potrebbe essere il simbolo di questa forza dell’io che agisce contro l’essenza fondamentale8.
Si prospetta dunque la questione filosofica dello spirito e dell’anima con la
delineazione: a) dell’io-centro (Ichzentrum), il quale attinge la sua forza dall’insediamento (Einbettung) e manda la sua luce all’esterno e all’interno; b) del Sé
o insediamento, illuminato dall’io-centro e formato dai tanti fili dei vissuti; e infine, c) dell’essenza fondamentale spirituale. Se la “testa” è il “dove” dello spi-
5. Il confronto con le esperienze orientali. Perdita dell’io empirico nella fenomenologia, distacco dall’io mondano, apparente, nell’induismo e nel buddhismo e sacrificio di sé nel cristianesimo. S’impone dunque il confronto con la
tradizione orientale. L’ipertrofia dell’ego è una malattia tipica dell’Occidente,
certamente conosciuta e respinta dai mistici e dalle mistiche di ogni tempo e
luogo, che hanno piuttosto lavorato su di sé per dimenticare e rinunciare a sé,
un’ascesi configurata come una vera e propria lotta contro la propria natura,
come una sorta di de-costruzione dell’ego. Si parla infatti di abnegare se ipsum
o abnegare proprium (S. Giovanni della Croce si riferisce all’egoità appropriativa: proprietad; Eckhart all’annientamento dell’egoità: Eigenschaft; il paradigma è e rimane in ogni caso quello dello svuotamento del Crocifisso/Abbando-
NOTE
rito, il “cuore” è il “dove” dell’anima, la quale ultima è una regione molto profonda dell’insediamento. Importante qui, e la Pellegrino lo rileva con squisita sensibilità femminile, la ricorrenza dell’aggettivo leibhaftig: la corporeità è sperimentabile dall’interno, è possibile sentirla e percepirla “da dentro”, come l’immagine del “vaso poroso” proposta dalla Walther ben documenta. Si tratta di
un “sentire” analizzato anche attraverso il vissuto empatico e quello telepatico,
i quali aiutano a comprendere i vissuti propriamente mistici per la comune appartenenza alla sfera spirituale, sia pure con diverse gradualità e sfumature. Il
sentire mistico è tale che il suo “oggetto” si manifesta in modo vivo, presente,
efficace, senza tuttavia coincidere con una percezione esterna. Ma quale tipo
di datità è? Ovvero: come distinguere ciò che viene da Dio e ciò che è “proprio”? La garanzia sta nel contenuto noematico. La Walther porta al riguardo
l’esempio della presenza vivente di Cristo nell’Eucarestia, un’esperienza non
di semplice unione, ma di vera comunione. Qui è possibile fornire una lettura
che amplia e insieme approfondisce l’esperienza “semplicemente” etero-centrata in quella noi-centrica, personale, d’ispirazione trinitaria9. Ancora, la Walther valuta l’esperienza del nirvana come esperienza di unione, caratterizzata
da armonia, quiete, forza d’amore spirituale; come anche accade in altre tradizioni che non concepiscono Dio come Persona, e lo confondono con l’essenza fondamentale, in una sorta di “antropomorfizzazione” del divino e/o di una
“teomorfizzazione” dell’umano (presunta identità tra io e Dio). La vera comunione, invece, si dà soltanto tra persone, e qui emerge come s’è detto la centralità del momento del “noi”, quello della comunione eucaristica ma anche il
dinamismo relazionale trinitario (l’essenza fondamentale del Cristo è una e
identica con quella del Padre e dello Spirito Santo) e l’unicità del Figlio, che ha
assunto forma umana con un io-centro, un corpo proprio (Leib) e un insediamento psichico (Sé). Ma tutto ciò in questa sede può essere soltanto segnalato e non ulteriormente sviluppato, riguardando complesse questioni teologicotrinitarie10 e cristologiche. Sul versante più propriamente fenomenologico, si
evidenzia l’affinità con la Scientia Crucis, quando la Stein11 rimarca l’importanza dell’“essere Dio per partecipazione” di cui parla Giovanni della Croce al vertice della “scala segreta”.
Vuoto + Spirito-Anima = Significato della via individuationis + significato del
desiderio di riempimento per la coscienza religiosa
97
nato, attestato dal paolino heautòn ekénosen di Fil 2,7), come anche di distacco dall’io per raggiungere il vero sé metaempirico, transegoico e assoluto (induismo, buddhismo).
Un’altra straordinaria pensatrice, S. Weil, ha definito tale distacco (detachement) come una sorta de-creazione (decreation), nel senso di un essere nulla
per essere al proprio vero posto nel tutto: «Noi non possediamo niente al mondo eccetto il potere di dire Io. Questo è ciò che bisogna dare a Dio, cioè distruggere. Non c’è assolutamente nessun altro atto libero che ci sia permesso,
se non la distruzione (destruction) dell’Io»12.
Sia detto solo per inciso che qui emerge con forza il tema del “sacrificio” nel
suo evidente legame al “mistico” piuttosto che al “sacro”13, come offerta della
parte migliore, come dono sino all’abban-dono.
98
5.1. La mistica del Sé e le vie dell’interiorità. Alla via del distacco, della purificazione e dell’interiorità è dunque connessa la cosiddetta “mistica del Sé” o mistica in-statica14. La quale affonda le sue radici in intuizioni e percezioni spontanee
che diversi metodi, sapientemente elaborati nel corso di tradizioni secolari, si applicano a spingere fino a quel grado mistico nel quale l’apofasi è posta al servizio di un’esperienza originaria. La mistica d’immanenza centrata sull’esperienza
del Sé è un’istanza privilegiata dell’autoconoscenza, sollecitata tanto da religioni
e discipline spirituali, quanto da dottrine filosofiche: in questo senso, in Occidente essa riecheggia il delfico “Conosci te stesso” e l’agostiniano “vivere interiore”,
ripresi e riattualizzati dall’analisi fenomenologica sull’anima; in Oriente, essa riaffiora nell’esperienza buddhista del “vuoto mentale” o “vuoto di pensiero”, intesi
come un vedere nella propria interiorità, nel Sé autentico.
Il primo punto da prendere in considerazione è che la de-costruzione dell’ego è l’istanza privilegiata della via ad intus. Dove si nota che la tradizione occidentale moderna e contemporanea ha spesso risolto l’interiorità nella soggettività, diventando sempre più “sistematica”, “egologica”, “solipsistica”. Questa
è anche la lettura che il filosofo giapponese della scuola di Kyoto K. Nishitani15
fornisce della modernità in Occidente, interpretandola come una squalificante
autorealizzazione dell’ego. Egli parla di discesa al nulla, di abbandono della
soggettività e di trascendimento della ragione discorsiva nel “sapere di non-sapere”. Non si tratta della posizione di una negatività semplicemente negativa,
ma di una posizione in cui l’assoluta negazione è al contempo una grande affermazione. Riecheggiano le parole dei grandi mistici cristiani: quando sono
nulla, possiedo tutto. Non il Sé è il vuoto, ma la vacuità è il Sé, afferma Nishitani; non le cose sono vuote, ma la vacuità è le cose. Si tratta di un “approdare sull’altra sponda”, espressione efficacemente presente anche nella Walther16 sia pure con sfumature diverse.
Il secondo punto concerne il paradosso del raggiungimento della piena
identità con Sé attraverso l’annullamento di Sé, attestata sia nell’esperienza
kenotica del Cristo, sia nella sunyata del buddhismo zen (del “grande veicolo”)
come vertice spirituale e come stanziamento dinamico. Secondo lo zen, quando “vedere” è “non-vedere”, proprio allora è autentico “vedere”: definito in termini negativi, esso viene chiamato “vuoto di pensiero” o “vuoto mentale”. Ve-
5.2. Io e Sé. Atman (io, sé) e anatman (non-io, non-sé). Ego e non-ego secondo Nishitani. In Occidente, è solo a partire dal sec. XVIII che il pronome riflessivo “sé” viene esplicitamente impiegato per designare le autopercezioni del
soggetto: eppure questa nozione è presente in tutte le riflessioni sull’anima, come anche nelle locuzioni composte con tale pronome o con il suo corrispettivo
greco autós, usato come prefisso (autocoscienza, autoconoscenza, autorealizzazione, autonomia, autonatura, ecc.). Ma il termine “Sé” diviene problematico
più di recente, quando è delegittimata la sua identificazione all’io, cioè in connessione con le analisi junghiane della psiche e, in altro àmbito, quando la differenza tra i termini sanscriti atman e anatman viene resa con “io”, “Sé”, “anima”, per il primo, e con “non-io”, “non-Sé”, “libero dal Sé”, per il secondo. In tale contesto, alcuni esponenti della scuola di Kyoto hanno incentrato la discussione sul nulla assoluto o vuoto (sunyata). Poiché il buddhismo del grande veicolo non concepisce il nirvana in termini di “essere”, il suo luogo proprio è il
vuoto. Il Buddha è il vuoto assoluto, cioè il vuoto di ogni termine relativo e determinato, la grande compassione.
Come s’è detto, il vuoto non coincide con il non-essere, perché si trova oltre il dualismo e/o l’antinomia essere/non-essere, come anche oltre il dualismo
d’ogni altra specie; parimenti, non è l’essere, ma il privo di determinazione,
l’Assoluto (ab-solutus) nel senso di sciolto da ogni legame (e dunque libero). Il
nirvana viene perciò definito come il non-composto, il non-condizionato, il nonnato, il non venuto all’esistenza, il senza attributo: un vuoto spaziale che evoca ed esplicita un’assenza. Tale vuoto è dinamico, privo delle connotazioni di
notte, tenebre e abisso che l’Occidente associa generalmente al nulla. La su-
NOTE
dere nel proprio autentico Sé, quest’ultimo non essendo alcuna cosa, è vedere nel nulla, nel vuoto o vacuità (sunyata): si tratta di un’illuminazione proveniente dalla pratica assidua della meditazione che prende come oggetto l’assenza di ogni oggetto e conduce così alla saggezza-sapienza. Quale affinità
con l’io descritto dalla Walther che, nel vissuto dell’abbandono, è vuoto, cioè
privo di contenuti e di determinazioni?
Tanto nella kenosi quanto nella sunyata, si tratta del “ritornare al Centro”
che si ottiene de-costruendo e/o spogliando l’ego: annientando il “mio”, il “tuo”,
il “proprio”, emerge il vero Sé. Il cristianesimo parla di comunione mistica, di
agape; il buddhismo di unione e di compassione: negando se stessi, ci si unisce agli altri, in una sorta di luminosa interdipendenza. Siamo alla fonte di un
altruismo agito e vissuto, di un essere-per-l’altro tipico dell’esperienza eterocentrata. Nishitani afferma che la vacuità è il Sé: ciò significa che il Sé non è
semplicemente ciò di cui il Sé è cosciente, ma la sua sorgente, la sua fonte. Il
Sé trova la sua origine in un punto libero, sciolto dal mondo e dalle cose, in una
sorta di “trascendenza” che costituisce la vera consapevolezza. Tale consapevolezza non è un’autoconsapevolezza o un’autocoscienza. Siamo soliti vedere il Sé come qualcosa che diviene cosciente di se stesso, che comprende se
stesso e che intuisce intellettualmente se stesso; ma ciò che qui viene chiamato “consapevolezza” non è in alcun senso il conoscer-si del Sé: al contrario, è
il punto in cui un tale Sé e una tale conoscenza sono entrambi svuotati.
99
100
nyata è piuttosto una sorta di nulla luminoso, accompagnato da uno stato di
calma, imperturbabilità, quiete, serenità, compassione. Ma qual è la concezione della soggettività che ne emerge? Nishitani opera una distinzione tra la nozione di ego, che rimanda alla filosofia cartesiana e al modo d’essere di un io
chiuso in se stesso, e quella di sé, intesa piuttosto come radice fontale, sorgiva, originaria. Egli traduce il termine sanscrito atman con “ego”, e il termine
anatman con “non-ego”, e scrive: «Ego indica un sé che è in uno stato di “attaccamento” a se stesso. Ciò spiega come sorgano all’interno del sé quei problemi che si radicano nell’essenza del modo d’essere egocentrico […]. Cogito
ergo sum è la verità più immediatamente evidente; ma, vista a partire dal campo del cogito, diventa problematica e, a un livello più fondamentale, si trasforma in un nuovo dubbio. La sua autoevidenza diventa una sorta di autoinganno, poiché l’ego non riesce più a trovare il fondamento di se stesso. Si tratta di
un problema implicito fin nell’origine dell’ego stesso. Dobbiamo perciò pensare l’autocoscienza del cogito ergo sum nella sua soggettività a partire da un
campo più fondamentale di quello dell’autocoscienza, un campo chiamato
“sorgivo”. Pensare l’ego da un campo sorgivo vuol dire che l’ego stesso fa venire alla luce soggettivamente un campo d’esistenza all’interno di sé. Ovvero
la consapevolezza sorgiva dell’ego viene ad essere un sé sorgivo. In questo
senso, il cogito ergo sum cartesiano può assicurare la propria verità solo quando il campo della coscienza viene aperto al più sorgivo campo del Sé. Se ciò
non accade, il sé dell’autocoscienza diventa persino una finzione»17.
Conclusione
I vari elementi qui raccolti anche in direzione di un auspicabile dialogo interculturale e interreligioso s’arricchiscono reciprocamente proprio nel confronto con l’esigenza di radicalità, con la vocazione all’originario e con il capovolgimento dell’ovvio e dell’ordinario che la filosofia fenomenologica produce: si
pensi soltanto alla portata speculativa della riduzione, col ritenere quale terreno ultimo non la monade soggettiva, bensì il noi intersoggettivo. Non comportando – e neppure significando – l’assolutizzazione dell’ego ma uno scavo “archeologico” nel/del profondo, la centralità attribuita alla coscienza e ai suoi Erlebnisse offre un esempio paradigmatico e pressoché unico nel pensiero filosofico occidentale, avendo rielaborato e riattualizzato tanto il delfico “Conosci
te stesso” quanto l’agostiniano “vivere interiore” senza fagocitare l’interiorità
nella soggettività. Con le parole dello stesso Husserl: «Il detto delfico “conosci
te stesso” ha ottenuto un significato nuovo. La scienza positiva vale nella dispersione mondana. Si deve prima perdere il mondo mediante l’epoché, per
riottenerlo poi con la presa universale del senso di sé. Noli foras ire, dice Agostino, in te redi, in interiore homine habitat veritas»18. Il contributo che l’analisi
fenomenologica offe alla filosofia della mistica risulta dunque, sotto molteplici
riguardi, esemplare e irrinunciabile.
NOTE
1 M. P. PELLEGRINO, L’essere umano e la sua vita interiore. Linee di fenomenologia della mistica in Gerda Walther, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007.
2 P. MANGANARO, Filosofia della mistica. Per una pratica non-egologica della ragione, Lateran
University Press, Roma 2008 (in corso di stampa ).
3 Rimando ai puntuali lavori di A. ALES BELLO, tra i quali segnalo qui Per un recupero della mistica nell’ambito fenomenologico: Gerda Walther e Edith Stein, in: AA. VV., Esperienza mistica e
pensiero filosofico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 11-25; Id., Fenomenologia dell’essere umano. Lineamenti di una filosofia al femminile, Città Nuova, Roma 1992.
4 Cf. M. P. PELLEGRINO, op. cit., p. 91.
5 Per un approfondimento, cfr. P. MANGANARO, Verso l’Altro. L’esperienza mistica tra interiorità
e trascendenza, Città Nuova, Roma 2002.
6 M. P. PELLEGRINO, op. cit., p. 71.
7 Ivi, p. 69.
8 La notazione della Walther confina con altri àmbiti d’indagine, nei quali l’attenzione al nesso
male/libertà innerva il pensiero filosofico sino ad assumere accenti tragici. Cfr. L. PAREYSON, Ontologia della libertà Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 1995.
9 M. P. PELLEGRINO, op. cit., pp. 79-80.
10 Cf. il denso studio di P. CODA, Il Logos e il Nulla. Trinità religioni mistica, Città Nuova, Roma
2003. Dello stesso Autore segnalo anche La mistica trinitaria: dal castello interiore al castello esteriore, in P. MANGANARO (ed.), L’anima e il suo oltre. Ricerche sulla mistica cristiana, Ed. O.C.D., Roma 2006, pp. 9-13.
11 E. STEIN, Scientia Crucis. Studio su san Giovanni della Croce, tr. it., Postulazione Generale
dei carmelitani scalzi, Roma 1982.
12 S. WEIL, L’ombra e la grazia, tr. it., Bompiani, Milano 20032, p. 49.
13 Cfr. P. MANGANARO, Il sacrificio e la croce. Note sul “filosofico-teologico”, il “sacro”, il “mistico”, in “Filosofia e Teologia”, 1/2008, pp. 39-53.
14 Cf. L. GARDET-O. LACOMBE, L’esperienza del Sé. Studio di mistica comparata, tr. it., Massimo, Milano 1988.
15 K. NISHITANI, Il risveglio del Sé nel buddhismo, tr. it., in: La relazione io-tu nel buddhismo zen
e altri saggi, L’Epos, Palermo 2005, p. 93.
16 G. WALTHER, Zum anderen Ufer. Von Marxismus und Atheismus zum Christentum, Otto Reichel Verlag, Remagen 1960.
17 K. NISHITANI, La religione e il nulla, tr. it., Città Nuova, Roma 2004, pp. 46-47.
18 E. HUSSERL, Meditazioni cartesiane e Discorsi parigini, tr. it., Ets, Pisa 1990, pp. 210-211.
101
LA DIMENSIONE SIGMA
di Cosimo Caputo
1. L’ Oggetto Dinamico come “terminus a quo”
102
In Kant e l’ornitorinco (1997) Umberto Eco, sottolineando che il rapporto tra
la “fase primaria e lo sviluppo successivo della semiosi pienamente dispiegata non presenta fratture evidenti” (ivi, p. 107), considera l’Oggetto Dinamico come terminus a quo della semiosi (cfr. ivi, p. 396). Egli così riposiziona il suo
punto di vista teorico rispetto al Trattato di semiotica generale (1975) che focalizzava l’Oggetto Dinamico come terminus ad quem dei processi segnici. Inoltre, la contaminazione fra la semiotica glossematica e la semiotica interpretativa avviata nel Trattato conosce una tappa ulteriore: si apre una prospettiva
più ampia che vede coinvolte in un dialogo di ricerca la riflessione hjelmsleviana e quella peirceana, le quali – dice ancora Eco (1997, p. 218) – “debbono
coesistere, perché a volerne scegliere una sola non si rende ragione del nostro modo di conoscere e di esprimere quello che conosciamo”.
L’Oggetto Dinamico “rimane sempre come una Cosa in sé, sempre presente e mai catturabile, se non per via, appunto, di semiosi” (ivi, p. 5); esso c’è prima ancora che un interpretante ne ‘parli’, ne faccia sapere qualcosa, e sussiste anche dopo, disponibile per altre interpretazioni. Questa eccedenza, questa resistenza, questa asimmetria dell’Oggetto Dinamico con i suoi interpretanti dice di un continuum originario, di un “sinechismo” (Peirce), o di una “materia” (Hjelmslev), che è un cum-tenere (un tenere insieme) e quindi già una relazionalità, garanzia e base di semiosi.
Prima c’è Qualcosa “che sveglia l’attenzione, anzi la stessa attenzione in agguato fa già parte (è testimonianza) di questo qualcosa” (ivi, p. 6); c’è un “razionalismo naturale” (Prodi 1988, pp. 31, 46) o una “fisiosemiosi” (Deely 2002,
trad. it. p. 63). Questo Qualcosa, che nel Trattato (1975, p. 34) era la “soglia inferiore della semiotica”, ora Eco (1997, p. 8) lo chiama “Essere”, ovvero “l’orizzonte, o il bagno amniotico, in cui naturalmente si muove il nostro pensiero”, “il
nostro primo conato percettivo”. La semiotica strutturale non si è mai posto questo problema, “con l’eccezione di Hjelmslev”, annota ancora Eco (ivi, p. 4).
Uno “zoccolo duro dell’essere” che non è “qualcosa di solido e tangibile”,
ma un insieme di “linee di resistenza, magari mobili, vaganti”, di “sensi permessi e sensi vietati” (ivi, pp. 36-39) che pongono limiti ai discorsi e alle interpretazioni. Nel sostenere ciò Eco si richiama appunto al continuum materiale, o
più semplicemente “materia” di Hjelmslev: una “classe di variabili” che nella
prospettiva epistemologica del linguista danese è il luogo di funzioni di “costellazione”, ossia di funzioni tra due funtivi (variabili) dove nessuno dei due pre-
al di là […] di ogni restrizione di tipo cognitivo”; e se essa è davvero, come crediamo, più soddisfacente di altre assunzioni e definizioni teoriche,
allora “bisogna poter trarne tutte le conseguenze ammissibili: e il ‘qualcosa’, posto che di esso ci si voglia occupare ad un opportuno livello d’indagine, non sarà più necessariamente il ‘qualcosa’ del linguaggio considerato nella sua dominante funzione cognitiva; il ‘qualcosa’ non si confonde, cioè, con il ‘conosciuto’.
2. La semiosi globale/locale
Ripartiamo dunque ancora una volta da Louis Hjelmslev che nel saggio
Struttura generale delle correlazioni linguistiche (1933, trad. it. p. 70) scrive:
L’analisi per dimensioni è la sola che possa spiegare il fatto che, rispetto
alla correlazione, alla sostituzione reciproca e al sincretismo, i membri di
NOTE
suppone l’altro, e dove le “coesioni” (interdipendenze e determinazioni) impongono delle direzioni (sensi permessi e sensi vietati) o interpretazioni, ovvero
delle costruzioni di significati (cfr. Hjelmslev 1943, trad. it. p. 146, deff. 16, 17;
p. 148, def. 69). Ma la concezione hjelmsleviana ci sembra più ampia: essa
guarda al di sotto della linea di galleggiamento delle forme semiotiche, o dei
sensi (interpretazioni) dell’essere, mentre Eco accorpa tutto ciò nell’Essere, nel
Qualcosa, sminuendo in tal modo ciò che pur costituisce un approfondimento
della nozione di materia segnica o di materia dell’essere (del segno) che vive
in esso condizionandolo. Quando Eco (cfr. 1997, p. 39) sostiene che nel magma del continuum ci sono delle linee di resistenza e delle possibilità di flusso,
come delle nervature del legno o del marmo che rendono più agevole tagliare,
in una direzione piuttosto che nell’altra; e ancora: “Se il continuum ha delle linee di tendenza, per impreviste e misteriose che siano, non si può dire tutto
quello che si vuole, sta facendo appunto quest’operazione di comprensione o
di riduzione, ma ci sta dicendo anche che le linee del marmo o le nervature del
legno rimangono nell’opera costruita; ci sta dicendo di una materia dell’essere
dell’opera, di un Altro che si estende e vive in essa. Un riduzionismo che conduce ad una ambivalenza, o forse meglio ad una certa ambiguità della nozione echiana di continuum e/o di essere”.
Questo riposizionamento di Umberto Eco sulla “soglia inferiore” della semiosi si pone in consonanza con una rivisitazione o ricognizione della semiotica, per dirla con Emilio Garroni (1977), che all’interesse per le forme semiotiche e metasemiotiche appartenenti all’umano unisce l’interesse per le forme
semiosiche appartenenti al non umano, al mondo della vita nella sua sterminata antichità. Come scrive Garroni nel suo Progetto di semiotica (1972, p. 178),
“non si riesce a scorgere la legittimità di uno studio del linguaggio in senso
stretto che trascuri tutti quegli aspetti che, pur avendo relazioni con aspetti e finalità propriamente cognitivi, non sono ad evidenza riportabili senz’altro ad
una funzione cognitiva”. E va sottolineato al riguardo che anche Garroni sceglie l’“impostazione hjelmsleviana” perché va
103
una stessa categoria grammaticale sono sullo stesso piano, e che ciascuno di questi membri, rispetto agli altri, è dotato al tempo stesso della
stessa dipendenza di qualsiasi altro membro.
104
Il metodo glossematico, che descrive le dipendenze e le indipendenze fra
le parti di un oggetto, “non è valido solo in linguistica”, ma “è utilizzabile e necessario in qualunque semiologia” (Hjelmslev 1939b, trad. it. p. 130); è valido,
i altri termini, per evidenziare la forma di qualunque sistema di segni.
L’analisi per dimensioni consiste “nel riconoscere, all’interno di una categoria, due o più sotto-categorie che si intersecano e si compenetrano” e che sono “perfettamente coordinate” e simultanee.
Nella prospettiva gerarchica, invece, l’analisi procede per suddivisioni: “si
individuano successivamente due (o più) sotto-categorie di cui la seconda è
subordinata alla prima (la terza alla seconda, e così di seguito all’occorrenza)”
(Hjelmslev 1933, trad. it. pp. 69-70). Si tratta di un procedimento dicotomico e
binaristico che stipula dipendenze e indipendenze fisse, ruoli attribuiti per sempre, al di fuori dei contesti e delle situazioni comunicative. C’è distintività senza continuità; differenza con indifferenza.
Per rappresentare la semiosi verbale Hjelmslev adotta l’immagine della rete in quanto “più conforme ai fatti” (ivi, p. 67), rete che, per estensione del metodo glossematico, rappresenta anche la semiosi non verbale. Si tratta in ogni
caso di una fattualità sincretica, e “il concetto di sincretismo, a cui si è arrivati
da premesse linguistiche interne, si potrebbe usare utilmente per gettare luce
sui vari fenomeni di cui si presume che non siano linguistici” (Hjelmslev 1943,
trad. it. p. 99; cors. ns.).
La reticolarità si rivela come partecipazione di aspetti o profili simultanei di
una categoria, posti sullo stesso piano e con gli stessi diritti (cfr. p. 60), piuttosto che come disposizione verticale, ad albero, di qualità o di importanza decrescenti. Il sincretismo infatti è legato a un principio di partecipazione. La fattualità della semiosi è appunto un sincretismo, o un intrico partecipativo che interessa tutto il mondo della vita e l’estensione di questo mondo. Punto di partenza inderogabile, costante e anipotetico è proprio l’estensione della materia
vivente che nel suo realizzarsi ed esplicarsi assume pieghe diverse, concentrazioni o intensificazioni diverse attraverso un processo di interpretazione/determinazione. Questa tensione fra un’estensione e le sue varie intensificazioni
ci riporta alla sublogica del segnico (cfr. Caputo 2003, cap. 4; 2004, cap. 4) retta dalle opposizioni partecipative tra termini estensivi ed intensivi del tipo A/A
+ non A, oppure A vs A + B + C + D….
Il termine estensivo viene delimitato e soprattutto connotato da un termine
intensivo che è variabile rispetto al primo, vale a dire che può esserci oppure
no. E tuttavia l’estensivo si protende nell’intensivo, crea un canale di collegamento, esso – dice Hjelmslev (1933, trad. it. p. 60) – “non è caratterizzato dalla mancanza di qualcosa, ma dal fatto di poter occupare qualunque parte della zona; il termine intensivo invece si colloca definitivamente in una sola casella e non ne varca i confini”.
Se A è estensivo e non A è intensivo, A, potendo denotare sia l’assenza
si possono manifestare in due modi diversi: come fusioni o come implicazioni. Con fusione intendiamo una manifestazione di un sincretismo che,
dal punto di vista della gerarchia della sostanza, è identica alla manifestazione di tutti i funtivi che entrano nel sincretismo, o di nessuno di essi. […] Con implicazione intendiamo una manifestazione di un sincretismo che, dal punto di vista della gerarchia della sostanza, è identica alla
manifestazione di uno o più funtivi che entrano nel sincretismo, ma non
di tutti. […]
Vogliamo sottolineare che questo uso del termine implicazione concorda
con quello della logistica, e non è che un esempio particolare di esso.
L’implicazione è una funzione “se-allora” […]. L’implicazione logica fra
proposizioni non ci pare che un altro caso particolare dell’implicazione
linguistica (Hjelmslev 1943, trad. it. pp. 97-98).
Il se dell’implicazione è l’esteso, il presupposto o il polo costante di un’opposizione partecipativa, o ancora una sovrapposizione (fusione) di conseguenze possibili che in presenza di un certo contesto, che è variabile, discretizza la
sua continuità. Si tratta, in altri termini, di una “determinazione” (se ←« allora;
Grund/Folge) in cui la conseguenza (l’allora) implica una serie di possibilità
(essa stessa compresa) sincretizzate nella premessa (il se). Non si prospetta
un percorso unilaterale, monosemiosico, causalistico e prestabilito, bensì un
percorso plurale, multilaterale, non prestabilito, dipendente dall’azione della
materia fisica e culturale, dalle pratiche comunicative, testuali, sociali, economiche, biologiche, e dalle disposizioni o inclinazioni, dalle “nervature” del sistema di partenza che funge da premessa o condizione.1
La “determinazione” è una funzione semiotica che stabilisce un percorso interpretativo in cui la forza trainante è nel polo variabile, ossia negli interpretanti (cfr. Caputo 2003, cap. 2).
Il percorso di determinazione è l’esplicazione e la concretizzazione/discretizzazione di un sincretismo attraverso l’azione selettiva di un interpretante, o,
in termini glossematici, attraverso una catalisi: “una registrazione di coesioni
[interdipendenze e determinazioni] attraverso il rimpiazzamento di un’entità
con un’altra rispetto a cui la prima ha sostituzione” (Hjelmslev 1943, p. 103). Si
tratta dell’inserimento di nuove entità (nuovi tratti semantici, nuove connotazioni) in un intreccio semiosico che viene così adattato a nuove esigenze: un processo di trasformazione o traduzione da uno stato ad un altro, provocato da un
NOTE
che la presenza di un tratto semantico, può supplire a un’intensificazione non
superficializzata o non espressa. ‘Umano’, ad esempio, è estensivo rispetto a
‘umano-donna’, ‘umano-uomo’, ‘umano-bambino’ che ne sono intensificazioni;
si vede inoltre come ‘umano’ si ripete o si prolunga nelle sue determinazioni/intensificazioni o interpretazioni. ‘Umano-donna’, ‘umano-uomo’, ‘umano-bambino’ non sono subordinati a ‘umano’ in quanto inferiori, ma lo sono in quanto
‘umano’ funge da premessa o condizione: è un fatto funzionale (o di forma) non
sostanziale. I termini intensivi sono implicati e fusi, sincretizzati, nell’estensività che la pratica sociale, ideologica, comunicativa di una data comunità concretizza ed esplica. I sincretismi, riassume Hjelmslev nei Fondamenti,
105
106
catalizzatore o un interpretante la cui natura genera varie forme semiosiche e
semiotiche.
La tensione tra fluenza e conservazione, o tra divenire e stabilità, caratterizza la semiosi in tutte le sue forme, o in tutte le forme nelle quali essa si traduce. Ogni esistenza è l’espressione di un conflitto tra l’effetto erosivo e degradante della durata e un principio di permanenza che ne garantisce la stabilità. Ogni
forma sussiste tra il panta rei e il suo specifico logos, come dice René Thom (cfr.
2006, p. 113) richiamandosi a Eraclito; ogni forma, in altri termini, è un ‘terzo’ fra
due poli opposti e in quanto tale costituisce una relazione segnica.
In questo processo morfogenetico e topologico la modellazione biosemiosica rimane costante pur nelle sue traduzioni. La morfogenesi si realizza nell’opposizione partecipativa, o “determinazione”, in senso glossematico, fra globale (esteso) (A) e locale (concentrato) (non A) dove il globale è appunto la modellazione biosemiosica in quanto criterio generale e originario della vita in tutte le sue specificazioni o localizzazioni nei vari corpi viventi. Che questo sia un
processo segnico lo conferma anche Thom quando in Topologia e significazione scrive: “Una disciplina che cerchi di precisare il rapporto tra una situazione
dinamica globale (il ‘significato’) e la morfologia locale (il ‘significante’) nella
quale si manifesta, non è per l’appunto una ‘semiologia’?” (ivi, p. 26).
La dimensione sigma è dunque la dimensione segnica nella sua doppia articolazione semiosica (materiale) e semiotica (formale o metasemiosica); è, in
altre parole, la dimensione della reticolarità in cui i membri di una stessa categoria sono sullo stesso piano e ciascuno di essi è in pari tempo dipendente e
indipendente da qualsiasi altro membro, a seconda della direzione del percorso interpretativo o di attraversamento della rete impressa dall’interpretante.
Una categoria è un sistema fra i cui membri esistono delle dipendenze e
delle indipendenze che costituiscono una struttura. Nominativo, genitivo, dativo, accusativo, ablativo sono membri della categoria dei casi; singolare e plurale della categoria del numero; maschile, femminile e neutro della categoria
del genere. Una stessa categoria può formare sistemi diversi e realizzarsi in
modi diversi:
Così la categoria dei casi si ritrova invariabilmente in sanscrito, in latino
e in tedesco; ma il sistema dei casi differisce da una di queste lingue all’altra, dal momento che il numero dei casi non è lo stesso, e che le correlazioni contratte reciprocamente dai casi sono proprie ad ogni lingua, al
punto che non esiste alcun caso che si definisca in modo assolutamente
identico in tutte le lingue. […]
Ciò che vale per i casi vale allo stesso modo per qualsiasi altra categoria grammaticale. Il sistema è pertanto la forma specifica sotto cui la categoria si realizza in una data lingua (Hjelmslev 1933, p. 46).
In linea con le indicazioni di Hjelmslev – come altrove abbiamo fatto notare
(cfr. Caputo 2003) –, ciò vale anche per la categoria del segno, su cui torneremo fra poco. Per ora dobbiamo sottolineare che non esistono categorie né sistemi assoluti e che le categorie “sono generali, non universali. Esse sono realizzate nel sistema di un qualsiasi stato di lingua, ma risiedono nel linguaggio
NOTE
a titolo di possibilità”; sono “preesistenti alla lingua, generali e realizzabili. Esse vengono realizzate, in una data lingua [ma possiamo hjelmslevianamente
dire in un dato sistema di segni] dalle combinazioni e dalle determinazioni”
(Hjelmslev 1938, trad. it. pp. 107-108). Le categorie, inoltre, sono definite in base a criteri funzionali e più precisamente “in base a un fenomeno di rection,
non in base al significato” (Hjelmslev 1939a, trad. it. p. 140), anche se tale nozione “non esaurisce tutte le funzioni possibili”. La “rection”, che è una determinazione, non è “la sola possibilità funzionale che si presenti”. Oltre a questa
dipendenza “unilaterale e obbligatoria”, vi è una “interdipendenza o dipendenza bilaterale e obbligatoria”, e una “costellazione o dipendenza facoltativa” (ivi,
p. 145). Le entità, o meglio i funtivi che entrano a costituire una struttura o una
particolare forma segnica si definiscono a seconda delle funzioni che contraggono con altre entità. Ciò dice della relatività e mobilità delle categorie e dei loro costituenti (sotto-categorie).
Una categoria è uno spazio relazionale; ovviamente una categorizzazione
è un processo di imposizione di relazioni ad opera di un organismo o di una
mente vivente: il tipo di relazioni è congruente alla capacità relazionale della
mente. La dimensione sigma è lo spazio relazionale costituito dalla categoria
del segno.
Nel saggio La sillaba come unità strutturale, Hjelmslev (1939c, trad. it. p.
238) descrive la lingua come “una categoria composta di due membri, detti piani”: il piano plerematico (o del contenuto) e il piano cenematico (o dell’espressine). In ogni piano ci sono altri membri e “un’unità costituita da membri in un
piano può implicare un’unità costituita da membri nell’altro”, il che vuol dire che
i due piani “sono definiti in termini di una relazione reciproca”, ma vuol dire anche che “ciascun piano è una categoria”.
E data la validità del metodo glossematico per ogni sistema segnico e non
soltanto per la lingua storico-naturale, ne segue che il segno è una categoria
(e in quanto tale contrae altre funzioni con i sistemi non segnici) e una funzione di categorie. Gli strata del segno (ossia la forma dell’espressione, la forma
del contenuto, la sostanza dell’espressione e la sostanza del contenuto), infatti, non sono che categorie e dimensioni di funtivi che possono presentarsi come determinanti, determinate, determinanti e determinate al contempo, come
solidali e/o combinate, come solidali e combinate al tempo stesso, oppure come funtivi che non contraggono affatto funzione, secondo lo spettro di possibilità funzionali che Hjelmslev traccia nei Fondamenti (cfr. 1943, trad. it. pp. 9394). Questa rete di dipendenze è la base della stratificazione del linguaggio o
del sistema semiotico (cfr. Hjelmslev 1954).
La dimensione sigma fuoriesce dalla ontologia del segno e dalla semiotica
idealistica per supportare una semiotica materialistica e critica; essa adotta un
punto di vista sistematologico che scarta le definizioni individuali e ogni tipo di
atomismo. Ogni unità viene definita dai suoi rapporti con le altre unità dello
stesso sistema. Si tratta di una “visione totalista”, come direbbe Hjelmslev
(1935, trad. it. p. 171), che essendo una visione relazionale non ha nulla di assolutistico o totalitario, sicché – con le parole di François Rastier (2006, p. 99)
– “le concept de globalité semble-t-il préférable à celui de totalité, car il dessi-
107
108
ne une clôture relative et non plus absolue”. Questo tipo di (semio-logica) consente un affrancamento dal fascino delle scienze logico-formali e dell’organicismo vitalistico che vedono le strutture (culturali, cognitive, linguistiche) come
totalità chiuse; si tratta cioè di una concezione morfodinamica dei segni o delle piegature (testualizzazioni) della semiosi.
Le forme non sono tutte uguali, come pretende l’approccio onto-logicogrammaticale di tante filosofie della significazione basate sulla cosalizzazione
(feticizzazione) del significato, ossia sul significato “inteso come ‘proprietà’
esclusiva, interna, oggettiva del segno”, prospettiva entro la quale la verità è
vista come “adeguazione o corrispondenza al referente (concepito come fisicamente esistente) […] e separata dalle procedure interpretative e comunicative” (Caputo, Petrilli, Ponzio 2006, p. 56)2.
Le forme sono imperfettamente uguali perché sono sempre segnate in una
o più sostanze-materie da un percorso interpretativo situato nella rete dei segni, dove, cioè, la determinazione del significato non è confinabile né nel segno “come cellula isolata” né in un solo tipo di segni (ivi, p. 57). Le forme sono
sempre forme/segno, o meglio sono forme del ‘semiosico’ e del ‘semiotico’, per
cui dobbiamo più propriamente parlare di morfologia del semiosico e morfologia del semiotico (v. oltre).
Una stessa categoria – s’è detto – può formare sistemi diversi e realizzarsi
in diversi modi: a differire è il sistema e le relazioni che intercorrono fra i membri che lo costituiscono. Si è anche detto, ancora con Hjelmslev, che il sistema
è il modo specifico in cui una categoria si realizza in una data forma segnica.
La categoria dei segni si realizza in sistemi diadici, con due membri, e in sistemi triadici, con tre membri, il che condiziona la semiosi che ne deriva. Nei sistemi diadici prevale la segnalità, la codifica o il codice come mera nomenclatura, scambio eguale tra significante e significato. È la concezione popolare e
ingenua, oltre che quella informazionale della semiosi e della comunicazione.
Nei sistemi triadici, invece, prevale la segnità, l’asimmetria tra significante e significato, l’azione dell’interpretante e dell’interprete. In Hjelmslev la categoria
dei segni si realizza in un sistema a tre termini: forma, sostanza e materia. I loro rapporti sia sul piano dell’espressione sia su quello del contenuto definiscono le varie forme di semiosi. Anche in Peirce i membri del sistema semiotico
sono tre: oggetto, segno e interpretante e dalle loro correlazioni deriva la varietà della semiosi: iconica, indicale, simbolica.
3. Le categorie della comunicazione e la semiotica
Se, come dice Thomas A. Sebeok (1981, trad. it. p. 151) “ogni forma di comunicazione è una manifestazione della vita” e la riproduzione della vita stessa è un processo comunicativo regolato dal codice genetico, ne deriva che la
vita in quanto comunicazione è semiosi, e la semiotica, che ha per oggetto di
studio la semiosi, è scienza dei segni della vita e scienza della comunicazione
in tutte le loro forme. Tutto il vivente comunica ma non allo stesso modo. ‘Comunicazione’ vale in maniera imperfettamente uguale fra l’ameba e l’uomo.
NOTE
Biosemiosi, microsemiosi, fitosemiosi, micosemiosi, endosemiosi, zoosemiosi,
antroposemiosi, cibersemiosi sono localizzazioni della globalità della comunicazione.
Ma anche nell’ambito antroposemiosico ‘comunicazione’ ha varie declinazioni; ne riportiamo quelle individuate da Michele Sorice (2006).
1)
“Comunicazione come contatto”, che “assorbe anche l’idea di comunicazione come ‘partecipazione’” (p. 19).
2)
“Comunicazione come trasferimento di risorse e influenza. È il caso più
semplice e rozzo di trasmissione”, in cui “non esiste alcuna dimensione
interpretativa”. In quest’ambito “si può situare, pur con qualche difficoltà
concettuale, la definizione di comunicazione come influenza”, fondata
“su un modello sostanzialmente comportamentista” che risulta essere
anche una delle “più semplicistiche teorizzazioni” della comunicazione,
vista come “inoculazione di messaggi, idee, orientamenti su un pubblico
di massa considerato sostanzialmente passivo e incapace di produrre
elaborazioni proprie” (pp. 19-20).
3)
“Comunicazione come passaggio di informazione”, concezione esposta
originariamente da Shannon e Weaver nel secondo dopoguerra e derivante dal bisogno di rendere più efficace la trasmissione. Sotto questo
ombrello paradigmatico di tipo diadico, Sorice colloca “le elaborazioni di
Roman Jakobson” (cfr. anche Caputo 2006b, pp. 73-81), “l’idea di comunicazione delegata […], in cui l’emittente e il ricevente sono rappresentati nel messaggio”, i “concetti di Autore Modello e Lettore Modello, elaborati da Eco” (Sorice 2006, p. 20).
4)
“Comunicazione come condivisione”, accezione strettamente connessa
all’etimologia di ‘comunicazione’, ovvero al ‘rendere comune’, ‘unire’,
‘partecipare’, ‘condividere’, determinare “un sistema organico e coerente nel quale le persone producono la loro percezione della realtà sociale” (ivi, pp. 20-21). Sulla scorta della lezione della bio e della zoosemiotica aggiungiamo che ciò non accade solo negli animali umani, ma anche negli altri organismi viventi (gli animali non umani) dotati di una specie-specifica capacità di percezione/modellazione (Umwelt) della realtà
pur di natura non sociale, a conferma della comunicazione come dimensione fondamentale della vita in tutte le sue modalità.
5)
“Comunicazione come inferenza”, modello alternativo a quello informazionale: il processo comunicativo si sostanzia “in una complessa attività
di costruzione di indizi e produzione di congetture (inferenze, implicature) sugli indizi prodotti dagli interlocutori. […] Sperber e Wilson – dice
Sorice – parlano a questo proposito di comunicazione ostensivo-inferenziale”, fondata cioè “sull’esibizione – anzi sulla vera e propria ostentazione – di segni linguistici che permettono al destinatario di produrre significati” (ivi, p. 21).
6)
“Comunicazione come scambio”, in cui è compresa anche l’idea della
cooperazione e quella della competizione. In quest’ambito Sorice colloca le strategie di marketing. “In questo caso, affinché possa parlarsi di
scambio è necessario che i due poli della comunicazione abbiano deter-
109
110
minate caratteristiche: possiedano valori (informazioni, merci, servizi,
ecc.) da scambiarsi, siano in grado di comunicare informazioni specifiche e trasferire valore da una parte all’altra” (ivi, p. 22). Si tratta di una
comunicazione prettamente commerciale, quantificata e omologante.
In questa cornice concettuale Sorice situa inoltre “le elaborazioni di impostazione antropologica che considerano lo scambio di valori sociali,
condotto secondo determinate e specifiche regole (talvolta ritualizzate),
come attività comunicativa” (ib.).
7)
“Comunicazione come relazione sociale” (ib.): una accezione che Sorice indica a parte per rimarcarne la rilevanza, ma che sottende e attraversa tutte le altre forme di comunicazione umana.
8)
“Comunicazione come interpretazione”, concetto fondato “sui presupposti teorici dell’ermeneutica” (ivi, p. 23) la cui idea centrale è che la fruizione di un messaggio o di un testo non possa ridursi all’atto della mera decodifica (per quanto coerente con le intenzioni dell’emittente o dell’autore), bensì alla produzione, sulla base di abduzioni, di nuova comunicazione, nuovo senso. Il concetto di interpretazione/comunicazione è
qui innervato alla pratica della traduzione creativa.
In queste sotto-categorie della rete comunicativa ci sono delle intersezioni.
La sotto-categoria 1 (“comunicazione come contatto”) si intreccia con la 4 (“comunicazione come condivisione”), accomunate dall’azione partecipativa e dalla socialità (a livello umano) che instaurano, incontrandosi così con la sotto-categoria 7 (“comunicazione come relazione sociale”).
La “comunicazione come trasferimento di risorse e influenza” (2) va a intrecciare e partecipare le accezioni 3 (“comunicazione come passaggio di informazione”) e 6 (“comunicazione come scambio”). Queste sotto-categorie sono basate e si realizzano su un sistema binario, costituito da un emittente e un
ricevente, un significante e un significato.
La “comunicazione come condivisione” (4), a sua volta, si intreccia con la
“comunicazione come inferenza” (5) e con la sotto-categoria 8 (“comunicazione come interpretazione”), basate, queste ultime, su un sistema ternario, costituito da un segno, un oggetto e un interpretante.
La categoria (il globale) della comunicazione si realizza in modi diversi, in
sotto-categorie (il locale) che si intersecano e si compenetrano in un reticolo
continuo e illimitato.
La semiotica, triadicamente impostata, si propone come studio unificato,
“sistematologico” o “totalista” (per ritornare alle connotazioni teoriche hjelmsleviane; cfr. supra), di ogni fenomeno di significazione e di comunicazione, ovvero, nella prospettica peiceano-sebeokiana, come semiotica globale, ma si propone anche come un’organizzazione teorica in cui si relazionano comunicazione, interpretazione e significanza, dove la comunicazione è il relatum costante che viene manifestato o concretizzato ora come interpretazione ora come significanza, ossia ora come semiosi consapevole, intenzionale, ora come semiosi inconsapevole, inintenzionale. Ciò vuol dire che la comunicazione non è
soltanto quella prodotta e pensata come tale, ma anche quella che il soggetto
comunicante non controlla.
4. Il semiosico e il semiotico
Avendo per oggetto la semiosi, che è costitutiva di tutto il vivente, la semiotica ha per oggetto una estensione indefinita, illimitata di tensioni, opposizioni
partecipative che, seguendo il suggerimento di Hjelmslev3, indichiamo con i
neutri semiosico e semiotico, i quali prendono forma attraverso la capacità di
modellazione osservabile in tutte le forme di vita.
Pensiamo sia preferibile ‘semiotico’ a ‘linguaggio’. Quest’ultimo termine può
infatti generare molti equivoci non solo perché porta con sé i significati aggiuntivi della tradizione filosofica, ma anche perché è molto eterogeneo l’ambito dei
suoi interpretanti e delle sue espansioni, come ‘linguaggio della moda’, ‘linguaggio delle merci’, ‘linguaggio dell’inconscio’, ‘linguaggio gestuale’, ‘linguaggio del computer’, ‘linguaggio della vita reale’, ovvero linguaggio dell’attività
materiale e delle relazioni sociali degli uomini. In queste accezioni ‘linguaggio’
specifica il semiotico non verbale. Esso, inoltre, è adoperato per riferirsi a determinati settori della lingua, o meglio del semiotico verbale, come ‘linguaggio
giornalistico’, ‘linguaggio sportivo’, ‘linguaggio filosofico’, ‘linguaggio burocratico’, ecc.. Il termine ‘linguaggio’ dunque denota tanto i segni verbali quanto i segni non verbali della semiosi umana, mentre per la semiosi del vivente in generale è più opportuno parlare soltanto di ‘messaggi’, ‘codici’, ‘sistemi di segnali e di trasferimenti’. Possiamo pertanto spiegare la distinzione fra semiotico e semiosico introdotta poco sopra, precisando che il primo neutro riguarda
la semiosi umana, mentre il secondo riguarda la semiosi-vita in tutta la sua
estensione, ivi compresa la vita dell’umano.
Il semiotico va quindi distinto in semiotico linguistico verbale e semiotico linguistico non verbale. Il semiosico è invece ‘non linguistico’, anche se nell’umano può diventare ‘linguistico’. L’aggettivo ‘linguistico’ indica la provenienza
umana della morfologia del semiotico (cfr. Caputo 2007), ossia il suo essere un
prodotto del lavoro del linguaggio inteso come capacità sintattica o congegno,
o procedura di modellazione primaria specie-specifica dell’umano, e non come
un congegno di comunicazione. Sono piuttosto le sostanze semiotiche verbali
e non verbali a svolgere la funzione comunicativa.
Il semiosico e il semiotico sono fenomeni di natura biologica e culturale, includendo in “culturale” anche la ‘cultura della natura’, o capacità di ripiegamento (auscultazione) della materia su se stessa (cfr. Prodi 1988).
Il semiosico è un’estensione costituita dalla materia bio-chimico-fisica,
mentre il semiotico ne è un’intensificazione o una piegatura propria del bíos
umano ad opera della sua capacità sintattica o capacità metasemiosica, astraente e progettante. Si pone dunque un’opposizione partecipativa in cui il semiosico si estende nel semiotico e ne costituisce la condizione necessaria di
NOTE
La comunicazione in ogni caso è il punto di partenza della semiotica: non è
possibile non comunicare, ne va della condizione stessa della vita. La semiotica studia i processi di comunicazione, o meglio la semiotica è la scienza fondamentale della comunicazione in tutte le sue declinazioni.
111
112
sussistenza e in cui il semiotico intensifica (o determina) il semiosico producendo altri segni o altra semiosi col suo lavoro di categorizzazione (cfr. Caputo 2004, pp. 118-126).
La comparsa di forme naturali e culturali più complesse come il bíos umano e come le forme sociali e metaculturali che esso produce, ivi incluse le loro
modalità di riproduzione, richiedono stabilizzazioni più raffinate che si realizzano attraverso la funzione simbolica del linguaggio. Se infatti nell’animale non
umano l’attività semiosica è legata eminentemente alla regolazione o alla finalità della salvaguardia e della riproduzione della propria forma di vita, nell’animale umano essa si estende anche a ciò che è biologicamente indifferente e
si realizza come attività semiotica o metasemiosica (cfr. Caputo 2006b, cap. 7).
Le forme del semiosico e del semiotico non sono altro che increspature o
piegature del continuo eracliteo della comunicazione vitale per via di una “catalisi” e di un catalizzatore (un gas, una luce, l’acqua, la mimesi, la capacità
sintattica, la percezione, un contesto teorico, una situazione sociale, ecc.). In
altri termini, la morfogenesi è l’esplicazione di sincretismi ad opera di vari interpretanti più o meno complessi.
La dimensione sigma dunque è una architettura bifacciale che rompe con
l’idealismo semiotico anche di certo strutturalismo incline al formalismo e al logicismo, secondo cui la materia è un continuum amorfo e passivo che l’imposizione della forma come principio attivo suddivide in zone ben delimitate, generando un dualismo dicotomico e parallelistico che oppone la parte non semiotica della materia alla semioticità della forma. Si prospetta invece un pensiero strutturale attento ai fondamenti semiosici delle forme che all’arte del taglio contrappone l’arte della piegatura, al procedere per divisioni e subordinazioni contrappone il procedere per dimensioni, intrecci, alla logica dell’esclusione quella della partecipazione. Ciò comporta inoltre una curvatura in senso semiotico dell’ermeneutica, vale a dire un’ermeneutica materiale e materializzata che non attiene all’ontologia o all’essere del segno bensì alla sua materia
(cfr. Caputo 2006a).
La dimensione sigma ricentra l’attenzione sulle componenti iletiche del senso, sovverte cioè la ragione insensibile e autoreferenziale, e fa emergere la responsabilità del pensare.
Riferimenti bibliografici
AUGIERI C. A. (a cura), Esperienze di lettura e proposte di interpretazione, Ediz. G. Laterza, Bari, 2006.
CAPUTO C., 2003, Semiotica del linguaggio e delle lingue, Graphis, Bari, 2003.
CAPUTO C., 2004, Semiotica e comunicazione, Edizioni dal Sud, Bari, 2004.
CAPUTO C., 2006a, Semio-logica della lettura, in Augieri, 2006.
CAPUTO C., 2006b, Semiotica e linguistica, Carocci, Roma, 2006.
CAPUTO C., Tutto il segnico umano è linguaggio, in Petrilli 2007, pp. 131-160.
CAPUTO C., PETRILLI S., PONZIO A., Tesi per il futuro anteriore della semiotica, Mimesis,
Milano, 2006.
DEELY J., Basics of Semiotics, Bloomington, Indiana U. P., 2002; trad. it., Basi della semiotica, Ediz. G. Laterza, Bari, 2004.
ECO U., Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 1975.
ECO U., Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano, 1997.
GALASSI R., Valeur linguistique et valeur sémiotique du principe Grund/Folge, in Galassi, De Michiel, 2001, pp. 25-42.
GALASSI R., DE MICHIEL M. (a cura), Louis Hjelmslev a cent’anni dalla nascita, Imprimitur, Padova, 2001.
GALASSI R., MORANDINA B., ZORZELLA C. (a cura), Janus 6. Studi in onore di Eli FischerJørgensen, Terra Ferma, Vicenza, 2006.
GARRONI E., Progetto di semiotica, Laterza, Roma-Bari, 1972.
GARRONI E., Ricognizione della semiotica, Officina, Roma, 1977.
HJELMSLEV L., 1933, Structure générale des corrélations linguistiques, “Travaux du Cer-
NOTE
1 La relazione di causalità, al contrario, lega in un rapporto di necessità e univocità l’effetto alla sua causa, sì che da una causa precisa deriva un effetto preciso, impostazione che rientra nella logica dell’esclusione e della non contraddizione: da una causa A non proviene simultaneamente l’effetto B1 e B2, si ammette cioè un solo elemento conseguente e un percorso unilineare e deduttivo, Su questa problematica cfr. Galassi 2001, Orfano 2006.
2 Le strutture ubiquitarie come il “quadrato semiotico” di Greimas “ne sont pas à proprement
parler sémiotiques”. Solo una forzatura formalista ha permesso a questo famoso quadrato di essere considerato come organizzatore di ogni narratività, osserva Rastier (2006, p. 99). In altra sede lo stesso Rastier (2001, trad. it. p. 88) ne parla come dell’“ennesima testimonianza dell’origine
logica del concetto di significazione”. A proposito del paradigma testualista di scuola greimasiana,
Claudio Paolucci (2006, pp. 123, 139-140) parla di “una nuova forma di imperialismo semiotico”
che comprime la molteplicità della semiosi nell’unità omogenea di un metalinguaggio, cui contrappone l’“antilogos” della semiotica interpretativa.
3 In Numerus et genus leggiamo: “in tutti i casi in cui sussista una chiara opposizione si usa il
genere neutro per indicare una quantità ‘indefinita’, la massa, l’informe o il non formato, l’indistinto, l’illimitato, ciò che in qualche modo viene percepito come qualcosa in espansione, che si dispiega; per questo concetto ho proposto un termine: l’espansivo. Al contrario, il genere comune si usa
per indicare un oggetto definito e formato, un individuo, ciò che in qualche modo viene percepito
come una cosa unita, delimitata, ben circoscritta; ho proposto: il concentrato (Hjelmslev 1956, trad.
it. pp. 12-13).
113
114
cle Linguistique de Copenhague”, XIV, 1973, pp. 57-98; trad. it., Struttura generale delle correlazioni linguistiche, in Hjelmslev 1991, pp. 43-88.
HJELMSLEV L., 1935, La catégorie des cas. Étude de grammaire générale, première partie, “Acta Jutlandica”, VII, 1, pp. I-XII e 1-184; trad. it. 1999, La categoria dei casi. Studio di HJELMSLEV L., 1938, Essai d’une théorie des morphèmes, “Actes du
IV Congès Int. des Linguistes 1936”, Copenhague, pp. 140-151; trad. it., Per una
teoria dei morfemi, in Hjelmslev 1991, pp. 97-109.
HJELMSLEV L., 1939a, La notion de rection, “Acta linguistica. Revue Int. de Linguistique
Structurale”, 1, pp. 10-23; trad. it. La nozione di rection, in Hjelmslev 1991, pp.
136-148.
HJELMSLEV L., 1939b, La structure morphologique, “V Congrès Int. des Linguistes, Rapports”, Bruges, pp. 66-93; trad. it. La struttura morfologica, in Hjelmslev 1991,
pp. 110-135.
HJELMSLEV L., 1939c, The Syllabe as a Structural Unit, “Proceeding of the Third Int. Congress of Phonetic Sciences, Ghent 1938”, Gand, pp. 266-272; trad. it., La sillaba come unità strutturale, in Hjelmslev 1991, pp. 233-240.
HJELMSLEV L., Omkring sprogteoriens grundlæggelse, Ejnar Munksgaard, Copenhague,
1943; trad. it., I fondamenti della teoria del linguaggio, a cura di G.C. Lepschy,
Einaudi, Torino, 1968.
HJELMSLEV L., La stratification du langage, “Word”, 10, 1954, pp. 163-188; trad. it., La
stratificazione del linguaggio, in Hjelmslev 1988, pp. 213-246.
HJELMSLEV L., Om numerus og genus, “Festskrift til Christen Møller”, Borgens Forlag,
Copenhague, 1956, pp. 167-190; trad. it., Numerus et genus, “Janus. Quaderni
del Circolo Glossematico”, 3, 2003, pp. 11-24.
HJELMSLEV L., Saggi linguistici, a cura di R. Galassi, Unicopli, vol. I, Milano, 1988.
HJELMSLEV L., Saggi linguistici, a cura di R. Galassi, Unicopli, vol. II, Milano, 1991.
ORFANO E., Osservazioni sul principio Grund/Folge e confronto con il principio dsi Causa/Effetto, in Galassi, Morandina, Zorzella 2006, pp. 169-184.
PAOLUCCI C., Antilogos. Imperialismo testualista, pratiche di significazione e semiotica
interpretativa, “Semiotiche”, 4, 2006, pp. 123-142.
PETRILLI S., (a cura), La filosofia del linguaggio come arte dell’ascolto, Edizioni dal Sud,
Bari, 2007.
PRODI G., La cultura come ermeneutica naturale, “Intersezioni”, VIII, 1, 1988, pp. 23-48.
RASTIER F., Arts et sciences du texte, PUF, Paris, 2001; trad. it., Arti e scienze del testo,
Meltemi, Roma, 2003.
RASTIER F., La structure en question, in Galassi, Morandina, Zorzella, 2006, pp. 93-104.
SEBEOK TH. A., The Play of Musement, Bloomington, Indiana U. P., 1981; trad. it., Il gioco del fantasticare, Spirali, Milano, 1984.
SORICE M., I media. La prospettiva sociologica, Carocci, Roma, 2006.
THOM R., Morfologia del semiotico, a cura di P. Fabbri, Meltemi, Roma, 2006
LA FAMIGLIA TRA LA COSTITUZIONE
E I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ
1. Crisi della famiglia nella società individualistica
L’inizio del XXI secolo è un momento molto importante per la società italiana e per la famiglia in particolare, in quanto viviamo anni di transizione caratterizzati dalla continua emorragia di valori sia politici che sociali. In questo frangente di estrema difficoltà, la famiglia dovrebbe essere una colonna portante
per la crescita del cittadino italiano, ma si dimostra anch’essa in un’evidente
confusione d’identità in quanto l’evoluzione della società verso posizioni meno
tradizionali ha fatto sì che l’istituto familiare non venga più considerato come
fondato esclusivamente sul matrimonio. Questa apertura della famiglia a posizioni meno ortodosse se da una parte è il chiaro sintomo di una richiesta della società italiana di mettersi al passo con altre realtà europee, dall’altra pone
su di un livello di incertezza questo istituto, che nella storia italiana ha avuto da
sempre un ruolo tradizionale.
La Costituzione italiana, che quest’anno festeggia il suo sessantesimo anniversario, ha dedicato alla famiglia i primi articoli riguardanti i rapporti eticosociali. Gli articoli 29, 30 e 31 sono i primi che si incontrano nel Titolo II della
nostra Carta e questo fa sì che risulti evidente come i padri costituenti abbiano voluto dare un valore molto alto a questo istituto all’interno dello Stato italiano1. Il problema di cui i padri costituenti non potevano tener conto è di come
l’Italia dopo il secondo conflitto mondiale abbia sviluppato una concezione individualistica della società. Questa visione individualistica, che ha le proprie radici nella rivoluzione francese, ha indirizzato verso una concezione di famiglia
sempre meno numerosa. Il rapporto tra una famiglia unipersonale e una con
almeno 5 componenti si è invertito in proporzioni considerevoli negli ultimi trent’anni. Se nel 1971 vigeva un rapporto di 1 a 2 a favore delle famiglie numerose, oggi ne abbiamo invece uno di quasi 4 a 1 a favore dei nuclei unifamiliari2.
Questa inversione di tendenza è il chiaro segnale del modello a cui si è ispirato il legislatore nel modificare il codice nel 1975. I fondamenti a difesa della solidità della famiglia avrebbero dovuto essere la libertà e la responsabilità dei
due coniugi ed in questa chiave fu inteso anche il concetto di separazione personale in modo che i singoli individui potessero autotutelarsi3, ma l’autotutela,
che sulla carta poteva essere una iniziativa di spessore per rendere i coniugi
finalmente responsabili, ha portato invece solo alla riduzione sensibile del numero dei componenti il nucleo, mettendo in evidenza l’incapacità dell’uomo di
gestirsi senza veri precetti esterni.
La rarefazione della famiglia e l’individualizzazione delle logiche familiari so-
NOTE
di Pierandrea Casto
115
116
no oggi i due processi che delineano la nuova struttura che si viene formando e
che procedono sulla stessa direttiva in quanto la rarefazione della famiglia avviene in virtù di una visione sempre più individualistica delle politiche familiari4. Con
la riforma del codice del 1975 e le leggi sulla separazione e sull’aborto da una
parte si è fornita una seria risposta ai mutamenti della società in chiave di emancipazione femminile e organizzazione della famiglia, dall’altra, tuttavia, si è dimostrato chiaramente come l’anello debole, all’interno del nucleo familiare, sia la
prole. Questo significativo dato di fatto deriva dai sempre più numerosi contenziosi sull’assegnazione dei figli da parte delle coppie separate e dalla perdita del
significato concreto di prole, che non è più vista come il dono e il soggetto da tutelare, ma come un bene di cui disporre a piacere. Il rapporto tra la famiglia e la
società è diventato esso stesso problematico, in quanto il nucleo familiare è oggi molto debole; ciò è dovuto al fatto che i propri componenti, ed in particolare i
coniugi, non sono più legati tra loro in un principio solidale di vinculum familiaris,
mentre si sentono soltanto legati alla società (vinculum societatis)5.
La società negli ultimi decenni ha assorbito buona parte dei compiti della famiglia, in quanto gli individui non instaurano più all’interno delle mura domestiche legami solidi, ma guardano alla famiglia come ad un involucro in cui fare
emergere le proprie individualità. Ci troviamo di fronte alla prospettiva auspicata dalla Rivoluzione francese: l’individuo in diretto rapporto con le istituzioni.
Non si può negare che l’uomo debba essere libero e mai costretto a seguire le
direttive che la propria famiglia vuole imporre; la libertà è un diritto inviolabile
dell’uomo e la realizzazione delle proprie ambizioni è sicuramente il traguardo
che ognuno deve perseguire. Le richieste di una struttura familiare più vicina
alle nuove esigenze del cittadino, che vive in un ambiente globalizzato, agevolano il cammino dell’uomo in questa ottica, ma è evidente che la famiglia negli
ultimi anni, perdendo a ragion veduta il ruolo autoritario, ha perso, però, anche
il ruolo guida e formativo nei confronti dei giovani. La società odierna invia allarmi continui ai propri membri e se prima la famiglia risultava essere il cuscinetto di difesa per l’individuo, oggi la rarefazione del tessuto familiare implica
una maturazione incompleta per il singolo, che si traduce sempre più frequentemente in atti di bullismo e in manifestazioni di criminalità minorile.6
Per questi motivi, a sessant’anni dalla sua stesura, diviene fondamentale rileggere la Carta Costituzionale in modo da poter analizzare con la giusta attenzione la tematica e riassegnare alla famiglia il ruolo basilare e fondamentale nei rapporti etico-sociali dell’Italia del nuovo millennio.
2. Il Concordato del 1929 e il ruolo della famiglia durante il fascismo
La nostra Carta Costituzionale in tema di famiglia è tuttavia condizionata dal
precedente periodo storico. Se i padri costituenti svolsero un compito di rottura
completa con il ventennio fascista, portando a compimento una Carta Costituzionale più che mai democratica, per quel che riguarda l’istituto familiare i componenti della Democrazia Cristiana, in particolare, pressarono affinché rimanesse in
piedi la concezione di famiglia cattolica emanata con i Patti Lateranensi.
NOTE
La politica mussoliniana dedicò ampio spazio a ricucire i rapporti tra Stato
italiano e Chiesa, dopo l’entrata trionfale dell’esercito italiano a Roma nel 1871.
Tale cambiamento di vedute era voluto espressamente dal partito fascista in
quanto l’intento della propaganda era quello di formare un cittadino che dedicasse la sua vita allo Stato. Tale obiettivo era ottenibile con l’aiuto delle istituzioni ecclesiastiche in quanto soltanto la religione aveva l’efficacia di raggiungere ampi strati della popolazione; popolazione che viveva in gran numero nelle campagne e che aveva un livello educativo molto basso e un ampio tasso di
analfabetizzazione. La famiglia di conseguenza ebbe un ruolo sociale chiave
nella formazione del cittadino fascista, poiché doveva essere il primo nucleo a
manifestare l’interesse esplicito dello Stato-persona7. Nella dottrina fascista,
quindi, la famiglia doveva essere un’istituzione stabile e indissolubile, ovvero
parte delle fondamenta a sostegno della crescita in chiave nazionalista della
popolazione.
Successivamente alla marcia su Roma, ma prima ancora che il fascismo divenisse il regime che tutti i libri di storia ricordano amaramente, l’indissolubilità di matrimonio e famiglia era uno dei punti stabili della propaganda mussoliniana8; già nel 1924 il guardasigilli Oviglio sanciva durante la campagna elettorale questa chiara volontà del governo fascista, come era altrettanto palese
la netta opposizione a qualsivoglia proposta di reintrodurre il divorzio9. Il matrimonio conservò quindi durante il fascismo un carattere che aveva chiaramente i criteri di sacramento religioso ed è innegabile che tale decisione in tema di
matrimonio e famiglia ebbe una notevole valenza a livello sociale e nei rinati
rapporti politici con la Santa Sede10.
L’istituto matrimoniale ebbe un ruolo centrale durante gli incontri per sancire gli accordi tra Stato e Chiesa11; ed il Concordato del 1929 fu un momento di
svolta per riaffermare ufficialmente il carattere tradizionale che tale istituto doveva avere. L’articolo 34 del suddetto documento indicava come lo Stato italiano riconoscesse gli effetti civili al sacramento del matrimonio che si fosse svolto in chiesa; un chiaro segnale di come il fascismo volesse ridare importanza
alle tradizioni religiose12. Il matrimonio cattolico quindi era un atto valido anche
per lo Stato, che quindi era teso a riconoscere tutti i principi che il Vaticano riteneva fondamentali nell’istituto matrimoniale. Si offriva quindi l’opportunità al
cittadino di decidere se sposarsi in chiesa o in municipio e, sebbene la religione di Stato fosse la cattolica, il regime fascista garantiva anche di potersi sposare con un culto differente da quello ufficiale13. La facoltatività del matrimonio
civile in pratica abolì qualsiasi accezione contrattualistica dell’istituto garantendo quella eticità naturale di hegeliana memoria14.
Il fascismo delegò al matrimonio tradizionale un ruolo fondamentale che va
oltre la firma dei Patti Lateranensi. Infatti nel Codice civile del 1942, legislazione redatta durante il periodo bellico, l’istituto matrimoniale è considerato
“l’unione esclusiva al fine della procreazione”15. Sicuramente se questa espressione fosse catapultata ai nostri giorni, potrebbe essere accolta poiché inserita nelle problematiche bioetico-sociali, molto attuali nel XXI secolo, ma l’intento primario del legislatore in quel periodo era quello di preservare la razza16. All’epoca la conservazione della razza aveva il sopravvento su qualsiasi altro
117
obiettivo per il legislatore fascista e questa deve essere la chiave di lettura anche quando si procede nella lettura del Codice. Nella norma sull’unione matrimoniale, infatti, in ultimo il legislatore afferma che il matrimonio «è reso eticamente perfetto solo se consegua il suo fine assicurando la continuazione della famiglia»17 e viene rimarcato il riconoscimento statale del carattere religioso
del matrimonio proprio come già espresso attraverso i Patti lateranensi18.
Il ruolo della famiglia, come è stato visto precedentemente, era basilare per
la costruzione dello Stato fascista, infatti il legislatore ribadisce come sia compito della famiglia quello di crescere i figli e di prepararli alle «finalità etiche nazionali»19. L’Assemblea costituente, per nostra fortuna, sarà capace di salvaguardare la famiglia, assegnando ad essa un ruolo educativo e non distruttivo.
3. L’Assemblea Costituente e l’articolo 29
118
Il ruolo del matrimonio e della famiglia, alla vigilia della formazione dell’Assemblea costituente, era dunque forte e i due istituti erano ben legati l’uno all’altro. Questo contribuì notevolmente a definire la stesura del documento costituzionale, relativamente alla famiglia, anche se l’approvazione in questo
senso non fu semplice. Se la corrente cattolica presente in assemblea poteva
basarsi sul Concordato per far valere la propria posizione tradizionale, tuttavia
essa non ebbe la via spianata in tal senso. Vi fu un ampio dibattito in cui le forze liberali, legate a concezioni individualistico-borghesi, propendevano per il ritorno ad un valore contrattuale del matrimonio20. L’obiezione più grande, presentata dagli esponenti liberali, partiva dalla concezione dell’inopportunità di
inserire norme sulla famiglia nella Costituzione, in quanto già disciplinata in
ambito civilistico21.
Per poter comprendere bene il ruolo che i padri costituenti diedero alla famiglia e al matrimonio, è bene esaminare gli articoli con cui hanno previsto la
regolamentazione della famiglia. L’articolo 29 è il primo e sembra un pilastro
fondamentale a favore della teoria istituzionalistica, in quanto il Costituente afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e inserisce la norma, come detto prima, nel Titolo II della Costituzione, la sezione dedicata ai rapporti etico-sociali, ponendola
come primo articolo. Ne seguono due altri articoli attestanti il compito genitoriale e il valore sociale della famiglia all’interno dello Stato. L’articolo 30 recita:
«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti». Si evidenzia qui come il ruolo dei genitori sia
quello di occuparsi della prole, compito specifico della famiglia.
A differenza del periodo fascista in cui era lo Stato ad occuparsi dell’educazione del bambino, con l’articolo 30 si riafferma l’importanza genitoriale nell’ambito della crescita della prole22. Il ruolo dello Stato non è comunque passivo, infatti è già evidente in questa norma come si preveda l’intervento delle istituzioni per sopperire all’incapacità della famiglia. Lo Stato, inoltre, secondo
l’articolo 31 è obbligato ad agevolare «con misure economiche e altre provvi-
NOTE
denze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose».
La struttura familiare ha quindi una valenza molto importante dal punto di
vista sociale per la nostra Repubblica e la Costituzione, per affermarne il valore eccezionale, non può esimersi dal seguire il principio di indissolubilità tra
matrimonio e famiglia. Così facendo l’istituto familiare ne risulta giuridicamente autonomo e non soggetto all’evoluzione della società, come afferma chi vorrebbe la piena libertà dell’individuo in tutto ciò che concerne il rapporto del singolo con le istituzioni23.
Ciò che risulta molto evidente è come la famiglia sia vista non tanto come
oggetto del diritto privato, quanto come primo nucleo di socialità nello Stato.
L’aver inserito il matrimonio e la famiglia in un ambito che non riguarda la sfera privata dell’individuo è un segnale di come questi istituti si vengano a trovare a cavallo tra il diritto privato e quello pubblico. Il ruolo ed il fine della famiglia, infatti, devono essere concepiti tenendo conto dell’autonomia ed indipendenza che possiede questa istituzione, e valutandone il rilievo pubblico come
prima entità sociale nel rapporto tra gli individui24. La presenza del termine naturale (società naturale) ne designa un’origine che non esula dal diritto positivo, e i termini famiglia e matrimonio sono uniti in un ben evidente rapporto di
endiadi25.
La critica nei confronti di questo legame tra matrimonio e famiglia ha aperto un ampio dibattito in cui il compito dei fautori del matrimonio come contratto è stato quello di cercare di sminuire ogni possibile connubio tra questi due
elementi. Si è cercato in particolare di mettere in evidenza come l’articolo 29 e
i due successivi, riguardanti i compiti dei genitori nei confronti della prole, e che
da esso prendono spunto, siano stati solo il frutto di compromessi. Articoli scaturiti, in sede di lavori costituzionali, solo dalla necessità di trovare punti di vista comuni. L’articolo in questione non avrebbe alcunché di valore in quanto i
due termini sarebbero in realtà un vero e proprio ossimoro. Questo contrasto
condurrebbe a stravolgere tutto il significato dell’articolo, in quanto l’endiadi diverrebbe una proposizione impossibile da determinare e garantirebbe al legislatore ampia libertà in materia26.
Se i contrattualisti pongono a pilastro della loro tesi questa teoria, tuttavia è
difficile sostenere che questo articolo, fondamentale nella nostra Costituzione,
sia semplicemente il frutto di accordi parlamentari. Tale considerazione deriva
dal fatto che tutte le correnti partitiche, presenti in sede di lavori costituzionali,
confluirono liberamente sulla posizione espressa nell’articolo in questione, in
particolare gli onorevoli della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista27.
L’unica eccezione fu quella della corrente liberale, come abbiamo accennato
precedentemente, che faceva dell’individualismo un punto nodale della propria
ideologia. Dunque sia il Partito Comunista che la Democrazia Cristiana appoggiarono la formula poi diventata ufficiale; soprattutto il Partito Comunista riteneva fondamentale il ruolo della famiglia come soggetto naturale per dare
maggiore risalto alla parità uomo-donna e per porre la famiglia stessa a pedina indispensabile nella scacchiera della società italiana28. Le relazioni sulla famiglia avutesi nell’ambito della “I Sottocommissione per la Costituzione”, furo-
119
120
no quindi due; una di Leonilde Iotti per il PCI e l’altra di Camillo Corsanego per
la DC29.
Il deputato della Democrazia Cristiana pose da subito l’accento sul ruolo
tradizionale da assegnare alla famiglia, un’istituzione «naturale, dotata di diritti innati, anteriori e superiori a qualsiasi legge positiva»30. Il punto nodale della
relazione è comunque quello riguardante l’importanza dei genitori nell’educazione dei figli e del cambiamento di prospettiva rispetto al periodo precedente.
La Democrazia Cristiana voleva così allontanarsi da una visione della famiglia
fascista, pur mantenendo in piedi quelle che erano le prerogative dei Patti Lateranensi. Diversa la relazione dell’onorevole Iotti, che pose l’importanza della
famiglia proprio per instaurare un rapporto paritario tra i due genitori. La famiglia deve essere rafforzata dalla Carta Costituzionale proprio per garantire
uguaglianza tra i sessi e superare il vecchio concetto antidemocratico di pater
familias inserito nelle legislazioni liberali.31
Un ruolo di grande importanza in ambito sociale prima della Carta costituzionale, come abbiamo visto, era stato dato alla famiglia soltanto dai Patti lateranensi e dal Codice civile del 1942. Lo Statuto Albertino, coerentemente con
la tradizione propria del pensiero liberale, non conteneva alcuna norma riferibile alla società familiare, materia tradizionalmente disciplinata dal codice civile. L’articolo 29 della nostra Carta costituzionale possiede invece una matrice
teutonica che deriva dalle nozioni presenti nella Costituzione di Weimar32. La
costituzione tedesca introdotta nel 1919 è la prima Carta costituzionale ad offrire principi democratici in uno Stato repubblicano. L’articolo in riferimento alla famiglia, il 119, poneva il matrimonio a fondamento della vita familiare e tale istituto doveva essere protetto dalla costituzione. Il principio innovativo che
l’articolo della costituzione tedesca proponeva era l’uguaglianza dei due sessi
nell’ambito della famiglia33.
Nella nostra Costituzione il concetto di uguaglianza tra i due coniugi fu la
condizione sine qua non che impose il Partito Comunista per approvare l’articolo stesso. Vi era la chiara volontà di sollevare la figura della donna, fino ad
allora su di un livello subalterno rispetto all’uomo. Se il suffragio universale
consegnava al sesso femminile i diritti politici che giustamente le spettavano,
la parità di condizione all’interno del quadro familiare dava finalmente l’uguaglianza a livello civile e «la garanzia di appagamento della moglie, che altrimenti avrebbe potuto accusare il peso del compito matrimoniale»34. Questo
principio andrebbe apparentemente contro il concetto di società naturale voluto dall’articolo stesso poiché tale contrarietà deriva dalla convinzione che il diritto naturale accetti solo un legame familiare in cui vi è la supremazia di un coniuge sull’altro. Nella seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, Nilde Iotti si dichiara infatti non molto favorevole alla formula “società naturale” in quanto «appare dottrinaria, specie nella sua prima parte»35.
L’articolo 29 della nostra Costituzione è indiscutibilmente aperto ad interpretazioni che oggi costituiscono la base per la legittimazione o meno di nuove forme di famiglia. Sia durante il dibattimento nell’Assemblea costituente,
quanto nei sessant’anni che da allora si sono susseguiti, i termini della diatriba si sono fondati su quale accezione dare al concetto di società familiare36.
Da un lato ci sono i tradizionalisti che investono gli istituti di matrimonio e di famiglia di una matrice naturale, universale ed immutabile; dall’altro lato i contrattualisti che invece definiscono il matrimonio come un semplice contratto e,
di conseguenza, la famiglia è solo il luogo dove la persona può esprimere al
meglio le proprie individualità in favore dei propri interessi.
Nell’Assemblea Costituente le tematiche affrontate con i toni più accesi riguardarono la definizione di famiglia da inserire nella Costituzione, il rapporto
tra il suo ordinamento interno e le norme di fonte statale, la garanzia dell’istituto del matrimonio e l’eventuale menzione del requisito di indissolubilità37. Oltre
a ciò venne affrontato il problema dell’eguaglianza tra i due coniugi come fondamento del matrimonio che abbiamo visto come fosse il punto nodale per gli
onorevoli comunisti38.
Di certo il punto fondamentale per i costituenti fu la definizione di famiglia
come società naturale, in quanto trovare il preciso significato da assegnare a
questo concetto ne determinerebbe oggi il valore all’interno del rapporto tra
Stato e famiglia. Il termine società naturale, alla quale la Repubblica riconosce
i diritti di famiglia, è stato legato, dagli interpreti contrattualistici, ad un rapporto dinamico della vita statale che è innegabilmente in continua evoluzione. Ciò
fa in modo che la famiglia, come società naturale, ma anche come società che
si evolve, sia totalmente dipendente dal diritto positivo e quindi non più da considerare come tradizionalista nella sua struttura. In chiave giusnaturalistica, la
famiglia è invece una società naturale che non deriva dallo Stato, ed è quindi
da considerarsi immodificabile, essendo una disciplina autonoma, separata dal
diritto positivo.
La chiave di lettura della Carta Costituzionale del 1948 non può non tener
conto del carattere giuridico del documento e quindi della natura giuridica della famiglia stessa, ma questo non significa che la famiglia debba essere considerata alla stregua di qualsiasi altra formazione sociale. Per meglio chiarire il
carattere speciale della famiglia, bisogna comprendere come sia da intendersi
l’espressione “società naturale” all’interno del articolo 29. I contrattualisti e gli
istituzionalisti hanno dato due interpretazioni differenti alla locuzione, una dinamica e l’altra statica. La tesi incentrata su di una interpretazione dinamica si
poggia essenzialmente sulla natura evolutiva dell’uomo, che, quindi, rende impossibile determinare comportamenti preordinati. L’Assemblea costituente,
nell’inserire il concetto di “società naturale”, non ha voluto far riferimento ad
una società preesistente allo Stato, ma solo trovare un momento di sintesi che
potesse accontentare tutte le scuole di pensiero e, soprattutto, lasciare ampio
spazio alla libertà di scelta individuale in tema di famiglia. Nei lavori assembleari emergerebbe quindi la volontà di trovare una formula a cui nessuno si
NOTE
4. La famiglia come società naturale
121
122
potesse opporre39. Dare della società familiare una definizione dinamica, e
quindi mutevole nell’arco del tempo, vuole premiare il lato esperienziale dell’individuo umano che evolvendosi dovrebbe trovare modelli di vita sempre migliori e, soprattutto, modelli che vengano incontro alle esigenze temporali.
I caratteri di relatività e di storicità nella nostra Carta costituzionale trovano
conferma nell’articolo 2 della stessa40. In questa norma, che è inserita nella prima parte del documento, quella dedicata ai principi fondamentali, è presente
l’intento dei costituenti di garantire all’individuo i propri diritti inviolabili sia come singolo sia come facente parte di una formazione sociale. Chi sostiene la
società familiare, alla stregua delle altre formazioni sociali, mette quindi in
stretta relazione l’articolo 29 con l’articolo 2 e ne determina la sua dipendenza
stretta. La famiglia quindi non sarebbe una società naturale che possiede una
propria autonomia a livello legislativo, ma sarebbe dipendente dal diritto privato e dal diritto pubblico che già disciplinano tutte le altre formazioni sociali41.
Per i giusnaturalisti il termine “società naturale” vuole intendere una struttura indipendente dallo Stato e quindi che esula dalle sue leggi. La famiglia risponderebbe così soltanto alle leggi della famiglia stessa che la porrebbero in
simbiosi con il matrimonio e quindi impossibile da sciogliersi. Per i fautori di
questa teoria tradizionale se il significato di “società naturale” fosse stato dinamico, la società familiare sarebbe dovuta diventare una macchina dove gli intrecci sociali sono il motore e il percorso su cui muoversi è solo quello del terreno sociologico. La conseguenza di questa valutazione dell’apparato familiare sarebbe quella di porre la famiglia stessa alla mercé dei mutati interessi temporali, che tanto interessano il diritto di famiglia. Un processo di deregolamentazione, quindi, che vorrebbe meno principi basati sull’imperatività della norma
a fronte di un ampliamento di regole di fonte negoziale42.
La corrente di pensiero dinamica, secondo i giusnaturalisti, abbraccia la tesi del compromesso in sede costituente in quanto, altrimenti, la formula dovrebbe giustificare una delega a valutazioni estranee al diritto positivo e conseguentemente un rinvio della disciplina ad ordinamenti esterni allo Stato43. Il
timore che le religioni e le tradizioni culturali di particolari luoghi della nostra
Penisola, possano incidere nei rapporti di natura familiare, è quindi il motivo
principale per cui la corrente contrattualistica insiste per non assegnare alla famiglia un ruolo speciale all’interno dello Stato e della nostra Carta costituzionale. Chi sostiene questa tesi statica della famiglia, pone in evidenza come all’interno del documento sia ben specificato il termine “società naturale” e non
“formazione sociale”, che implica di per sé come la famiglia sia vista all’interno
della Costituzione come un’istituzione sociale a parte. L’importanza e il valore
assegnato a questo istituto è evidente già dal fatto che l’articolo 29 è posto come prima norma del Titolo II, quello relativo ai rapporti etico-sociali. Ciò determina che la famiglia sia da considerare, inequivocabilmente, come il primo nucleo di socialità e l’elemento unico che possa garantire il mantenimento di un
continuum naturale, che si pone al di fuori di tutte le componenti storicistiche.
La preesistenza della famiglia allo Stato è un concetto determinante per questa corrente di pensiero. Infatti, la società familiare è concepita come legata in
modo stretto alla nascita dell’uomo e quindi precedente alla formazione di qua-
5. Il matrimonio come fondamento della famiglia
Il concetto di famiglia che viene fuori dall’analisi del termine “società naturale” è quindi più vicino ad un concetto statico di famiglia che non dinamico in
quanto la famiglia, perché sia legittimata dalla nostra Costituzione, deve fondarsi sul matrimonio e quindi essere monogamica48. L’endiadi che si presenta
nell’articolo 29 ci garantisce un indissolubile legame tra matrimonio e famiglia.
Una famiglia che ha il suo fondamento nell’istituto matrimoniale.
NOTE
lunque Stato. Il diritto della famiglia, in questo senso, prevale sul diritto posto
dallo Stato ai singoli cittadini, ma ciò non implica che la presenza di una legislazione speciale per la famiglia annulli i diritti dei singoli che ne fanno parte.
A favore di quest’ultima visione è da porre in evidenza come sia stato ribadito, durante i lavori assembleari, il ruolo speciale della famiglia. L’onorevole
Mortati ha affermato nell’Assemblea costituente che la famiglia ha una sfera di
ordinamento autonomo che si autodetermina e che è «destinata a circoscrivere i poteri del legislatore in ordine alla sua regolamentazione»44. L’onorevole
Moro, in relazione a cosa intendere per istituto familiare, affermava che lo si
dovesse valutare come qualcosa di più elevato rispetto ad una semplice formazione sociale, all’interno della quale riconoscere i diritti di famiglia. L’istituto
familiare, essendo una società naturale, è una società razionale che risulta indipendente dallo Stato e ciò non può essere in nessun caso ignorato dal legislatore.45 Se i diritti di famiglia non fossero orientati su di un piano etico-sociale, ma verso un piano individualistico, non ci sarebbe stata necessità di indicare la famiglia come formazione sociale e soprattutto di specificare che dovesse fondarsi sul matrimonio. Sarebbe bastato rinviare all’articolo 2 dove la norma antepone i diritti dei singoli a quelli del gruppo; solo in questo modo, l’Assemblea Costituente, avrebbe indirizzato il diritto di famiglia verso il recupero
privatistico e liberale e avrebbe favorito il conseguente arretramento dell’intervento pubblico nella regolamentazione della materia46.
I costituzionalisti, che sostengono invece un chiaro riferimento dell’articolo
29 all’articolo 2 per quanto concerne i diritti di famiglia, lo fanno per allargare
l’ambito applicativo delle garanzie costituzionali, poiché in questo modo andrebbero difesi tutti gli interessi che si riflettono e che riconducono esplicitamente ai diritti di famiglia. Tali interessi sono sviluppati in quanto riguardano lo
svolgimento della personalità del singolo individuo nell’ambito sociale47. Questa interpretazione del dettato costituzionale lascia aperti, però, molti dubbi in
quanto la società naturale familiare, se considerata solo come il contenitore in
cui l’individuo sviluppa i propri interessi, viene ad essere sminuita del proprio
ruolo. Aver proposto la questione familiare nella prima norma dei rapporti etico-sociali, rende esplicitamente la famiglia l’elemento indispensabile nella crescita della società statale. La famiglia ha la necessità di preservarsi soprattutto perché possiede una peculiarità che nessun altra formazione sociale può
avere: il fondamento sul matrimonio che è l’unico modo per dar vita a questa
società naturale.
123
124
La Carta costituzionale non definisce né disciplina il matrimonio ed invece
rinvia, come in molti casi, alle nozioni tradizionali, sviluppate dalla scienza del
diritto, che ne determinano il concetto49. Tale situazione rende esplicito come,
per definire le caratteristiche dell’istituto matrimoniale, sia necessario individuarle nell’affectio maritalis, un legame naturale che ha il suo fondamento nell’unione e comunanza di vita tra due coniugi di sesso diverso, all’interno del
quale è possibile sviluppare peculiarità utili per il singolo nella sua funzione di
membro della socialità familiare50. L’affectio maritalis, diviene soltanto successivamente rapporto giuridico vincolante, quando lo Stato offre la sua consacrazione formale al matrimonio e accetta la matrice naturale dell’istituto.
Diviene indispensabile quindi verificare se l’intento dei nostri padri costituenti fosse realmente quello di individuare l’istituto matrimoniale con l’affectio
maritalis e quindi di identificare il matrimonio al pari di una nozione giuridica
presupposta51.
Le tradizioni del diritto romano e del diritto canonico, che sono alla base del
nostro diritto positivo, ci offrono un chiaro elemento di come il matrimonio nell’ordinamento italiano non riguardi le unioni poligamiche o poliandriche proprie
di altre culture52. Non sono contemplate nell’ordinamento neppure le unioni
matrimoniali omosessuali, in quanto mai associate all’istituto matrimoniale. Si
pensi infatti che nell’antica Roma, sebbene l’omosessualità fosse alquanto diffusa, non era prevista alcuna unione che potesse avvicinarsi al vincolo matrimoniale53.
Nella nostra Costituzione è evidente il ricorso alle tradizioni giuridiche precedenti in quanto, come si è detto, il matrimonio non viene definito in nessun
articolo. La continuità di vedute con il Concordato del 1929, ci orientano, quindi, soprattutto verso la visione tradizionale e la conferma è data dalla norma
stessa dove il matrimonio è il fondamento della famiglia in quanto società naturale. L’unica famiglia naturale che può essere garantita dal matrimonio è solo quella monogamica ed eterosessuale54. Molto chiaro a proposito è Giacobbe che afferma come «ipotesi di relazioni tra omosessuali, ovvero tra soggetti
che non possono realizzare una società naturale fondata sul matrimonio, non
possono assurgere al ruolo di famiglia né, tanto meno, possono essere equiparati atti che quelle unioni determinano al matrimonio»55.
Questo quadro storico e istituzionalistico, che si è qui delineato, dovrebbe
portarci a sostenere che il matrimonio e la famiglia, sono istituzioni con una natura antecedente alle codificazioni, indissolubili tra di loro e intoccabili dal legislatore. Tuttavia il problema dell’indissolubilità è al centro del dibattito, menzionato precedentemente e che porta con se tutte le questioni riguardanti la possibilità di apertura a nuovi modelli familiari56.
I contrattualisti si rifanno alla garanzia del diritto e al pieno svolgimento della propria personalità, come stabilito nell’articolo 2 della Carta costituzionale57.
Tale richiamo deriva dal fatto che, l’indissolubilità matrimoniale, obbligherebbe
i due sposi al vincolo coniugale sino alla morte di uno dei due, imponendo quindi un arbitrario diritto, che invece è incompatibile con i principi di autonomia individuale58. Il matrimonio come la famiglia avrebbero dovuto avere, pertanto,
un carattere elastico in modo da adattarsi al variare della storia e degli interes-
NOTE
si della comunità e, quindi, la Costituzione doveva lasciare alla disciplina codicistica, la possibilità di modificare le leggi inerenti l’istituto matrimoniale59.
Questo principio di libertà codicistica in tema matrimoniale prevalse nell’Assemblea costituente, in quanto non vi fu chiarezza nel redigere la norma, ma
si lasciò lo spazio ad interpretazioni legislative. Eppure la connessione diretta
e non scindibile tra i tre concetti, matrimonio, famiglia e indissolubilità furono
portati avanti da numerosi componenti l’Assemblea, ma tale comportamento
non portò a nessuna esplicita norma nella Carta Costituzionale60. Il matrimonio
quindi è stato equiparato negli ultimi sessant’anni ad un semplice contratto tra
due individui, che si scambiano una prestazione d’opera. «Ha prevalso – come dice Vari – un modello matrimoniale di stampo individualistico-borghese»61.
6. Le nuove forme di famiglia
Il problema delle coppie di fatto è molto attuale in Italia, in quanto la famiglia italiana, dopo gli sconvolgimenti in tema legislativo degli ultimi sessantanni, in questo inizio del XXI secolo, si sta modificando ulteriormente.
Le relazioni interpersonali sono sempre più libere, e la formazione di nuovi
nuclei sociali sta prendendo il sopravvento rispetto al modello classico di famiglia. Bisogna chiedersi, quindi, se si sia giunti ad un punto in cui un nuovo concetto di famiglia debba sostituire la famiglia basata sul matrimonio o se invece
si debba difendere strenuamente questo modello tradizionale. In Europa la giurisprudenza si occupa di questa problematica già da diverso tempo, a differenza della nostra nazione dove la ricerca di regolamentare le nuove strutture familiari ha avuto un’accelerata solo nell’ultimo biennio62.
Le legislazioni in tema di “coppie di fatto” appaiono comunque disomogenee
nel vecchio continente. Nei Paesi scandinavi esiste una disciplina in tutto simile
a quella matrimoniale, che consente alle coppie di formare unioni, registrate e tutelate dallo Stato. Questa legislazione che potremmo definire, come fa il Macioce, una estensione analogica dell’istituto matrimoniale63, è stata recepita anche
in Portogallo e in Germania dove dal 2001 esiste l’istituto della Eingetragene Lebenspartnerschaft, una disciplina autonoma e parallela a quella delle famiglie tradizionali. In Olanda, Belgio ed in ultimo in Spagna sono state introdotte solo delle leggi apposite che estendono gli effetti del matrimonio civile anche a questa tipologia di legame. In Francia invece è stata introdotta una disciplina che regolamenta la convivenza anche di individui che non hanno legami affettivi64.
L’Italia, invece, fino al 2006 ha sempre evitato di mettere in piedi una disciplina riguardante le coppie di fatto, come in altri Paesi dell’Unione Europea
(Austria, Irlanda, Grecia). Il cambiamento di tendenza è avvenuto con l’avvento della XV legislatura che ha portato in parlamento la questione sui PACS
(Patti civili di solidarietà) e successivamente sui DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi). Il governo in carica sino a pochi mesi fa, dopo
aver inserito nel programma di coalizione la volontà di regolamentare le unioni di coppie di fatto, ha proceduto a presentare una Proposta e un Disegno di
legge a riguardo, producendo le reazioni dell’opinione pubblica e dividendo il
125
126
Paese tra chi riteneva giusto questo ammodernamento dell’istituzione familiare e chi invece lo criticava.
In questo serrato dibattito, la causa della mancanza di un regolamento in
materia è stata attribuita più all’ingerenza palese dei precetti cattolici, tesi a difendere il modello classico di famiglia, che ad una reale inopportunità della disciplina. Il riconoscimento dei Patti civili di socialità è stato quindi appoggiato e
preso ad emblema sia da chi ne ha valutato una sua reale valenza, che da coloro che hanno sempre ribadito l’importanza della laicità dello Stato contro gli
indirizzi della Chiesa.
Bisogna ammettere che l’indissolubilità del matrimonio e della famiglia è
una posizione condivisibile sia dai cattolici che dai laici, che appoggiano la teoria sull’origine naturale della società. Quindi è riduttivo credere che porre un divieto all’equiparazione di “famiglia tradizionale” e “famiglia di fatto” sia dovuto
soltanto alla categorica imposizione della Santa Sede. È innegabile che il Vaticano abbia sempre avuto una forte voce all’interno del panorama politico italiano, ma in tema di famiglia le considerazioni che ci inducono a difendere la
famiglia tradizionale non sono trascendenti ma razionali. Questa presa di posizione che è innegabilmente penalizzante per le coppie di fatto, non è dettata
da una posizione contraria a questo tipo di unioni, ma è la risultante di un’analisi approfondita del rapporto tra vantaggi e rischi che la modifica del Testo Costituzionale potrebbe produrre. Con un’attenta lettura della Proposta Grillini
(dal nome del suo primo firmatario) e del Disegno di Legge del Governo si può
trovare la chiave per comprendere quali conseguenze porti l’attribuzione del
termine famiglia alle formazioni che non si fondano sul matrimonio65.
La proposta di Legge Grillini, sin dal suo primo articolo, riprende i contorni
dell’interpretazione contrattualistica e privatistica della Costituzione. La finalità
è quella di garantire alla persona la sua piena realizzazione nell’ambito della
relazione affettiva di coppia, essendo questa arbitrariamente inserita tra le formazioni sociali garantite dagli articoli 2 e 3 della nostra Carta costituzionale. I
PACS ricalcano quasi per intero la disciplina delle famiglie fondate sul matrimonio, in particolare sul tema del regime patrimoniale, sulle decisioni in caso
di malattie e morte, sulle successioni, sul diritto al lavoro e non ultimo sul fisco
e previdenza. La disciplina è modellata seguendo lo stesso iter della famiglia
tradizionale anche per quanto concerne gli impedimenti e la separazione.
L’unica differenza, ma sostanziale e fondamentale, è la possibilità di formare
coppie dello stesso sesso. Questa proposta vuole creare una disciplina autonoma e parallela a quella matrimoniale, che si avvicina alle legislazioni presenti in Germania e nella penisola scandinava. Il testo sui DICO, presentato sottoforma di Disegno di Legge dal Consiglio dei Ministri qualche mese più tardi,
è un documento sicuramente di più difficile lettura rispetto alla proposta sui
PACS. Se la proposta di Legge Grillini vorrebbe equiparare completamente la
famiglia di fatto ad una famiglia basata sul matrimonio, nel secondo caso vi è
minore chiarezza su quelli che sono i diritti-doveri degli individui nelle loro unioni. Il documento si avvicina maggiormente al caso francese, dove la disciplina
è molto flessibile, poiché riguarda le convivenze e non i legami stabili66.
I DICO italiani seguono infatti il modello francese soprattutto nella modalità
1 Cfr. C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Studi in onore di A. Cicu, Milano 1951, p. 136 ss.
2 Cfr. R. VOLPI, La fine della famiglia. La rivoluzione di cui non ci siamo accorti, Milano 2007,
p. 113.
3 Cfr. P. UNGARI, Storia del diritto di famiglia in Italia, Bologna, 1974, ed. 2002, p. 249.
4 Cfr R. VOLPI, op. cit., p. 117.
5 Cfr. CICERONE, De Re Publica. 1, 32, 49.
6 Cfr. R. VOLPI, op. cit., p. 121
NOTE
di applicazione (articolo I), in quanto nella proposta italiana come in Francia è
sufficiente la dichiarazione dei singoli di volersi riunire in un vincolo di affetto
per poter essere titolari dei diritti presentati nel documento. Basta presentare
soltanto una dichiarazione all’anagrafe (in Francia è la cancelleria del tribunale di residenza) per confermarne la volontà o per manifestarne la fine. Quello
che tuttavia fa risultare il disegno di Legge italiano davvero eccezionale, e comunque poco razionale anche rispetto a quello d’oltralpe, è la possibilità di potersi presentare all’ufficio preposto anche separatamente, dando poi comunicazione al partner attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno; cosa
che non avviene in Francia dove la coppia deve presentarsi congiuntamente.
Questa procedura come tutto il Disegno di Legge, lascia spazio a diversi interrogativi. Il documento apre le porte a convivenze basate soltanto su interessi e anche alla possibilità di unioni poligamiche; la procedura basata sulla dichiarazione
individuale, garantisce che due persone possano formare un legame pur se distanti l’uno dall’altro con la conseguenza che vi si possa instaurare un chiaro legame di convenienza. Un esempio su tutti potrebbe essere la convivenza tra persone anziane e cittadini extracomunitari. La stessa procedura non costringe poi,
come invece ben evidente nella proposta Grillini, l’obbligo alla monogamia all’interno della coppia. In linea di massima con i DICO vi possono essere diverse dichiarazioni attestanti la convivenza con la stessa persona. La questione è quindi
seria e merita una valutazione razionale ed etica del problema. Se i PACS potevano essere un documento eticamente più vicino all’idea di famiglia fondata sul
matrimonio, i DICO stravolgono completamente il legame all’interno di una coppia e quindi, di conseguenza, la struttura familiare. Bisogna, quindi, verificare se
l’accettazione di questi nuovi stili di vita, attraverso una disciplina stabile, sia un
vantaggio o uno svantaggio per l’individuo e soprattutto per la società.
La richiesta di nuove forme di famiglia, ricalca i problemi della società italiana evidenziati precedentemente. In un contesto di vita in cui l’individuo resta
solo, essendo privo di una struttura familiare stabile, la ricerca di legami deboli e temporanei è la via più semplice per evitare troppe responsabilità. La visione individualistica ci porta a trovare nella nostra Costituzione solo i diritti che
questa ci offre (art. 2 e 3), senza osservare lo scopo che la Carta possiede nel
suo enunciato. La Costituzione lascia ampia possibilità di realizzazione all’individuo all’interno dello Stato, ma cerca anche di preservare le strutture sociali che sono alla base della crescita dell’individuo stesso. La salvaguardia della
famiglia tradizionale ha appunto questa funzione.
127
Cfr. F. VARI, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, Bari 2004, p. 26.
P. UNGARI, Storia del diritto di famiglia in Italia, op. cit. p. 208.
9 La proposta di Legge sul divorzio di Marangoni e Lazzarri venne dapprima appoggiata in parlamento e successivamente bloccata per opposizione del Partito popolare appena sorto e del Partito fascista. v. P. UNGARI, Ivi, pp. 207-208.
10 Ivi, p. 210.
11 Cfr. F. VARI, op. cit., p. 52.
12 Cfr. Ivi, Idem, p. 53-54
13 F. D’AGOSTINO-G. DALLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli, ideali e
disciplina giuridica, in AA.VV., Le stagioni della famiglia, a cura di G. CAMPANINI, Cinisello Balsamo
1994, p. 233.
14 Ivi, p. 234.
15 P. UNGARI, op. cit. p. 220.
16 Nella norma sulla tutela della razza, il legislatore si esprime in questi toni: «Difendere e rinvigorire la stirpe è fine precipuo dello Stato. Ad esso compete assicurare l’integrità morale e la sanità nella successione delle generazioni. Prime cause di decadimento della razza sono gli incroci
di razze ed i matrimoni di persone ereditariamente tarate»; Ibidem.
17 Ibidem.
18 Sul ruolo della famiglia, il legislatore è esplicito: «La famiglia è il nucleo fondamentale della
società nazionale. L’unità e la saldezza morale ed economica della famiglia sono garanzie della
forza della Nazione. Lo Stato riconosce il carattere religioso dell’atto di fondazione della famiglia»
Ibidem.
19 Sulla protezione della prole, il legislatore si esprime in questi termini: «Lo Stato affida alla famiglia l’educazione, l’istruzione e la preparazione morale del giovane; ma integra e sviluppa l’opera della famiglia nel completo raggiungimento delle finalità etiche». in P. UNGARI, Storia del diritto
di famiglia in Italia, cit. p. 220.
20 F. VARI, op. cit., p. 54.
21 Ibidem.
22 Cfr. P. UNGARI, op. cit. p. 220.
23 Sull’argomento cfr. E. SPAGNA MUSSO, Problemi costituzionali di una riforma del diritto di famiglia, in AA.VV. Studi per il ventesimo anniversario dell’assemblea costituente, Firenze 1969, p.
430 s.; F. CUOCOLO, Principi di diritto costituzionale, II ed. Milano 1999.
24 A. CICU, Il diritto di famiglia. Teoria generale, Roma 1914, ristampa, Bologna 1978, p. 77 ss.
25 L’endiadi, che tradotta letteralmente dal greco significa una parola in due, consiste nell’utilizzo di due o più termini per determinare un unico concetto, v. F. VARI, Contributo allo studio della
famiglia nella Costituzione italiana, cit., p. 46.
26 Su tutti v. R. BIN, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in “Studium iuris”, 2000, p. 1066.
27 Cfr. Resoconto sommario della seduta del 30 ottobre 1946 in Atti Assemblea costituente, I
sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, vol. VI, Roma, 1976, pp. 321-336. Sul punto vedi anche A. LOIODICE-P. PISICCHIO, Moro e la
costituente: principi e libertà, Napoli 1984.
28 Togliatti afferma: «La famiglia è riconosciuta come naturale associazione umana ed è tutelata allo scopo di accrescere la prosperità materiale e la solidità morale della nazione», in Resoconto sommario della seduta del 30 ottobre 1946, Atti Assemblea costituente, I sottocommissione,
in La Costituzione della Repubblica, cit., p. 335.
29 Cfr. Relazione sulla famiglia, Atti assemblea costituente, I sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica, cit., pp. 53-57.
30 Cfr. Ivi, pp. 53-54.
31 Cfr. L. IOTTI, Relazione sulla famiglia, Atti assemblea costituente, I sottocommissione, in La
Costituzione della Repubblica, cit., pp. 55-57.
32 F. VARI, op. cit., p. 40.
33 Ibidem.
34 L. IOTTI, op. cit., pp. 55-57.
35 In, Atti assemblea costituente, Adunanza plenaria, in La Costituzione della Repubblica, cit.,
p. 103.
36 F. VARI, op. cit., p. 39 ss.
7
8
128
NOTE
37 F. CASAVOLA, La famiglia dalla identificazione nel pater familias alla società naturale, op. cit.,
p. 27 ss.
38 Cfr.. L. IOTTI, Relazione sulla famiglia, Atti assemblea costituente, I sottocommissione, in La
Costituzione della Repubblica, op. cit., p. 55 s.
39 Cfr. R. BIAGI GUERINI, Famiglia e Costituzione, Milano 1989, p. 9 e ss.
40 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» (Articolo 2). Sul punto v. P. RESCIGNO, Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto di famiglia, Torino 2000.
41 Cfr. F. D’AGOSTINO-G. DALLA TORRE, op. cit., p. 237 e ss.
42 Cfr. A. ZOPPINI, Tentativo d’inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in AA.VV., I contratti di convivenza, a cura di E. MOSCATI. A. ZOPPINI, Torino 2002, p. 7 ss.
43 Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 332 e ss.
44 Cfr. C. MORTATI, Atti assemblea costituente, (seduta plenaria del 23 aprile 1947), in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., vol. IV, p. 3248.
45 Cfr. A. MORO, Seduta del 6 novembre 1946, Atti Assemblea costituente, I sottocommissione, in La Costituzione della Repubblica, cit., vol. VI, pp. 343-354.
46 Cfr. CAGGIA F.-ZOPPINI A., Art. 29, in Commentario alla Costituzione a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, I, Artt. 1-54, Torino, 2006, pp. 601-621.
47 Cfr. Ivi, p. 607.
48 Cfr. F. VARI, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione italiana, cit., p. 46.
49 Su questo argomento, v. P. F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I,1, II ed. Torino 1991;
F. VARI, op. cit., p. 49.
50 Sul punto cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Padova 1976, p. 1166; A. PIETROBON, Sull’essenza del matrimonio civile, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia, dieci anni
dopo, Atti del Convegno di Verona 14-15.06.1985, Padova 1986, p. 224.
51 Sul punto cfr. F. VARI, op. cit., p. 49 e ss.
52 Cfr. P. F. GROSSI, La famiglia nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in AA. VV.,
La famiglia nel diritto pubblico, a cura di G. DALLA TORRE, Roma, 1996, p. 12.
53 Il diritto romano affermava: maris atque feminae coniuctio, quam nos matrimonium appellamus (D.1.1.1); sull’argomento cfr. G. LA PIRA, La famiglia, una casa costruita sulla roccia, in Il Focolare, n, 8, 14 aprile 1974, p. 5.
54 Sul punto cfr. F. DI FELICE, Radici umane e valori cristiani della famiglia, Città del Vaticano
2005, p. 157 ss.; cfr. P. F. GROSSI, La famiglia nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale,
op. cit., p. 12.
55 G. GIACOBBE, La famiglia dal codice civile alla legge di riforma, in Iustitia, Torino 1999, p. 269.
56 Cfr. R. VOLPI, op. cit., p. 113 ss.
57 Cfr. F. CAGGIA-A. ZOPPINI, Art. 29, op. cit., p. 608; v. M. BESSONE, Art. 29-34: Rapporti eticosociali, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma 1976, p. e 29 ss.
58 Cfr.. M. BESSONE, Art. 29-34, cit., p. 31.
59 Cfr. F. VARI, op. cit., p. 53.
60 Ivi, p. 52. In particolare il Vari parla dell’intervento dell’on G. La Pira che affermava, senza
ambiguità, il ruolo speciale e autonomo della famiglia e del matrimonio.
61 Cfr. ivi, p. 56.
62 Sul panorama europeo in tema di Pacs, v. su tutti F. MACIOCE, PACS. Perché il diritto deve
dire di no, Alba 2006, cap. IV.
63 Ivi, p. 39.
64 Ivi, p. 40 e ss.
65 La proposta di Legge è del 28 aprile 2006 ed è denominata Disciplina del patto civile di solidarietà. Il disegno di Legge (AS 1339) approvato dal Consiglio dei Minisri è intitolato Diritti e doveri delle persone stabilemnte conviventi è dell’8 febbraio del 2007. Per una lettura degli articoli di
legge v. in appendice a A. MANTOVANO, La guerra dei “dico”, Soveria Mannelli 2007, p. 79 ss.
66 F. MACIOCE, op. cit., p. 43.
129
L. GHERSI, Croce e Salvemini. Uno storico conflitto ideale ripensato nell’Italia
odierna, Bibliosofica, Roma 2007, pp. 638.
130
«C’è un presente che non succede al passato e non precede al futuro, e abbraccia in sé tutti i tempi e le vicissitudini del nascere e morire di tutte le cose,
ed è immortale, infinito, eterno; e c’è un presente, e si dimostra infatti inafferrabile e inattingibile, e muore sul nascere, traendo seco il futuro nei gorghi del
passato. È chiaro che il presente che è veramente presente, è del pensiero; e
che il presente che è passato, è del mondo». Questo efficace passaggio di un
noto testo di Giovanni Gentile può essere, a nostro avviso, assunto come il “segreto” del volume di Livio Ghersi, la cui ispirazione muove dalla coscienza della attualità e della irrinunciabile presenza nel nostro tempo del pensiero di Benedetto Croce e di Gaetano Salvemini, figure che, secondo l’autore, possono
«ancora risultare utili nell’approccio alla realtà presente» e che, inoltre, possono essere poste «in relazione con le nostre passioni ed i nostri problemi» (p.
12). Ghersi recupera le esperienze intellettuali in questione a partire essenzialmente da due variabili, una filosofica e l’altra politica, seguite, innanzitutto, nel
loro essersi costituite nel contesto della formazione dei due autori e, poi, nel
più vasto – e problematico – ambito della loro produzione e del loro non marginale contributo alla vita culturale e politica del nostro paese, durante la prima
metà del secolo scorso.
Prendendo l’avvio dalla constatazione della comunanza di «non poche circostanze storiche» (p. 15), Ghersi delinea i profili di Croce e di Salvemini senza temere i rischi di un’analisi che appare (certo non a torto) evidentemente
sbilanciata a favore del filosofo napoletano, e, ricostruendo il percorso di vita e
di ricerca dei “suoi” autori, propone un affresco del contesto culturale italiano
fra le due guerre, che rende la ricchezza di un chiaroscuro di idee e di emergenze storiche, etiche e politiche che hanno reso il filosofo napoletano e lo storico pugliese le figure di riferimento del dibattito culturale del tempo.
La tesi portante del testo, comunque, al di là della molteplicità di spunti e di
prospettive su cui è articolata, si sostanzia a partire da una solida e inequivocabile idea di fondo: la difesa della filosofia e delle «ragioni del filosofare» (p.
24), contro ogni tentativo di eclissarne le conquiste dietro un determinismo e
un realismo esasperati. Va da sé che tale difesa conduca ipso facto al recupero senza riserve di una proposta che per l’autore «significa l’attività del pensiero mossa dall’esigenza di un orientamento, di un indirizzo spirituale, di individuare il senso della propria collocazione nel divenire della storia, con la connessa consapevolezza di un compito da svolgere» (p. 24). Alla luce di queste
premesse, ben si comprende l’opzione manifestata da Ghersi nei confronti della esperienza crociana, seguita nel suo essersi sviluppata in tre direzioni principali: la formazione idealistica, l’itinerario storicistico e la teoria del liberalismo.
Se Hegel ha rappresentato per Croce un costante e per certi versi imprecisato termine di confronto, la riflessione filosofica sul senso della storia ha costituito l’autentico piano di verifica della formazione hegeliana, contribuendo così, in larga misura, a fondare l’orizzonte logico e storico dell’idea di liberalismo.
Ghersi segue e tenta di verificare le linee di convergenza di questi tre ordi-
RECENSIONI
ni di discorso, saldandoli, da un lato, al contesto culturale che ha contribuito a
originarli – l’Italia di Bertrando e di Silvio Spaventa, di Francesco De Sanctis e
della Destra storica – e collocandoli, dall’altro lato, nel reticolo della vita politica italiana della prima metà del XX secolo. Il tutto, alla luce di una variabile che
riteniamo non possa essere trascurata, il fatto, cioè, che il confronto tra Croce
e Salvemini appare per molti versi sbilanciato proprio in forza di quella “pregiudiziale filosofica”, su cui l’intera vicenda di pensiero crociana si è fondata e che,
al contrario, ha rappresentato il costante bersaglio polemico dello storico di
Molfetta. La pressoché totale estraneità di Salvemini dai domini della riflessione filosofica ha sostanziato, infatti, almeno in una prima fase, il confronto con
il filosofo napoletano, determinato a rifiutare senza appello (e con risultati che
non avrebbero tardato a manifestarsi) l’obiettivismo di matrice positivistica, che
caratterizzava l’esperienza teorica salveminiana e che avrebbe condotto lo storico pugliese a quel concretismo, diametralmente opposto all’approccio crociano alla realtà, che non avrebbe resistito alla prova dei fatti. Il discrimine della,
a tratti aspra, discussione tra i due, infatti, era rappresentato dall’impiego, nella indagine storiografica, di un approccio empirico che, per Salvemini, era garanzia di attendibilità e di difesa dalle «nebbie dei filosofi» e che, al contrario,
per Croce, era sintomo della deriva degli studi storici degli ultimi cinquant’anni. All’esperienza di storico di Salvemini – esperienza intrisa di un immanentismo immoto e cieco – si contrapponeva, dunque, una determinazione intellettuale certamente più «ricca, varia e pieghevole», per usare una felice espressione crociana; determinazione sorretta e nutrita da uno storicismo “militante”,
che, fuori da ogni ortodossia idealistica, era riuscito a restituire all’attività dello
Spirito la sua originaria (e più prossima) radice, la vita della storia, dalla quale
era impossibile isolare la prospettiva del singolo. Prospettiva che, viceversa, in
Salvemini riceveva un incontrovertibile radicamento sul terreno della prassi
storiografica e dell’azione politica e civile. L’opera storica salveminiana, infatti,
era supportata da una ricchissima serie di tracciati, avente origine dalle emergenze della vita pratica. Allo storico pugliese, non a caso collocato dalla storiografia italiana nel novero degli “individualisti metodologici”, non interessavano
molto le mere generalizzazioni; al contrario, egli riteneva avessero importanza
gli individui nella loro soggettività e singolarità, le cui azioni non sempre erano
riconducibili a grandi categorie standardizzate. «La storia – scriveva a questo
proposito – non è fatta né dalle moltitudini inerti, né dalle oligarchie paralitiche.
La storia è fatta dalle minoranze consapevoli e attive, le quali, vincendo le inerzie delle moltitudini le trascinano verso nuove condizioni di vita, anche contro
la loro volontà».
In questa prospettiva si inserisce un ulteriore elemento di riflessione che
Ghersi non trascura: il fatto, cioè, che alla polemica storiografica fosse connessa, poiché in essa affondava le radici e, in gran parte, traeva motivazione, la
polemica politica. Il carattere empirico della storiografia salveminiana aveva
ispirato, infatti, un approccio alla realtà – rifiutato radicalmente da Croce perché giudicato «senza problema storico», poiché rischiava di pregiudicare quella proficua (e indispensabile) incursione del pensiero nella muta realtà dei fatti; la storiografia salveminiana, dunque, aveva ispirato un approccio politico in-
131
genuamente democratico che non convinceva chi, come Croce, aveva impegnato la propria esperienza filosofica ed etica nella costituzione dell’impianto
teoretico di un liberalismo vissuto e agito nel tessuto politico dei difficili anni tra
le due guerre.
Questo impegno, non avrebbe potuto ovviamente ispirarsi alla matrice ideale della opzione politica salveminiana, il materialismo storico, al centro di una
difficile e lunga disamina da parte del filosofo napoletano, saldo nell’affermazione di uno stile filosofico e politico che vedeva l’uomo di cultura impegnato a
tutto tondo nelle vicende della sua comunità e che, nel 1931, lo avrebbe fatto
parlare di «simpoliticismo», ovvero di «interessamento per la politica come per
ogni altra parte della vita umana», visto che «l’uomo intero accoglie nel suo
animo l’interessamento per tutte le forme della vita, e per tutte batte il suo cuore; e il politico e lo storico le indicano tutte nelle loro relazioni e nella loro viva
dialettica».
Emilia Scarcella
M. CARBONE, Essere morti insieme. L’evento dell’11 settembre 2001, Bollati-Boringhieri, Torino 2007, pp. 105
132
Nella celebre conferenza dedicata alla Questione della tecnica, Heidegger
avvertiva che se vogliamo pensare l’essenza della tecnica, non possiamo credere che essa sia qualcosa come uno strumento nelle mani dell’uomo, né che
essa sia dia all’uomo come qualcosa di neutrale. Mezzo secolo separa quella
riflessione heideggeriana dall’attentato alle Twin Towers dell’11 settembre
2001, ma la richiesta di de-antropologizzazione della tecnica avanzata da uno
dei maggiori filosofi del Novecento appare tutt’ora essenziale e oggi più che
mai estendibile alla guerra: per comprendere che cosa oggi la guerra è, occorre iniziare a pensarla come qualcosa che non è nelle mani dell’uomo, o almeno qualcosa che non è un mero strumento della politica.
Può sembrare strano, e troppo spesso non se ne è nemmeno consapevoli, ma il secolo che ha conquistato un ulteriore elemento, l’aria, come nuovo
spazio per la guerra, che ha prodotto due guerre mondiali (più una Guerra fredda) e una serie illimitata di small wars, che ha progettato realizzato e utilizzato la bomba atomica, il secolo degli stermini e dei genocidi su scala industriale, è anche il secolo in cui il pensiero tace o fugge dinanzi alla domanda: che
cos’è la guerra? Con questo non intendo dire che la parola «guerra» sia poco
utilizzata, che non vi siano state e non vi siano in continuazione pubblicazioni,
conferenze, dibattiti in cui si parla della guerra. Anzi. Ma a livello informativo, a
livello politico e a livello filosofico si dà per scontato che si sappia che cosa la
guerra è. In effetti proprio i testi di filosofia, proprio i capolavori dei maestri del
pensiero, si sono tenuti a debita distanza dall’affrontare quello che è stato uno
degli eventi caratterizzanti il secolo passato e, come è ormai assai evidente,
anche il secolo che stiamo vivendo. Anche nel dibattito presente – fatte salve
alcune rare e marginali eccezioni – la filosofia sembra che sulla questione che
cos’è la guerra abbia abdicato a uno dei suoi compiti originari: porre il dubbio,
RECENSIONI
fare epoché, combattere gli idola, mettere in discussione i pregiudizi che di volta in volta ottundono la capacità dell’essere umano di comprendere il mondo.
Certo che se il carattere determinante del XX secolo, come scriveva Jan
Patocka, è proprio di essere «il secolo della guerra», questa dimenticanza non
può essere liquidata come se fosse di secondaria importanza e pone un interrogativo assai inquietante circa la funzione odierna del sapere filosofico e dei
filosofi nel loro complesso. La filosofia invece di scendere nelle strade per cercare di capire ciò che sta accadendo, rimane inebetita sulla sua poltrona e al
massimo riesce ancora a muoversi fino alla finestra per dare un po’ d’acqua ai
vasi di fiori sul davanzale.
Eppure quei (rari) filosofi che non si sono trincerati dietro le cattedre delle
accademie, non hanno faticato ad accorgersi, per esempio, che uno dei pregiudizi più diffusi nella società occidentale contemporanea è che esisterebbe
un progresso continuo e lineare nella storia delle guerre umane in grado di
condurre a una mitigazione e a un controllo della violenza in ambito bellico.
Dalla clava agli interventi di “guerra chirurgica”, il genere umano sarebbe riuscito progressivamente a circoscrivere e a ridurre l’elemento violento all’interno dei conflitti armati con il risultato che, dal punto di vista bellico, il nostro sarebbe, almeno fino a oggi, il migliore dei mondi possibili. Questo tipo di rappresentazione della guerra non si ascolta soltanto nelle chiacchiere da bar, ma sta
al fondo, in modo più o meno implicito e inconsapevole, di gran parte delle argomentazioni che consentono di giustificare i diversi interventi di polizia internazionale o di guerra al terrorismo e di cui si nutre costantemente il sistema informativo. Ma anche la filosofia e le scienze sociali non sono immuni da questo pregiudizio, non fosse altro che per il silenzio in cui si sono chiuse.
Accade così che l’intera visione filosofica-giuridica-politica in base alla quale gli Stati uniti e/o l’Onu possono intervenire per sconfiggere il terrore e “portare la democrazia” al popolo oppresso di turno, si può reggere sull’assunto implicito, e spesso inconfessabile, che l’Occidente sarebbe in grado di gestire la
guerra come se fosse uno strumento violento ma intelligente, cruento ma razionale, in quanto sotto il totale controllo della politica democratica e dei suoi
ideali. La guerra, dunque, come uno strumento che quando non serve più si
può riporre nella scatola degli attrezzi al pari di un martello o di un cacciavite.
Corollario morale necessario di questa concezione della democrazia globale e
della guerra come suo strumento doloroso ma necessario è che essa sia in
fondo un rimedio estremo a mali estremi (il terrorismo, per esempio) e sia comunque finalizzata all’estinzione della guerra in quanto tale e all’istituzione di
una planetaria pace perpetua. Ma la guerra permanente che abbiamo quotidianamente davanti ai nostri occhi è davvero uno strumento al servizio di una democrazia globale, interessata alla libertà dei cittadini del pianeta?
Il dubbio che la questione non stia in questi termini, sorge osservando gli
esiti dei diversi interventi ai danni dei cosiddetti “stati canaglia” – dal Vietnam
all’Iraq – che si caratterizzano sia per il carattere estremamente cruento e poco “intelligente”, sia per un processo di cronicizzazione e moltiplicazione del
conflitto originario che rende difficile o addirittura impossibile porre termine in
tempi ragionevolmente prevedibili alla riproduzione della violenza bellica me-
133
134
diante una decisione politica. Un ulteriore dubbio circa la rappresentazione della guerra come strumento della democrazia e della pace viene dall’aumento
smisurato degli apparati polizieschi di controllo negli ambiti “civili” che lascia intendere che la guerra più che uno strumento politico sia divenuta lo spazio sperimentale di nuovi modelli di vita “pacifica”.
Dunque guardando retrospettivamente, ci si accorge che la filosofia contemporanea si è “dimenticata” della guerra, proprio nel «secolo della guerra».
L’evento dell’11 settembre 2001, in quanto tragica esplosione della violenza bellica nel cuore stesso dell’Occidente, ha risvegliato i filosofi dal loro torpore e li ha (in parte) costretti a tornare a interrogarsi sul senso della guerra e del
terrore. Guerra e terrore nell’attentato dell’11 settembre si mostrano proprio in
tutta la loro dimensione esorbitante rispetto alla tradizione dello ius publicum
europaeum, che dalla fine delle guerre di religione fino alla Prima guerra mondiale aveva determinato che la politica statale fosse l’unica detentrice del potere di esercitare la violenza bellica con la conseguente messa «in forma» della pratica della guerra. Il crollo delle Twin Towers mette davanti agli occhi di tutti (filosofi compresi) che la storia della universalità del diritto internazionale è
giunta al termine e che guerra e violenza hanno subito una mutazione genetica tale per cui esse tendono a diventare elementi normali della vita quotidiana
che riguardano non solo i cosiddetti “paesi del Terzo mondo“, ma il pianeta nel
suo complesso.
In questa nuova fase della storia mondiale, che verrà probabilmente ricordata in futuro per la normalità del terrore su scala planetaria, il libro di Mauro
Carbone Essere morti insieme. L’evento dell’11 settembre 2001 (Bollati-Boringhieri, Torino 2007, pp. 105, euro 12) si pone come una riflessione filosofica rara e necessaria.
Che tipo di evento è l’11 settembre? In che misura la (iper)rappresentazione di quell’evento incide sulla sua comprensione? L’attacco alle Twin Towers
mette in scena la dimensione globale del terrore in cui viviamo, che sembra
sfuggire alla logica della classica politica statale; è possibile oggi pensare una
politica all’altezza di un evento che è «impresentabile» per gli strumenti della
politica classica? Che genere di questioni impone oggi alla filosofia l’«irrapresentabilità» di un evento come l’11 settembre? E ancora, per quali ragioni estetiche e filosofiche occorre tornare a pensare all’immagine delle Torri Gemelle
che crollano trasformandosi in Ground Zero? Queste in breve sono alcune delle questioni fondamentali che Carbone mette a fuoco nel suo volume con straordinaria profondità teoretica e chiarezza.
Molteplici ed essenziali sono i filosofi e gli scrittori con cui Carbone si confronta nelle pagine del suo testo da Heidegger a Merleau-Ponty (di cui probabilmente Mauro Carbone è oggi lo studioso più importante a livello mondiale),
dalla Scuola di Francoforte a Deleuze e a Baudrillard, da Marc Augé a Slavoj
Zizek. In questo senso il volume di Carbone svolge la preziosissima funzione
di raccogliere tutte quelle scintille di pensiero che possono gettare un po’ di luce su ciò che, come abbiamo accennato, per decenni è rimasto uno dei punti
ciechi della visione filosofica. Forse gli autori più significativi nella tessitura del
volume di Carbone sono Kant e Derrida: Carbone infatti intende ripercorre le
RECENSIONI
tracce dell’autore della Pace perpetua e inserirsi nel solco del pensiero aperto
da Derrida verso una nuova «figura di alleanza tra la filosofia e la politica». Tale «alleanza» deve essere eccentrica rispetto «all’orbita della filosofia politica
di tradizione platonica» e deve saper radicare nel pianeta quell’«utopia» di
«cosmopolitismo» teorizzata per la prima volta da Kant; come scrive con estrema lucidità Carbone: «Alla deterritorializzazione del politico (…) corrisponde infatti, come suo altro versante, la depoliticizzazione del territorio, il quale va irrimediabilmente perdendo i suoi caratteri di polis, appunto, ossia di un universum inteso quale fondamento e garante di una comune origine, per assumere
piuttosto quelli di un pluriversum i cui conflitti risultano sempre più probabili».
(p. 12). In questo senso il volume di Carbone si pone come un fondamentale
strumento di orientamento filosofico per muoversi nel mondo della globalizzazione; l’11 settembre mostra in un istante come i concetti universali che il pensiero occidentale ha elaborato non riescono a comprendere il senso di ciò che
sta accadendo davanti ai suoi stessi occhi: i diritti dell’uomo che ha faticosamente elaborato per secoli si mostrano come diritti universali, mentre globali
sono il conflitto e il terrore che li negano. L’11 settembre costituisce la realizzazione del definitivo s-fondamento delle categorie e dei valori universali che lasciano spazio a quella situazione che si definisce come globale. Per mettere a
fuoco questo cruciale passaggio della storia planetaria è fondamentale il primo
capitolo del volume di Carbone, nel quale egli ripercorre i momenti essenziali
del dibattito sul postmoderno che appaiono oggi estremamente preziosi per
comprendere la formazione di un pensiero all’altezza del pluriversum globale.
Oggi per Carbone il cosmopolitismo non è più solo un ideale utopico, quanto piuttosto uno degli aspetti del mondo così come si sta realizzando, uno dei
tratti espressivi che caratterizzano il volto del presente. Certo, Carbone sottolinea come la nascita di questa comunità globale emerga dallo scenario tragico dell’11 settembre, da una tragedia che pare ricapitolare in un episodio la
«banalità» del male del XX secolo: «Un evento tragico» scrive Carbone «e simultaneamente qualcosa come una tragedia greca svoltasi davanti a una polis allargata al mondo intero: questa è la peculiarità dell’evento dell’11 settembre 2001, con tutti gli interrogativi circa le emozioni tragiche e le loro implicazioni politiche che tale peculiarità non ha smesso di rivolgerci». In questa direzione Carbone richiama Habermas per il quale quell’episodio tragico ha rappresentato una svolta all’interno della storia del mondo: l’11 settembre è il «primo evento storico mondiale in senso rigoroso», il primo «naufragio» in cui gli
spettatori sono diventati tutti naufraghi. Carbone, elaborando un elemento essenziale del pensiero merleau-pontyano osserva: «Un naufragio al quale tutti
siamo stati spettatori, dell’essere stati spettatori dello stesso naufragio sentendoci accomunati a quei naufraghi e fra noi, a nostra volta resi perciò naufraghi:
mondo la cui carne fa di carne chi a quel mondo partecipa».
Per certi versi il libro di Mauro Carbone e quello di Antonio Scurati La letteratura dell’inesperienza costituiscono il recto e il verso della stessa questione.
Per Scurati la guerra televisivamente rappresentata appare oggi come il luogo
per eccellenza dell’inesperienza, «una serata di morte e distruzione trascorsa
comodamente adagiati sul divano di casa sorseggiando birra fresca». Il rac-
135
conto della guerra che per la modernità ha costituito la massima pienezza dell’esperienza, diventa oggi il suo baratro, il punto della sua totale dissoluzione.
Il saggio di Carbone tende invece a scandagliare filosoficamente questa dimensione dell’irrapresentabilità e dell’inesperienza cercando di portare alla luce i segni premonitori del futuro, l’eccedenza di un evento come quello dell’11
settembre in cui emerge certo la distruttività nichilistica della violenza massificata, ma che nella condivisione planetaria del dolore per quelle assurde morti, nel sentimento di «vulnerabilità» globale che unisce tutti, indica forse anche
la possibilità di realizzazione di un sogno a occhi aperti, di ciò che di buono ci
attende nel futuro. È innegabile che la telecronaca in diretta del crollo delle
Twin Towers abbia trascinato con sé, come un fiume in piena, tutti i detriti dei
“buoni sentimenti” planetari e abbia mobilitato tutte le armi della retorica televisiva fino a raggiungere il punto grottesco – come ha osservato David Forster
Wallace – di «raccontare di essere stati traumatizzati da un filmato quando le
persone nel filmato stavano morendo». Ma è altrettanto vero che quelle stesse immagini, mentre conducevano al limite estremo il cinismo televisivo “in diretta” sbriciolando il limite tra reale ed immaginario, sono riuscite a esporre lo
spettatore a un sentimento di vulnerabilità e di com-passione: abbiamo sentito
appunto di «essere morti insieme», secondo le parole di Carbone, perché abbiamo vissuto insieme la «morte di altri».
136
Maurizio Guerri