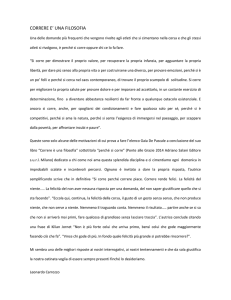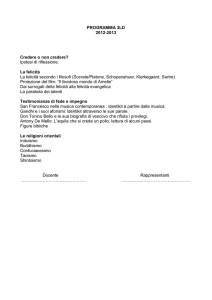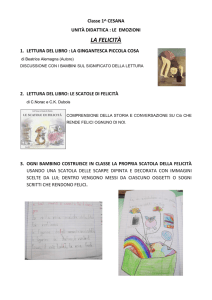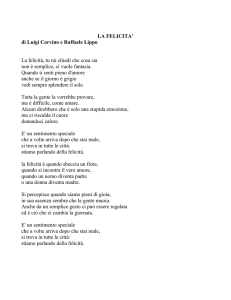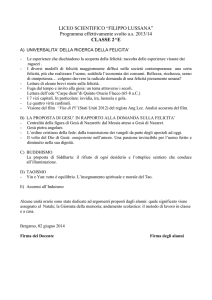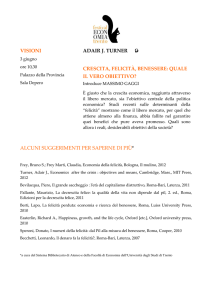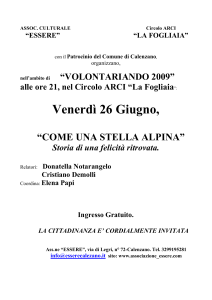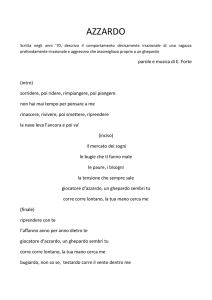Si corre:
–
per dimostrare il proprio valore, come gli dèi e gli eroi greci, come i molti che, giorno dopo
giorno, ingaggiano la propria battaglia per correggere le storture del destino;
–
per recuperare la propria infanzia, sempre alla ricerca del tempo perduto, di un’oasi di
purezza alla quale tendere, senza accontentarsi di guardarla con nostalgia;
–
per agguantare la propria libertà: oltre i vincoli sociali, culturali, oltre alle sbarre di qualsiasi
prigione, mentale o reale, fisica o emotiva;
–
per dare più senso alla propria vita, o per costruirsene una diversa, fatta a propria immagine e
somiglianza;
–
per provare emozioni, sempre più intense, sempre più vere;
–
perché si è un po’ folli e perché si cerca, nel caos contemporaneo, di trovare il proprio
scampolo di solitudine;
–
per migliorare la propri salute e per prendere lezioni di verità dal proprio corpo;
–
per provare dolore e per imparare ad accettarlo, in un costante esercizio di determinazione,
fino a diventare abbastanza resilienti da far fronte a qualunque ostacolo esistenziale;
–
per spogliarsi dei condizionamenti e fare qualcosa solo per sé, qualcosa che valga solo nel
momento in cui si compie, nel qui e ora del suo svolgimento, e che racchiuda in questo
presente di fatica e sudore il senso di tutto il passato e di tutto il futuro;
–
perché si è competitivi,
–
perché si ama la natura,
–
perché si sente l’esigenza di immergersi nel paesaggio;
–
per scappare dalla povertà;
–
per affrontare incubi e paure.
E l’elenco potrebbe continuare.
Si dice che avere troppe possibilità equivalga a non averne nessuna. Lo stesso ragionamento è
valido per le motivazioni: averne un numero così ampio significa, di fatto, non averne. I racconti dei
corridori sono accomunati da un dato: alla domanda «Perché corri? » nessuno è in grado di fornirne
una risposta precisa. Qualcuno azzarda un’ipotesi banale, qualcun altro non risponde, i più
affermano la loro semplice verità: «Perché mi piace».
È tutto qui. Si corre perché correre piace. Perché correre rende felici. La felicità del niente, che si
srotola in un tempo suo proprio, al di là del lavoro, del tempo libero, delle tabelle di marcia
dell’efficienza. La felicità del non avere nessuna risposta per una domanda, del non saper
giustificare quello che si sta facendo. Silenzio come opposizione alle parole d’ordine, spontaneità
del gesto come schermo all’artificio che ci governa quotidianamente. Fuori della corsa ogni cosa ha
la sua funzione, il suo nome, la sua spiegazione. Dentro la corsa risplende la beatitudine della parola
non detta, l’ammutolirsi della lingua nel suo essere fuori posto, fuori tempo.
Eccola qui, la felicità della corsa, il gusto di un gesto senza senso, che non produce niente, che
non serve a niente.
Nemmeno il traguardo conta. Nemmeno il risultato.
Un’attività che si bea dei suoi aspetti estremi, che ostenta il suo essere “fuori norma”, che viaggia
sulle ali dell’effimero: partire anche se si sa che non si arriverà mai primi, fare qualcosa di
grandioso senza lasciare traccia.
Ci hanno provato, runner di vari livelli, a dare una spiegazione a tutto questo: il loro silenzio resta
la risposta migliore.
Volendo proprio scegliere delle parole e farle assurgere a manifesto di quanto raccontato in queste
pagine, sceglierei queste di Kílian Jornet, che con una semplice frase dice tutto quello che c’è da
dire:
«Non è più forte colui che arriva primo, bensì colui che gode maggiormente facendo ciò che fa».
Vince chi gode di più.
In fondo, quale felicità più grande si potrebbe rincorrere?
G. DE PASCALE, Correre è una filosofia. Perché si corre, Milano 2014, 175-177.