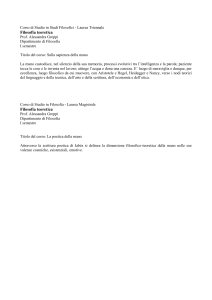RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XIX
NUOVA SERIE - N. 56 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2005
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia e
Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del
“Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce,
e dello stesso Dipartimento.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce),
Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno),
Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo,
Lucia De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia
e Scienze sociali, Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel.
(0832) 294627/8; fax (0832) 294626. E-mail: [email protected]
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto
I, 51 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto al
n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento
annuo: Italia t 25,00, Estero t 35,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero
Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da
gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo t 10,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nel settembre 2005 - per conto di Piero Manni s.r.l.
SOMMARIO
5
Luigi Longhin – Maurizio Zani
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA PSICOANALITICA:
SULL’INTENZIONALITÀ
18
Daniela De Leo
MICHELSTAEDTER E NIETZSCHE:
L’UMWERTUNG DELL’IMPERATIVO KANTIANO
34
Isabella Aguilar
LA ROSA SENZA PERCHÉ
HEIDEGGER E LA QUESTIONE DEL VIVENTE
57
Giovanni Borgo
CRISTIANESIMO E CULTURA DELLA LIBERTÀ
IN PAREYSON
74
Augusto Ponzio
LA TRANSIZIONE DELLA CULTURA ITALIANA NELLA COMUNICAZIONE GLOBALE
Su alcune riflessioni di Tullio De Mauro
Pier Paolo Pasolini, Ferruccio Rossi-Landi
86
Spartaco Pupo
LA CONOSCENZA COME “COMPRESENZA”
DI FINITI NEL REALISMO DI SAMUEL ALEXANDER
94
Graziella Morselli
LE PASSIONI TRA ETICA E POLITICA.
ANTIGONE NELLA LETTURA DI FRANCESCA BREZZI
101
Sandro Ciurlia
INDIVIDUALISMO ED UNIVERSALISMO NEL PRIMO LEIBNIZ
113
Cecilia Gazzeri
PENSIERO, PAROLA, CORPOREITÀ:
UN NESSO IDEOLOGICO-SENSISTA NELLA FILOSOFIA
DEL LINGUAGGIO DI GIACOMO LEOPARDI
124
Lucia Angelino
MERLEAU-PONTY/MELANIE KLEIN:
PROPOSTA DI UN CONFRONTO
3
132
Nunzio Bombaci
SAVIGNANO LETTORE DI MARÍA ZAMBRANO
140
Piero Venturelli
DEMOCRAZIA PLURALISTICA E SOCIETÀ GLOBALE IN MICHAEL WALZER
144
Gaetano Scatigna Minghetti
ORONZO SUMA 1880-1954. UNA TESTIMONIANZA
146
Antonio Stanca
PIERRE LEROUX E GEORGE SAND
La filosofia e la letteratura “de l’humanité”
150
Santo Arcoleo
LA FILOSOFIA: SETE DI VERITÀ E FORMAZIONE INTEGRALE DELL’UOMO
Nota sul pensiero di Maria Teresa Antonelli
160
Recensioni
184
Libri ricevuti
4
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I
testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta
su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà
essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà
restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA
PSICOANALITICA: SULL’INTENZIONALITÀ
La psicoanalisi ha sviluppato percorsi interpretativi dell’intenzionalità che
non di rado la mettono in rotta di collisione con le teorie dell’intenzionalità
offerte dalla tradizione filosofica (Agazzi, 1976, 1985a, 1985b). Il presente
lavoro cerca di tracciare le grandi linee di demarcazione che segnano questa differenza. Non potendo prendere in esame e confrontare in questa sede
tutti gli indirizzi teorici che contrassegnano le letture dei fenomeni intenzionali condotte in un’ottica filosofica e in una prospettiva psicoanalitica, ci limiteremo a individuare solo alcuni luoghi problematici salienti che possano fungere da ancoraggio per cogliere, almeno nei loro tratti essenziali, le divergenze tra i due piani disciplinari.
Filosofia, psicoanalisi e fenomeni intenzionali
A prescindere dalle macroscopiche divergenze teoriche che contrassegnano i modelli di intenzionalità consegnatici dalle due grandi correnti interpretative presenti nella tradizione filosofica, quella fenomenologia e quella espressa
dalla “svolta linguistica” (sulle cui divaricazioni teoriche cfr. Gozzano, 1997), si
può affermare, a grandi linee, che entrambe concettualizzano l’intenzionalità in
base a un comune presupposto: l’idea di un Io o di un Sé già compiuti, privi di
parti interne, dunque monolitici, i quali si relazionano a degli oggetti intenzionali indipendenti dalla coscienza individuale (oggetti astratti nel caso della
fenomenologia e proposizioni nel caso della filosofia analitica) (Longhin, 1992;
Zani, 2000). Posta in questi termini pregiudiziali la questione dell’intenzionalità
diventa il problema di come una coscienza individuale dai contorni chiaramente definiti o puntualmente definibili (almeno in linea di principio) esercita la sua
capacità di rappresentarsi individui, eventi, accadimenti interiori e di pianificare azioni. Quale che sia la caratterizzazione dell’intenzionalità, essa comunque
esprime l’attività funzionale e relazionale di una mente priva al suo interno di
zone intermedie in cui i confini tra il Sé e non-Sé sono saldamente pre-definiti, in cui non si danno contenuti intenzionali a carattere concettuale dei quali
non siano predicabili giudizi di verità o di falsità. Sotto condizioni normali, entro
questo duplice orizzonte teorico (fenomenologico e analitico), ciò che è il nonSé risulta collocato “fuori dal Sé”, mai alla “periferia del Sé”. Non appare infatti plausibile –diversamente dalla psicoanalisi– distinguere gradi di identità del
Sé tali da poter ammetterne, per esempio, una discriminazione tra aree disposte in rapporto a un nucleo centrale da cui si diramano settori concentrici il cui
grado di lontananza corrisponde simmetricamente al livello di intensità del
SAGGI
di Luigi Longhin – Maurizio Zani
5
6
senso di identità personale. La trasparenza del Sé, quanto meno a un accesso di terza persona, –assunto comunque rigettato dalla psicoanalisi– comporta la trasparenza dell’intenzionalità e dei suoi oggetti. L’intenzionalità non ha
pertanto bordi incerti, frastagliature o frange opache.
In un orizzonte fenomenologico o analitico, non meno accettabile appare
la prospettiva –di cui la psicoanalisi si è fatta portavoce– che accredita una normale oscillazione tra i diversi livelli di intensità dell’identità personale. Se ciò
fosse ammissibile, allora si dovrebbe presumere che ne derivi una alternanza
di gradi di identità del Sé, una sua eventuale frammentazione o comunque una
sua non operatività funzionale. Analogamente, non sembra acquisibile l’idea di
flussi di coscienza che, attraverso una miscelazione continua dei loro contenuti e una modulazione di intensità affettiva su una scala qualitativa, promuovano un’identità del Sé dotata di una certa fluidità interna. Ciò sembrerebbe
minare pericolosamente l’idea, ancora persistente ed ereditata per mille canali dalla tradizione descartesiana, di un “Quartiere Generale centrale” (per dirla
con Dennett, 1993, pp. 284-285) quale matrice di tutti gli atti intenzionali.
Ancor meno accreditabile è l’idea, che alberga invece in molte riflessioni
psicoanalitiche, di un Sé che si ponga all’infuori dei “confini” del proprio corpo
e/o della propria mente in virtù di processi proiettivi ovvero quella di un Sé che
si osservi come un oggetto estraneo o che si viva come un oggetto pericoloso o perturbante capace di inibire o limitare la normale attività intenzionale del
soggetto. La premessa implicita che regola questo atteggiamento filosofico di
chiusura verso ciò che appare anomalo rispetto a degli standard condivisi di
“normalità” consiste nell’assumere come modello di indagine dell’intenzionalità un soggetto adulto dotato di una mente non affetta da patologie che riguardano la sfera dell’affettività. La filosofia, in altre parole, in questo in linea con
la scienza cognitiva, ritiene di norma che la disamina dei modi distorti di operare dell’intenzionalità in ambito affettivo non sia rilevante ai fini della caratterizzazione dei processi mentali. Essa è disposta a prendere in considerazione casi di acrasia, circostanze in cui, cioè, una scelta viene condotta in contrasto con prove ed evidenze che depongono a favore di un’alternativa migliore (Searle, 2003) oppure, e più diffusamente, casi di frammentazione della
consapevolezza del soggetto ovvero di dissociazione della personalità (Di
Francesco, pp. 51-53). Tuttavia, non è orientata a fare tesoro di questa e simili incongruenze intenzionali fino a spingersi a investire le patologie dei vissuti
affettivi di una dignità cognitiva.
Gli stati intenzionali, tematizzati entro un orizzonte filosofico, non sono in
linea di massima dotati storia (se non evolutiva, in senso biologico, cfr. per
esempio: Dennett, 2004). Il problema della loro genesi e della loro trasformazione in rapporto all’esperienza pertanto non risulta particolarmente rilevante.
Se lo fosse, allora, si incapperebbe in ciò che si intende accuratamente evitare: lo “psicologismo”. Gli atti intenzionali presentano dunque una struttura già
codificata e non possono soffrire di alterazioni nel tempo.
Scarsamente significativa si presenta anche la questione della continua
ricategorizzazione dei contenuti intenzionali. Si tratta cioè della circostanza,
per cui essi, per esempio quelli mnestici, sono sottoposti a una continua riela-
2. Intenzionalità e identità personale
In ambito fenomenologico, l’applicazione di procedure empatiche a fini
cognitivi ed euristici ha trovato un luogo privilegiato nella Quinta delle Meditazioni cartesiane di Husserl (Husserl, 1960). Altri filosofi di tradizione fenomenologica, quali M. Scheler (1980, pp. 52 sgg.), M. Merleau-Ponty, (1945) ne
hanno approfondito alcuni aspetti; in ambito analitico, tramite il “principio di
carità” tematizzato da W.V.O. Quine (Quine, 1960, par. 45; Quine, 1992, pp.
66, 72) e da D. Davidson (Davidson, 1994) l’empatia ha fatto la sua ricomparsa come regola interpretativa degli stati e dei contenuti intenzionali delle altre
menti. Tuttavia, nonostante queste specificazioni “psicologiche”, benché alcuni, come Searle (Searle, 1985) parlino di differenti “modi psicologici” dell’intenzionalità, il quadro complessivo della problematica dell’intenzionalità, tuttavia,
non sembra essenzialmente lontano dai tratti che sono stati sopra delineati
(Zani, 2005). Il discorso sull’intenzionalità sviluppato entro una prospettiva psicoanalitica, segna, a questo riguardo una marcata distanza.
Innanzi tutto, il correlato profondo dell’intenzionalità, ossia il Sé, non si presenta come un tutto omogeneo. La psicoanalisi, soprattutto quella di matrice
kleiniana, ha fornito diverse versioni dell’idea di una molteplicità di parti del Sé.
Di particolare interesse appare, per esempio, la recente tematizzazione offertane da Mancia (Mancia, 2004). A suo avviso il Sé risulta suddiviso in due
SAGGI
borazione che ne muta la configurazione concettuale e affettiva tale da alterare i modi di operare degli atti intenzionali corrispondenti. L’accettazione di un
simile punto di vista, peraltro acquisito dalla psicoanalisi fin dai suoi primi passi
freudiani, può implicare, in effetti, che l’immagine autoriflessiva di noi stessi sia
sottoposta alla varianza delle narrazioni che il soggetto cerca di mettere insieme al fine di definire la propria identità.
Infine, le relazioni interattive tra intenzionalità, cioè gli incontri tra intenzionalità che promanano da diverse coscienze individuali, mantengono salde le
differenziazioni individuali di coscienza. In altre parole, i modi funzionali di operare delle singole intenzionalità che si confrontano non sono suscettibili di
modificazioni sostanziali e durature. Ciò implicherebbe mettere in gioco specificità psicologiche di operare della mente e, implicitamente, porsi la questione
degli eventuali apporti epistemici che la psicologia, e non da ultimo la psicoanalisi, può fornire alla filosofia (Zani, 2000).
Solo per ciò che concerne il problema dell’individuazione del contenuto
degli stati intenzionali altrui si è fatto talora appello a una nozione psicologica,
quella, di empatia (si veda, per esempio, Goldman, 1992; Darwall, 1998; ecc.),
sulla scia di ricerche condotte su questo tema dalla scienza cognitiva. Tuttavia,
alcuni fondamentali risvolti mentali, per esempio in termini di decentramento di
parti del Sé e di un eventuale depauperamento o potenziamento dell’identità
personale, non sembrano comunque essere stati oggetto di una particolare
attenzione filosofica (Zani, 1998)1.
7
nuclei: un nucleo inconscio non suscettibile di rimozione (“inconscio non rimosso”) e un nucleo che può andare incontro a rimozione Su questi due nuclei si
fondano e si articolano e interagiscono mutuamente parti del Sé riconducibili a
immagini genitoriali interiorizzate.
In linea di massima, la psicoanalisi assume che il grado di unità sistemica di
queste parti (quale ne sia la formulazione teorica) non è mai dato a priori, bensì
è il frutto di circostanze, non di rado casuali, che contrassegnano le esperienze
biografiche del soggetto. Le diverse forme di intenzionalità che ne derivano (scissione, identificazione proiettiva, introiezione, ecc.) costituiscono funzioni dei modi
in questa aggregazione sistemica di parti si è venuta configurando nel tempo.
L’intenzionalità non è dunque data a priori, cioè fondata originariamente su basi
trascendentali (per dirla con Husserl). Essa è sottoposta a continui ridimensionamenti che ne inficiano la “purezza”. L’“originario”, inoltre, non è, almeno in linea
di principio, pienamente trasparente all’analisi linguistica dal momento che la psicoanalisi (soprattutto quella di derivazione kleiniana) mette in gioco una dimensione pre-linguistica costitutiva del Sé. L’architettura strutturale dell’intenzionalità
e quella del linguaggio non possono pertanto confondersi né sovrapporsi, come,
ad esempio, pensa Searle (Searle, 2003).
8
3. Molteplicità degli stati intenzionali scoperti in sede psicoanalitica. Il caso dell’identificazione proiettiva
La psicoanalisi privilegia dunque tipi di intenzionalità non presi in considerazione dalla tradizione filosofica in quanto legate a esperienze inconsce precoci di cui di norma si è disinteressata la filosofia. Tali esperienze devono essere considerate rilevanti in quanto danno forma a una specifica organizzazione
del Sé e a una conformazione particolare dei modi di esplicazione dell’intenzionalità. Per esempio, nel caso di violenze o di un eccesso di frustrazioni, di
incomprensioni ecc. finiranno con il prevalere atteggiamenti intenzionali a
carattere difensivo contrassegnati da patologie relazionali contrassegnate da
un uso distorto di quelle forme di intenzionalità scoperte dalla psicoanalisi, e
da queste tematizzate sotto i titoli di scissione, identificazione proiettiva, negazione, idealizzazione (Longhin, 1992).
Per ragioni di brevità, tuttavia, ci limiteremo a tratteggiare una di queste
forme, quella codificata sotto il nome di identificazione proiettiva, oggetto di
indagine soprattutto entro la cornice del setting e considerata come una delle
maggiori scoperte della psicoanalisi dopo quella dell’inconscio (Mancia, 2004;
Grotstein, 1983). “Identificazione proiettiva” fa riferimento a un processo mentale inconscio di espansione del Sé del paziente (Grotstein, 1983; Rosenfeld,
1965; Money-Kyrle, 1978; Ogden, 1979, 1982) articolato su tre aspetti: i) un
elemento del Sé è ripudiato e proiettato in un altro (analista); ii) il paziente che
proietta compie una pressione interpersonale che costringe l’analista all’identificazione inconscia con ciò che è stato proiettato; iii) l’analista che riceve la
proiezione contiene ed elabora, al fine di “bonificarli”, i contenuti proiettati e
così favorisce la reintroiezione da parte del paziente nella forma modificata.
L’importanza della scoperta da parte della psicoanalisi di questa forma di
intenzionalità inerisce a tre circostanze. La prima, va relativa alla specifica
modalità operativa di questo tipo di intenzionalità il cui esplicarsi in riferimento
a un oggetto induce nello stesso tempo una modificazione inconscia della
natura di questo (sia nel senso di un cambiamento a livello immaginativo e
reale della sua identità, sia in quello di una pressione su di esso). La seconda,
attiene al fatto che questo tipo di intenzionalità è legata alla fantasia inconscia
di liberarsi di una parte di sé, cioè a una trasformazione del vettore stesso dell’intenzionalità, ossia il Sé. La terza, che tale atto intenzionale segue un percorso di “andata-e-ritorno”, nel senso che torna alla sua fonte dopo aver subito una significativa trasmutazione.
Infine, la rilevanza di tale scoperta anche dalla circostanza che essa mette
tipicamente in luce alcuni caratteri specifici dell’interpretazione dei contenuti
intenzionali condotta dalla psicoanalisi. Balza subito agli occhi che, nella cornice del setting, l’“interpretare” implica un “modificare”. Tale cambiamento non
si limita alla semplice manipolazione da parte dell’analista delle resistenze del
paziente, come pensano, per esempio, P. Ricoeur (Ricoeur, 1965, pp. 437
sgg.) o, in un ambito teorico non ermeneutico, A. Grünbaum2 (Grünbaum,
1985, 1988, 1993). L’interpretazione, infatti, comporta sul versante dell’analista, da una parte, accoglienza dei contenuti proiettivi (l’analista ne diventa il
“contenitore” attivo), dall’altra, una loro rielaborazione controtransferale al fine
di permettere al paziente la loro introiezione una volta privati delle loro cariche
affettive “negative” (in termini di angoscia, paura ecc.). Inoltre, l’interpretazione
psicoanalitica mira a recuperare unificare elementi dispersi della mente del
paziente (contenuti mnestici, fantastici, simbolici ecc.) che senza di essa permarrebbero in uno stato frammentario. In questo senso, “interpretare” equivale in qualche misura anche a “comunicare”. Il contesto interattivo della comunicazione si definisce, infatti, sia sotto l’egida di un’espansione del Sé da parte
del paziente, di cui l’identificazione proiettiva costituisce un importante indizio,
sia sotto il segno di un atteggiamento intrusivo da parte del paziente nella persona fantasmatica dell’analista.
5. Ermeneutica filosofica ed ermeneutica psicoanalitica
L’interpretazione psicoanalitica non segue, pertanto, una traiettoria lineare
come quella postulata dall’ermeneutica filosofica. Quest’ultima, peraltro, assume (differenziandosi ulteriormente da quella psicoanalitica) come postulato irrinunciabile la compattezza dell’Io dell’interprete e, nel caso di un contesto
comunicativo plurimo (stile Habermas, per esempio; Habermas, 1986), l’unitarietà dei Sé che concorrono comunicativamente nella formulazione dell’interpretazione (Longhin, 1992, pp. 108-110).
Qualche pur breve nota merita il rilievo delle ulteriori differenze che marcano le posizioni di due degli esponenti più in vista dell’orientamento ermeneuti-
SAGGI
4. Identificazione proiettiva e interpretazione
9
10
co che si sono interessati dello statuto epistemologico della psicoanalisi: P.
Ricoeur e A. Lorenzer3.
L’impostazione data da Ricoeur alla questione dell’interpretazione psicoanalitica discende da come, a suo avviso, l’intenzionalità viene concepita dalla
psicoanalisi. Egli pensa (con esclusivo riferimento a Freud) che la radice ultima dell’intenzionalità vada identificata nell’istinto (Ricoeur, pp. 151 sgg.). Pertanto, ogni atto intenzionale (per esempio la rimozione) si configura come uno
dei modi attraverso cui l’istinto si dota di una forma mentale. A questo punto,
l’interpretazione non può che combinare un’istanza “energetica” (ponderazione del ruolo dell’istinto in ogni attività mentale inconscia e conscia) con
un’istanza ermeneutica (la valutazione delle funzioni intenzionali e dei loro
contenuti) (Buzzoni, 1989, pp. 78-91). Una simile lettura dell’intenzionalità, la
quale ne valorizza la matrice biologica senza tuttavia offrire una qualche ipotesi comprovabile dei modi in cui il biologico viene trascritto in termini mentali,
conduce implicitamente a un risultato sicuramente non voluto da Ricoeur: quello cioè di fornire un implicito sostegno teorico a chi vorrebbe fare della neurofisiologia il tribunale ultimo di ogni giudizio sull’intenzionalità. La psicoanalisi
rimarrebbe pertanto confinata a un ruolo analitico secondario.
Lorenzer, a sua volta, fonda l’interpretazione psicoanalitica dei contenuti
intenzionali sul ruolo centrale delle procedure metodiche empatiche utilizzate
dall’analista al fine di pervenire alla comprensione dei vissuti profondi del
paziente (Lorenzer, 1970, 1977). L’esclusiva valorizzazione della funzione
metodica assolta dall’empatia comporta, tuttavia, una sottovalutazione del ruolo
attivo svolto dall’analista nel setting. Questi è colto soprattutto nel ruolo di interprete (Buzzoni, 1989, pp. 58-78) e non in quello di fattore attivo di trasformazione delle proiezioni del paziente inerenti parti del Sé, come vuole la psicoanalisi
post-freudiana4. Il Sé postulato da Lorenzer è, infatti, ancora, tutto sommato, un
Sé dotato di una struttura verticale su due livelli (il conscio e l’inconscio), ma non
articolato su parti (gli “oggetti interni” della tradizione kleiniana) che sono essere suscettibili di identificazione proiettiva. Infine, il tentativo di giustificare epistemologicamente il valore cognitivo dell’interpretazione psicoanalisitca appoggiandosi, a titolo di supporto, all’indagine dell’ontologia sociale dei pazienti
incorre nel rischio (analogo a quello di Ricoeur) di fondare il valore interpretativo della psicoanalisi su una disciplina esterna a essa: in questo caso, la sociologia (Buzzoni, 1989, pp. 77-78; Longhin, 1992, pp. 106-108).
6. Intenzionalità come matrice di diversi livelli di realtà
Un altro tratto teorico diversifica a nozione di interpretazione psicoanalitica
da quella ermeneutica e, più in generale, filosofica. “Interpretazione”, in chiave
psicoanalitica, mette infatti in gioco il concetto di livelli di realtà, assente nella
versione ermeneutica. Uno degli obiettivi dell’intervento interpretativo dell’analista, in effetti, consiste nel cogliere quell’aspetto funzionale della mente del
paziente connesso alla elaborazione, da parte di questi di forme intenzionali
proiettive che lo inducono a una confusione tra il piano di realtà dell’analista e
7. L’ascrizione di contenuti intenzionali
Secondo la psicoanalisi, dunque, l’attribuzione di stati intenzionali ad altri
individui segue strade difformi da quelle tracciate dalla fenomenologia e dalla
scuola analitica. Tali percorsi devono infatti attraversare le accidentate foreste
degli affetti e dei loro ruoli cognitivi. L’ascrizione di contenuti intenzionali si
caratterizza, infatti, nei termini di criteri che comunque mettono fuori gioco la
tradizionale contrapposizione filosofica tra un accesso privilegiato di prima persona ai propri vissuti –quali resoconti introspettivi, di matrice cartesiana– e un
accesso di terza persona, per esempio attraverso regole interpretative condotte mediante l’analisi logica delle espressioni linguistiche [come vorrebbero, per
esempio, filosofi analitici come R. Chisholm (1968) o B. Russell (1961) sulla
linea tracciata da G. Frege (1988) e da L. Wittgenstein (1967)]. L’identificazione di stati intenzionali, segnatamente entro il setting, richiede la congiunzione
dei due tipo di accesso. Si tratta cioè di una combinazione in costante fieri, in
quanto mediante l’interazione continua dei vissuti transferali del soggetto e
SAGGI
quello del soggetto stesso (Mancia, 2004). L’interpretazione, cioè, mira a
cogliere i modi dell’alterazione da parte dei soggetti in analisi di quella funzione discriminativa nei confronti dei propri oggetti che la filosofia ha tradizionalmente ascritto all’intenzionalità. Attraverso la sottolineatura del nesso intenzionalità-livelli di realtà la psicoanalisi coglie dunque una modalità specifica di
operare, cioè di “orientarsi”, dell’intenzionalità.
Ora, nel quadro teorico ermeneutico, come peraltro in quello fenomenologico e analitico, essa ha una “direzione” specifica, cioè procede dalla coscienza verso i suoi oggetti, ossia rimane su un medesimo livello di realtà. In un
orizzonte psicoanalitico, al contrario, essa ha spesso un andamento che combina diversi tipi di direzione (verso l’interno, verso l’esterno, a feedback) e di
modalità operative. Nel caso dell’identificazione proiettiva attiva nel setting,
essa consiste, per il paziente, in una preventiva scissione a titolo difensivo di
parti del sé (dunque diretta verso l’interno) che vengono proiettate (dunque
orientata verso l’esterno) sull’analista e quindi reintroiettata (una sorta di
retroazione attiva verso l’interno). L’interazione tra il transfert del paziente e il
controtransfert dell’analista (su cui cfr. Longhin, 1992, pp. 130-141) non solo
indica la non linearità del percorso intenzionale in quanto sottoposto all’azione di affetti profondi, ma anche come essa contribuisca a modificare progressivamente il senso di identità del soggetto. In quest’ottica, l’intenzionalità
assume il valore di uno dei mezzi con cui apprendiamo continuamente a
essere noi stessi. Nella sua attività multiforme, infatti, si riversano fattori normativi e affettivi tanto di ordine personale attinenti alla storia delle relazioni primarie esperite individualmente, tanto di natura morale filtrati attraverso la
nostra relazione con l’ambiente. Quest’ultimo rilievo suggerisce, dunque, il
ruolo costitutivo rispetto all’identità personale delle forme funzionali assunte
diacronicamente dall’intenzionalità, troppo spesso sottovalutate dalla filosofia
(soprattutto di tradizione analitica).
11
controtransferali dell’analista i confini tra le due linee di accesso si intersecano, si separano, si reintersecano ecc. L’attribuzione dell’intenzionalità da parte
dell’analista, ma anche dello stesso paziente, gioca dunque sull’intersezione di
questi due piani. Da parte dell’analista, essa è rivolta al fine di condurre progressivamente il paziente a ricostruire e costruire i confini della propria
coscienza deformati e distorti da traumi psicologici e, quindi, a sviluppare una
capacità di accesso personale ai propri vissuti condotta sotto il segno della
distinzione tra livelli di realtà (Longhin, 1992, pp. 135 sgg.).
8. Discriminazione tra stati intenzionali rappresentazionali e stati intenzionali
affettivi
12
In un’ottica psicoanalitica, la rete di connessione tra gli stati intenzionali,
ossia i nessi inferenziali di natura prevalentemente analogica che danno loro
un’apparente coerenza, non è evidenziabile nella sua interezza, almeno in
linea di principio (esistono contenuti e stati intenzionali che permangono
comunque a livello di latenza inconscia). Risulta in effetti difficile in molti casi
rispettare quella che in ambito filosofico è ritenuta essere una distinzione
necessaria al fine dell’individuazione degli stati intenzionali. Si tratta, cioè,
della discriminazione tra stati intenzionali rappresentazionali (quelli che presentano una relazione con un contenuto) e stati mentali privi di una direzione
verso un oggetto (quale ne sia la natura), quali, per esempio, un generico stato
di allegria, di ansia ecc. o stati caratterizzati da un diffuso e pervasivo vissuto
d’angoscia (Green, 154). Confrontiamo, a titolo illustrativo, quest’ultimo caso,
l’affetto di angoscia.
In sede filosofica, l’angoscia viene ritenuta uno dei tipici stati affettivi non
caratterizzati da un contenuto condivisibile (in quanto privato) e privo di una
qualche relazione con un contenuto. Di esso infatti, non è predicabile un valore di verità in quanto non risponde al requisito che sia descrivibile e isolabile
mediante un enunciato assertivo (come pensa, per esempio, Anscombe; cfr.
Anscombe, 1957). Inoltre, non gli può essere attribuita una condizione di soddisfazione, tale per cui, cioè, esistano delle circostanze in cui si realizza (come
nel caso, per esempio, del desiderio; cfr. Searle, 1985, 1996, 2003). L’angoscia, pertanto, non dispone dei titoli minimali per essere qualificata come atto
intenzionale.
Dal punto di vista psicoanalitico le cose stanno in modo affatto diverso.
Prendiamo il caso di un’angoscia depressiva legata a un trauma relazionale
precoce con una figura genitoriale, quale la separazione dalla madre. In tale
circostanza il soggetto potrebbe proiettare inconsciamente a titolo difensivo il
suo stato affettivo su un oggetto esterno (la persona dell’analista, entro la
situazione del setting, per esempio, vissuta come sostituto della figura materna) con cui identificarsi una volta “bonificato” tale stato. Inoltre, il soggetto
potrebbe utilizzare questa identificazione proiettiva per studiare le proprie sensazioni attraverso l’effetto che esse producono su tale persona. Ciò al fine di
ricavare, a livello conscio, con l’ausilio del terapeuta, informazioni circa le
SAGGI
matrici causali della sua angoscia e i modi simbolici attraverso cui essa si
esprime e si è manifestata. La natura intenzionale dell’angoscia appare ora
evidente; essa: i) possiede dei contenuti anche se non concettuali (l’articolazione del suo simbolismo); ii) è dotata di una direzione verso un oggetto (la
madre, trasfigurata immaginativamente sotto altre forme personali); iii) occorre in un sistema di altri stati intenzionali (affetti, rappresentazioni ecc.) e contenuti intenzionali (esperienze biografiche pregresse) fissati mnesticamente;
iv) svolge un ruolo funzionale (di tipo cognitivo e autoriflessivo) entro la rete
degli stati intenzionali; v) emerge grazie all’attività interpretativa del terapeuta;
vi) è ragionevolmente trattabile con il linguaggio grazie a tale lavoro ermeneutico. L’esempio mostra dunque come l’assunto della discriminazione tra stati
mentali dotati di un contenuto e stati che ne sono privi non può essere acquisito senza ampie riserve da parte psicoanalitica.
9. Il requisito della razionalità di un sistema intenzionale
L’attribuzione di stati intenzionali colta in un’ottica filosofica analitica mette
di solito in gioco l’assunto implicito della razionalità del sistema cui vengono
ascritti. Per quanto tale schema interpretativo sia stato sottoposto a interessanti correttivi (Gozzano, pp. 187-211), permane il presupposto secondo cui
uno degli indicatori più significativi di razionalità vada identificato con il livello
di complessità dell’organizzazione inferenziale degli stati mentali. Il grado di
razionalità di un sistema-mente, in altre parole, è valutabile in rapporto al
numero presumibile di inferenze e di connessioni possibili tra di esse che tale
sistema è capace di elaborare. Ne consegue, inoltre, che quanto più complessa è la rete delle inferenze (per esempio quelle che possiamo estrarre da alcune credenze) e delle conclusioni cui risulta possibile pervenire, tanto maggiore è il grado di accessibilità cosciente ai loro contenuti. Questo punto di vista
assume implicitamente che un interprete possa ricostruire i passi inferenziali
che contrassegnano l’attività del pensare in base o a criteri di coerenza di
senso comune (i quali escludono macroscopiche contraddizioni) o a canoni di
coerenza formale.
Da un osservatorio psicoanalitico il requisito del grado di integrazione inferenziale tra stati mentali quale indicatore di razionalità risulta quanto meno
troppo pretenzioso e comunque corrispondente a un modello antropologico
troppo astratto, se non ideale. Innanzi tutto, sotto il profilo psicoanalitico, qualsiasi predicato di razionalità assegnato a un intreccio di pensieri non può essere definito senza fare riferimento al ruolo di fattori inferenziali inconsci (asserto peraltro condiviso da parte di alcuni filosofi, cfr. Wisdom, 1953; MacIntyre,
1995; Audi, 1972; ecc.). In secondo luogo, un orizzonte psicoanalitico ammette una pratica inferenziale di connessione tra stati mentali piuttosto trascurata
dalla filosofia, in quanto meglio propensa a valorizzare quei nessi tra eventi
che sono concettualizzabili e descrivibili con un linguaggio proposizionale
assertivo o modale. Si tratta dell’inferenza per via di “diffusione” (Green, 2004,
pp. 150-151), ossia condotta secondo modalità che mettono innanzi tutto in
13
14
gioco connessioni non lineari tra vissuti affettivi, considerati come stati intenzionali. Tali stati si propagano nella mente in modo pervasivo e diffusivo e veicolano processi cognitivi, spesso di natura inconscia, grazie alla loro congiunzione con pensieri di diversa natura (concettuale: rappresentazioni linguistiche,
giudizi proposizionali ecc.; non concettuale: immagini mentali, tracce mnestiche ecc.) associati per via analogica. Si configura così un’interazione tra stati
affettivi e pensieri diversamente miscelati o disgiunti, contrassegnata da un
andamento irregolare “a rete” in cui si compongono aspetti di linearità con altri
oscillatori o a feedback. Ciascuno di questi aspetti, inoltre, varia in relazione
alla specifica modulazione espressiva che lo caratterizza. La proceduta miscelatoria di questi fattori possiede presumibilmente una configurazione più simile ai modi analogici in base ai quali la mente produce e inanella metafore linguistiche e non linguistiche a fini cognitivi. Si potrebbe forse parlare, a questo
riguardo, di “inferenza metaforica” o di inferenza “a grappolo” (Pagnoni, 2002)5.
In terzo luogo, l’articolazione inferenziale dei pensieri è condizionata,
soprattutto entro la cornice del setting, da un incessante processo oscillatorio
della mente del soggetto fra il suo punto di vista e quello di altri (dell’analista,
segnatamente) del tipo figura/sfondo. L’identificazione proiettiva ne configura
un significativo caso tipico.
In quarto luogo, l’errore inferenziale, il quale nella prospettiva filosofica
costituisce un segnale di scarsa integrazione tra stati mentali e dunque un elemento che parzialmente inficia la razionalità di un sistema intenzionale, rappresenta un fattore di normalità. Per esempio, nel caso del transfert si trasferiscono inconsciamente su una persona immagini e vissuti genitoriali che alterano
la percezione della dimensione reale dell’oggetto della traslazione.
In ultima analisi, la ragione di fondo per cui la psicoanalisi non è disposta a
fare proprio il criterio della complessità della strutturazione inferenziale degli
stati mentali deriva dal suo rifiuto di accreditare l’equivalenza tra razionalità e
normalità che soggiace implicitamente all’analisi filosofica dell’intenzionalità.
Da un osservatorio psicoanalitico, infatti, la sfaccettatura del Sé di un soggetto “normale” in molteplici parti implica la possibile compresenza di parti nevrotiche, narcisistiche, sadiche ecc., di parti arcaiche legate alle prime fasi di sviluppo della mente, giustapposte, sovrapposte o diversamente integrate con
altre parti non distorte o di più recente formazione. La differente combinazione
(spesso gerarchica) di queste componenti si trova a fondamento delle diverse
forme di intenzionalità attivate dalla mente. Essa si trova anche all’origine della
convivenza di pratiche inferenziali corrette e di procedure inferenziali incerte,
come di tutta una gamma di errori inferenziali possibili. La necessità di ponderare tutto questo rende piuttosto scettica la psicoanalisi in ordine al valore
cognitivo di predicati di razionalità astratti.
La conclusione che si può trarre da questi pur sintetici rilievi è che la psicoanalisi non può riconoscere come accettabili vincoli di razionalità troppo rigidi. In particolare, essa rigetta criteri che facciano leva su procedure inferenziali lineari informate a grammatiche logiche costruite in base a norme inferenziali rigorose o a modelli linguistici. In particolare, non è disposta ad ascrivere
valore a un’ipotesi di simmetria tra le regole che sorreggono l’articolazione logi-
1 Presumibilmente, questa chiusura è collegata alla premessa implicita della cristallinità del Sé
a un’analisi in terza persona mediata attraverso gli enunciati pubblici di un soggetto. I filosofi,
soprattutto quelli di tradizione analitica, comunque, hanno parzialmente corretto questa immagine
diamantina del Sé introducendo la nozione di “opacità referenziale”. Tale locuzione è nondimeno
applicata esclusivamente a contesti linguistici dove la presenza di locuzioni verbali intenzionali
(“credere”, “supporre”, “desiderare”, “auspicare” ecc.) impedisce a tali contesti di svolgere un qualsiasi ruolo referenziale. Essa, comunque, non viene mai riferita alla mente e alle sue rappresentazioni mentali (Simons, 1995).
2 Il quale ne coglie impropriamente un aspetto di “suggestione” intrusiva da parte dell’analista.
Per una critica all’impostazione metodica di Grünbaum, si veda Longhin, 1989b; Wollheim, 1993,
pp. 91-111)
3 Per un ulteriore approfondimento, cfr. Buzzoni, 1989, cap. 2 e Longhin, 1992.
4 Inoltre, tale posizione pone in essere una concezione estremamente soggettivistica della psicoanalisi. Per esempio, trascura il ruolo “oggettivante” della supervisione nella definizione dello
statuto epistemologico della psicoanalisi, ossia del controllo esercitato, secondo linee metodiche
stipulate entro una data comunità psicoanalitica, da parte di psicoanalisti esperti sul lavoro di altri
analisti (cfr. in proposito, Longhin, 1989a, 1992).
5 In sede filosofica, alcuni interessanti spunti a questo riguardo si trovano, per esempio, in
Hesse (1982) e in Hofstadter (1996). Sulle implicazioni in ordini al tema della causalità mentale
derivanti da questo andamento pluridirezionale delle inferenze individuato dalla psicoanalisi, cfr.
Fornaro (1998).
Bibliografia
AGAZZI, E. (1976), “Criteri epistemologici fondamentali delle discipline psicologiche”, in
G. Siri (a cura di), Problemi epistemologici della psicologia, Milano, Vita e Pensiero.
– (1985a), Riflessioni epistemologiche sul tema Segno, simbolo, sintomo, comunicazione, implicanze e convergenze fra filosofia psichiatria e psicoanalisi (a cura di A.
Dentone e M. Schiamone), Esagraph, Genova.
– (1985b), La questione del realismo scientifico, in Scienza e filosofia (a cura di C. Mangione), Garzanti, Milano.
ANSCOMBE, G.E.M. (1957), Intention, Cornell University Press, Ithaca.
AUDI, R. (1972),”Psychanalytic Explanation and the Concept of Rational Action”, The
Monist, vol. 56, n.3, july, pp 444-464.
SAGGI
ca del linguaggio e quelle che correlano i pensieri. Infatti, il concetto di linguaggio cui fa riferimento la psicoanalisi non è sovrapponibile a quello che ci ha
consegnato la “svolta linguistica”. Mentre quest’ultimo appare privo di rivestimenti affettivi e di sovrastrutture sonore, la psicoanalisi rende significative
variabili, quali: il tono, il timbro, il volume, il ritmo, la prosodia, i tempi, la sintassi (Mancia, 2004). Ciascuna di queste proprietà, in quanto dotata di un gradiente espressivo, può essere considerata come il vettore di stati intenzionali profondi e di inferenze inconsce da parte dei soggetti linguistici.
15
16
BUZZONI, M. (1989), Operazionismo ed ermeneutica. Saggio sullo studio epistemologico della Psicoanalisi, F. Angeli, Milano.
CHASSEGUET-SMIRGEL, J. (1964), La sessualità femminile, Laterza, Bari 1971.
CHISHOLM, R. (1957), Teoria della conoscenza, Il Mulino, Bologna 1968.
GROTSTEIN, J. S. (1981), Scissione e identificazione proiettiva, Astrolabio, Roma 1983.
DARWALL, S. (1998), “Empathy, Sympathy, Care”, in Philosophical Studies, vol. 89, nn.
2-3. March 1998, pp. 261-282.
DAVIDSON, D. (1984), Verità e interpretazione, Il Mulino, Bologna 1994.
DENNETT, D.C. (1991), Coscienza, Milano, Rizzoli 1993.
(2003), L’evoluzione della libertà, Milano, Cortina 2004.
DI FRANCESCO, M. (1998), L’io e i suoi sé. Identità personale e scienza della mente, Cortina, Milano.
FORNARO, M. (1998), “Relazioni causali e relazioni di senso: il caso delal psicoanalisi”,
in Discipline filosofiche, a. VIII, n. 2, pp. 227-244.
FREGE, G. (1923), Le connessioni di pensieri. Ricerche logiche: terza parte, in Ricerche
logiche, Guerini e associati, Milano 1988, pp. 99-125.
GOLDMAN, A. (1992), Liaisons: Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences,
Cambridge, M.I.T. Press.
GOZZANO, S. (1997), Intenzionalità, contenuto e comportamento, Armando, Roma.
GREEN, A. (2002), Idee per una psicoanalisi contemporanea, Cortina, Milano 2004.
GROTSTEIN, J.S. (1981), Scissione e identificazione proiettiva, Astrolabio, Roma 1983.
GRÜNBAUM, A. (1983), “La teoria di Freud nella prospettiva di un filosofo della scienza”
in L’anima e il compasso, (a cura di Repetti) Teoria, Roma-Napoli, 1985.
– (1984), I fondamenti della psicoanalisi, Il Saggiatore, Milano 1988.
– (1993), Validation in the Clinical Theory of Psychoanalysis, International Universities
Press, Madison.
HESSE, M. (1982), “The cognitive claims of metaphor”, in Metaphor and religion, a cura
di J.P. van Noppen, Bruxelles, Free University of Brussels, p. 27.
HOFSTADTER, D.–French, R., “Tabletop, BattleOp, Ob-Platte, Potelbat, Blattöpe, Platbeto”, in R. Hofstadter (a cura di), Concetti fluidi e analogie creative, Milano, Adelphi 1996, pp. 347-384.
HUSSERL, E. (1950), Meditazioni cartesiane (a cura di F. Costa), Bompiani, Milano 1960.
HABERMAS, J. (1981), Teoria dell’agire comunicativo, vol. I, Il Mulino, Bologna 1986.
KLEIN, M. (1928), I primi stadi del conflitto edipico, in Klein (1921-1958).
LONGHIN, L. (1989a), “La fondazione epistemologica del sapere psicoanalitico”, Bollettino della Società Filosofica Italiana, n. 137, pp. 47-63.
– (1989b), “Alcuni criteri epistemologici in risposta alle critiche di A. Grünbaum ai fondamenti della psicoanalisi”, in Neurologia Psichiatria Scienze umane, n. 5, vol.
IX, pp. 729-748.
– (1992), Alle origini del pensiero psicoanalitico, Borla, Roma.
LONGHIN, L., MANCIA, M. (a cura di) (1998), Temi e problemi in psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino.
LONGHIN, L., MANCIA, M. (a cura di) (2001), Sentieri della mente, Bollati Boringhieri, Torino.
LORENZER, A. (1970), Crisi del linguaggio e psicanalisi, Laterza, Bari 1975.
(1977) “Sprachspiel und Interaktionsformen, Suhrkamp, Frankfurt a M. (tr. it. parziale in
Simbolo ermeneutica comunicazione (a cura di) A. La Rocca, Zanichelli, Bologna 1984.
MACINTYRE, A. (1955), The Unconscious, Routledge and Kegan Paul, London.
MANCIA, M. (1987), Il sogno come religione della mente, Laterza, Roma-Bari.
– (2004), Sentire le parole, Bollati Boringhieri, Torino.
SAGGI
MELTZER, D. (1973), Lo sviluppo kleiniano, Borla, Roma, 1978.
MERLEAU-PONTY, M. (1945), Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard.
MONEY-KYRLE, R. (1978) Scritti 1927-1977, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
OGDEN, T.H. (1991), Identificazione proiettiva e la tecnica psicoterapeutica, Astrolabio,
Roma 1994.
PAGNONI, G. (2002), “Metafore e neurofisiologia”, in La metafora nelle scienze cognitive
(a cura di C. Morabito), McGraw-Hill, Milano, pp. 67-89.
POPPER, K.R. (1963), Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Il Mulino, Bologna 1972.
QUINE, W.V.O. (1960), Parola e oggetto, Il Saggiatore, Milano 1970.
– (1992), Pursuit of Truth. Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge Ma.
RICOEUR, P. (1989), “Che cos’è un testo”, in Dal testo all’azione. Saggi di Ermeneutica,
Jaca Book, Milano.
– (1965), Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, Milano 1967.
ROSENFELD, H.A. (1965), Stati psicotici, Armando, Roma 1973.
RUSSELL, B. (1958), Logica e conoscenza, Longanesi, Milano 1963.
SCHELER, M. (1973), Essenza e forme della simpatia, Città Nuova, Roma 1980.
SEARLE, J.R. (1983), Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, Bompiani, Milano 1985.
– (2001) La razionalità dell’azione, Cortina, Milano 2003.
SIMONS, P. (1995) “Mind and Opacity”, in “Dialectica”, vol. 49, fasc. 2-4, pp. 131-146.
WITTGENSTEIN, L. (1951), Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1967.
WOLLHEIM, R. (1993), The Mind and its depths, Harvard University Press, Harvard.
ZANI, M. (1998), “Alcune note sull’uso metodologico dell’empatia”, Fenomenologia e
Società, n. 3.
– (2000), “Filosofia versus psicoanalisi: rassegna critica e bibliografica di studi dell’ultimo decennio”, in Bollettino della Società Filosofica Italiana, n. 169, gen.-apr.
2000, pp. 29-40.
– (2001) “Filosofia e progresso”, in Fenomenologia e Società, n. 3.
– (2005), “Simmetrie mentali. Alcune note sulla filosofia di John Searle”, in Fenomenologia e società (in corso di pubblicazione).
17
MICHELSTAEDTER E NIETZSCHE:
L’UMWERTUNG DELL’IMPERATIVO KANTIANO
di Daniela De Leo
18
Nell’Appendice Zur Kants Metaphsik der Sitten1 agli Appunti di filosofia su
Empedocle del 1910, Michelstaedter affronta, in modo conciso, e aggiungo,
sarcastico, le risposte della “sapienza kantiana” alle questioni morali, facendo
nascere da esse nuove domande sulla genesi della morale: dalla domanda
“quale origine abbia propriamente il bene e il male” a quella, più opportuna, di
“quale valore abbiano in se stessi”.
L’imperativo categorico kantiano è per Michelstaedter occasione di percorrere con nuovi interrogativi, «con nuovi occhi l’immensa, lontana e così nascosta regione della morale, della morale realmente esistita, realmente vissuta»2,
quella zona dal colore grigio3, il documentato, l’effettivamente verificabile.
Il riferimento alle parole di Nietzsche, non è casuale, in quanto può essere
rilevato, nell’enfasi espositiva e nelle argomentazioni sostenute in questa
Appendice, l’accostamento di Michelstaedter alla filosofia del Tedesco4.
Il rilievo a prova del sostrato nietzscheano che sottende tale critica michelstaedteriana5 è quello esplicitato nello scritto del 27 novembre 1908, in cui il
Nostro pone in parallelo Nietzsche e Kant, in quella costante ricerca «del
mistero dell’essere»6. Da un lato la «filosofia e la morale eroica»7, per cui l’uomo «fa d’una sua idea particolare l’universale intuizione della realtà e che
abbatte ogni impedimento per far trionfare quest’idea ed esser così libero […]
allora ricrea o crea l’universo»8, dall’altro il «razionare» di Kant «ultima finzione del nostro egoismo?»9.
In quest’ottica, il percorso argomentativo intrapreso sarà quello, partendo
dall’Appendice agli Appunti su Empedocle e vagliando la filigrana composita
dell’opera michelstaedteriana, di affiancare al Goriziano un compagno dotto,
ardito e laborioso10, del quale si risente viva la voce nel tono alla critica antikantiana: il Nietzsche che avverte, nella difficoltà del filosofo di Königsberg di
ricondurre le cosiddette scienze della natura organica allo stesso statuto epistemologico cui sono ridotte le scienze della natura inorganica, la crisi della
visione del mondo11.
La premessa, della critica michelstaedteriana, è l’asserzione kantiana che
l’imperativo, oltre alla legge, non contiene che la necessità, per la massima, di
essere conforme a tale legge, senza che la legge sottostia a nessuna condizione, di conseguenza non resta che l’universalità d’una legge in generale, a
cui deve conformarsi la massima dell’azione, ed è soltanto questa conformità
che l’imperativo presenta propriamente come necessaria12.
L’icasticità delle conclusioni si evince fin dalle prime locuzioni di questa
Appendice: «Der granze absolute Kant ist also nur die φιλοψυχία der Men-
SAGGI
scheit»13, fino a giungere ad asserire, in conclusione, che «quella domanda
kantiana è una fredda rettorica di chi vuol giustificare il suo istinto bestialmente morale»14.
L’assoluto della legge kantiana in quanto universale mostra come l’interesse dell’io, del singolo, diventi per Kant l’interesse dell’umanità. Questo innalzamento, in realtà, produce per Michelstaedter, una ricaduta di senso: l’assoluto
di queste leggi consiste solo nell’universalità, vale a dire nella possibilità della
vita di tutti gli uomini. La volontà del singolo, le sue inclinazioni, il suo interesse vengono trasmessi all’umanità, «“Ich” wende zur Menscheit»15, la mia massima è la legge umana universale, il mio interesse è il più alto interesse morale umano. In tale prospettiva ermeneutica, l’interesse del singolo, perseguito
per istinto o per calcolo, è l’effetto tangibile della riduzione della sapienza kantiana, in quanto fondata su proposito egoistico.
L’uomo kantiano è «piegato sotto un dovere. Che forza ha il dovere? O io
riconosco per paura che per ottenere questo o quello scopo egoistico è necessario ch’io mi sottometta alla legge dell’ambiente e la morale è un puro istinto
di conservazione. Oppure voglio il bene dell’ambiente e dovere e amore s’identificano. E la felicità corrisponde in ogni caso alla mia volontà libera (sia della
mia abilità personale sia del bene universale)»16.
Nel primo caso, nel quale la morale per Michelstaedter è un puro istinto di
conservazione, è quello in cui Kant rinviene nell’amor di sé il principio di legge
universale: una natura la cui legge consistesse nel distruggere la vita proprio
in virtù di quel sentimento che è destinato a promuoverla, cadrebbe in contraddizione con se stessa, quindi non sussisterebbe come natura. Dunque, è
impossibile che quella massima possa valere come legge universale della
natura, e risulta contraria al principio supremo di ogni dovere, del dovere reale
che proviene dal principio unico suddetto: «si deve poter volere che una massima della nostra azione diventi una legge universale: ecco il canone del giudizio morale in generale»17.
In modo esplicativo, Michelstaedter così si esprime: «Ogni uomo sa il proprio interesse. E se l’istinto è niente per la posizione, l’interesse di questa posizione andrà <per> le vie dell’istinto; e l’uomo saprà che così egli può ott.<ottenere> il proprio ὰγαθὸν [beneficio]. E non gli sarà punto utile né necessario quel
ragionamento “sull’universalità”. E se lo farà così rimarrà una affermazione insignificante come quella “che un terremoto è dannoso per una città ecc”. Ma se
davvero deve aver una forza, allora egli si domanda “che m’importa dell’umanità?” Che mi vale l’umanità? E immediatamente tutta la sua morale se ne va
all’altro mondo. E in questo giudizio del valore egli avrà tanta poca sicurezza
quanta in ogni discorso della “reine theoretische Verunnft” [pura rappresentazione teoretica]. “La pura affermazione che una cosa è male per gli uomini non dice
niente sul valore degli uomini quindi sul valore morale della “cosa”»18.
Michelstaedter fa la chiosa a tale argomentazione, arguendo: «“che io me
lo prenda o non me lo prenda il permesso d’ammazzare questo non influisce
sugli altri che restano legati in ogni caso – ergo nocemus19”. La sapienza di
queste persone si riduce dunque al loro interesse personale ch’essi conoscono o per istinto o per calcolo, circa come ogni bestia»20.
19
20
Sfugge loro il possesso delle cose, la padronanza delle rispettive vite, in
quanto non possono affermarsi nel futuro, ma solo in rapporto alla “cerchia
finita”. Per il singolo «le cose non gli sono indifferenti ma giudicabili in
riguardo a un fine. Questo fine che è nella sua coscienza gli è indiscutibile,
fermo, luminoso fra le cose indifferenti […] Questo è il cerchio senza uscita
dell’individualità illusoria che afferma una persona, un fine, una ragione: la
persuasione inadeguata, in ciò ch’è adeguata solo al mondo ch’essa si
finge»21.
In questa immagine della “cerchia finita” è rinvenibile la “sufficienza” della
persona, la sicurezza dell’adattamento a un codice di diritti e doveri, è la via
kantiana, secondo Michelstaedter, delle individualità che domandano un valore e lo rapportano alla loro volontà libera e incrollabile.
«È cosa spregevole trar la legge per ciò ch’io devo fare da quanto vien fatto
o anche per la considerazione di questi limitarla»22.
La critica michelstaedteriana alla morale kantiana, trova il suo apogeo nella
condanna a questa “volontà di essere”, che è la persuasione illusoria per cui
l’individuo vuole le cose valide in sé ed agisce come rivolto verso un fine certo.
Il fine certo, la sua ragione d’essere, il senso che ha per lui ogni atto, non è
nuovamente altro che il suo continuarsi. Questa affermazione di se stesso
come individuo che ha la ragione in sé, altro non è che volontà di se stesso nel
futuro. Ma se mancando di se stesso nel presente egli si vuole nel futuro, per
la via di queste singole determinazioni, dei singoli bisogni, egli sfugge a se
stesso, non può possedersi, avere la ragione di sé, in quanto è costretto ad
attribuire valore alla propria persona e alle cose delle quali necessita per vivere. Le cose che lo attorniano sono l’unica realtà assoluta, indiscutibile, come il
bene e il male: «egli non dice: “questo è per me”, ma “questo è”; non dice:
“questo mi piace”, ma “è buono”: perché appunto l’io per cui la cosa è od è
buona, è la sua coscienza, il suo piacere, la sua attualità, che per lui è ferma
assoluta fuori del tempo. È lui ed è il mondo. E le cose del mondo sono buone
o cattive […] le cose non gli sono indifferenti ma giudicabili in riguardo a un
fine. Questo fine che è nella sua coscienza gli è indiscutibile, fermo, luminoso
fra le cose indifferenti»23.
L’uomo afferma nelle cose soltanto le relazioni superficiali, il suo piccolo
mondo. E tanto è più piccolo tanto è facilmente riproducibile in cose diverse:
«si prende il pesce con un po’ dell’acqua […] e si getta in altra acqua; la pianta non colle nude radici, ma con quel tanto di terra, e si mette in un vaso; l’uomo con i mezzi di sussistenza, e si fa di lui quello che si vuole»24.
Questo è il “cerchio” senza uscita dell’individualità illusoria, che afferma una
persona, un fine, una ragione, una coscienza: la persuasione inadeguata, in
ciò che è adeguata solo al mondo che essa si finge. Ed è questo, per Michelstaedter il cerchio della filosofia kantiana, quello di una soggettività che si erige
ad universalità, e che è, in verità, una ricaduta nella individualità illusoria. Sotto
accusa è sia la morale che la Weltanschauung di Kant, in quanto ciò che esiste, secondo il Goriziano, deve cessare di essere tale se gli si toglie il futuro, il
divenire, non l’essere è il postulato dell’esistenza: di nulla si può chiedere l’esserci, ed è l’esempio del peso che cade, del corpo chimico che aspetta il suo
SAGGI
affine25. «Non c’è sosta per chi porta un peso su per un’erta, ma quando lo
deponga dovrà andarlo a riprender sotto ove sarà ripiombato»26.
In questa congerie di casi, il valore dei valori morali è posto in discussione,
in quanto rapportabile ai tópoi koinoí (luoghi comuni) necessari per vestire27 la
persona sociale.
Questo comporta l’acquisizione di una posizione di primato della società
rispetto all’individuo. La società è divenuta l’officina fondamentale dei giudizi di
valore.
Con l’avvento della società prende avvio l’istituzione di una gerarchia di
beni, fondata sulla distinzione tra padroni e schiavi, o per usare una metafora
nietzscheana tra morale dei signori e quella del gregge.
Bene o male è allora in primo luogo tutto ciò che, rispettivamente, garantisce e rafforza o minaccia e indebolisce il potere del gruppo dominante.
«Gli uomini hanno trovato nella società un padrone migliore dei singoli
padroni, perché non chiede loro una varietà di lavori, una potenza bastante alla
sicurezza di fronte alla natura –ma solo quel piccolo e facile lavoro famigliare
ed oscuro– purché lo si faccia così come a lei è utile, purché non si urti in nessun modo cogli interessi del padrone»28.
Ciò che, in linea generale, induce i più ad accogliere la gerarchia dei
valori imposta è la paura, e non il dovere per il dovere. In una situazione di
paura gli uomini non misurano le cose e le azioni in base al piacere o al
dispiacere che esse procurano loro, ma fingono di condividere i giudizi di
valore dominanti.
Col tempo questi giudizi si trasformano in abitudini, inducendo ad attribuire
un valore supremo al sacrificio di sé e all’altruismo. Nell’interpretazione michelstaedteriana, ciò vuol dire che i più non fanno nulla per se stessi, ma soltanto
per conformarsi ad un modello di uomo, che è solo una finzione costruita dalla
società e da chi detiene il potere per il proprio vantaggio.
Sono individui ridotti a meccanismi, non vittime delle loro debolezze in balìa
del caso, «ma sufficienti e sicuri come divinità. – la loro degenerazione è detta
educazione civile, la loro fame è attività di progresso, la loro paura è la morale, la loro violenza, il loro odio egoistico. […] È il regno della rettorica»29. Il
regno in cui “addomesticati” allo stesso modo gli uomini useranno le parole
come semplici termini tecnici: «come […] si dice “forza d’attrazione”, che non
dice niente ma vuol significar solo quel complesso di effetti che tutti hanno vicini, ai quali bisogna pur supporre una causa sufficiente, così allora si dirà: virtù,
morale, dovere, religione, popolo, dio, bontà, giustizia, sentimento, bene, male,
utile, inutile, ecc. E s’intenderanno rigorosamente quelle date relazioni della
vita: i tópoi koinoí saranno fermi come quelli scientifici»30. La fornitrice di questi tópoi koinoí è la scienza.
Ma la casa della scienza è costruita sul terreno vulcanico31, sempre pronta
a farla saltare in aria, ciò vuol dire che le proposizioni scientifiche non possono più pretendersi esatte fuori del divenire storico dell’uomo.
L’accostamento è alla polemica nietzscheana32 intorno al valore conoscitivo della scienza, che risuona nella centralità del pensiero michelstaedteriano,
speculare alla messa fuori gioco del pensiero sistematico di matrice hegeliana.
21
22
Per esplicitare l’ipotesi di fondo che accomuna, nella critica alla scienza e
alla società, le due filosofie33, lasciamo parlare lo stesso Michelstaedter: «l’uomo […] solo di fronte al grande mistero dell’essere che egli non indaga ma
intuisce; solo di fronte agli altri uomini, che come lui vivono soli e selvaggi
senza la parola che veli e turbi l’unità dell’essere, senza la società che elevi a
codice l’egoismo e la conservazione degli uomini, e mentre li toglie dall’universalità della loro incoscienza, li avvicina in servitù che la paura ha creato e faccia loro crescere sotto la propria egidia ipocrita le tante piccole e grandi viltà
sentimentali, che la crescente finzione morale codifica. Così credo parlasse un
giorno un germanico Zaratustra»34.
È la rettorica della scienza che separa il fenomeno dall’affermazione individuale, occorre, dunque, attuare l’Umwertung, il capovolgimento dei valori.
Guardare «il quadro generale della vita e dell’esistenza» per «servirsi delle singole scienze senza danneggiarsi: infatti senza un tale quadro complessivo
regolatore, esse sono fili che non portano mai alla fine e che rendono il corso
della nostra vita ancora più confuso e labirintico»35.
Riprendendo le parole del profeta Isaia, Michelstaedter accusa gli scienziati moderni di avere dei microscopi e non vedere, microfoni e non sentire. E suggerisce, come prova della soggettività nell’oggettività scientifica, di fare l’esperimento di «Gilliatt nei Lavoratori del mare quando si lascia uccidere dall’acqua
che monta, seduto sullo scoglio»36. Nessuna cosa è per sé, ma in riguardo ad
una coscienza, non c’è possesso d’una cosa, ma solo mutarsi in riguardo ad
una cosa, entrare in relazione con una cosa.
Nelle trame dei rapporti costituiti l’uomo vi immette se stesso per una qualunque affermazione di sé, come coscienza di quel rapporto. «Determinazione
è attribuzione di valore: coscienza»37. Parafrasando Husserl: ogni atto implica
intenzionalmente un ambito più vasto che alla fine risulta essere l’intero mondo
come orizzonte universale, il mondo è soltanto per un io e che l’io è soltanto in
quanto proiettato in un’esperienza di mondo. L’esito al quale perviene Michelstaedter è indicativo della necessità del rapporto medesimo – coscienza/realtà, mettendo in discussione l’unicità assoluta della realtà sia in se stessa che
nella coscienza individuale.
Con l’oggettività la scienza, implica la rinuncia totale dell’individualità, in
quanto considera i valori dei sensi, o i dati statistici dei bisogni materiali come
ultimi valori.
Sulle orme di Nietzsche, il Goriziano direbbe che, crollata la rettorica,
sopravvive la dolorosa tensione dell’essere: «e l’uomo s’innalza eroicamente e
si purifica: le arti imitative lo rappresentano nei suoi vari atteggiamenti misticamente eroici, la musica manifesta l’empito della sua volontà»38.
«Così dunque nella società organizzata ognuno violenta l’altro attraverso
l’onnipotenza dell’organizzazione, ognuno è materia e forma, schiavo e padrone ad un tempo per ciò che la comune convenienza a tutti comuni diritti conceda ed imponga comuni doveri»39.
La trama della loro vita è sottesa dalla paura del dolore: «questo dolore
accomuna tutte le cose che vivono senza persuasione, che come vivono temono la morte»40. La paura della morte induce gli uomini a prendersi cura di un
SAGGI
futuro che è ripetizione del presente, contaminato dalle loro visioni sufficienti.
Ma se a questo presente non si riconosce alcun valore, niente ha valore.
La validità implicita nel termine valore è una validità che si può intendere o
come provvisoria o come assoluta.
Gli uomini hanno bisogno, nella allegoria michelstaedteriana, per la loro esistenza, d’attribuire valore alle cose nell’atto stesso che le cercano, e nello stesso tempo riscontrare la loro vita non essere in queste, ma «esser libera nella
persuasione e fuori di quei bisogni. Perciò il valore di quelle cose non confessano essere in riguardo al loro bisogno finito; ma sotto sotto c’è il valore assoluto nel quale essi s’affermano come assoluti»41.
Ma questo è tutto apparenza, questa non è la loro persona. “Sotto sotto”
permane la loro persona assoluta, che s’afferma assolutamente nel valore
assoluto «che ha il valore assoluto: la conoscenza finita»42.
Michelstaedter e Nietzsche si ritrovano sullo stesso piano nel pretesto per
distruggere i punti cardinali, i valori, la possibilità di indicare un qualsiasi termine e di usarlo in una assoluta identità con se stesso. La logica dell’identità è
sopraffatta da una logica che non concepisce nessun termine in una inconcussa ed assoluta identità con se stesso. Il riferimento testuale è incastonato all’interno della Lettera del gennaio 1907 alla famiglia, dove è esplicitato quel concetto prettamente nietzscheano: «l’uomo superiore nel suo immediato congiungimento d’amore, d’entusiasmo con la natura, con le forze vive della vita,
al di fuori della società, al di fuori quindi da tutti i suoi concetti morali, ha diritto di schiacciare senza riguardo, a questi concetti, tutte le barriere che la società gli mette fra il suo amore e il conseguimento del suo ideale»43.
Da qui la rivolta, verso la sufficienza del piano mondano, radicata nell’esigenza morale dell’uomo che non si accetta come assorbito dalle categorie trascendentali. Ribellione di colui che è arrivato alla conoscenza della persistenza irreparabile di tutte le cose nella loro qualunque instabilità.
Questo è il composto dal quale Michelstaedter sferra la critica contro la filosofia kantiana.
Come Nietzsche, il Goriziano asserisce che la centralità del soggetto della
rivoluzione copernicana, declamata nella filosofia di Kant, finisce col riprodurre in un’altra situazione quella centralità della terra e soprattutto la sua immobilità secondo la concezione tolemaica. «Dopo Copernico l’uomo scivola sempre più verso una X»44. Prendendo come punto di partenza la filosofia kantiana si giungerebbe: «da una forma di scetticismo e relativismo corrosivo e sminuzzatore»45 a «quello scoraggiamento e quel disperare di tutta la verità»46.
Inoltre, Kant considera il mondo reale nella sua oggettività, nella sua alterità rispetto al soggetto di conoscenza, infatti sebbene cerchi di vedere, nella
sua Critica della ragion pura, come un mondo delle cose possa diventare un
cosmo conoscitivo, non nega mai la realtà in sé e per sé, l’indipendenza delle
cose rispetto al soggetto di conoscenza.
Questa vastità di contingenze è rapportabile all’impulso kantiano di una
coscienza assoluta, che in Michelstaedter non può essere legittimata, in quanto la coscienza non sarebbe altro che volontà dell’assoluto cristallizzata nella
sua illusione.
23
24
Applicare le categorie e gli a priori, dunque, vuol dire di fatto, per il Goriziano, l’illusione dell’individualità, assegnare, cioè, i più diversi significati e fini alla
realtà, in quanto si riporta la conoscenza alla coscienza individuale, che si
erige a coscienza assoluta. L’esserci consci47 è irrimediabilmente perduto.
Dalla confutazione delle posizioni teoretiche kantiane, si pongono le basi
del Michelstaedter moralista: è necessario un soggetto se l’oggetto esiste
anche senza di lui? Oppure se si osservano le cose senza essere spinti dai
bisogni, la coscienza e la cosa, il soggetto e l’oggetto si compenetrano indivisibilmente nell’attualità del presente?
Il sum tratto dal cogito è, per Michelstaedter, un errore implicito di logica, in
cui l’uomo, rinvenendo la forma assoluta, traccia le linee dalle relazioni vitali ad
un punto messo come assoluto. La coscienza «nel punto che nel presente […]
entra in relazione con la data cosa, essa si crede nell’atto del possesso e non
è che una determinata potenza […] L’Attualità – ogni presente, quella che ogni
volta, in ogni modo è detta vita, è l’infinitamente vario congiungersi della potenza localizzata determinatamente negli aspetti infinitamente vari: come coscienza, per la quale ogni volta nell’instabilità è stabile il suo correlato. […] Il senso
della vita αλλοιου̃ται δ'χωσπερ δχόταν συµµιγη̃ ϑυώµατα ϑυώµασιν [varia
come quando si mescolino profumi a profumi]»48.
Il mondo non è significato una volta per sempre, non si ha più una immagine del mondo, ma infinite immagini del mondo. Decostruita la logica dell’identità vacilla anche la sintassi: «la lingua non c’è ma devi crearla, devi crear il
mondo, devi crear ogni cosa»49. L’uomo è solo nel deserto50 e deve creare tutto
da sé, e crear sé stesso per avere il valore individuale51, deve fare di sé stesso fiamma52.
La critica michelstaedteriana si intreccia con quella nietzscheana53, indirizzata
a tutta una impostazione oggettivista e rappresentazionalista ereditata da Cartesio. L’uomo finge di credere che ci sia un mondo indipendente dal soggetto, che
possa averne una rappresentazione corretta e che la correttezza di questa descrizione del mondo passi attraverso la corrispondenza fra pensiero e realtà.
Per smontare la versione oggettivista imperante nella storia del pensiero,
Nietzsche revisiona il linguaggio perché è al suo interno che risiede la costruzione del mondo54. Il linguaggio organizza il mondo in generi, categorizza gli
oggetti in funzione delle necessità umane e costruisce un mondo raggruppando ed ordinando il suo contenuto in funzione di preferenze umane incontrate in
certe proprietà delle cose.
Comprendere il mondo è dunque possederlo.
L’esperienza sensibile cogitandola non può essere resa assoluta. La realtà
percepita dai sensi e quella rielaborata dal pensiero non rappresentano la
medesima cosa, ma son due conoscenze una in rapporto all’altra. Per spiegare questa dicotomia gnoseologica, Michelstaedter ricorre all’esempio della
punta: «noi tutti sappiamo che la punta punge: ma invano vorrei ridur questo
mio sapere a un’esperienza oggettiva: l’occhio vedrebbe una forma puntiva
conficcarsi in una mano e gocce di sangue sortirne –e la mano sentirebbe una
spiacevole impressione, ma io non saprei che la punta punge, poiché l’occhio
non ha da esser il mio occhio, la mano la mia mano, s’io pur voglia esser
SAGGI
oggettivo; e la contemporaneità delle due esperienze per l’osservatore oggettivo deve esser un caso, che egli ben si guardi dal costituire a regola –appena
dopo ripetute energiche esperienze egli potrebbe azzardare l’ipotesi che forse
le due cose dovrebbero avere un certo “legame di causa”–»55.
Il nesso di correlatività –di soggetto e oggetto– che Michelstaedter pone alla
base della concezione della coscienza, ritorna qui per stabilire l’unità organica
e vitale del rapporto uomo-natura.
«Lo stomaco non ha fame per sé ma per il corpo. Lo stomaco solo è assorbito dal mangiare –il corpo per esser assorto nel mangiare, non ne è assorbito;
quello esaurisce insieme il cibo e sé stesso in ciò che è tutto fame, –questo esaurendo col mangiare la fame– ha più buona speranza di continuare. –La soddisfazione della determinata deficienza dà modo al complesso delle determinazioni di
deficere ancora. Il complesso si dice sazio in quel riguardo senz’esser sazio del
tutto: poiché nell’affermarsi di quella determinazione c’è come criterio la previsione delle altre: il complesso delle determinazioni non è un caos ma un organismo»56. Non qui la natura e là l’uomo, ma unità vitale e organica di entrambi i termini in costante correlazione, se così non fosse invano l’uomo tenterebbe di
impossessarsi della cosa che lo attrae, finita e non in lui sarebbe la correlatività 57.
«La vita è un’infinita correlatività di coscienze»58.
Un accostamento alla fenomenologia husserliana e propriamente alla realtà dell’intenzionalità, che si rivela come la proprietà della nostra coscienza di
essere sempre correlata al mondo esperito nel suo complesso. Poiché ciascun
ente esperito è circondato da un orizzonte di rimandi, ogni atto implica intenzionalmente un ambito più vasto che alla fine risulta essere l’intero mondo
come orizzonte universale. Per questo motivo, la coscienza intenzionale è vita
che esperisce il mondo: il mondo è soltanto per un io, e l’io è soltanto in quanto proiettato in un’esperienza di mondo.
Il rapporto con le cose è di reciproco condizionamento, asserisce Michelstaedter: l’io dà valore alle cose, le cose volute riconfermano l’esserci dell’io.
In tale visione, la percezione non è solo affezione, passiva e ricettiva, ma è
anche un io posso che afferra, apprende, riconosce gli oggetti. Queste interpretazioni si snodano in maniera molto simile a quella della fenomenologia
husserliana: «nell’atto in cui l’io cede all’oggetto è sottentrata una nuova tendenza che è diretta dall’io all’oggetto»59.
Nello specifico, nell’intendere il rapporto del mondo in un costante reciproco condizionamento con il soggetto, Michelstaedter, da un lato, rende il mondo
stesso mero strumento e conduce al disconoscimento, che sarà anche heideggeriano, di un proprio valore oggettivo, pervenendo a sospettare dell’idea di
mondo, usando una metafora nietzscheana, e di tutto ciò che è contenuto o
realizzato al suo interno.
Dall’altro, come Nietzsche, il Goriziano respinge la soggettività quale astratto principio, quello di un io che pretende essere ciò che non è, e costruirsi su
un metro assoluto che nessuna unità di misura gli può fornire, in difesa dell’“io”,
sentito come finitezza spirituale, quell’io al quale tutte le cose sono insufficienti, giungendo all’altra forma di strumentalità, quella dell’io di fronte alle cose.
Nell’orientamento che mette in gioco una rete di rapporti che hanno la loro ori-
25
26
gine nella vita di esperienza60 complessiva della particolare soggettività che la
effettua, permane solo il rapporto tra il soggetto e l’oggetto, come unico principio
di individuazione: «A ognuno il suo mondo è mondo: e il valore di quel mondo è
il correlativo della sua valenza, il sapore il correlativo della sapienza»61.
La positività di questo rapporto come identità è rinvenibile nella «coscienza
più vasta» in cui «la stessa cosa è più reale, poiché riflette quella vita più vasta.
Questa l’ha di più poiché nella sua affermazione ci sono i modi della previsione più organizzata a una vasta vita, sufficiente a eliminare maggior vastità di
contingenze, che ha certa, finita, vicina nell’attimo una maggior lontananza.
Come quando due giocano agli scacchi, che le stesse figure per l’uno e per l’altro non sono le stesse, poiché per l’uno hanno una vasta cerchia di possibilità
connesse l’una all’altra, a esser sufficienti in una lontana previsione a tutte le
possibilità dell’avversario; – per questo, che gli sia inferiore, s’esauriscono in
una breve cerchia di mosse che non possono connettersi che a un piccolo
piano vicino, mentre le mosse dell’altro gli sono una incomprensibile contingenza per la quale via via egli si vede scalzati i suoi piccoli piani ed è necessitato, ogni volta alla nuova situazione adattandosi, a ricominciarli»62.
Ciò che guida l’uomo alla conoscenza della realtà sensibile è rinvenibile
negli uomini in quella facoltà del prevedere, che li colloca in un piano diverso
rispetto agli animali, e che è riscontrabile nella paura e nel desiderio che creano le gerarchie di valori in correlazione alla vita individuale.
Abolito l’orizzonte della trascendenza, della metafisica, la conoscenza veritativa è una costruzione dell’uomo, la verità da raggiungere è una aletheia,
qualcosa che esce dal nascondimento, da portare alla luce di volta in volta, mai
una volta per sempre. È l’impulso alla verità, che chiede soltanto «a che vale
in generale l’esistenza?»63.
Non c’è più posto per una comprensione comune delle cose, anche delle cose
più umili, ma c’è un non sapere dire che cosa è questo o che cosa è quello.
«Dove è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno
precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un
alto e un basso?»64.
Il nichilismo metafisico accomuna le due filosofie, quella michelstaedteriana e quella nietzscheana, quale punto di partenza. Diverso è lo sbocco argomentativo sul piano etico.
Nella divinizzazione dell’uomo come volontà di potenza Nietzsche trova
l’unica manifestazione che salvi la vita nella sua essenza. Ma questa è ancora vita nel mondo, fra le cose.
Di contro Michelstaedter invoca insistentemente la deficienza, come inconsistenza, della presenza di una assolutezza riempita di cose e voluta in correlazione alla propria persona.
Se, come per il filosofo tedesco, la vocazione, quale tensione alla libertà, è
assoluta, il tempo e lo spazio mi rideterminano in quell’atto dell’isolamento
assoluto: sono nel mondo ma non ne dipendo più. La vita consiste, per il Goriziano, nel non adattarsi ad alcuna via.
«Che giova, dunque, parlare di categorie e di principi e di apriorismi sottintendendo una cosa in sé, un mondo assoluto: ma se quello fosse non risareb-
SAGGI
be questo. […]. È la nostra coscienza che […] ci finge un essere assoluto […]:
dando sé per prova dal mondo di là il mondo di là per prova di sé – Mentre proprio essa coscienza è prova che non c’è una coscienza assoluta. (Che se quella ci fosse questa non ci sarebbe)»65.
Il parallelo è nuovamente, con Nietzsche, che comprende la necessità
umana di costruire concetti mediante il raggruppamento schematizzato di
esperienze simili, per l’esigenza di rappresentare il mondo per pensarlo.
È quello che Nietzsche chiama l’impulso verso la costruzione di metafore,
che restano chiuse all’interno del linguaggio: «quell’impulso a formare metafore, quell’impulso fondamentale dell’uomo da cui non si può prescindere neppure per un istante, poiché in tal modo si prescinderebbe dall’uomo stesso, risulta in verità non già represso, ma a stento amministrato, dal fatto che con i suoi
prodotti evanescenti, i concetti, sia stato costruito per lui un nuovo mondo,
regolare e rigido, come roccaforte»66.
Nel campo di quegli schemi è possibile costruire un ordine piramidale, creare un mondo di leggi, di delimitazioni, che si contrapponga ormai, all’altro
mondo intuitivo delle prime impressioni come qualcosa di più solido, di più
generale, più noto, di più umano, e quindi come l’elemento regolatore ed imperativo67. Questo è il meccanismo di possesso del mondo, ma è anche il rischio.
Come risolutivo si eleva il monito socratico del rispetto: «l’anima trova la
propria felicità e la sapienza in questa suprema virtù umana»68.
Per Socrate il valore dell’umanità non è un dovere astratto: «quando il ragionamento sulla possibile universalizzazione della propria massima incute rispetto, l’individuo sa quanto più vale la vita dell’umanità che la sua vita individuale,
perché vuole quella soltanto. E alla sua bontà umana corrisponde la somma saggezza umana»69. La dialettica socratica riempie di «valore i valori comuni»70.
L’esempio lo si trova nel testo Il prediletto punto d’appoggio della dialettica socratica del 1910, in cui Michelstaedter discute con Socrate sul significato del “bene”:
«Io indico, un bene. Socrate mi fa convenire che il bene non può far male; e mi
porta col mio bene in una contingenza dove esso è male. Io mostro di non curarmi più ch’esso sia bene purché sia il mio comodo. E Socrate mi chiede cosa sia
piacevole pel corpo, dormire, mangiare cose dolci, ecc. o mangiar sobriamente
e faticare negli esercizi ginnastici. Io convengo che il primo. Socrate allora mi
chiede se anche il più comodo pel corpo. Io convengo che no. Sicché è bene pel
corpo non il capriccio della piacevolezza, ma ciò che è conveniente alla sua natura»71. Dunque, Michelstaedter, riprendendo Socrate72 rinviene nella natura dell’individuo la sede del bene. Una natura che gli uomini ignorano, in quanto non
si curano di conoscere, illusi dai beni apparenti, e non è che la voce della «propria richiesta d’un essere, d’un possesso attuale; la voce della deficienza»73. Ed
è proprio questa deficienza, che Socrate vive più vasta, che può portare il filosofo greco a parlare in modo vicino e distinto la voce lontana della persuasione.
«Egli può condurmi per mano […] e tutte le cose, che colla loro attrattiva vincendomi mi rendono schiavo del cieco giro della mia illusione, egli mi può così far
vedere fragili e vane […] sì ch’io senta raccolta la mia vita, e con maggior forza,
uniti i frammentari accenti del mio dolore, chieda un valore sicuro, chieda dove
fondar in loco stabile mia speme»74.
27
28
Il bene dell’umanità che egli vuole, lo vuole come il proprio bene, dell’umanità avrà rispetto soltanto colui che saprà il valore dell’umanità, rispetto a lui
stesso: cioè colui che vorrà il bene dell’umanità come il proprio bene»75. L’uomo di fronte al proprio simile non deve comunicare il proprio valore individuale, deve attribuir valore all’altro, come persona che nega, che soffre, che non
ha, ch’egli sente dentro di sé: «e questa persona in lui rispettando negare l’apparente valore, e più vicine portare le cose lontane e più lontane cose far vivere nel presente»76.
Quest’uomo non avrà alcun bisogno di chiedere di fronte a un caso peculiare come bisogna agire, perché ognuno possa uniformarsi a quell’azione, per
il bene dell’umanità stessa, reagirebbe con lo sdegno e l’amore immediato
quali essi sgorgano da una ben definita volontà.
Nel cosmo michelstaedteriano della privazione, dove a domandare è l’inadeguatezza della individualità illusoria, il valore fondante la morale diviene la
realtà, la via socratica, il Logos eracliteo77, l’attività filosofica: il vero sapere
equivale non al possesso, ma alla ricerca del correlativo, a quella tensione-a,
quale atto morale. La vera conoscenza sta nel cercarsi e nel volersi in questa
ricerca, non nel possesso di una qualunque, non realizzabile, consistenza.
«Essere liberamente e interamente se stesso»78.
Il persuaso deve prendere su di sé la responsabilità e in sé la sicurezza
della propria vita, che altri non gli può dare: deve creare sé e il mondo, deve
essere padrone e non schiavo nella propria casa. Ma che cosa è la vita? La
risposta è nello Scritto del 1910, in cui Michelstaedter dialoga con Socrate: «la
vita non ha altro scopo se non la vita stessa»79.
«L’uomo deve farsi una via per riuscire alla vita e non per muoversi fra gli
altri, per trar gli altri con sé e non per chiedere i premi che sono e non sono
nelle vie degli uomini»80.
Così l’uomo deve avere la ragione di sé, e averla in sé per darla, senza
soste battendo la dura via lavorare nel vivo il valore individuale81, riempiendo
la propria vita di negazioni. La conseguenza è la rimostranza michelstaedteriana alla morale kantiana: «reagisci al bisogno d’affermare l’individualità illusoria, abbi l’onestà di negare la tua stessa violenza, il coraggio di vivere tutto il
dolore della tua insufficienza in ogni punto – per giungere ad affermare la persona che ha in sé la ragione, per comunicare il valore individuale: ed esser in
uno persuaso tu ed il mondo»82.
Si tratta, in altre parole, di elaborare una genealogia della morale, senza
assumere l’uomo come un’entità fissa, immutabile nel tempo; l’uomo per
Michelstaedter, come per Nietzsche, è divenuto e diviene e in esso matura il
bisogno individuale di azione riformatrice. L’assolutezza dei valori morali sia
per l’uomo della persuasione, che per lo Zarathustra è assolutezza vissuta,
sperimentata, voluta, prima ancora che proclamata, esigenza radicale che
cancella ogni norma preesistente e si fa forma e contenuto insieme, via e
verità, vita assoluta.
Ciò significa che non esistono valori assoluti, ma che i valori e le norme
morali, alle quali la vita viene di volta in volta assoggettata, hanno la loro radice nella vita stessa e, quindi, sono il prodotto di fattori umani, troppo umani.
SAGGI
1 Nel manoscritto di Michelstaedter, Appunti di filosofia su Empedocle, l’Appendice Zur Kants
Metaphsik der Sitten è da pagina 27 a pagina 34. Per la trascrizione del manoscritto rimando al
mio studio critico: D. DE LEO, Michelstaedter filosofo del “frammento”. In Appendice: CARLO MICHELSTAEDTER, Appunti di filosofia: Empedocle, Platone, Zenone stoico, Milella, Lecce 2004, pp. 52-62.
Oltre agli Appunti di filosofia su Empedocle nel libro sono riproposti anche gli appunti di Michelstaedter su Zenone stoico e Platone (Ivi, pp. 63-96), in cui il Nostro si cimenta sul confronto-conflitto
tra unità e molteplicità, due posizioni inconciliabili nella loro assolutezza, che vengono affrontate
secondo una ermeneutica che le troverà inseparabili e inestricabilmente connesse.
2 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale Scelta di frammenti postumi 1886-1887, a cura di G.
Colli e M. Montanari, Mondadori, Milano 1979, p. 11.
3 È la direzione verso l’effettiva storia della morale, non di quella costruita sulle nuvole: «è anzi
del tutto evidente quale colore debba essere per una genealogia della morale cento volte più
importante del bianco delle nuvole; intendo dire il grigio, il documentato, l’effettivamente verificabile, l’effettivamente esistito, insomma tutta le lunga, difficilmente decifrabile, scrittura geroglifica del
passato morale dell’uomo!», Ibidem.
4 La domanda se esista o meno una presunta filiazione di Michelstaedter con la filosofia di
Nietzcshe è legittima, e una risposta immediata, frutto di una analisi sommaria, porterebbe ad
escluderla, in quanto il fulcro della filosofia del Goriziano, la persuasione, è certamente un valore.
Dunque, proprio il fondamento del pensiero filosofico michelstaedteriano, non è certo passato al
vaglio della speculazione nietszcheana. Pur tuttavia esaminando attentamente gli effettivi riscontri testuali, si possono notare, nella filosofia di Michelstaedter, tematiche fortemente nietzscheane,
che influenzano le interpretazioni critiche e le scelte teoretiche del Nostro. Michelsatedter si accosta al Nietzsche del secondo periodo, mutando da quest’ultimo l’idea di una filosofia in rivolta contro quel tipo di società sottomessa all’ideologia borghese.
Di seguito si ripropongono stralci di testi dell’opera di Michelstaedter, per poter sottolineare
queste ricadute nietzscheane, alla quali si fa riferimento nel saggio presente.
I rimandi espliciti al filosofo tedesco, nelle opere del Goriziano, si contano sulle dita di una
mano, in La persuasione e la rettorica, Nietzsche, risulta praticamente ignorato. È menzionato
nelle lettere e in qualche appunto contenuto nelle Opere complete a cura di Gaetano Chiavacci.
– Lettera del gennaio 1907 alla famiglia (in C. MICHELSTAEDTER, Epistolario, a cura di S. Campailla, Adelphi, Milano 1983, pp. 166-168). In cui Michelstaedterdescrive le impressioni avute
andando a teatro ad assistere ad una pièce: Più che l’amore di Gabriele D’Annunzio. In questa
lettera così scrive: «questa sera andai a sentire Più che l’Amore – il concetto è prettamente Dannunziano, o meglio Nietzschiano», (Ivi, p. 167). In questa asserzione il Nostro, mostra di non
leggere Nietzsche attraverso D’Annunzio, bensì quest’ultimo attraverso Nietzsche. Il concetto è
esplicitato poco innanzi: «l’uomo superiore nel suo immediato congiungimento d’amore, d’entusiasmo con la natura, con le forze vive della vita, al di fuori della società, al di fuori quindi da tutti
i suoi concetti morali, ha diritto di schiacciare senza riguardo, a questi concetti, tutte le barriere
che la società gli mette fra il suo amore e il conseguimento del suo ideale», (Ibidem). Le figure
che si contrappongono in questo quadro riassuntivo, del concetto prettamente Nietzschiano
sono: individuo-società; forze vive della vita [la fedeltà alla terra e il sì alla vita dice Zarathustra]concetti morali; il suo amore-conseguimento del suo ideale. Per realizzare le proprie aspirazioni l’uomo superiore deve, da un lato, aderire alle forze della natura, ed è un aderire immediato
ed entusiastico, dall’altro deve “tendere-a”. in questa riflessione, sembra già enuclearsi la dicotomia persuasione-rettorica, e innescarsi lo scontro, inteso nel linguaggio nietzscheano, tra i due
piani e la relativa azione della ricerca della via persuasa. E, in senso analogico dal teatro alla
vita, «perché questa azione spicchi è necessario drammaticamente l’ambiente sociale con tutte
le sue leggi, i suoi affetti, i suoi pregiudizi, o un suo rappresentante convinto inesorabile, che
non possa nemmeno intendere altre idee, oppure infine un resto di questo mondo nell’animo
dell’eroe, a produrre la lotta, la crisi, la catastrofe», (Ibidem). Michelstaedter tende ad allontanarsi dalla volgarizzazione dannunziana della filosofia di Nietzsche ben distinguendo il profondo spessore filosofico che determina il superuomo di Nietzsche da quello che invece permea il
superuomo di D’Annunzio.
– Nella lettera al Chiavacci del 22 dicembre 1907, (in C. MICHELSTAEDTER, Epistolario, cit., pp.
265-269), Michelstaedter fa riferimento esplicito all’«elemento dionisiaco», (Ivi, p. 267), assimilan-
29
30
dolo all’elemento mistico che, mancherebbe nella «razionalistica», (Ibidem), religione ebraica: proprio questa assenza, dice il Nostro, spiegherebbe «la ragione dell’antisemitismo filosofico (Schopenhauer e Nietzcshe)», (Ibidem).
– Scritto del 27 novembre 1908 (in C. MICHELSTAEDTER, Opere, a cura di G. Chiavacci, Sansoni, Firenze 1958). È un passo in cui scrive di un «germanico Zaratustra […] bestialmente fulvo»,
fautore di un pensiero «mistico filosoficamente e disonesto artisticamente. Filosoficamente mistico perché è una manifestazione d’impotenza nel tempo stesso che della volontà di uniformare la
vita alla visione raggiunta», (Ibidem) fautore di tutte quelle «bestie più o meno fulve che da allora
cominciarono a infestare il mondo», (Ibidem).
5 Michelstaedter lesse Nietzsche. Di sicuro le opere Zarathustra e La nascita della tragedia.
Alcuni indizi che possono renderne prova:
a chiosa di un passo centrale della Hedda Gabler di Henrich Ibsen, Michelstaedter scrive:
«Stirb zur rechten Zeit», citazione testuale del paragrafo Vom freien Tode dell’opera di Nietzsche
Also sprach Zarathustra,
in una lettera di Vladimiro Arangio-Ruiz a Michelstaedter, si fa esplicito riferimento alla lettura,
da parte di quest’ultimo, del testo La nascita della tragedia.
6 Scritto del 27 novembre 1908, cit., p. 664.
7 Ivi, p. 665.
8 Ivi, pp. 665-666.
9 Ivi, p. 666.
10 Parafrasando lo stesso Nietzsche, si veda la Prefazione a F. NIETZSCHE, Genealogia della
morale, cit., pp. 5-12.
11 Il concetto di organico a partire da Kant, nell’aprile 1868, rappresenta il tema che Nietzsche, nell’aprile 1868, aveva avuto intenzione di affrontare in occasione della propria dissertazione di dottorato, progetto abbandonato all’inizio del maggio dello stesso anno, e sostituito con
il problema della contemporaneità di Omero ed Esiodo, basato su una nuova collazione dello
scritto Intorno a Omero, Esiodo, la loro stirpe e il loro agone. Evidenziamo i punti perspicui della
confutazione nietzscheana. Nella confutazione della concezione finalistica che crivella l’esistenza di miracoli, «l’eliminazione della teleologia ha un valore pratico», (F. NIETZSCHE, Quaderno P
18, Sulla teleologia, in ID., Appunti filosofici 1867-1869, Omero e la filosofia classica, a c. di G.
Campioni e F. Gerratana, Adelphi, Milano 1993, P 18, 22, p. 138), in quanto la teleologia solleva una quantità di problemi insolubili, come il mondo come organismo, l’origine del male. Nietzsche rimprovera al Kant della Critica del giudizio teleologico l’interpretazione del punto di vista
critico nel senso di un radicale soggettivismo gli fa vedere l’uomo che di fronte all’ignoto inventa concetti, che però raccolgono solo una somma di proprietà fenomeniche, non raggiungono la
cosa. Il problema diviene, allora, se in senso lato esistano o meno dei giudizi costitutivi aventi
universalità e necessità. Di ciò Nietzsche dubita fin da quando afferma che solo la matematica,
per il fatto stesso di essere una scienza formale, è in grado di costituire conoscenza. I giudizi
che la mente umana è in grado di elaborare, come anche quello teleologico, sono giudizi riflettenti, non determinanti. Il pericolo dinanzi al quale ci troviamo è quello di disperare della verità.
Kant avrebbe svenduto la sua conquista conoscitiva circa l’essenza della ragione per fondare
una metafisica e far sì che la morale avesse ragione.
12«Non c’è dunque che un solo imperativo categorico, cioè questo: agisci soltanto secondo
quella massima che, al tempo stesso, puoi volere che divenga una legge universale», I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, trad. it. P. Chiodi, Laterza, Bari 1988, p. 49.
13 «L’intero ed assoluto Kant dunque è unicamente la φιλοψυχία (brama della vita, amore per
la vita) dell’umanità», C. MICHELSTAEDTER, Empedocle, cit., p. 60.
14 Ibidem.
15«Io” vado verso l’umanità», Ibidem.
16 Ivi, p. 61.
17 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 54.
18 C. MICHELSTAEDTER, Empedocle, cit., pp. 61-62.
19 Dunque facciamo del male.
20 C. MICHELSTAEDTER, Empedocle, cit., p. 61.
21 ID., La persuasione e la rettorica, a cura di Sergio Campailla, Adelphi, Milano 1995, p. 19.
22 ID., Empedocle, cit., p. 62.
23 ID., La persuasione e la rettorica, cit., p. 18.
24 Ivi, p. 30.
SAGGI
25 «Un peso pende ad un gancio, e per pender soffre che non può scendere: non può uscire
dal gancio, poiché quant’è peso pende e quanto pende dipende», C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica, cit., p. 7.
«Per esempio il cloro è sempre stato così ingordo che è tutto morto, ma se noi lo facciamo
rinascere e lo mettiamo in vicinanza dell’idrogeno, esso non vivrà che per l’idrogeno», Ivi, p. 14.
26 Ivi, p. 35.
27 Metaforicamente Michelstaedter argomenta: «già ora nessun uomo nasce più nudo ma tutti
con la camicia, tutti già ricchi di ciò che i secoli hanno fatto per render loro facile la vita.. […] Questa forma, questa camicia di forza o camicia rettorica è contesta di tutte le cose nate dalla vita
sociale. […] La coscienza d’ogni uomo riposa nel possesso d’un grado qualsiasi di queste conoscenze […] egli conosce i luoghi comuni necessari per vestire la persona sociale, perché il suo
discorso a proposito di questa forma abbia l’apparenza richiesta e accetta fra gli uomini della previsione buona a ogni contingenza», Ivi, pp. 119-120.
28 Ivi, p.100. Un riferimento alla società è presente nella poesia Dicembre: «Nella pozza riflettete, /gocce unite in società, /grigio in grigio terra e cielo /per i campi e le città. /Ma la noia, il disinganno/ fra le gocce sollevar, /ed il bene che non sanno /van col vento a ricercar», C. MICHELSTAEDTER, Dicembre, in ID., Dialogo della salute, Poesie, a cura di V. Arangio-Ruiz, Formiggini ed., Genova 1912, p. 66.
29 ID., La persuasione e la rettorica, cit., p. 95.
30 Ivi, p. 119.
31 Ne La gaia scienza Nietzsche, rivolgendosi agli uomini delle conoscenza, scrive: «Credete
a me! – il segreto per raccogliere dall’esistenza la fecondità più grande e il più grande godimento
si chiama: vivere pericolosamente (gefährlich leben)! Costruite le vostre case sul Vesuvio […].
Finalmente la conoscenza stenderà la mano verso ciò che le spetta», F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Adelphi, Milano 1993, p. 54.
Si veda a tal proposito il confronto delle immagini dei fondamenti del sapere scientifico di Cartesio, Popper e Nietzsche presentato da Negri: «Cartesio […] voleva fondare l’universo del suo
sapere su un terreno tutt’altro che sismico», non sulla terra mobile e la sabbia, ma sulla roccia e
l’argilla. «Si tratta di un Cartesio che offre un’immagine dei “fondamenti” del sapere scientifico alla
quale si oppone, quasi per espresso, quella di K.R. Popper», per il quale la scienza non posa su
un solido strato di roccia, ma risulta essere un edificio costruito su palafitte, che vengono conficcate dall’alto, giù nella palude. «Non c’è dubbio che l’immagine di Popper, avverso alle certezze
dogmatiche di una scienza che pretendeva di esprimersi in proposizioni universali ed oggettive, è
più vicina a quella di Nietzsche che a quelle di Cartesio. La sabbia della palude sarà anche meno
mobile o meno improvvisamente catastrofica della terra vulcanica; ma è evidente che la sua immagine rende ugualmente conto di una scienza che non si intende più rinchiusa nella cittadella tradizionale che nessuna esperienza ulteriore avrebbe potuto, secondo i suoi costruttori e secondo
quanti fiduciosamente vi si riparavano dentro, scuotere o far saltare in aria», A. NEGRI, Nietzsche.
La scienza sul Vesuvio, Laterza, Bari 1994, p. 5. Per una analisi dettagliata dell’immagine popperiana si veda M. PERA, Popper e la scienza su palafitte, Laterza, Roma-Bari 1981.
32 L’uomo e il Vesuvio si incontrano, si uniscono dialetticamente, nell’innocente fanciullo eracliteo: «giuoco di costruzione e distruzione (Aufbauen und Zerstrümmeni) del mondo individuale,
similmente come la forza plasmatrice del mondo viene paragonata da Eraclito l’oscuro a un fanciullo che giuocando disponga pietre qua e là, innalzi mucchi si sabbia e di nuovo li disperda», F.
NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., p. 97. Il riferimento è al seguente frammento eracliteo: «αίὼν παίϕ
ε’στι παίζων πεσσεύων παιδὸϕ η‘ βασιληίη», DK, Fr.52. («Il tempo è un bambino che gioca coi dadi:
di un bimbo è il regno»). Per una analisi dettagliata cfr. A. NEGRI, Nietzsche il «fanciullo che giuoca» di Eraclito, in ID., Nietzsche e/o l’innocenza del divenire, Napoli 1986, pp. 117 e ss.
33 Ricadute nietzscheane si possono ritrovare in Michelstaedter nella germinale polemica anti-rettorica, in nuce già in questi Appunti. L’analisi demolitrice dell’apparato rettorico, almeno nelle linee
essenziali deve in realtà molto al giovane Nietzsche, che scriveva, non molti anni prima del Nostro, Su
verità e menzogna in senso extramorale. In esso, il filosofo tedesco, indagava col medesimo cipiglio
le costruzioni del filisteismo intellettuale e sociale, soprattutto, traeva conclusioni analoghe di dinsicanto: rispetto al male, al dionisiaco, all’assurdo della vita (non solo umana, ma universale). Cfr. F. NIETZSCHE, Su verità e menzogna in senso extramorale, in ID., La filosofia nell’epoca tragica dei greci e scritti dal 1870 al 1873, a cura di G. Colli e M. Montanari, Ed. Adelphi, Milano 1973, pp. 354-372.
34 C. MICHELSTAEDTER, Scritto del 27 novembre 1908, cit., pp. 664-665.
35 F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali III, Schopenhauer come educatore, in ID.,Considera-
31
32
zioni inattuali, a cura di S. Giametta e M. Montinari, Einaudi, Torino 1981, pp. 164-246, p. 182. Nell’interpretare il quadro della vita come un tutto, secondo l’ermeneutica nietzscheana, Schopenhauer «è grande, perché segue il quadro, come Amleto lo spirito, senza lasciarsi distogliere, come
fanno gli scienziati, o senza rimanere impigliato in una scolastica concettuale, che è la sorte dei
dialettici sfrenati», Ibidem.
36 C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica, cit., p. 81. Gilliatt è protagonista de romanzo I lavoratori del mare di Victor Hugo. (Gilliatt con spirito di sacrificio favorisce le nozze della sua
amata con un altro uomo, e seduto sulla sommità dello scoglio, si lascia sommergere dall’alta
marea guardando la nave che porta via i due sposi).
37 Ivi, p. 12.
38 C. MICHELSTAEDTER, Scritto del 27 novembre 1908, cit., p. 666.
39 ID., La persuasione e la rettorica, cit., p. 102.
40 Ivi, p. 24.
41 Ivi, p. 54.
42 Ibidem.
43 ID., Lettera del gennaio 1907 alla famiglia, cit., p. 167.
44 Nell’aforisma 23 di Al di là del bene e del male Nietzsche dice che i buoni sentimenti fanno
la cattiva psicologia e incita a eliminare l’impedimento che i pregiudizi morali costituiscono per il
suo sviluppo come «morfologia e teoria evolutiva della volontà di potenza». Solo così, afferma, «la
psicologia ridiventerà signora delle scienze e la via che porta ai problemi fondamentali». Da Copernico in poi, afferma, «l’uomo scivola dal centro verso una x». Questa x è la realtà, che non è più
costruita stabile costituzione delle cose. La realtà è divenuta un enigma, una x, diviene una x
anche l’Uomo. L’Uomo non c’è più, ci sono solo gli uomini, che hanno una diversa visione della
vita secondo la diversa misura della loro forza. Cfr. F. NIETZCSHE, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano 1977, pp. 28-29.
45 F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali III, Schopenhauer come educatore, cit., p. 181.
46 Ibidem. Quale effetto della filosofia di Kant, quello scoraggiamento e quel disperare di tutta
la verità, come li visse, ad esempio, Heinrich von Kleist, citato nella terza Inattuale nietzscheana,
in cui si riporta la lettera dello stesso Kleist a Wilhelmine von Zenge del 22 marzo 1801. Nella visione kleisteniana la condanna è al soggettivismo di Kant ritenuto “sconvolgente”. Il riferimento è al
fatto che lo stesso Kant non esita a proclamare che è l’uomo a prescrivere le leggi alla natura, non
sono, perciò stesso, oggettive. Cfr. I. KANT, Prolegomeni ad ogni futura metafisica, a cura di R.
Assunto, Laterza, Roma-Bari 1979, p. 82.
47 «La mia vita in rapporto alla quale io reagisco di fronte a qualsiasi esperienza sensuale è
per me certo a priori di questa esperienza, poiché è la mia vita il voús (ragione) d’ogni cosa io
posso νοειν (pensare) cioè τη̆ διανοια θεωρει̃ν (contemplare con il pensiero) le cose. Ma questo
non è uno sdoppiamento né un lavoro sulle cose ma un sich inne werden (rendersi conto), un
esserci consci, τωυ’τὸν δ’’εστὶ νοει̃ν τε καὶ ου‘´νεκέν ε’στι νόηµα (Una cosa è il pensiero e la cosa
ch’io penso)», C. MICHELSTAEDTER, Emepdocle, cit., p. 58.
48 ID., La persuasione e al rettorica, cit., pp. 12-13.
49 Ivi, p. 61.
50 Ivi, p. 34. «Egli deve avere il coraggio di sentirsi ancora solo, di guardar ancora in faccia il
proprio dolore, di sopportarne tutto il peso», Ivi, p. 44. «Io son solo, lontano, io sono diverso», C.
MCIHELSTAEDTER, Risveglio, in ID., Dialogo della salute, Poesie, cit., p. 76.
51 Ivi, p. 35.
52 «L’uomo deve far di se stesso fiamma», Ivi, p. 49. Su questa riferimento alla “fiamma” è,
ancora una volta, sorprendente la convergenza tra Michelstaedter e Nietzsche. In La gaia scienza si legge: «Vivere vuol dire per noi trasformare costantemente in luce e fiamma tutto quel che
siamo», F. NIETZCSHE, La gaia scienza, cit., p. 17.
53 Nel testo Su verità e menzogna in senso extramorale, Nietzsche sostiene che la verità dell’uomo non è nient’altro che un esercito mobile di metafore, metonimie, antropomorfismi
54 È il linguaggio l’espressione adeguata di tutta la realtà. Sulla tematica del linguaggio si veda
F. NIETZSCHE, Su verità e menzogna in senso extramorale, cit.
55 C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e al rettorica, cit., p. 80.
56 Ivi, p. 16.
57 Ivi, p. 34.
58 Ibidem.
59 E. HUSSERL, Esperienza e giudizio, Bompiani, Milano, 1995, p. 71.
SAGGI
60 Rimando alla filosofia huesserliana: «qualunque cosa siano e possano dirsi il mondo e la
realtà. Devono essere rappresentati nel quadro di una coscienza reale e possibile per mezzo di
corrispondenti sensi (e proposizioni) riempiti di un contenuto più o meno visivo», E. HUSSERL, Idee
per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, a cura di E. Filippini, Einaudi, Torino 1976, vol. I, p. 300.
61 C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e al rettorica, cit., pp. 19-20.
62 Ivi, p. 29.
63 F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali III, Schopenhauer come educatore, cit., p. 186.
64 ID., La gaia scienza, cit., p. 37.
65 C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e al rettorica, cit., p. 81.
66 F. NIETZSCHE, Su verità e menzogna in senso extramorale, cit., p. 368.
67 Ivi, p. 368.
68 C. MICHELSTAEDTER, Empedocle, cit., p. 61.
69 Ibidem.
70 «Così Cristo parla denso e complesso ai discepoli e in parabole al popolo […]. Così la dialettica socratica riempie di valore i valori comuni», C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica, cit.,
p. 48. Le analogie fra Cristo e Socrate le ritroviamo anche nelle kierkegaardiane Briciole di filosofia:
«Consideriamo brevemente oscurate, ch’è stato, lui pure, un maestro. Nasce in un determinato
ambiente, viene educato in mezzo al popolo al quale appartiene, e quando nell’età matura sentì in sé
una vocazione e un impulso egli cominciò ad insegnare, a suo modo, agli altri. Dopo aver vissuto qualche tempo come Socrate privato, egli si presenta in pubblico –quando il tempo gli sembrò opportuno–
come Socrate maestro. Benché anch’egli avesse prima subito l’influsso delle circostanze, poi a sua
volta reagì nel suo ambiente. Compiendo la sua opera, egli dava soddisfazione tanto all’esigenza che
sentiva in sé, quanto all’esigenza che altri uomini potevano avere su di lui. Così inteso, e così l’intendeva anche Socrate, il maestro si trova in una situazione scambievole nella quale la vita e l’ambiente
diventano per lui l’occasione per diventare maestro e ciò a sua volta diventa occasione per gli altri di
imparare da lui qualcosa. La sua citazione è quindi sempre tanto autopatica come simpatetica. Comprese la situazione a questo modo anche Socrate: perciò egli non volle accettare né onori, né posti
onorifici, né denaro per il suo insegnamento, poiché egli giudicava con la incorruttibilità di spirito di un
morto», S. KIERKEGAARD, Briciole di filosofia, Zanichelli, Bologna 1972, vol. I, p. 113.
71 C. MICHELSTAEDTER, Il prediletto punto d’appoggio della dialettica socratica, in ID., Opere, cit.,
p. 875.
72 La figura di Socrate assume un significato differente nelle due filosofie: per Michelstaedter
è l’uomo persuaso, per Nietzsche –come si evince dall’analisi condotta in La nascita della tragedia– è il padre del razionalismo occidentale, simbolo dell’odio della ragione e del sapere nei confronti della vita. È, comunque, per entrambi un personaggio che ha condizionato la lro vita, il loro
filosofare. Nietasche, infatti, nell’inattuale Noi filologi afferma che «Socrate –lo confesso– mi è
totalmente vicino, che devo quasi sempre combattere contro di lui», F. Nietzcshe, Richard Wagner
a Bayreuth, Considerazioni inattuali IV, Frammenti postumi 1875-1876, trad. it. G. Colli, S. Giametta e M. Montanari, in Opere, p. 159.
73 Ivi, p. 876.
74 Ivi, p. 877.
75 ID., Empedocle, cit., p. 62.
76 ID., La persuasione e la rettorica, cit., p. 45.
77 Riproponendo i versi eraclitei Michelstaedter determina la modalità stessa del fare ricerca
propria del persuaso: «cercare con dati negativi così è la ricerca della ragione del valore che non
sappiamo che cos’è ma sappiamo che non deve essere in riguardo all’irrazionalità del bisogno»,
C. MICHELSTAEDTER, Parmenide ed Eraclito, in D. DE LEO, Mistero e persuasione in Carlo Michelstaedter. Passando da Parmenide ed Eraclito, Milella, Lecce 2003, pp. 69-106, p. 103.
78 F. NIETZSCHE, Considerazioni inattuali III, Schopenhauer come educatore, cit., p. 187.
79 C. MICHELSTAEDTER, Opere, cit., p. 738.
80 ID., La persuasione e la rettorica, cit., p. 36.
81 Ivi, p. 45.
82 Ivi, p. 46.
33
LA ROSA SENZA PERCHÉ
HEIDEGGER E LA QUESTIONE DEL VIVENTE*
di Isabella Aguilar
Die Ros ist ohn warum; sie blühet, weil sie blühet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.
La rosa è senza perché; fiorisce poiché fiorisce,
di sé non gliene cale, non chiede d’esser vista.
34
Nel suo corso del 1955-1956 su Il principio di ragione Martin Heidegger utilizzò per diverse lezioni come filo conduttore questo celebre distico tratto dal
poema secentesco Il pellegrino cherubico del mistico Angelus Silesius1. In questo corso Heidegger si interroga sull’essenza del fondamento a partire dal principio di ragione sufficiente nella sua formulazione leibniziana; formulazione che
per Heidegger inaugura, regge e conforma la metafisica dell’età moderna2.
Nella quinta lezione, in cui fa la sua prima comparsa il distico di Silesius, Heidegger tratta del decisivo carattere di pretesa del principio, sulla scorta di Leibniz che lo definisce un principium reddendae rationis sufficientis3. La ratio è
ratio reddenda; “da fornire”, “da porre”. Nel costante rapportarci all’ente noi
pretendiamo che esso nella sua totalità abbia una ragione, un fondamento che
in qualche modo lo “ponga al sicuro”; esigiamo che la sufficienza del fondamento sia perfetta, completa. Efficere, sufficere, perficere: i termini che Leibniz
utilizza nei pressi della tesi del fondamento, nota Heidegger, non a caso rimandano tutti ad un molteplice facere, un fare o produrre4.
“Perché c’è il rappresentato?”, “perché esso è così com’è?”: è nel modo
banale del chiedere perché [Warum], che noi domandiamo del fondamento,
pretendendolo. Cosicché, nota Heidegger, la versione rigorosa della tesi del
fondamento, “niente è senza il fondamento che va fornito”, può venire riportata alla forma: “niente è senza perché”5. Ma finché domandare del fondamento
sarà inteso come un domandare nel modo del chiedere perché, verrà presupposta l’identificazione del fondamento con una causa, con una ragione sufficiente tale da rispondere alla domanda: “Warum?”; e finché penseremo secondo questa logica, la logica dell’intelletto e dell’ente compreso come semplice
presenza, non potremo mai arrivare mai a pensare il fondamento nel modo che
gli è appropriato. È in questo contesto, come occasione retorica per indicare
all’uditorio la possibilità di un altro cammino, che Heidegger cita il distico di
Angelus Silesius, contemporaneo di Leibniz, che al principio di Leibniz, “niente è senza perché”, indirettamente e poeticamente risponde: la rosa è senza
perché6.
Si entra così in uno dei tanti luoghi heideggeriani in cui s’incontra la rosa,
fiore per eccellenza e simbolo guida di questo breve saggio, che si interroga
proprio sul senso del simbolico e dell’esemplare nel cammino di pensiero di
Heidegger, in riferimento ai concetti di vita e natura.
I
Heidegger chiosa l’entrata della rosa di Silesius sulla scena del Principio di
ragione con queste parole:
La rosa sta qui evidentemente come esempio per tutto ciò che fiorisce,
per tutte le piante, per tutto ciò che cresce e si sviluppa nel mondo vegetale. In questo ambito, secondo la parola del poeta, la tesi del fondamento non vale8.
La rosa nominata nel distico di Silesius: evidentemente, solo un “esempio”,
o meglio una metonimia, dell’intero ambito vegetale. È in questo ambito, nella
sua interezza e nella sua particolarità regionale, che la tesi del fondamento in
qualche modo sembrerebbe non dover valere. Il riferimento privilegiato all’ambito naturale è dunque il punto di partenza che Heidegger assume per la sua
argomentazione. Interpretare il distico in riferimento alla regione dell’ente di
natura significa partire dalla prospettiva del pensiero comune e lato sensu
metafisico. E da questa prospettiva, nota Heidegger, il detto non può che suonare enigmatico: infatti, che ne è della catena di ragioni, cause e condizioni
necessarie da cui, la scienza ci insegna, dipende il fiorire della rosa? E non
cade forse il primo verso in una manifesta contraddizione, riconoscendo subito dopo che la rosa “fiorisce poiché fiorisce”? La poesia dice: La rosa è senza
perché [Warum] e tuttavia non senza poiché [weil]. Dietro la diversità dei due
termini, che trova peraltro un corrispettivo in gran parte delle lingue europee,
potrebbero forse celarsi due modi diversi di rappresentare la relazione al fon-
SAGGI
La rosa nelle arti e nel pensiero costituisce un eterno paradosso: è la fragilità stessa della sua spoglia sensibile ad aver donato a questo piccolo fiore una
spoglia simbolica immortale. Di cosa è eterno simbolo la rosa? Innanzitutto del
mistero della fioritura. Un mistero in sé molteplice: della nascita spontanea,
radicata nella terra; della Bellezza; dell’Amore e della Vita; e soprattutto del
carattere effimero di questi, se il fiorire non è che l’inizio del breve e delicato
ciclo che declina nello sfiorire. Detto questo, la rosa si presta però a tante interpretazioni quante sono le filosofie: è exemplum dell’ordine eterno del cosmo
come del mistero mistico, o del mero limite del pensiero, dell’ineffabile. «Rose
is a rose is a rose is a rose», canta il più celebre verso di Gertrude Stein, e su
cosa esso significhi generazioni di interpreti non a caso continuano ad interrogarsi7. Ma l’interpretazione heideggeriana della rosa di Silesius e più in generale del senso della Φúσις in cui cercheremo di addentrarci è forse una tra le
più sorprendenti dell’intera storia del pensiero occidentale: per il livello di originarietà cui si spinge e per il gioco ambiguo, e come vedremo irrisolto, tra la letteralità e la metaforicità del linguaggio, con cui per decenni il pensatore di
Meßkirch ha cercato di catturare e guidare i suoi ascoltatori lungo il difficile
cammino che conduce dal misterioso fenomeno del fiorire all’ancor più misterioso fiorire del fenomeno.
35
damento: il perché cercherebbe il fondamento nel modo del pretenderlo, dell’esigerlo; il poiché conterrebbe invece «la risposta che indica il fondamento»,
adducendolo. Ma se il fondamento fosse nei due casi il medesimo, e cambiasse solo il modo di rapportarvisi, laddove il perché fallirebbe come potrebbe il
poiché riuscire nel rappresentarlo? Inoltre, il verso dice chiaramente che il fondamento è il fiorire (“poiché fiorisce”): può questa risposta tautologica bastarci? Insomma, Heidegger si dilunga a mostrarci come il modo rigido di ragionare dell’intelletto comune e della logica ordinaria, nonostante i suoi sforzi, non
possa che dibattersi con impaccio fra le parole del poeta.
Tantomeno si tratta per il nostro filosofo di leggere il distico in chiave mistica –come pure sarebbe ermeneuticamente più corretto. Potremmo accontentarci di interpretare il primo verso come un monito affinché ci arrestiamo nella
nostra volontà di sapere ed accettiamo il mistero del creato attraverso la pura
fede nel creatore. Ma sebbene l’intero pellegrino cherubico sia inevitabilmente
pervaso di riferimenti a Dio e a Cristo, è probabile che il vero motivo dell’interesse di Heidegger stia piuttosto nel fatto che nel secondo verso del distico né
l’uomo né alcun dio sono nominati, bensì solo la rosa stessa:
di sé non gliene cale, non chiede d’esser vista
36
Il suo essere senza perché, piuttosto che con il rapporto tra l’uomo e Dio,
ha a che fare con il rapporto della rosa con se stessa, con il modo di essere
della rosa stessa. Qui della rosa si parla per così dire “in prima persona”. Ma
la rosa non è per l’appunto una persona; perché a differenza della persona,
ricorda Silesius, alla rosa di per sé non cale di sé. La rosa, per essere ciò che
è, non ha bisogno di curarsi espressamente di se stessa, di prestare attenzione a tutto ciò che le è proprio, tantomeno al suo “che cosa” ed al suo “come”,
alle sue ragioni determinanti, al suo fondamento. «Tra il fiorire e le ragioni del
fiorire non c’è spazio per quella attenzione alle ragioni, in forza della quale soltanto le ragioni potrebbero essere di volta in volta in quanto [als] ragioni»9. Ciò
che manca alla rosa nella prospettiva del senso comune è, potremmo dire, l’attitudine intenzionale e attenzionale, il potere riflessivo o il linguaggio. Piuttosto,
alla rosa accade il fiorire e in tale fiorire essa si risolve tutta, senza curarsi di
ciò che, come un qualcosa di diverso, potrebbe produrre quest’ultimo soltanto
dopo come effetto. La rosa dunque, a differenza dell’uomo non ha bisogno che
prima le si fornisca espressamente il fondamento del suo fiorire, non necessita di reddere rationem10.
Fin qui si procede sul piano delle ovvietà. L’uomo e la rosa hanno due modi
di essere differenti: l’uomo è quell’essere riflessivo e linguistico che ha la possibilità di interrogarsi sul mondo, su se stesso e infine sul fondamento di tutto
ciò, domandando perché, e in modo tale che questa possibilità è per lui considerata la più ovvia e dunque è legittimamente da lui pretesa; il che ci è ricordato dal principio di ragione, che è principium ratio sufficientis reddenda. Invece la rosa –e con la rosa, che è solo un esempio, tutti gli enti di natura– ha un
differente modo di essere: in questo senso è “senza perché”.
Il senso comune, rincuorato, può a questo punto notare che non per que-
SAGGI
sto, però, la rosa è senza fondamento. Piuttosto essa rientra nel dominio del
principio di ragione; semplicemente, siamo noi e non lei per se stessa a dover
chiedere quale sia il suo fondamento. Il suo rapporto con il fondamento è “in
terza persona”, non in prima. L’intelletto ordinario si sente rassicurato nella sua
logica: non gli si voleva sottrarre il potere di reddere rationem della rosa, bensì
legittimarlo; noi siamo più della rosa, che è solo e semplicemente presente in
mezzo agli altri enti, vivente, “fiorente” e, lei, non dispone del perché. Entrambi però, la rosa e noi, sebbene in modo diverso, stiamo dentro al dominio del
principio del fondamento; il principio vale nel caso della rosa (in quanto oggetto del nostro rappresentare), solo che essa non vive secondo [nach] ragioni,
fondamenti e cause, bensì solo per [durch] ragioni, fondamenti e cause11.
Fin qui può procedere l’intelletto comune in base a ciò che è riscontrabile
attraverso l’osservazione quotidiana. Le banali considerazioni svolte finora non
sono che il risultato di quella che potremmo indicare come un’analisi comparativa dei differenti modi di essere di due generi di enti semplicemente presenti
in mezzo ad un unico mondo comune.
II
1 – Un’analisi comparativa metodologicamente affine, ma in quel caso tutt’altro che banale, era stata tentata da Heidegger venticinque anni prima, nel
corso del semestre invernale 1929-30 Concetti fondamentali della metafisica12. Oggetto del raffronto con l’uomo era allora non la rosa bensì l’animale,
spesso però esplicitamente indicato come exemplum di ogni essere vivente.
Un terzo di queste lezioni è dedicato allo sviluppo di una “osservazione comparata”13 del modo di essere dell’animale rispetto a quelli dell’uomo e della
pietra (dell’ente inanimato), a partire dall’ingenua constatazione del loro carattere comune di enti semplicemente presenti “nel” mondo. Dopo la via attraverso la comprensione quotidiana del mondo-ambiente tentata in Essere e
tempo e dopo la “via storiografica” tentata l’anno precedente in Dell’essenza
del fondamento, Heidegger presenta ai suoi studenti questa analisi comparata come una terza via per rispondere alla domanda “Che cos’è mondo?”14. Si
tratterebbe, spiega, di considerare i differenti modi in cui l’uomo, l’animale e
la pietra si rapportano al mondo stesso, e di comprendere il mondo all’intersezione di questi diversi rapporti, come fosse una sorta di minimo comune
denominatore15. Se, ovviamente, si tratta di un’impostazione che finirà presto
smascherata nella sua ingenuità, non dobbiamo per questo distogliere l’attenzione dal fatto che Heidegger opera qui la scelta metodologica di partire da
una prospettiva “naturalistica”, da una sorta di metafisica della natura, e che
questa scelta costituisce una sorprendente violazione di ogni indicazione
metodologica presente nei suoi scritti della fine degli anni Venti e dei primi
anni Trenta. Infatti, se in questo delicato periodo Heidegger sembra ancora
propenso a considerare un’ontologia della natura e della vita, e dunque dell’animale e della rosa –e così pure altre “ontologie regionali”– come una possibilità e finanche una necessità per il pensiero filosofico, egli ne rimanda però
37
38
decisamente l’elaborazione, subordinandola all’analitica dell’esserci. Solo
dopo aver guadagnato una comprensione del Dasein nel suo carattere unitario, a sua volta preliminarmente orientata dal problema del senso dell’essere,
sarà possibile indagare il campo della natura vivente, ripete più volte Heidegger in Essere e tempo. Ed è proprio alla fretta di ricorrere al concetto di natura che egli attribuisce il “salto” del fenomeno del mondo da parte delle “ontologie finora apparse”16. Quello di natura, comunque lo si intenda, resta infatti
per Heidegger innanzitutto un concetto legato alla comprensione dell’ente nei
termini della Vorhandenheit, della semplice presenza: esso è il frutto di «una
determinata demondificazione del mondo»17. Se nell’analitica dell’esserci la
natura sembra assente, come si legge nella nota 55 a Dell’essenza del fondamento, è quindi per delle “buone ragioni”: «Quella decisiva è che la natura
non è qualcosa che noi possiamo incontrare nell’ambito del mondo-ambiente,
né la si può incontrare primariamente come qualcosa in rapporto a cui noi ci
comportiamo. La natura si manifesta originariamente nell’esserci in quanto
questo esiste in mezzo all’ente, sentendosi situato in uno stato d’animo. Ma
poiché il sentirsi situati (l’essere-gettato) appartiene all’essenza dell’esserci, e
si esprime nell’unità del concetto complessivo di cura, solo qui si può trovare
la base per il problema della natura»18. Finché il nostro originario sentirci
situati viene naturalisticamente interpretato in termini di un mero esser piazzati in mezzo all’ente, il concetto di natura resta il più insidioso dei concetti;
non potrà che essere fuorviante seguirlo, e ciò proprio allo scopo di raggiungere un “concetto naturale di mondo”19; solo che qui “naturale” sta per “originario”; e questa idea di originarietà è opposta all’idea di originarietà concepita in base alla categoria della semplice presenza20.
Ora, a dispetto di tutte queste indicazioni, nel corso del 1929-30 non si ha
propriamente lo sviluppo di una ontologia regionale, quanto piuttosto una lunga
analisi del modo d’essere dell’animale che in qualche modo vorrebbe preparare tale ontologia; e che, sorprendentemente, prescinde di proposito dallo sviluppo dell’analitica esistenziale. Heidegger sembra voler tentare una descrizione essenziale dell’animale, articolata ed esauriente, in grado di conciliarsi con
i risultati della più moderna biologia ed anzi di renderne conto, senza presupporre esplicitamente i traguardi di Essere e tempo. Un eccentrico interprete dei
Grundbegriffe 1929-30, il filosofo americano David Farrell Krell, non ha forse
esagerato definendo queste pagine di Heidegger sull’animale “his most splendid failure”21. Certamente il meno che si possa dire è che Heidegger abbia
seguito qui una via azzardata rispetto ai suoi presupposti metodologici, forse
spinto dall’urgenza di confrontarsi con la questione dell’essere vivente ed in
particolare dell’animalità, tanto più mentre andava maturando in lui la consapevolezza del fallimento di impostazione della sua opera principale. Certo l’impresa di Heidegger non è poi così azzardata; in queste lezioni ci si appella
spesso al carattere circolare del discorso filosofico, e di fatto l’intera descrizione è inevitabilmente guidata dai risultati dell’analitica esistenziale. Ma l’esito
dell’analisi non risulta affatto scontato. Si cercherà qui di esporlo brevemente,
per tornare poi nei pressi di quella rosa che sembriamo aver lasciato indietro.
SAGGI
2 – L’analisi del 1929-30 del modo d’essere dell’animale trae il suo orientamento da quella che a detta di Heidegger rappresenta la tesi guida del senso
comune in merito all’animalità –e che si rivelerà filosoficamente vera, seppure
ad un livello per il senso comune insospettato. La tesi afferma: “l’animale è
povero di mondo” [das Tier ist weltarm]. Essa è introdotta da Heidegger in correlazione e opposizione alle altre due tesi “l’uomo è formatore di mondo” [der
Mensch ist weltbildend] e “la pietra è senza mondo” [der Stein ist weltlos]22.
Rispetto ai modi di essere dell’uomo e della pietra, l’animale sembra così in
qualche modo trovarsi “nel mezzo”. Ora, questa posizione intermedia, per Heidegger, non è che il segno del fatto che l’indagine sull’animale costituisce per
noi l’unico vero caso in cui si dia legittimamente una questione dell’alterità, vale
a dire un problema relativo alla possibilità di trasporre noi stessi [sich versetzen] in un ente altro da noi23. Infatti, se riguardo alla pietra è impossibile anche
solo concepire per noi una “sfera di trasponibilità” con essa (se si esclude un
contesto animista, mitologico o “artistico”); e se per motivi opposti nemmeno la
questione dell’alter ego com’è noto, a differenza che per il maestro Husserl,
costituisce per il suo allievo un autentico problema, ma è piuttosto una questione superflua, perché già “essere uomo” significa: “essere trasposto nell’altro”
[Versetztsein in den Anderen], “con-essere con l’altro” [Mitsein mit den Anderen]»24; allora ecco che la questione dell’alterità consiste, si riduce a e si identifica con la questione dell’alterità tra uomo ed animale. Infatti, sostiene Heidegger, da un lato possiamo sempre legittimamente tentare una descrizione
del modo d’essere dell’animale, poiché la possibilità di accompagnarci ad esso
è da noi considerata non problematica a priori; dall’altro però non possiamo
mai essere sicuri della riuscita, dei limiti della trasposizione e del metodo più
appropriato, cosicché tale alterità costituisce effettivamente e legittimamente
un problema.
Heidegger riassume questo ambiguo stato di cose con una locuzione tanto
determinante quanto inizialmente oscura: nel caso del rapporto con gli animali quel che ci si offre è il poter concedere una trasposizione e il dover negare
un accompagnarsi [Gewährenkönnen der Versetztheit und Versagenmüssen
eines Mitgehens]25. Il fondamento di questo stato di cose lo si incontra in un’altra enigmatica formula, con cui Heidegger introduce il modo d’essere dell’animale stesso: si tratta, leggiamo, di un non avere nel poter avere il mondo o,
anche, di un farne a meno; questo “fare a meno” custodirebbe il vero senso
della povertà di mondo che il senso comune, a ragione, ritiene definire l’essenza dell’animale: «Armut (Entbehren) als Nichthaben im Habenkönnen», povertà (fare a meno) come non avere nel poter avere, sentenzia Heidegger.
Cerchiamo di far luce sul senso di queste espressioni: se l’uomo “può e non
può” rapportarsi all’animale, se “può concedere una trasposizione” ma “deve
negare un accompagnarsi”, è per via del modo d’essere dell’animale stesso, a
sua volta duplice o ambiguo: l’animale non è semplicemente “senza mondo”
come la pietra. Se così fosse, per esso non vi sarebbe possibilità di alcun rapporto con l’uomo. Il suo “non avere” è piuttosto fondato su una qualche forma
di possibilità, su un enigmatico “poter avere”; che a sua volta è la condizione
di possibilità del suo “poter concedere una trasposizione”. Il punto per Heideg-
39
40
ger sta nella necessità di pensare questa forma di possibilità al di fuori dell’alternativa tra la libera scelta –la possibilità in senso umano, in “prima persona”–
e la possibilità “in terza persona” –oggettiva, determinata da una forza vitale e
animata da una qualche forma di teleologia. Nel primo caso si antropomorfizzerebbe l’animale, nel secondo lo si considererebbe un mero meccanismo. In
entrambi i casi, avverte Heidegger, la sua essenza verrebbe radicalmente
fraintesa.
Ora: quella che Heidegger intraprende a seguito di queste indicazioni di
metodo è proprio la descrizione di questa nuova e problematica forma di possibilità di avere un qualche tipo di rapporto col “mondo” per l’animale –possibilità che a sua volta fonda l’opportunità per noi di avere un qualche tipo di rapporto con l’animale.
L’analisi del vivere animale è presentata così da un lato come legittima e
affidabile ma dall’altro come costitutivamente destinata a mantenere un lato
oscuro, intrinsecamente non svelabile. Infatti, l’oggetto della descrizione è un
modo di essere parzialmente altro da quello dell’esserci umano, e in questa
misura solo parzialmente comprensibile: il lato oscuro della descrizione, la sua
problematicità intrinseca, non potranno mai essere risolti, eliminati. D’altro
canto, come vedremo, pur senza smettere di costituire un enigma, il lato oscuro della vita animale e della vita in generale a detta di Heidegger potrà essere
compreso in modo autentico solo effettuando un passaggio su un piano totalmente altro da quello descrittivo. Ma giunti su questo piano, il piano del pensiero originario, sembra aprirsi una falla nel sistema filosofico heideggeriano.
Una falla corrispondente a quel punto oscuro che costituiva il residuo della
descrizione. Non possiamo che procedere per gradi: innanzitutto, finalmente,
dove conduceva quell’analisi?
3 – Se in Sein und Zeit il modo d’essere dell’esserci era determinato come
essere-nel-mondo [In-der-Welt-Sein] e, nel suo carattere unitario, come Cura
[Sorge], nei Concetti fondamentali della metafisica il modo d’essere dell’animale è indicato con il termine “Benommenheit”, “stordimento”26. Ciò che più preme
ad Heidegger in queste pagine è di mostrare che, come nel caso dell’esserci,
neppure il modo di essere dell’animale deve essere compreso separatamente
dal rapporto con il suo ambiente. Ma il polo “oggettivo” cui l’animale si rapporta non può essere il mondo [Welt], e nemmeno un mondo-ambiente [Umwelt]
come quello di cui parlava il biologo von Uexküll27. Piuttosto Heidegger –avvalendosi di prove empiriche tratte dall’esperienza quotidiana come da quella
scientifica– definisce questo polo come un “Ring” o “Umring”, un “cerchio” o
“cerchio ambientale”28: entro questo cerchio l’animale sarebbe incessantemente sospinto [getreiben, umgetrieben] da un comportamento all’altro da continui
stimoli ambientali in grado di disinibire i suoi istinti [Triebe], senza alcuna possibilità estatica di fuga: come stordito, appunto. Il comportamento animale
[Benehmen], completamente altro dalla condotta [Verhalten] o agire [Handeln]
propri dell’uomo, è descritto come «il lottare [Ringen] dell’animale con il suo
cerchio ambientale»29, una lotta cieca in cui l’animale è assorbito dagli “oggetti”, piuttosto che apprenderli, rap-presentarli in quanto tali.
SAGGI
L’io animale, polo “soggettivo” della struttura unitaria dello stordimento, correlativamente deve potere in qualche modo “essersi-proprio”, autopossedersi:
ciò è espresso da Heidegger con il termine di “proprietà” [Eigentum]; ma questa sorta di identità deve essere nettamente distinta dall’umana “personalità”
[Personalität] – dotata di “autocoscienza e riflessione”, nota Heidegger limitandosi sempre al piano della descrizione, dell’intelletto comune30.
La lunga descrizione di cui si sono esposti a grandi linee i risultati, in conclusione, fornisce un ritratto dell’animale come di un essere dotato di quelli che
potremmo definire uno pseudo-io, una pseudo-intenzionalità, degli pseudocomportamenti ed uno pseudo-mondo popolato da pseudo-oggetti. Con questa caratterizzazione Heidegger vuole principalmente impedire un’interpretazione del modo d’essere animale basata su un concetto di istinto quale forza
cieca e svincolabile a priori dai suoi “oggetti”, ed evitare così la legittimità del
ricorso nella spiegazione a forze vitali e teleologie di qualsiasi sorta.
Ora, il punto è che in base dell’analisi heideggeriana nulla sembra poterci
impedire di parlare nel caso dell’animale piuttosto che di pseudo-, di protointenzionalità, proto-oggetti etc… Niente nella descrizione sembra obbligarci a
riconoscere una differenza abissale ed essenziale piuttosto che una mera differenza di grado a separare, per quanto eclatantemente, l’uomo dall’animale.
Su questo piano non si può ancora affatto giustificare la posizione che Heidegger ha mantenuto con sorprendente costanza lungo il corso di tutto il suo pensiero: l’idea che l’uomo e l’animale siano separati da un abisso d’essenza. «Il
salto [Sprung] dall’animale che vive all’uomo che parla è tanto ampio se non
più ampio di quello dalla pietra senza vita all’essere vivente», afferma Heidegger per esempio nelle lezioni del 1934-5 dedicate all’inno Germanien di Hölderlin31. «La mano si distingue da ogni altro organo prensile, come zampe, artigli, zanne, infinitamente, ossia tramite un’abissalità essenziale», si legge in
Che cosa significa pensare?32. Ma i riferimenti sono innumerevoli. Il punto è
che questo abisso non può però trovare giustificazione sul piano della descrizione; nemmeno di quella fornitaci ex novo dallo stesso Heidegger. Certo, l’animale è privo di autocoscienza, del linguaggio e della sua struttura elementare,
l’in-quanto [Als]; esso non è in grado di comprendere le cose in quanto cose:
per la lucertola che si crogiola al caldo su un sasso il sole non è in quanto sole
e la pietra non è in quanto pietra. Ma basandosi sulla mera osservazione è
impossibile dire, per esempio, che l’uomo faccia altrimenti, che egli abbia davvero la possibilità di vedere il sole in quanto sole e così via; è Heidegger stesso ad averci insegnato, in Essere e tempo, che il modo in cui innanzitutto e per
lo più ci rapportiamo agli oggetti è piuttosto quello del “prendersi cura maneggiante-usante”: atteggiamento molto simile a quello con cui la formica si rapporta al sassolino, e rispetto al quale la considerazione in base alla mera semplice presenza è secondaria e derivata tramite un processo di astrazione
depauperante. Il punto è che il piano della descrizione zoologica e antropologica non può affatto bastare di per se stesso al fine di scardinare una volta per
tutte, come vuole Heidegger, l’idea antichissima e resistente che l’uomo sia un
animale in più dotato di ragione, di linguaggio.
41
42
4 – La consapevolezza che non si possano raccogliere vere e proprie prove
empiriche a favore di una distinzione essenziale e abissale tra uomo e animale è da sempre viva tra i filosofi; anche quelli che più strenuamente hanno difeso l’idea che tale distinzione esista ne hanno cercato in qualche modo il fondamento altrove; un altrove che però differisce profondamente da pensatore a
pensatore.
Kant offre un esempio eminente di questa situazione. Uno dei luoghi kantiani più cari ad Heidegger in questi anni è il primo capitolo della prima parte de La
religione nei limiti della semplice ragione33. Qui Kant, in relazione alla questione
di come l’uomo sia costituito quanto alla facoltà pratica (o, come ancora si esprime, alla “facoltà di desiderare”), distingue tre “disposizioni” originarie e ineliminabili della natura umana quali condizioni di possibilità della volontà buona. La
prima disposizione è quella all’animalità [Tierheit]; essa si esprime in un amore
di sé “puramente fisico”, “meccanico” e istintuale; sotto questo rispetto l’uomo
non è che un mero essere vivente. Nella seconda disposizione l’amore fisico di
sé è mediato dalla comparazione con gli altri; per realizzare questo confronto
l’amore di sé ha bisogno della ragione. Visto sotto questo riguardo l’uomo non
cerca ancora ciò che è bene in assoluto ma ciò che è bene per lui, ciò che è
causa della sua felicità (in un confronto con gli altri che può degenerare in invidia, ingratitudine e cattiveria); Kant chiama questa seconda disposizione, con
un’espressione per certi versi sorprendente, disposizione all’umanità [Menschheit]. Questo significa che se l’uomo rimane semplicemente uomo, non si solleverà al di là dell’amore fisico di sé e di un uso strumentale della ragione, prigioniera della brame dell’animalità: per Kant, come per Heidegger, non solo l’animalità, ma nemmeno la ragione è di per sé sufficiente a definire essenzialmente
l’uomo. Ora: sia la prima che la seconda “disposizione” possono essere filosoficamente raggiunte attraverso la semplice descrizione del nostro comportamento quotidiano. Ma solo per via della terza, quella alla personalità [Persönlichkeit],
nota Heidegger, l’uomo può mostrarsi in grado di essere all’altezza del compito
che la sua essenza gli impone; «l’essenza dell’uomo non è definita esaurientemente dalla sua umanità, essa non si compie e non si determina propriamente
che nella personalità». E la disposizione alla personalità, per Kant, si esperisce
quando l’uomo giunge a considerare se stesso non solo come razionale, ma
anche come “suscettibile d’imputazione”, cioè come soggetto moralmente
responsabile delle sue azioni. Nella Critica della ragion pratica la personalità così
intesa viene definita «ciò che eleva l’uomo al di sopra di sé (in quanto parte del
mondo dei sensi)».
Quel che interessa ad Heidegger è l’intuizione kantiana che per raggiungere la sua essenza più propria, nell’esistenza e nel pensiero, l’uomo debba elevarsi al di sopra del mondo dei sensi, dell’animalità e dell’umanità a lui proprie,
e librarsi così oltre il piano descrivibile osservativamente, per attingere all’“altrove” (un altrove dal quotidiano e non ancora dal soggetto, nel caso di Kant) della
ragione pratica pura. L’animale fuori e dentro di noi può essere compreso nella
sua “disposizione” restando sul piano dei sensi; ma perché l’uomo sia davvero
compreso in ciò che da esso lo distingue abissalmente ed essenzialmente, si
richiede che questo piano venga trasceso in un senso radicale.
5 – Torniamo all’animale ed al suo lato oscuro e impenetrabile. Come si è
detto, per quanto si possa e si debba ammettere in virtù della nostra stessa
esperienza empirica che per l’animale si dia una qualche apertura [Offenheit],
ciò che è aperto all’animale, per Heidegger, non è il mondo, non sono gli enti
in quanto tali, non è l’ambito della manifestatività [Offenbarkeit]; è invece il cerchio, all’interno del quale l’animale si trova rinchiuso, in cui è condannato a
girare e girare, stordito, sospinto da un comportamento istintuale all’altro, in
una «lotta attraverso l’oscurità»36. Ma il cerchio per Heidegger non deve essere inteso affatto come un ambito di manifestatività di tipo diverso e però anche
solo in minima parte coincidente con quello umano (di nuovo, come una protomaifestatività); e ciò non più in forza di ciò che l’empiria può o potrà mai
mostrarci. La manifestatività per Heidegger è compresa nella sua origine solo
quando è compresa nel suo emergere dal nascondimento e in originaria unità
con esso. E l’animale, come si esprime Heidegger, «è escluso dall’ambito del
conflitto essenziale di velatezza e svelatezza»; preso nella sua lotta per la vita,
esso non ha alcun rapporto con un’altra ben più essenziale lotta: la lotta di
velamento e svelamento in cui propriamente consiste la verità, compresa nella
sua essenza originaria di α-ληθεια, ossia come rapporto originario dell’uomo
con l’essere. L’animale è escluso dal rapporto originario con l’essere, per l’animale non si dà αληθεια, ed è per questo che nel suo caso non ha senso parlare del darsi di un ambito di manifestatività, di un mondo di qualsiasi genere,
fosse anche il più misero dei mondi-ambiente. «Nello stordimento l’ente per il
comportamento dell’animale non è manifesto, non è dischiuso, ma appunto per
questo neppure chiuso. Lo stordimento si trova al di fuori di questa possibili-
SAGGI
Al contrario, secondo Heidegger, laddove Kant ha cercato di pensare il proprio dell’essenza umana a partire da una comprensione ordinaria del cosmo,
della natura e della causalità, invece di cercarlo immediatamente nell’altrove
della ragione pura pratica, si è ritrovato in una dimensione irresolubilmente fallace e problematica (quella dell’idea cosmologica di libertà)34.
Un filosofo contemporaneo di Heidegger come Scheler non si trova davanti a difficoltà tanto diverse. Ne La posizione dell’uomo nel cosmo si trovano
descrizioni dettagliate del modo d’essere della pianta, dell’animale e dell’uomo,
tutte esplicitamente riconosciute come compatibili con, anzi implicanti un ordinamento unico, graduale e gerarchico degli esseri viventi. Così, alla domanda
se vi sia qualcosa di assolutamente peculiare nell’uomo in grado di scavare un
abisso d’essenza con l’animale, Scheler può rispondere positivamente solo
attraverso il ricorso alla nozione del tutto altra e nuova di Spirito (e necessiterà del concetto di Dio per riconciliarla con la vita).
D’altro canto, per Heidegger né Kant né Scheler, pur essendosi spinti molto
oltre nella ricerca di un fondamento essenziale alla distinzione tra uomo e animale, hanno raggiunto il luogo davvero originario a partire dal quale essa
possa essere fondata nella sua abissalità, bensì hanno continuato, in qualche
modo, a pensare l’uomo anche accanto all’animale, nella misura in cui non si
sono disfati del tutto da una comprensione del mondo in base alla categoria
della semplice presenza35.
43
tà»37. E se l’uomo, più propriamente, non ha bensì è rapporto con l’essere,
quella tra l’uomo e l’animale non potrà in nessun caso essere compresa come
una differenza accessoria, e nemmeno in generale come una differenza, poiché essa si fonda su un piano radicalmente altro da quello dove si situano differenze qualitative e quantitative specifiche: essa si fonda nel luogo dell’essenza unitaria e originaria dell’esser uomo. L’originario luogo ove solo può trovare fondamento la distinzione abissale tra uomo e animale è quel luogo assoluto in cui si gioca eternamente il gioco del sorgere del mondo come ambito della
manifestatività, un differenziarsi a partire dal sottrarsi originario dell’essere
stesso. Un gioco che l’uomo gioca con l’essere affinché l’essere possa giocarvi con l’uomo. E che può essere giocato in modo più o meno appropriato. Un
gioco ultimo, in cui naufraga ogni ulteriore possibilità di fondazione38.
44
6 – Solo a partire dalla “logica originaria” del fondamento infondato è possibile comprendere quel che Heidegger intende quando nei Grundbegriffe 192930 afferma che «all’animale è sottratta [genommen] la possibilità di apprendere
qualcosa in quanto qualcosa, e non qui e ora, bensì sottratta nel senso di non
data affatto […] e per questo esso non è semplicemente non-riferito ad altro,
bensì appunto assorbito da ciò, stordito»39: il vero senso e fondamento della
Benommenheit, dello stordimento, è la Genommenheit, la sottrazione del
mondo. Sottrarre, esser povero, fare a meno, non avere nel poter avere: tutti
questi termini non sembrano affatto presentare la condizione animale con neutralità, bensì valutarla negativamente. E non potrebbe esserci fraintendimento
maggiore del pensiero di Heidegger che quello di considerare la sua descrizione del modo d’essere animale e questa sorta di valutazione negativa come l’esito di un punto di vista “soggettivo”: la povertà di mondo non è un carattere
desunto dal confronto con l’uomo (come ente dotato di capacità empiricamente
costatabili). Al contrario, afferma Heidegger verso la conclusione dei Grundbegriffe, «se in certe sue varianti il fare a meno è un soffrire, allora, se il fare a
meno del mondo e l’esser-povero fanno parte dell’essenza dell’animale, la sofferenza e il dolore dovrebbero aggirarsi per l’intero regno animale e per il regno
della vita in generale»40, e che «forse soltanto i poeti, di quando in quando, ne
parlino è un argomento che la metafisica non può gettare al vento. In fondo non
è necessaria la fede cristiana per comprendere qualcosa di quella parola che
Paolo (Romani VIII, 19) scrive della struggente attesa delle creature e del creato le cui vie, come dice anche il libro Esdra, IV, 7, 12, in questo Eone sono divenute anguste, tristi e faticose»41.
S. Paolo e un testo apocrifo, trattati come testi poetici, alluderebbero a ciò
che le scienze non potranno mai vedere: che in qualche modo l’animale è stato
privato di “qualcosa”, e ciò in un senso assoluto. Questo “qualcosa” è definibile, se non forse come “grazia”, certamente come una peculiare specie di “salvezza”. Nelle lezioni del 1942-43 su Parmenide non a caso Heidegger riprende la questione dell’animale proprio in occasione della accentuazione del motivo del salvamento [Bergung] come carattere intrinseco alla αληθεια pensata
come disvelamento [Entbergung]42. «In termini iniziali lo svelato è ciò che […]
viene salvato e messo in salvo nello svelamento»; quanto è dischiuso [das
SAGGI
Augegangene] e svelato viene “accolto nella svelatezza”, ne viene “salvato” e
vi “resta in salvo”: «Das Unverbogene [lo svelato] ist das also Geborgene [salvato]»43. Ma «l’aperto salva il sito essenziale dell’uomo, se non altro perché
solo ed esclusivamente l’uomo è quell’ente per cui l’essere si apre nella radura»44; «solo ed esclusivamente l’uomo vede nell’aperto», sebbene ciò possa
poi avvenire o meno «nello sguardo essenziale del pensiero autentico»; solo
ed esclusivamente l’uomo è in rapporto con l’essere nel modo del lasciar essere la manifestatività, e reciprocamente e a un tempo e proprio in questo modo
solo ed esclusivamente per l’uomo si dà salvezza dell’ente nella sua totalità –
e così a un tempo della sua stessa essenza. L’aperto è innanzitutto quello che
«giammai la creatura potrà vedere, dal momento che il poterlo scorgere costituisce il contrassegno essenziale dell’uomo, e dunque il confine essenziale e
invalicabile tra uomo e animale». Da parte sua, «l’animale è escluso dall’ambito essenziale del conflitto fra svelatezza e velatezza, e il segno di tale esclusione essenziale è il fatto che nessun animale e nessuna pianta “ha la parola”»45: l’assenza di linguaggio non è affatto una causa (empirica), ma un segno:
la traccia visibile di ciò che è determinato una volta per tutte sul piano dell’essenza, e che possiamo chiamare una tragica assenza di salvezza.
Se ci si permette qui di saltare indisciplinatamente da un riferimento testuale all’altro è perché, a dispetto dei mutamenti linguistici e degli slittamenti concettuali attraverso cui il pensiero di Heidegger non smette mai di riguadagnare la radicalità del proprio compito, è sorprendente la costanza con cui nel
corso dei decenni egli ha affrontato il tema della vita animale. Che si guardi ai
Grundbegriffe 1929-30, ai Beiträge, al corso su Parmenide, alla Lettera sull’umanismo, all’ultimo seminario tenuto con Fink su Eraclito, rimangono immutati i termini, i concetti e le locuzioni con cui la questione viene affrontata
(anche se, con l’eccezione dei Grundbegriffe, sempre solo di sfuggita).
Ma tutt’altro che risolta, tale questione resta piuttosto irresolubile. E questa
irresolubilità è ben chiara ad Heidegger, e a ben guardare è sempre esplicitamente ribadita in questi luoghi: «La vita è un ambito che nel suo esser-aperto ha una ricchezza che forse il mondo dell’uomo non conosce per nulla»,
scrive Heidegger nel 1929-3046. «Unicamente accennando all’esclusione dell’animale dall’ambito essenziale della svelatezza, l’enigma di tutto il vivente
comincia per noi a chiarirsi in quanto enigma», si legge nelle lezioni su Parmenide47. Il pensiero originario della αληθεια non risolve né liquida affatto
l’enigma dell’alterità animale e in generale del vivente. Al contrario, ne pone
in luce il carattere di enigma assoluto, puro e ultimo. Gli animali e più in
generale i viventi si muovono in ciò che in Parmenide viene indicato –in una
sostanziale identità col Ring di quindici anni prima– una Erregbarkheit, un
“ambito di eccitabilità”; d’altro canto, essi sono esclusi dall’ambito della manifestatività [Offernbarkeit]. Questa contrapposizione di due ambiti in definitiva
assolutamente altri sembrerebbe però, così espressa, un ultimo baluardo
della metafisica, una sorta di punto cieco ove a qualcosa di metafisico ancora si accede all’interno del pensiero di Heidegger. L’allodola non vede l’aperto; ma allora «Che cosa essa “veda”, come vede, e che cosa intendiamo per
“vedere” attribuendole occhi, questo resta da domandare»48. L’enigma del
45
46
vivente non è altro che questa domanda residua, in quanto è destinata a
restare tale. Infatti, come si potrebbe «intuire tale lato nascosto [Verbogene]
del vivente»? «Vi sarebbe bisogno di una facoltà poetica innata, cioè di un
poetare a cui fosse dato qualcosa di più, di più alto e di più essenziale, perché intrinsecamente essenziale» ben diverso da quel poetare che antropomorfizza piante e animali49; ma questa facoltà poetica, che è quella di Paolo
e dei testi apocrifi citati quindici anni prima, non costituisce appunto una
sorta di ristretto spazio concesso ad un pensiero metafisico? Nella misura in
cui il vivente è cacciato in modo radicale fuori dall’ambito della manifestatività, nella misura in cui si vuole mantenere il mondo “mondo” dall’animale, in
questa misura l’enigma del vivente è e resta fuori di noi, e questo “fuori” sembra non potersi comprendere che come un luogo metafisico. Se in Heidegger resta spazio per qualcosa come una dimensione noumenica, in un senso
paragonabile a quello kantiano, la si trova qui; non nel mistero dell’interiorità, e nemmeno tanto, paradossalmente, nel mistero dell’essere con la sua
“logica salvifica”, quanto nell’enigma del vivente. Entro i confini del Ring,
come uno di quei cerchi magici tracciati dagli antichi stregoni per ospitare
forze misteriose, resta forse un luogo residuo per quell’antichissima stregoneria del pensiero che per Heidegger è in fondo la metafisica. E la possibilità parziale di comprendere l’animale, raggiungibile a partire dal nostro punto
di vista attraverso una legittima “osservazione privativa” (come la chiama
Heidegger in Essere e tempo e nei Grundbegriffe), piuttosto che trovare una
giustificazione essenziale, infine finisce per somigliare ad una sorta armonia
prestabilita.
III
1 – Torniamo finalmente alla rosa e al distico di Silesius e seguiamo Heidegger per un altro tratto nelle sue lezioni sul principio di ragione.
La rosa è senza perché; fiorisce poiché fiorisce,
di sé non gliene cale, non chiede d’esser vista.
Ci eravamo fermati all’interpretazione ordinaria secondo cui la rosa e l’uomo sarebbero due enti semplicemente presenti in mezzo al mondo, con due
differenti modi di essere e di stare nell’unico e universale dominio del principio
di ragione. Per comprendere il detto di Silesius si tratterà ora di compiere un
altro passo, un “passo indietro”, che ha il carattere di un salto [Sprung] del pensiero «fuori dall’ambito della tesi del fondamento quale principio supremo riferito all’ente […], in un dire che parla dell’essere in quanto tale». Se pensassimo che il senso del detto consiste soltanto nell’indicare la differenza fra i modi
in cui la rosa e l’uomo sono ciò che sono, infatti, saremmo davvero miopi: «Il
non detto del detto –da cui tutto dipende– dice piuttosto che l’uomo è veramente nel fondamento più nascosto della sua essenza soltanto quando, a suo
modo, è come la rosa – senza perché»50.
Il fiorire si fonda in esso stesso, ha il proprio fondamento presso esso
stesso e in esso stesso. Il fiorire è puro schiudersi da se stesso, puro
splendere. I più antichi pensatori greci dicevano Φυσις54.
2 – Il verbo ϕυω, da cui deriva il termine ϕυσις, significa far nascere, crescere, produrre; per i greci esso era riferito eminentemente proprio alla pianta,
ai suoi frutti, alle foglie. «La rosa sta qui evidentemente come esempio per tutto
ciò che fiorisce, per tutte le piante, per tutto ciò che cresce e si sviluppa nel
mondo vegetale», ci aveva detto Heidegger nell’introdurci al distico di Silesius.
Ed ora prosegue con dei cenni alla Fisica di Aristotele, ove si tenta di determinare l’essere degli enti di natura o, come traduce Heidegger, di ciò che è da sé
[das von-sich-her-Seiende].
Nel saggio del 1939 Sull’essenza e sul concetto della ϕυσις Heidegger
era partito proprio dalla distinzione aristotelica tra enti cresciuti naturalmente (Gewachse) ed enti artefatti (Gemachte)55. Qui Heidegger si appropriava
inizialmente della definizione di Aristotele della ϕυσις, riformulandola come
la «disposizione che avvia la motilità di qualcosa che è mosso, ma gli appartiene, sì che questo dispone della sua motilità in esso stesso, da esso e per
esso»56. La ϕυσις, in quanto principio genetico della rosa, non la determina
come fosse un urto iniziale che spinge via l’urtato lasciandolo poi a se stesso. «Viceversa, ciò che è così determinato dalla ϕυσις non solo nella sua
motilità resta in esso stesso, ma, dispiegandosi secondo la sua motilità (il
suo cambiare), ritorna proprio in esso stesso»57. Anche in quel saggio troviamo l’“esempio” della pianta, definita un ente cresciuto naturalmente da sé
“in senso stretto”.
SAGGI
La rosa, che ci era parsa “meno” di noi, incompleta nel suo mero stare al
mondo, si scopre avere ora piuttosto qualcosa da insegnarci. L’ente di natura,
proprio in virtù del suo essere senza perché, mostrerebbe un altro modo di
essere del fondamento, e ad un tempo un altro possibile modo di stare nel fondamento per l’uomo: l’uomo è come la rosa, scrive Heidegger, ma a suo modo.
L’uomo e la rosa: entrambi senza perché, l’uno come l’altro, ma ognuno a suo
modo. Questo è per Heidegger il non-detto del detto di Silesio; l’inespressa
possibilità che, come sempre avviene nei pensatori essenziali, sola è degna di
essere ripetuta51.
Quel che ha la rosa da insegnare all’uomo in merito al fondamento è infine
un rapporto al fondamento altro da quello che lo interroga chiedendo “perché”
e lo rappresenta espressamente, che viene dato per scontato e sottinteso nel
principio di ragione. Infatti il poiché «nomina il fondamento, ma un fondamento singolare e, presumibilmente, eccelso»52. Il punto è che il “poiché” non
rimanda qui a qualcosa d’altro, a qualcosa che non sia un fiorire e che debba
fondare il fiorire “dall’esterno”: né a una catena di cause naturali, né ad una
qualunque accezione di forza vitale. Al contrario, il poiché del detto riferisce il
fiorire semplicemente a se stesso. È in questo apparente vuoto non dire nulla
che secondo Heidegger si direbbe in qualche modo «la pienezza di ciò che è
possibile dire del fondamento e del “perché?”»53.
47
La “pianta”, infatti, mentre spunta, si schiude e si distende nell’aperto,
nello stesso tempo ritorna nella sua radice, fissandola nel chiuso e ottenendo così la sua stabilità. Lo schiudersi che si dispiega è, in sé, un ritornare in sé. Questo modo di essere essenzialmente presente [Wesung] è
ϕυσις; essa però non deve essere pensata come un “motore” che, applicandosi da qualche parte, mette in moto qualcosa, né come un “organizzatore” che, presente da qualche parte, organizza qualcosa. Eppure si
tenderebbe a cadere nell’opinione che l’ente determinato dalla ϕυσις sia
ciò che si fa da se. Questa opinione si impone così facilmente e inavvertitamente che ha finito col diventar determinante persino per l’interpretazione della natura vivente; ne è espressione il fatto che, sotto il dominio
del pensiero moderno, il vivente è concepito come “organismo”. Forse ci
vorrà ancora molto tempo per renderci conto che l’idea di “organismo” e
di “organico” è un concetto puramente moderno, meccanico-tecnico, per
cui anche ciò che cresce naturalmente da sé è interpretato come un artefatto che fa se stesso58.
48
Tutto sta ad evitare che si intenda «la ϕυσις come un’autoproduzione e i
ϕυσει οντα onta come un genere di artefatti»59. L’artefatto, per esempio la
casa, venendo a stare nell’aperto e nello svelato, non può mai, stando così,
rimettersi nel suo principio d’origine; «la casa, infatti, non mette mai radici, ma
resta sempre solo messa lì, come appoggiata sulla terra»60. Ciò che conta per
la determinazione del modo d’essere della rosa è di certo innanzitutto il fatto
che essa non è concepita in base ad un piano razionale determinato dall’uomo61. Ma nemmeno questo basta ad assicurare agli enti di natura quella che
è, appunto, la loro specifica natura; è convinzione di Heidegger che nell’intera
tradizione metafisica, nella filosofia come nella biologia organicista –che pure
sosteneva dal principio del secolo scorso di aver superato tanto l’interpretazione vitalista quanto quella meccanicista del vivente– nonostante le dichiarazioni di principio, l’essenza della rosa, del vivente, sia stata sempre concepita
come autoproduzione62: infatti l’autonomia nei confronti di un progetto razionale umano, divino o “naturale”, non è ancora autonomia dalla ratio in senso lato,
finché il nomos dell’autonomia del fiorire, del venire da sé alla presenza, resta
compreso come un fare, «un porre qui davanti nell’essere presente in quanto
avente questo o quell’aspetto, in quanto finito», un produrre se stesso nel venire alla presenza, nell’installarsi.
Insomma la preoccupazione di Heidegger (nella prima parte del saggio del
1939 come pure nell’introdurci alla rosa di Silesio e in una varietà di altri testi
su cui non possiamo qui soffermarci) in prima istanza viene spesso presentata come quella di salvare l’ente di natura nella sua specificità dal fraintendimento in base ad una comprensione tratta da altre regioni dell’ente. Ma il cammino che dovrebbe condurre a questo salvataggio è destinato ad una svolta
tanto brusca da costringerci a perdere di vista lo stesso problema dell’ente di
natura da cui siamo partiti.
3 – La rosa fiorente è innanzitutto un ente semplicemente presente; ma la
sua presenza [Anwesenheit], nota Heidegger, è altresì e più propriamente una
L’essenza dell’essere è di svelarsi, di schiudersi e venir fuori nello svelato - ϕυσις. Solo ciò che per essenza si s-vela [ent-birgt] e deve svelarsi
può amare velarsi. Solo ciò che è svelamento può essere velamento.
Perciò non si tratta di superare il κρυπτεσθαι della phusis e di strapparglielo, ma qualcosa di ben più arduo ci è assegnato: lasciare alla phusis,
in tutta la purezza della sua essenza, il κρυπτεσθαι come appartenente
ad essa […].Φυσις è αληθεια, svelamento, e perciò κρυπτεσθαι ϕιλει66.
Gli enti di natura per Aristotele sono le piante, gli animali, la terra, il fuoco,
l’acqua e l’aria; gli enti il cui essere riluce già da se stesso, senza preoccuparsi del fatto di venire espressamente scorto da noi o meno. Ma, mossi dall’apparente motivazione di difendere l’ambito dell’ente di natura dal suo fraintendimento in base ad un’altra regione dell’ente, siamo stati guidati in un contesto
più originario di quello aristotelico, in cui la distinzione tra un ambito e l’altro
diventa inessenziale e si dissolve. In questo luogo “eracliteo” scopriamo che la
rosa di Silesius per Heidegger non costituisce affatto un esempio degli enti di
natura, così come la Φυσις non è affatto il modo d’essere loro proprio e peculiare. La rosa col suo fiorire è piuttosto “esempio” del modo di essere dell’ente
nel suo insieme. Il sapere custodito nel detto di Silesius è infine: l’ente fiorisce
poiché fiorisce.
Il modo d’essere dell’ente è il fiorire, l’essere dell’ente è la Φυσις, ossia il
venire alla presenza. Un venire alla presenza che non deve affatto essere a sua
volta compreso in base ad un domandare perché; che non è da fondarsi su una
causa, una ratio, e nemmeno da intendersi come autoproduzione, ossia in
senso metafisico. Per comprendere il venire alla presenza è necessario piuttosto pensarlo nella sua provenienza autentica; pensare questa provenienza nei
termini di un sottrarsi originario: Φυσις κρυπτεσθαι ϕιλει. Ciò che fonda il venire alla presenza è ciò che in esso resta nascosto come ciò che dona alla pre-
SAGGI
Anwesung in das Unverbogene, un venire alla presenza nello svelato. Il carattere verbale, “cinetico”, di motilità proprio di questo ente e indicato dal participio “fiorente” deve essere compreso come avente un primato rispetto al carattere “nominale” o “materiale” della presenza; così si apre la possibilità al pensiero di spingersi verso un luogo più originario. Si tratta di un passo indietro
anche nella storia del pensiero, da Aristotele verso i pensatori iniziali, ed in particolare verso Eraclito.
Φυσις è per Heidegger la parola fondamentale del dire dei pensatori “preplatonici”63. Ma per questi essa aveva un significato completamente diverso da
quello aristotelico, più originario, e dal quale l’altro si deve rivelare essere un
mero derivato64.
Φυσις nel suo senso iniziale ed essenziale per Heidegger non indica affatto un determinato campo specifico dell’ente; essa è piuttosto «la parola-fondamentale greca iniziale per indicare l’essere stesso nel senso della presenza
che si schiude da sé e che così regna sovrana»65. La traduzione heideggeriana del notissimo frammento eracliteo n. 123, Φυσις κρυπτεσθαι ϕιλει, suona:
l’essere ama nascondersi, all’essere appartiene un velarsi, un sottrarsi. Il saggio del 1939 si conclude così:
49
senza la possibilità di darsi; l’essere è [west] proprio questo sottrarsi nel fiorire,
nell’apparire. L’apparire ed il sottrarsi si coappartengono originariamente in
unità, in modo tale che non si possa parlare del loro rapporto come di un “processo” nel tempo, in base alle categorie del “prima” e del “poi”. E nulla è più
insensato del volersi interrogare ulteriormente sul fondamento di questa coappartenenza. Il reciproco rimando dell’apparire e del sottrarsi nell’essere, come
abbiamo già detto, è piuttosto una sorta di gioco senza perché; esso gioca giocando, e «rimane soltanto gioco: il più alto e il più profondo». Così si conclude
–nell’evocazione del frammento 52 di Eraclito– Il principio di ragione.
50
4 – «L’uomo è veramente nel fondamento più nascosto della sua essenza
soltanto quando, a suo modo, è come la rosa – senza perché». Quel che Heidegger intendeva significare con queste parole, siamo ora in grado di dirlo, è
che l’uomo comprende il suo proprio fondamento quando si rapporta ad esso
come fa la rosa, ossia senza chiedere perché, senza reddere rationem, bensì
standovi nel modo del poiché: «Nel “poiché” […] lasciamo libero il nostro rappresentare di andare proprio nella direzione del fondamento e della cosa da
esso fondata. Nel “poiché” ci abbandoniamo alla cosa fondata; affidiamo la
cosa a se stessa e al modo in cui il fondamento, dandole fondamento, la lascia
semplicemente essere la cosa che è»67. La rosa si lascia essere, e come la
rosa noi possiamo e dobbiamo lasciar-essere la rosa, l’ente in generale e l’ente che noi stessi siamo. Il lasciar-essere, l’abbandonarsi, è il modo di rapportarsi all’ente che ne rispetta la provenienza da un fondamento inteso come un
originario donarsi sottraendosi. Come la rosa, l’uomo deve rapportarsi al suo
fondamento nel modo del lasciar essere, e non comprendere il mondo e se
stesso secondo ragioni, cause.
Lasciando essere l’ente in tal modo l’uomo comprende che nel suo senso
originario «Φυσις significa lo schiudersi al modo in cui la rosa si schiude e si
mostra sviluppandosi da sé»68: ma la rosa non è ormai che una sorta di metafora di qualcosa che in definitiva sembra non riguardarla affatto nello specifico.
Piuttosto, tra l’uomo che riesca ad essere “come la rosa” e la rosa quale ente
semplicemente vivente si apre un vero e proprio abisso, limite invalicabile che
alla “lezione” della rosa non è concesso in alcun modo superare, e racchiuso
in quel “ma a suo modo”: questo modo è il modo della possibilità, del poter
essere dell’e-sistenza; l’esserci è un ente che costitutivamente si autotrascende nel suo progettare: così si esprimeva Heidegger in Essere e tempo, e la
natura essenzialmente estatica dell’esserci non è mai messa in discussione.
L’uomo può essere come la rosa è. Ma questa possibilità –che non è una fra
tante ma è la sua possibilità più propria, nella misura in cui si tratta della possibilità per lui di comprendesi nel fondamento più nascosto della sua essenza,
di quel progetto sommamente antisoggettivista dell’abbandono [Gelassenheit]– non sembra avere infine niente a che fare con la possibilità di riconoscere l’ente di natura nella sua essenza specifica, né tantomeno di riconoscere
una qualche parentela con esso. Infatti quel che si tratta qui piuttosto di riconoscere e realizzare per l’uomo nel modo più appropriato è quel rapporto
esclusivo con l’essere dal quale la rosa, come l’animale, è esclusa. È per l’uo-
SAGGI
mo che l’essere appare velandosi in quanto essere e si lascia determinare
malamente nella forma delle cause e dei fondamenti razionali. È con l’uomo
che l’essere gioca il gioco del rimando reciproco di velatezza e svelatezza in
cui accade la storia, ed è a questo accadere storico-destinale che si riduce il
vero senso della finitezza radicale dell’uomo.
Ma che ne è della rosa di Silesius, un ente di natura “in senso stretto”, col
passaggio alla Φυσις eraclitea? Sapevamo che la rosa era solo un esempio;
ma non si trattava di un esempio dell’ente di natura, come ci era stata presentata all’inizio, bensì di un ente qualsiasi. Quel che aveva da insegnarci la rosa
col suo fiorire, ce l’avrebbe potuto insegnare qualunque altro ente. Perché, più
propriamente, è l’intero ambito della manifestatività a “fiorire” senza perché.
Heidegger, a partire dai secondi anni Trenta, fa spesso e sempre più ricorso al concetto di Φυσις, come parola fondamentale del pensiero iniziale, va via
che sotto l’influenza della poesia di Hoelderlin egli sviluppa il suo progetto di
riappropriazione della sapienza dei presocratici. Ma in questa riappropriazione
il concetto di Φυσις sembra è ridotto ad un mero analogo del venire alla presenza del mondo, così come il concetto di terra [Erde] sembra rappresentare
un analogo del suo reciproco sottrarsi. Il mistero proprio del fiorire della rosa
sembra dover essere completamente assorbito, identificato col mistero del
darsi dell’apertura del mondo come ambito assoluto. D’altro canto, è innegabile che Heidegger non voglia rinunciare al potere di evocazione metaforica, di
messa in immagine di una nascita misteriosa dal grembo della terra che la rosa
offre col suo fiorire all’immaginazione filosofica. Ma questo tipo di “esemplarità” residua non può che considerarsi un di più del tutto accessorio.
Si potrebbe obiettare che una rosa, col suo fiorire muto, ciclico e immotivato, più di un artefatto si presta a fornirci l’occasione di uscire dalla nostra attitudine di pensiero onnipotente, attraverso quello stato d’animo di stupore che
in ogni tempo essa sembra essere in grado di suscitare. Ma a ben guardare
nemmeno questo tipo di potere esemplare le è concesso. Infatti Heidegger ci
ha mostrato che qualsiasi ente può divenire occasione per noi di accedere al
suo più proprio fondamento. Un semplice utensile in panne, una penna che
smetta di scrivere, può costituire un’esperienza altrettanto epifanica69. Un’opera d’arte può chiarirci all’improvviso la lotta tra terra e mondo custodita in un
semplice paio di povere scarpe70. E un ente di poco conto preso nella sua singolarità qualunque, come una brocca o un ponte di campagna, può rimetterci
in contatto con una dimensione ben più conciliante di quella della moderna
epoca atomica, ove possiamo prestare ascolto alla sua silenziosa perpetua fioritura, in quel misterioso fiore a quattro petali che il tardo Heidegger chiama
Geviert71.
Certo, Heidegger riconosce che per noi l’essenza della Φυσις «risulta
immediatamente evidente nel germogliare del germe di grano sepolto nella
terra […], nello sbocciare della fioritura» o nel sorgere del sole. Ma anche il
nascere dei desideri o il sorgere di un gesto sono parimenti indicate come
manifestazioni evidenti del sorgere. «Dappertutto […] si dà un multiforme e
reciproco venire alla presenza di tutti gli “esseri”, e in tutto questo si dà il manifestarsi, nel senso del mostrarsi che nasce e viene fuori»72.
51
52
E soprattutto, sarebbe “assolutamente errato” credere che ciò la Φυσις nomina originariamente per i pensatori iniziali «sia innanzitutto desunto dall’osservazione del germe che germoglia, della pianta che nasce, del sole che sorge, per
poi essere applicato in modo corrispondente a tutti i cosiddetti processi naturali e
venire infine attribuito in senso traslato agli uomini e agli dei, in modo che a partire dalla Φυσις “dei e uomini” possano in un certo senso venir rappresentati “naturalisticamente”»73. La Φυσις greca non nasce attraverso un processo di “generalizzazione” e “astrazione” a partire da un’esperienza osservativa ordinaria. Essa,
al contrario, è il frutto diretto di un’esperienza originaria. Semmai è possibile definire quelle esperienze esemplari in quanto metaforiche messe in immagine, ma
questa cogenza, di nuovo, la si può cogliere in modo appropriato e senza rischi di
fraintendimento solo in un secondo momento, in seguito all’esperienza pura della
Φυσις. Al contrario, seguire quelle immagini senza la meditazione appropriata non
può che condurre all’equivoco, per via del carattere processuale del sorgere del
fiore dalla terra, e del suo situarsi all’interno di un ciclo del tempo naturale. «La
Φυσις nomina piuttosto ciò in cui in primo luogo sorgono terra e cielo, mare e
monti, alberi e animali, uomini e dei, e tutte queste cose, in quanto sorgono e si
mostrano in modo tale che possono essere nominate come “enti” proprio in riferimento a questo ambito del sorgere. Solo nella luce della Φυσις diventano visibili
per i Greci quelli che noi chiamiamo processi naturali nelle modalità specifiche del
loro “sorgere”». Un sorgere che a questo punto non può che essere scritto tra virgolette, essendo una modalità derivata, “stretta” e impropria, in qualche modo
metaforica della Φυσις intesa come sua condizione di possibilità74.
Ma anche parlare di una vero e proprio carattere metaforico del fiorire naturale è improprio perché, infine, la Φυσις è semplicemente, assolutamente
irrappresentabile; non si dà alcuna intuizione sensibile o “estetica” di essa: «la
traccia dell’essere che si può cogliere col pensiero, in quanto rimane all’interno dell’essenza inizialmente semplice dell’accordo, è in se stessa priva di
immagine»75. Quello di “metafora” per Heidegger è un concetto proprio del
pensiero metafisico: infatti, spiega Heidegger nel Principio di ragione, «l’idea
del “traslare” e della metafora si basa sulla distinzione, se non addirittura sulla
separazione, fra sensibile e non sensibile, intesi come due ambiti a sé stanti»;
una distinzione propria del pensiero metafisico, ma che viene invece a cadere
nel pensiero originario76. Per cui solo a partire dal raggiungimento di questo
ambito è semmai possibile permettersi messe in immagine come quella della
rosa, o quella dell’arco e della lira di Artemide cui ricorre Eraclito nel frammento 51 e nella cui forma, commenta Heidegger, il puro apparire della Φυσις
assume un’immagine e si dà a vedere nel modo migliore»77. Ma si tratta di un
privilegio concesso solo al dire poetante; quello stesso dire con cui S. Paolo
accennava alla struggente attesa delle creature…
IV
È arrivato il momento di portare a confluire i due rami del nostro discorso.
Si è parlato dell’animale e si è parlato della rosa. Heidegger si riferisce all’uno
* Questo saggio è frutto della rielaborazione di una lezione seminariale da me tenuta presso
l’Università di Lecce il 13 dicembre 2004, per la cattedra di Filosofia Teoretica del prof. Giovanni
Invitto. Ringrazio il prof. Invitto ed i suoi studenti, a cui questo scritto è dedicato, per l’importante
opportunità di dialogo e confronto offertami in quell’occasione.
1 Der Satz vom Grund [1955-56], Neske, Pfullingen 1957, ora in Gesamtausgabe, Bd. X, Klostermann, Frankfurt a.M. 1997 (tr. it. di G. Gurisatti e F. Volpi, Il principio di ragione, Adelphi, Milano 1991). Angelus Silesius (Johannes Schleffer), Cherubinischer Wandersmann [1657], ed. critica
a cura di L. Gnädinger, Reclam, Stuttgart 1984 (Il pellegrino cherubico, a cura di G. Fozzer e M.
Tannini, Paoline, Milano-Torino 1989. La traduzione del distico riportata nel testo è quella approntata da Volpi e Gurisatti in conformità all’esegesi heideggeriana.
2 Cfr. HGA X, p. 51 (tr. it. p. 65).
3 Cfr. Monadologia, par. 32, cit. in HGA X, p. 50 (tr. it. p. 64) e sgg.
4 Cfr. HGA X, ivi.
5 Cfr. HGA X, p. 53 (tr. it. p. 67).
6 Cfr. HGA X, p. 53 (tr. it. p. 68) e sgg.
7 Rosa è una rosa è una rosa è una rosa. Tra le variegatissime interpretazioni suscitate da questo verso –che compare più volte nell’opera poetica di G. Stein– in questo contesto è particolarmente interessante ricordare come alcuni suggeriscano, assecondandone la naturale accentazione nel parlato, questa lettura possibile del verso: “Arose / is / arose / is / arose / is / arose” (Sorse
è sorse è sorse è sorse): il mistero della fioritura, dell’originario sorgere [to rise] come simultaneo
ed indisgiungibile dall’essere presente [is].
SAGGI
e all’altro per lo più in modo indifferente con il termine di esseri “viventi”. Eppure nell’uno e nell’altro caso siamo giunti a conclusioni differenti.
Nel primo caso, seguendo la traccia della muta e docile rosa di Silesio, l’essenza dell’ente naturale e semplicemente vivente ci è stata indicata nella
Φυσις. Ma la Φυσις è stata completamente identificata con la αληθεια. Il ricorso all’ente naturale vivente si è rivelato così in definitiva nient’altro che un artificio retorico, una metafora impropria, un simbolo che si distrugge da sé, una
scala che salendo attraverso Aristotele, debba essere gettata giunti alla vetta
eraclitea; al limite, un lusso del poetare originario. La spontaneità della natura
non sembra avere alcuna peculiarità propria, bensì sembra doversi identificare con la spontaneità dell’apparire del fenomeno in generale. Ne consegue che
un discorso sulla natura non possa avere nulla da insegnarci sul piano della
filosofia prima. La rosa sembra condannata a restare non solo senza perché,
ma anche senza poiché, in quanto rosa. Il suo mistero sembra poter essere
completamente assorbito nel mistero dell’essere.
Nell’altro caso però, nel tentativo di costruirci una via verso l’alterità animale siamo stati costretti ad ammettere l’enigma del vivente come un enigma irriducibile. Siamo stati portati a considerare la vita come «un ambito che nel suo
esser-aperto ha una ricchezza che forse il mondo dell’uomo non conosce per
nulla». E così ora anche l’enigma dell’essere della rosa, spinto fuori dalla filosofia prima, sembra condannato a restare come residuo metafisico. Il mondo
dei vegetali, degli animali, ma anche e soprattutto dei viventi che noi stessi
siamo, per lo più annientato nella pura luce del pensiero originario, sembra talvolta cercare di rientrare da una finestra oscura, portando con sé un importuno vento metafisico.
53
HGA X, p. 55 (tr. it. p. 69).
HGA X, p. 56 (tr. it. p. 71).
10 Cfr. HGA X, ivi e sgg.
11 Cfr. HGA X, p. 63 (tr. it. pp. 79-80).
12 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, in HGA, Bd. XXIX/XXX,
Klostermann, Frankfurt a.M. 1983 (tr. it. di P. Coriando, Concetti fondamentali della metafisica.
Mondo –finitezza– solitudine, il melangolo, Genova 1992).
13 HGA XXIX/XXX, p. 261 (tr. it. p. 230).
14 Cfr. HGA XXIX/XXX, § 42.
15 Cfr. HGA XXIX/XXX, p. 274 (tr. it. p. 242).
16 Cfr. Sein und Zeit [1927], in HGA, Bd. II, Klostermann, Frankfurt a.M. 1977 (d’ora in poi SZ;
a seguire la pagina dell’ed. Niemequer e poi della tr. it. di P. Chiodi, Essere e tempo, Utet, Torino
1969), p. 65 (tr. it. p. 90).
17 SZ, ivi (tr. it. p. 91).
18 Vom Wesen des Grundes [1929], in Wegmarken, HGA, Bd. IX, Klostermann, Frankfurt a.M.
1976, pp.155-6 (tr. it. di F. Volpi, Dell’essenza del fondamento, in Segnavia, Adelphi, Milano 1987,
p.112).
19 Cfr. SZ, II, § 11.
20 Karl Löwith –in quegli anni promettente allievo di Heidegger dalle attitudini vivacemente critiche– lamentò al maestro l’assenza in Sein und Zeit della natura «intorno a noi e in noi stessi»,
non come ambito regionale bensì come «l’unica natura di ogni ente, la cui forza produttrice fa
nascere da sé e poi perire tutto ciò che è, in generale, e quindi anche l’uomo», e la sua illegittima
scomparsa nella comprensione esistenziale di fatticità e gettatezza. Heidegger gli rispose in una
lettera del 20 agosto 1927 che ribadisce esemplarmente la sua posizione: «La “natura” dell’uomo
non è una cosa a sé stante, che poi viene incollata allo “spirito”. Chiediamoci piuttosto: è possibile ricavare un filo conduttore fondamentale per l’interpretazione concettuale dell’esserci dalla natura, oppure dallo “spirito” – o da nessuno dei due? E in tal caso bisognerà prendere originariamente le mosse dalla totalità della costituzione d’essere? È qui, infatti, che l’esistenziale ha un primato, sul piano concettuale, per quanto concerne la possibilità dell’ontologia. Infatti l’interpretazione
antropologica è attuabile come interpretazione ontologica solo sulla base di una problematica
ontologica chiara» (K. Löwith, “La questione heideggeriana dell’essere: la natura dell’uomo e il
mondo della natura”, in Su Heidegger. Cinque voci ebraiche, a cura di F. Volpi, Donzelli, Roma
1998, pp. 78-9).
21 DAVID FARRELL KRELL, Daimon Life: Heidegger and Life-Philosophy, Indiana University Press,
Bloomington 1992.
22 Cfr. HGA XXIX/XXX, § 42.
23 Ivi, §§ 49-50.
24 HGA XXIX/XXX, p. 301 (tr. it. p. 265). Cfr. anche SZ, § 26.
25 HGA XXIX/XXX, § 50.
26 Cfr. HGA XXIX/XXX, § 58 e sgg.
27 Il barone Jacob von Uexküll è passato alla storia per le sue ricerche sugli animali; in particolare, si deve a lui l’elaborazione del fortunato concetto di “mondo-ambiente” [Umwelt], il contesto di
vita proprio di ogni specie, compreso così come l’animale stesso lo percepisce in base ai suoi organi senso-motori specifici ed ai suoi comportamenti peculiari. L’intento di v. Uexküll era quello di evitare che la biologia antropomorfizzasse il modo d’essere degli animali e che ne ricostruisse invece
il vissuto autentico. I suoi scritti, corredati altresì di curiose illustrazioni del mondo-ambiente del riccio di mare, della vespa e di altri esserini, erano ben noti ad Heidegger, che lo stimava uno dei biologi dalle intuizioni più felici. Ma anche v. Uexküll non esce da una considerazione ingenua e “metafisica” della questione, se per lui il mondo dell’uomo non è altro che una varietà particolarmente
ricca e articolata di mondo-ambiente fra le altre. La differenza fra il modo d’essere dell’animale e
quello dell’uomo nei suoi scritti, nota Heidegger, resta compresa come una «differenza di grado nei
livelli di perfezione nel possesso dell’ente di volta in volta accessibile» (HGA XXIX/XXX, p. 285; tr.
it. p. 251). I testi di v. Uexküll cui Heidegger fa riferimento sono la sua Theoretische Biologie [ed.
1928] e Umwelt und Innerwelt der Tiere [ed. 1921], quest’ultimo ora reperibile in inglese nel volume
Foundations of Comparative Ethology, Van Nostrand Reinhold, 1985. Cfr. anche la simpatica esposizione delle ricerche di v. Uexküll offerta da Giorgio Agamben nel suo L’aperto.
8
9
54
Cfr. HGA XXIX/XXX, § 60 e sgg.
HGA XXIX/XXX, p. 374 (tr. it. p. 329).
30 Cfr. HGA XXIX/XXX, § 56. Sullo stesso tema cfr. anche i Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) [1936-1938], HGA, Bd. LXV, Klostermann, Frankfurt a.M. 1989, dove in merito al polo soggettivo dello stordimento, si legge (§ 154): «La custodia del sé e il primato del “genere”, che non
riconosce alcun singolo come egoistico [caratterizzato dal sé: selbstisches]».
31 Holderlins Hymnen “Germanien” und “Der Rhein”, HGA, Bd. XXXIX, Klostermann, Frankfurt
a.M. 1980, p. 75 (tr. n).
32 Was heisst Denken?, Niemeyer, Tübingen 1954 (tr. it. di U. Ugazio e G. Vattimo, Che cosa
significa pensare?, Sugarco, Milano 1978-9, p. 108).
33 Cfr. Die Grundprobleme der Phänomenologie [1927], HGA, Bd. XXIV, Klostermann, Frankfurt a.M. 1975 (tr. it. di A. Fabris, I problemi fondamentali della fenomenologia, il melangolo, Genova 1989), § 13b; Kant und das Problem der Metaphysik [1929], HGA, Bd. III Klostermann, Frankfurt a.M. 1991 (tr. it. di M.E. Reina, a cura di V. Verra, Laterza, Roma-Bari 1981, 1989), § 30; e
per un’interpretazione approfondita della morale kantiana, cfr. l’intero Vom Wesen der menschlichen Freiheit – Einleitung in die Philosophie, HGA, Bd. XXXI, Klostermann, Frankfurt a.M. 1982.
34 Cfr. la critica all’impostazione della questione della libertà come idea cosmologica nella
Terza Antinomia della ragione della Critica della ragion pura, sviluppata da Heidegger in HGA
XXXI.
35 Per la critica a Kant in questi anni si vedano i testi indicati nella nota 33. Per la critica a Scheler si veda HGA XXIX/XXX, p. 283 (tr. it. p. 250).
36 HGA LXV, cit. in Pöggeler, op. cit., p. 307.
37 HGA XXIX/XXX, p. 361 (tr. it. p. 317).
38 La caratterizzazione del fondamento in termini di “gioco” è in realtà successiva al 1930, e la
si incontra sovente nell’Heidegger della maturità; la richiamiamo qui in quanto con essa si conclude Il principio di ragione, al quale ci accingiamo a ritornare.
39 HGA XXIX/XXX, p. 360 (tr. it. p. 316).
40 Ivi, p. 393 (tr. it. p. 345).
41 Ivi, p. 396 (tr. it. p. 348).
42 Parmenides [1942-3], HGA, Bd. LIV, Klostermann, Frankfurt a.M. 1982 (tr. it. di G. Gurisatti, Parmenide, Adelphi, Milano 1999), § 8.
43 HGA LIV, p. 197.
44 Ivi, p. 224.
45 Ivi, p. 237 (tr. it. p. 282).
46 HGA XXIX/XXX, pp. 371-2 (tr. it. pp. 327).
47 HGA LIV, tr. it. pp. 282-3 (tr. it. pp. 282-283).
48 Ibidem. (tr. it. p. 283).
49 Ibidem. Questo poetare non è nemmeno quello di Rilke, che con la concezione dell’aperto,
radicalmente opposta a quella heideggeriana, con la sua ottava elegia duinese costituisce il bersaglio polemico dell’intero discorso sull’animale nel Parmenide.
50 Ivi, pp. 57-8 (tr. it. pp. 72-3, c.n.).
51 Non ci interessa qui la legittimità di una tale forzatura del distico; si tratta piuttosto di comprendere l’interpretazione heideggeriana del modo d’essere della rosa, del nostro e del loro rapporto, in base alla duplice indicazione: l’uomo è come la rosa: senza perché; ma ognuno a suo
modo.
52 HGA X, p. 84 (tr. it. p. 103).
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Vom Wesen und Begriff der phisis Aristoteles, Physik B, 1 [1939], in Wegmarken, HGA, Bd.
IX, Klostermann, Frankfurt a.M. 1976; tr. it. di F. Volpi, Sull’essenza e sul concetto della phisis. Aristotele, Fisica B, 1, in Segnavia, Adelphi, Milano 1987, p. 199 e sgg. (d’ora in poi citato direttamente dalla traduzione di Volpi come Segnavia)
56 Segnavia, p. 208.
57 Ibidem.
58 Segnavia, p. 209.
59 Ibidem.
28
SAGGI
29
55
Segnavia, p. 212.
La penna, che è uno strumento, non scrive da sé; la macchina, per esempio la lavabiancheria, conosce certo un decorso di processi autonomo, è un automa, è automatica, ma in definitiva
è anche essa, come lo strumento, un mezzo [Zeug], semplicemente un po’ più complesso. Lo stesso vale evidentemente per il computer e per tutto ciò che possa oggi venir entusiasticamente esaltato dal nome di “intelligenza artificiale”. Al contrario la rosa fiorisce da sé. Nessun piano umano,
nessuna ratio umana concorre a determinarne la fioritura.
62 Nei Concetti fondamentali della metafisica Heidegger sviluppava ampiamente questa critica
alla biologia organicista del suo tempo, dimostrando peraltro una certa competenza in materia.
63 Cfr. esemplarmente Der Anfang des abendländischen Denkens [1943], in Heraklit, HGA, Bd.
LV, Klostermann, Frankfurt a.M. 1979; tr. it. di F. Camera, L’inizio del pensiero occidentale, in Eraclito, Mursia, Milano 1993, pp. 61 e 70.
64 Cfr. p. es. Segnavia, pp. 197 e 254.
65 Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst [1936-7], HGA, Bd. XLIII, Klostermann, Frankfurt
a.M. 1985; tr. it. di F. Volpi, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, p.174.
66 Segnavia,p. 255.
67 Ivi, p. 78.
68 HGA XLIII; tr. it. p.174.
69 Cfr. SZ, § 16.
70 Cfr. Der Ursprung des Kunstwerkes [1935], in Holzwege, HGA, Bd. V, Klostermann, Frankfurt a.M. 1977; tr. It. di P. Chiodi, L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia,
Firenze 1968.
71 Cfr. p. es. Bauen Wohnen Denken [1951] e Das Ding [1951] in Vorträge und Aufsätze,
Neske, Pfullingen 1954; tr. it. di G. Vattimo, Costruire abitare pensare e La cosa, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976.
72 Cfr. HGA LV; § 78.
73 Ibidem. Dove si legge anche, parimenti: «la Φυσις, il puro sorgere, non viene compresa
esattamente astraendo in primo luogo dal ristretto ambito di ciò che noi chiamiamo comunemente natura, né tantomeno più essere attribuita in un secondo momento in senso traslato a uomini e
dei quale loro tratto essenziale».
74 Ibidem. Cfr. anche p. 62: «l’essenza greca della Φυσις non è affatto l’appropriata generalizzazione dell’esperienza dello schiudersi del germe, dello sbocciare della fioritura e del sorgere del
sole, che il nostro punto di vista considera ancora ingenua; essa è piuttosto l’originaria esperienza del sorgere e del venire fuori dal nascosto e dal coperto, è rapporto con la “luce”, nel cui chiarore il germinare e la fioritura si mantengono nel loro sorgere, e perciò solo in questo processo si
può osservare il modo in cui il germe “è” nel suo germogliare e il fiore “è” nel suo forire».
75 Ivi, p. 97.
76 HGA X, p. 71 (tr. it. p. 89).
77 HGA LV; tr. it. p. 98.
60
61
56
CRISTIANESIMO E CULTURA DELLA LIBERTÀ
IN PAREYSON
Di fronte alle rovine della cultura moderna, nasce il
problema d’una nuova cultura, di un nuovo mondo
da edificare, nel quale tutti abbiamo da vivere (de re
nostra agitur), ed è qui che la scelta per o contro il
cristianesimo diventa decisiva. Non meno che la
questione, è filosofica anche la decisione: è la filosofia che configura il dilemma, che pone l’aut aut,
che esige la scelta.
L. Pareyson, Esistenza e persona
È noto che l’opera di Luigi Pareyson costituisce una compiuta trattazione filosofica dell’idea di libertà, pur non essendo facile ripercorrere e dipanare l’insieme
delle conseguenze tematiche contenute nelle pagine pareysoniane e degne di
uno sviluppo autonomo. Tuttavia può non essere inutile un tentativo di problematizzarne la dinamica fondamentale, volta a definire una cultura della libertà, che
parrebbe essere intrinseca finalità del pensiero, soprattutto in relazione a due nodi
cruciali, indissolubilmente intrecciati, quali la riflessione sul cristianesimo e sulla
filosofia moderna, o, come anche si preciserà, sulla modernità della filosofia e del
“pensiero tradizionale”. Si tratterà quindi di mettere in luce la particolare rilevanza,
nel pensiero di Pareyson, della «funzione» attribuita alla ricerca filosofica, ma
anche al particolare metodo intrinsecamente correlato a questo fine e rintracciabile nell’itinerario complessivo della filosofia pareysoniana. Tale approfondimento
infatti potrà portare alla conoscenza di una riflessione che costituisce senza dubbio un percorso molto più organico e sintetico di quanto sia stato accertato da una
certa prospettiva storiografica, che privilegerebbe, rispetto alla «continuità» dell’opera, la tesi delle diverse “fasi” o delle “svolte” nella filosofia pareysoniana1; e
che, se compreso nella sua distensione globale, si presenta come una vera e propria summa, in cui “pensiero moderno” e “pensiero tradizionale”, in vista di una
proposta filosofico-culturale di stampo personalistico, ben lungi dall’escludersi, si
compenetrano a vicenda e a vicenda si sorreggono.
Il metodo filosofico legato a questa finalità speculativa, potrebbe essere
definito quello della «mediazione» o dell’«inclusione»2, ed è innegabilmente
presente nell’intero modus operandi del filosofo, pur precisandosi in altre
distinzioni terminologiche, tuttavia facilmente riconducibili al senso addotto;
si preciseranno in tal modo anche alcune apparenti contraddizioni della terminologia pareysoniana, quelle che si riscontrano, per chiarezza, nella scrittura del «paradosso», la quale, lungi da rappresentare una rinuncia del pensiero, manifesta piuttosto la trascrizione dello sforzo del pensiero di superare –grazie al simbolo– le numerose aporie scaturite da un certo razionalismo
moderno (di matrice illuministica e neoilluministica).
SAGGI
di Giovanni Borgo
57
58
La finalità –o meglio– la «funzione» della filosofia, nell’accezione pareysoniana, risulta essere la risposta alle questioni poste dalla concretezza storica
e per meglio interpretare –e quindi avvicinare ad una «soluzione razionale»–
ciò che viene rilevato come «problema storico»3. La filosofia di Pareyson mira
dunque alla elaborazione di una cultura che si configura quale risposta ad ogni
situazione di «crisi»4, che si presenta in varie forme in ogni epoca, ed è per
questo sempre «attuale». La filosofia –quale impegno di elaborazione di una
cultura che resista alla crisi– è come tale ben lontana dall’essere semplice speculazione: proprio per questo valore sintetico, «al tempo stesso concreto e
speculativo»5, essa prende la forma di quel «pensiero della libertà» che –nel
suo più alto spessore teoretico– si amplia in proposta etica e politica, grazie al
superamento del prassismo ideologico da una parte e dell’integralismo etico
dall’altra. A questa prospettiva conducono il ripensamento filosofico del «cristianesimo religioso» da un lato e della filosofia moderna dall’altra (operazione
che equivale alla ricerca della modernità di ogni filosofia).
Tale declinazione storica nasce da un impianto speculativo cogente: la filosofia (e in ultima analisi la cultura che ne deriva) è mediazione di un «tempo»
e di una prospettiva di «eternità», di una libertà in atto e di una donazione trascendente. È quindi proprio («funzione») della cultura filosofica –e questo ne
chiarirebbe anche la pertinenza politica– produrre quell’equilibrio tra azione e
riflessione, tra determinatezza temporale e senso dell’ulteriorità, tradizione e
innovazione, primato della verità e prassi conseguente, che richiami «il problema di un nuovo mondo da edificare, nel quale tutti abbiamo da vivere (de re
nostra agitur)», tesi che richiede pertanto la precisazione di una specifica
responsabilità storica del filosofo nel delineare e prospettare dal suo punto di
vista (ossia il piano della cultura) degli spazi di civiltà.
Il presente saggio, infine, nella ricezione del legame tra cristianesimo e
libertà, intende sottolineare una particolare prospettiva rilevata da Pareyson
nel cuore di quella sintesi culturale nota come “pensiero tradizionale”, dimostrando da una parte che il cristianesimo è “pensiero della libertà” e quindi in
linea con il progetto della filosofia moderna («da Cartesio a Fichte»6); e in
secondo luogo come la filosofia di ogni epoca possa accertare la modernità del
messaggio cristiano in relazione alla comune e mai sopita esigenza di problematizzazione, tipica, oltre che della filosofia, anche della fede. Tale operazione
farebbe venire meno anche quella artificiosa contrapposizione tra tradizionale
e moderno che, lungi dal favorire la comprensione della storia del pensiero,
continua a limitarne il valore e impedirne una vera e propria incisività. Al tempo
stesso l’impianto speculativo renderebbe ragione del nesso inscindibile tra
fides ed intellectum, da Pareyson mai ritenuto un ostacolo ad una vera e propria elaborazione filosofica, anzi, vigorosamente affermato quale sua personalissima Weltanschauung. La chiave di lettura pareysoniana è il costante riferimento ad un’idea di libertà di chiara ispirazione cristiana, qualificata da una
consapevole complessità e nello stesso tempo da una decisiva fedeltà; che si
pone da una parte il problema di una deriva della libertà, esemplificata dall’ateismo moderno e delle sue varianti ideologiche contemporanee; ma dall’altra
parte capace di valorizzarne la forza propositiva, nel rispetto della propria ori-
1. «Cristianesimo e cultura moderna»: il problema della crisi e il suo superamento
Il problema del rapporto tra modernità e cristianesimo7 è uno dei tratti più
originali della riflessione pareysoniana, che, pure raccolto in pagine molto
essenziali, presenta dei lati di attualità e una rilevanza speculativa forse non
del tutto valutati nel loro spessore. A ricordare invece l’importanza di questa
prospettiva contribuisce un intervento di Giuseppe Riconda8, nel quale viene
articolata una riflessione sulla ricezione dell’idea di modernità (nella tradizione
italiana più recente) e delle sue «linee» interpretative, attraverso la dialettica
tra «pensiero tradizionale» e «pensiero moderno»9; in tale senso egli utilizza
come chiave ermeneutica il percorso di Augusto Del Noce, a cui viene accostata –per metterne in risalto le analogie ma anche le differenze– la prospettiva di Luigi Pareyson10. Del Noce accetta –per ampliarla nelle sue ragioni profond– una lettura della modernità da intendersi essenzialmente nella linea che
va da Cartesio a Nietzsche; secondo tale schema –risalente a Gentile e Croce,
e in definitiva al neohegelismo– il moderno sarebbe caratterizzato da una
presa di distanza nei confronti del passato, coincidente con l’insieme valori e
della cultura (in senso filosofico) dell’Europa cristiana, e inteso come tradizione da superare.
Tale passaggio al moderno si sarebbe configurato grazie a una rottura
duplice nei confronti della tradizione: dalla trascendenza all’immanenza prima,
da Cartesio a Hegel, quest’ultimo essendo considerato il culmine della secolarizzazione del pensiero cristiano; e dall’immanentismo all’ateismo poi, nella
linea che va, dopo Hegel, da Feuerbach a Nietzsche.
È noto come Del Noce considerasse la modernità nella sua valenza problematica, anassiologica, aporetica e quindi ne rifiutasse l’interpretazione di «età
adulta»11 nel senso del superamento di un’era infantile e acritica, retaggio del
sonno della ragione di matrice essenzialmente religiosa (ed ambiguamente
inconsapevole). La modernità nasceva anzi grazie a un contrasto e una semplice negazione di un ordine precedente (camuffato nella fase iniziale, come fa
pensare il termine «secolarizzazione», ma diventato aperto nella seconda,
quella dell’«ateismo»), ed era portatrice di una nuova proposta che non poteva certo connotarsi nel senso del valore12. La modernità rappresentava quindi
per Del Noce un «problema», proprio perché l’esito nichilistico non poteva
costituirne una conclusione: era proprio l’essenza anassiologica a rendere la
modernità un’epoca instabile e quindi non vicina (e nemmeno tesa) ad una sintesi storico-culturale alternativa. L’ateismo –come scriveva Del Noce– non era
un «punto di arrivo», il destino di un processo storico, ma una contraddizione
SAGGI
gine. Si tratta in definitiva di una proposta che non si pone contro il pensiero
moderno (pur evidenziandone le debolezze e le unilateralità) né si adegua ad
una riedizione del tradizionale, ma, in aderenza alla funzione specifica del pensiero, riconosce un orizzonte di valore che –oltre il contingente e prima di ogni
negoziazione– funga da costitutivo di una cultura dell’uomo e della persona
universalizzabile e condivisa.
59
60
irrisolta; che, una volta accertata, poneva la nuova questione, assai più urgente, del superamento della situazione «problematica» suscitata dal moderno13.
Peraltro, la definizione del moderno come «epoca della secolarizzazione»14
(che, sulla linea del Löwith, è pur sempre secolarizzazione della tradizione cristiana) e poi dell’ateismo, non contribuiva a spegnere la linea del «pensiero
tradizionale», una modernità “seconda” –forse inattuale– ma non per questo
inesistente. Del Noce si riferiva a quella linea «tradizionale»15 che, ispirata dal
pensiero cristiano, aveva ricevuto una elaborazione filosofica con la metafisica
classica, «intendendo questo termine nel senso più ampio tale da includervi
così S. Agostino, come S. Tommaso, come Rosmini»16. La conclusione cui egli
perveniva era dunque il riconoscimento di una duplice alternativa –«nella filosofia dei tempi cosiddetti moderni»17– costituita da «due linee irriducibili» e
opposte, il cui esito non era al momento prevedibile e scontato. Nel pensiero
di Del Noce saltava infatti la possibilità di una mediazione tra le alternative e il
superamento del nichilismo stava dalla parte del pensiero tradizionale, attraverso una non meglio precisata «esplicazione di virtualità della tradizione»18.
Tale compito sarebbe dovuto partire dalle «contraddizioni insuperabili» in cui
cadrebbe appunto una tesi puramente “intramondana”, e «sullo sfondo di queste contraddizioni insolubili» troverebbero ancora attualità «le verità della
metafisica classica». Proprio per rimarcare ancora l’incompatibilità delle alternative, Del Noce affermava come non si potesse «cercare di cristianizzare
l’epoca della secolarizzazione, sceverandone i motivi progressivi» e come «dal
punto di vista del pensiero religioso», tale epoca non potesse «essere criticata che nella sua totalità»19. È questa una ulteriore articolazione dell’aporia della
modernità che Del Noce sembra non affrontare: posta la superiorità teoretica
del tradizionale rispetto al moderno, non viene chiarito come sia possibile recuperare il tradizionale senza cadere nello stesso metodo del moderno, senza
cioè ricorrere ad una ulteriore (e forse impraticabile) negazione.
È rispetto a tale articolazione che ci sembra significativo sottolineare il metodo speculativo di Pareyson, legato peraltro a Del Noce da una consonanza di
pensiero testimoniata dallo stesso20, riconosciuta anche da studi recenti21, e che
presenta invece ulteriori coordinate per affrontare l’aporia della modernità e del
suo superamento. Come Del Noce anche Pareyson chiarisce fin da subito un
suo punto di partenza: egli sta dalla parte22 del pensiero tradizionale, però non
rigetta le istanze del moderno, consapevole che la negazione moderna possa in
qualche modo essere assorbita nella sua aporeticità e resa inoffensiva da un
processo di «ritrovamento» del tradizionale nel moderno, senza che quest’ultimo
sia considerato un elemento in aperta contraddizione con il primo (pena la sua
inefficacia). In un paragrafo di un saggio giovanile già citato e ripubblicato di
recente23, dal titolo significativo Cristianesimo e cultura moderna, Pareyson rileva l’aporia e la «crisi» del moderno nella fine del sistema hegeliano, quindi nella
caduta di una sintesi culturale i cui effetti perdurano anche nel Novecento. Egli
sembra intendere il concetto di crisi come assenza di una riconoscibile sintesi
filosofica, ancora presente e rilevabile, secondo il giudizio dell’autore, negli anni
della propria attività, come si evince da un suo testo eloquente degli anni Cinquanta e riproposto anche nell’ultima edizione di Esistenza e persona:
È stata la «dissoluzione» del sistema hegeliano ad aver determinato una
situazione di «instabilità» culturale analoga a quella riconosciuta da Del Noce
e che non ha trovato ancora una sistemazione. I postumi della crisi hegeliana
avevano disseminato dei frammenti di sistema che non si erano più ricomposti: rinunciando alla trascendenza (secolarizzazione del cristianesimo) si era
persa anche «la rilevanza filosofica» del cristianesimo oltre che quella religiosa; per non parlare della indecisione riguardo «la natura del pensiero filosofico», di cui «l’esistenzialismo» novecentesco rappresentava una possibile
risposta dopo la crisi del «razionalismo metafisico». Ma la via di uscita da una
crisi culturale così prolungata, posto che anche l’esistenzialismo, più che una
soluzione, rappresentava l’evidenza di questa instabilità25, poteva essere trovata verificando la possibilità di una nuova cultura ispirata al cristianesimo,
comprensiva di tutta l’eredità storica, filosofica, intellettuale e religiosa ad esso
legata. Pareyson prospettava quindi nella cultura contemporanea –in analogia
a quella moderna post-hegeliana– una duplice possibilità: o il ritrovamento del
cristianesimo religioso (e quindi del pensiero tradizionale: «ritrovamento» non
semplice riproposizione) o la sua definitiva perdita a favore di una nuova cultura non più ispirata al cristianesimo (l’ateismo), ma ancora più difficile da edificare vista l’assenza di punti di riferimento. La scelta del cristianesimo –nella
prospettiva pareysoniana– aveva (ed ha) quindi la valenza di una responsabilità filosofica, ossia dell’elaborazione di una nuova cultura che, a partire da una
opzione previa, nella complessità indicata, superi le istanze della modernità
secolarizzata, proponendo una nuova sintesi, uscendo dalla crisi. Tale è il progetto dell’opera di Pareyson, il quale fin da allora scorge la presenza di due
possibili inconvenienti: la retorica dell’«aggiornamento» del pensiero tradizionale, che per venire incontro alle istanze della modernità finisce per rinunciare
alle sue prerogative profonde e quindi cedere alle istanze del moderno (e questo non fa che riprodurre il caso tipico del «cristianesimo secolarizzato», riflesso hegelianamente in pensiero filosofico); e in secondo luogo la demonizzazione dell’esito laico della modernità (che riproduce la semplice formalizzazione
dogmatica del cristianesimo: un’altra forma di razionalismo che si coestende al
precedente) a cui finisce per attribuirne quel valore o quella rilevanza filosofica che non ha (proprio grazie alla contrapposizione)26.
Volendo anticipare la conclusione, si potrebbe affermare che per il filosofo
torinese la categoria ricostruttiva di una nuova cultura è l’idea di libertà e il programma filosofico che ne consegue è una «filosofia della libertà», che a partire da precisi elementi costitutivi riferibili alla storia del pensiero e della tradizione cristiana, superi l’interruzione attribuibile al moderno, eliminandone la con-
SAGGI
Cento anni fa la crisi del razionalismo metafisico culminato nella filosofia
hegeliana poneva un’alternativa: Feuerbach o Kierkegaard. Oggi quella
crisi non è ancora risolta [corsivo mio] […]. Ai problemi della realtà del
finito e della rilevanza filosofica del cristianesimo s’è aggiunto il problema
della natura del pensiero filosofico, e questi problemi s’impongono oggi
con una perentorietà tanto più inevitabile, quanto più importante è stata
quella corrente filosofica in cui maggiormente si è resa evidente la crisi
del razionalismo metafisico: l’esistenzialismo24.
61
62
trapposizione rispetto al “tradizionale”. A questo proposito la filosofia della
modernità, pur declinando in un radicale rifiuto del teismo, è comunque il luogo
in cui con maggiore forza si rivendica il pensiero della libertà, attestata proprio
dalla negazione, quale segno autonomia e di distanza nei confronti della cultura precedente. Si tratta naturalmente di una libertà negativa, «quella dei Demoni», come scrive Pareyson lettore di Dostoevskij27, non certo quella di Cristo,
ma che dimostra come l’eredità del cristianesimo –proprio in quanto rigettata–
rappresenti comunque, per la modernità, un riferimento indelebile. Certo, il
semplice accertamento della libertà moderna si presenta nei fatti in senso
alternativo alla libertà della tradizione: Pareyson infatti rileva come l’esito della
modernità, nel senso dell’ateismo e del nichilismo, rimandi a una diversa (e
opposta) interpretazione della libertà. Ma risulta altresì che la libertà negativa
(assoluta, si potrebbe aggiungere) dei moderni si rapporta necessariamente
con la libertà della tradizione. La genesi dell’ateismo moderno, come si è visto,
non si produce in contrapposizione immediata al cristianesimo, nel senso di
una cesura netta, ma attraverso la mediazione della filosofia hegeliana, ossia
con la tradizione razionalistica. Lo stesso Pareyson afferma esplicitamente che
la filosofia moderna, da Cartesio a Hegel, consiste in «una forma di cristianesimo secolarizzato»28. Soltanto dopo questo passaggio, dalla trascendenza
all’immanenza, si precisa l’ulteriore cesura29. Se questo è vero, l’esito ateistico, nichilistico e anticristiano trova addirittura una radice stessa nella cultura
cristiana, nel senso naturalmente di cristianesimo secolarizzato. A questo
punto è possibile trarre una prima conclusione: è il modello di libertà contenuto nel pensiero tradizionale a fornire un’anima al moderno, sia nella sua versione secolarizzata che in quella nichilistica: in tale modernità peraltro l’assunzione della categoria di libertà diventa qualcosa di diverso e alternativo rispetto alla tradizione, assumendo un’assolutizzazione che ne rende problematica
la dinamica ricostruttiva. Inoltre, nella ricostruzione pareysoniana si evince
come sia il cristianesimo secolarizzato sia l’ateismo presentino, nello stesso
tempo in cui la reclamano, un analogo deficit di libertà, e quindi siano più prossimi all’«ideologia»30 che alla filosofia. Ideologia che nasce a causa del fraintendimento del significato filosofico del temine libertà, che, in questo caso si
rovescia sua negazione. Annota ancora il filosofo in uno dei suoi ultimi testi (in
forma di frammento):
Chi sceglie il rifiuto lo fa dogmaticamente, senza ammettere ch’è una
scelta o un’ipotesi. C’è la scelta di chi la fa ma non lo sa, o non vuole
saperlo, anzi nega di farla (dogmatica acritica). C’è poi la scelta di chi la
fa sapendo di farla, e ammettendo di farla, e cercando perciò di motivarla in ogni modo.31
La libertà è apparentemente presente in entrambe le prospettive (quella cristiana e quella atea), ma con una declinazione tanto diversa da renderne equivoca l’accezione: consapevole nel cristiano, inconsapevole nell’ateo, ovvero
libertà “condizionata” nel cristiano, “incondizionata” nell’ateo. Ecco allora come
la preferenza accordata al pensiero tradizionale –inteso nel suo riferimento alle
quello “spirito”, ovvero quella dimensione di pensiero, che esso porta con
sé e che può parlare a tutti. Egli ha ritenuto di aver individuato tale “spirito” nel “pensiero della libertà”, quale cuore o dinamismo propulsore ultimo del reale. […] Quella via del “pensiero della libertà”, che non solo corrisponde al nucleo essenziale dello “spirito” cristiano, ma anche all’ideale segreto più autentico della cultura moderna.35
Il cristianesimo –nella sua «essenza» come pure nelle culture cui ha dato
vita– è «pensiero della libertà»36: in virtù di questa origine, a ben vedere, la cultura moderna presenta un innegabile legame con la tradizione cristiana, dimostrando come il contrasto tra elemento tradizione ed elemento moderno sia più
apparente che reale. Quello che cambia, come già si diceva, è l’accezione di
libertà: una libertà che mantiene il legame con la trascendenza, o il mistero o
anche l’«ambiguità» dell’origine, nella sua accezione cristiana; una libertà
«puramente umana» e storica, chiusa all’ulteriorità, nell’accezione moderna.
Questa differenza prende le forme di un’alternativa filosofica illustrata da
Pareyson tramite le prospettive di Kierkegaard e Feuerbach.
2. Le «due possibilità» del moderno: Kierkegaard e Feuerbach.
Come l’esistenzialismo –rileva Pareyson sulla scia di Karl Löwith37– è un
prodotto della crisi dell’hegelismo, quale reazione all’inglobamento della realtà
SAGGI
sue radici profonde– diventi per Pareyson la scelta di una forma di libertà non
ideologica, tale da diventare la chiave ermeneutica della modernità (che, in
fedeltà a questo metodo, anziché essere «rigettata» viene «accolta» e approfondita) e base di sviluppo di una ulteriore proposta filosofica contemporanea.
Si può ben dire allora come la modernità sia figlia di quel «pensiero della libertà» di cui è intriso il pensiero cristiano, nella forma del pensiero tradizionale, e
d’altra parte la modernità (o meglio: l’attualità) del cristianesimo sia quella che
si manifesta e incarna nello stesso metodo della libertà. Anzi, è dalla lettura di
una linea della filosofia moderna32 che Pareyson estrae quelle suggestioni di
una «filosofia della libertà» che sarà anche il culmine della propria opera. È
noto intatti che la proposta pareysoniana di una «filosofia della libertà» si pone
quale «passo decisivo» nel percorso della filosofia moderna, come l’autore
stesso aveva consapevolmente elaborato, «da Cartesio a Fichte»33. Si tratta
naturalmente di una particolare lettura della modernità che si prolunga nel percorso filosofico di Pareyson– fino all’esistenzialismo e da qui al proprio personalismo ontologico per confluire nell’ultimo contributo dell’ontologia della libertà. Il termine di ispirazione appare in tale senso il richiamo al cristianesimo
nella sua più ampia portata, come risulta anche dalla scelta degli autori da cui
Pareyson trae spunto: Pascal, Kierkegaard, Fichte, Schelling, Dostoevskij, profili «moderni» ma nello stesso tempo non prigionieri di una concezione eminentemente razionalistica della filosofia34. Pareyson quindi –come annota G. Ferretti– ha saputo cogliere, nel cristianesimo,
63
64
singola e concreta nel sistema panteistico e panlogistico del filosofo di Berlino,
così anche l’ateismo è l’esito della riaffermata consistenza del soggetto che si
vuole affermare in contrasto con la teologia filosofica in cui l’hegelismo è recepito in una posterità romantica. È a questo punto che Pareyson ritiene che sia
Kierkegaard che Feuerbach siano «due possibilità» paradigmatiche della
modernità, che nascono dalle ceneri del sistema hegeliano che essi rifiutano e
in nome della singolarità (della persona) e della concretezza (della realtà) che
essi affermano. Entrambe le istanze manifestano l’esigenza di una libertà del
soggetto, in nome della trascendenza per l’uno, della natura terrena per l’altro.
In riferimento a questa che definisce la «duplice possibilità» della filosofia post
hegeliana, Pareyson intende riflettere sulla possibile ricaduta e incidenza del
cristianesimo nella filosofia moderna. Ciò che è coinvolto dalla duplice alternativa è infatti il problema del cristianesimo nella sua valenza religiosa ma soprattutto nella sua valenza filosofica. È in questo secondo senso che esso diventa
il centro dell’alternativa messa a fuoco nell’elaborazione e nell’interesse dei
due critici dell’hegelismo come Kierkegaard e Feuerbach. La duplice alternativa, infatti, oltre che affrontare un problema religioso (che l’uno accetta e l’altro
rifiuta) o una professione di fede, costituisce un’angolazione filosofica sul
senso della libertà. A ben vedere è la modalità con cui viene esercitata la scelta ad essere centrale: la prospettiva di Kierkegaard non è quella della semplice accettazione, mentre quella di Feuerbach è una negazione vera e propria.
Le due scelte infatti non sono semplicemente una la negazione dell’altra. Kierkegaard per Pareyson è il rappresentante di una tradizione che si confronta
con la sua matrice originaria (il cristianesimo), ma si pone anche il problema
dell’incidenza storica e della modernità di quest’ultima. Feuerbach invece afferma l’ateismo attraverso la semplice negazione del cristianesimo (la religione
ricondotta ad antropologia, o potremmo dire, ad ideologia), senza tener conto
degli esiti storici di questa possibilità:
Kierkegaard contempla la possibilità di uno schietto paganesimo come
ultima conseguenza del cristianesimo laico. Ma una nuova possibilità di
affermare il cristianesimo contro la sua fine è quella presentata da Kierkegaard: e questa possibilità non è contemplata da Feuerbach38.
Il dato che emerge dal testo è che la filosofia di Kierkegaard può includere
nella sua prospettiva l’anticristianesimo di Feuerbach, inteso come problema e
confronto necessario, e questa inclusione contribuisce a rafforzare il cristianesimo stesso, proprio perché ne approfondisce l’origine, la specificità, il valore
storico, il significato religioso: in altre parole ne riflette il valore culturale proprio
in quanto ne rivendica il valore eterno. Se il cristianesimo secolarizzato sostituisce quello religioso significa allora che ne è stato perso il valore specifico:
ma questo non è per forza un destino ultimo. L’ateismo, nell’ipotesi di Kierkegaard, è quindi una prospettiva che certo può nascere dalla radice del cristianesimo secolarizzato e ne deve essere messa in conto anche la deriva schiettamente atea. Ma quand’anche accadesse, questo non significherebbe ancora rinunciare alla forza culturalmente propositiva di una filosofia cristianamen-
Mentre il pensatore religioso è ben conscio di muoversi nell’orizzonte
della scommessa e di doverne approfondire indefinitamente i termini, il
suo oppositore è costretto a parlare un linguaggio necessariamente dogmatico, che si esprime in enunciati assertori senza possibilità di appello
(si pensi al ritornello: Dio è morto!): egli non può passare a presentare la
sua tesi semplicemente come una scelta, quale pure è, perché ciò significherebbe riconoscere che non v’è quella trasparenza indiscutibile della
storia dell’essere che alla sua proposta è essenziale41.
Il nichilismo –a parere di Pareyson– esito della filosofia hegeliana nella versione di Feuerbach e degli epigoni, viene considerato e decostruito non attraverso le desuete armi dell’apologia e quindi della contrapposizione ideologica.
Piuttosto esso viene illustrato per il metodo con cui il suo pensiero agisce, e
SAGGI
te ispirata: e questo, a parere di Pareyson, costituisce la modernità della prospettiva culturale di Kierkegaard anche di fronte alla professione di ateismo a
cui perviene la cultura moderna. Più in profondità, il pensiero di Kierkegaard
può attuare questa inclusione per il fatto che la sua prospettiva si serve in
fondo dell’opzione filosoficamente consapevole della libertà, intesa come consapevolezza di un compito, operazione che invece che nella prospettiva di
Feuerbach manca. La filosofia di Kierkegaard viene quindi recepita da Pareyson in modo molto esplicito quale affermazione di una «filosofia della libertà»39.
È in quest’ottica che il cristianesimo, o una «filosofia cristiana» (come scrive lo
stesso autore) non può che presentarsi sotto le insegne di un pensiero che problematizza ed approfondisce l’istanza della libertà presente in ogni formulazione filosofica, e ne valuta la proposta sulla base degli effetti di più lunga durata
che tale opzione determina. L’esempio di Kierkegaard non nasconde il costo
che questa mediazione della cultura presenta: Pareyson stesso ne ha la consapevolezza, quando, in riferimento al danese, richiama che «ciò non sopprime il carattere d’intensa e drammatica problematicità che il cristianesimo oggi
non può non avere»40. Il programma di una filosofia della libertà richiede una
coraggiosa scelta culturale, che nell’esplicito riferimento della libertà ad un riferimento di «verità», deve poi assumere l’onere di una laboriosa elaborazione
di sintesi. Scegliere Kierkegaard è molto più scomodo, filosoficamente e culturalmente, che scegliere Feuerbach, perché la responsabilità che ne deriva si
traduce in un intenso impegno intellettuale e morale, personale e collettivo
insieme.
Tutto questo appare molto meno impegnativo nella prospettiva di Feuerbach. La sua prospettiva, scelta da Pareyson quale esito –alternativo a Kierkegaard– della filosofia hegeliana, rappresenta invece la scelta dell’esclusione
della dimensione trascendente e della sua conseguente negazione. Ed è attraverso questo tipo di decisione che nel pensiero moderno si sceglie una direzione ben precisa che conduce alla perdita del cristianesimo. Tale rinuncia,
nella lettura di Pareyson, equivale alla perdita di una sponda problematica: è
la scelta dell’immanenza (intesa come finitismo) a depotenziare l’apertura del
discorso filosofico, e non viceversa l’ammissione di un “a priori” religioso.
Annota a questo proposito G. Riconda nel saggio già ricordato:
65
66
per gli esiti possibili cui può dare origine: il nichilismo è frutto di una scelta di
esclusione. Paradossalmente il nichilismo nasce da un rifiuto affermativo, cioè
non dialettico, non critico, ossia dalla scelta di non ammettere quale elemento
di confronto il fatto religioso. Ma questo rilievo ne mette in luce un altro: il fatto
che il nichilismo alla Feuerbach si sostanzia di un metodo che, dimentico della
propria dimensione prospettica, è sostanzialmente ideologico. Così, come
Riconda chiaramente scrive, gli asserti nichilistici sono «senza possibilità di
appello», e lungi dal riconoscere criticamente la propria «tesi» nel senso di una
«scelta», di fatto presenta i termini della sua proposta in un «linguaggio necessariamente dogmatico». E questo sulla base di una pretenziosa lettura uniforme della storia del pensiero: va da sé che il porsi da un punto di vista assoluto («la trasparenza indiscutibile della storia dell’essere»!) nella lettura del reale
riproduce il metodo idealistico di Hegel. Pertanto il pensiero di Kierkegaard si
è configurato come «risposta a una coerenza come quella a cui Feuerbach
porta il cristianesimo secolarizzato»42 e quindi come contributo specifico al
riverbero religioso di una crisi filosofica. È il pensiero di Kierkegaard –secondo
Pareyson– a contenere le premesse per l’elaborazione di una vera e propria
cultura filosofica, perché consapevole del proprio punto di partenza e non
dimentica di essere “prospettica”, capace di una riflessione che riconosce la
complessità ontologica non meno che antropologica senza operare riduzionismi. Scegliere Feuerbach significa riprodurre in termini di finitismo le conclusioni del razionalismo hegeliano, senza produrre al contrario quel pensiero che
–pur affermando vigorosamente il punto di vista del finito– non rinuncia al rapporto con l’assoluto. La preferenza di Feuerbach rispetto a Kierkegaard implica l’esclusione di una ben precisa mediazione filosofica, che richiederebbe
invece, se adottata, una elaborazione di una prospettiva globale sull’essere
non meno che sull’uomo, che abbia una ricaduta sul piano della cultura: a questo infatti risponde in Pareyson l’urgenza di un personalismo ontologico che
soltanto attraverso la scelta di Kierkegaard risulta ammissibile, mentre dalla
prospettiva di Feuerbach rimane escluso. Il costo della mediazione filosofica è
alto perché chiede –superando sia Hegel che Feuerbach– una messa a punto
dei piani in questione, distinti ma uniti, che incrociano finito e infinito, persona
e verità, tempo ed eternità, nella convinzione che soltanto in questa loro composizione sia verificabile, alternativa alla crisi, una cultura della libertà che
possa essere duratura.
Due alternative alla crisi: «ritrovamento» o «rinnovamento»
Il riferimento alla filosofia di Kierkegaard, come possibile soluzione di una
crisi culturale che risale alla dissoluzione del sistema hegeliano, ma in generale di ogni crisi, è per Pareyson indicativa di una prospettiva di recupero del cristianesimo, nel suo significato religioso e insieme speculativo. A patto di operare una scelta precisa e impegnativa, religiosamente non meno che filosoficamente, nota come «ritrovamento» del cristianesimo:
o si porta fino in fondo il processo di secolarizzazione del cristianesimo,
con il che se ne dichiara la fine e se ne conferma perciò il valore puramen-
Tale categoria –che potrebbe anche essere convertita in «ripensamento»–
si specifica in un duplice movimento circolare: da una parte indica la rilevanza
“religiosa” del cristianesimo («la sua forma autentica di fede») e dall’altra ne
sottolinea la rilevanza speculativa, l’«esperienza» del cristianesimo formatasi
lungo la storia. Va da sé che il recupero –il «ritrovamento» o il ripensamento–
dell’elemento cristiano alla base dell’interesse di Pareyson non avviene sulla
base di una riproposizione pura e semplice del «pensiero tradizionale», quanto invece sulla linea di un fattivo lavoro filosofico che sintetizza tradizione e
modernità. Tale approfondimento, che si risolve in un’interpretazione e “storicizzazione” della tradizione cristiana, è una vera e propria operazione culturale, che prende le mosse da una significativa affermazione della trascendenza
della verità. Affermare la valenza religiosa del cristianesimo, non significa
depotenziarne la dimensione storica e culturalmente attiva, perché ammettere
«un cristianesimo che intenda affermarsi nel suo valore puramente religioso»
non equivale ad attribuirgli un «carattere» «astrattamente metastorico né
meramente interiore»44, avendo l’esperienza religiosa una valenza personale e
quindi concretamente attiva, ed essendo il pensiero a fungere da elemento
mediatore nel circolo virtuoso di «fede ed esperienza».
«Rinnovamento» o «ritrovamento» sono due termini posti da Pareyson in
dialettica ed agenti profondamente in ogni dinamica storica e soltanto superficialmente ascrivibili a una dimensione eminentemente religiosa. Se «rinnovamento» equivale ad «aggiornamento», descritto dalla modalità di aggiungere
qualcosa di nuovo ad un elemento invecchiato, o addirittura di sostituire globalmente l’elemento considerato oramai inadatto ai tempi, è evidente che esso
non risponde ad una prospettiva culturalmente matura. In questo caso, e in
riferimento al cristianesimo, si farebbe strada l’idea che esso coincida interamente con una cultura storica e possa declinare in contemporanea con il declino questa, richiedendo poi un rinnovamento. In questo senso il «rinnovamento» finisce per essere il corollario di una rinuncia al cristianesimo stesso, considerato nella sua variabilità continua in relazione al tempo, al punto da richiedere aggiunte o emendamenti che lo rendano di nuovo adeguato, o peggio
ancora una completa palingenesi di esso facendo piazza pulita della sua storia precedente. I sostenitori della linea del «rinnovamento» compiono secondo
Pareyson una confusione piuttosto grossolana tra il cristianesimo come «fatto
eterno» ed esso come fatto storico. Se così fosse –fa capire Pareyson– allora
si cadrebbe nello stesso errore della teologia liberale dell’Ottocento e oggetto
della critica di origine barthiana: il cristianesimo sarebbe ridotto a fatto umano,
a messaggio filosofico piuttosto che messaggio teologico, a prassi se si vuole,
e perderebbe lo spessore trascendente ch’è l’essenza del cristianesimo stesso45. Pareyson –formatosi in giovinezza anche sui testi di Barth46– richiama
l’equivoco presente nella terminologia del «rinnovamento», e propone in alternativa la terminologia –e la conseguente cultura– del «ritrovamento». Tale
SAGGI
te storico-culturale, oppure si dissocia il cristianesimo dalle forme che
essa ha assunto nel processo di secolarizzazione e allora si tratta di ritrovare il cristianesimo nella sua forma autentica di fede e di esperienza43.
67
dinamica, che insinua fin dall’etimologia una impostazione alternativa alla
prima, dal momento che oggetto di ritrovamento è soltanto ciò che già c’è e
permane, non esclude una situazione problematica propria anche di un «fatto
eterno». Anch’esso deve sopportare la possibilità di essere dimenticato, consegnato com’è al tempo e all’arbitrio della storia. Con la precisazione che se
l’eterno è consegnato alla storia non per questo si deve dedurre che la storia
ne disponga, equivoco che è invece conseguente alla prima prospettiva. Su
questa stessa linea interpretativa si pone Roberto Esposito, il quale riconosce
come non esista «un cristianesimo diverso dal cristianesimo storico, dal
momento che la storia –come evento e come durata, come durata dell’evento–
gli è cioè, del tutto intrinseca: a meno di non sbilanciarlo drasticamente verso
una prospettiva di tipo gnostico che finirebbe inesorabilmente per rinnegarlo
sottraendogli lo stesso oggetto di salvezza»47. Come si diceva, questa dialettica di rinnovamento e ritrovamento non è interna soltanto al cristianesimo, ma
anche alla dinamica della cultura, e permette di precisare, perlomeno a livello
di abbozzo, quello che Pareyson intende per tradizione e del suo rapporto con
l’innovazione. Tradizione non un semplice deposito del tempo messo in custodia e garantito dalla «durevolezza storica».
68
La tradizione è qualcosa di più profondo, perché non si limita ad essere
la trasmissione d’un risultato storico, ma è fondamentalmente ascolto
dell’essere, che è dialogo col passato solo in quanto richiamo all’origine;
e attraversa i secoli non perché sia collocata nel tempo, ma perché è
inserita nel cuore stesso dell’avvento temporale dell’essere 48.
La tradizione storica non è intesa semplice continuità temporale, in senso
quantitativo, come se questa fosse un prodotto naturale; essa è invece la testimonianza di un lavoro molto più complesso, che include sostanzialmente
l’«ascolto dell’essere» e il «richiamo all’«origine», è luogo di mediazione tra
rivelazione intemporale e ricezione temporale. Può esistere la tradizione soltanto a partire da una previa «concezione ontologica del tempo»49, che sottrae
il passato dalla «mera temporalità» e lo collega ad un elemento più originario
che è oltre il tempo. Non è la durevolezza storica a fondare la tradizione, ma
piuttosto è la tradizione a presentarsi nel senso della continuità e della durata:
e questo implica che a costituire la tradizione non entra soltanto una presenza
storica (l’uomo) ma anche una presenza sovrastorica, non meglio specificata
da Pareyson se non come «essere» e da intendere verosimilmente come
Assoluto o Dio, come risulta dall’affinità teologica della terminologia. Se pertanto la tradizione è mediazione di tempo ed eternità, essa permette di superare
l’assolutizzazione dell’elemento storico (che è il mondo dell’uomo) e quindi il
suo riscatto da qualsiasi uso strumentale (e in ultima analisi ideologico), affermandone la relatività, la perfettibilità e nel contempo l’autonomia. A partire
dalla pregnanza della tradizione è allora possibile porre a tema l’innovazione,
che prenderà appunto il significato di «ritrovamento» o ripensamento di una
prospettiva tradizionale: l’innovazione non si definirà nel senso di inizio assoluto o interruzione della continuità, quanto invece in un ulteriore lavoro di
E anche qui ci vuole coraggio: il coraggio di dire cose semplici e «tradizionali», di spogliarci dalla superbia degli intellettuali e dei dotti, di annullare in sé il piccolo io smanioso di originalità, di preferire la verità all’originalità e la traccia dell’eterno allo spirito del tempo50.
La prospettiva di Pareyson richiede pertanto di superare «la superbia» illuministica di porre nella ragione il fondamento della storia e del suo conseguente sapere, ed assumere invece l’onestà intellettuale che ammette di non essere in possesso di un potere creatore, capace di «originalità», riconoscendo
invece un primato alla «verità» di cui non dispone; è in fondo il coraggio che
richiama il senso del limite, non certo per deprimere la forza «degli intellettuali e dei dotti», ma per evidenziare i rischi di un certo tipo di approccio storico
che –nella sua conformazione ideologica– produce ampie ricadute collettive.
Prospettare il metodo del «ritrovamento» significa porre una sostanziale questione di libertà: riconoscere nel tempo la «traccia dell’eterno», riconoscibile a
chi (persona) decide (liberamente) di cercarla, piuttosto che cedere allo «spirito del tempo» al «piccolo io», che nella sua sicurezza affermativa denota la sua
impostazione di parte.
Ritrovare la traccia dell’eterno in ciò che è semplice e tradizionale non implica comunque arrendersi al semplicismo e rinunciare alla problematicità: «il
senso del difficile»51 è tipico di ogni operazione intellettuale, che per sua natura è complessa e mai definitiva; «semplice», scrive Pareyson, «è ciò ch’è
schietto e profondo: è l’originario», che come tale, nel suo rivelarsi nel tempo,
«non si lascia imprigionare in singole forme, ma piuttosto tutte le suscita ed
esige, tutte le genera e rigenera, in un processo tanto più critico e incontentabile quanto più ricco e inesauribile»52. È l’originario (il «semplice») a dischiudere gli spazi dell’iniziativa storica, e a suscitare pertanto tutte le possibili
«forme», ogni possibile conseguente cultura, che il soggetto intende costruire.
Il soggetto non può sostituirsi al semplice ma soltanto assumere il ruolo dell’interprete, riconoscendosi in una situazione mediana di ascoltatore dell’essere e
tessitore di prospettive storiche.
Sulla base di queste considerazioni è possibile rileggere anche il percorso
complessivo della filosofia pareysoniana: la dinamica del ritrovamento è la
migliore trascrizione del metodo della libertà, intesa come fedeltà e iniziativa,
in relazione al problema storico dell’edificazione di prospettive culturali conseguenti: nella libertà vi è un ancoraggio necessario al fondamento ontologico,
oggetto di costante riferimento e ritrovamento; ed è sempre in relazione al fondamento (essere, verità) che il soggetto (persona, libertà) diventa rilevante,
SAGGI
mediazione tra senso del tempo e senso dell’origine. Al di fuori della dialettica
ripetizione –invenzione, l’innovazione risponderà al problema di ritrovare e
mantenere nel tempo la presenza dell’essere, coniugando la necessità razionale del fondamento con la libertà del tempo: questo significa porre la dimensione della cultura, ossia edificare una prospettiva storica senza cedere ad
assolutizzazioni ed unilateralità, ancorando il tempo ad una autentica base di
durata. È in tale senso che Pareyson parla di «coraggio» della tradizione.
69
70
potenziato nella sua autonomia e nel suo compito storico. Se si rilegge sulla
base di questo dato il percorso filosofico di Pareyson, sembrano ridimensionate le tesi che mettono l’accento sulle “svolte” e sulla discontinuità dell’opera, e
si riferisce alle interpretazioni che privilegiano l’evento alla continuità, e quindi
contrappongono un “primo” Pareyson legato ad una precisa fedeltà ad un personalismo filosofico compiuto, ad un “secondo” Pareyson segnato da una concentrazione metafisica sulla libertà ai limiti della disperazione antropologica
(riferendosi alla preminenza della tematica del male, del nulla e della dialettica
in Dio53). Come appare indebito lo sdoppiamento dell’opera pareysoniana, così
appare non comprensibile l’insistenza sulla presunta novità (contro la continuità) della concezione pareysoniana del cristianesimo, come annotato da Luca
Bagetto: «il cristianesimo è interruzione [= verità] e realizzazione [= il movimento della libertà]. Nel termine stesso realizzazione risuona la tensione tra il
dato compiuto e il movimento da compiere. Come vi può essere movimento,
se la verità è interruzione del movimento?»54. Tale interpretazione dimentica un
nesso da Pareyson sempre ribadito, vale a dire la relazione vitale della «persona» con la «verità» e con «l’essere», come pure un’accezione della libertà
dell’uomo sempre connotata dall’esser sì «iniziativa», e quindi una discontinuità, ma sempre «iniziata», e kierkegaardianamente, una comprensione essenziale dell’uomo come «rapporto ontologico» e «coincidenza di autorelazione ed
eterorelazione»55: non c’è l’uno senza l’altro. L’accezione del «ritrovamento»
del cristianesimo è poi indicativa di una procedura filosofica che non rinuncia
affatto al riconoscimento di una continuità storica, di una dimensione tradizionale, di una Wirkungsgeschichte, senza per questo, anzi, rinunciare alla
dimensione personalistica della scelta, che rappresenta certo una «interruzione», ma non totale. In questo caso si può anche parlare di «tensione», chiarendo però che essa non significa cesura o aporia, ma si inserisce nella dialettica tipica di qualsiasi operazione intellettuale o culturale, come di ogni dinamica esistenziale. Viene meno quindi il problema della contrapposizione tra continuità della tradizione, o, meglio, eternità della verità, ed evento temporale
della decisione o «realizzazione»: il ritrovamento del cristianesimo è il prodotto, certo temporale, e frutto di mediazione culturale, religiosa, esistenziale, che
risulta dall’incontro con la prospettiva della sua verità eterna; mediazione che
è resa necessaria in ogni tempo: faticosa, imperfetta, mai conclusa, ma
comunque necessaria.
Inoltre il riferimento al cristianesimo non è soltanto questione di scelta intimistica e privatistica, e in definitiva soltanto religiosa, quanto invece un’opzione filosofica, che riguarda la prosecuzione di una prospettiva di civiltà –e quindi di una responsabilità per il futuro– che si distende in una dimensione culturale, filosofica, ma anche politica. Un cristianesimo ritrovato è un cristianesimo
«attuale», reso possibile innanzitutto da un’operazione sistematica di pensiero: «un rigoroso esercizio di critica attenta e vigilante, come si richiede per
prima cosa dal pensiero autentico, il quale pone sempre le sue ambizioni nel
difficile»56. Precisazione che non esclude affatto, ma anzi, rafforza, la stessa
componente religiosa che nel cristianesimo Pareyson dimostra di valorizzare
anche in chiave filosofica57.
SAGGI
1 La tesi dell’unitarietà dell’opera pareysoniana, escludendo ipotetiche svolte o «stagioni speculative» separabili, è attestata anche dalla studiosa Rosanna Finamore, che scrive: «Da questo punto di
vista ci sembra quanto mai arbitrario raccogliere e sperimentare con artificiosi steccati le opere di un
filosofo che ha avuto sempre vigilissima la coscienza della continuità della propria dinamica speculativa. Non può non suscitare perplessità il fatto che l’individuazione delle varie stagioni speculative, operabile a motivo di studio, diventi sguardo miope, incapace di cogliere la complessità dell’Organon
pareysoniano, come accade a quei lettori dell’«ultimo» Pareyson –concentrato sui problemi del male
e della libertà– che ignorano il «primo» e avanzano la pretesa di conoscere comunque l’Autore, o,
cosa ancor più grave, si sostituiscono al suo genio decidendo quale debba essere il suo profilo speculativo» (Id., Arte e formatività. L’estetica di L. Pareyson, Città Nuova, Roma 1999, pp. 207-208).
2 In tale senso e per maggiore pertinenza, si segnala come Pareyson, per indicare l’inclusione
o la mediazione, scrive più propriamente di «nuova dialettica», per evitare l’equivoco della dialettica hegeliana che egli intende superare: cfr. L. PAREYSON, Una nuova dialettica in Essere, libertà,
ambiguità, Mursia, Milano 1998, pp. 92-95.
3 «La filosofia è strettamente legata alla cultura, e si presenta sempre come soluzione razionale di un problema storico», L. PAREYSON, La situazione religiosa attuale, in Esistenza e persona, Il
Melangolo, Genova, 1985, p. 111.
4 L. PAREYSON, Dal personalismo esistenziale all’ontologia della libertà, in Esistenza e persona,
Il Melangolo, Genova, 1985, pp. 9 sgg. La «crisi» a cui si allude è sì il tramonto della sintesi hegeliana a cui non ha fatto seguito alcun’altra sintesi speculativa in grado di superarla, ma anche ogni
altro momento di crisi, che richiede, per passare, l’elaborazione di una nuova cultura.
5 L. PAREYSON, Prefazione [1988] a Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, Milano, 1996.
6 L. PAREYSON, Filosofia della libertà, in Ontologia della libertà, Einaudi, Torino, 1995, pp. 463 sgg.
7 Pareyson ne scrive in modo diffuso nelle sue opere, ma anche in modo significativamente
insistente nell’ultima edizione di Esistenza e persona (1985): il saggio introduttivo, Dal personalismo ontologico all’ontologia della libertà (pp. 9-17), richiama in modo programmatico la problematica di un altro testo, ivi contenuto, e dal titolo La situazione religiosa attuale (1947). Scrive Pareyson: «Quando uscì questo libro [nel 1950], il tipo di problematica che ho descritto non era così diffuso come divenne in seguito, ed è perciò che mi son permesso di indugiare sul modo con cui credetti allora di poterla configurare» (ivi, pp. 13-14).Tutto questo sta ad indicare come il problema del
cristianesimo e del moderno, come pure del rapporto tra teismo e ateismo, sia stato uno dei temi
mai abbandonati dalla riflessione di Pareyson. Esistenza e persona è stato pubblicato in quattro
edizioni complessive: la prima nel 1950, la seconda nel 1960, la terza nel 1966, la quarta nel 1985.
Questa ricorrenza, unica tra le opere di Pareyson, ne mette in rilievo la funzione primaria.
8 Si sta facendo cenno a un articolo di Giuseppe Riconda, interessante per la storiografia filosofica contemporanea: Pensiero tradizionale e pensiero moderno, in «Annuario Filosofico», 1987,
pp. 17 sgg. È in queste pagine che emerge una prospettiva su Pareyson come interprete del
moderno
9 G. RICONDA, Pensiero tradizionale…, cit. p. 17.
10 Pareyson si ispirava in tal senso alle tesi di Karl Löwith in Da Hegel a Nietzsche (Einaudi, Torino, 1949).Cfr. L. Pareyson, Rettifiche sull’esistenzialismo [1975], in Esistenza e persona, cit. p. 253.
11 Cfr. per questo A. DEL NOCE, L’epoca della secolarizzazione, Giuffré, Roma, 1970, pp. 75 sgg.
12 Così scrive A. Del Noce: «Se si situa l’ateismo nella storia della filosofia crolla quell’idea del progresso unitario della filosofia moderna, e crolla lo stesso criterio della modernità come valore: si disegnano cioè nella storia della filosofia dei tempi cosiddetti moderni, due linee irriducibili, quella da Cartesio a Marx e a Nietzsche e quella da Cartesio a Rosmini, rivolta all’incontro con la metafisica classica
e alla sua riformulazione in relazione ai nuovi problemi». (Id, L’epoca della secolarizzazione, cit., p. 75).
13 A. DEL NOCE, L’epoca della secolarizzazione, cit., p. 75.
14 Per una più approfondita ricognizione di questo termine in Del Noce, oltre alle citate, cfr. G.
Riconda La filosofia dopo il nichilismo, in Atti della I edizione dei Simposi Rosminiani, «Rivista
Rosminiana», n. I-II 2001, pp. 18 sgg. In queste pagine viene anche proposta la distinzione delnociana tra «moderno» e «post-moderno».
71
72
15 Giuseppe Riconda, in consonanza con la prospettiva delnociana, precisa l’espressione
«pensiero tradizionale» nel senso di una cultura identificabile nell’orizzonte del cristianesimo, e
cronologicamente compresa tra l’epoca greco-cristiana e l’umanesimo, «leggendo lo stesso
momento scolastico solo come suo momento senza privilegiarlo come suo punto culminante». (cfr.
G. RICONDA, Pensiero tradizionale e pensiero moderno…, cit. p. 8). Ciò che caratterizza in modo
essenziale il «pensiero tradizionale» è pertanto «l’apriori religioso o teologico», che dal punto di
vista speculativo si riflette nel riconoscimento «di una superiorità della religione sulla filosofia contro ogni forma di razionalismo» (ibidem).
16 A. DEL NOCE, L’epoca della secolarizzazione, cit. p. 183.
17 Ivi, p. 75.
18 Ivi, p. 7.
19 Ivi, p. 183.
20 Ivi, p. 5.
21 Il legame tra Pareyson e Del Noce riguarda essenzialmente (ma non solo) il problema del
cristianesimo e dell’ateismo, come Pareyson riconosce in Esistenza e persona, Il Melangolo,
Genova, 1985, p. 273. Si ricorda a questo proposito le seguenti opere di Del Noce con le quali
Pareyson riconosce un’affinità di pensiero: Il problema dell’ateismo, Bologna, Il Mulino 1964; Riforma Cattolica e Filosofia moderna, I, Cartesio, 1965; Da Cartesio a Rosmini, Giuffré, Roma, 1992.
22 Cfr. in tale senso LUCA BAGETTO, Il processo della forma in Aa.Vv., Il pensiero di Luigi Pareyson nella filosofia contemporanea. Recenti interpretazioni (a cura di G. Riconda e Claudio Ciancio), Trauben, Torino, 2000, pp. 160-163. Nel caso in questione la vicinanza di Pareyson con la
prospettiva di Del Noce riguarda la lettura della storia dell’occidente come «ideologia del progressivo superamento di ciò che è dato sul mobile fondamento di quanto è fatto sempre di nuovo»,
intendendo per «dato» il tradizionale e per «fatto» il moderno (p. 161); tale comunanza, secondo
l’autore, sarebbe poi in contrasto con il senso generale del pensiero di Pareyson.
23 Chi riconosce a Pareyson una piena consonanza con il «pensiero tradizionale» è lo stesso
proposito G. Riconda: oltre al saggio già menzionato, cfr. anche in AA.VV. Filosofia ed esperienza
religiosa. A partire da Luigi Pareyson, Macerata, 1995, p. 134.
24 L. PAREYSON, La situazione religiosa attuale, in Esistenza e persona, cit., pp. 113 sgg. Questo saggio, pubblicato come si è detto nel 1947, è stato incluso nell’ultima edizione della raccolta
(1985) proprio per l’importanza della riflessione sul cristianesimo.
25 Così Pareyson scrive nella Prefazione alla prima edizione di Esistenza e persona (1950),
testo che egli stesso cita nel saggio introduttivo dell’ultima edizione (1985), Dal personalismo esistenziale all’ontologia della libertà, pp. 9-10.
26 Negli Studi sull’esistenzialismo (1943) Pareyson connotava tale corrente filosofica nel senso
dell’«instabilità»; tale giudizio veniva rovesciato in Rettifiche sull’esistenzialismo (del 1975, ora raccolto nell’ultima edizione di Esistenza e persona), la cui formulazione però non riguardava tanto
l’esistenzialismo “storico” (e quindi i propri studi precedenti, come se le «rettifiche» negassero la
validità complessiva di quelle ricerche), quanto invece le potenzialità degli sviluppi dell’esistenzialismo “filosofico”, e quindi del «personalismo ontologico», categoria formulata da Pareyson e indicativa degli sviluppi del proprio pensiero.
27 Così Pareyson in La situazione religiosa attuale, già citato: «Il cristianesimo che si limita a
difendersi dall’anticristianesimo si pone con ciò stesso al di qua della crisi, e con questo atteggiamento puramente antitetico conferma l’impotenza dei mezzi di cui dispone, vale a dire tutto l’armamentario della cultura in dissoluzione. Perché il cristianesimo abbia qualcosa da dire nel momento presente, bisogna che il cristiano riconosca la realtà della crisi, e si ponga non prima, ma dopo
la crisi. Il che significa che un cristianesimo valido al giorno d’oggi è quello che non si limita a
opporsi all’anticristianesimo, ma è capace di oltrepassarlo» (pp. 117-118).
28 L. PAREYSON, L’esperienza della libertà, in Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino, 1993, p. 133.
29 Cfr. L. PAREYSON, Dal personalismo esistenziale…, cit. pp. 118 sgg. Pareyson sarà molto
chiaro anche nel considerare come il cristianesimo «secolarizzato» non debba essere confuso con
il cristianesimo «religioso» e come il primo abbia indotto a un equivoco non trascurabile, ossia alla
riduzione del cristianesimo a sistema filosofico (e quindi a specifica cultura).
30 Cfr. L. PAREYSON, Due possibilità: Kierkegaard e Feuerbach [1950], in Esistenza e persona,
cit., p. 78: «La domanda ultima è perciò: il finitismo e lo strumentalismo [vale a dire l’esito ateo]
SAGGI
non sono per avventura soltanto l’antitesi, o, anzi, la ritrascrizione in termini d’attualità del razionalismo metafisico? [vale a dire l’hegelismo]».
31 Per Pareyson il termine ideologia è inteso nel senso deteriore del «pensiero puramente
espressivo», «pensiero ch’è mero prodotto storico», prassistico e strumentale, e quindi come
negazione convinta e consapevole della verità. Cfr. Pensiero rivelativo e pensiero espressivo
[1964] in Verità e interpretazione, cit., pp. 16 sgg.
32 L. PAREYSON, Frammenti sull’escatologia, in Ontologia della libertà, Einaudi, Torino, 1995, p. 343.
33 PAREYSON accoglie nell’accezione di filosofia moderna quella linea «eminente», derivata dall’insegnamento di Piero Martinetti e Gioele Solari, «il periodo aureo» che «è la meravigliosa e
impareggiabile fioritura che ebbe luogo in Germania da Kant a Schopenhauer, dal criticismo al
Romanticismo e all’idealismo tedesco» (L. PAREYSON, Attualità di Martinetti [1972], in Prospettive
di filosofia contemporanea, Mursia, Milano 1993, p. 115).
34 L. PAREYSON, Filosofia della libertà [1989], in Ontologia della libertà, cit., pp. 463 sgg.
35 L. Pareyson, Libertà e situazione [1988], in Ontologia della libertà, cit., pp. 7 sgg. Qui Pareyson
riporta gli autori che meriterebbero di essere collocati «sotto l’insegna di una filosofia della libertà»:
«Plotino, Pascal, Fichte, Kierkegaard, Schelling, l’esistenzialismo» (p. 9). Inoltre, nei materiali preparatori riportati alla nota 6 della stessa pagina, egli menziona esplicitamente, accanto a Plotino, la «tradizione giudaico cristiana» e «l’esperienza religiosa come ruolo privilegiato della libertà». Questi
rimandi confermano come dalla fonte del pensiero tradizionale sia riconducibile una autentica storia
della libertà che anticipa, attraversa e supera il moderno (lo invera, si sarebbe tentati di dire).
36 G. Ferretti in AA.VV., Filosofia ed esperienza religiosa: a partire da Luigi Pareyson, cit., pp. 38-39.
37 La continuità essenziale tra libertà e cristianesimo è confermata da Pareyson anche in Il
nulla e la libertà come inizio [1992] in Ontologia della libertà, cit. pp. 460-462; cfr. anche Filosofia
della libertà, in Ontologia della libertà, cit., pp. 469 sgg.
38 K. LÖWITH, Da Hegel a Nietzsche, cit.
39 L. PAREYSON, Kierkegaard e Feuerbach, in Esistenza e persona, cit., p. 77.
40 Se ne trova un preciso riferimento in L. PAREYSON, Kierkegaard e Pascal, Mursia, Milano,
1999, p. 135. Il testo qui citato è la riedizione di una dispensa universitaria dal titolo L’etica di Kierkegaard nella “Postilla”, Giappichelli, Torino, 1971.
41 L. PAREYSON, Dal personalismo esistenziale all’ontologia della libertà, cit., p. 13.
42 G. RICONDA, Pensiero tradizionale e pensiero moderno, cit., p. 35.
43 G. RICONDA, Pensiero tradizionale e pensiero moderno, cit., p. 77.
44 L. PAREYSON, Se muore il Dio della filosofia (intervista a cura di Ciro Sbailò) [1989], in Essere, libertà, ambiguità, Mursia, Milano, 1998, p. 182.
45 L. PAREYSON, Dal personalismo esistenziale all’ontologia della libertà, cit. p. 11.
46 A proposito di quest’aspetto cfr. L. PAREYSON, Se muore il Dio della filosofia, cit. p. 181.
47 Cfr. L. PAREYSON, L’esistenzialismo di Karl Barth [1939], in Studi sull’esistenzialismo, Mursia,
Milano 2001 (prima ed. Sansoni, Firenze, 1943), pp. 81 sgg. Si tratta di un ampio studio sul «barthismo» e sulla teologia dialettica.
48 R. ESPOSITO, Immunitas, Einaudi, Torino 2002.
49 L. PAREYSON, Valori permanenti e processo storico [1968], in Verità e interpretazione, Mursia, Milano, 1971, p. 47.
50 L. PAREYSON, Valori permanenti e processo storico, cit., p. 48.
51 L. PAREYSON, Presentazione de Il magnifico oggi di M. F. Sciacca, Città Nuova Editrice,
Roma, 1976, p. X.
52 L. PAREYSON, Prefazione a Estetica. Teoria della formatività, cit. p. 210.
53 L. PAREYSON, Presentazione de Il magnifico oggi di M. F. Sciacca, cit., p. X.
54 È la proposta di Sergio Givone, che privilegia il tema della dialettica in Dio e al «Dio nascosto», «su cui l’ultima opera pareysoniana si soffermerà con esiti altissimi e che forse non hanno
l’uguale nella riflessione filosofico-teologica contemporanea» (S. GIVONE, Premessa a L. PAREYSON, Kierkegaard e Pascal, Mursia, Milano 1998, p. 187).
55 L. BAGETTO, Il processo della forma in AA.VV., Il pensiero di Luigi Pareyson nella filosofia contemporanea. Recenti intepretazioni (a cura di G. Riconda e Claudio Ciancio), Trauben Torino,
2000, p. 161.
56 L. PAREYSON, La filosofia dell’esistenza e Carlo Jaspers, Ed. Loffredo, Napoli 1940, pp. 82 sgg.
57 L. PAREYSON, Presentazione de Il magnifico oggi di M. F. Sciacca, cit., p. X.
73
LA TRANSIZIONE DELLA CULTURA ITALIANA
NELLA COMUNICAZIONE GLOBALE
Su alcune riflessioni di Tullio De Mauro
Pier Paolo Pasolini, Ferruccio Rossi-Landi
di Augusto Ponzio
74
Questo articolo prende spunto dal recente libro di Tullio De Mauro, La cultura degli Italiani (2004) per riflettere sulla transizione o sulla “mutazione” della
cultura italiana verso la globalizzazione considerandola nel periodo che va
dalla fine degli anni Sessanta fino ad oggi e attraverso l’interpretazione di tre
autori particolarmente interessati ai problemi del linguaggio e della comunicazione: Pier Paolo Pasolini, Ferruccio Rossi-Landi e lo stesso De Mauro. Speciale attenzione è rivolta al rapporto tra segni e valori e ai processi di trasformazione di questi ultimi, soprattutto per quanto riguarda i giovani.
Il libro di De Mauro, che è a cura di Francesco Erbani, è un libro-intervista:
una conversazione dell’autore con il curatore sul tema della cultura degli italiani. “Cultura” è qui intesa non in senso restrittivo di “cultura intellettuale” ma nel
senso ampio fornito dagli antropologi, utile per qualunque cultura e che sta alla
base di quelli che in ambito anglosassone si chiamano cultural studies, secondo cui qualunque popolazione, anche la più ‘incolta’ –come diremmo in riferimento alla cultura intellettuale, ‘alta’– non può non avere una sua capacità di
elaborazione culturale. Assumendo quest’accezione larga della nozione, De
Mauro considera il passaggio brusco dalla cultura del mondo contadino dell’Italia fino agli anni Cinquanta. Il centro di questo mondo era la famiglia come
bottega familiare, luogo di elaborazione del sapere e del sapere fare e anche
del sapersi orientare nelle relazioni: un complesso di competenze tramandate
e messe a frutto. Negli anni Cinquanta e Sessanta, con spostamento della
manodopera nella città, queste competenze furono messe a bassissimi costi al
servizio delle grande industria. Osserva De Mauro:
Chi è arrivato in città non ha trovato nulla, o quasi nulla, di ciò che la bottega familiare in una realtà contadina riusciva a garantire. Gli adulti
hanno trovato lovoro e redditi più alti, e questo era desiderabile. Ma i loro
figli non hanno trovato niente. Hanno trovato scuole assolutamente incapaci di capire cosa potessero e dovessero fare dinanzi a questi nuovi arrivati. […] Ma è impressionante che sul campo degli anni Cinquanta solo
alcuni, da Pier Paolo Pasolini a don Lorenzo Milani, colgano il rischio di
quello che stava avvenendo. Il rischio di quello che quasi vent’anni dopo,
in un editoriale del Corriere della sera, Eugenio Montale chiamò “il terremoto antropologico sotterraneo” che ha devastato il paesaggio culturale
italiano (ivi: 10).
La scomparsa della “bottega familiare” non ha trovato un’adeguata compensazione in una crescita educativa integrale in grado di recuperarne o sosti-
NOTE
tuirne il sistema delle competenze e dei valori. Malgrado l’offerta di un’alfabetizzazione più alta e di “un pezzo di carta”, la formazione che la scuola forniva
ai giovani, nella realtà urbana che si andava via via delineando negli anni Sessanta e Settanta, si rivelava, secondo De Mauro, carente sotto due aspetti: da
una parte, per quanto riguardava il sapere, risultava sempre più insufficiente
rispetto alla sempre maggiore complessità dell’organizzazione produttiva, dall’altra, circa la capacità di orientamento nel mondo, non riusciva trasmettere né
i valori che la scomparsa bottega familiare della società contadina garantiva,
né valori sostitutivi. All’inizio degli anni Settanta risultava chiaro che, con la
scomparsa dei luoghi della loro formazione, sia i valori sia le capacità artigianali elaborate e trasmesse dalla bottega familiare, risorsa fondamentale durante passaggio alla vita urbana e industriale, erano spariti. L’istruzione fornita ai
giovani era solo “un guscio”, dice De Mauro (v. ivi: 11-12) a cui non corrispondeva, sia sul piano conoscitivo sia su quello etico, niente di sostanziale. Le giovani generazioni imparavano a parlare italiano alla stessa maniera in cui imparavano a vestirsi allo stesso modo, ma ciò dava luogo a una omologazione e
a un livellamento soltanto apparente perché sotto quel guscio sussistevano
disparità e fratture drammatiche. Evidenziando questo aspetto, De Mauro ritiene di discostarsi dal modo in cui Pasolini intendeva l’omologazione dei giovani quale si presentava all’inzio degli anni Settanta come effetto del consumismo, della scuola dell’obbligo e della televione. In realtà anche per Pasolini
l’omologazione è solo apparente, perché è ben consapevole del fatto che non
solo restano ma si acuiscono le differenze economiche e di condizioni di vita e
che persistono in Italia denutrizione, ghettizzazione e sperequazioni sociali
drammatiche, al punto tale da sottolineare le diverse forme di frustrazione e di
rabbia che la logica del consumismo produce nei ragazzi meno abienti che la
stessa scuola dell’obligo fa trovare gomito a gomito a quelli degli strati sociali
più ricchi.
Alla totale esposizione dei giovani all’ideologia del consumismo consegue,
dice Pasolini, la frustrazione di coloro che avendo ormai gli stessi bisogni, desideri e immaginari di quelli più abienti non ha i mezzi per realizzarli Di ciò sono
direttamente responsabili la televisione e la scuola dell’obbligo. “La televisione,
e forse ancora peggio la scuola d’obbligo, hanno degradato tutti i giovani e i
ragazzi a schizzinosi, complessati, razzisti borghesucci di seconda serie”. Perciò la proposta “swiftiana” di Pasolini: abolire immediatamente la scuola dell’obbligo, abolire immediatamente la televisione che con i loro modelli rendono
i giovani insieme presuntuosi e frustrati, “aggressivi fino alla delinquenza” e
“passivi fino all’infelicità” (Pasolini 1976: 165-171).
Pasolini, particolarmente con i suoi articoli pubblicati sul Corriere della
Sera, svolge agli inizi degli anni Settanta fino alla sua morte avvenuta il 2
novembre 1975, una lucida analisi del processo di sviluppo in Italia della civiltà dei consumi, che oggi si presenta nella forma del mercato universale, della
unificazione economica e della comunicazione globale. Ne individua la base
nella “rivoluzione delle infrastrutture” e nella “rivoluzione del sistema di informazione”. Soprattutto la televisione, “autoritaria e repressiva”, divenuta centro
di elaborazione dei messaggi, ha avviato, osserva Pasolini, un’opera di accul-
75
76
turazione omologante, che non ammette altra ideologia che quella del consumo, secondo le norme di quella che egli chiama “Produzione creatrice di
benessere” (v. Acculturazione e acculturazione, 9 dicembre 1973, in Pasolini
1990: 237).
L’accezione secondo cui De Mauro intende “cultura” è anche quella di
Pasolini. La parola “cultura”, chiarisce Pasolini in un articolo sui giovani e la
droga del 24 luglio 1975 (in Pasolini 1976: 85-91), non indica soltanto la cultura specifica, d’élite, di classe: indica anche, e prima di tutto, secondo l’uso
scientifico che ne fanno etnologi, antropologi e sociologi, “il sapere e il modo
d’essere di un paese nel suo insieme, ossia la qualità storica di un popolo con
l’infinita serie di norme, spesso non scritte, e spesso addirittura inconsapevoli,
che determinano la sua visione della realtà e regolano il suo comportamento”
(ivi: 87).
Tutte le classi sociali sono coinvolte nella perdita dei vecchi valori e nella
mancanza di nuovi, alternativi agli pseudovalori del consumismo, ma i più colpiti sono i giovani delle classi povere: “appunto perché essi vivevano una ‘cultura’ ben più sicura e assoluta di quella vissuta dalle classi dominanti” (ivi: 89).
È sulla base di questa analisi che Pasolini considera il fenomeno della droga
e cerca di spiegarne il dilagare fra i giovani e soprattutto fra quelli degli strati
sociali più bassi e dei quartieri popolari più emarginati.
Un punto fermo dell’analisi di Pasolini è il fatto evidente che le due culture,
quella della borghersia e quella del popolo, come pure le due storie, quella borghese e quella proletaria, si sono unite, in conseguenza di una “borghesizzazione totale e totalizzante” (Pasolini 1976: 80). La responsabilità ideologica di
tale unificazione è, secondo Pasolini, di tutti coloro, intellettuali e partiti di sinistra, che in buona o in cattiva fede, hanno creduto di dover risolvere il problema della povertà sostituendo la cultura e i modi di vita delle classi povere con
la cultura e le abitudini della classe dominante; cioè hanno creduto, dice Pasolini, che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese.
In questo senso Pasolini denuncia il carattere totalitario di tale unificazione,
e mostra come la sua repressività non sia “arcaicamente poliziesca”, ma, come
la riorganizzazione attuale della forma capitalistica richiede, falsamente permissivista e ipocritamente tollerante.
“La tolleranza, sappilo”, dice Pasolini, nel suo trattatello pedagogico Gennariello (che inizia nei primi mesi del 1975 e si interrompe il 5 giugno 1975, con
una “digressione” politica e la dichiarazione di impegno in questa “digressione”
“fin che sarà necessario”),
è solo e sempre puramente nominale. Non conosco un solo esempio o
caso di tolleranza reale. E questo perché una “tolleranza reale” sarebbe
una contraddizione in termini. Il fatto che si “tolleri qualcuno” è lo stesso
che lo si “condanni”. La tolleranza è anzi una forma di condanna più raffinata (ivi: 23).
Il significato efffettivo della parola “tolleranza” e del verbo “tollerare”, è pienamente avvertito nel participio passato “tollerato”. Pasolini sa tutto questo nel
Il rapporto sessuale è un linguaggio (ciò per quanto mi riguarda è stato
chiaro ed esplicito specialmente in Teorema); ora i linguaggi o sistemi di
segni cambiano. Il linguaggio o sistema dei segni del sesso è cambiato
in Italia in pochi anni, radicalmente. Io non posso essere fuori dell’evoluzione di alcuna convenzione linguistica della mia società, compresa quella sessuale. Il sesso è oggi la soddisfazione di un obbligo sociale, non un
piacere contro gli obblighi sociali. da ciò deriva un comportamento sessuale appunto radicalmente diverso da quello a cui io ero abituato. Per
me dunque il trauma è stato (ed è) quasi intollerabile […]. Il sesso in Salò
è una rappresentazione o metafora di questa situazione: questa che
viviamo in questi anni: il sesso come obbligo e bruttezza (ivi: 316).
Da qui l’“abiura” di Pasolini (9 novembre 1975, in Pasolini 1976: 72 e segg.)
nei confronti dei suoi film della Trilogia della vita, espressione di un periodo,
cronologicamente vicino, ma sociologicamente e culturalmente lontano in cui
aveva senso la lotta per la democratizzazione del “diritto di esprimersi” e per la
“liberalizzazione sessuale”. Tale “lotta progressista” è stata “brutalmente superata e vanificata dalla decisione del potere consumistico di concedere una
vasta (quanto falsa) tolleranza” (ivi: 72). La liberalizzazione sessuale “anziché
dare leggerezza e felicità ai giovani e ai ragazzi, li ha resi infelici, chiusi, e di
conseguenza stupidamente preuntuosi e aggresssivi” (ivi: 74). Se nella società repressiva, il sesso era anche un’irrisione innocente del potere, oggi può
essere assunto, dice Pasolini, come la rappresentazione di quella che Marx
chiama la mercificazione dell’uomo: la riduzione del corpo a cosa. In Salò, dice
Pasolini, il sesso oltre che la metafora del rapporto sessuale, “obbligatorio e
brutto” che la tolleranza del potere consumistico ci fa vivere in questi anni, è
“anche la metafora del rapporto del potere con coloro che gli sono sottoposti.
[…] Dunque il sesso è chiamato a svolgere nel mio film un ruolo metaforico
orribile” (Pasolini 1991: 316).
Con la “Produzione creatrice di benessere” è connessa la diffusione del
“nuovo fascismo consumistico”. Il carattere nuovo di tale “fascismo” sta, per
Pasolini, nel fatto che a differenza del fascismo tradizionale che non era riuscito
a modificare gli italiani, sta producendo una “rivoluzione antropologica”, “una
mutazione della cultura italiana”, un cambiamento radicale delle coscienze, una
“irreversibile degradazione,” che si presenta (accanto ai selvaggi disastri edilizi,
urbanistici, paesaggistici, ecologici, della “civiltà tecnologica”) come “genocidio
culturale”, come un vero e proprio “disastro antropologico” (v. Pasolini, Studio
sulla rivoluzione antropologica in Italia, 10 giugno 1974 e Ampliamento del “bozzetto” sulla rivoluzione antropologica in Italia, 11 luglio 1974 (in Pasolini 1990: 39-
NOTE
senso vissuto, non gnoseologico, della parola “sapere”, sperimentandolo in
prima persona, avvertendolo sulla propria pelle: “Io sono come un negro in una
società razzista che ha voluto gratificarsi di uno spirito tollerante. Sono cioè
‘tollerato’” (ibidem).
“La repressione del potere tollerante, di tutte le repressioni, è la più atroce”.
Nei rapporti sessuali fra i giovani la tolleranza subentra alla represione sessuale, una tolleranza che rende il sesso “triste e ossessivo” (Pasolini 1991: 315).
77
44 e 56-64). L’interclassimo obiettivo del fascismo ma che il fascismo non era
affatto riuscito a realizzare è invece ottenuto dal consumismo.
Pasolini evidenzia, potremmo dire con un’espressione usata da Walter Benjamin in uno scritto così intitolato degli inizi degli anni Trenta, il “carattere distruttivo dell’attuale”, il carattere distruttivo della fase economica della “Produzione
creatrice di benessere”. “La sua prima esigenza è quella di far piazza pulita di
un universo ‘morale’ che le impedisce di espandersi” (Pasolini 1990: 23).
Salò o Le 120 giornate di Sodoma è il film, dice Pasolini, che raffigura l’Italia com’è diventata nell’arco di una decina d’anni e anche meno:
78
Un’immensa fossa di serpenti, dove, salvo qualche eccezione e alcune
misere élites, tutti gli altri sono appunto dei serpenti, stupidi e feroci, indistinguibili, ambigui, sgradevoli. E tutto ciò a causa a) del loro degradante consumismo coatto, e, in secondo luogo e settorialmente; b) della
scuola dell’obbligo che li ha frustrati rendendoli coscienti della propria
ignoranza e nel tempo stesso presuntuosi per quelle quattro sciocchezze moralistiche e pseudo-democratiche che vi hanno imparato; c) della
televisione, che mostra loro i modelli di vita e concretizza i valori attraverso il suo linguaggio che, essendo pura rappresentazione, non ammette
repliche logiche; d) di una infinità di altre cause tutte concorrenti e tutte
nate dalla stessa matrice che è il mutamento della natura del Potere economico (Pasolini 1991: 319).
Le vittime principali di tale mutazione antropologica sono i giovani (compresi gli estremisti fascisti che “sono in realtà forze statali”). “I giovani italiani nel
loro insieme costituiscono una piaga sociale forse ormai insanabile: sono o
infelici o criminali (o criminaloidi) o estremistici o conformisti: e tutto in una
misura sconosciuta fino ad oggi” (Pasolini 1976: 90). La privazione di valori ha
gettato i giovani nel vuoto, facendone una “massa di criminaloidi”.
Non solo i criminali veri e propri sono una “massa”: ma, ciò che più conta,
la massa giovanile italiana tout court (eccettuate piccole élites…) è costituita ormai da criminaloidi: ossia da quelle centinaia di migliaia o milioni
di giovani che patiscono la perdita dei valori di una ‘cultura’ e non hanno
trovato intorno a sé i valori di una nuova “cultura”: oppure accettano, con
ostentazione e violenza, da una parte i valori della “cultura del consumo”,
dall’altra i valori di un progressivismo verbalistico” (ivi: 81).
La diretta lettura del processo di trasformazione dei giovani delle classi
povere è direttamente offerto a Pasolini dai comportamenti dei giovani delle
borgate romane, una trasformazione registrabile nel 1975, –anno in cui viene
proiettato in televisione Accattone, che è del 1961, rispetto al modo d’essere
dei personaggi di Accattone– cioè dei giovani della malavita delle borgate
romane quali erano meno di una quindicina di anni prima.
I personaggi di Accattone erano tutti ladri o magnaccia o rapinatori o gente
che viveva alla giornata. […] In sostanza sono personaggi enormemente
simpatici: è difficile immaginare gente simpatica (al di fuori dei sentimenta-
Certo, il materialismo consumistico e la criminalità dilagano in tutto il modo
capitalistico, e non solo in Italia. Ma ciò che caratterizza quanto avviene in Italia all’inizio degli anni Settanta, osserva Pasolini, è il passaggio violento alla
omologazione consumistica. Ciò che oggi avviene violentemente in Italia è,
negli altri paesi, il risultato di un lungo processo che ha trovato possibilità di
compensazione:
A New York, a Parigi, a Londra, ci sono delinquenti feroci e pericolosi (quasi
tutti, toh!, di colore o quasi): ma ospedali, scuole, case di riposo, manicomi,
musei, cinema d’essai, funzionano perfettamente. l’unità, l’acculturazione,
l’accentramento sono avvenuti in ben altro modo. Dei loro genocidi è stato
testimone Marx più di un secolo fa. Che tali genocidi avvengano in Italia
oggi, cambia sostanzialmente la loro figura storica. Accattone e i suoi amici
sono andati alla deportazione e alla soluzione finale silenziosamente, magari ridendo dei loro aguzzini. Ma noi testimoni borghesi? (ivi: 158)
Qual è, nei confronti di questi avvenimenti, da parte dei cosiddetti “intellettuali di sinistra” l’atteggiamento che Pasolini registra di fronte a questo svutamento dei valori tradizionali essi, nella quasi totalità, non sono riusciti a contrappore l’indicazione di nuovi valori alternativi ai falsi valori del consumismo.
Anzi, gli intellettuali progressisti, abituati ad avere a che fare con i valori della
vecchia società clerico-fascista –e questa osservazione di Pasolini sul principio di inerzia che spesso caratterizza l’ideologia quando da progettazione
sociale diviene complesso di stereotipi e pregiudizi è particolarmente interessante–, hanno continuato, per inerzia, meccanicamente, a lottare per la sconsacrazione e la de-sentimentalizzazione della vita, anche quando il nuovo
potere è ormai esso stesso interessato a liberarsi di quei valori per fare spazio
a quelli della “Produzione creatrice di benessere”.
NOTE
lismi borghesi) come quella del mondo di Accattone, cioè della cultura sottoproletaria e proletaria di Roma fino a dieci anni fa. Il genocidio ha cancellato per sempre dalla faccia della terra quei personaggi. Al loro posto ci
sono quei loro “sostituti”, che, come ho avuto già occasione di dire, sono
invece i personaggi più odiosi del mondo. […] Metà e più dei giovani che
vivono nelle borgate romane, o insomma dentro il mondo sottoproletario e
proletario romano, sono, dal punto di vista della fedina penale, onesti. Sono
anche bravi ragazzi. Ma non sono più simpatici. Sono tristi, nevrotici, incerti, pieni di un’ansia piccolo borghese; si vergognano di essere operai; cercano di imitare i “figli di papà”. Sì oggi assistiamo alla rivincita dei “figli di
papà”. Sono essi che realizzano il modello guida. Il lettore confronti personaggi come i pariolini neofascisti che hanno compiuto l’orrendo massacro
in una villa al Circeo, e personaggi come i borgatari di Torpignattara che
hanno ucciso un automobilista spaccandogli la testa sull’asfalto: a due livelli sociali diversi, tali personaggi sono identici: ma i “modelli” sono i primi,
quei fili di papà, che così a lungo –per secoli– sono stati sfottuti e disprezzati dai ragazzi di borgata, che li consideravano nulli e pietosi mentre erano
fieri della loro “cultura”, che dava loro gesti, mimica, parole, comportamento, sapere, termini di giudizio” (ivi: 156-157).
79
80
Gli intellettuali progressisti “che continuano a macinare il vecchio illuminismo”
fanno dunque cosa utile al potere. Questa critica a un illuminismo vecchio e sclerotico, che considera la storia come unilineare e orientata al “progresso” (v. ivi: 21)
è uno degli aspetti che accomuna il “poeta” Pasolini –come lo connota Alberto
Moravia per sistemarlo nelle “altezze” e “voli” della poesia– e Leopardi, al di là
della formula generica e soporifera di Moravia: “Un poeta civile che nella sua poesia civile si riallaccia a Leopardi, ne ha lo stesso atteggiamento: la patria è degradata, e il poeta piange sulla sorte del proprio paese” (cit. in Pasolini, 1991: 39).
Nel trattatello pedagogico Gennariello, Pasolini mette in guardia contro le
illusioni e i danni dell’ideologia del progresso: “Non è vero che comunque si
vada avanti. Assai spesso sia l’individuo che la società regrediscono o peggiorano. In tal caso la trasformazione non deve essere accettatta: la sua ‘accettazione realistica’ è in realtà una colpevole manovra per tranquillizzare la propria
coscienza e tirare avanti”. Questa critica del “progresso”, che in effetti è critica
dello sviluppo funzionale al profitto e alla riproduzione della forma capitalistica,
non è affatto in Pasolini nostalgia di qualche momento del passato: “Capirai
pian piano, nel corso di queste lezioni, capirari, caro Gennariello, che malgrado l’apparenza questi miei discorsi non sono affatto le lodi del tempo passato
(che io, in quanto presente, non ho del resto mai amato)” (Pasolini 1976:28).
Un’altro esempio del rilevamento del principio di inerzia a cui vanno soggetti
slogan e parole d’ordine, anche se inizialmente capaci di rinnovamento, e dunque
anche movimenti collettivi e idee individuali che automaticamente li ripetono, lo
troviamo nell’articolo del 24 luglio 1975, in cui Pasolini, fa notare come “disobbedienza”, a differenza di una decina d’anni prima, non possa valere più come parola d’ordine nella lotta per la critica e la trasformazione dell’ordine vigente, perché
la “disobbedienza” è divenuta una modalità normale, conformista, di comportamento. L’intera massa giovanile italiana è normalmente, conformisticamente,
“disobbediente”. Per tutti i giovani della odierna realtà sociale organizzata in funzione della “Produzione creatrice di benessere”, vale la figura o il modello di disobbediente. Non c’è nessuno di essi che si consideri obbediente. Il rapporto fra la
parola “obbedienza” e la “parola “disobbedienza” si è rovesciato.
Una decina d’anni fa il significato della parola “obbedienza” e quello della
parola “disobbedienza” erano profondamente diversi da oggi. La parola
“obbedienza” indicava ancora quell’orrendo sentimento che essa era
stata in secoli di controriforma, di clericalismo, di moralismo piccolo borghese, di fascismo; mentre la parola “disobbedienza” indicava ancora
quel meraviglioso sentimento che spingeva a ribellarsi a tutto questo. […]
In realtà, semanticamente, le parole hanno rovesciato il loro senso scambiandolo; in quanto consenziente consensiente all’ideologia del nuovo
modo di produzione, chi si crede “disobbediente” (e come tale si esibisce)
è in realtà ‘obbediente’ […]. L’Italia di oggi è distrutta esattamente come
l’Italia del 1945. Anzi, certamente la distruzione è ancora più grave, perché non ci troviamo tra macerie, sia pure strazianti, di case e monumenti, ma tra “macerie di valori’”: “valori” umanistici e, quel che più importa
popolari. […]. È chiaro che ciò che, oggi, conta individuare e vivere è una
“obbedienza a leggi future e migliori” […] (ivi: 80-84).
Ho detto, e lo ripeto, che l’acculturazione del Centro consumistico ha
distrutto le varie culture del Terzo Mondo (parlo ancora su scala mondiale, e mi riferisco dunque appunto anche alle culture del Terzo Mondo, cui
le culture contadine italiane sono profondamente analoghe): il modello
culturale offerto agli italiani (e a tutti gli italiani del globo, del resto) è
unico. La conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto,
nell’esistenziale; e quindi nel corpo e nel comportamento. È qui che si
vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura della civiltà dei
consumi, cioè del nuovo e del più repressivo totalitarismo che si sia mai
visto (Pasolini, Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino,
8 luglio 1974, in Pasolini 1990: 53-54).
Come si vede, nella fase iniziale del processo di inserimento dell’Italia nella
nuova configurazione della forma di produzione capitalistica, quella odierna
della comunicazione-produzione, Pasolini è riuscito a coglierne e a descriver-
NOTE
I casi estremi di criminalità giovanile derivano da un ambiente criminaloide
di massa, come quello popolare romano. “Non c’è nessuna soluzione di continuità tra coloro che sono tecnicamente criminali e coloro che non lo sono: il
modello di insolenza, disumanità, spietatezza è identico per l’intera massa dei
giovani”.
Conformismo, neolaicismo egoistico, interclassismo, impoverimento dell’espressività e riduzione di tutta la lingua a “lingua comunicativa”: sono per
Pasolini alcune delle conseguenze del diffondersi dell’ideologia del consumismo (che è quella che di fatto ha vinto nel referendum sul divorzio –egli dice–.
Altro che vittoria della sinistra!), rispondente alla nuova situazione economica
italiana, in cui si fa avanti un nuovo potere che non è quello del Vaticano, dei
Democristiani, delle Forze Armate e neppure quello della Grande Industria. È
il potere che consiste nel controllo della produzione e della comunicazione
divenute un tutt’uno, un unico sistema, di cui il collegamento comunicazioneconsumo è solo l’aspetto più vistoso. Sia al vecchio potere, sia all’opposizione
sfugge la metamorfosi delle masse italiane. E sfugge all’analisi dei sociologici,
giornalisti, politologi, psicologi, linguisti il “problema italiano”, che non ha equivalenti nel mondo capitalistico, perché in nessun paese è avvenuto uno “sviluppo” così travolgente, così “stupido e atroce”. L’omologazione consumistica,
osserva Pasolini, è la prima unificazione reale del nostro paese.
Si tratta, allora, prima di tutto, di studiare e comprendere al più presto il
mutamento socio-culturale che le trasformazioni intervenute nel sistema di produzione hanno comportato in Italia; e, in secondo luogo, di affrontare lucidamente la questione: “come opporsi a questo nuovo modo di produzione?” (ivi:
79-80).
Interessato al “problema italiano” Pasolini non perde di vista che esso fa
parte della complessiva riorganizzazione del sistema capitalistico a livello mondiale e che va considerato non solo facendo riferimento al Centro consumistico, al cosidetto Sviluppo, ma anche alle Periferie, ai paesi del Terzo mondo,
ruotanti nell’orbita dello Sviluppo, con le conseguenze disastrose che ciò comporta per essi.
81
82
ne, gli elementi centrali, e a prevederne anche le possibilità di sviluppo. La sua
posizione di scrittore, situata fuori dalla lingua divenuta “comunicativa”, (scrittore, dice M. M. Bachtin, è colui che usa la lingua standone fuori) lo ha esposto a una consapevolezza che egli, a differenza di altri scrittori, non ha esitato
a perseguire e a sviluppare fino in fondo, fino a trovarsi nella condizione di una
estremamente partecipe solitudine.
Un contributo particolarmente importante per la comprensione dell’evoluzione della cultura e della forma di produzione in Italia a partire dalla fine degli
anni Sessanta viene dato anche da Ferruccio Rossi-Landi, soprattutto con la
linea di ricerca avviata con il suo libro del 1968, Il linguaggio come lavoro e
come mercato (nuova ed. 2003), e con la fondazione nel 1967 di Ideologie, la
rivista che Rossi-Landi diresse fino all’ultimo numero apparso nel 1972. Anche
l’analisi di Rossi-Landi è svolta secondo una prospettiva ampia che tiene conto
dell’evoluzione complessiva del processo della “riproduzione sociale” –concetto centrale della prospettiva di Rossi-Landi– a livello mondiale. Rossi-Landi
studia la cultura da un punto di vista semiotico, come insieme di sistemi segnico-comunicativi verbali e non verbali (v. Rossi-Landi 2003: 108). Il libro di
Rossi-Landi del 1968, risulta oggi di grande attualità perché anticipa e affronta con lucidità e lungimiranza problematiche centrali della fase attuale della
forma capitalistica, in cui la comunicazione si presenta come il fattore costitutivo della produzione, e il cosiddetto “lavoro immateriale” come la principale
risorsa.
La comunicazione risulta, oggi più che mai, qualcosa di ben diverso da ciò
che è stata presentato come tale in base allo schema dell’emittente, del ricevente, del codice del messaggio e che è descritto in termini di un oggetto che
passa da un punto ad un altro. Ferruccio Rossi-Landi già nel suo libro del
1961, Significato, comunicazione e parlare comune (v. Rossi-Landi 1998)
prese posizione contro questo modo di concepire la comunicazione, che egli
ironicamente chiamava “comunicazione del pacco postale”. La comunicazione
svolge oggi un ruolo dominante non soltanto nel momento intermedio del ciclo
produttivo, quello della circolazione, dello scambio, del mercato, ma anche, in
seguito allo sviluppo dell’automazione, della computerizzazione e dei mezzi e
delle vie di comunicazione, nella stessa fase della produzione di merci ed
anche in quella del loro consumo. Quest’ultimo è fondamentalmente consumo
di comunicazione, ed è ormai abbastanza evidente che non solo le merci sono
messaggi, ma che anche i messaggi sono merci. L’intera produzione è comunicazione, e viceversa.
Ciò che Rossi-Landi chiama produzione linguistica, lavoro linguistico, capitale linguistico, considerandone i rapporti di omologia con la produzione materiale, risulta oggi fattore fondamentale della riproduzione sociale. Ad esso si
riferiscono espressioni ormai di uso comune come “risorsa immateriale”, “capitale immateriale”, “investimento immateriale”, e ad esso si richiama l’affermazione della centralità per lo sviluppo e la competitività, nella knoledge society,
dei processi formativi, dell’informazione e dell’incremento dei saperi.
Nell’attuale riconoscimento della centralità del “lavoro immateriale”
(un’espressione piuttosto infelice, perché implica una concezione abbastanza
NOTE
rozza di ciò che è “materia”) si ritrova quanto Rossi-Landi sosteneva in base
alla nozione “lavoro linguistico” e alla conseguente connessione, che all’epoca
poteva risultare strana o nient’altro che una semplice similitudine, tra produzione materiale e produzione linguistica, e tra linguistica ed economia (Linguistics
and Economics è il titolo di un suo libro, non tradotto in italiano, del 1975).
La produzione materiale e la produzione linguistica, che non molto tempo
fa apparivano separate sotto forma di “lavoro manuale” e “lavoro intellettuale”,
si sono oggi congiunte saldamente. Il computer, unità di hardware e software,
rende ormai eclatante la connessione, di lavoro e artefatti materiali, da una
parte, e di lavoro e artefatti linguistici, dall’altra, ed evidenzia, al tempo stesso,
la superiorità e il carattere trainante, nella produzione e nello sviluppo, del lavoro linguistico, del “lavoro immateriale”. L’assunto centrale di Rossi-Landi nel
considerare il linguaggio come lavoro è che la produzione linguistica è uno dei
fattori fondamentali della vita sociale, e come tale è omologa alla produzione
di utensili e di artefatti.
Negli editoriali e nei suoi saggi apparsi nella rivista Ideologie, Rossi-Landi
rivolge particolare attenzione allo studio del rapporto fra cultura e ideologia,
quest’ultima esaminata in termini di “progettazione sociale” (da un punto di
vista teorico-metodologico questo studio sarà in seguito approfondito nel suo
libro intitolato Ideologia (1978 e 1982, nuova ed. 2005). La parte propositiva
del discorso di Rossi-Landi sull’ideologia è strettamente collegata con la questione del rapporto tra segni e ideologie e di conseguenza con quella del rapporto tra semiotica e studio dell’ideologia.
Con una capacità di analisi che per lucidità può essere paragonata a quella
svolta da Pier Paolo Pasolini nei primi anni Settanta, del neocapitalismo italiano
si evidenziavano alcune dimensioni particolari che ne facessero cogliere la specifica articolazione: il cattolicesimo politico, lo scarto all’interno del fronte dell’industria fra posizioni “progressiste” e reazionarie; la carenza dei servizi civili elementari; l’etnocentrismo razzista; “la brutalità dei rapporti umani non solo interclassistici ma anche, per antico e complesso retaggio di corporativismo e di
miseria, infraclassistici” (Scritti programmatici di Ideologie, p. 42); la particolare
sensibilità della borghesia nei confronti dei miti di evasione. «Ideologie» preconizzava un nuovo tipo di “lavoro produttivo” –un lavoro lungo che richiede “moltissima nuova prassi creativa con moltissima nuova teoria creativa”– volto a produrre gli strumenti di una presa di posizione critica nei confronti della complessiva organizzazione economico-culturale. Nel quadro complessivo della situazione politica mondiale, si individuavano, alcune tendenze della società neocapitalistica dell’Europa occidentale, che oggi risultano abbastanza evidenti, dato lo
sviluppo raggiunto: l’incremento della stabilizzazione capitalistica, la progressiva
estensione della socialdemocrazia, l’eclissi del comunismo, la suddivisione interna e la metamorfosi della classe operaia in rapporto a nuovi tipi di lavoro, una
maggiore separazione fra produttore e prodotto. Circa quest’ultimo aspetto, particolarmente perspicaci sono le considerazioni sul progressivo attenuarsi della
finalizzazione diretta dell’attività individuale verso la produzione, fino all’apparente distacco dell’individuo dal piano della produzione. È questo l’effetto degli sviluppi organizzativi e tecnologici della produzione sovra-individuale nella società
83
84
neocapitalistica, che, oltre a rendere possibile esonerare l’uomo dalla necessità
quotidiana della produzione, aumentano, ampliano e rendono maggiormente
mistificate le mediazioni della costrizione ad essere produttivi, al punto da creare l’illusione di esseri liberi e autonomi dal piano complessivo della produzione,
perché non costretti al lavoro da un padrone identificabile da cui direttamente si
dipenda. Evidenziando in quelli anni il carattere di lavoro dello stesso linguaggio
e il carattere produttivo dello stesso consumo e studiando i rapporti fra segni e
riproduzione sociale, Rossi-Landi evidenziava il fatto che l’uomo lavora, in gran
parte in maniera inconsapevole e inintenzionale, anche linguisticamente e partecipando alla riproduzione del ciclo produttivo attraverso il consumo di messaggimerci oltre che di merci-messaggi.
Il lavoro di analisi svolto da Rossi-Landi, come pure quello prospettato da
Pasolini, risulta di grande attualità nel contesto odierno della comunicazione
globale, per la connessione strettissima che intercorre tra comunicazione e
ideologia, benché nel mondo della globalizzazione tali sono la forza e l’espansione dell’ideologia dominante e così aderente è la sua progettazione alla realtà della comunicazione-produzione che essa tende a identificarsi con la logica
stessa di questa fase della produzione capitalistica, risultando una sorta di
“ideo-logica” e producendo, tra gli idola fori e idola theatri del nostro tempo,
l’idea della “fine della ideologia”.
L’educazione e l’istruzione sono le condizioni essenziali per una visione critica del ruolo che gli individui umani svolgono all’interno dei programmi culturali
verbali e non verbali e nella riproduzione sociale complessiva. Nella parte finale
del suo libro De Mauro, che a questi aspetti ha dedicato gran parte della sua vita,
evidenzia i rischi che educazione ed istruzione corrono nell’attuale fase della globalizzazione, alla luce della complessiva politica scolastica e culturale di vari
paesi, Italia compresa. Il piano è quello dello smantellamento dell’apparato pubblico dell’istruzione, riducendo l’istruzione da obbligo sociale garantito da leggi a
un fatto privato, regolato da scelte delle famiglie. De Mauro, citando quanto ha
denunciato nei confronti della Banca mondiale Joseph Stliglitz, premio Nobel per
l’economia nel 2001, costretto, come conseguenza di tale denuncia a dimettersi
dal suo ruolo di vicepresidente della Banca mondiale, fa presente che quest’ultima chiede ai paesi in via di sviluppo, che fanno sforzi eroici per accrescere i livelli di istruzione della loro popolazione, di bloccare i loro stanziamenti per l’istruzione di base e per l’alfabetizzazione se vogliono accedere ai prestiti e al sostegno
della Banca. L’idea che sta alla base del progetto diffuso di smantellamento dell’apparato pubblico dell’istruzione è l’idea di un buon mondo sia quella di un
mondo “straordinariamente simile al Brave New World di Aldous Huxley: sopra
gli Alfa Plus, colti, ricchi, forse capaci di autonomia, capaci di controllo mondiale,
e sotto via via le altre caste, ben divise e ben irregimentate” (De Mauro 2004:
232-233). L’alternativa, dice De Mauro (v. ivi: 234), è un mondo in cui, a turno,
tutte e tutti possano essere governanti e governati, in cui la progettazione politica sia quella del libero sviluppo di tutte le persone in modo che ciascuna di loro
possa esse messa nella condizione di partecipare attivamente e creativamente
alla vita sociale. Non si tratta di un sogno: non siamo pochi a volerlo e insieme il
mondo che vorremmo potrebbe essere vicino, anche in Italia”.
BACHTIN, MICHAIL M., 1988, L’autore e l’eroe, Torino, Einaudi.
BACHTIN, MICHAIL M., 2003, Linguaggio e scrittura, a cura di A. Ponzio, Roma, Meltemi.
DE MAURO, TULLIO, 2004, La cultura degli Italiani, Roma-Bari, Laterza.
PASOLINI, PIER PAOLO, 1972, Empirismo eretico, Milano, Garzanti.
PASOLINI, PIER PAOLO, 1976, Lettere luterane, Torino, Einaudi.
PASOLINI, PIER PAOLO, 1990, Scritti corsari, Milano, Garzanti.
PASOLINI, PIER PAOLO, 1992, Petrolio, Torino, Einaudi.
PETRILLI, SUSAN, 2003, Lavoro immateriale, «Athanor», fascicolo monografico dedicato
al pensiero di Ferruccio Rossi-Landi, XIV, 6, Roma, Meltemi.
PETRILLI, SUSAN, 2004, Percorsi della semiotica, Bari, Graphis.
PETRILLI, SUSAN; CALEFATO, PATRIZIA (cura e introd.), 2003, Logica, dialogica, ideologica.
I segni tra funzionalità ed eccedenza, Milano, Mimesis.
PONZIO, AUGUSTO, 1988, Rossi-Landi e la filosofia del linguaggio, Bari, Adriatica Editrice.
PONZIO, AUGUSTO, 1999, La comunicazione, Bari, Graphis.
PONZIO, AUGUSTO, 2002a (a cura), Vita, fascicolo monografico della serie «Athanor»,
XIII, 5, Roma, Meltemi.
PONZIO, AUGUSTO, 2002b, Il linguaggio e le lingue, Bari, Graphis.
PONZIO, AUGUSTO, 2003, I segni tra globalità e infinità. Per la critica della comunicazione globale, Bari, Cacucci.
PONZIO, AUGUSTO, 2004a, Ideology, in Semiotik/Semiotics, a cura di R. Posner, K. Robering, T. A. Sebeok, Berlin, Mouton de Gruyter, vol. 4, pp. 3436-3447.
PONZIO, AUGUSTO, 2004b, Linguistica generale, scrittura letteraria e traduzione, Perugia,
Guerra.
PONZIO, AUGUSTO; Petrilli, Susan, 2000, Il sentire nella comunicazione globale, Roma,
Meltemi.
PONZIO, AUGUSTO; PETRILLI, SUSAN 2003, Semioetica, Roma, Meltemi.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1967-1972 (a cura), Ideologie, rivista diretta da F. R.-L., Roma,
Edizioni di Ideologie.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1972, Scritti programmatici di Ideologie, Roma, Edizioni di
Ideologie.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1975a, Linguistics and Economics, L’Aja, Mouton.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1975b, Charles Morris e la semiotica novecentesca (1a ed.
1953), Milano, Feltrinelli Bocca.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1985, Metodica filosofica e scienza dei segni, Milano, Bompiani.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1999 (a cura), Charles Morris, Lineamenti di una teoria dei
segni (1a ed.1954), a cura di S. Petrilli, Lecce, Manni, 1999.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 2003, Il linguaggio come lavoro e come mercato (1a ed. 1968),
a cura di A. Ponzio, Bompiani, Milano.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1992, Between Signs and Non-Signs, a cura di S. Petrilli,
Amsterdam, John Benjamin.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1994, Semiotica e ideologia (1a ed.1972), a cura di A. Ponzio,
Milano, Bompiani.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 1998, Significato, comunicazione e parlare comune (1a ed.
1961) a cura di A. Ponzio, Marsilio, Venezia.
ROSSI-LANDI, FERRUCCIO, 2005, Ideologia (1978, 1982), Roma, Meltemi.
SEBEOK, THOMAS, 2003, Segni. Introduzione alla semiotica (2001), a cura di S. Petrilli,
Roma, Carocci
VAUGHAN, GENEVIEV, 2004, (a cura), The Gifth, fascicolo monografico della serie «Athanor», XV, 8, Roma, Meltemi.
VAUGHAN, GENEVIEV, 2005, Per-donare, Roma, Meltemi.
NOTE
Riferimenti bibliografici
85
LA CONOSCENZA COME “COMPRESENZA” DI FINITI
NEL REALISMO DI SAMUEL ALEXANDER
di Spartaco Pupo
86
Nell’introduzione a Space, Time and Deity, il trattato di metafisica e ontologia pubblicato a Londra nel 1920, Samuel Alexander (nato a Sidney nel 1859
ma trasferitosi ventenne in Inghilterra, ad Oxford, e successivamente a Manchester, dove fu tra i fondatori della odierna università e dove morì nel 1938)1
dichiara la sua appartenenza al realismo anglo-americano, quel «movimento
largamente esteso», che ebbe inizio «in Inghilterra con Moore e Russell e in
America con gli autori del neorealismo»2. Il movimento di pensiero cui si riferisce Alexander era talmente esteso che è più opportuno parlare non di un solo
realismo, ma di “più orientamenti realistici” che, soprattutto in campo gnoseologico, si possono distinguere al suo interno.
Gli impulsi iniziali del neorealismo ebbero il loro centro propulsore, come è
noto, in Inghilterra, nei primi anni del ’900, grazie a G. E. Moore, il docente di
Cambridge che rappresentava, insieme con B. Russell, l’alternativa logicoanalitica all’idealismo anglosassone. Moore contrapponeva alla tesi idealistica
dell’esse est percipi, sulla quale insisteva un filone di pensiero, rappresentato
in quel periodo soprattutto da F. H. Bradley, quella realistica che intende la sensazione come conoscenza di qualcosa di diverso sia dall’atto della sensazione
stessa che dal soggetto senziente. In Refutation of Idealism, il celebre articolo
che divenne una sorta di manifesto del realismo, Moore dimostrava che non
esiste alcuna identità tra l’atto della sensazione e l’oggetto dell’atto stesso.
Quando cerchiamo di scoprire la sensazione del blu, affermava in un esempio
rimasto famoso, «tutto ciò che possiamo vedere è il blu»; la coscienza, la «consapevolezza del blu», ci appare in modo chiaro, ma può essere distinta «se
guardiamo molto attentamente e se sappiamo che c’è qualcosa da cercare» 3.
Anche Russell, in Our Knowledge of the External World, argomentava contro
l’identificazione tra le sensazioni e gli oggetti sentiti, sostenendo che la «cosa»
posta a fondamento dei dati di senso altro non è se non una «ipotesi», una
«costruzione logica», di cui non può essere dimostrata l’esistenza4.
Sulla strada tracciata con successo dal primo neorealismo inglese si incamminarono, in America, dopo un breve arco di tempo, due correnti di pensiero.
La prima nacque per iniziativa di R. B. Perry, E. B. Holt, W. T. Marvin, E. G.
Spaulding, W. P. Montague e W. B. Pitkin, i quali inauguravano il programma
del New Realism per la sottrazione alla coscienza umana della caratteristica
della psichicità (o dell’interiorità), e consideravano la mente come un oggetto
tra gli oggetti. La coscienza si distingue dagli altri oggetti fisici solo per quel
particolare tipo di relazione che la lega ad essi: il processo conoscitivo. Tutto
ciò che può essere relazionato in termini di conoscenza ha una realtà propria,
NOTE
sussiste per sé, in modo autonomo. Anche gli errori e le illusioni, quindi, hanno
una propria realtà. In opposizione a questa prima linea di pensiero, dopo una
ventina d’anni, vide la luce il secondo movimento realista americano, che trovò
in G. Santayana, A. O. Lovejoy, R. W. Sellars, J. B. Pratt, A. K. Rogers e C. A.
Strong, i sei autori di Essays in Critical Realism, del 1920, gli esponenti principali. Essi accusavano i loro predecessori di essere caduti nella trappola del
relativismo per avere identificato l’essere con l’apparire e avere dato oggettività all’errore e alle illusioni, e tentavano di costruire una forma di esistenza intermedia tra il mentale e il fisico, la cosiddetta «essenza», un dato della «conoscenza immediata» che è presente nell’esistente fisico e si rivela alla mente,
la quale conosce «mediatamente» ed è capace di errare. La conoscenza, per
questi pensatori, è sempre rappresentazione, e come tale è incapace di cogliere l’esistenza degli oggetti e si ferma di fronte alla loro essenza. Si negava la
realtà delle illusioni, dei sogni, ma anche degli enti matematici. La realtà di questi eventi è solo legata ad una relazione di tipo mentale. Gli errori, invece, si
verificano quando le essenze e le cose non trovano un’identità o anche quando si ritengono mentali oggetti invece fittizi.
Alexander può essere collocato in questa seconda forma di realismo,
nonostante egli erediti dal Nuovo Realismo la tendenza a ridurre la mente a
un oggetto tra gli oggetti, come dimostra la sua concezione della realtà come
una «democrazia di finiti». Sulla scia di Russell e Moore, Alexander dà una
dimensione metafisica alla visione realistica del mondo e dell’uomo, proponendo un metodo di indagine che toglie alla mente umana quella reverenza
che da secoli le veniva tributata e che consente di condurre ad unità il variegato universo della natura, di cui l’uomo e la sua coscienza non sono che
elementi, parti di un complesso «democratico», certamente importanti, ma
pur sempre dei componenti, eguali alle altre esistenze finite che abitano la
multiforme realtà naturale.
Non ha dubbi R. Metz, tra i più autorevoli studiosi di storia della filosofia
inglese del ’900, quando afferma che la novità che un autore come H. Bergson
ha rappresentato per la filosofia francese vale per Alexander con riferimento al
pensiero britannico, nonostante il filosofo di Sidney sia arrivato più tardi alla
maturità «e al conseguimento di una posizione influente rispetto al più famoso
contemporaneo francese, suo coetaneo». È vero, aggiunge Metz, che la sua
influenza è stata confinata all’interno del mondo anglosassone, ma egli non
può comunque essere escluso, per l’originalità delle sue formulazioni, dalla
ristretta cerchia dei grandi autori sistematici del suo tempo. Filosofi come
«Whitehead, Bradley e McTaggart sono gli unici che possono paragonarsi a lui
con riguardo all’impulso verso la formazione di un comprensibile sistema del
mondo»5.
Sul finire del primo decennio del ’900, Alexander si appresta ad attuare
quella che lui stesso chiama una «rivoluzione copernicana». Attribuisce al suo
pensiero una valenza storica, come se il progetto di naturalizzazione della
mente, che era stato iniziato da Copernico, continuato da Darwin e su cui tanto
insisteva un pensatore della statura di Freud, possa trovare nella sua filosofia
un contributo decisivo per la soluzione del problema del rapporto uomo-mondo
87
88
nella società a lui contemporanea. In un saggio del 1909, dal significativo titolo di Ptolemaic and Copernican Views of the Place of Mind in the Universe, Alexander sostiene che «la visione geocentrica e quella eliocentrica dell’astronomia trovano la loro controparte in metafisica, e la visione geocentrica è ancora onnipotente». Ma la vera preoccupazione è che «la mente umana, in quasi
tutta la metafisica moderna, è il centro dell’universo». La verità che l’idealismo
assoluto tenta di nascondere è che la mente fornisce «unità e ordine al mondo
delle cose conoscibili, che vuol dire essere la risorsa di quelle nozioni fondamentali di permanenza, esistenza sostanziale e causalità da cui dipendono la
fabbrica e la vita delle cose»6. La mente non è altro che «una reazione nei confronti delle cose che le sono esterne, le quali ad essa si rivelano»7. Alexander
adotta la visione eliocentrica del mondo e colloca il nostro universo all’interno
di una miriade di universi. Come la terra assunse il privilegio di essere considerata un corpo celeste in mezzo agli altri, «così nella metafisica copernicana
la mente è come una cosa o classe di cose tra le altre, essendo i corpi fisici un
gruppo coordinato, o piuttosto, per essere più precisi, la mente è una proprietà distintiva di un certo gruppo di cose che sono esse stesse fisiche»8.
La visione alexanderiana del mondo appare subito come una delle più prorompenti tra quelle che tentarono di far perdere credibilità all’idealismo, nonostante sia passata per lungo tempo inosservata e scarsamente considerata nel
dibattito critico. Una prima dimostrazione è data dalla interpretazione di quella
che è la differenza tra le dottrine filosofiche del realismo e dell’idealismo.
Secondo Alexander la vera differenza sta nel loro punto di partenza e nello spirito del loro metodo. Per il realismo, la mente è «la misura delle cose nonché
il punto di partenza dell’indagine. Il nocciolo dell’idealismo assoluto consiste
nella sua affermazione che le parti del mondo non sono fondamentalmente
reali o vere ma che solo la totalità è vera. Per il realismo, la mente non occupa un posto privilegiato, tranne che per la sua perfezione»9. Un carattere discriminante tra le opposte concezioni può venire certamente dalla delucidazione
della specifica funzione della metafisica, dei suoi obiettivi fondamentali e del
modo in cui essa si rapporta alle diverse classi di esistenze. In Space, Time
and Deity, Alexander definisce la metafisica come «un tentativo di studio dei
soggetti più disparati, di descrizione della natura ultima dell’esistenza, se ne ha
una, e dei caratteri penetranti delle cose o categorie. Se è possibile trascurare troppi e accurati particolari d’interpretazione, si può utilizzare la definizione
di Aristotele: la scienza dell’essere come tale ed i suoi attributi essenziali»10.
Le peculiarità essenziali di una metafisica realistica sono ampiamente
descritte in The Basis of Realism, un saggio del 1914. Una metafisica che si
dichiari realistica, secondo Alexander, non può che ridurre la mente al suo
stato di esistente finito e materiale. Tutte le esistenze, dalle pietre, alle piante,
agli animali, all’uomo ed alla sua coscienza, anche con riferimento alle qualità
etiche di quest’ultima, sono tutte egualmente reali. Il realismo è il metodo di
trattare tutte le forme dell’esistenza allo stesso modo e trova la sua ragion d’essere nella deantropomorfizzazione del genere umano, che è il processo volto
alla collocazione dell’uomo e della sua mente al loro proprio posto nel mondo
delle esistenze finite. Il filosofo realista ha il compito primario di praticare il
NOTE
metodo della «spoliazione delle esistenze», che consiste nello «svestire le
cose fisiche delle colorazioni che hanno ricevuto dalla vanità e dall’arroganza
della mente», e di «assegnare loro, in compagnia delle menti, la loro giusta
misura di autoesistenza». Per questo motivo il realismo è una filosofia dell’eguaglianza: esso considera ogni finito come esistente in ciò che è la «democrazia delle cose». Filosofia realistica è quella che «spoglia la mente delle sue
pretese ma non del suo valore o grandezza». È nel lasciare alle altre cose i
loro diritti che la mente entra in possesso dei propri, «come in una democrazia, in cui tutti gli uomini sono uguali, ma dove parlando teoreticamente e tralasciando le limitazioni del costume o della tradizione o della povertà, ogni
uomo è libero di elevarsi al più alto dei suoi poteri originari»11.
Anche le prime pagine di Space, Time and Deity inneggiano all’universo
democratico di cose e mente: «Le menti sono i membri più dotati che noi conosciamo in una democrazia delle cose. In considerazione dell’essere o della
realtà, tutte le esistenze si posizionano ugualmente. Esse variano per eminenza; come in una democrazia, dove il talento ha un campo aperto davanti a sé,
il più dotato prevale in influenza ed autorità. Questa attitudine della mente stabilita dal metodo empirico è e può giustamente essere chiamata, in filosofia,
l’attitudine del realismo, se un nome che ha prodotto così tanti significati può
essere usato»12.
L’elemento cruciale di tutta l’epistemologia alexanderiana sta nel significato della nozione di «compresenza» (compresence). Essa si rivela come la
prima e la più semplice relazione tra gli esistenti finiti. Per rendercene conto
basta che ci immedesimiamo nel fare l’esperienza di un comune oggetto finito, col quale ci relazioniamo: «Senti te stesso nella situazione totale e capirai
che questa è la compresenza di due cose, di cui l’una, l’atto della mente, fruisce di se stessa e, nell’atto di fruire se stessa, contempla l’altra. Accorgersi di
una cosa è come essere pescato nella rete comune dell’universo, essere
un’esistenza accanto ad altre esistenze […] Ma è questa peculiarità della
mente, la quale fruisce e non contempla se stessa, che ci nasconde, se non ci
guardiamo attentamente dai pregiudizi, il fatto sperimentato che un mondo
comune ci unisce, gli uni agli altri, con le cose contemplate»13.
La mente e il suo oggetto sono «tenute insieme dalla relazione di «insiemezza» (togetherness) o compresenza, dove il termine compresenza non è
usato per indicare la co-esistenza nello stesso momento temporale, ma solo il
fatto di appartenere ad un unico mondo sperimentato»14. Non c’è di che meravigliarsi, avverte Alexander, se la compresenza dell’uomo con un oggetto fisico sembra la stessa di quella di un oggetto fisico con un altro: «La nostra compresenza con le cose fisiche, in virtù della quale noi siamo coscienti di esse, è
una situazione simile alla compresenza di una cosa fisica con un’altra. Capire
che la mia coscienza di un oggetto fisico è solo un particolare della compresenza universale dei finiti è, nei fatti, il modo migliore di comprendere l’analisi
che è stata fatta»15.
Una tale concezione della relazione soggetto-oggetto (o oggetto-oggetto) si
avvicina molto a quello che Whitehead descriveva come «concrescenza». Per
l’autore di Process and Reality, ogni «entità reale», che è legata a ciascun’al-
89
90
tra da un rapporto di interdipendenza e che ha un valore dinamico, interagisce
creativamente con le altre entità ed acquista la sua individualità grazie proprio
alla concrescenza16, un processo mediante il quale ogni entità reale si incontra con i dati resi utilizzabili da altre entità reali, cioè «prende» in se stessa tutte
le entità passate e, a sua volta, è presa da tutte quelle future. Whitehead chiama «prensione» quel processo attraverso il quale un’entità reale reagisce al
suo ambiente. In altre parole, è un processo di appropriazione, l’essenza dell’entità reale.
La compresenza, che per Alexander è «la più semplice ed universale delle
relazioni», si articola in due elementi distinti: l’atto mentale, ossia la consapevolezza, da una parte, e l’oggetto di cui essa è consapevole, dall’altra. Ne consegue che la conoscenza si articola in due momenti fondamentali: quello della
«contemplazione», che è la conoscenza che la mente ha degli oggetti ad essa
compresenti, e quello della «fruizione», che è la conoscenza che la mente ha
di se stessa, dei suoi propri atti. In qualsiasi esperienza, la mente fruisce di se
stessa e contempla il proprio oggetto. L’atto mentale è «fruito» (enjoyed), mentre la cosa percepita o ideata è «contemplata» (contemplated). Le fruizioni,
precisa Alexander, sono ciò che Locke chiamava «idee di riflessione», anche
se il grande empirista inglese le considerava come classi di oggetti di contemplazione accanto alle idee di sensazione. Contemplazione e fruizione non sono
atti separati, poiché un soggetto fruisce di se stesso solo contemplando un
oggetto. E a fruire di se stesso è il soggetto, non il corpo. Quest’ultimo, quando è oggetto della coscienza, viene contemplato dal soggetto. La soggettività
è «autofruizione della contemplazione», non è mai presente a se stessa, ma
conosce se stessa solo nella sua attività. L’atto mentale e l’oggetto sono due
esistenze distinte, anche se tenute «unite dalla relazione di compresenza». La
prima, «quella fruita, fruisce di sé, o ha esperienza di sé come una fruizione»,
mentre l’altra, «quella contemplata, è sperimentata da quella fruita»17.
Nell’esperienza della percezione, ad esempio, si distinguono: l’atto della
percezione e l’oggetto percepito. La percezione non si verifica in modo isolato, afferma Alexander in Foundations and Sketch-Plan of a Conational Psychology, uno scritto di psicologia del 1911, ma è «continuo rispetto ad altri atti dello
stesso tipo o della stessa natura, e dal momento che questo continuum è la
mente, l’atto della percezione può essere chiamato atto mentale. L’oggetto
percepito (o perceptum) è continuo con altri oggetti simili dell’esperienza, e dal
momento che questo continuum è ciò che è chiamato cosa, si può parlare dell’oggetto della percezione, senza rischio di confusione, come di una cosa»18.
Se si estende l’esperienza percettiva ad altre esperienze, sempre due rimangono gli elementi che, pur nella loro «insiemezza», possono essere distinti. In
una sensazione, quindi, troviamo il senziente ed il sensum; in un’immaginazione, l’immaginante e l’immagine; in un’idea, l’ideazione e l’ideatum; in una concezione, il concepiente e il conceptum. Si ha sempre, in definitiva, «una
coscienza ed un oggetto». E l’oggetto di cui una mente è consapevole è sempre un oggetto non mentale, esterno, distinto dalla mente e rivelato ad essa ora
come un sensum e ora come un’immagine, un conceptum, e così via.
Nella compresenza con l’oggetto io non solo fruisco di me stesso, ma mi
NOTE
trovo con esso in una relazione di spazio e tempo, e mi relaziono all’oggetto
come l’effetto alla causa. La contemplazione dell’oggetto non deve intendersi
come percezione totale delle esistenze compresenti, ma come «conazione»
(conation) del mondo dei finiti in base ai bisogni comportamentali. Tra la mera
percezione e la conazione c’è solo una differenza di tipo funzionale. Il termine
«conazione» deve essere riservato a certi atti mentali come il desiderio e la
volontà, anche se «ogni atto mentale è una conazione e nient’altro, ad eccezione di una possibile aggiunta di sentimento»19. Nella percezione, l’oggetto
eccita i sensi con il risultato di una reazione volitiva che è riferita all’oggetto. La
conazione è avviata in parte dallo stimolo ed in parte dalla previsione mentale
della risposta. Entrambe le reazioni sono due fasi dell’atto mentale. Per una
maggiore chiarezza Alexander ricorre a due esempi. Il primo è basato sulla
relazione con una mela: «Noi non percepiamo dapprincipio la mela come una
cosa rotonda dalle guance rosse e come qualcosa di commestibile, ma siamo
consapevoli del suo essere commestibile nel e dall’atto in cui noi cerchiamo di
mangiarla». Il secondo esempio è tratto dal cricket, popolare sport inglese:
«Nell’atto mentale che mira a tenere le nostre mani in modo da prendere la
palla da cricket che sta venendo verso di noi in una certa direzione, noi siamo
coscienti della direzione che sta seguendo nel venire verso di noi; noi non comprendiamo dapprincipio la sua direzione e poi compiamo la nostra azione nei
suoi confronti; essa ci obbliga ad agire in un certo modo e quindi diventiamo
consapevoli di essa stessa»20.
Quanto alla sensazione, Alexander sostiene che essa non dipende dalla
mente ma è «immediatamente» riferita alle esistenze esterne, di conseguenza
al mondo del non mentale. Il filosofo di Sidney dimostra di concordare con tutte
le scuole del realismo quando afferma: «L’esteriorità e la natura fisica delle
sensazioni sono di una materia particolarmente discutibile, perché a qualcuno
esse appaiono come immediate esperienze totalmente dipendenti dalla mente,
anche se oggettive, poiché distinte dagli atti soggettivi come il desiderio o l’attenzione. Io dirò solo che per me ogni atto mentale è ugualmente immediato,
pensando tanto alla sensazione quanto al senso come non meno esterni e non
mentali rispetto al pensiero»21.
Ogni esistenza, dalla più semplice alla più complessa, dal più basso al più
alto livello di evoluzione, possiede una sua specifica capacità di fruizione e contemplazione. Alexander la assegna persino ad un oggetto materiale come il
pavimento, nella relazione di questo con un altro finito quale può essere il tavolo. Scrive in Space, Time and Deity: «Il pavimento certamente “conosce” il tavolo non come esercizio di pressione, neanche come materiale, ma attraverso
forme equivalenti più basse, come un insieme persistente di movimenti, come
dire, accelerati verso di esso secondo la legge gravitazionale». Il pavimento
«fruisce» la materialità del tavolo, «è certo della materialità del tavolo»22.
Da tutto ciò deriva il carattere della oggettività che Alexander assegna alle
«qualità secondarie». I colori, i sapori, gli odori sono oggettivi, nel senso che
non sono semplici prodotti della mente. C’è «qualcosa di incomprensibile nell’idea che fuori dal materiale eterogeneo la mente possa fabbricare un colore
o un sapore o un odore», se partiamo dal presupposto che «noi non vediamo
91
92
i colori nei nostri occhi ma solo con i nostri occhi e nella rosa e nella mela»23.
Come si può notare, le nozioni di contemplazione e fruizione sono strettamente collegate a quella di compresenza. Nella relazione di compresenza con
un essere finito di un livello inferiore, la mente umana, secondo Alexander, è
consapevole di esso e, mentre lo contempla, fruisce di se stessa. La conoscenza è, pertanto, un caso di compresenza di due esseri finiti. Ogni oggetto
finito, nella relazione di compresenza con la mente, agisce direttamente su di
essa, determinando un processo mentale appropriato, per mezzo del quale al
variare dell’oggetto varia il corrispondente stato mentale. La mente che fruisce
di sé non può contemplarsi, ossia non può essere oggetto di se stessa. La
mente cosciente può solo contemplare gli oggetti finiti situati ai livelli di esistenza più bassi rispetto al suo. Ciò non significa, però, che gli oggetti debbano il
loro esse al loro percipi, secondo quanto stabilito dalla formulazione idealistica tradizionale. La mente sceglie gli oggetti. Ad essa, quindi, appartiene solo il
percipi degli oggetti. Gli oggetti non sono affatto mentali, così come non lo
sono le apparenze illusorie, che si presentano come delle prospettive del
mondo reale visto in modo strabico. Esse, però, non perdono il carattere dell’oggettività, e sono reali.
La teoria della conoscenza alexanderiana, con riferimento al suo procedimento metodologico, è senz’altro in linea con l’empirismo inglese tradizionale.
La spoliazione degli esistenti finiti suggerita da Alexander non si distacca dalla
generale tendenza dell’empirismo tradizionale (penso a Locke, ma anche a
Hume e a Stuart Mill) a risolvere i complessi della realtà nei loro dati semplici,
elementari. Alexander, da realista, nega alla mente sia l’indipendenza dalla
realtà che la capacità di creazione degli oggetti reali e, sull’esempio di Moore,
afferma l’assoluta oggettività dei dati provenienti dall’esperienza.
1 Una ricostruzione della vita e del pensiero di questo filosofo, unica in Italia, è contenuta nel
recente volume: S. PUPO, Samuel Alexander. Naturalismo e democrazia delle cose, Edizioni Brenner, Cosenza 2003.
2 S. ALEXANDER, Space, Time and Deity, Macmillan and Co., London 1920, I, p. xxvi. L’opera è
stata di recente ristampata, insieme ai principali scritti alexanderiani, in The Collected Works of
Samuel Alexander, Thoemmes Press, Bristol, 2000, Voll. 2 e 3. La traduzione di tutti i passi tratti
dalle opere di Alexander, e qui di seguito, riportati è mia.
3 G. E. MOORE, “Refutation of Idealism”, Philosophical Studies, Routledge & Kegan Paul, London 1922, pp. 24-25. Per un approfondimento delle tesi di Moore, insuperabili restano le monografie di A. GRANESE, George E. Moore e la filosofia analitica inglese, La Nuova Italia, Firenze 1970 e
di E. LECALDANO, Introduzione a Moore, Laterza, Roma-Bari, 1972.
4 Cfr.: B. RUSSELL, Our Knowledge of the External World, The Open Court Publishing Company, London-Chicago 1914.
5 R. METZ, A Hundred Years of British Philosophy, The Macmillan Company, New York 1938,
pp. 622-623.
6 S. ALEXANDER, “Ptolemaic and Copernican Views of the Place of Mind in the Universe”, The
Hibbert Journal, VIII, Ottobre 1909, pp. 47-48.
7 Ivi, p. 60.
8 Ivi, pp. 53-54.
S. ALEXANDER, Space, Time and Deity, cit., I, p. 8.
Ivi, p. 2.
11 S. ALEXANDER, “The Basis of Realism”, Proceedings of the British Academy, Humphrey Milford, Oxford University Press, London, Gennaio 1914, p. 2.
12 S. ALEXANDER, Space, Time and Deity, cit., I, p. 6.
13 S. ALEXANDER, “The Basis of Realism”, cit., p. 6.
14 Ivi, p. 5.
15 Ivi, pp. 6-7.
16 In Adventures of Ideas, Whitehead sottolinea la derivazione latina del termine concrescenza, che vuol dire «crescere insieme». Essa non è altro, quindi, che un crescere insieme dei vari
aspetti dell’esperienza (A. N. WHITEHEAD, Avventure di idee, Bompiani, Milano 1961, p. 301). V.
Lowe, noto biografo e studioso di Whitehead, ha notato la somiglianza tra la concezione di questo
filosofo e quella di Alexander, ma l’ha riferita alla nozione di prensione e non a quella di concrescenza. Scrive che entrambi gli autori «sostengono che attività e valore pervadono la natura», ma
non sottolinea la derivazione da Alexander della concezione whiteheadiana (V. LOWE, Alfred North
Withehead. The Man and His Work, The Johns Hopkins Press, Baltimore 1990, Vol. II, p. 174). In
Samuel Alexander. Naturalismo e democrazia delle cose, cit., ho dedicato un paragrafo all’influenza di Alexander su Whitehead, dimostrando come alcune intuizioni del filosofo di Sidney abbiano
senza dubbio anticipato una parte non trascurabile delle teorie di Whitehead (pp. 181-191).
17 S. ALEXANDER, Space, Time and Deity, cit., I, p. 13.
18 S. ALEXANDER, “Foundations and Sketch-Plan of a Conational Psychology”, British Journal of
Psychology, IV, Dicembre 1911, pp. 239-240.
19 S. ALEXANDER, Space, Time and Deity, cit., II, p. 118.
20 Ivi, p. 119.
21 Ivi, I, p. 24.
22 Ivi, p. 104.
23 Ivi, p. 140.
9
NOTE
10
93
LE PASSIONI TRA ETICA E POLITICA.
ANTIGONE NELLA LETTURA
DI FRANCESCA BREZZI
di Graziella Morselli
94
Davanti ad un tema di così vasta portata come quello che racchiude i molti
significati dell’Antigone di Sofocle, e che da secoli è alimentato da una sterminata letteratura, Francesca Brezzi (in Antigone e la Philìa. Le passioni tra etica
e politica, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 299) ha scelto di richiamarsi a quelle letture filosofiche (e poetiche) che rientrano nei contorni ben delineati del
suo progetto, così dichiarato nell’introduzione a questo libro: “intrecciare il problema etico e quello politico […] grazie ad una sorta di rivoluzione morale ed
antropologica, che giustifica la nostra ipotesi di presentare Antigone come figura della diversità e paradigma del conflitto, in vista di una prassi altra”. Una
prassi, vale a dire, che dallo scontro di personaggi e di valori rappresentato
nella tragedia di Sofocle porti a “pensare ad un possibile accordo che eviti l’esito tragico” (pp. 10-11). In vista di questa diversa prassi, Brezzi rivisita la figura
di Antigone seguendo e intrecciando le due maggiori direttive attuali del pensiero politico: da una parte quella d’ispirazione sociologica, che rifiuta gli assoluti della razionalità normativa e universalistica, e privilegia per contro il confronto e la negoziazione tra le differenti culture, dall’altra una direttiva d’ispirazione etica, secondo la quale lo spazio politico è dato dalla relazione tra le persone, è lo spazio dove esse mettono insieme le loro esperienze del dolore e
fronteggiano il male ricorrendo di volta in volta alle decisioni della saggezza
pratica.
Analogamente, anche nella tragedia di Sofocle è possibile vedere rappresentate le due istanze: l’una “esterna”, della ribellione politica e l’altra “interna”,
della rivoluzione morale e dell’apertura al soprannaturale: sotto il primo aspetto vi si può rinvenire l’origine delle fratture politiche e sociali, e sotto il secondo la rigenerazione della comunità, per opera di quanti mettono “in comune” il
loro cercar di risolvere i conflitti. Aristotele nella Poetica, come si sa, attribuiva
una funzione educativa al teatro tragico, dove gli spettatori sentivano ridestarsi in loro il ricordo delle sofferenze passate e provavano il bisogno di chiarire
quei fatti inconciliabili con la ragione, legati alla violenza delle passioni, contradditori ed estremi: dalla riflessione nascevano le sagge deliberazioni, condivise tra i cittadini.
In questa seconda direzione è significativo il ricorso dell’autrice al pensiero
di Paul Ricoeur, quale si evince in sintesi da questa citazione, tratta dal libro
Soi-même comme un autre (éd. du Seuil, Paris 1990): “Rifiutando di portare
una ‘soluzione’ ai conflitti che la finzione ha reso insolubili, la tragedia, dopo
aver disorientato lo sguardo, condanna l’uomo della prassi a riorientare l’azione, a suo rischio e a sue spese, nel senso di una saggezza pratica in situazio-
NOTE
ne che risponde al meglio alla saggezza tragica”. Tra i molti interpreti che Brezzi esamina nel suo percorso ermeneutico alla ricerca del senso del mito e della
tragedia, Ricoeur appare, infatti, come la sua più autorevole guida, e in particolare per l’analisi dell’Antigone sofoclea che si trova nel testo citato sotto il
titolo Le tragique de l’action, in apertura del capitolo 9 (ovvero del neuvième
étude).
E ancora a Ricoeur s’ispira l’autrice nel delineare il complesso rapporto di
distinzione-fusione tra poesia e filosofia, poiché secondo il filosofo francese la
tragedia greca ha la dimensione della non-filosofia, e tuttavia “funzione della
filosofia è l’appropriazione del nostro sforzo di esistere e del nostro desiderio
di essere, attraverso le opere che testimoniano di questo sforzo e di questo
desiderio” (De l’interpretation. Essai sur Freud, éd. du Seuil, Paris, citato da
Brezzi a p. 150).
Anche la religiosità si rapporta alla filosofia, secondo Ricoeur, poiché alla
nostra sensibilità di oggi la trascendenza appare accompagnata dalla dimensione simbolica del mito. Religiosità, mito e filosofia, sono i tre momenti essenziali attraverso cui il soggetto può comprendere se stesso1. Tale orientamento
fornisce a Brezzi il filo conduttore delle scelte nel vasto campo delle interpretazioni generate all’infinito dall’opera sofoclea. In realtà, piuttosto che di un
campo d’esercitazione ermeneutica e di dibattito, secondo l’autrice si tratta di
un’intricata foresta di miti, simboli, figure poetiche, categorie metafisiche, dove
ci sembra di non poter distinguere tra poesia e filosofia, teologia e ideologia,
anelito al soprannaturale e dettami di giustizia umana. Nei primi capitoli del suo
testo Brezzi illustra questi complessi rapporti tra mithos e logos, non solo con
un’accurata opera di composizione tra Aristotele (Poetica, Retorica, Politica,
Etica nicomachea) e Scheler, Jaspers, Ricoeur, Nussbaum, ma anche attraverso l’esame di filosofi più specificamente inclinati al linguaggio poetico, come
Heidegger, e Kierkegaard, o di un poeta come Hölderlin, la cui profondità speculativa risalta nelle Note all’Antigone.
Inoltrandoci nella lettura dopo il chiarimento introduttivo degli intenti e del
metodo, vediamo che il libro presenta una particolare struttura bipartita. Nella
“parte prima” sono trattati i filosofi della tradizione e della contemporaneità, in
quanto viste come sedi del pensiero maschile; della “parte seconda” sono protagoniste le filosofe che hanno fatto oggetto d’analisi al femminile la figura di
Antigone, con discussione del pensiero maschile al proposito, dando origine
ad una letteratura filosofica molto sviluppata e ancora in corso.
Nel complesso si delinea, così, un confronto tra filosofi e filosofe che percorre un lungo cammino analitico di interpretazioni della tragedia di Sofocle, e
in particolare della figura di Antigone, attraverso una quantità considerevole di
testi di filosofi. Da una parte, oltre a quelli sopra citati, emergono fra i tanti i
nomi di Hegel, Goethe, Nietzsche, e di studiosi contemporanei come l’inglese
G. Steiner, dall’altra parte prevalgono i nomi di María Zambrano, Luce Irigaray,
Marguerite Yourcenar, e quello già citato di Martha Nussbaum. Tutte pensatrici del nostro tempo, alle quali si possono affiancare i nomi di Hanna Arendt e
Simone Weil, che pure si sono occupate solo marginalmente di Antigone.
È evidente, in questa particolare impostazione, un intento propositivo, che
95
96
nel delineare la “figura della diversità” e l’idea di una “prassi altra”, apre la prospettiva verso le possibilità offerte dall’autonomia recentemente conquistata
dalle donne nel pensiero, nella visione del mondo, nell’elaborazione espressiva e riflessiva delle proprie passioni. In altri termini, da quella recente opera
femminile di trasformazione della società e della cultura cui Francesca Brezzi
si riferisce nell’introduzione, definendola “rivoluzione morale e antropologica”.
Ma recensire il libro dovendo districare una linea di svolgimento dell’esegesi
condotta dall’autrice, non risulta facile per la complessità con cui i diversi temi
vi s’intrecciano e per la quantità dei riferimenti testuali, delle citazioni, delle
note. Si tratta nell’insieme di un andare e venire dove la successione lineare
del tempo appare soltanto nel capitolo secondo, che traccia rapidamente una
storia delle interpretazioni di Antigone tra ottocento e novecento, sempre rapportate al mutare del clima politico in cui sono nate. Negli altri capitoli, invece,
seguendo un ordine non cronologico, ma interno al discorso, letture esegetiche e libere rielaborazioni intersecano richiami a filosofi e a letterati antichi e
moderni, come a filologi, poeti, teologi e psicanalisti. Rispetto a questo disegno
dalla trama compatta, anziché riassumere linearmente il contenuto mi sembra
più proficuo rivolgere l’attenzione all’ipotesi progettuale esposta nell’Introduzione, e seguire il suo dipanarsi fino a cogliere gli esiti cui approda. Il progetto di
Francesca Brezzi, come si è detto, consiste nell’interpretare Antigone come
figura della diversità di genere, che include anche quella dell’opposizione civile, politica, ideologica alle istituzioni: da tale configurazione intende ricavare le
premesse per delineare una prassi che porti a superare i conflitti.
Al riguardo della diversità di genere va notato anzitutto come in Antigone,
molto più (e molto più in alto) del suo essere donna, spicca la dimensione eroica, con tutto il carico dei miti di cui la tragedia greca l’ha rivestita. Proprio su
questa dimensione che la pone al centro della scena, non solo in rapporto con
il re Creonte, ma attorniata da molti personaggi, si sono misurati nei secoli sia
i commentatori, sia gli scrittori che s’ispirarono al personaggio, chi privilegiando il suo lato politico (della disobbedienza al tiranno) chi l’altro lato, quello
morale (dell’osservanza religiosa e dei valori familiari). Su entrambi i lati, questa figura ha rappresentato in forma letteraria i più duri scontri e grovigli di passioni, o in sede filosofica i nodi irresolubili delle tante contraddizioni che gravano sui rapporti umani; perciò fin dall’antichità la rilettura di questa tragedia di
Sofocle ha costituito il banco di prova d’ogni versione della problematica della
conflittualità.
Com’è noto, e come Brezzi ci ricorda con un lungo excursus nel capitolo
secondo, Hegel all’inizio dell’ottocento ha elaborato una sintesi delle tante
dicotomie presenti in questa problematica, sintesi che ancor oggi s’impone per
la sua insuperata forza dialettica. Per quanto riguarda, in particolare, il nostro
argomento, è a partire dalla dicotomia hegeliana uomo/donna che il punto di
vista critico della filosofia femminile si è sviluppato, prendendo la forma di un
confronto con il pensiero maschile a proposito di una differenza occultata o
cancellata proprio servendosi della figura di Antigone. Nel II volume della
Fenomenologia dello spirito 2, ampiamente citato da Brezzi, Hegel definiva il
femminile come elemento di eversione, in passi famosi come questo: “Il femi-
NOTE
nino, eterna ironia delle comunità, cambia co’ i suoi intrighi il fine universale del
governo in un fine privato”. Così il filosofo contrapponeva Antigone e Creonte
come due lati della sostanza etica, l’uno in rappresentanza della legge divina
insita nella coscienza l’altro in rappresentanza della legge scritta (rispettivamente il “senso infero racchiuso nel profondo” e “l’universale senso pubblico
esposto alla luce del giorno”)3. Affermando che le due leggi governavano l’una
la famiglia, naturale comunità etica e l’altra lo Stato, comunità umana istituita
(ovvero “il concetto privo di consapevolezza e tuttora interiore della effettualità
conscia di sé” e la “eticità che si forma e si mantiene lavorando per l’universale” )4 Hegel, al tempo stesso, impostava con la massima nettezza quegli insanabili contrasti tra privato e pubblico, coscienza singola e norma universale,
individuo e potere statale, che a partire dal regime patriarcale hanno eletto a
simbolo la dicotomia donna/uomo.
In modo alquanto sommario si può parlare dell’interpretazione hegeliana
come di un paradigma per il pensiero femminile, che nel lavoro di confutazione (o di dissoluzione) di quel simbolismo si è impegnato già a metà del novecento. Un punto che esso voleva particolarmente attaccare, a proposito delle
pagine ricordate della Fenomenologia, era quello di un dualismo dei sessi che
vi appare talora fondato sul predominio del maschile e l’inferiorità del femminile, talaltra sulla loro complementarietà.
Il dualismo, comunque, era per Hegel la conseguenza necessaria del movimento dialettico delle due essenze in conflitto: le due parti erano egualmente
colpevoli di aver rotto l’equilibrio della sostanza etica, e solo attraverso il riconoscimento della colpa sarebbero tornate a congiungersi. “Solo nell’eguale
assoggettamento di entrambi i lati si consuma e compie il diritto assoluto, ed è
sorta la sostanza etica come forza negativa che li inghiotte entrambi; è sorto
cioè il destino onnipotente e giusto” 5. Un finale, questo che, ancora secondo
Hegel, risponde al senso della giustizia morale “espresso nella maniera sublime nelle tragedie di Sofocle. Lì si parla del destino e della necessità; il destino
degli individui è rappresentato come un qualcosa di inconcepibile, ma la
necessità è riconosciuta come la vera giustizia” 6. Come si vede, si trattava di
un destino e di una necessità dettati dal sistema hegeliano, e intrisi, oltre che
dei concetti di colpa, sofferenza, riconoscimento, giustizia, di quell’afflato religioso che vi si connetteva alla visione idealistica dell’Assoluto.
Dopo Hegel la conciliazione tra gli opposti contendenti, ovvero tra le due
essenze in conflitto, non sarebbe più stata accettata, a motivo dello spirito di
ribellione proprio dell’età romantica e in seguito, nel novecento, delle dure
esperienze della resistenza alle dittature. Così le due posizioni di Antigone e
Creonte si radicalizzarono, e ne vennero interpretazioni sempre più raffinate e
complesse che Francesca Brezzi percorre con accuratezza, senza tralasciare
le figure degli altri personaggi minori e la presenza del Coro.
L’insieme dei conflitti che dividono queste figure sul piano politico, è centrato sul problema della fondazione della polis, sostiene l’autrice, che estende il
senso della sua osservazione ad ogni comunità umana e per ogni epoca, come
possiamo cogliere in queste sue parole: “Il conflitto delineato da Sofocle mantiene la sua perenne attualità proprio nel mostrare lo scontro tra codici arcaici
97
98
da un lato e una nuova razionalità dall’altro” (p. 87). Con questa collocazione
l’agire della nostra eroina appare anticipare i tempi, quasi a fondare future
modalità di azione politica che soltanto una donna poteva già sentire e rappresentare. Come dice Brezzi: “il richiamo della fanciulla alle leggi non scritte,
infatti, prefigura il lungo cammino, che il pensiero politico ha nel seguito compiuto, sui sentieri dei diritti individuali, della coscienza personale contro i divieti collettivi” (p. 88). Poche pagine dopo, è citata in questo senso l’osservazione di R. Rossanda circa la figura del figlio di Creonte, il giovane Emone innamorato di Antigone, che chiede al padre “di considerare Antigone una parte
della polis, un pensato diffuso e taciuto dal quale chi governa non può prescindere” 7 e in tal modo, sottolinea Brezzi, “affronta il nodo di fondo della democrazia” (p. 107) ovvero, secondo un passo della stessa tragedia, “la voce del
popolo che non giunge al potere” 8.
Dopo le Antigoni viste dalla parte maschile, considerate sia sotto l’aspetto dell’opposizione politica sia sul piano trascendente, per il carattere religioso che presentano i conflitti della tragedia, il confronto con le interpretazioni dalla parte femminile ci riporta all’immanenza. Ponendosi su questo piano, infatti, il pensiero
delle donne si è andato piuttosto a misurare con altre forme di trascendenza, proprie della sfera relazionale ed emotiva. Così nel breve scritto La tomba di Antigone, Maria Zambrano suggeriva l’affascinante metafora della caverna in cui, a
differenza del mito narrato da Platone, la figlia di Edipo discende volontariamente alla ricerca del senso della sua propria nascita e della “sua vita non vissuta, e
con essa la tragica vicenda della sua famiglia e della sua città”9. In questa caverna la vita esplode come “seconda nascita che è vita e visione nello speculum
justitiae“, visione sempre tesa verso la trascendenza, poiché l’essere umano è
sempre in divenire, sempre “sul punto di nascere” così come lo sono città e
comunità umane: “si direbbe che la radice stessa dell’Occidente sia la speranza
della Nuova Legge, che non è soltanto l’intimo motore d’ogni sacrificio ma si
costituisce in Passione che presiede la storia”10.
Di una seconda nascita, in quel luogo della “passione inaugurale dell’amore, dell’arte, del pensiero” che è la filosofia, avrebbe parlato anche la pensatrice francese Luce Irigaray, intendendola come “nascita ad una trascendenza,
quella dell’altro, ancora sensibile, ancora fisica e carnale, e già spirituale”11.
E Martha Nussbaum avrebbe insistito, nella sua opera La fragilità del bene12,
sull’unione di emozioni e ragione, e su quella “sensibilità verso il mondo” alla
quale una buona deliberazione non può che connettersi. La filosofa americana
rimarcava, nella sua rilettura della Poetica e dell’Etica Nicomachea, come Aristotele attribuisse all’arte tragica il merito di rappresentare la vulnerabilità dell’essere umano, inducendo il pubblico a riflettere sul conflitto delle passioni che ne scaturiva, e a cercare la soluzione dei problemi morali attraverso l’accordo, frutto di
saggezza pratica. A suo avviso il nodo di eventi fatali, di emozioni e di opposte
rigidità, di errori e di inevitabili scontri, che Sofocle ha saputo esprimere con stile
di sublime poesia, segnala quella “illimitata contingenza” che è impossibile comporre e armonizzare come voleva Hegel, ma che, ammoniva la filosofa americana, dobbiamo fronteggiare tramite quella philìa, quella forza empedoclea che
lega insieme i diversi, e sulla quale soltanto può fondarsi una comunità.
NOTE
Ma qui viene da osservare che nel senso aristotelico la philìa è l’amicizia tra
i cittadini, pari di natura e di condizione, cui è demandato di stabilire le norme
della città: nulla a che fare, quindi, con le sofferenze e le passioni condivise,
con l’accordo che supera le differenze, con una politica che sorga dal confronto e nella composizione tra ragioni diverse. Il concetto di philìa, peraltro, è inteso da Nussbaum in senso di politica attuale, in quanto riferito alla condivisione
dei valori su cui può fondarsi la legge, e quindi riportato alle esperienze dei
nostri giorni, ad esempio laddove è riferito ai rapporti di amicizia, desiderio e
legame affettivo, cui si accompagnano il reciproco rispetto, la considerazione
dell’indipendenza dell’altro, l’amore che mira al suo bene.
Tuttavia (e su questo punto del testo in esame vediamo prevalere il pensiero di Francesca Brezzi) proprio dal concetto di philìa è possibile trarre la chiave di volta per capire il valore del gesto politico di Antigone, che è al tempo
stesso gesto di eversione e di ristabilimento della giustizia. Per chiarirlo, è
d’obbligo il ricorso agli scritti di studiose come M. Calloni, E. Pulcini, A. Putino,
F. Duroux, M. David-Jougneau. In analogia con le loro stesse pratiche, esse
colgono in quel gesto un duplice senso: la denuncia della discriminazione delle
donne, non appartenenti alla comunità dei phìloi, dalla scena politica della
città, e la ricerca di un nuovo legame con la stessa città. Come ha scritto Virginia Woolf, le giovani del suo tempo che protestavano “volevano come Antigone non violare le leggi ma trovare la Legge”13.
Ma quale possibilità aveva, come donna, di riscrivere quella Legge che può
solo rifulgere in un orizzonte proteso al di là della famiglia e della patria? Il pensiero di Adriana Cavarero implica una risposta negativa a questo interrogativo:
secondo lei Antigone “del tutto antipolitica, ha la funzione di comparire come
un’alterità radicale, sia nei confronti dell’Atene democratica, sia della polis tirannica […] umana corporeità e identità femminile, dunque nell’Antigone, insieme
si tengono in un solo tremendo e impolitico concetto”14. Nel riportare questa citazione, e nel concludere la sua dimostrazione della tesi di una diversa prassi politica, aperta dalla rivoluzione morale e antropologica che le donne stanno realizzando, Francesca Brezzi si dice di diverso avviso. Sottolineando la corrente
“confusione tra la Legge e l’esercizio del diritto e della giustizia” ingenerata da
molti malintesi (p. 283), essa nota che, “se il diritto mette l’accento sulla responsabilità del soggetto colpevole, il gesto ‘ribelle’ di Antigone mostra un’altra
dimensione dell’essere umano, quella di essere sorgente, fonte di diritto, non
perché inventa il contenuto, ma perché manifesta con un atto un altro ordine,
più giusto dell’ordine primitivo” (p. 285), e occorre aggiungere che lo mostra
come dimensione di tutti, senza differenza di sesso. Il fondamento di questo
diverso ordine è nel concetto aristotelico di equità, e il suo nome era già noto ai
Greci che, prosegue Brezzi citando Hanna Arendt, “chiamavano filantropia questa umanità che si realizza nel dialogo dell’amicizia, poiché essa si manifesta
nella disponibilità a condividere il mondo con altri uomini”15. Questa citazione
racchiude il monito che possiamo ricavare dalla frequentazione dei testi antichi,
poiché oggi, conclude Francesca Brezzi, a noi tutti tocca far rivivere la philìa,
sebbene si viva in un mondo più che mai lacerato da ostilità e divisioni senza
fine, e proprio perché, sofferenti e disorientati, condividiamo questa vita.
99
100
1 Dei testi di P. Ricoeur, in particolare dei più recenti, è fatta ampia menzione nel testo in
esame. Si veda, oltre alle pagine del capitolo primo, cui mi sono riferita fin qui, tutto il quinto, e inoltre altri riferimenti e citazioni in diversi capitoli.
2 G. F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, 2 voll., Göbhart, Bamberg 1807, tr. it. La Nuova Italia, Firenze 1995, p. 34.
3 Ivi, p. 24.
4 Ivi, p. 9.
5 Ivi, p. 30.
6 ID., Lezioni di filosofia della religione, 2 voll., in Hegels Werke, Berlino 1832-45, tr. it. Zanichelli, Bologna 1974, vol. II, p. 140.
7 R. ROSSANDA, Antigone ricorrente, in: SOFOCLE, Antigone tr. it. Feltrinelli, Milano 1987, p. 40.
8 SOFOCLE, Antigone, vv. 693-700.
9 M. ZAMBRANO, La tomba di Antigone, 1983, tr. it La tartaruga, Milano 1995, p. 48.
10 Ivi, p. 46.
11 L. IRIGARAY, Etica della differenza sessuale, ed. Minuit, Paris 1984, tr. it. Feltrinelli, Milano
1985, p. 67.
12 M. NUSSBAUM, La fragilità del bene, Cambridge University Press, 1986, tr. it. Il Mulino, Bologna 1996.
13 V. WOOLF, Le tre ghinee, London 1938, tr. it. Feltrinelli, Milano 1975, p.181.
14 A. CAVARERO, Corpi in figure, filosofia e politica della corporeità, Feltrinelli, Milano 1985, pp.
18-20.
15 H. ARENDT, L’umanità e i tempi oscuri. Riflessioni su Lessing, in “La società degli individui”,
I, 2000, p. 24.
INDIVIDUALISMO ED UNIVERSALISMO
NEL PRIMO LEIBNIZ
1. La vocazione nominalistica e l’universalità della metafisica
«Sicuramente la problematica dell’individuo –ha scritto con efficacia Giovanni Aliberti– è solo un aspetto della produzione filosofica di Leibniz, ma sembra
essere efficace per cercare di fare ordine in quel labirinto di idee: la sua intelligenza potrebbe essere una delle chiavi per comprendere in quale modo sia da
considerare il sistema leibniziano»1. Tale indicazione permette di focalizzare
l’attenzione su un concetto arduo e sfuggente come quello di individuo, che trae
le mosse dalla fiducia critica giovanile leibniziana verso la tradizione del nominalismo e finisce con il configurarsi come un ‘termine singolare collettivo’, alla
definizione del quale contribuiscono riflessioni di varia natura, dall’idea di formulare un linguaggio universale all’organizzazione di un’enciclopedia fondata sulla
logica inveniendi, dalla definizione delle tecniche combinatorie alla matura
monadologia. Né va dimenticato che la fiducia critica dimostrata da Leibniz
verso la tradizione logico-metafisica dell’individualismo convive con un altrettanto definito affidamento nei riguardi dell’universalità della metafisica.
Infatti, riflettere sulla determinazione individuale significa, anzitutto, per Leibniz, ingaggiare una sistematica revisione dei rapporti con la ‘scienza dell’essere’.
Lo conferma il confronto con l’annoso problema del principio d’individuazione di
scolastica memoria nella Disputazione di baccellierato, dal titolo De principio individui, discussa a Lipsia nel 1663. Non poteva essere altrimenti, visti gli auctores
che, a suo stesso dire, ne condizionarono la prima formazione: Zabarella, Rubio
e l’aristotelismo padovano, da un lato; Fonseca e Suárez, dall’altro2.
Una delle questioni legate all’articolato intreccio di interessi logici e metafisici negli anni giovanili è l’adesione al nominalismo, sinonimo, per Leibniz, di
individualismo metafisico e di terminismo logico3. Com’è noto, la logica nova
degli scolastici aveva negato la realtà ontologica dell’universale, riconoscendo
l’individuo in entitate tota come unica realtà metafisica concepibile nonché
come notio completa e termine logico semplice di combinazione. «Il nominalismo –precisa Carlo Giacon– si caratterizza come reazione all’astrattismo e
come affermazione di una realtà attinta intuitivamente»4. Tale tradizione filosofica aveva, inoltre, gettato i presupposti di una moderna concezione empiristica della realtà, non ultimo attraverso l’utilizzo in chiave gnoseologica del principio logico-ontologico di ‘economia’, altrimenti noto come teoria del «rasoio»
di Ockham (entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem)5: dimensioni
critiche, queste, dotate di un «aspetto profondamente rivoluzionario»6 e tali da
porre il nominalismo «alla radice del movimento scientifico moderno»7.
NOTE
di Sandro Ciurlia
101
102
Parlare di nominalismo come temperie culturale dalla quale Leibniz trae
fecondi spunti di meditazione partecipandovi significa leggere il suo primo pensiero come la celebrazione del trionfo del metodo analitico attraverso cui si
coglie l’individuo-termine. Quando si colloca Leibniz nel solco del tradizione
analitica, si allude a quel diffuso riesame secentesco «delle funzioni del pensiero alle quali la filosofia affida ogni sua possibilità», perseguito proprio
mediante il metodo dell’analisi, che permette «con rigorosa precisione la riduzione progressiva di ogni dato conoscitivo sino alla massima semplicità possibile»8. Una simile impostazione consente di risalire ai grandi poli speculativi
d’influenza posti a monte delle sue meditazioni: Suárez e Hobbes. Si tratta di
autori che soddisfano, per Leibniz, precise esigenze critiche, la cui opera costituisce un costante punto di riferimento nel confronto con la tradizione e con le
sfide lanciate dai problemi aperti del suo tempo. Nel loro pensiero, Leibniz
vede concentrati, inoltre, gli echi di esperienze speculative con cui egli si era,
in quegli anni, variamente confrontato.
Al primo si deve una vigorosa meditazione sul tema dell’individuo. Non si
tratta piú, però, secondo Suárez, d’intendere la determinazione individuale
all’insegna di una duplice negazione (della molteplicità e dell’ulteriore scomponibilità), raccolta nel prefisso verbale del termine in-dividuum, quanto di declinarne il concetto all’insegna della categoria di relazione. Infatti, l’identità del
singolo è tale solo se distinta da ogni altra. Il processo d’identificazione passa,
dunque, attraverso il confronto con la differenza, con l’‘altro’, che esiste, anzi
deve ammettersi, affinché ciascuna identità possibile possa dirsi esistente.
Qui, Suárez dimostra di aver fatto proprie le posizioni nominaliste, sulla scia
delle quali diviene possibile definire l’individuo come l’unico ens reale cui attinge la metafisica per definire i principî della realtà. Ne discende un’idea di
«mondo» come sistema di relazioni tra entità definite9.
L’individualismo leibniziano si accresce e si problematizza, inoltre, a sèguito dello studio della filosofia di Hobbes, pensatore, con tutti i suoi motivi, davvero onnipresente entro l’intero arco della produzione leibniziana. È il taglio
convenzionalista del razionalismo hobbesiano a sorprendere ed affascinare
Leibniz. Com’è noto, Hobbes intende il ragionamento come una forma di calcolo di concetti semplici che si esprime attraverso il linguaggio, órganon dell’argomentazione razionale e, se preso in sé, insieme di segni convenzionalmente stabiliti. La parola-segno, nella funzione logica del giudizio, significa le
cose, consente di astrarre dal particolare concreto sino a permettere di ragionare su concetti quali genere e specie. La scienza diviene, cosí, scire per causas e si dispone ad indagare la natura degli oggetti determinabili10.
In sintesi, il convenzionalismo linguistico, la concezione del ragionamento come
calcolo, mediati da Hobbes; la vigile attenzione per l’individuo, la persuasione di un
nuovo e raffinato ruolo da attribuirsi alla logica, l’idea di una categoria di relazione
intesa ad esprimersi mediante uno schema di calcolo di combinazioni sintetiche di
parti semplici, idee, queste, in larga parte attinte a Suárez ed alla tradizione nominalista, costituiscono il prezioso apparato di matrici speculative a cui bisogna riferirsi per comprendere a cosa pensi Leibniz quando parla di nominalismo.
Gli echi di simili influenze s’avvertono sin dalle prime opere: tra queste, soprat-
NOTE
tutto, la citata e spesso trascurata Disputazione di baccellierato. Com’è noto, la
questione dell’individuazione era sorta in seno al dibattito, sollevato da Porfirio11,
sullo statuto ontologico degli universali ed aveva alimentato una secolare controversia. Dopo aver delineato le dimensioni del problema, Leibniz espone la tesi
secondo cui le sostanze create non rintracciano il loro principio d’individuazione
né nella materia signata di Tommaso, vale a dire «designata» a fondare la realtà
metafisica dell’individuo12, né nella forma di Scoto, che dà origine all’ecceità della
determinazione individuale mediante una «contrazione fondamentale» della
materia13. Leibniz dimostra con chiarezza di aderire all’ipotesi nominalista, secondo la quale si deve negare la realtà metafisica dell’universale, riconoscendo l’individuo come unica determinazione ontologica concepibile. Egli si orienta, però,
verso una soluzione nominalista piú sfumata, volta a cogliere logicamente l’individuo «per negationem adiunctam»14, proprio come aveva asserito Suárez meditando l’Ockham. Resta il problema delle fonti. Nella Disputazione, il riferimento a
Ockham è sempre indiretto. In realtà, Leibniz si nutre di filosofemi della tradizione
dell’occamismo, quasi tutti tratti dal De principiis rerum naturalium di Benedetto
Pereira15. L’altra fonte è proprio Suárez. Ad ogni modo, tutto ciò testimonia la realtà di un’adesione, quella di Leibniz al nominalismo, che finisce con il rintracciare
una soluzione al tema dell’universale colta per via prioritariamente logica.
Per Leibniz, infatti, è preziosa la disinvoltura con cui il nominalismo ha
dimostrato di superare le formidabili complicazioni teologico-metafisiche in cui
andavano ad imbrigliarsi le altre positiones. È opportuno, dunque, nel complesso, pensare a quella leibniziana come all’adesione ad un nominalismo
moderato, frutto dell’influenza combinata di Suárez, Fonseca, del Soncinate e
del riflesso, diretto ed indiretto, proveniente dai primi influssi del pensiero di
Hobbes16. Tantomeno è trascurabile l’influenza dell’aristotelismo luterano del
Thomasius17, il cui equilibrio storico ed acume critico ebbero a caratterizzarsi,
per Leibniz, come i termini di una fondamentale lezione di metodo e di un
atteggiamento di riguardo verso la tradizione, specie quella formale in logica,
che lo accompagnerà per tutta la vita. Ne discende un nominalismo scaturito
dalla circostanziata discussione dei limiti e delle inesaurienze logiche di ciascuna delle piú autorevoli posizioni sul campo.
Per una conferma, si pensi anche solo al procedimento argomentativo leibniziano, fondato, in quest’opera, sul metodo della quaestio disputata: posta una tesi,
segue la discussione dei contrastanti giudizi sul suo valore. Ciò sino al progressivo crescendo degli argumenta in contrarium, al culmine dei quali risulta scaturire
da una sorta di implicita esigenza il passaggio alla positio successiva. La tesi
nominalista, però, costituisce sin d’ora un provvisorio punto d’arrivo non in quanto l’unico o il solo, ma soltanto come il piú duttile o, meglio, il piú euristico tra quelli messi a punto dalla tradizione filosofica. Del resto, in un frammento del 1686,
ripensando agli anni giovanili, Leibniz aveva asserito: «Nec hactemus alium video
modum evitandi hos scopulos, quam si abstracta non ut res, sed ut compendia
loquendi considerem […] et eatenus sum nominalis, saltem per provisionem»18.
Una professione di fede nominalista, dunque, assai duttile, registrata «per
misura precauzionale», quantunque assai problematica, perché convive con
un «moderato realismo»19: lo dimostra il Corollario III a chiusa della stessa
103
Disputatio. Scrive Leibniz: «Essentiae rerum sunt sicut numeri»20. La proposizione esprime un’uguaglianza (sicut). L’identità tra i due termini dell’enunciato
permette di sostenere che il numero stesso è «essenza», pertanto la sequenza numerica risulta dotata di immutabile coerenza interna, perché reale. Trattandosi di una tautologia, si deve sostenere che, galileanamente, la realtà si
esprime in un linguaggio fatto di numeri. Detto altrimenti: il numero è sostanza, partecipa di un mondo di forme, non è solo un segno designante la quantità. Inoltre, se la «materia» e la «quantità» sono «realmente la stessa cosa
(realiter idem)»21, si pone l’esigenza di applicare la scienza dei numeri, la
matematica, alla descrizione dei fenomeni naturali, essendo, gli enti fisici, in
considerazione della loro stessa dimensione materiale, parametrizzabili. Da
questo punto si diparte quel platonismo aritmologico tipico del Leibniz maturo,
su cui si fonda la sua concezione del calcolo logico e numerico.
2. La ricerca dell’unità del linguaggio e dell’universalità della Scienza
104
L’individualismo metafisico che si ricava dall’opera del 1663 diviene anche sinonimo di terminismo logico nella sezione introduttiva della Nova methodus (1667)22.
Qui egli fa leva sulle proprie riflessioni in merito alle tecniche combinatorie e ripensa all’insegnamento hobbesiano intorno al carattere calcolativo del ragionamento,
alla volta del perseguimento di una compiuta logica inveniendi da mediarsi, in sede
gnoseologica, con il sensismo del filosofo inglese23. Precisa, al riguardo, Corsano
come «l’accostamento al sensismo hobbesiano avesse il còmpito di condurre a termine l’erosione dei presupposti metafisici e antropologici, apparentemente scampati alla già avanzata riforma suáreziana»24. Non solo. Meditare Hobbes equivaleva, piú in generale, per il Leibniz di questo periodo, a riflettere su quella fisica del
continuo al centro sin d’ora della sua speculazione logico-matematica e delle sue
riflessioni sulla struttura logico-meccanica dell’universo.
La filosofia di Hobbes rappresentava, inoltre, un’occasione di confronto, tra
riserve e consensi, con la tradizione gnoseologico-metafisica classica. E se,
agli occhi di Leibniz, Hobbes fornisce un sicuro metodo, Suárez si rende corresponsabile di un atteggiamento sempre piú critico nei riguardi di quell’atomo
che la ragione analitica scorge e doma, ma dinanzi a cui presto sarà costretta
a rassegnarsi a non poter mai penetrare.
Se letta in tal senso, l’operetta del 1667 completa ed esalta il punto di vista
già esposto da Leibniz, l’anno prima, nella celebre Dissertatio de Arte Combinatoria, nella quale trova espressione il primo dei tanti –ed a piú riprese perseguiti– progetti di Caratteristica universale. Com’è noto, si tratta del tentativo di
elaborare un alfabeto logico del pensiero umano ed uno schema integrato di
tutte le combinazioni possibili, redatti allo scopo di determinare le premesse a
fondamento di una lingua universale incentrata sul calcolo logico di concetti25,
priva d’interferenze contenutistiche e retta da una sintassi logica coerente e
rigorosa26. Il modello è il linguaggio formalizzato della matematica27. L’idea
della combinabilità dei termini semplici trova in Leibniz un vigoroso impulso
anche d’ordine ontologico a sèguito della meditazione dell’opera di Johann
NOTE
Heinrich Bisterfeld28 e dalla sua concezione olistica –e neoplatonica29– della
realtà individuale30. Come in un organismo vivente, infatti, ogni elemento assume uno specifico significato solo in relazione alla totalità organica del sistema,
cosí il termine bisterfeldiano di immeatio rende bene l’esigenza della compenetrazione tra parti e della loro subordinazione al tutto, secondo un ideale di
unità armonica di tutte le possibili determinazioni individuali.
La Caratteristica si colloca in un quadro teorico in cui confluiscono temi di
natura logico-linguistica, ma anche cabbalistica e teosofica, entro quella ricerca della lingua perfetta che discende strettamente dalle tradizioni del lullismo
e dei poligrafismi universali secenteschi31. A tal riguardo, Frances A. Yates ha
richiamato l’attenzione sulla rappresentazione iconografica posta in apertura
della Dissertatio: «Il diagramma con cui si apre quest’opera, in cui il quadrato
degli elementi è unito con il quadrato logico di opposizione, mostra la sua perfetta conoscenza del lullismo come logica naturale»32. Del resto, il termine
«combinatoria» era stato già utilizzato da Bruno nel De specierum scrutinio
(1588) per indicare l’Ars di Lullo. Per Leibniz, la Caratteristica rimane, però, in
principal luogo, un sistema di tecniche di calcolo linguistico, secondo un metodo affine a quello di Dalgarno33, ma fortemente influenzato da Kircher34 e dall’intera tradizione mnemonica35, e, in piú, deciso a proporre un articolato disegno di formalizzazione. Infatti, «le lingue ordinarie sono soggette ad innumerevoli equivoci, né possono essere impiegate per il calcolo» senza riferirsi ai
«segni impiegati dagli aritmetici e dagli algebristi», in modo da rendere «ogni
errore mentale […] lo stesso che un errore di calcolo»36.
Quest’ultimo punto è davvero di rilievo: risulta ancora condivisibile –lo ha
ricordato Paolo Rossi37– l’idea di Couturat secondo cui il primo intento di Leibniz nel pensare alla Caratteristica non risiede tanto nel progetto di calcolo logico, quanto nella necessità di una formalizzazione del linguaggio ordinario in
direzione del linguaggio universale38. Ne costituisce conferma la costante
attenzione leibniziana per i «dizionari numerici», nei quali il numero assume
una preziosa funzione denotazionale e semantizzante. In tal modo, Leibniz
ritiene di poter individuare, come si comprende sin dal lungo sottotitolo del De
Arte Combinatoria, gli spazi di espressione di un’ars inveniendi tale da divenire integrativa della teoria classica del giudizio39.
La Combinatoria trova il proprio suggello nella determinazione di una
«Scriptura Universalis […] cuicunque legenti […] intelligibilis»40, la quale è da
Leibniz presentata come «Porisma seu usus XI» della medesima logica combinatoria. Dopo aver accennato a Gaspar Schott41, Kenelm Digby42, Johann J.
Becher43 ed al celebre Athanasius Kircher, Leibniz espone il metodo generale
secondo cui «scribantur […] quae ab omnibus intelligi debent, numeris, et qui
legere vult, is evolvat in lexico suo vernaculo vocem dato numero signatam, et
ita interpretabitur»; chi scrive, invece, «necesse est […] et vernaculam et latinam tenere, et utriusque lexicon evolvere»44.
La codificazione del linguaggio universale non destituisce di senso, tuttavia,
le lingue naturali. Infatti, per un verso è lo studio delle analogie e delle costanti presenti al fondo dell’intelaiatura morfologico-sintattica delle lingue d’uso a
condurre all’impianto sintattico dello stesso linguaggio universale; per l’altro, gli
105
106
idiomi naturali conservano il ruolo di fondamentale mezzo di comunicazione,
esprimono l’originaria tensione emotiva con cui gli uomini hanno vissuto il
mondo e, dinanzi al linguaggio universale come linguaggio della scienza, assumono una funzione divulgativa. Dunque, è dallo studio comparativo delle lingue che si giunge alla prospettiva dell’unità del linguaggio45.
Il linguaggio universale diviene, a sua volta, lo strumento per realizzare
l’unità enciclopedica del sapere nel segno della Scienza generale, che costituisce l’elemento piú elevato di realizzazione del progetto della Caratteristica.
Tra i cultori dell’unità del sapere a cui Leibniz s’ispira vi sono gli enciclopedisti di Herborn46, in particolare Alsted47 e Comenio48, i quali erano convinti che
l’ideale della circolarità della conoscenza traeva le proprie mosse e celebrava
il misticismo pansofico del lullismo. Un sapere simmetricamente organizzato,
infatti, dall’orbis sensualis all’orbis intellectualis, sarebbe stato lo specchio dell’armonia dell’universo, l’elogio dell’onnipotenza divina e la celebrazione della
dignità ontologica dell’uomo49.
L’unità del linguaggio, inteso a realizzare l’unità della conoscenza, riflette e
celebra la simmetrica unità dell’universo, che da macchina diventa sistema di
relazioni. Caratteristica, enciclopedia, giustificazione logico-ontologica dell’universale si raccolgono nell’alveo della Scienza generale, la quale conduce alla
«saggezza», vale a dire alla «perfetta conoscenza dei principî di tutte le scienze e dell’arte di applicarli»50. La Scienza generale, nel trovare i «principî inventivi»51 delle singole scienze, diviene un momento di chiarificazione metodologica, uno strumento di coordinazione dei risultati raggiunti da ciascuna. Cosí, si
risponde ai dettami dell’ars inveniendi e si fonda un’autentica «enciclopedia
dimostrativa», capace di redigere una planimetria degli obiettivi euristici ancora da cogliersi. Questo percorso critico è legato ad un ultimo passaggio. Per il
Leibniz della piena maturità, esiste un luogo deputato a garantire il trionfo della
Scienza ed a guidare le ricerche di quei sapienti disposti a pensare in nome
del progresso del genere umano: l’accademia, a cui spetta il còmpito di fondare la società universale della conoscenza52.
3. L’individualismo nominalistico come modello metodologico
V’è, dunque, un complesso articolarsi, nel giovane Leibniz, di un duttile
nominalismo, volto a far leva sull’individuo-termine, e di un’ontologia del linguaggio universale. La Mathèsis universalis, però, pur essendo insieme un
progetto solo in parte realizzato ed un ideale regolativo, è molto piú che un
semplice sinonimo di quel calcolo logico di concetti persèguito a partire dall’opera del 1666. L’idea stessa della Caratteristica, infatti, coordinando le giovanili convinzioni nominalistiche, la tradizione lulliana della Clavis universalis e
la tecnica delle complexiones, costituisce un raffinato modo di riappropriarsi
delle ragioni della metafisica attraverso un rinnovato approccio alla logica.
Cosí, l’universalismo neoplatonico di Leibniz può essere interpretato come lo
strumento che lega tanti motivi speculativi e come una sorta di proficuo prezzo da pagare alla tradizione metafisica per rendere compiuta l’idea del calcolo
NOTE
logico. In quest’ottica, l’ispirazione neoplatonica che alimenta l’universalismo
del periodo della Dissertatio assume un’estensione piú ampia e definita rispetto alla stessa componente lulliana che aleggia sullo sfondo.
Il calcolo, in tal modo, per quanto si serva di sistemi segnici convenzionali,
come aveva insegnato Hobbes, tende a conferire a sé una superiore finalità
ontologica, determinandosi come un sistema di relazioni legittimato da una
solida fisionomia sintattica. La Dissertatio rappresenta, in questo senso, il vero
modello del razionalismo analitico giovanile leibniziano. L’idea di atomo logico
porta a compimento sia la lezione hobbesiana relativa alla teoria della computatio, sia l’invito (ontologico) suáreziano a considerare il carattere fondativo
della categoria di relazione. Ciononostante, rimane una sfuggente piattaforma,
quella delle numerose e convinte allusioni all’universalità della metafisica sparse negli scritti di questo primo periodo, che rende assai problematico tanto l’individualismo logico del De Arte Combinatoria, quanto la disinvoltura terministica dimostrata da Leibniz nei brevi scritti del decennio successivo. Per il verso
opposto, tale sensibilità ontologica non va nemmeno oltremodo enfatizzata, dal
momento che lo schema calcolativo delle complessioni sarebbe addirittura
impensabile se disgiunto da quell’individualismo logico che rappresenta una
delle impronte dai contorni piú definiti della filosofia del giovane Leibniz.
Uno dei tratti piú impervi dell’opera leibniziana è quello relativo all’interpretazione del «passaggio» dalla produzione giovanile ai tratti metafisici del pensiero
maturo. A questo punto, l’adesione al nominalismo costituisce una parentesi
ormai chiusa? O, piuttosto, ora presenta caratteri di piú specifica singolarità?
Per focalizzare la questione è utile riferirsi all’opera che introduce ai grandi
temi della piena maturità speculativa: la lunga Prefazione (1670) all’Antibarbarus
(1553) dell’umanista italiano Mario Nizolio. Questo testo offre spunti di grande
interesse, pur nel solco di una sostanziale continuità di vedute rispetto agli scritti
precedenti. Leibniz vi ribadisce la propria fiducia nella logica come «scienza dei
principî» e, in quest’ottica, trova luogo un significativo riferimento al valore metodologico del nominalismo, trionfo del metodo analitico e lucida guida critica nell’indagine dei fenomeni della natura53. Leibniz ne traccia anche una storia, al vertice
della quale colloca, accanto ad Ockham, sia Suárez, sia Hobbes54. Tutto ciò in
funzione del ritornare a riflettere sul tema dell’universale. Sottoponendo a radicale critica la concezione «collettivistica» dell’universale proposta dal Nizolio, Leibniz propende verso un’idea «distributiva» dello stesso, tale da evitare astratte ipostatizzazioni ed a favore, invece, di una valutazione di questo concetto quale
sistema di relazioni tra determinazioni individuali55.
Cominciano, però, proprio in quest’opera, a manifestarsi i primi segni di un
certo distacco dal nominalismo di maniera per il sopraggiungere di nuovi interrogativi sulla natura del linguaggio: in quale misura i segni condizionano il
ragionamento ed in qual senso andrebbe intesa la verità se la si ritenesse
dipendente dalla mera volontà del singolo? Qual è il valore di verità dei segni?
In qual senso d’essi è possibile proporre un calcolo? Può il linguaggio definirsi un’immagine logica dei fatti56? E, ancora, qual è la natura delle regole che lo
governano? Il Dialogus del 1677 si fa carico di un simile orizzonte problematico e costituisce un punto di svolta: se è ritenuta ancora agevole la teoria del-
107
108
l’accordo convenzionale sui significati e sui procedimenti di denotazione tesi a
connettere il signum alla res, ha pure da ammettersi –scrive Leibniz– un «qualche ordine che conviene alle cose», legato non tanto alle parole che ne esprimono le rappresentazioni, vincolate come sono al pensiero, quanto all’intima
natura della «loro connessione e […] flessione»57.
Questo rigurgito realistico non pone in ombra quella mentalità terministica che
proviene da molto lontano. Ne è testimonianza la cosiddetta teoria della substitutio logica dei termini dell’enunciato in quanto retti da una relazione di equipollenza. Solo raffinando il terminismo logico, infatti, si rende possibile un’adeguata teoria della dimostrazione fondata sulla convertibilità logico-semantica degli elementi categorematici del discorso. In una comunicazione a Con ring del 1678, il filosofo di Lipsia ribadisce la superiorità dell’analisi rispetto allo spirito sintetico, definendo il metodo analitico come la ricerca dei principî di un ragionamento a muovere dalle conclusioni cui si è giunti. Perciò, esso s’incentra sul procedimento di
calcolo logico delle proposizioni, fa uso di «mere equazioni, ossia di proposizioni
convertibili», nel senso che, dato un enunciato nella forma soggetto-predicato,
dev’essere ammessa la reciproca convertibilità dei suoi elementi sulla base del
duplice assunto della loro medesima estensione semantica e della loro congruenza. Questo procedimento fonda la Scienza, costituendone la struttura logica58.
La teoria della substitutio promuove, inoltre, l’esigenza di stabilire un’equa
relazione tra pensiero, linguaggio e realtà. Infatti, se, cartesianamente, idea è
rappresentazione, cosa garantisce l’adeguata corrispondenza dell’idea stessa
alla cosa e secondo quali ragioni di legittimità, data la res, il pensiero ne elabora una veritiera rappresentazione? A questi quesiti Leibniz tenta di offrire
una risposta nelle Meditationes de cognitione, veritate et ideis (1684), occasionate dalla polemica tra Arnauld e Malebranche circa la natura delle idee. L’argomentazione è lineare: deve dirsi provvisoria ogni «definizione nominale»
delle cose, in quanto destinata a coglierne solo l’involucro esteriore; è necessario, piuttosto, proporre una «definizione reale»59, intesa a disvelarne l’essenza autentica, all’insegna di una posizione complessiva definita da Corsano
«realismo critico»60. Il tutto viene considerato come una «risposta» a Hobbes.
Leibniz aspira, ormai, ad un deciso passaggio di piano: recare al cospetto del
pensiero la res, non piú solo il nomen che la designa.
Con la definizione reale si è ormai alle soglie di una fase di pensiero dominata da preoccupazioni metafisiche, ma non certo a discapito della logica. La definizione reale stabilisce solo la possibilità logica di una cosa, non la sua dimensione
ontologica. In ragione di ciò, è reale solo quanto risulta possibile per il pensiero in
quanto esprimibile nel giudizio: l’ontologia, dunque, passa sempre al vaglio dell’analisi logica, in una sintesi critica che non ammette giudizi di priorità. Nel frattempo, s’infittisce il confronto critico leibniziano con le opere di Cartesio, del quale
inizia a commentare gli assunti, con gli scritti di Locke, da cui trarranno origine i
Nuovi Saggi sull’intelletto umano, e con Pascal, la cui critica del procedimento
dimostrativo praticato dalla geometria lo condurrà ad una ridefinizione dei termini
del proprio razionalismo nel segno di una piú decisa impronta realistica.
Come si può osservare, dunque, quando si studia il problema delle convinzioni nominalistiche giovanili leibniziane si affronta un tema multiverso, ma anche
NOTE
carsico: per un verso, il nominalismo costituisce un appiglio a cui si aggrappa lo
spirito analitico leibniziano dinanzi alle sfide ed alle formidabili difficoltà del realismo onto-gnoseologico classico; per l’altro, è un modo per rendere operativa la
Combinatoria, per dare un sostegno al calcolo proposizionale, come si arguisce
dalla teoria della substitutio, ma anche per battere in breccia il convenzionalismo
hobbesiano e dare sanzione alla relazione pensiero-linguaggio volta ad esprimersi nella categoria logico-ontologica della possibilità, formulata nelle Meditazioni. Si tratta, in fondo, come suggerisce Mugnai, di un «atteggiamento di cauto
disimpegno»61 onto-metodologico, secondo la massima del cosiddetto «rasoio»
di Ockham. Seguendo quest’itinerario, si getta anche luce sul fenomenismo degli
anni in cui s’inaugura la fase monadologica62.
In questo senso è possibile sostenere, inoltre, che, per Leibniz, nominalismo
non è sinonimo di semplice occamismo. In altri termini, ribadire la centralità dell’individualismo non equivale, di necessità, a patrocinare un atteggiamento antimetafisico, cosí come le convinzioni terministiche in sede logica non escludono la
metafisica del linguaggio universale. Ecco perché, a giudizio di Leibniz, il nominalismo costituisce un fenomeno culturale di lunga durata, indice di un nuovo modo
d’intendere l’oggetto della metafisica e sinonimo di profonda apertura ai rinnovati
interessi metodologici derivati dalla ‘rivoluzione scientifica’, che proprio il secolo di
Leibniz celebra come uno dei suoi eventi epocali.
La distinzione è significativa: testimonia il passaggio dallo studio dei motivi
della tradizione del nominalismo ad una mentalità nominalistica capace di esprimersi nella trattazione dei problemi piú vari, dall’analisi dello statuto delle monadi
alla definizione della natura del corpo, verso la professione di una sorta di «realismo ipotetico»63, fondato sulla categoria del possibile e governato dall’isomorfismo pensiero-linguaggio-realtà. Tale nominalismo metodologico, dunque, finisce
con l’assumere i tratti di una compiuta posizione gnoseologico-epistemologica.
Certo, sono ancora molte le questioni aperte: la definizione della funzione critica assunta dalla Prefazione al Nizolio, il suo rapporto di coerenza rispetto al platonismo matematico colto alla scuola di Weigel ed esibito sin dai primissimi scritti, la determinazione del senso di quell’ambivalente eclettismo su cui si fonda il
sistema leibniziano, reso possibile proprio dalla flessibilità metodologica educata
da principî tratti dalla tradizione del nominalismo, l’ordine e l’articolazione interna
del progetto-sogno di una Caratteristica universale tale da superare le differenze
e celebrare l’unità del genere umano, la definizione dello statuto dell’individuo e
dell’ambigua fede nell’intuizione mediante cui penetrarlo, l’articolazione isomorfica dei rapporti pensiero-linguaggio-realtà. A questi problemi ci si riferisce quando
si parla dell’assegnamento critico nei riguardi del nominalismo da Leibniz con
costanza dimostrato nel corso di tutta la sua vita; un nominalismo che gli aveva
permesso di assumere un atteggiamento di scaltrita diffidenza nei riguardi delle
strettoie dogmatiche della tradizione metafisica e che aveva reso possibile la
Caratteristica e, nel suo solco, una logica come ars inveniendi. A quest’ultima era
consegnato il còmpito di celebrare i trionfi della ragione, lungo un sentiero mai
garantito, fatto di trionfi e di tonfi, di risposte certe e di ipotesi piú o meno plausibili, in una condizione in cui la difficoltà rappresenta un’opportunità, essendo posta
lì, in fondo, solo per essere affrontata e, prima o poi, risolta.
109
110
1 G. ALIBERTI, Introduzione, in G. W. LEIBNIZ, Disputazione metafisica sul principio di individuazione, a c. di G. Aliberti, Levante, Bari 1999, p. 16.
2 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Vita Leibnitii a se ipso breviter delineata, in G. E. GUHRAUER, Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibnitz. Eine Biographie, Bde. 2., Georg Olms Verlag, Hildesheim 1966 [già
Hirt, Breslau 1846], Bd. II., p. 55: «Interea in Zabarella et Rubio et Fonseca aliisque scholasticis
non minori, quam antea in Historicis voluptate versabar et eousque profeceram, ut Suaresium non
minore facilitate legerem, quam Milesias fabulas solemus, quas vulgo Romanos vocant».
3 Sui problemi scaturiti dalla presenza, nell’opera di Leibniz, di un’evidente vicinanza al nominalismo, di un profondo spirito anti-sistematico e di un altrettanto forte istinto neoplatonico, si permetta di
rinviare a S. CIURLIA, Unitas in varietate. Ragione nominalistica e ragione ermeneutica in Leibniz.
4 C. GIACON, Tracce occamiste nel pensiero leibniziano, in Studi in onore di Antonio Corsano,
a c. di A. Lamacchia, Lacaita, Manduria 1970, pp. 349-60: 350.
5 Cfr. A. CRESCINI, Le origini del metodo analitico. Il Cinquecento, Del Bianco Editore, Udine
1965, pp. 35-47.
6 Ivi, p. 41.
7 Ivi, p. 36. La questione assume contorni assai estesi nel corso del secolo XVII, allorché
sottolineare il nuovo ruolo assunto dalla logica rispetto alla Scienza dell’essere e dei principî
primi equivale ad esprimere l’avvertita necessità di un approccio logico non solo ai grandi problemi della metafisica, ma anche a quelli del mondo naturale: cfr. A. CORSANO, Le origini della
filosofia analitica da Suárez a Frege, Adriatica, Bari 1962, p. 3. Per uno studio delle relazioni che
legano Leibniz agli sviluppi della filosofia analitica moderna secondo la prospettiva interpretativa corsaniana si veda S. CIURLIA, Antonio Corsano e la filosofia analitica: il pensiero giovanile di
Leibniz, Congedo, Galatina 2002.
8 G. PAPULI, L’affermazione del metodo analitico e il pensiero filosofico e scientifico dell’età
moderna, “Bollettino di Storia della filosofia dell’Università degli Studi di Lecce”, I (1973), pp. 10545: 109.
9 Cfr. F. SUÁREZ, Disputationes metaphysicae, voll. 2, Georg Olms Verlag, Hildesheim-ZürichNew York 1998 [ristampa dell’Editio nova, a c. di C. Berton, Vivès, Paris 1866; già Apud Ioannem
et Andream Renaut fratres, Salmanticae 1597], II, 1.14, v. I, p. 70, IV, 1.1-27, v. I, pp. 115-22; IV,
2.1-10, v. I, pp. 122-25; V, 2.1-40, v. I, pp. 148-61.
10 Cfr. T. HOBBES, Il corpo, in Elementi di filosofia, a c. di A. Negri, U.T.E.T., Torino 1972, pp. 61489: 80-82.
11 Cfr. PORFIRIO, Isagoge, a c. di G. Girgenti, Rusconi, Milano 1995, 7, 22-26, p. 75.
12 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Disputazione etc., cit., pp. 136-49.
13 Cfr. Ivi, pp. 149-91.
14 Cfr. Ivi, pp. 130-35.
15 Cfr. C. GIACON, Tracce occamiste etc., cit., pp. 352-53.
16 Cfr. Ibidem.
17 Cfr. F. PIRO, Varietas identitate compensata. Studio sulla formazione della metafisica di Leibniz, Bibliopolis, Napoli 1990, p. 75.
18 G. W. LEIBNIZ, Textes inédits d’après les manuscrits de la Bibliothèque Provinciale de Hanovre, publiés et annotés par Gaston Grua, voll. 2, P.U.F., Paris 1948, v. II, p. 547.
19 F. BARONE, Introduzione, in G. W. LEIBNIZ, Scritti di logica, voll. 2, a c. di F. Barone, Laterza,
Roma-Bari 1992?, v. I, pp. XI-LXXXIV: XXXVI.
20 G.W. LEIBNIZ, Disputazione etc., cit., Corollario III, p. 190.
21 Ivi, Corollario II, p. 191.
22 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae, in G. G. LEIBNITII, Opera omnia, nunc primum collecta, in classes distribuita, praefationibus et indicibus exhornata, studio Ludovici Dutens, voll. 6, Apud fratres de Tournes, Genevae 1768, v. IV, pp. 169-230: 176
e sgg. Per un’analisi della prospettiva metodologica contenuta in quest’operetta giovanile, ancora
in parte trascurata, cfr. R. PALAIA, Unità metodologica e molteplicità disciplinare nella Nova methodus, in Unità e molteplicità nel pensiero filosofico e scientifico di Leibniz, a c. di A. Lamarra e R.
Palaia, Olschki, Firenze 2000, pp. 143-57.
NOTE
23 Cfr. A. CORSANO, G. W. Leibniz, a c. di G. Sava, Congedo, Galatina 2000 [già Libreria Scientifica Editrice, Napoli 1952], p. 45.
24 Ivi, p. 46.
25 Cosí ne parla G. W. Leibniz retrospettivamente in uno scritto, di probabile datazione 1684,
dal titolo Sulla scienza universale o calcolo filosofico: «Se si desse una lingua esatta […] o almeno un tipo di scrittura veramente filosofica, mediante la quale le nozioni venissero ricondotte ad
una sorta di alfabeto dei pensieri umani, tutte le conclusioni che derivano razionalmente dalle
nozioni date potrebbero esser scoperte per mezzo di una specie di calcolo, allo stesso modo in cui
si risolvono i problemi aritmetici o geometrici» (in Scritti di logica, cit., v. I, pp. 169-75: 170).
26 Cfr. G.W. LEIBNIZ, Dissertatio de Arte Combinatoria, in Die philosophischen Schriften, Bde.
7., hrsg. von C.I. Gerhardt, Georg Olms Verlag, Hildesheim 1965 [già Weidemann, Berlin 18751890], Bd. IV, pp. 27-104: 39 e sgg. Sui benefici della formalizzazione ha scritto H. SCHOLZ:
«Leibniz comprese che l’inaudito sviluppo della nuova matematica si fondava proprio su questo
esonero contenutistico del pensiero. Tale sgravio, infatti, facilita straordinariamente il processo
inferenziale, liberandolo con intelligenti accorgimenti da tutte le inutili operazioni mentali, e lo assicura a un tempo in maniera esemplare contro gli errori da cui il pensiero contenutistico viene incessantemente minacciato nelle deduzioni» (Breve storia della logica, Silva, Milano 1967, p. 105).
27 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Sulla scienza universale etc., cit., p. 170.
28 Cfr. J. H. BISTERFELD, Alphabeti philosophici libri tres, in Bisterfieldus redivivus, seu operum
Joh. H. Bisterfieldi tomus primus-secundus, A. Vlacq, Hagae Comitum 1661, pp. 1-132: 17-18. Sul
neoplatonismo di Bisterfeld si veda soprattutto M.-R. ANTOGNAZZA, Immeatio and Emperichoresis.
The Theological Roots of Harmony in Bisterfeld and Leibniz, in The Young Leibniz and his Philosophy (1646-1676), ed. by S. Brown, Kluwer, Dordrecht 1999, pp. 41-64; M. L. BIANCHI, Signatura
rerum. Segni, magia e conoscenza da Paracelso a Leibniz, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1987, pp.
144-54.
29 Cfr. C. MERCER, Leibniz’s Metaphysics. Its Origins and Development, Cambridge University
Press, Cambridge (Mass.) 2000.
30 Cfr. P. ROSSI, The Twisted Roots of Leibniz’s Characteristic, in The Leibniz Renaissance.
International Workshop (Firenze 2-5 giugno 1986), Olschki, Firenze 1989, pp. 271-89: 276; M.
MUGNAI, Astrazione e realtà. Saggio su Leibniz, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 62-112; Introduzione
alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001, pp. 65-66; Der Begriff der Harmonie als metaphysische Grundlage der Logik und Kombinatorik bei Johannes Heinrich Bisterfield und Leibniz, in “Studia Leibnitiana”, V (1973), pp. 43-73. Non va dimenticato, inoltre, l’ormai classico studio di W.
KABITZ, Die Philosophie der jungen Leibniz. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte seines
Systems, Winter, Heidelberg 1909. Si deve proprio al Kabitz l’aver ritrovato, nella biblioteca leibniziana di Hannover, il volume delle opere di Bisterfeld annotato dallo stesso Leibniz.
31 Cfr. P. ROSSI, Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz,
Il Mulino, Bologna 1983? [già Ricciardi, Napoli-Milano, 1960]; A. CORSANO, Il pensiero filosofico di
G.W. Leibniz, Corso universitario, voll. 2, Adriatica, Bari 1952, pp. 235 e sgg.; C. VASOLI, L’enciclopedismo nel Seicento, Bibliopolis, Napoli 1978.
32 F. A. YATES, L’arte della memoria, Einaudi, Torino 1993, p. 354. Com’è noto, la prima edizione inglese di quest’opera risale al 1966.
33 Cfr. G. DALGARNO, Ars signorum, vulgo Character Universalis et Lingua Philosophica , J.
Hayes, Londini 1661. La lettura leibniziana di quest’opera risale, con ogni probabilità, al 1671,
pertanto non può aver influenzato il De Arte Combinatoria: cfr. P. ROSSI, Clavis universalis, cit.,
p. 265.
34 Cfr. A. KIRCHER, Polygraphia nova et universalis, ex combinatoria arte detecta, Romae, ex
typ. Varesij, 1663; Ars magna sciendi in XII libros digesta, qua nova et universali methodo per artificiosum combinationum contextum de omni re proposita plurimis et prope infinitis rationibus disputari omniumque quaedam cognitio comparari potest, J.J. Waesberge et E. Weyerstraeten, Amstelodami 1669.
35 Cfr. F. A. YATES, L’arte della memoria, cit., p. 355.
36 G. W. LEIBNIZ, Sulla caratteristica, in Scritti di logica, cit., v. I, pp. 175-80: 177.
37 Cfr. P. ROSSI, The Twisted, cit., p. 277.
38 Cfr. L. COUTURAT, La logique de Leibniz d’après des documents inédits, Alcan, Paris 1901, p. 51.
39 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Dissertatio de Arte Combinatoria, cit., pp. 36-38; Sulla caratteristica, cit.,
111
112
p. 178. Cfr. M. MUGNAI, Astrazione e realtà, cit., pp. 32-37; e, a proposito della concezione leibniziana della logica scientifica come logica naturale, si rinvia a C. CELLUCCI, Le ragioni della logica,
Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 48-55.
40 G.W. LEIBNIZ, Dissertatio de Arte Combinatoria, cit., p. 72.
41 Cfr. C. SCHOTT, Technica curiosa, sive mirabilia artis, qua varia experimenta pneumatica,
hydraulica, mechanica, graphica, cronometrica, automatica, cabalistica proponuntur, J. Hertzt,
Norimbergae 1664.
42 Cfr. K. DIGBY, A Treatise on the Nature of Bodies, G. Blaizet, Paris 1644; poi ristampato in
latino con il titolo Demonstratio immortalitatis animae rationalis, sive tractatus duo philosophici in
quorum priori natura et operationes corporum, in posteriori vero natura animae rationalis ad evicendam illius immortalitatem explicantur, B.C. Wust, Francofurti 1664.
43 Cfr. J. J. BECHER, Character pro notitia linguarum universalis, J.C. Spoerlin, Francofurti 1661.
44 G. W. LEIBNIZ, Dissertatio de Arte Combinatoria, cit., p. 72.
45 Leibniz si confronta anche con quel filone di ricerca orientato a risalire alla cosiddetta «lingua adamitica»: da qui il suo vivo interesse per l’ebraico.
46 Cfr. E. LOEMKER, Leibniz and Herborn Enciclopedists, “Journal of the History of Ideas”, XXII
(1961), pp. 323-38.
47 Cfr. J. H. ALSTEDIUS, Enciclopäedia septem tomis distincta, J.A. Hugueton et M.A. Rovaud,
Lugduni 16492. L’influenza di quest’opera sui numerosi abbozzi enciclopedici leibniziani fu notevole, costituendo un imprescindibile punto di riferimento, per quanto da riformare. Si veda, al riguardo, G. W. LEIBNIZ, Sur l’Encyclopédie d’Alsted, in Opuscules et fragmentes inédits par L. Couturat,
Georg Olms Verlag, Hildesheim 1966 [già Alcan, Paris 1903], pp. 354-55.
48 Cfr. J. A. COMENIUS, Pansophiae Prodromus, L. Fawre et S. Gellibrand, Londini 1639.
49 Cfr. C. VASOLI, L’enciclopedismo etc., cit., p. 24.
50 G. W. LEIBNIZ, Sulla saggezza, in Scritti di logica, cit., v. I, pp. 129-33: 129.
51 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Precetti per il progresso delle scienze, in Scritti filosofici, voll. 2, a c. di D.
O. Bianca, U.T.E.T., Torino 1968, v. II, pp. 737-54: 749.
52 Cfr. N. HAMMERSTEIN, Accademie e società scientifiche in Leibniz, in Università, accademie
e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a c. di L. Boehm e E.
Raimondi, Il Mulino, Bologna 1981, pp. 395-419; E. J. AITON, Leibniz, Il Saggiatore, Milano 1991,
pp. 295-99.
53 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Dissertazione preliminare sull’edizione di opere altrui, sullo scopo dell’opera, sul discorso filosofico e sugli errori del Nizolio, in Scritti di logica, cit., v. I, pp. 63-96: 90:
qui Leibniz cita il criterio metodologico occamista del cosiddetto «rasoio».
54 Cfr. Ivi, p. 91: in questa pagina, Hobbes è addirittura definito un «super-nominalista (plusquam nominalis)».
55 Cfr. Ivi, pp. 93-94.
56 Sul tema del linguaggio come «proiezione logica» e sulla riflessione leibniziana intorno al
segno come «corpo sensibile del significare», si rinvia a R. FABBRICHESI LEO, I corpi del significato.
Lingua, scrittura e conoscenza in Leibniz e Wittgenstein, Jaca Book, Milano 2000.
57 G. W. LEIBNIZ, Dialogo, in Scritti di logica, cit., v. I, pp. 102-08: 106.
58 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Lettera a H. Conring (Hannover, 19 marzo 1678), in Scritti di logica, cit.,
v. II, pp. 435-39. Si vedano, inoltre, Sulla definizione in modo matematico delle forme dei sillogismi; Ricerche generali sull’analisi delle nozioni e delle verità; Matematica della ragione, tutti in
Scritti di logica, cit., v. II, pp. 217-26; 271-325; 390-416.
59 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Meditazioni sulla conoscenza, la verità e le idee, in Scritti di logica, cit., v.
I, pp. 160-67: 164.
60 A. CORSANO, Le origini, cit., p. 21.
61 M. MUGNAI, Introduzione, cit., p. 152.
62 Cfr. G. W. LEIBNIZ, Nuovi Saggi sull’intelletto umano, voll. 3, a c. di M. Mugnai ed E. Pasini,
U.T.E.T., 2000, v. II, p. 356.
63 M. Mugnai, Introduzione, cit., p. 152.
di Cecilia Gazzeri
1. Filosofia del linguaggio e teoria della mente
La riflessione leopardiana intorno al linguaggio prende forma e si sviluppa
nell’ambito di una ben più ampia indagine sull’uomo che ha le sue radici in una
concezione sensista della natura delle facoltà dell’intelletto e del loro funzionamento nell’appropriazione conoscitiva della realtà. Si può dire che il linguaggio
occupi un posto privilegiato nell’indagine filosofica di Leopardi essendo profondamente collegato quasi ad ogni altro settore di ricerca. Per questo motivo i
temi linguistici occupano circa mille delle 4526 pagine dello Zibaldone e per lo
stesso motivo, con ogni probabilità, essi non trovarono posto in un trattato specificamente linguistico cui l’autore pensò più volte di dedicarsi.
In una lettera datata 13 luglio 1821 e indirizzata al Giordani, Leopardi
annunciò il progetto di voler dare forma ad un libro di argomento linguistico illustrandone in modo dettagliato gli obiettivi. Dello stesso progetto torna a parlare nel 1929 in un’altra lettera, questa volta indirizzata all’amico Pietro Colletta,
in cui afferma che pur avendo una grande disponibilità di materiali questi non
riuscivano ancora a trovare né un ordine né uno stile. Non stupisce che questo libro non sia mai stato scritto se consideriamo il legame strettissimo che la
riflessione linguistica intratteneva nella filosofia leopardiana con la più ampia
indagine sul processo conoscitivo e sulla natura delle facoltà della mente.
In particolare, le argomentazioni riguardanti il rapporto tra linguaggio e pensiero sono inscindibili dalla generale scienza dell’uomo elaborata dal Leopardi
e sono esse stesse uno dei momenti che più di altri contribuiscono a definirla.
Il materialismo leopardiano, o, più esattamente il sensismo della filosofia del
recanatese, emerge in questo settore rivelando degli indubbi legami, sia pure
di non facile definizione, con la filosofia francese della fine del XVIII secolo.
2. Status quaestionis
È proprio a partire dal problema della non sistematicità del pensiero leopardiano che prende le mosse la bibliografia critica sulle note linguistiche dello
Zibaldone. La considerazione del “carattere asistematico e piuttosto episodico
del pensiero leopardiano”1, anche e soprattutto in riferimento al problema linguistico, è per Salvatore Battaglia un chiaro segno della natura preparatoria delle
meditazioni zibaldoniane rispetto al più autonomo e compiuto momento poeti-
NOTE
PENSIERO, PAROLA, CORPOREITÀ:
UN NESSO IDEOLOGICO-SENSISTA
NELLA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO
DI GIACOMO LEOPARDI
113
114
co. Il quadro interpretativo dello studioso risente evidentemente ancora dell’estetica di Benedetto Croce che per lungo tempo aveva orientato la bibliografia critica leopardiana in particolare quella relativa allo Zibaldone. La concezione crociana della poesia come pura intuizione e il correlato convincimento che
un vero poeta non potesse essere al tempo stesso un grande pensatore, ha
ritardato di molto l’individuazione di un Leopardi linguista accanto ad un Leopardi poeta ed erudito. Il primo convinto assertore dell’esistenza di una vera e propria teoria linguistica elaborata dal Leopardi è Tristano Bolelli. Il discorso che
tenne a Recanati il 29 giugno 1975 riconosceva già nel titolo l’esistenza di un
“Leopardi linguista” e portava avanti la convinzione che: “per valutare l’importanza di Leopardi linguista, ci vuole un linguista e non uno storico della letteratura”2. Ricerche successive hanno poi dimostrato la fondamentale importanza
dello studio delle fonti, o meglio, della collocazione del pensiero linguistico leopardiano nella giusta prospettiva critica. Solo negli ultimi tempi si sono fatti gli
agganci giusti con la linguistica francese e italiana del Settecento e del primo
Ottocento, in particolare con i Philosophes e con gli Idéologues. Del 1984 è il
saggio di Stefano Gensini: Linguistica leopardiana, la prima monografia interamente dedicata all’argomento, in cui lo studioso ricostruisce i percorsi che
hanno portato il giovane Leopardi ad elaborare le proprie teorie linguistiche, evidenziandone da un lato i rapporti con il pensiero dei diversi filosofi che più o
meno direttamente hanno agito sulla formazione del recanatese, e contemporaneamente procedendo ad un’analisi che esamina le note linguistiche zibaldoniane nel contesto della più ampia “filosofia dell’uomo” elaborata dal Leopardi.
Ulteriori contributi allo studio delle fonti sensiste e ideologiche del pensiero leopardiano si leggono in Dardano (1991)3 che attua una ricostruzione dei riferimenti culturali all’interno dei quali poté muoversi il Leopardi e in Andria, Zito
(2002)4, i quali, esaminata anche una lista di volumi conservata tra gli autografi leopardiani nella Biblioteca Nazionale di Napoli e soltanto nel 2000 resa nota5,
concludono che: “l’indagine sulla natura del linguaggio, tenacemente meditata
dal recanatese nell’arco di oltre un decennio, convoglia al suo interno e assimila in profondità le sollecitazioni di una filosofia d’oltralpe […] E, come altrove, la
ricostruzione dell’itinerario si imbatte in ambiguità e in reticenze, in citazioni
implicite non certo perspicue, in nessi e accostamenti di dubbia decifrazione”.
3. Le fonti ideologico-sensiste del pensiero leopardiano
Ripercorrendo, o meglio, cercando di ricostruire questo itinerario di studi leopardiani, pur con le difficoltà più volte segnalate da tutti gli studiosi della materia,
tre sono in particolare gli autori di riferimento da cui ormai non si può prescindere per una reale comprensione del pensiero linguistico di Leopardi: Condillac,
Destutt de Tracy e Cabanis. Rimane tuttora aperta la domanda riguardante una
lettura diretta da parte del nostro delle opere dei tre autori d’oltralpe, mentre certa
ne risulta ormai una loro conoscenza almeno indiretta. Nonostante gli Idéologues
vengano citati nello Zibaldone, delle loro opere non c’è traccia né nel catalogo
della biblioteca paterna, né negli elenchi di letture pubblicati dal Pacella6.
NOTE
Del pensiero del padre del sensismo e dei due principali esponenti del
gruppo degli Idéologues (questi ultimi annoverati in una nota zibaldoniana nell’elenco dei grandi pensatori insieme a Kant e Leibniz)7 il Leopardi poté però
certamente avere notizie tramite l’opera di divulgazione che ne fece in Italia il
Soave. Padre barnabita molto attento alla diffusione delle idee filosofiche d’oltralpe nel nostro paese, Francesco Soave curò nel 1794 l’edizione italiana del
Saggio sull’intelletto umano di Locke, arricchendo il testo con un’appendice
sulla filosofia sensista. Operando una sorta di cattura dei più importanti temi
culturali del suo tempo, Leopardi riuscì a supplire alle carenze, più volte lamentate, della biblioteca paterna e all’isolamento culturale in cui viveva traendo
notizie del movimento idéologique anche dai pochi opuscoli e riviste letterarie
e filosofiche dell’epoca e rielaborandone i temi con un acume che risultava raro
in qualunque altro luogo dell’Italia di quel tempo. Tra queste pubblicazioni va
ricordata almeno la “Scelta di opuscoli interessanti”, che il Leopardi possedeva in un’edizione del 1781, curata proprio dallo stesso Soave e che conteneva
uno scritto del condillacchiano Sulzer dal significativo titolo di “Osservazioni
sull’influenza reciproca della ragione sul linguaggio e del linguaggio sulla ragione”. Infine va detto che una conoscenza diretta delle opere di Tracy e di Cabanis, non può essere affermata con certezza ma neanche del tutto esclusa se
si guarda alla storia editoriale di queste opere. Dei Rapports du physique et du
moral de l’homme di P.J.G. Cabanis, saggio del 1802, esisteva un’edizione italiana, la prima, pubblicata nel 1820, anno dell’avvio della riflessione zibaldoniana intorno ai problemi di linguaggio e conoscenza. Ancora più rilevante è
osservare che gli Eléments d’idéologie del conte de Tracy, stampati in Francia
nel 1804, vennero pubblicati per la prima volta in Italia nel 1817, in una versione curata dall’ideologo italiano Giuseppe Compagnoni e pubblicata dall’editore milanese Antonio Fortunato Stella, grande amico del Leopardi, il quale tra
l’altro ne fa riferimento in una lettera inviata al recanatese il 3 febbraio 18278.
Quel che più conta è però il fatto che, anche se mediata da una conoscenza indiretta e frammentaria la filosofia degli Idéologues in tutti i suoi nodi teorici più importanti ha sicuramente agito come riferimento preciso nello svolgersi della ricerca zibaldoniana. Un primo generale punto di contatto è dato già
dalla vocazione “interdisciplinare” propria sia della indagine degli Idéologues
che della disposizione filosofica leopardiana. Esaminare l’uomo nella sua
complessità e specificità: è questa la prospettiva che subito colpisce nella lettura di opere pur così diverse come l’Essai sur l’origine des connaissances
humaines di Condillac (1746), i Rapports du physique et du moral de l’homme di Cabanis, gli Eléments d’idéologie di Tracy e lo Zibaldone. D’altra parte
gli Idéologues vengono spesso definiti esponenti di un gruppo di pensiero,
filosofi certo, ma non solo. Nel salotto di M.me Hélvetius si riunivano infatti
pensatori di diversa formazione, quali economisti, matematici, medici (grande
importanza, come su vedrà riveste in particolare la figura di Cabanis, medicofilosofo) e più in generale coloro che erano interessati, sulla scia dell’empirismo inglese e del sensismo francese, a porre le basi di una nuova antropologia che, ripulita di ogni istanza metafisica, si fondasse su un’ipotesi materialistico-sensista da verificare con l’aiuto delle scienze sperimentali.
115
Le idee leopardiane sul linguaggio prenderanno forma proprio da un’analoga visione dell’uomo in cui la sensibilità e in ultima analisi la corporeità lungi
dall’essere cartesianamente considerata il polo opposto dell’anima, verrà riabilitata come fonte della conoscenza, per cui anche il linguaggio, funzione superiore dell’essere umano, non può nascere se non in stretto rapporto con la
nostra fisicità, con la nostra attività percettiva e sensibile, posto che: “tutto è
materiale nella nostra mente e facoltà” (Zib.1657).
4. “… perché noi pensiamo parlando”: la sostanza linguistica del pensiero
116
Inscrivendosi nella linea di pensiero empiristico-materialista che da Locke
giungeva fino a Condillac, Leopardi accoglie dunque il principio dell’antiinnatismo delle idee e del loro formarsi a partire dall’esperienza sensibile. È proprio
in questo percorso di indagine che egli approda alla profonda convinzione del
carattere formativo del linguaggio. Già Condillac, riconoscendo che ogni operazione conoscitiva ha origine da una percezione sensibile e che la formazione di ogni idea presuppone la mediazione del dato materiale, aveva dedicato
un’ampia parte del suo saggio allo studio di come le operazioni conoscitive
possano nei fatti avere luogo, riservando al linguaggio una funzione fondamentale in questo processo.
Il padre del sensismo infatti, considerando ogni operazione dell’anima,
anche il più astratto ragionamento, come originato da una sensazione trasformata, aveva indagato proprio sulle modalità per cui le diverse operazioni dell’intelletto (tra cui il discernimento, la comparazione, l’astrazione) potessero
avere luogo pur partendo tutte da quel principio elementare che è il sentire, e
aveva individuato proprio nel linguaggio il ponte gettato tra i processi percettivi più elementari e quelli cosiddetti superiori. Funzione fondamentale dei segni
è infatti quella di esprimere in successione ciò che nella percezione si dà simultaneamente, permettendo di distinguere, categorizzare e istituire rapporti tra
idee semplici. La formazione di ogni nuovo concetto poggia sul sentimento di
un rapporto tra due idee precedentemente individuate e ben distinte. I segni,
concorrendo alla separazione delle singole idee dalla globalità delle percezioni con cui veniamo in contatto e costituendole così come idee circoscritte e
definite, permettono poi alla mente di poter percepire eventuali rapporti di
somiglianza o differenza tra di esse e di procedere nella formulazione delle
idee composte, di idee cioè che non avendo un referente concretamente individuabile, restano nella nostra memoria e nella nostra coscienza solo grazie
alle parole che le esprimono.
Per Condillac il linguaggio ha la possibilità di innestare le facoltà superiori
della mente umana a partire dall’analisi che possiamo operare grazie ai segni
delle nostre sensazioni e percezioni, cioè dei dati primari della conoscenza. Il
passaggio da una conoscenza percettiva e sensibile ad una modalità conoscitiva fondata sulla riflessione cosciente, si compie con gradualità, senza rotture
tra le due modalità e soprattutto senza bisogno di ricorrere a un deus ex machina meta-fisico come attivatore del processo di pensiero.
5. Immaginazione, metaforicità e vaghezza: la dimensione non calcolabile del
significato
È nell’ambito di questo discorso che si sviluppa il secondo aspetto dell’indagine leopardiana intorno ai fatti di linguaggio e pensiero. Già Condillac
aveva rilevato che le diverse lingue possono diversamente favorire le varie
operazioni del pensiero, quindi alcune risulteranno più adatte all’analisi, altre
all’immaginazione. Leopardi distingue a questo proposito, tra lingue basate
su termini, come ad esempio il francese12 e lingue basate sulle parole, come
la lingua italiana e sommamente il greco antico. Naturalmente una stessa lingua è poi al suo interno formata sia di termini, ossia di segni che “determinano e definiscono la cosa da tutte le parti, presentando la nuda e circoscritta
idea di quel tale oggetto”, che di parole, le quali presentano anche delle
“immagini accessorie”. Per prima cosa, c’è da osservare qui una sostanziale differenziazione delle idee di Leopardi da quelle dei suoi predecessori:
mentre la linea di pensiero Locke-Condillac-Tracy auspicava una razionalizzazione del linguaggio che garantisse una maggior “esattezza” al discorso e
una maggior certezza alla comprensione e quindi accordava la sua preferen-
NOTE
Risulta dunque chiaro che nella linea di pensiero seguita da Leopardi la
parola è ben lontana dall’essere un semplice contrassegno formale di un concetto già precostituito. Essa risulta, al contrario, un dispositivo che media la
cognizione permettendo di determinare l’idea, nel duplice senso di tracciarne i
confini rispetto al pensiero nebuloso prelinguistico e di determinarla come idea;
il linguaggio conferisce al pensiero di per sé vago e indeterminato, la possibilità di trovare un ordine. È in questo senso che la moderna linguistica parla di
formatività ed è questo il primo cardine su cui ruota la ricerca leopardiana: studiare la funzione di condizionamento che i segni linguistici esercitano sulla formazione del pensiero.
Posto dunque che noi “pensiamo parlando” 9, la riflessione leopardiana si
volge ad esaminare l’effetto che le differenti lingue possono avere sulla nostra
capacità di ragionare nonché il vantaggio che deriva dal conoscere più di una
lingua concludendo che “la nuda cognizione di molte lingue accresce anche
per se sola il numero delle idee e ne feconda poi la mente” (Zib.2214). Non
siamo lontani dalla concezione novecentesca nota come ipotesi di SapirWhorf, tanto più che anche nel caso di Leopardi il discorso riguardante l’influenza delle lingue sulle cognizioni umane si riferisce sia al singolo individuo
che alla nazione. Mutuando anche qui una teoria molto diffusa nella linguistica
settecentesca di stampo illuminista10, egli individua l’esistenza di un nesso preciso tra popolo nazione e lingua. Il tema della indole, o più precisamente del
genio delle lingue, è affermato già nella lettera al Giordani del 1821 in cui si
legge che: “la lingua e l’uomo e le nazioni per poco non sono la stessa cosa”
e sviluppato in numerose note dello Zibaldone dedicate all’analisi delle caratteristiche dei differenti idiomi e delle diverse potenzialità espressive che ne
conseguono11.
117
118
za ai termini, al contrario, per Leopardi, la considerazioni dei confini aperti
del significato delle parole, ricche di immagini accessorie (connotazioni)
costituisce, oltre che un dato imprescindibile del linguaggio umano anche
uno dei suoi maggiori pregi.
In questo, più che in altri ambiti del pensiero linguistico leopardiano i riferimenti extralinguistici o generalmente filosofici, i riferimenti cioè allo “schema
concettuale” dello Zibaldone, sono piuttosto complessi. In particolare egli istituisce un preciso collegamento tra l’indeterminatezza semantica delle parole e
il più generale desiderio di infinito e di indefinito caratteristico della natura
umana. Le parole, soprattutto le parole poetiche, ma più in generale le parole
in quanto tali e in contrapposizione ai termini, in virtù del loro carattere vago e
appunto in-determinato, hanno la capacità di dar forma al desiderio di infinito
esposto da Leopardi nella nota “Teoria del piacere”, poiché appunto: “la bellezza del discorso e della poesia consiste nel destarci gruppi di idee e nel far errare la nostra mente nella moltitudine delle concezioni e nel loro vago, confuso,
indeterminato, incircoscritto” (Zib. 1234). Nella semantica leopardiana è infatti
chiara la distinzione tra significato e quello che dalla moderna linguistica è definito “referente extralinguistico”; l’oggetto, per esempio una pianta, può essere
significato mediante un termine o attraverso una parola, la differenza tra le due
modalità è sostanziale, infatti scrive Leopardi: “s’io nomino una pianta col
nome Linneano invece del nome usuale, io non desto nessuna di queste idee
[concomitanti], benché dia chiaramente a conoscer la cosa” (Zib. 1701). Il referente viene dunque indicato in entrambi i casi, ma “significato” in due modi profondamente diversi, poiché utilizzando la parola “comune” in luogo del nome
scientifico si introducono nella sfera semantica tutta una serie di idee, ricordi e
sentimenti legati all’esperienza del singolo individuo. Ci si riferisce alla stessa
cosa, ma la si significa in un modo diverso, e dunque, realmente, non si dice
la stessa cosa.
È grazie ai confini aperti del significato delle parole che è possibile recuperare nella significazione le connotazioni (le infinite idee e ricordanze) che i termini invece escludono. Ma non solo. La funzione delle parole è anche una funzione produttiva, come Leopardi illustra in Zib. 110:
e riducendo l’osservazione al generale troveremo il suo fondamento nella
natura delle cose, vedendo come la filosofia e l’uso della pura ragione
che si può paragonare ai termini e alla costruzione regolare, abbia stecchito e isterilito questa povera vita, e come tutto il bello di questo mondo
consista nella immaginazione che si può paragonare alle parole e alla
costruzione libera varia ardita e figurata.
In queste poche righe è già racchiuso il nocciolo della filosofia non solo linguistica di Leopardi: la precisione e l’univocità dei termini sono proprie della
parte razionale della mente umana, mentre la vaghezza semantica delle parole trova il proprio corrispettivo nella facoltà immaginativa. Ed è l’immaginazione, per Leopardi, il motore principale del processo conoscitivo, che lo porta ad
affermare non solo che “la ragione ha bisogno della immaginazione e delle illu-
chiunque potesse attentamente osservare e scoprire le origini ultime delle
parole in qualsivoglia lingua, vedrebbe che non v’è azione o idea umana o
cosa veruna la quale non cada precisamente sotto i sensi, che sia stata
espressa con parola originariamente applicata a lei stessa e ideata per lei.
Tutte simili cose […] non hanno ricevuto il nome se non mediante metafore, similitudini, ecc. prese dalle cose affatto sensibili, i cui nomi hanno servito in qualunque modo e con qualsivoglia modificazione di significato o di
forma ad esprimere le cose non sensibili […] tale è la natura e l’andamento
dello spirito umano. Egli non ha mai potuto formarsi un’idea totalmente chiara di una cosa non affatto sensibile se non ravvicinandola, paragonandola,
rassomigliandola alle sensibili e così, per certo modo, incorporandola13.
La necessità di conferire un corpo (tramite le parole) alle nostre percezioni
è per Leopardi una chiara conseguenza della natura materiale della mente
umana, come ribadito in Zib. 1658:
tutto è materiale nella nostra mente e facoltà. L’intelletto non potrebbe niente senza la favella, perché la parola è quasi il corpo dell’idea la più astratta.
Ella è infatti cosa materiale, e l’idea legata e immedesimata nella parola è
quasi materializzata. La nostra memoria, tutte le nostre facoltà mentali, non
possono, non ritengono, non concepiscono esattamente nulla se non riconducendo ogni cosa a materia, in qualunque modo, ed attaccandosi sempre
alla materia quanto è possibile; e legando l’ideale col sensibile; e notandone i rapporti più o meno lontani e servendosi di questi alla meglio.
NOTE
sioni ch’ella distrugge” (Zib. 1839) ma che “immaginazione e intelletto è tutt’uno” (Zib. 2134). È la facoltà immaginativa infatti che, permettendo di cogliere i rapporti, le somiglianze e le affinità tra le cose attiva quel meccanismo di
liaison dei idées che permette di arrivare alla costituzione di nuovi concetti.
L’elemento creativo e “poetico” del pensiero risiede dunque in questa facoltà e
trova il suo corrispettivo linguistico nella procedimento metaforico, il quale concretizza quei legami tra idee intuiti dall’immaginazione.
Le metafore, lungi dall’essere dei puri ornamenti retorici, rivestono un ruolo
fondamentale nel processo di appercezione del reale in quanto sono il mezzo
“di cui l’uomo naturalmente si serve a significare le cose nuove o non ancora
denominate” (Zib. 1266). Le metafore dunque gettano luce sul procedimento di
costituzione dei significati delle parole. Riallacciandosi nuovamente alla filosofia sensista, Leopardi illustra la modalità attraverso cui le lingue arrivano a
denominare le nozioni più astratte partendo dalla denominazione di elementi
concreti e sensibilmente percepibili.
Da un punto di vista filogenetico, le prime parole dovettero essere denominazioni di oggetti che cadevano immediatamente sotto i sensi, In seguito, proprio grazie all’appoggio di questi referenti concreti, si andò incontro, nelle
diverse lingue, a un processo di estensione del significato necessario ad esprimere le nozioni più astratte. Così ad esempio “anima” deriva da vento, e pur
essendo una nozione che non cade sotto i sensi ha derivato la sua prima origine da un’idea sensibile. Su questo punto così si esprimerà Leopardi in una
nota del 26 luglio 1821:
119
6. La riabilitazione della corporeità nell’ambito della teoria conoscitiva
120
Nel passaggio sopra riportato non soltanto c’è un riferimento alla teoria condillacchiana secondo cui il pensiero è un processo che ha bisogno del dato
sensibile per poter giungere a compimento, ma il quadro teorico in cui queste
esemplificazioni sono inserite sembra risentire fortemente delle teorie di un
idéologue in particolare: il medico e filosofo Pierre-Jean-George Cabanis. Non
sappiamo se Leopardi –che sicuramente lo conosceva poiché lo inserisce
come si è detto nell’elenco dei grandi pensatori– avesse letto la principale
opera di questo filosofo, e cioè i Rapports du phisique et du moral de l’homme.
Come si è detto, una conoscenza diretta di questo saggio non può essere
affermata mancando al riguardo esplicite indicazioni del Leopardi, (sempre
peraltro piuttosto restio a dichiarare le proprie fonti), ma neanche del tutto
esclusa se si guarda alla storia editoriale dei Rapports, di cui esisteva un’edizione italiana datata proprio 1820, anno dell’avvio della riflessione zibaldoniana intorno ai problemi di linguaggio e conoscenza.
Partendo come Condillac dallo studio della sensibilità come origine della
conoscenza, Cabanis elaborò i suoi Rapports con l’intento dichiarato di andare oltre Condillac, di dimostrare cioè come quel principio conoscitivo non avesse nulla di spirituale ma fosse una funzione interamente appartenente al corpo
il quale era in grado di compiere autonomamente quelle funzioni cosiddette
superiori –come quelle di pensiero e di linguaggio– che fino a quel momento
la filosofia, compresa quella sensista dell’abate di Condillac, aveva riservato
all’anima e di conseguenza come il pensiero, che da quel principio discende
avesse una natura completamente organico-materiale.14
Il materialismo leopardiano, portato all’estremo in un a nota del 9 marzo
1827 in cui si legge che: “la materia può pensare, la materia pensa e sente”, si
ricollega alla concezione cabanisiana di un corpo che non è in alcun modo un
fatto meccanico e inerte ma che risulta dotato di proprietà vitali interne che si
generano grazie a continue aggregazioni di carattere chimico-fisico e che dunque non necessita di alcun intervento esterno da parte di un ente meta-fisico.
La riabilitazione della corporeità in chiave antimeccanicistica era per gli
Idéologues il dato fondamentale su cui innestare la nuova scienza dell’uomo.
Non ci si accontentava più di escludere l’âme dalla science de l’homme, si
chiedeva invece un’analisi nuova e specifica dell’organisation corporea. Questa organisation cui fa riferimento Cabanis è il risultato dei rapporti tra il fisico
e il morale, termini ben lontani dal riproporre l’antico dualismo corpo-anima, in
quanto con moral precisa, si fa riferimento al complesso, relativamente autonomo, delle operazioni intellettuali e affettive dell’uomo, complesso che non
possiede un proprio statuto ontologico, “non essendo altro che il fisico considerato sotto certi punti di vista più particolari”15. L’uomo dunque non è nella
concezione cabanisiana, come non sarà in quella leopardiana, la somma di
due nature eterogenee, ma il risultato di una complessa organisation materiale che da sola giustifica l’esistenza e il funzionamento di tutte le facoltà, comprese quelle cosiddette superiori di pensiero e di linguaggio. Ed è proprio quest’ultimo che consente l’attivazione del processo conoscitivo, il quale, stabilita
nelle parole si chiudono e quasi si legano le idee come negli anelli le
gemme, anzi s’incarnano come l’anima nel corpo, facendo seco loro
come una persona, in modo che le idee sono inseparabili dalle parole, e
divise non sono più quelle, sfuggono all’intelletto e alla concezione, e non
si ravvisano, come accadrebbe all’animo nostro disgiunto dal corpo.
L’idea dunque assume consistenza grazie alla parola, mentre una “idea” prelinguistica sfuggirebbe in breve anche alla persona stessa che l’ha concepita.
NOTE
la natura materiale della mente umana può essere innescato solo rivestendo
di una forma materiale i contenuti psichici. L’idea infatti, per poter essere compatibile con il congegno tecnico della facoltà conoscitiva ha bisogno di “incapsularsi” nell’elemento sensibile, come scriverà Leopardi in Zib. 2584:
7. Linguaggio e memoria
Di questa complessa organisation umana sono parte integrante anche altre
facoltà, tra cui va ricordata almeno la memoria, che occupa un posto centrale
nella indagine linguistica sia di Leopardi che di un ideologo in particolare:
Destutt de Tracy. Con maggior precisione rispetto a Condillac, Tracy esamina
il ruolo giocato da questa facoltà nel funzionamento “linguistico” della mente,
evidenziando come sia proprio la limitatezza della memoria a rendere necessario l’uso dei segni. Le parole infatti sono punti di riposo e di ancoraggio per
una mente, quale è la mente umana, che non è in grado di ritenere una quantità troppo estesa di informazioni. Per illustrare questo concetto, Tracy ricorre
ad un esempio tratto dall’algebra: affermato che la lingua algebrica è un sistema di segni, l’autore degli Eléments d’idéologie invita a riflettere sul fatto che
“non si ha mai bisogno di pensare al significato di questi segni durante il tempo
in cui li si combina.” Durante i calcoli operiamo cioè una combinazione delle
quantità basandoci sulle regole algebriche senza dover continuamente richiamare alla mente il significato dei segni, tanto che se le regole saranno state
seguite nel modo corretto, giungeremo ad un risultato esatto. Ora, posto che
le lingue storico-naturali non hanno l’esattezza della lingua algebrica (purtroppo, secondo Tracy, il quale contrariamente a Leopardi si dimostra estremamente favorevole nei confronti di una lingua razionalizzata ed epurata di ogni
vaghezza semantica) egli conclude analogamente che “ragionando, noi, senza
accorgercene, siamo condotti dalle parole come dai caratteri algebrici; la loro
utilità” –è qui il nesso parola-memoria– “è di dispensarci in parte dall’aver presente le idee che rappresentano.”16
Oltre all’estrema modernità della conclusione tracyana, per cui il soggetto
parlante sarebbe in buona parte condotto dalle parole, ciò che dunque emerge esaminando il funzionamento collaborativo di pensiero memoria e linguaggio, è il problema del significato. Scriverà Leopardi che senza la favella ci è
possibile contare fino ad un numero estremamente limitato di oggetti, ad esempio di pietre, forse fino a cinque o sei, poiché solo fino a quella cifra ci è pos-
121
122
sibile avere una conoscenza intuitiva e individuale degli oggetti17. Di fronte a
entità più complesse, come ad esempio cento pietre, in luogo di una conoscenza individuale di ogni singolo elemento, ci serviamo di una conoscenza simbolica di esso. Il significato linguistico delle parole fa dunque le veci della conoscenza individuale di ciascuna delle cento pietre, conoscenza che, se mai
fosse possibile, bloccherebbe la mente dal compiere qualunque passo successivo poiché occuperebbe troppo spazio in una memoria che invece ha dei limiti. Possiamo dunque parlare delle cento pietre senza conoscerle una per una.
Senza che ci sia un accesso diretto agli oggetti, senza conoscere le loro caratteristiche, possiamo nominarli attraverso i simboli e procedere nel calcolo e,
più in generale, nel pensiero.
Già Leibniz aveva rilevato che per la mente umana è possibile concepire
senza la parola solo un numero limitato di oggetti; per concepirne un numero
più ampio, ma non illimitato la mente ha invece bisogno del segno, infine, ci si
affida ad una conoscenza esclusivamente simbolica nel caso di numeri altissimi o illimitati. In quest’ultimo caso il linguaggio diventa un vero e proprio “telescopio della mente”, permettendole di guardare dove ella non arriverebbe
senza il segno. Senza la parola dunque non potremmo avere il concetto. Questo genere di considerazioni sono per Leibniz come per Tracy e per Leopardi,
l’ennesima riprova del fatto che la nostra mente ha bisogno del linguaggio per
funzionare, cioè per pensare.
C’è poi un altro aspetto presente nella riflessione di Leopardi e degli Idéologues intorno al rapporto tra parola e memoria, che li porta ad affermare che
un essere umano privo di linguaggio sarà con ogni probabilità anche privo di
memoria. Gli esempi riportati dagli Idéologues, come dal citato scritto del Sulzer, si riferiscono ai casi, proprio in quei tempi molto studiati, dei cosiddetti
“ragazzi selvaggi”. Riportando il caso di un ragazzo vissuto nei boschi senza
contatti con altre persone, che non ricordava nulla della propria esistenza precedente il ritrovamento e l’avvio dei rapporti interumani, relazioni cioè non solo
affettive ma anche linguistiche, Sulzer imputa la mancanza di memoria alla
mancanza di linguaggio, affermando che “la memoria manca a chi non ha
segni per fissare le idee”. Analogamente, Leopardi avanza l’ipotesi che la poca
memoria che abbiamo degli avvenimenti della nostra infanzia potrebbe essere
attribuita ad uno scarso sviluppo nei bambini non solo di questa facoltà in sé
ma anche della facoltà linguistica, cosa che non avrebbe permesso di fissare
idee e ricordi. Questi, afferma, cominciano proprio dal punto in cui il bambino
ha acquistato un linguaggio sufficiente, concludendo con un pensiero che ha
agli occhi del lettore di oggi il sapore proustiano della madeleine: “come la
prima mia ricordanza è di alcune pere moscadelle che io vedeva e sentiva
nominare al tempo stesso.”
Per pervenire alla costituzione di un’idea e per far sì che questa resti nella
nostra memoria, è necessario dunque che essa venga “materializzata” tramite la
parola ed è rilevante ed estremamente moderna la consapevolezza che Leopardi ha del fatto che questo percorso avvenga sempre per “tentativi” e “alla meglio”.
Il processo conoscitivo ha dunque un carattere provvisorio, è la ricerca di una
forma che ha un carattere maieutico: si tenta di dare un ordine al pensiero trami-
si è tanto detto, senza prove, che se fossimo tutta materia non potremmo pensare, è dimostrato, al contrario, che se fossimo totalmente immateriali e senza corpi non potremmo pensare come facciamo e non
sapremmo nulla di tutto ciò che sappiamo.
1 S. BATTAGLIA, “La dottrina linguistica del Leopardi”, in Le dottrine linguistiche del Settecento,
Liguori, Napoli 1963.
2 T. BOLELLI, “Leopardi linguista”, in Leopardi linguista e altri saggi 1982, G. D’Anna, Messina
1975.
3 M. DARDANO, “Le concezioni linguistiche del Leopardi”, in Lingua e stile nell’opera di Leopardi. Atti dell’VIII Convegno internazionale di studi leopardiani. Recanati 30 settembre – 5 ottobre
1991, 1991.
4 M. ANDRIA, P. ZITO, “Tutto è materiale nella nostra mente. Leopardi sulle tracce degli idéologues”, in S. Gensini (a c. di) “D’uomini liberamente parlanti.” La cultura linguistica italiana nell’Età
dei Lumi e il contesto intellettuale europeo. Editori Riuniti, Roma 2002.
5 ZITO, op. cit. (pp.114-116).
6 G. PACELLA, op. cit., “Elenchi di letture leopardiane”, in Giornale storico della letteratura italiana, LXXXIII, 1966, vol.143, fasc. 441, pp. 557-577.
7 Si veda Zib. 946; gli altri due riferimenti diretti agli Idéologues si leggono in Zib.1235 e in zib.
2616.
8 Nell’epistola (1043) c’è un breve riferimento al Compagnoni e “alle note da lui apposte alla
Grammatica del Tracy.” Il riferimento parrebbe sottintendere una conoscenza di quest’opera da
parte del Leopardi.
9 Zib. 2214.
10 E in generale nella linguistica settecentesca che aveva ben chiaro il nesso fra popolo, nazione e lingua. Su questo tema si veda L. ROSIELLO, Linguistica illuminista, Il Mulino, Bologna 1967.
11 Si cfr. ad esempio Zib. 2591: “La storia di ciascuna lingua è la storia di quelli che la parlarono o la parlano e la storia delle lingue è la storia della mente umana.”
12 Per una dettagliata analisi della polemica leopardiana nei confronti della lingua francese, si
veda, su tutti, S. GENSINI, Linguistica leopardiana, Il Mulino, Bologna 1984.
13 Vicinissimo è questo brano ad un passaggio di Locke (Essay, libro III, cap.I, § 5) che così
suona: “non dubito affatto che se potessimo ricondurre tutte le parole fino alla loro sorgente, troveremmo che, in tutte le lingue, le parole che si usano per significare cose le quali non cadono
sotto i sensi, hanno derivato la loro prima origine dalle idee sensibili.”
14 La più completa analisi del pensiero cabanisiano è tuttora, nel panorama italiano, il saggio
del 1974 di S. MORAVIA. Il pensiero degli Idéologues: scienza e filosofia in Francia (1780-1815), La
Nuova Italia, Firenze.
15 P.-J.-G. CABANIS, Rapports du physique et du moral de l’homme, 1802-1805.
16 Questa e le precedenti asserzioni sono riportate dal Tracy in una lunga e importante nota al vol.I,
cap.16, pp. 340-349; la traduzione delle citazioni tracyane come di quelle cabanisiane è di chi scrive.
17 Si veda Zib. 360-361: “l’uomo senza la cognizione di una favella non può concepire l’idea di
un numero determinato. Immaginatevi di contare trenta o quaranta pietre senza avere una denominazione da dare a ciascheduna, vale a dire una, due, tre, fino all’ultima denominazione, cioè
trenta o quaranta, la quale contiene la somma di tutte le pietre e desta un’idea che può essere
abbracciata tutta in uno stesso tempo dall’intelletto e dalla memoria essendo complessiva ma definita e intera. […] [senza i segni] bisogna che l’intelletto concepisca e la memoria abbia presenti in
uno stesso momento tutti gli individui di essa quantità, la quale cosa è impossibile all’uomo.”
NOTE
te i segni materiali che permettono, come scrive il Sulzer, di “trarre dall’oscurità
qualche idea.” La base su cui poggia questo processo è la nostra corporeità,
base imprescindibile per la nascita del pensiero, poiché, scrisse Tracy:
123
MERLEAU-PONTY/MELANIE KLEIN:
PROPOSTA DI UN CONFRONTO1
di Lucia Angelino
La realtà del legame contro l’a priori della distinzione
124
Come Merleau-Ponty sottolinea nel capitolo della Fenomenologia della percezione intitolato “L’altro e il mondo umano”, la relazione con l’altro è incomprensibile se la si pensa come il ‘faccia a faccia’ di un soggetto, concepito
come pura coscienza, con un oggetto, posto di fronte a lui e dispiegato davanti al suo sguardo senza segreti. “L’esistenza dell’altro”, scrive il filosofo, “costituisce una difficoltà e uno scandalo per il pensiero oggettivo”2. Un tale pensiero oggettivo, così come la filosofia riflessiva che ne è l’opposto speculare, riflette la struttura dell’ontologia classica, derivata da Cartesio, che oppone un Soggetto come puro essere per sé (presenza a sé) e come coscienza costituente
a un Oggetto inerte pensato come puro essere in sé, che si offre interamente
davanti al suo sguardo. Affinché l’altro sia comprensibile, bisogna rinunciare
alla “biforcazione della ‘coscienza di’ e dell’oggetto”3 e prendere finalmente sul
serio la realtà del legame, che abbiamo vissuto durante l’infanzia, nella forma
di una “tranquilla coesistenza”4 con gli altri. Come Merleau-Ponty scriverà in
una Nota di lavoro del Visibile e l’invisible, “In realtà né io né l’altro siamo dati
come positivi, come soggettività positive. Si tratta di due antri, di due aperture,
di due scene in cui accadrà qualcosa, –e che appartengono entrambi allo stesso mondo, alla scena dell’Essere”5. E aggiunge in una nota dello stesso anno:
“Se si parte dal visibile e dalla visione, dal sensibile e dal sentire, si ottiene una
idea completamente nuova della ‘soggettività’ : non ci sono più ‘sintesi’, c’è un
contatto con l’essere attraverso le sue modulazioni, o i suoi rilievi –L’altro non
è più tanto una libertà vista dall’esterno come destino e fatalità, un soggetto
rivale di un soggetto, ma è preso nel circuito che lo collega a noi– E questo
mondo ci è comune, è intermondo – E c’è transitivismo per generalità” 6.
Nel campo della psicoanalisi, Melanie Klein deve risolvere un problema
analogo, nel momento in cui descrive la genesi della prima relazione con l’altro, incentrata, durante la “posizione schizo-paranoide” (0-4 mesi), sul seno
materno. In effetti, la distinzione tra un soggetto e un oggetto, così come la
nozione di oggetto perdono la loro pertinenza in una relazione arcaica di questo tipo, che è plasmata dall’alternanza tra l’introiezione e la proiezione, e che
implica un va-e-vieni fluido tra situazioni e oggetti interni ed esterni, parti allontanate da sé e integrate in sé.
Tuttavia, Klein ricorre a un sistema che, come scrive Jean Laplanche, “fonctionne par jeu de paires opposées permettant toutes les mécaniques et toutes les stéréotypies”7 e non riesce ad eliminare l’inadeguatezza esistente tra i
La coppia io-oggetto e la sua critica
Occorre innanzitutto precisare che Klein presuppone, sin dall’inizio della
vita, l’esistenza di un Io “primitivo”, benché privo di coesione, e di un “primo”
oggetto, benché parziale, che corrisponde al seno materno. Ma una lettura
attenta dell’articolo Note su alcuni meccanismi schizoidi, permette di accorger-
NOTE
concetti che utilizza e l’esperienza che descrive. In poche parole, siamo tentati di rimproverarle di aver conservato, nella forma la più classica, la nozione di
oggetto e la distinzione soggetto-oggetto, che sembra nondimeno contestare,
quando descrive il processo che conduce alla genesi della prima relazione
oggettuale, vale a dire il meccanismo paranoide dell’“identificazione proiettiva”.
Tutta la mia argomentazione si sviluppa intorno alla seguente domanda:
qual’è la nozione di oggetto che deriva più direttamente dalla descrizione
dell’“identificazione proiettiva”? Qual è il senso attribuito da Klein alla prima
relazione oggettuale, malgrado il ricorso, talvolta infelice e impreciso, a una
concettualizzazione inappropriata? Per proporre un abbozzo di risposta a tali
questioni, propongo di utilizzare la filosofia di Merleau-Ponty, che, naturalmente, manipola con tutt’altra disinvoltura le grandi coppie concettuali ereditate
dalla tradizione metafisica occidentale, per venire qui in soccorso a Klein.
Procedo quindi a una ‘lettura incrociata’ della psicoanalisi di Klein e della
filosofia di Merleau-Ponty, per stabilire tra questi due autori un dialogo che
dovrebbe permettere di mettere in evidenza il fatto che le grammatiche concettuali kleiniana e merleau-pontiana, almeno dal punto di vista delle insufficienze individuate nel sistema della psicoanalista, si completano in maniera felice
e feconda. Così facendo, vorrei fare un passo nella direzione della localizzazione di un campo di risonanze concettuali tra fenomenologia e psicoanalisi.
Che sia completamente fedele o no allo spirito del pensiero di Klein, questa lettura mi permette di attribuire un senso più forte e chiaro alla nozione di oggetto che è implicita nella sua descrizione del processo che conduce alla costituzione della prima relazione oggettuale.
Il mio percorso si articola in tre momenti. In un primo tempo, faccio una critica della concettualità alla quale si è riferita Klein per descrivere questa prima
tappa dello sviluppo del bambino, che corrisponde alla posizione “schizo-paranoide” (0-4 mesi). In un secondo tempo, esamino la nozione merleau-pontiana
di “carne”. Infine, mi propongo di ritrovare, grazie a questa nozione, una descrizione più soddisfacente del meccanismo paranoide dell’“identificazione proiettiva” e di far valere questa stessa descrizione come espressione del senso,
nascosto e originale, della nozione kleiniana di oggetto. È quindi da un’analisi
delle insufficienze, individuate nella grammatica concettuale kleiniana e più
precisamente nella concettualizzazione di questo meccanismo, che occorre
cominciare.
In questo tentativo, seguirò le analisi che le dedica Julia Kristeva, nel
secondo volume del suo libro su Le génie féminin, intitolato Mélanie Klein ou
le matricide comme douleur et comme créativité8.
125
si che, in questa prima tappa dello sviluppo, denominata “posizione schizoparanoide”, non esiste una tale distinzione netta (concettuale, naturalmente,
non empirica) tra il bambino e il seno materno, tra il cosiddetto io e il suo oggetto, perché al contrario questi sono presi l’uno nell’altro in un gioco incessante
di proiezione-introiezione, riproiezione-reintroiezione. Detto altrimenti, quello
che esiste all’esterno proviene, secondo questa prospettiva infantile, da quello che è stato espulso, proiettato al di fuori e, reciprocamente, quello che esiste all’interno proviene da quello che è stato integrato o introiettato. Brevemente, e per riprendere le parole di Julia Kristeva: “Une lecture attentive de ces textes révèle que, malgré l’utilisation de termes comme ‘objet’ et ‘moi’, l’auteur se
contente d’établir, à cette étape précoce du début de la vie, une distinction
entre dedans et dehors, intérieur et extérieur”9. Si può ipotizzare che, introducendo il nuovo termine di “identificazione proiettiva”, Klein cercasse di esprimere proprio questa situazione. Ma, come dimostrerò tra poco, questo termine non risolve il problema di fondo e non evita a Klein una ricaduta nel dualismo tra l’io e il suo oggetto che cerca di evitare; al contrario, non fa che rivelare la continuazione inopportuna di questo dualismo.
Mi limiterò per il momento a tratteggiare l’essenziale della spiegazione kleiniana di questo meccanismo, quale si coglie dall’articolo Note su alcuni meccanismi schizoidi 10.
126
L’“identificazione proiettiva”
L’identificazione proiettiva è un meccansimo che consiste in una proiezione
fantasticata delle pulsioni d’amore sul seno buono e delle pulsioni distruttrici
sul seno cattivo della madre; questa identificazione nasce dalla deflessione
verso l’esterno della pulsione di morte, e permette al bambino di superare l’angoscia primaria di essere annientato da questa forza distruttrice sentita all’interno.
Melanie Klein introduce per la prima volta questo nuovo termine –“identificazione proiettiva”– che diventerà un concetto centrale nella dottrina dei
suoi allievi, nell’articolo Note su alcuni meccanismi schizoidi (1946), nel
momento in cui descrive “la première étape dans la capacité de se relier au
monde extérieur”11 durante la quale nascono l’uno per l’altro il mondo psichico del bambino e il mondo dei suoi oggetti esterni. L’introduzione di questo
altro termine –“identificazione proiettiva”– per definire il processo costitutivo
della prima relazione del bambino con la madre (incentrata inizialmente sul
seno) è il segno di uno spostamento da riconoscere e da interrogare: quello
che Melanie Klein intende sottolineare, è, forse, che il meccanismo della proiezione, in quest’epoca arcaica della vita psichica che lei osserva, è ben più
complessa di quanto non si accontenti di descrivere e di esplicitare la psicoanalisi classica, e quindi che essa esige uno statuto e una determinazione più
precise. In effetti, quello che lei osserva (e che descrive) è un movimento
complicato di proiezione-introiezione, di riproiezione-reintroiezione per
mezzo dei quali l’io primitivo del bambino e questo quasi-oggetto che è il
La carne
La “carne”, in senso merleau-pontiano, il più proprio e fondamentale, designa
la circolarità nel corpo, nello stesso tempo senziente e sensibile. Essa “è il sensibile nel doppio senso di ciò che sentiamo e di ciò che sente”15. Come scrive Pierre Rodrigo, “fait inaugural de la convenance réciproque d’un sensible et d’un sentant, par où se dévoile avec plus ou moins d’acuité et de finesse un sens, la chair
s’affecte en étant affectée, s’émeut en étant mue, se ressent en sentant”16.
NOTE
seno della madre entrano l’uno con l’altro in un gioco interminabile di identificazioni: per mezzo della proiezione, nella propria fantasia, il bambino si
getta su, o nel, corpo della madre, per prenderne possesso, in modo tale che
il corpo della madre è vissuto/percepito nella fantasia come pieno di parti
proiettate del bambino e identico ad esse. Come spiega Hanna Segal, “nella
identificazione proiettiva parti del Sé e degli oggetti interni sono scissi e proiettati sull’oggetto esterno, che diventa allora posseduto e controllato dalle
parti proiettate, con le quali viene inoltre identificato”12.
Il difetto principale del concetto dell’“identificazione proiettiva”, che vorrei
mettere qui in evidenza, risiede in un’illusione legata al concetto di proiezione,
di cui l’identificazione proiettiva è una modalità particolare13, tipica della posizione “schizo-paranoide”. In effetti, nel momento in cui si parla di proiezione, si
suppone l’esistenza di due termini o entità distinte. Al contrario, l’io primitivo del
bambino, in questo periodo di inizio della vita –come sottolinea Kristeva– non
è veramente separato dal seno della madre “comme le sera un ‘sujet’ d’un
‘objet’, mais ne cesse de le prendre au-dedans et de l’expulser au-dehors, en
se construisant-vidant soi-même tout en construisant-vidant l’autre”14.
Il rischio qui è di vedere sovrapporsi e confondersi (e ciò non significa chiarirsi reciprocamente), da una parte, il postulato di partenza, riguardante l’esistenza, dalla nascita di un io primitivo, benché privo di coesione e di un primo
oggetto, (il seno della madre), benché parziale, e, dall’altra parte, la descrizione di una relazione che implica un va-e-vieni fluido tra un contenuto, quello che
il bambino proietta et un contenitore, il corpo della madre che arriva a contenere le parti ‘cattive’ del bambino. In altri termini, il rischio è qui quello di una
circolarità viziosa che comprometterebbe almeno la pretesa di descrivere
l’emergenza di una coppia concettuale che, al contrario, è sotterraneamente
postulata alla radice di questa cosiddetta descrizione, o meglio di una descrizione, già investita e caricata concettualmente.
Si potrebbe suggerire che il meccanismo dell’“identificazione proiettiva”
–nella misura in cui stabilisce un va-e-vieni fluido di parti espulse/proiettate
all’esterno e integrate all’interno– assomiglia molto alla famosa porosità carnale dei limiti dentro/fuori. Allora, di fronte a questa incertezza dei limiti
dentro/fuori che caratterizza la prima relazione oggettuale, parlare di “carne”,
piuttosto che di relazione tra un soggetto e un oggetto, sarebbe forse più pertinente. Per verificare questa ipotesi, occorre ora riprendere la nozione merleau-pontiana di “carne”.
127
Si potrebbe dire che la carne si lascia descrivere come uno stesso tessuto,
piegato e ripiegato tante volte che è difficile stabilire una vera distinzione tra il
dentro e il fuori. Così compresa e incorporata all’analisi della visibilità, la carne
denomina il campo totale del visibile che, da una delle sue pieghe diviene in
qualche parte vedente, in modo tale che il vedente, pronunciandosi nell’incavo
del visibile, è ancora del visibile. Essa denomina propriamente e fondamentalmente il “medium formatore dell’oggetto e del soggetto”17, il “mezzo di comunicazione” tra “la visibilità propria della cosa” e la “corporeità propria del vedente”18; o anche il tessuto comune del corpo vedente e del mondo visibile,
nascenti l’uno per l’altro da una “deiscenza del sensibile”19 che è l’apertura del
mondo. In altri termini, con questa nozione, Merleau-Ponty cerca di pensare
una vera co-originarietà tra soggetto e mondo. In questo senso, come lo sottolinea T.F. Geraets, “elle n’est pas une ‘solution’ du paradoxe fondamental,
elle est ce paradoxe même, en acte, plus éclairant, plus authentiquement
‘rationnel’, que tous les concepts purs, mais fermés de ‘sujet’, d’‘objet’, de ‘pour
soi’ et d’‘en soi’.”20 Vorrei a questo punto mettere in evidenza l’affinità della
nozione merleau-pontiana di “carne” con l’“identificazione proiettiva”, per proporre una lettura di questo meccanismo, che espliciterà la nozione d’oggetto
che vi è implicata.
128
Confronto tra l’“identificazione proiettiva” e la “carne”
Mi sembra che la famosa impurità della “carne” che implica una “ramificazione del mio corpo e ramificazione del mondo e corrispondenza del suo interno e del mio esterno, del mio interno e del suo esterno”21, rappresenti adeguatamente questo va-e-vieni fluido “fra oggetti e situazioni interni e oggetti e
situazioni esterni”22 che modella la prima relazione oggettuale del bambino con
il seno materno. Come nella carnale porosità merleau-pontiana dei limiti interno/esterno, il soggetto percipiente, incessantemente intrecciato in chiasma con
il mondo, al quale appartiene, mai si perde, ma al contrario si ritrova ancora là
dove il mondo si apre a lui, allo stesso modo l’io del bambino si costruisce
vedendo se stesso, costruendo-vedendo l’altro. Così compresa, in un prisma
merleau-pontiano, l’“identificazione proiettiva” designa una relazione inaugurale della coppia io/oggetto, io/altro nella quale si osserva che soggetto e oggetto non diventano se stessi che nascendo l’uno per l’altro sullo sfondo di una
situazione d’indifferenziazione, ma già di discriminazione iniziale tra dentro e
fuori, tra interno ed esterno. Essa esprime anche, allo stesso modo, il fatto che
questa relazione d’identificazione proiettiva, di proiezione-introiezione, sarebbe impossibile tra un soggetto e un oggetto concepiti secondo il modello cartesiano come entità positive, piene, distinte l’una dall’altra, pienamente dispiegate l’una davanti all’altra, e quindi prepara un rinnovamento radicale della
nozione classica di oggetto.
Al termine di questo esame, m’interessa sottolineare ancora una volta che
il processo costitutivo della prima relazione con l’altro nel mondo del bambino,
descritto da Klein, implica la messa in questione della distinzione tra soggetto
e oggetto; che questo processo deve essere considerato come la prova empirica della realtà del legame e sembra così confermare quello che MerleauPonty dice nel capitolo della Fenomenologia della percezione dedicato all’altro, vale a dire che non bisogna descrivere la relazione con l’altro come il ‘faccia a faccia’ di un soggetto con un oggetto posto di fronte a lui, perché percepire il corpo dell’altro, è trovarvi “come un prolungamento miracoloso delle
[sue] proprie intenzioni, una maniera familiare di trattare il mondo”23, come se
“il corpo altrui e il mio [fossero] un tutto unico, il rovescio e il diritto di un solo
fenomeno…”24.
Dopo aver messo in evidenza l’inadeguatezza delle nozioni di soggetto e di
oggetto e dell’a priori della distinzione, che utilizza Klein, il mio tentativo, consistente in un confronto tra il meccanismo paranoide dell’“identificazione proiettiva” e la nozione merleau-pontiana della “carne”, non solleva la presunzione, in senso forte, che le riflessioni psicoanalitiche di Klein sarebbero per così
dire ‘in attesa’ di ricevere una fondazione filosofica. Il mio tentativo non solleva nessun’altra pretesa che quella di far avanzare la realizzazione del programma che Merleau-Ponty definiva, quando suggeriva che “la fenomenologia
apporta [sotto questo aspetto] alla psicoanalisi categorie, mezzi di espressione di cui essa ha bisogno per essere del tutto se stessa”25. In questo senso, la
fenomenologia merleau-pontiana farebbe ‘avanzare’ la psicoanalisi di Klein,
non tanto, lo ripeto, in direzione di una fondazione del suo discorso o della sua
legittimità, ma piuttosto nella direzione di una accresciuta coscienza di sé, di
una consapevolezza più acuta delle proprie implicazioni e dei propri presupposti. Più precisamente, si potrebbe sostenere la tesi secondo la quale la descrizione della genesi della coppia io-oggetto proposta da Klein, sottratta al quadro cartesiano e situata all’interno del pensiero merleau-pontiano della “carne”,
ci fa meglio comprendere la nozione di oggetto, implicita in questo va-e-vieni
fluido di frammenti espulsi all’esterno e integrati all’interno.
In effetti, l’oggetto precoce della posizione schizo-paranoïde (vale a dire il
seno materno) è un oggetto paradossale e ontologicamente instabile: esso
appartiene al “per sé” perché è una rappresentazione, un’immagine interiore
costruita dal fantasma inconscio e, nello stesso tempo, appartiene all’“in sé”
perché essendo costituito di elementi sensoriali e materiali come dei pezzi
buoni e cattivi del seno esiste all’esterno dove –come sottolinea Julia Kristeva– “le moi infantile le situe comme extériorité dès le début de la vie”26. Si dirà,
da un lato, che l’oggetto della posizione schizo-paranoïde si lascia descrivere
come dentro, che ossessiona o minaccia l’io e che questi è costretto ad esorcizzare per mezzo di un processo proiettivo, situandolo fuori di sé, in un oggetto esterno onnipotente; e si dirà dall’altro lato, che il ‘successo’ di quest’operazione di proiezione dipende dalla presenza di un oggetto reale. Un tale sconfinamento dell’oggetto sull’io e dell’io sull’oggetto sembrerà strano solo se ci
NOTE
Conclusione
129
130
rifiutiamo di considerare, con Merleau-Ponty, la carne come punto di partenza
della relazione soggetto-oggetto, la carne che è, lo ripetiamo, “indivisione di
questo Essere sensibile che io sono, e di tutto il resto che si sente in me”27.
Detto altrimenti, un tale sconfinamento ci stupirà solo se pensiamo la relazione io-oggetto senza tener conto della situazione d’indivisione tra il corpo e il
mondo che ne è lo sfondo.
Si dovrà ammettere anche che, in un’ottica cartesiana, l’oggetto orale del
bambino è un oggetto molto strano e sconcertante perché, visto attraverso le
lenti proiettive del bambino, l’oggetto della posizione schizo-paranoide è, per
un verso, l’istanza esterna alla quale si attacca la pulsione di morte –vale a dire
una realtà esterna– e, per l’altro, un’istanza interna d’identificazione –vale a
dire una realtà psichica.
Per quanto incomprensibile possa sembrare da un punto di vista cartesiano, una tale situazione dell’oggetto non sembrerà però sconcertante se si
ammette con Merleau-Ponty che il “dentro” e il “fuori” sono “dimensions de la
corporéité, avant d’être dimensions d’esprit et corps ou réalité” 28.
Concludo sollevando la seguente domanda: un tale oggetto nel quale il
bambino investe una parte del suo io e che esprime di ritorno quello che è, un
tale oggetto che, nella sua fantasia onnipotente fa parte di lui e continua la sua
unità prenatale con la madre, a cosa sarà destinato? Se si segue il cammino
aperto da Merleau-Ponty, un tale oggetto si rivela utile e pertinente –mi sembra– per comprendere il nostro rapporto con l’altro, che è inconcepibile se si
tenta di pensarlo come uno star di fronte ad un oggetto visto dall’esterno, perché l’altro “è preso nel circuito che lo collega al mondo, come noi stessi, e con
ciò anche nel circuito che lo collega a noi”29.
Proprio come l’oggetto precoce, il corpo dell’altro “è come una replica di me
stesso, un doppio errante ; esso frequenta il mio ambiente più che comparirvi, è la risposta inopinata che io ricevo altrove, o come se per miracolo le cose
si mettessero a dire i miei pensieri”30. “Ogni altro”, prosegue Merleau-Ponty, “è
un altro me stesso. È come quel doppio che quel malato sente sempre al suo
fianco, che gli assomiglia come un fratello, che non sa come fissare senza farlo
scomparire e che visibilmente non è che un prolungamento oltre se stesso”31.
Questo tipo di oggetto permette dunque una comprensione più adeguata della
nostra esperienza dell’altro e costituisce, a questo fine, una risorsa ontologica
più appropriata del sistema concettuale cartesiano.
1 Questo saggio è stato presentato il 12 marzo 2005 all’Université de Paris –I Panthéon– Sorbonne con il titolo Merleau-Ponty/Mélanie Klein: Une confrontation possibile, in occasione di un
convegno di formazione dottorale sul tema “Phénoménologie et psychanalyse”.
2 M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2003, p. 453.
3 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1999, p. 157.
4 M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, cit., p. 461.
5 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 274.
6 Ivi, p. 280.
NOTE
7 J. LAPLANCE, Faut-il brûler Mélanie Klein? in La révolution copernicienne inachevée, Aubier,
Paris 1992, p. 221.
8 J. KRISTEVA, Le génie féminin, Gallimard, Paris 2003.
9 Ivi, p. 101.
10 M. KLEIN, Note su alcuni meccanismi schizoidi, in Scritti (1921-1958), Boringhieri, Torino
1978.
11 H. SEGAL, Mélanie Klein: développement d’une pensée, P.U.F, Paris 1982, p. 114.
12 H. SEGAL, Introduzione all’opera di Melanie Klein, Martinelli, Firenze 1968, p. 33.
13 Ricordiamo che Melanie Klein distingue l’“identificazione proiettiva”, quale modalità della
proiezione dall’“identificazione introiettiva”, che è una modalità dell’introiezione.
14 J. KRISTEVA, Le génie féminin, cit., p. 102.
15 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 271.
16 P. RODRIGO, Ni le corps ni l’esprit. La chair de Husserl à Merleau-Ponty, in “Studia Phænomenologica”, vol.III, n. 3-4, 2003, p. 117.
17 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 163.
18 Ivi, p. 151.
19 Ivi, p. 160, nota.
20 T.F. GERAETS, Vers une nouvelle philosophie transcendantale, Martinus Nijhoff, La Haye
1971, p. 181.
21 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 150, nota.
22 M. KLEIN, Note su alcuni meccanismi schizoidi, in Scritti (1921-1958), cit. p. 410.
23 M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, cit., p. 459.
24 Ibid.
25 M. MERLEAU-PONTY, Prefazione a A. Hesnard, L’opera di Freud, Sansoni, Firenze 1971, p. 7.
26 J. KRISTEVA, Le génie féminin, cit., p. 103.
27 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 267.
28 M. MERLEAU-PONTY, Nota inedita, volume XVII dei Manoscritti depositati presso la Bibliothèque Nazionale de France, foglio 99 verso.
29 M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 280.
30 M. MERLEAU-PONTY, La prosa del mondo, Editori Riuniti, Roma, 1984, p. 137.
31 Ibid.
131
SAVIGNANO LETTORE DI MARÍA ZAMBRANO
di Nunzio Bombaci
132
Armando Savignano, docente di Filosofia Morale presso l’Università di Trieste nonché autore di importanti saggi su Miguel de Unamuno, Xavier Zubiri,
Ortega y Gasset, è indubbiamente uno dei più noti studiosi italiani della filosofia spagnola del Novecento. Questo volume –piccolo nella mole ma estremamente ricco di riferimenti agli autori suddetti– è dedicato al percorso intellettuale di María Zambrano (Vélez-Malaga 1904 – Madrid 1991) e costituisce una
ulteriore attestazione della competenza con cui egli tratta i nodi teoretici più rilevanti di tale filosofia. Per lo studioso che non si è mai accostato al pensiero iberico novecentesco, esso può costituire un valido stimolo a prestare maggiore
attenzione a un ambito culturale non ancora conosciuto in modo adeguato.
Il libro (María Zambrano. La ragione poetica, Marietti 1820, Genova-Milano,
2004, pp.163) ripercorre la parabola esistenziale e filosofica di un’autrice che
la cultura italiana ha scoperto solo da qualche lustro e, nella ricorrenza del centenario della nascita, intende offrire –in una prospettiva tutt’altro che “venerativa e meramente esegetica”– un contributo alla valutazione della originalità del
suo pensiero, “la cui attitudine può essere considerata una filosofia in tempo di
crisi” (p.9). Sul piano dossografico, peraltro, il volume offre un valido approccio
alla più autorevole letteratura secondaria riguardante l’opera zambraniana (A.
Guy, A. López Quintas, J.J.L. Aranguren, J.F. Ortega Muños, J. Moreno Sanz,
Ch. Maillard, A. Bundgard).
In particolare –osserva Savignano– Chantal Maillard, ha esaminato le condizioni di possibilità della “ragione poetica” di Zambrano quale peculiare forma
di conoscenza. Tale indagine pone in luce che “il fare proprio dell’uomo che fa
se stesso, è ragione poetica, ragione creatrice (p.15). Opportunamente, Maillard presta attenzione al topos zambraniano espresso metaforicamente come
“sogno creatore”: la vita stessa è sogno, la nascita comporta sia la nostalgia
per il paradiso perduto sia l’accesso alla libertà connaturale all’esistenza. Ana
Bundgard, da parte sua, evidenzia che, con il passare degli anni, per Zambrano la ragione poetica “si trasforma da metodo di apprensione della realtà e
della storia a attitudine mistica” (pp.15-16). Ancora, secondo questa studiosa,
nelle opere della maturità, allorché l’autrice andrebbe “al di là della filosofia”
(más allá de la filosofia), la scrittura zambraniana diventa “trascrizione” delle
“ragioni del cuore”, luogo di rivelazione dell’essere e della verità. Sta qui il
“segreto” che coincide con lo stesso atto di scrivere, come sottolinea proprio
Zambrano in Por qué se escribe (1934) e Hacía un saber sobre el alma (1950).
Savignano ritiene di potere sintetizzare quanto i critici summenzionati hanno
affermato riguardo alla ragione poetica scrivendo che essa costituisce una
NOTE
“attività fenomenologica”, poiché “non si tratta di descrivere il darsi diretto di un
oggetto nella sua intentio recta ma di costeggiarlo, facendo sorgere da un dire
indiretto la sua configurazione come accadimento intimo. La ragione poetica
[…] svela l’azione stessa in cui hanno luogo le forme intime della vita
umana”(p.18).
Nel suo saggio, Savignano mette in rilievo la forte connotazione etico-politica degli scritti anteriori all’esilio, nei quali la filosofa si schiera a favore della
causa repubblicana e contro le forze reazionarie. Zambrano vi propugna una
“riforma dell’intelligenza” volta a “rompere il mutismo del mondo”. In questi anni
ella sottolinea l’esigenza di contribuire all’affermazione di una democrazia fondata sui valori della persona. Mentre la coeva riflessione personalista, in auge
soprattutto in Francia e Germania, contrappone non di rado le nozioni di “persona” e “individuo”, negli scritti politici dell’autrice si riscontrano lapidarie affermazioni riguardanti la differenza tra “persona” e “personaggio”: “il personaggio,
per quanto sia storico, lo rappresentiamo, mentre la persona lo siamo”(Persona y democrazia, 1958, cit. a p. 62). Essere necessariamente persona equivale, per Zambrano come per Ortega, a essere “necessariamente libero”. La
democrazia, poi, è per la filosofa “la società dove è permesso, anzi necessario essere persona”.
A giudizio di Savignano, gli scritti giovanili di Zambrano vanno comunque
esaminati “alla luce delle suggestioni mutuate dal maestro Ortega, del sentimento tragico di Unamuno, della metafisica pratica di Machado e del sistema antropologico-religioso di Zubiri” (p.9). Negli anni del lunghissimo esilio,
poi, l’autrice va elaborando la categoria di “ragione poetica” e tributa grande
attenzione alle connessioni, vitali e tenaci sebbene non sempre manifeste,
tra filosofia, poesia e mistica. La “ragione poetica”, in fondo, viene considerata da Savignano come il principium individuationis del pensiero maturo
(ovvero della “filosofia poetica” o “poesia filosofica”) di questa “discepola eterodossa” di Ortega y Gasset, l’assertore della “ragion vitale”. Per l’autrice, la
ragione poetica offre un percorso volto ad affrancare il pensiero dall’astrattezza del razionalismo e dell’idealismo. Nelle opere più tarde, inoltre, si ravvisa una chiara attitudine mistica, e “Zambrano volta le spalle alla storia per
fare appello al sogno creatore e decifrare attraverso la scrittura quel segreto
onde comunicarlo nel segno della pietà che equivale a saper trattare adeguatamente con l’altro”(p.10). In tali scritti l’intento dell’autrice è quello di
recuperare l’“unità originaria” di filosofia, poesia e religione, ovvero quell’unità antecedente al costituirsi della metafisica nel pensiero occidentale. Ella
spera che, dopo l’allontanamento della filosofia dalla poesia, la loro unità si
ricomponga, e scrive: “Non sarà possibile che un giorno fortunato la poesia
raccolga tutto ciò che sa la filosofia, tutto ciò che apprese nel suo allontanamento e dubbio, per fissare lucidamente e per tutti il suo sogno?” (Filosofia
y poesia, 1939, cit. a p.100).
Uno dei motivi di interesse del saggio di Savignano è costituito dal serrato
susseguirsi degli agili quanto penetranti parallelismi che esso istituisce tra
Zambrano e autori quali Unamuno, Ortega, Zubiri e Machado, rilevando il debito intellettuale da lei contratto nei loro confronti e, al contempo, l’autonomia con
133
134
cui la filosofa –come, del resto, ogni autentico discepolo– sa avvalersi dei guadagni teorici di questi maestri per costruire il suo percorso. Lo studioso, pertanto, non manca di rilevare le analogie e le differenze tra la ragione poetica di
Zambrano, la ragion vitale di Ortega, la religione poetica nell’agonismo di Unamuno, la fede poetica di Machado, nonché tra il “sentire illuminante” di cui parla
l’autrice e l’“intelligenza senziente” delineata da Zubiri.
Zambrano, che appartiene alla “generazione del ’27”, nutre una profonda
ammirazione per “don” Miguel de Unamuno, il gigante della “generazione del
’98”, del quale apprezza –e, in España, sueño y verdad (1965), fa suo– il
“discorrere per metafore”, modalità originaria di accesso al reale, radicata nell’immaginazione creatrice, e che nel reale stesso coglie ciò che sfugge alla
presa del pensiero concettuale. La metafora, per Unamuno e Zambrano, veicola quella sapienza poetica che è l’unica matrice della poesia e della filosofia,
e in particolare della filosofia spagnola, poco propensa ad esprimersi nella
forma dei grandi sistemi. Per entrambi, solo un pensiero che sappia restaurare i legami vitali tra la filosofia e la conoscenza poetica, la quale coglie la verità delle cose quasi per tactum intrinsecum, può validamente delineare un percorso di salvezza per l’uomo europeo prostrato dalla crisi spirituale.
Ancora, per Unamuno e Zambrano, l’uomo si coglie originariamente nel
“sentirsi” anziché nel “pensarsi”. Zambrano, in Para una historia de la piedad
(1989), scrive che l’uomo concreto “ha” determinate “funzioni psichiche”, mentre non si può propriamente dire che “abbia” il “sentire”, poiché “è”, innanzitutto, “sentire”. In questo sentire originario, l’uomo coglie, per Unamuno, la sua
stessa finitezza. A quella che Ricoeur chiamerebbe “la tristezza del finito”, l’uomo di Unamuno reagisce affermando vigorosamente la sua volontà di immortalità, e abbraccia pertanto una fede fortemente permeata dal volontarismo.
Per Zambrano, invece, nello stesso “sentire” l’uomo fa esperienza della “lacerazione del proprio essere rispetto all’essere originario, dove il reale formava
un tutto armonico e unitario” (pp. 24-5). Alla nascita consegue la nostalgia per
l’essere originario, ma anche l’impulso ad autocrearsi per riunirsi ad esso.
Per Zambrano, se Unamuno è “autore” in quanto reca “parole di poetica
comunione” ed esprime in modo paradigmatico il genio spagnolo, Ortega è
“scrittore” e “filosofo” (Ortega, filósofo español, 1949). La ragione di Ortega,
per l’autrice, vuole innanzitutto intendere se stessa “per poter intendere la vita”.
Aranguren ha scritto che, se la filosofia di Ortega è fatta di idee, quella di Zambrano è fatta con le parole; il primo, cui non è estranea “l’ansia di sistema”, si
esprime di preferenza nel saggio, la seconda nel frammento. La differenza tra
la “ragion vitale” di Ortega e la “ragione poetica” di Zambrano (variante o rinnegamento della prima?) ha costituito materia di ampia discussione tra i critici, per i quali è inoltre tutt’altro che scevro di problematicità il rapporto della filosofa con la “scuola di Madrid”. La ragion vitale, ovvero il “logos del Manzanares” è volta a integrare, a “salvare le circostanze”, la ragione poetica è invece
luce che si proietta su una zona di penombra, poiché, nelle parole di Zambrano, “si fa carico delle viscere” (De la aurora, 1986), penetra nelle viscere stesse, nelle entrañas, fondo oscuro dell’umano che è al di qua e al di là della corrente dicotomia tra “mente” e “cuore”. Allo scrivente sembra di potere aggiun-
NOTE
gere che la ragione poetica vuole desentrañar, ovvero portare alla luce/leviscerare, ciò che trova il suo luogo nelle entrañas.
Ancora, il logos zambraniano, che pur non nega di avere avuto nella
ragione orteghiana uno stimolante punto d’avvio, riconosce la sua ascendenza orfico-pitagorica, nonché l’affinità con il logos di cui parlava Empedocle, il
quale “si deve ripartire bene per le viscere”. Osserva Savignano al riguardo:
“Zambrano ricerca l’oscurità delle ‘viscere’, quell’‘abisso della divinità’, che
sostiene l’essere e che si tinge di nostalgie religiose e di rivelazioni mistiche:
altrettante attitudini affatto distinte e distanti” (p. 38). In sintesi, per il critico,
ella, a differenza di Ortega, non ravvisa un percorso di salvezza semplicemente nella “riforma della ragione” propugnata dal maestro, ma in una ragione che si ampli e si transvaluti fino ad accostarsi senza timore alle “zone
insondabili dell’irrazionale” o, in altre parole, fino ad attraversare “le viscere”.
Ancora prima della prognosi della crisi, è differente, nei due autori, l’analisi
della temperie culturale europea. Per Ortega, essa comporta il declino di
determinate “credenze” sulla vita e sul mondo, mentre Zambrano, che pur
non nega tale fenomeno, rileva tuttavia il carattere di “rivelazione” proprio
della crisi, che permette di “poter vedere con più chiarezza” la vita umana.
Per l’autrice di La agonía de Europa (1945), non si tratta soltanto dell’avvento di una crisi delle “credenze”, ma “della messa in discussione del rapporto
tra l’essere umano e la realtà, con il conseguente venir meno del fondamento stesso di ogni credenza che in definitiva è di origine sacra” (p. 65). Eppure, l’esperienza della precarietà, del non-essere, del negativo, che la crisi
comporta è, per Zambrano, il terreno in cui si può affermare la speranza, la
lotta contro il nulla per “nascere continuamente”.
Se per Unamuno (Agonía del cristianesimo, 1924) è innanzitutto il cristianesimo ad essere “agonico”, per Zambrano è l’Europa tutta a dovere dispiegare una tempra “agonica” per superare una crisi che è soprattutto spirituale. A
suo giudizio, inoltre, l’Europa non ha realizzato il cristianesimo tout court, ma
“la versione europea del cristianesimo”. Mentre il Mounier di Feu la chretienté,
nella Francia degli anni Quaranta, rileva nella cristianità europea i segni di una
agonia che prelude alla morte, senza che ciò precluda il sorgere, anche in altri
continenti, di altre culture vivificate dal cristianesimo, Zambrano ritiene legittimo chiedersi se sia possibile l’avvento di un’altra “versione” del cristianesimo,
che sia cristiana ed europea al contempo. Per lei, comunque, l’Europa, anche
se “agonizza”, non potrà morire del tutto.
Savignano non manca poi di rilevare i punti di convergenza tra il pensiero
zambraniano, aperto peraltro alle sollecitazioni dell’umanismo socialista, e la
“metafisica poetica” di Antonio Machado, “con speciale riferimento alla ragione
poetica incentrata sul nulla quale base dell’essere, alla dialettica tra sacro e divino, alla funzione della parola creatrice quale via di incontro dell’essere alla luce
della critica all’attitudine razionalistica” (pp. 41-2). Zambrano ravvisa in Machado
un poeta profondamente partecipe della “mistica popolare” e animato nella sua
opera da una forte tensione etica. Va detto, comunque, che, mentre Machado
distingue tra poesia e filosofia, Zambrano, che filosofa poeticamente e poetizza
filosoficamente, vuole risalire all’unità originaria tra la prima e la seconda.
135
136
Anche il rapporto tra Zambrano e Zubiri presenta non pochi motivi di interesse. I corsi su Aristotele tenuti a Madrid da questo grande metafisico sembravano particolarmente “oscuri” alla giovane, che comunque trasse dalla
lezione zubiriana un forte impulso a studiare Spinoza e Plotino. Per quanto
attiene agli esiti teoretici del rapporto Zambrano/Zubiri, si può dire che per l’uno
e per l’altra, distanti al riguardo da Ortega, “l’essere ci viene dato nel sentire”.
D’altronde va posta in rilievo la non sovrapponibilità tra l’“intelligenza senziente” di Zubiri e il “sentire illuminante” di Zambrano. Per il primo, è in virtù dell’intelligenza senziente che l’uomo –unico “animale di realtà”– “apprende” la realtà stessa. Nell’apprensione del reale non ha luogo alcuna dicotomia tra “intellezione” e “sensazione”, in quanto queste sono compresenti in un unico atto,
l’intelligenza senziente. Quanto al sentire illuminante di Zambrano, per Savignano esso è “un’esperienza ineffabile e mistica, in cui si attua l’identità tra
pensare e sentire” e che si potrebbe accostare “all’apprensione primordiale di
realtà dell’intelligenza senziente” (p. 54).
Sempre per quanto riguarda il confronto tra Zambrano e Zubiri, il rapporto
tra uomo e divino si configura in modo diverso nei due filosofi, autori rispettivamente di El hombre y lo divino (1955) e El hombre y Dios (1984). Se “per Zubiri si perviene a Dio attraverso l’analisi della realtà nella quale anche l’uomo è
impiantato e ‘re-legato’, per Zambrano il divino si mostra, non senza nostalgia,
nell’assenza, nel nulla. La ‘scoperta’ di Dio assume in Zambrano una dimensione di vera ‘tragedia’, consistente nel ‘non poter vivere senza dei’, mentre per
Zubiri l’uomo è fondamentalmente esperienza di Dio” (pp.124-5). In El hombre
y lo divino Zambrano delinea una sorta di “topografia dell’Occidente”, attraverso la ricognizione delle forme in cui si è articolato al suo interno il rapporto tra
l’uomo e il trascendente, dalla primigenia avvertenza del “sacro”, del “pieno
della pienezza arcana, sacra” che “perseguita” l’uomo, alla rivelazione del divino –gli dei appaiono allorché si apre un varco nel “pieno”del sacro– all’avvento del cristianesimo, fino al processo spirituale che si svolge nella modernità e
conduce all’eclissi del divino.
Il saggio di Savignano, oltre a porre in rapporto María Zambrano con i più
grandi filosofi spagnoli del Novecento, prende anche in esame l’originale modo
di declinarsi dell’identità ispanica nel pensiero dell’autrice, soprattutto durante
il periodo dell’esilio (pp. 75-91). La riflessione su tale identità si afferma proprio
allorché ella fa l’esperienza dello sradicamento e le si rivela la verità della condizione dei “des-terrati” (desterrados), di coloro che non trovano più sostegno
nella “storia”, né in un “mondo”: l’esiliato è l’uomo estraniato persino dalla propria “circostanza”, per dirla con Ortega. Durante l’esilio, nella prospettiva zambraniana destinato a transvalutarsi da evento storico a categoria metafisica, la
filosofa apprende che la temporalità è la “sostanza della nostra vita” e che la
condizione umana è pellegrinaggio di chi “vive morendo”. Allora, il “muero porque no muero” di Teresa d’Avila –che, da mistica, considera questa vita come
un esilio dall’Amato, voluto dall’Amato– potrebbe essere condiviso da chi sperimenta la realtà di un esilio diverso, imposto dalla violenza degli uomini e
accettato per rimanere fedele alle proprie convinzioni.
L’esilio assurge comunque nella riflessione di Zambrano a luogo di rivela-
NOTE
zione dell’essere, nel quale los bienaventurados, “i beati”, possono fare esperienza dell’unità originaria, accostata nella nostalgia e nel sogno, tra essere e
vita. Nel libro Los bienaventurados (1990), ella afferma che la stessa”immensità dell’esilio” è simbolo della patria anteriore alla nascita, luogo al di qua della
separazione tra senso e bellezza, giungendo a scrivere: “Amo il mio esilio”.
Savignano osserva che, negli anni dell’esilio, la filosofa coglie l’essenza
dello spirito spagnolo “in una dimensione a-storica e mediante la ragione poetica” (p. 76). Per Zambrano, il nucleo generativo della cultura spagnola, e
segnatamente della cultura popolare, non è tanto l’“impressionismo” volto a
cogliere la “sensazione viva delle cose” di cui parla Ortega, ma è un singolare
realismo, una peculiare attitudine conoscitiva svincolata dalla volontà, che
comporta “una relazione immediata e spontanea con le cose, delle quali si è
innamorati e a cui ci si sente legati, incatenati a tal punto da mettere a repentaglio la stessa libertà” (pp. 83-4). La filosofa ravvisa in Seneca –pensatore
alieno dalla “volontà di sistema”, fautore non di una “ragione pura” ma di una
“ragione addolcita”, la quale sa dare voce alle ragioni del cuore ed essere terapeutica e consolatrice dei mali dell’animo– un testimone autorevole del genio
spagnolo (El pensamiento vivo de Séneca,1944). Il carattere ispanico consente a Seneca, pur in un tempo di profonda crisi, di mantenersi fedele ai valori
della tradizione in cui si è formato.
Zambrano si rapporta con una pietas discreta non solo alle figure storiche
dal destino tragico, come Seneca, ma anche ai personaggi del romanzo e della
tragedia. Ha scritto una studiosa spagnola: “In diversi luoghi della sua opera,
María Zambrano, di fronte a un fatto, o a un personaggio della letteratura, ha
considerato il romanzo, o la tragedia, come luogo di salvezza, ove sembra verrebbero a consegnarsi questi personaggi ormai dotati di un ‘essere’ dal loro
creatore, e che hanno trasceso la loro propria storia” (Julia Castello, “La tumba
de Antigona”: tragedia y misericordia, in AA.VV., El pensamento de María Zambrano, Madrid, 1983, p.106).
È di particolare interesse, alla luce di tali considerazioni, la rilettura proposta da Zambrano dell’Antigone sofoclea. In La tumba de Antígona (1967), ella
apporta un’importante modifica alla vicenda dell’eroina, suicida nella tragedia
di Sofocle. Nella reinterpretazione di Zambrano, Antigone, reclusa nella tomba,
vive invece un ulteriore dramma interiore, che la conduce a una nuova
coscienza di sé. Savignano osserva che questa opera, vista talora dai critici
come”tragedia autobiografica e religiosa” o come “confessione poetica” di chi
ha conosciuto la guerra civile e l’esilio, è stata anche interpretata quale “archetipo della coscienza aurorale dell’uomo mediante il sacrificio quale scaturigine
della coscienza umana nella libertà e nella pietà” (p. 106). L’Antigone zambraniana, attingendo la chiara coscienza di sé, aprendosi all’amore e alla pietà, si
affranca anche dalla predestinazione divina. Ella diventa qui l’archetipo della
“stirpe dei murati”, alla quale appartiene anche María Zambrano: non solo
“murati vivi”, ma “viventi”, che conducono la loro esistenza “in luoghi sognati o
in mezzo alle città tra uomini indifferenti”, in un tempo “che li avvolge in una
specie di grotta che può nascondere un prato o un giardino in cui viene offerto loro un frutto puro o un’acqua viva che occultamente li sostiene: sogno, car-
137
138
cere, a volte, silenzi impenetrabili, malattia, alienazioni” (La tumba de Antigona, cit. a p.107). Come Giobbe, altra figura su cui ha indugiato la pietas di Zambrano in El hombre y lo divino, allorché è abbandonato dal “suo” Dio –dal Dio
fino allora che aveva vegliato sulla sua tenda– avverte il mistero della propria
trascendenza, nella impossibilità stessa di sopprimere la sua coscienza, persino quando non è più che un “viscere” nudo che geme e grida, così Antigone,
nella sua reclusione, perviene alla chiarezza dell’autocoscienza che, insopprimibile, trascende anche la condanna degli uomini e i dettami del destino.
Lo stesso atteggiamento di rispetto informa la lettura del Don Chisciotte di
Cervantes proposta da Zambrano. Anche don Chisciotte diventa nella riflessione dell’autrice una figura paradigmatica, archetipo dell’uomo “la cui volontà
urta con la realtà storica rispetto alla quale egli si rifugia nella follia per additare la giustizia e il bene” (p. 109). L’eroe di Cervantes, testimone dei valori che
sostengono la convivenza umana, quali la solidarietà e la fiducia, è “solo e lontano dagli uomini”, ma non ne è isolato, poiché è “unito e coinvolto con essi
mediante la volontà”. La sua volontà, anzi, è così forte da rendere reale questo “ente di finzione” quanto gli essere umani in carne e ossa. Ciò vale per
Zambrano come per Unamuno. Ancor più degli uomini in carne e ossa, don
Chisciotte custodisce un mistero e un’ambiguità che resiste a ogni tentativo di
chiarificazione. Zambrano, pertanto, non manca di rilevare il limite delle interpretazioni di questa figura proposte da Unamuno e Ortega, che credono con le
loro analisi di potere dissolvere il mistero del personaggio, di “questa figura
quasi mitologica della coscienza”. Essa, come i personaggi letterari e gli uomini reali, reca in sé un “sogno” refrattario alla descrizione fenomenologica. Nei
confronti di don Chisciotte, l’atteggiamento di Zambrano è forse più simpatetico rispetto a quello di Cervantes, cui viene rimproverato l’avere trasformato
l’eroe tragico in personaggio romanzesco, esposto alla burla per avere tentato
l’impresa, legittima perché umana quanto nessun’altra, di “inventare se stesso”, identificandosi con il proprio sogno.
Ancora, la pietas di Zambrano nei confronti degli “enti di finzione” –espressione che, alla luce di quanto detto, non rende giustizia alla consistenza della
loro verità umana– ha modo di dispiegarsi in pagine molto suggestive allorché
ella presta attenzione ai personaggi dei romanzi di Benito Perez Galdós (18431920). Questi, in particolare nel romanzo Misericordia, ha per lei il merito di
avere “transustanziato” in poesia l’essere della Spagna, di avere rappresentato il popolo spagnolo “come è in realtà, vero, come una parola di Dio” (Delirio
y destino, 1952, cit. a p. 117), perforando la superficie dei fatti storici per raggiungere la “corrente della vita che li alimentò” (La España de Galdós,1960).
Nei personaggi galdosiani, Zambrano coglie il conflitto connesso “al dualismo tra vita e storia, vita e realtà, realtà e verità: altrettanti elementi che alludono ad un principio unitario perduto, ad un centro preesistente al risveglio
della coscienza” (p. 120). La realtà si presenta come caos, lacerazione, dispersione –quasi come il regnum dissimilitudinis della tradizione agostiniana– mentre la vita è “unità” allorché è vissuta non dal personaggio ma dalla persona.
L’esperienza della vita come unità accade in momenti, in luoghi privilegiati, nei
“chiari del bosco che gli alberi hanno nascosto”. Claros del bosque è, appun-
NOTE
to, il titolo di uno dei libri più noti di Zambrano, pubblicato nel 1977. Per il poeta
J.A. Valente il sapere che si rivela nel chiaro del bosco è un “sapere della parola perduta”, secondo A. Bundgard nell’opera “la verità si mostra in un’esperienza al di là del linguaggio, nell’ineffabile simboleggiato nel ‘chiaro’, che allude a
una ‘parola originaria’ trascendente il linguaggio ordinario” (p.154). Savignano
scrive che l’autrice prospetta nel libro “una ‘nuova filosofia’, incentrata sull’ascolto della voce dell’essere occulto che a tratti si svela rendendosi visibile”(p.155). La ragione poetica coglie qui un sapere frutto di esperienza, “la presenza di un’assenza” che è indice del sacro e che precede ogni articolazione
linguistica. Non si tratta di una verità oggetto di una visione, ma della verità che
esige l’attitudine dell’ascolto.
Il claro del bosque, analogamente alla Lichtung di Heidegger è “luogo di
incontro simultaneo di luce ed oscurità, dove l’esistente è illuminato nel suo
stesso essere” (p. 156). Si tratta, per Zambrano, di un luogo accessibile non
alla ragione strumentale –ché, anzi, l’egemonia di questa ha condotto fino
all’oblio dell’essere e all’eclissi del divino– ma alla ragione poetica del poetafilosofo, di colui che in momenti di abbandono mistico può, attraverso la discesa agli inferi, alle “viscere” (quasi attraversando la “notte del senso” e la “notte
dello spirito”, nel linguaggio di San Giovanni della Croce), attingere quel “sentimento illuminante” ove coglie il vincolo tra l’uomo e il sacro nell’amore, fiamma che arde senza mai consumarsi.
139
DEMOCRAZIA PLURALISTICA E
SOCIETÀ GLOBALE IN MICHAEL WALZER
di Piero Venturelli
140
Da sempre scettico nei confronti di ogni sorta di filosofia speculativa o strettamente normativa, Michael Walzer è interessato ad esaminare situazioni reali e a
misurarsi con gli aspetti più prosaici della dimensione politica (marce, congressi,
campagne ecc.), prestando contestualmente attenzione cospicua al particolare, e
tuttavia rifiutando di arrestarvisi: mentre da un lato egli sovente non disdegna di
allargare la sua prospettiva d’indagine, dall’altro mostra però di considerare velleitaria la pretesa di raggiungere dimensioni onnicomprensive. Basare le proprie
analisi su casi concreti e sulle tensioni del vivere associato, richiamandosi alla
sfera dell’ordinario, lo porta a ricusare sistematicità e ambizioni fondative, cui con
vigore contrappone una critica effettuata nel nome del senso comune. Inoltre, egli
giudica opportuno adottare un approccio laico e pragmatico per prestare ascolto
alla voce degli uomini riuniti in società, salvaguardando la facoltà di ciascuno di
dissentire, e per promuovere più acute interpretazioni del mondo. Come si osserva, Walzer intende mettere sotto scacco le forme assolutistiche di pensiero grazie
agli strumenti della pubblica discussione e della trattativa, evidenziando così di
attribuire un ruolo cruciale nell’esistenza umana alla dimensione attiva e partecipata della politica, nelle cui possibilità egli nutre grande fiducia.
Di queste posizioni walzeriane offre una testimonianza di prim’ordine la
recente selezione di saggi Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo1, volume che raccoglie sei testi scritti dal critico americano tra il
1971 e il 2000. Considerevole è, in particolare, lo spazio che l’Autore qui riserva
all’idea e alle funzioni della società civile. “L’espressione ‘società civile’ –afferma
Walzer– definisce lo spazio di associazione umana non coercitiva e altresì l’insieme di sistemi relazionali –formati per motivi di famiglia, di fede, d’interesse, e
d’ideologia– che riempiono questo spazio”2. In tale “ambiente degli ambienti”, gli
individui possono essere liberi ed eguali, connessi fra loro e mutuamente responsabili, giacché sono tutti potenzialmente inclusi e nessuno vanta privilegi. Su
questo terreno agisce la politica che –spiega Thomas Casadei nell’ampia nota
introduttiva all’opera– si configura, per Walzer, “come delimitazione di spazi,
creazione di forme, relativamente stabili, di confini, come costruzione di relazioni fra soggetti e gruppi identificabili anche nelle loro differenze”3. Pertanto, secondo l’autore americano, il compito della politica consiste nel garantire la possibilità delle relazioni sociali, nelle loro manifestazioni cooperative e conflittuali, mentre per i communitarians più radicali essa è finalizzata a costituire l’identità, a
dare ragioni di vita o ad assicurare la rigenerazione spirituale. Tuttavia, egli ritiene che la politica possa stimolare il dibattito e la capacità deliberativa dei cittadini, ossia dare veramente i suoi frutti, solo nel caso in cui non venga delegato
NOTE
completamente a funzionari, esperti o giudici il compito di decidere. Questa sua
critica è palesemente indirizzata a filosofi normativi contemporanei quali John
Rawls, Ronald Dworkin, Bruce Ackerman e Jürgen Habermas.
La presenza di uomini e donne dinamici e impegnati a diversi livelli fa sorgere un aperto e proficuo contraddittorio intorno ai differenti progetti circa lo
stato, la nazione, l’economia e il mercato, concezioni che sono relativizzate e
riunite insieme nell’ambito della società civile affinché una di queste dimensioni non diventi onnicomprensiva e non limiti quindi le possibilità di autodeterminazione e di felicità di ciascuno. Nel complesso e ambivalente mondo contemporaneo, gli individui sono più che mai esseri multipli e flessibili, dotati cioè di
identità formatesi per moduli sovrapposti attraverso la possibile appartenenza
a più di un gruppo; onde, per Walzer, il trionfo di una prospettiva unilaterale
sarebbe oggigiorno un’evenienza dagli effetti distruttivi4.
È sua convinzione che ogni singolo individuo possa vedersi riconosciuta la
propria identità “parziale molteplice” ed avere accesso a infinite opportunità per
il presente e per il futuro solo se è ben salda una democrazia radicale e partecipativa, sociale e pluralista. Il potere esercitato dai comuni cittadini sancisce l’instaurazione e la permanenza di una contestatory democracy, contrassegnata da
quel conflitto “mite” (ovvero da quella “coesistenza agonistica”) che, come osserva Casadei, lo studioso americano ritiene immanente a una società civile accorta e vivace. A giudizio di Walzer, la “vita associativa della società civile è l’effettivo terreno ove tutte le versioni del bene sono elaborate e testate […] e si rivelano parziali, incomplete, in conclusione insoddisfacenti. Non si tratta del caso per
cui vivere su questo terreno è bene di per sé; non vi è alcun altro posto in cui
vivere. Ciò che è vero è che la qualità della nostra attività politica ed economica
e della nostra cultura nazionale è intimamente connessa alla forza ed alla vitalità delle nostre associazioni”5. Per questo motivo, nella partecipazione sociale a
diverse sfere e attività è possibile riconoscere la robustezza degli assetti democratici e il miglior antidoto contro i rischi di disintegrazione.
Avverte Walzer che alla società civile non sono connaturate aspirazioni
antistatalistiche; anzi, essa si giova dell’intervento politico dello stato (ma di
uno stato autenticamente democratico), in modo che il luogo di confronto e di
negoziazione tra gli uomini, lungi dal degenerare nella legge del più forte, conservi inalterata la sua funzione di sintesi ed espressione del pluralismo. Lo
stato, in altri termini, è disposto ad ammettere una molteplicità di posizioni e
punti di vista, ma pretende che, al medesimo tempo, i loro sostenitori si tollerino (o agiscano come se si tollerassero) reciprocamente: solo così, su un piano
di uguaglianza politica e in forma “mitigata”, vengono resi possibili il disaccordo e il conflitto senza fine, e la trattativa giorno per giorno (il cuore stesso dell’agire democratico), fra tutti i portatori di opinioni e valori.
Unicamente nella società civile l’uomo impara ad essere socievole e a collocarsi in una dimensione comunitaria che non sacrifichi capacità e caratteristiche individuali, bensì le valorizzi. Secondo Walzer, solo in questo ambito l’uomo può vivere bene, dal momento che la società civile è “la sfera della frammentazione e della
lotta, ma altresì di solidarietà concrete ed autentiche, ove […] diventiamo uomini e
donne socievoli o comunitari. E questo è, naturalmente, di gran lunga la cosa
141
142
migliore che si possa essere. Il quadro qui è quello di persone che si associano e
comunicano liberamente le une con le altre, formando e riformando gruppi di ogni
genere, non per amore di un qualche schieramento particolare –famiglia, tribù,
nazione, religione, comunità, fratellanza o sorellanza, gruppo d’interesse o movimento ideologico– ma per amore della socialità stessa. Poiché noi siamo, per natura, esseri sociali, prima che esseri politici o economici”6. In queste ultime considerazioni del critico americano, si può rinvenire una certa affinità col punto di vista del
filosofo della morale e del diritto, anch’egli di origine ebrea, Joseph Raz e con la
posizione espressa da Hannah Arendt soprattutto in Vita Activa.
Nel complesso, Walzer definisce la sua prospettiva “associazionismo critico”.
Oltre a rivelarsi frutto della radicalizzazione dell’orientamento già costitutivamente ‘plurale’ del modello americano di coesistenza e integrazione, la cui funzionalità gli sembra scaturire in primo luogo dall’aver “fatto propria l’idea protestante
dell’associazione volontaria”7 e dal porsi come obiettivi cardinali la salvaguardia
della massima libertà individuale e la lotta contro l’“irenismo” e il “silenzio” pubblico8, l’“associazionismo critico” walzeriano –puntualizza Casadei– sottende
una “idea di socialismo altra rispetto alle forme dominanti nel corso del Novecento […]: un socialismo innervato di istanze morali, umanistico ed etico, e ospitale
nei confronti di alcuni elementi marcatamente liberali”9, i cui principali referenti
sono autori statunitensi quali John Dewey, Irving Howe, Michael Harrington e la
cerchia di intellettuali raccolta fin dagli anni Cinquanta del secolo scorso intorno
alla rivista radical «Dissent», ma anche figure significative del movimento operaio europeo, tra cui spiccano quelle di Richard H. Tawney e di Eduard Bernstein.
Walzer giudica inattingibile la pace eterna e assoluta. A suo avviso, non si
dà un bene ultimo, sommo, dominante sul quale tutti concordino (egli si rivela,
in questo, distante dall’aristotelismo e dai communitarians neoaristotelici più
ortodossi), perciò la tutela della vita ordinaria e della coesistenza richiede un
accordo autenticamente alla portata degli sforzi umani. Walzer indica nella
pace politica, fondata sul dialogo e sul compromesso sempre fragile, questo
tipo d’intesa concretamente raggiungibile dalle collettività. Dimensione per
eccellenza in cui a trionfare è l’agire costituito da un intreccio di ragione e passione, di sfera razionale e sfera emotiva10, la politica consente di pervenire non
tanto a una verità univoca, quanto a innumerevoli verità sempre contingenti,
che traggono origine dall’assenso conquistato tramite il processo di decisione
democratica: quindi, anche i sostenitori di prospettive unilaterali (filosofiche,
religiose, ideologiche) sono da considerarsi alla stregua di semplici portatori di
convinzioni e, come tali, essi devono imparare a ‘politicizzarle’, rinunciando
alla loro assolutezza, per divenire compartecipi a pieno titolo di negoziazioni
che producano forme di convivenza soddisfacenti.
Walzer confida che, rafforzando l’amicizia sociale e la cooperazione tra i
singoli come pure potenziando il ruolo della politica, sempre più individui giungeranno a riconoscere la legittimità delle decisioni democratiche, evitando così
che il dogmatismo rappresenti l’ultima parola: “in una società pluralistica l’impegno della gente [ha] l’effetto di sradicare ideologie e prese di posizione razzistiche o sciovinistiche”11, e di promuovere la costituzione di un ancor più
vasto e tollerante dibattito pubblico, ove critiche, adattamenti, compromessi e
1 M. WALZER, Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo, a cura di Th.
Casadei, Diabasis, Reggio Emilia 2002.
2 Ivi, p. 71.
3 TH. CASADEI, Fragilità e permanenza della politica: gli itinerari di Michael Walzer, saggio introduttivo a M. WALZER, Il filo della politica, cit., p. XXXV.
4 Sulla multi-dimensionalità degli individui, cfr. soprattutto M. WALZER, Geografia della morale.
Democrazia, tradizioni e universalismo, Dedalo, Bari 1999, pp. 41-49 e 91-109.
5 M. WALZER, Il filo della politica, cit., p. 82.
6 Ivi, pp. 81-82.
7 M. WALZER, La libertà e i suoi nemici, intervista a cura di M. Molinari, Laterza, Roma-Bari
2003, p. 20. Sui legami associativi “volontari” e “involontari”, cfr. M. Walzer, Ragione e passione.
Per una critica del liberalismo, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 13-36.
8 Sul pluralismo garantito dal modello politico-sociale americano, cfr. soprattutto M. WALZER,
Sulla tolleranza, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 43-49 e 129-154.
9 TH. CASADEI, Fragilità e permanenza della politica, cit., p. XXV.
10 Sul ruolo della ragione e del coinvolgimento emotivo nell’ambito della lotta politica, cfr. M.
WALZER, Ragione e passione, cit., in particolare pp. 61-85.
11 M. WALZER, Sulla tolleranza, cit., p. 148.
12 M. WALZER, Il filo della politica, cit., pp. 138-139.
13 Ivi, p. 141.
14 Ivi, p. 138.
NOTE
revisioni senza fine siano riconosciuti quali aspetti ordinari e imprescindibili
della vita in comune.
Nell’ultimo saggio della raccolta, intitolato Governare il mondo: qual è la
cosa migliore che possiamo fare?, Walzer instaura un parallelismo tra società
civile e società internazionale: ambedue si configurano come regni della frammentazione, del contrasto e della trattativa. A suo giudizio, anche su scala globale si deve edificare un “regime capace di fornire un contesto per la politica
nel suo senso più pieno e per il più profondo impegno di comuni cittadini”12, un
pluralismo che possa rafforzarsi praticandolo, che sappia salvaguardare i diritti individuali e le differenze culturali e religiose, e che offra la più ampia gamma
di opportunità per l’azione politica a favore della pace e della giustizia; concorre altresì a rafforzare il baluardo contro la non impossibile affermazione di una
tirannia planetaria il riconoscimento di centri alternativi e di una rete sempre più
fitta di legami sociali, che valichino i confini di stato. Accantonate a priori le teorizzazioni di carattere giusglobalistico e “la speranza di conseguire la pace perpetua, la fine del conflitto e della violenza, ovunque e per sempre”13, egli prospetta una forma di global pluralism che consiste, per usare le sue parole, nella
“nota anarchia di stati, mitigata e controllata da un triplice insieme di agenti non
statali: organizzazioni come le Nazioni Unite, le associazioni della società civile internazionale e le unioni regionali come la Comunità Europea”14.
Dunque, come risulta ben evidente anche in questa selezione di saggi, allo
scopo di far convivere le tensioni tipiche del mondo contemporaneo, tanto a livello locale quanto a livello globale, Walzer propone un modello di democrazia aperta, radicale e partecipativa, caratterizzata dal conflitto e da momenti di coesione,
cioè dal contrasto fra rivendicazioni particolaristiche e attitudini solidaristiche. Ed
è grazie agli strumenti della politica che gli antagonismi possono trovare una composizione, anche se solo temporanea e continuamente rinegoziata.
143
ORONZO SUMA 1880-1954
UNA TESTIMONIANZA
di Gaetano Scatigna Minghetti
144
“La verità di dio come verità di esperienza”; esperienza interiore, beninteso!
È, essa la massima, il principio che può essere ricavato, grosso modo, dallo
studio delle opere edite e manoscritte che il filosofo Oronzo Suma ha redatto
nel corso della propria esistenza di ricercatore e di uomo di pensiero, svoltasi
sempre all’insegna della più rigorosa coerenza speculativa, all’ombra del suo
maestro Franz Brentano, che, agli inizi del ’900, e fino allo scoppio del primo
conflitto mondiale, aveva soggiornato in Firenze, all’epoca il centro culturalmente più vivace dell’intera Penisola italiana.
Qui, il Suma, giovane sacerdote della diocesi di Oria, nell’antica Terra
d’Otranto, si era recato per la laurea in filosofia, che conseguì poi, brillantemente, con Francesco de Sarlo, un meridionale della Lucania che, all’università di Firenze, teneva cattedra partecipando con forza ed intensità inusitate al
dibattito culturale e filosofico che in seguito sarà continuato, sempre con lo
stesso alto profilo, dai suoi discepoli Gaetano Capone Braga, Giovanni Calò,
Eustachio Paolo Lamanna, Antonio Renda.
Oronzo Suma, in un rapporto di filiale devozione e di amicale confidenza,
invece legatosi al Brentano, ne seguì l’itinerario speculativo rielaborando poi,
per quarant’anni e fedelmente, il pensiero del maestro avendo comunque
come costante riferimento Francesco Pietro Maine de Biran, alla cui vicenda
gnoseologica aveva dedicato la propria tesi di laurea, discussa, a Firenze, il 24
luglio del 1911.
Nato a Ceglie Messapica, a quel tempo ancora in provincia di Lecce, il 23
luglio del 1880, Oronzo Suma si era subito rivelato come persona dotata di un
ingegno perspicace e di una versatile vivacità.
Intrapresi gli studi nel seminario vescovile di Oria, importante per aver formato generazioni di sacerdoti colti ed intelligenti, Oronzo Suma ricevette l’ordine sacro ma volle continuare gli studi fino a pervenire alla laurea e al diploma del Corso di Perfezionamento in Filosofia. Il 27 giugno del 1914.
Sempre nel 1914, la sua prima pubblicazione: Dell’origine e del fondamento psicologico dell’idea di Giustizia, che ebbe la città di Pistoia come luogo di
stampa, seguita, nel 1915, dalla edizione de L’analisi della coscienza. La
coscienza come forma di apprensione per i tipi della casa “Attilio Razzolini” di
Firenze, che “scosse il de Sarlo dai suoi sogni speculativi”, come ebbe ad
esprimersi Michele Giorgiantonio, su “Il Mondo”, il 25 settembre del 1926.
Rientrato a Ceglie, anche per le pressioni della famiglia, Oronzo Suma mise
al servizio della comunità di origine la propria esperienza culturale e didattica
maturata a Terni, nell’odierno Lice ginnasio “G. C. Tacito”, e a Taranto, presso
NOTE
l’“Archita”, uno degli Istituti liceali ad indirizzo classico più prestigiosi del Mezzogiorno d’Italia, fondato nel 1943, la prima Scuola Media Comunale Autorizzata, che diresse per alcuni anni, in seguito ritirandosi a meditare, con pacatezza appartata; in un suo podere nella campagna di Ceglie.
Nello scorso mese di novembre 2004 si sono compiuti cinquant’ anni dalla
sua scomparsa, che è avvenuta a Ceglie Messapica il 24-XI-1954; ricorrenza
passata nel più totale silenzio: “Hai fatto bene a inviare un necrologio di Suma
a ‘Sophia’. Egli merita di essere segnalato e distinto dai vanitosi cerretani della
filosofia contemporanea”. In questi termini, che chiaramente sottolineano la
considerazione notevolissima in cui era tenuto Oronzo Suma, si espresse
Gaetano Capone Braga, dell’Università di Firenze, alcuni giorni dopo la dipartita del Filosofo, scrivendo a Michele Giorgiantonio, a Napoli.
Ora, questo scritto intende aprire un piccolissimo varco nella persistente
dimenticanza per ricordarlo agli studiosi, ma altresì per testimoniare la memorabile, attiva presenza nell’ambito degli studi filosofici italiani e per evidenziare
come in Italia, nella prima metà del XX secolo, non esistessero soltanto i capiscuola del neoidealismo ed i loro epigoni, ma anche altri ricercatori, altre correnti di pensiero, altri itinerari, ancora, speculativi di profonda ed “interiore
organicità” che, senza alcuna fanfara e privi di ogni battage massmediatico,
operavano, si, nel silenzio, ma con estrema efficacia, per rispondere credibilmente ed in modo significativo agli eterni interrogativi che l’uomo, nella complessità della sua articolata realtà interiore, sin dalla sua genesi, si è posto continuamente.
Uno di questi era il filosofo Oronzo Suma, l’“ultimo discepolo di Franz Brentano”, che si era prefisso, come stile, come cifra di vita, l’estrema coerenza tra
ricerca teorica e prassi reale, giungendo ad una sintesi viva che non lasciava
iati si sorta nel proprio percorso intellettuale e morale.
145
PIERRE LEROUX E GEORGE SAND
(La filosofia e la letteratura “de l’humanité”)
di Antonio Stanca
146
Nella storia il pensiero filosofico ha accompagnato la produzione letteraria ed
artistica contribuendo a caratterizzare, con essa, l’atmosfera culturale di una
determinata epoca o periodo storico. Gli esiti delle due attività sono rimasti, tuttavia, distinti giacché il processo della creazione artistica è diverso da quello dell’elaborazione filosofica, più libero dai vincoli della ragione, della logica, più
immediato, più pronto a seguire il sentimento, l’istinto, la passione.Questo non
impedisce che tra opere di filosofia e opere d’arte possano esserci delle relazioni o mutuazioni soprattutto quando il filosofo e l’artista sono o si sentono partecipi dello stesso clima culturale o sociale, della stessa spiritualità. Così è avvenuto nella Francia dell’’800 per la filosofia di Pierre Leroux (1797-1871) e la letteratura di George Sand (1804-1876). La scrittrice, in una fase della sua vastissima produzione, dichiarava di voler volgarizzare la dottrina lerouxiana poiché “la
sola che parli al cuore come il Vangelo” e da lei sentita come l’unica che potesse soddisfare i suoi bisogni di donna e narratrice, le sue esigenze umane ed artistiche. L’incontro con Pierre Leroux e il suo pensiero era avvenuto quando la
Sand aveva già prodotto opere di narrativa ed aveva rappresentato per lei la scoperta di una dimensione e prospettiva più ampie rispetto a quelle fino ad allora
perseguite. Verranno i romanzi “Spiridion”, scritto forse da Sand e Leroux insieme, “Il compagno del giro di Francia”, “Il mugnaio di Angibault”, “Il peccato del
signor Antonio”, “Horace”, “Consuelo”, “La contessa di Rudolstadt”, pubblicati, gli
ultimi tre, nella “Revue Indépendante”, fondata dalla scrittrice a Parigi insieme al
filosofo. Queste opere sono pervase da un profondo spirito di umanità, socialità,
religiosità. In esse viene esaltato il popolo perché depositario dei veri valori morali, denunciata la grave corruzione degli aristocratici, auspicata la caduta delle
barriere tra classi sociali e all’interno di queste nonché la fusione tra popolo e aristocrazia. Si tende, inoltre, alla formazione di una nuova società, nella quale il
popolo non soffra più1 e regnino i principi dell’amore, fraternità, uguaglianza, ad
inserire il problema dell’emancipazione femminile in un più ampio contesto
umano e sociale, a diffondere ed affermare una religione dell’anima diversa da
quella istituzionale. È evidente l’influenza della filosofia di Rousseau ed in particolare del sansimonismo rivelatosi alla Sand tramite la lettura di Leroux. Di questi ella si era dichiarata “fedele discepola” una volta conosciuti il pensiero e la
famosa opera che lo conteneva, “Dell’umanità” 2. Ne aveva ricavato una via da
seguire, un modo per ordinare ed esprimere quell’accensione spirituale mostrata nelle opere precedenti, ”Indiana”, “Valentine”, “Lélia”, “Jacques”, “Mauprat,” e
rimasta una protesta piuttosto confusa contro i pregiudizi e le convenzioni sociali in nome di una libera e straripante passionalità: l’incendio diffuso era divenuto
NOTE
una sola fiamma! Erano sopravvenuti il pensiero, la ragione ad arginare e dirigere l’impeto di una sensibilità traboccante, di un amore privo di precisi obiettivi. Lo
schema della confessione e il tono lirico, usati in precedenza per presentare eroine impegnate a rivendicare i propri diritti, avevano ceduto il posto ad una visione più estesa, l’individualità era divenuta socialità, l’uomo umanità, l’amore religione. Tale maturazione e passaggio sono contenuti nei romanzi, definiti “sociali”, della seconda fase della produzione sandiana3. In essi trovano la loro rappresentazione migliore delle tesi fondamentali in Leroux quali la perfettibilità dell’uomo, l’immortalità della specie, la proprietà collettiva, la rivalutazione del popolo e
del proletariato delle città e delle campagne.Questo avviene soprattutto ne “Il
compagno del giro di Francia” e “Il mugnaio di Angibault”.
È il periodo della vita e dell’opera della Sand che va dal 1840 al 1848 ed
allora il suo “socialismo” si manifestò oltre che nelle opere di letteratura anche
nel favore, nei vari aiuti da lei accordati a poeti proletari quali Magu, Reboul,
Jasmin, Poncy ed in altre iniziative di carattere politico e sociale. La scrittrice
sentì l’influenza della filosofia di Leroux in modo così intenso da farne una condotta di vita ed arte, una regola di azione e pensiero quasi fosse stata per lei
“una nuova religione”. Non a caso Sainte-Bevue, nel 1843, affermava che
“Béranger, Lamennais, Sand e Sue erano le quattro grandi potenze socialiste
e filantropiche della nostra età4.
“Il compagno del giro di Francia” e “Il mugnaio di Angibault” saranno le opere
maggiormente espressive del “socialismo” e “filantropismo” della Sand, del suo
amore per il popolo, della sua volontà di contrapporre le virtù di questo ai vizi dell’aristocrazia. Nella prima si dirà del falegname Huguenin, che è della “medesima stoffa divina” del carpentiere Gesù, e lo si opporrà al conte di Villepreux ed
alle sue convinzioni in campo sociale; nella seconda il protagonista, GrandLouis, sarà presentato come un santo e l’aristocratica Marcelle de Blanchemont
mostrerà di risentire delle nuove idee e di voler educare a queste il figlio poiché
dirà: “Mio Dio, datemi la forza e la saggezza necessarie per fare di questo ragazzo un uomo: per farne un patrizio, mi sarebbe bastato incrociar le braccia”5.
La Sand aveva mutuato da Leroux anche l’idea del miglioramento e perfezionamento dell’uomo nonché l’aspirazione ad una diffusa solidarietà umana
ed alla formazione di una società migliore. Per trasferire simili ideali in letteratura le era sembrato opportuno farli impersonare dai suoi eroi e mostrare come
dai pensieri ed azioni di questi potessero derivare effetti tali da convertire alla
“nuova religione” anche chi, come gli aristocratici, era rimasto ancora completamente estraneo. Arte e vita s’incontravano nella Sand e facevano in modo
che le istanze socialiste vissute accanto all’amico filosofo s’identificassero,
nelle opere, con quell’anima popolare che, secondo lei, aveva preservato da
ogni contaminazione di tempo o luogo i valori umani più autentici.
Non si tratta di un fenomeno di primitivismo o puritanesimo o nostalgia ché
la Sand non si dedica al culto di certi valori isolandoli dal contesto umano e
sociale ma affida loro un’azione, li investe di un compito di rinnovamento morale, li trasforma nei termini di un confronto. Di questo compito e confronto sono
espressione le sue creature impegnate a diffondere un messaggio e, per questo, a lottare contro ambienti e persone. È un’operazione di richiamo ai doveri
147
148
umani, una missione di evangelizzazione che esse svolgono sulla terra e l’opera e l’eroina che più di tutte interpretano il fenomeno è “Consuelo”. Come altre
figure della Sand anch’essa è di origine popolare ed è persona eccezionale per
le sue qualità stavolta non solo morali ma anche artistiche. Queste le permetteranno di accedere ad ambienti elevati ed intraprendere un lungo viaggio
attraverso le più varie vicende ed esperienze della vita.
Il modulo del viaggio era già noto in letteratura e sarà ripreso anche in tempi
a noi recenti. La Sand lo usa in maniera particolare giacché ne fa un evento vissuto naturalmente dalla protagonista e presenta le sue varie situazioni come
necessarie. È la vita vera quella attraversata da Consuelo durante la lunga
avventura descritta nel romanzo. Nelle diverse tappe la vediamo spesso intenta a lottare per affermare la sua presenza, il suo pensiero, il suo sentimento. Il
percorso sarà continuamente e variamente insidiato ma niente lo fermerà in
modo definitivo, nessuna minaccia potrà sottrarre la protagonista ai richiami
della coscienza, ai doveri dell’anima. A volte sarà costretta a fuggire il pericolo
incombente ma le sarà pure possibile imbattersi in “anime gemelle” e stabilire
con loro quella “comunione di affetti”, quella “solidarietà umana” da lei tanto cercate. Queste anime, però, hanno generalmente rinunciato all’azione, abbandonato l’impegno nel mondo mentre in lei sempre vivo, anche se tormentato, sarà
il desiderio d’agire perché l’amore e il bene si diffondano nella vita di tutti. Tale
tratto distintivo della figura di Consuelo, tale strenua lotta tesa a combinare il
proprio sentimento con l’altrui, fanno sì che essa diventi la proiezione più immediata dell’anima dell’autrice, la personificazione migliore dello spirito di “socialità”, del bisogno d’azione sentiti e vissuti dalla Sand. Sarà questo bisogno a fare
in modo che la scrittrice, col tempo, giunga a sentirsi diversa da Leroux ed a
rimproverargli di creare dei sistemi astratti, di rimanere nell’utopia. Ella era,
invece, per un’azione concreta che attuasse l’utopia, per degli obiettivi precisi
come attestano altri aspetti e momenti della sua vita quali la presa di posizione
contro Luigi Filippo, la fondazione dell’“Eclaireur de l’Indre”, l’adesione al movimento riformatore di Louis Blanc, la partecipazione alla rivoluzione parigina del
1848 insieme a gruppi repubblicani e socialisti, la fondazione del settimanale
“La Cause du Peuple”, la collaborazione ai “Bulletins de la Rèpublique”, l’asilo
offerto a profughi politici. Le idee umanitarie e sociali, provenutele da Leroux,
erano state completate con un proprio contributo, quello dell’azione necessaria
ad attuare le finalità perseguite. L’azione la Sand cercò nella vita e rappresentò nelle opere di quel particolare momento e se il fenomeno rimase indistinto in
altre narrazioni, in “Consuelo” acquistò precisione ed evidenza. In quest’opera
ed in questo personaggio si esprimono, nel migliore dei modi, la lezione di
Leroux e il “socialismo” della Sand inteso come teoria e pratica, pensiero e azione, necessità dell’anima e del corpo. Agire significava per lei muoversi alla ricerca di un accordo tra elementi opposti, di un equilibrio tra forze contrastanti,
significava dividersi ed unirsi in continuazione, perdere e vincere incessantemente: “il funambolo è il tipo di questa vita penosa, ardente e pericolosa. Egli
deve provare un piacere nervoso e terribile su quelle corde e quelle scale su cui
compie prodigi superiori alle umane forze; ma quando ne è sceso vincitore deve
sentirsi venir meno all’idea di risalirvi e di abbracciare ancora una volta la morte
1 G. SAND, Correspondance, vol. II, Garnier, Paris 1964-1990, pp. 218-220: “L’umanità che soffre […] è il popolo, il popolo ignorante, il popolo abbandonato, pieno di passioni focose che vengono eccitate in un cattivo senso, che vengono compresse, senza rispetto di quella forza che Dio
non gli ha tuttavia concesso senza motivo”.
2 P. LEROUX, De l’Humanitè, Perrotin, Paris 1845.
3 E. SEILLIÈRE, George Sand, Mystique de la passion, Alcan, Paris 1920, pp. 200-212: “Soggetto dei suoi nuovi romanzi era ora il proletariato delle città e delle campagne, i suoi lavori, le sue
miserie, e ne contrappose le virtù all’egoismo dei grandi e dei ricchi”.
4 SAINTE-BEUVE, Correnspondance générale, vol. V, Stock, Paris 1935-1949, p. 323.
5 G. SAND, Le meunièr d’Angibault, édition présentée, établie et annotée par B. Aidier, Libraire
générale française, Paris 1985, p. 154.
6 G. SAND, Consuelo, vol. III, Fratelli Treves editori, Milano 1930, p. 211.
NOTE
e il trionfo, spettro a due facce che spazia incessantemente sulla sua testa”6.
Questa è la figura dell’errante e fuggitiva Consuelo. In lei, come nel funambolo,
c’è una continua alternanza di pensieri, come lui vive perennemente esposta ai
pericoli e, sebbene sia consapevole che nessun successo potrà mai eliminarli
del tutto, che ogni nuova impresa glieli comporterà nuovamente, è sempre pronta ad affrontarli. Nel romanzo c’è un’immensa galleria di personaggi e situazioni che spesso ostacolano l’azione di Consuelo ma non saranno mai temuti al
punto da fermarla né saranno mai tali da superare la forza del suo animo, la
luce di verità e d’amore che l’accende e la muove.
L’insegnamento di Leroux non avrebbe potuto avere allievi ed esiti migliori
se si tiene conto che dalla Sand esso viene sviluppato ed arricchito poiché
adattato alla vita e rappresentato negli effetti positivi che da ciò derivano. Soltanto se inserito in simile processo si può spiegare il concepimento di Consuelo, il suo significato: tramite lei il popolo viene promosso per le sue qualità, per
queste può fondersi con le alte classi sociali ed operare per smascherarne e
combatterne i vizi, per preparare una nuova, migliore società.
È uno degli sviluppi più importanti del pensiero di Leroux sia perché mostra
come la filosofia possa diventare vita, come l’idea possa realizzarsi, sia perché
affida un’operazione di rinnovamento individuale e sociale, una rivoluzione
morale ad una donna. Questo fa di Consuelo-Sand la precorritrice di moderni
fenomeni culturali e sociali quali il femminismo, l’affermazione del popolo, il
recupero degli oppressi, la diffusione nella letteratura, nell’arte, nella società,
soprattutto del moderno Occidente, di tendenze di pensiero dette neoumanistiche perché volte a restituire all’uomo d’oggi l’identità smarrita.
Con la Sand la filosofia di Leroux ha acquisito una dimensione moderna. L’adattamento alla vita, ricevuto grazie all’opera della scrittrice, l’ha trasformata in un’importante anticipazione della modernità, un riferimento essenziale, un’indicazione
valida per ogni umanità che abbia bisogno di ritrovarsi. Se oggi si sta parlando di
neoumanesimo, se si sta cercando, dopo tante dissipazioni, di recuperare l’uomo
nei suoi elementi ed aspetti autentici, si deve riconoscere che modelli quali Pierre
Leroux e George Sand sono stati e sono utili, che dalla loro comparsa non hanno
mai smesso di operare all’interno della cultura e della coscienza europee.
149
LA FILOSOFIA: SETE DI VERITÀ
E FORMAZIONE INTEGRALE DELL’UOMO
Nota sul pensiero di Maria Teresa Antonelli
di Santo Arcoleo
La filosofia: sorgente alla quale tutti si abbeverano
e si rinfrescano.
Nessuno penetra nella profondità da cui sgorga.
150
L’invocazione che da millenni esprime la sofferenza e il disagio dell’Uomo-Dio
sulla Croce è stata ripresa, con la carica emotiva ed allusiva, dalla percezione
sensibile e dall’ascolto attento, dalla dottrina teoretica di M. T. Antonelli che, della
sete di verità e della sua ricerca ininterrotta, ha fatto lo scopo della propria esistenza e del proprio pensiero. La sete e la ricerca della verità si rivelano particolarmente esigenti ed incisive nel suo ultimo corso su Nietzsche dedicato all’approfondimento di due problematiche fondamentali: il richiamo alla dimensione umana del
dolore, sullo sfondo della tragedia della Croce (Io nuovo Crocifisso) e la fedeltà
dell’uomo alla propria identità tellurica (Rimanete fedeli alla terra). Al pensiero di
Nietzsche si è più volte riferita nel suo insegnamento e con le note dolenti della
sua dottrina ha concluso la sua trentennale ricerca filosofica.
A chi scrive è rimasto il compito di illuminare le pieghe nascoste di un pensiero, che si manifestava, oltre che nei trattati filosofici, anche nei piccoli scritti d’occasione e nelle osservazioni argute e preziose di cui è piena la sua corrispondenza.
Sono stato suo assistente, anzi, come preferiva Lei, il suo assistente, per
quasi vent’anni, legato a Lei da un sentimento di stima profonda e di affetto.
Nei rari incontri degli ultimi mesi si compiaceva nel ricordare i vari momenti
della nostra collaborazione, iniziata con la mia stesura delle dispense dedicate alla “Introduzione programmatica e metodologica” attinente al dibattito “Filosofia-Storia della Filosofia”, esposto ed esaminato nel semestre del suo primo
corso di professore ordinario alla cattedra di storia della filosofia, presso la
facoltà di lettere dell’Università di Genova, e successivamente proseguita con
la correzione delle bozze del volume: Morale: linee1, con la revisione delle citazioni testuali del prezioso articolo sulla matematica in Porfirio, inspiegabilmente perduto nella redazione di una rivista di filosofia, in cui anticipava un’intensa stagione di studi sul neoplatonismo iniziata con il saggio Introduzione dell’idea di matematica in Giamblico 2.
Con le lezioni dedicate a Porfirio, e in special modo al dibattito filosofia-religione-teologia alla luce della Lettera ad Anebo e la Lettera a Marcella, proponeva un ripensamento critico della filosofia neoplatonica, considerata nella sua
realtà ed anche nella sua eredità storica, principale momento di riflessione per
l’approfondimento di una teoresi che si offre come una delle tematiche fondamentali del suo pensiero. Iniziata alla fine degli anni ’50, l’analisi ed il commento critico dell’Enneade III3 aveva inaugurato questo processo.
NOTE
Sin d’allora la ripresa della dottrina neoplatonica l’aveva convinta anche a
riconsiderare le radici dello spiritualismo cristiano, che dalle problematiche
neoplatonico-agostiniane traeva molte delle sue argomentazioni. Gli studi e la
traduzione delle Enneadi a cura di V. Cilento4, le sollecitazioni critiche del Caramella5, i corsi del Bruni6, i saggi del Prini7, evidenziano con chiarezza l’importanza delle dottrine neoplatoniche per la filosofia spiritualista italiana, all’unisono con le ricerche condotte in quegli anni anche in Francia, in Belgio, in Germania ed in Inghilterra, che anticipavano conoscenze più solide ed obiettive,
successivamente consolidate dopo l’edizione critica del testo di Plotino, ad
opera di P. Henry e H. R. Schwyzer8.
Il neoplatonismo, con Plotino, Porfirio e Giamblico, è anche alla radice di
quell’afflato intimistico e religioso che apre la via al misticismo9, al quale con
umiltà e quasi con gratitudine l’Antonelli si accosta più intensamente nei suoi
ultimi terribili giorni. L’atteggiamento e l’adesione mistica appartengono alla
sfera del suo intimo e del suo privato, alla sua coscienza torturata e tormentata le cui tracce possono cogliere solo gli intimi10. L’Antonelli aborriva l’esternazione dei sentimenti e spesso questo suo atteggiamento riservato è stato considerato da quanti la conoscevano solo superficialmente, se non con ostilità
almeno come segno della rivendicazione di un élitismo intellettuale, quasi che
l’intelligenza e la cultura si potessero separare dal buon senso!
Descartes, con il suo atteggiamento sornione, aveva auspicato un uso
regolativo del “buon senso” fin dalle prime battute del suo celebre Discorso, e
Pascal, con il sottile richiamo a l’ésprit de finesse, aveva indirizzato verso un
ritorno all’interiorità, da Agostino in avanti uno degli elementi caratterizzanti del
Cristianesimo. Descartes e Pascal sono Autori che l’hanno plasmata all’intelligenza dell’agire e del pensare, alla ricerca appassionata e vissuta della verità,
alla quale non lesinò mai le sue forze e le sue migliori energie.
Improntato a chiarire il significato autentico, genuino e fondamentale della
filosofia, a cominciare dal suo primo saggio dedicato alle Figure dei Sofisti in
Platone11, il pensiero dell’Antonelli si nutre delle opere della tradizione classica
(Platone, Aristotele, Plotino), delle dottrine dei Padri della Chiesa (Origene,
Atenagora, Agostino), della filosofia medievale (Bernardo, Anselmo, Pier
Damiani, Abelardo, Tommaso), di singolari filosofi del Rinascimento (Telesio,
Erasmo) e si apre alla cultura moderna e contemporanea riproponendone la
tradizione razionalistica (Descartes, Pascal,) e pre-illuministica (Locke, Hume),
di Kant e della dottrina idealistica (Hegel in primis, la cui influenza ritrovava nel
pensiero di Bradley, autore preferito assieme a Maine de Biran e Rosmini).
All’ultimo periodo del suo insegnamento universitario risalgono rinnovati interessi per Nietzsche, per la metodologia storiografica della scuola analitica
inglese, Onians, Ryle, F. M. Cornford e per la scuola “psicologistica” francese:
Lavelle, Le Senne, Mounier. Non è mai venuta meno la passione per la psicologia e la sociologia, discipline basilari del suo insegnamento alla Scuola di
Servizio sociale di Genova, e per la pedagogia, che l’hanno vista impegnata in
una docenza pluriennale nella facoltà di Magistero di Genova.
La psicologia e la sociologia hanno contribuito ad alimentare la sua prospettiva pedagogica ancorata alla concezione cristiana dell’uomo, realtà spirituale,
151
152
ma anche creatura che vive in una dimensione nella quale, con il comporsi e
l’alternarsi dei sentimenti, interagisce una “Natura” momento intrinseco e fondamentale, segno di una telluricità che talvolta reclama la sua libertà di fronte
alle norme e alle regole.
Lo sforzo trentennale di osservazioni e meditazioni legate ad una pedagogia di indirizzo spiritualistico, teso a valorizzare il ruolo di una psicologia sperimentale, si sarebbe dovuto concretare in un complesso volume dedicato alle
scienze umane ed ad una organica concezione di un neo umanesimo, critico
ma non contrapposto alla pletora degli umanesimi del XX secolo12.
Lavorava a questo progetto quando la morte la colse e purtroppo le quasi
2000 pagine dattiloscritte sono andate irrimediabilmente perdute. Se ne possono trovare anticipazioni nei numerosi corsi del suo insegnamento universitario e negli articoli pubblicati nelle riviste di pedagogia, negli Atti dei Congressi,
nelle dispense della scuola di Servizio sociale ed in quel saggio dal titolo Caratteriologia, ancora inedito13.
Questo testo ben si collega ad un breve saggio Psyche e psichicità14 di
grande interesse teoretico, una specie di testamento filosofico spirituale. Vi si
analizza, seguendo una metodologia ed un procedere teoretico del tutto personale, l’elemento determinante per la riaffermazione di un neo umanesimo
che si radica in una visione dell’uomo considerato persona. La novità sta proprio nel soffermarsi su un aspetto taciuto della persona: la sofferenza. Esperienza personale e meditazione filosofica si fondono in questo percorso auto
biografico che si offre come momento emblematico di un vissuto che rende
diversi ma terribilmente umani. Ma non è del dolore tout-court che l’Antonelli
vuol discutere: altri, e forse con maggior forza, se non con maggiore sincerità,
ne hanno trattato gli aspetti molteplici e mai esaustivi. Il dolore, che secondo
Lei investe l’uomo, quello che più di ogni altro ne delinea la diversità e nello
stesso tempo ne segna la distanza dagli altri, è la sofferenza psichica, che
distrugge la mente e impedisce di pensare o meglio per curare la quale si
impongono delle medicine che impediscono di pensare e che quindi distruggono il pensiero. La chimicizzazione dell’uomo, attraverso l’adozione di una terapia che lenisce la sofferenza e talvolta la guarisce, è il risultato dell’oscenità
con la quale si guarda all’uomo quando lo si riduce a cosa. L’Antonelli ritiene
che fra le forme peggiori di reificazione quella psichica sia di gran lunga la più
penalizzante.
Da queste premesse emerge come sua direttiva filosofica la cultura spiritualistica, di cui si fa portavoce, che non si limita a costruire sistemi, a verificare teorie, a fondare dottrine, architettate forse in forma più compiuta da sublimi esperienze mistiche o da ideologie politico-sociali. Gli scritti di Rosmini,
meditati anche alla luce dei Pensieri di Pascal o dei testi di Agostino e dei Padri
sia Greci che Latini, l’hanno condotta per mano a scrutare il mistero ed il disagio dell’uomo, la sua grandezza e la sua miseria in questo itinerarium deiectionis nel quale l’uomo si scopre debole e miserabile.
L’uomo delle origini, che ricapitola l’uomo sofferente ed annichilito, cacciato dal Paradiso terrestre è l’essere atterrito, che si sente perduto in una natura sconosciuta, tremante preda delle belve e degli uragani. Solo un Dio lo può
NOTE
salvare: le astuzie e la prontezza dell’intelligenza non servirebbero a nulla, se
questa salvezza non fosse decretata dall’alto, come si ipotizzava già dai tempi
di Omero.
La natura dell’uomo non si mortifica quando se ne indicano le debolezze ed
il riconoscerle fino in fondo, anche quando l’abisso sta per inghiottirlo, è il
segno della sua grandezza. Quest’aspetto l’Antonelli volle tenere presente
nelle sue conferenze romane dedicate al problema del “giusto sofferente”.
Commentando “il libro di Giobbe” sottolineava che persino l’enormità della
bestemmia finale: “Sia maledetta la notte in cui è stato detto: ‘È stato concepito un uomo’”, lungi dall’essere l’espressione di un atto di ribellione, d’insofferenza verso il male diventato radicale, è la preghiera di lenire una sofferenza
che superava il limite del sopportabile. La tentazione di Giobbe è più radicale
di quella di Adamo, meno violenta dell’azione di Caino e della testimonianza di
fede di Isacco; il male gli si presenta progressivamente, anzi sembra anche
garantire lo spazio per una pausa di riflessione: “Se da Dio abbiamo accettato
i beni perché non accettarne anche i mali?” si chiede sgomento, ma non vinto,
Giobbe. Questo spazio però rischia di rimanere vanificato perché proprio dai
Saggi che si offrono di consolarlo ogni tentativo di riflessione è annullato: l’inesorabile va accettato, non si può discutere. La stessa moglie, pia e fedele,
anche lei prostrata dalla sofferenza per il sofferente, lo supplica di avanzare
una estrema richiesta liberatoria: “Rivolgi la tua preghiera a Dio e muori!”. Un
universo di sentimenti e di affetti frana ed all’uomo, ormai solo con se stesso,
non resta che la soluzione estrema; l’abisso della disperazione che nessuna
ragione può giustificare, nessun sentimento può lenire e che forse solo Dio può
risolvere.
L’Antonelli scopriva, nella vicenda di Giobbe, una caratteristica fondamentale dell’esistere, quasi l’anticipazione di quel suo dramma personale che
avrebbe condizionato la sua vita di donna e di studiosa.
E. Bonanati, nella prefazione al volume di A. Nobili dedicato alla Storia della
cattedra di Pedagogia dell’Istituto universitario di Magistero15, ha espresso profonde osservazioni sull’attività intellettuale dell’Antonelli docente e maestra,
sottolineando che “sullo sfondo della premessa metafisico-antropologica, dal
timbro ateistico-personalistico, la valenza teleologico-assiologica della pedagogia trova […] una trattazione concettuale rigorosamente fondata e partecipe:
il fine dell’itinerario educativo vi si rivela come l’inveramento, in pienezza, di
una creazione seconda […] attraverso cui si conferma come definitiva la creazione prima, divina dell’uomo”16.
Per l’Antonelli l’educazione è finalità elettiva nell’ambito della quale si avvia
la “formazione integrale della persona in tutte le sue componenti e strutture.
Con il Cristianesimo nasce il concetto che l’uomo è nel mondo per trasformarsi ontologicamente nella sua struttura a immagine del divino”; Cristo “propugna
la grande pedagogia del farsi uomini in senso umano integrale, attraverso la
dilatazione del senso soprannaturale del farsi figli di Dio e dà all’educarsi il
valore di un’azione metafisica di autocostruzione dell’io”.
A. Nobile ha messo in luce l’ampio orizzonte in cui matura la concezione
pedagogica personalista antonelliana nella quale è sempre presente l’istanza
153
154
della formazione integrale, nel solco della migliore educazione umanistico-cristiana: “ottica globale al cui interno l’Antonelli privilegia la dimensione morale,
civile e religiosa, oltre che la formazione del carattere e della volontà”17.
“Il discorso pedagogico dell’Antonelli si sviluppa […] interessando frequentemente, con sensibilità educativa, anche quelli che definiremmo oggi ‘svantaggiati’ o deprivati o emarginati, o anche ‘soggetti a rischio’, sia pure avvalendosi di una terminologia un po’ datata; in questo senso non solo il fanciullo ma
il minorato fisico, cioè l’uomo che non ha a disposizione tutte le sue forze corporee, il prostrato psichico, cioè l’uomo che subisce un collasso nelle sue
disponibilità psichiche e superiori, il traviato, cioè l’uomo che trova compresse
per abitudini negative le sue disponibilità spirituali sono tutti termini cui si rivolge di diritto l’educazione istituzionale”18.
M. A. Raschini ha ricordato, con annotazioni suggestive19 che “nella professione di docente di filosofia, che ella esercitò splendidamente, gli interessi filosofici trovano per lei singolare incremento nel tessuto culturale ricco di attenzione storica, acribia filologica, spirito critico, punte teologiche ed altezze spirituali che la caratterizzavano. Dimensioni nelle quali ella riversò quella che,
sotto il profilo intellettuale, fu forse la sua dote più caratteristica: una straordinaria acutezza interpretativa che rendeva impareggiabili le sue letture ed i suoi
commenti dei testi. Nelle sue mani un autore si rinnovava: quasi fatto ricco di
nuove possibilità che M. T. Antonelli traeva con eccezionale spirito di penetrazione: leggere un autore, anche il più noto, attraverso la interpretazione antonelliana, diventa una scoperta e suscita meraviglia”.
Secondo M. A. Raschini, “il suo lavoro intellettuale portava il segno della
sua personalità spirituale. Donna temperalmente forte, segnata da problemi
esistenziali sofferti nel nascondimento, coltivava una religiosità intima ed
essenziale che la fortificava di fronte al mondo. La penetrazione del pensiero
rosminiano era divenuta in lei intima partecipazione: la propria creaturalità, vissuta come dramma della carità quale rosminianamente è e quale essa la vide
[…]. A M. T. Antonelli pensiamo come ad una singolarità creaturale, miracolosamente vittoriosa della fragilità categoriale dell’esistenza che la martirizzò, lei
consapevole del martirio e consenziente”20.
M. R. Montagna, che fu sua assistente, ne ha tracciato un profilo dal quale
emergono le qualità singolari del suo pensiero: “Di eccezionale levatura intellettuale e di finissima sensibilità, viveva una dimensione di spiritualità profonda; credeva nei valori e ne trasfondeva l’amore a chi le stava vicino […]. Le tematiche
che prediligeva erano quelle di tipo metafisico e morale. Il suo pensiero sviluppava, nel senso della trascendenza, i motivi centrali della filosofia di Giovanni
Gentile, iscrivendosi nella corrente dello spiritualismo cristiano […]. Aperta a
vasti interessi, attenta alle problematiche della coscienza e della prassi dell’uomo contemporaneo, la si scopriva sempre sorprendentemente aggiornata”21.
Alla dimensione spiritualistica dell’uomo l’Antonelli abbina la “natura cosmica”, che accanto alla telluricità illumina un aspetto spesso misconosciuto: l’uomo non solo partecipa della realtà terrena, ma attraverso la terra è anche un
anello della realtà cosmica, secondo una concezione del concetto di Natura
che lei collega alla complessa realtà cosmologica.
NOTE
Vorrei citare, a questo proposito, alcuni momenti salienti di una sua lezione
dell’11 marzo 1961 dal titolo Natura e la natura umana. Dopo una sintetica analisi dei processi conoscitivi che inducono l’uomo ad accostarsi alla natura, l’Antonelli dichiara: “La Natura è il reale sensorio o il condizionamento della vita, ci
siamo trovati a dire, in quanto originarietà. Ha la stessa struttura, sostanzialmente nei tempi moderni, l’idea di natura umana: in fondo (e l’allusione più facile può essere a Dewey e ai precedenti roussoviani) i bisogni o le tendenze fondamentali della vita e del suo sviluppo possono essere considerati originarietà
rispetto al vivere: la Natura è dunque questo qualcosa analizzabile e ricomponibile secondo leggi che potremmo denominare lo spessore o il ritmo originario (e quindi anche la base ed il riferimento costante di ciò che è vita). La vita
come effettualità o fisicità è in questo senso in forma evidente Natura o radicata nella Natura; ma anche quanto fiorisce nell’esistenza e rappresenta non
l’area direttamente e determinatamente fisica o effettuale, bensì ciò che è spirituale e che diciamo libero, ha il suo riferimento alla natura visto in questo
modo”. C’è un atteggiamento theillardiano in questa rivendicazione dello spirituale nella Natura, ma anche l’intimo convincimento di una radice unica nell’immensa realtà cosmica, favorita dell’eco di lontane radici pitagoriche e neoplatoniche. In un momento nel quale la filosofia era stimolata dal confronto fra le
sollecitazioni delle discipline scientifiche, per una corretta ed organica conoscenza nel formulare dottrine filosofiche nell’allora nascitura “filosofia della
scienza”, e l’invasione massiva delle correnti esistenziali ed heideggeriane,
l’Antonelli formulava una teoria della Natura ricollegandosi sia alle dottrine
medioevali ed ad un ortodosso, il bergsonismo, sia alle ipotesi teoriche sulla
scienza, privilegiando le teorie cosmologiche.
In questa prospettiva indubbiamente hanno avuto notevole influenza le letture delle opere di G. Galilei, di Theillard de Chardin (in quegli anni a Genova
c’era un discreto movimento Theillardiano, sostenuto dai Gesuiti) e, ma non
sembri strano, soprattutto dei mistici. Sosteneva l’Antonelli che “in fondo anche
lo sviluppo della complessità intera dell’agire e del pensare è da Natura, in
quanto appunto sia radicata in condizionamenti originari: in questo senso nulla
prescinde dalla Natura, né il nutrimento, né la crescita, né il pianto né il riso, né
il poema, in cui s’esprime una personalità, né l’ideologia politica. Si può giungere a dire che la storia, in quanto indirettamente costruita a partire da ciò, è
da Natura. Chi veda, a parte post, ciò che s’è svolto a partire dai condizionamenti originari e sul loro binario, può forzare i termini del problema e giungere
a dire che, attraverso questi concatenamenti, lo sviluppo attivo non più fisico e
visibilmente fisiologico o biologico, non più legato alla vita organica e del corpo,
ma spirituale, storico, civico o sociale, rientra nella Natura”.
Questo concetto ampio ed articolato di natura allude anche, valorizzandoli,
agli aspetti della costituzione geo-orografica del territorio e stabilisce un parallelismo fra la “biografia” della Natura e la biografia dell’Uomo: i caratteri distintivi, la storia, le componenti essenziali dell’una e dell’altro, costituiscono il fondamento della loro autonoma, specifica, unica identità.
La Natura è la “premessa” dell’identità dell’uomo. Essa si può considerare
come “originarietà di condizioni base. Non è condizionante ma generante. La
155
156
natura umana in quanto tale non è in fondo che l’episodio dell’universo di fronte ad una osservazione globale; per altro verso, entro il funzionamento e la
struttura stessa di ciò che è natura umana, spesso ogni limite è trasbordato ed
è la Natura che si presenta come natura umana […]. Il tema della vita investe
la Natura prima che la natura umana, quindi presenta in qualche modo un continuum ed una continuità. Dove cominci la natura umana e dove finisca la Natura è cosa difficile da determinare ed in fondo è da questo punto di vista che
l’elementare concetto di natura umana diventa problematico. Che cos’è natura in fondo? Potremmo dire, forse, l’appartenenza alla terra, il rientrare nel suo
ritmo e nella sua storia, l’appartenere all’Universo”.
L’Antonelli ha considerato criticamente le teorie e le dottrine scientifiche del
suo tempo e, per certi aspetti, ha anticipato alcuni temi che costituiscono l’anima del dibattito filosofico contemporaneo. Ha illuminato, con la medesima sensibilità, le grandi tradizioni teoretiche, soffermandosi con mente pensosa e critica sulle categorie filosofiche che poi ha applicato alla pedagogia, alla psicologia ed alla sociologia. Se dal Rosmini ha mutuato principalmente l’attenzione profonda rivolta al dibattito interiore, se lo ha seguito in toto nella ripresa dei
criteri che regolano la carità, nodo cardinale della teoresi cristiana, del misticismo rosminiano, in accordo ed in armonia con Paolo, ha saputo percorrere la
difficilissima strada, tutta in salita, difficile e dispersiva, contornata com’è da
dirupi e burroni; solo l’amore, alla fine, conduce in quel porto dove finalmente
quieto riposa il cuore22.
La sua filosofia, personalissima e profondissima, quando rivela i tratti dell’animo inquieto, indica anche la via maestra che apre alla “veritas”. Non si dà
verità senza carità e la carità comincia e si conclude con l’amore per la persona, che è anima, vita, natura. L’anima umana, sosteneva alla fine di questa
lezione magistrale, non si lascia definire, proprio come non si lascia definire la
natura. Spesso la natura dell’anima umana scompare nella forte assunzione
volontaristica dello Spirito o del suo essere un io: l’io che crede e che vive e
che spiega l’uomo come sovrastruttura pensante e volente, ma, come organismo, può anche essere assorbita nel fluire della vita reale e fisica del mondo.
È questo l’equivoco della prospettiva materialista della natura umana”. L’Antonelli insiste nel sottolineare come la natura umana, in quanto tale, altro non è
che l’episodio dell’universo del quale presenta in qualche modo un contributo
ed una continuità. “Dove cominci la natura umana e dove finisca la natura è
cosa difficile da determinare e in fondo è da questo elementare punto di vista
che l’elementare concetto di natura umana diventa problematico. Ma cos’è la
natura in fondo? Potremmo dire, forse, l’appartenenza alla terra, il rientrare nel
suo ritmo e nella sua storia, l’appartenere all’Universo. Una natura umana
come tale nasce dunque da una definizione che è sempre astratta e restrittiva
ma per sé e la scienza recentissima ha insistito proprio su questi temi:c’è o la
singola natura umana o il distendersi della continuità della natura, o la natura
in quanto inglobanza, unità psico-fisica o il fenomeno ed i fenomeni naturali.
Da qui il fatale scomparire della natura umana nella forte assunzione volontaristica dello Spirito o il suo essere un io: l’io che crede e che vive, che è
coscienza di sé e persona che si fa e che sussiste o l’immergersi della natura
1 M. T. ANTONELLI, Morale: linee, Bozzi, Genova 1964. Sull’argomento cfr. S. ARCOLEO, L’emergere del problema morale alla luce della speculazione di M. T. Antonelli, “Segni e Comprensione”,
VII, 18, 1993, pp. 95-103.
2 M. T. ANTONELLI, Introduzione dell’idea di matematica in Giamblico, “Arts libéraux et philosophie au Moyen Age”, Vrin, Paris 1969, pp.1007-1021.
3 In particolare III, 5, “Eros”; III, 7, “L’eternità ed il tempo”; III, “La natura, la contemplazione e
l’Uno”.
4 PLOTINO, Enneadi, voll. 1-3, t. 4, a c. di V. Cilento, Laterza, Bari 1947-49.
5 S. Caramella aveva tenuto, nel 1939, all’Università di Catania, un corso di lezioni pubblicate
NOTE
umana nella distesa della natura che diviene. È più facile parlare forse di leggi
della natura umana che di natura umana. La natura di un soggetto spirituale è
in sostanza sempre unica, anche se la natura la travolge, la alimenta, la frusta
o la sostiene: l’immagine della gran madre natura è in fondo correlativa a quest’altra, l’unicità della natura umana. Quando essa sia pensata nel suo compimento, potremmo dire nella sua hecceitas, nella sua ‘autoctisi’, nella sua forma
di persona conscia e libera, la natura risulta sempre unica, in qualità di un soggetto spirituale e persona come personalità. Pertanto la natura umana diventa
in questo senso inesistente: assorbita in quella che potremmo dire la vita o la
scena naturale del mondo ovvero involta nell’esistere dell’unità integrale del
soggetto”.
Innamorata della metafisica l’Antonelli ha contribuito con i suoi scritti teoretici23 e con le sue interpretazioni storiche a delinearne le caratteristiche salienti rinnovando la concezione aristotelico-tomista e proiettando la metafisica
verso orizzonti “ulteriori”: “L’avvertimento kantiano della differenza qualitativa
tra sapere scientifico e sapere filosofico condiziona in assoluto l’impostazione
che è possibile dare oggi al problema metafisico e si può trasformare […] in
approfondimento della natura della metafisica. E un possibile sviluppo di un
tale approfondimento ci appare, per l’appunto, quell’idea di significato e di
significanza che si introduce nel corpo della metafisica, intorno al quale veniamo qui disquisendo […]. Noi condividiamo la convinzione antinaturalistica che
caratterizzò già le proteste degli spiritualismi recenti contro le impostazioni filosofiche che continuavano la tradizione del Seicento e soprattutto del Settecento cartesistico [sic!], newtoniano, wolfiano […]. Kant tendeva a specificare non
l’interrogativo metafisico in sé […] ma a esplicare questo attraverso l’oggetto
materiale della domanda metafisica, determinando appunto la metafisica con i
suoi oggetti primari e identificandola con la inchiesta su Dio, sull’anima, sul
mondo. Legata a degli oggetti precisi […] la metafisica subisce tutti gli attacchi
inerenti la verifica dei suoi contenuti […] e sembra che in questo possa venir
travolta”24.
L’Antonelli ritiene che merito di Kant sia stato il riconoscimento della metafisica come scienza unificante, in quanto l’unificazione del sapere, attraverso
le tre Critiche, è opera della metafisica. Il carattere intrinseco della metafisica
è il sapere e il sapere metafisico altro non è che la maggior conquista della
coscienza critica moderna25.
157
158
successivamente in volume. S. CARAMELLA, La filosofia di Plotino e il neoplatonismo, G.U.F., Catania 1940. Il volume del Caramella, redatto in un momento particolarmente difficile –erano i primi
eventi dello scoppio della seconda guerra mondiale– ha un duplice interesse, teoretico e storico.
Teoretico perché segna la radice neoplatonica del pensiero del Caramella e, con lui, dello spiritualismo cristiano, cui Caramella è legato in maniera appassionata; storico perché mette in luce gli
strumenti didattici e storiografici di cui disponeva la storiografia dell’epoca. Con Caramella, durante il mio soggiorno all’Università di Palermo quale borsista di un anno di perfezionamento post-laurea, avevamo deciso l’aggiornamento del volume. Conservo ancora le note che avevamo preparato. Caramella ha pubblicato, nel 1959, una nota interessante dal titolo Il problema eucaristico nel
Neoplatonismo, “Convivium dominicum”, 1959, pp. 35-49.
6 G. BRUNI, Studi sul Neoplatonismo, Gregoriana, Roma 1958; ID., Note di polemica neoplatonica, “Giornale critico della Filosofia italiana”, 39, 1960, pp. 205-236.
7 P. PRINI, L’etica della contemplazione creatrice e il suo fondamento nella teologia di Plotino,
“Quaderni dell’almo Collegio Borromeo”, Pavia 1946, pp. 1-36; ID., Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Abete, Roma 1968, 3 ed. Milano 1992.
8 P. HENRY-H. R. SCHWYZER, Plotini Opera , 3 voll., Desclée de Brouver, Paris-Bruxelles 1951,
1959, 1973.
9 Il misticismo è una costante nei rappresentati più “conseguenti” dello spiritualismo cristiano
italiano, Caramella e Antonelli, che spesso si riferiscono a Teresa d’Avila ed a Giovanni della
Croce. Un’indagine assai profonda, volta ad evidenziare i legami fra stati mistici e malattia mentale, è stata recentemente proposta da J. CHR. GODDARD, Mysticisme et Folie. Essai sur la simplicité, Paris 2002. La “mistica della follia” si può considerare quasi una perdita della propria identità in
un’umanità totale. Si tratta, riprendendo una indicazione di G. Deleuze, di preparare l’acquisizione
di una dimensione della follia come “promozione filosofica e spirituale della follia schizofrenica”. Mi
sembrerebbe opportuno chiarire che si tratta di proposizioni, ipotetiche e però orientative, come
momenti assai stimolanti della letteratura filosofica e non solo. Ma se la dimensione più alta del
misticismo è l’estasi, allora non si può convenire con Goddard: la via maestra rimane ancora Plotino, che ci insegna come l’estasi è un semplice contatto, “una dolcezza che nello stesso tempo
sarebbe odore, nel quale il sapore del vino s’unirebbe a tutti gli altri sapori” (VI, 7 12); l’estasi è un
toccare, un contatto ineffabile che non ha nulla d’intellettuale, “toccare non è pensare” (V, 3 10).
L’estasi si configura in maniera essenziale con l’immagine della visione in cui scompare la distinzione soggetto-oggetto. Dell’emozione mistica Bergson dirà che “rassomiglia indubbiamente […]
al sublime amore che è per il mistico l’essenza stessa di Dio”: E. BERGSON, Les deux sources de
la morale et de la religion, Alcan, Paris 1932, p. 271.
10 Mi riferisco a notizie ed eventi a me noti in parte perché testimone ed in parte perché comunicatemi dalla signora Pina, madre dell’Antonelli.
11 M. T. ANTONELLI, Figure di Sofisti in Platone, SEI, Genova 1948.
12 Anticipazioni di un certo rilievo teoretico sono presenti in alcune pagine dell’ultimo testo pubblicato dal titolo emblematico: M. T. ANTONELLI, Se Metafisica. Metafisica e Metarazionalità, Bozzi,
Genova 1973. Il titolo allude alla complessità dell’universo della metafisica, sulla quale ci può essere il disaccordo più completo fino a negarne l’esistenza. L’Antonelli invita quanti vogliono discutere, privi di preconcetti, di metafisica (da qui quel “Se Metafisica”, nel titolo del volume) ad abbandonare le vie battute da tutta una tradizione razionalistica e ad affidarsi alla “metarazionalità”,
segno della centralità di un “nuovo umanesimo”. Scrive infatti: “L’umanesimo non è pensabile
senza il termine dell’uomo e della sua creatività. Tutta la vastità di differenziazione dell’umanesimo sta nel modo di vedere l’uomo: egli è più che altro la creatività nel suo ruotare intorno ad un
termine piuttosto che ad un altro. L’uomo […] è il fulcro della visione umanistica e di ogni umanesimo; l’essenza dell’umanesimo consiste nel fare dell’uomo un’alfa anche se non il principio […]
questo uomo può dilatarsi a principio divino […]. Ogni umanesimo muore ogni volta che si accetti
di fare dell’uomo strumento e non fine”, p. 197.
13 Il saggio avrebbe dovuto essere pubblicato nella rivista “Incontri culturali dei P.P. Domenicani”, 1976, nel numero dedicato all’antropologia.
14 M. T. ANTONELLI, Psiche e psichicità, in Dal Micro al Macro, “Accademia teatina delle scienze”, Chieti 1961. Nella prefazione al volume Se Metafisica, cit., l’Antonelli accenna all’origine di
questo scritto considerandolo come indagine sul concetto di coscienza e di “egemonicità”, alludendo alla concezione critica che svilupperà nelle non sempre agevoli pagine di questo volume.
NOTE
15 A. NOBILI, Storia della cattedra di Pedagogia nell’Istituto universitario di Magistero di Genova (1946-1967), LU, Genova 1998.
16 M. T. ANTONELLI, L’Educazione. Appunti sul fatto educativo, IUM, Genova 1953, pp.1-16.
17 A. NOBILI, op. cit., p. 289.
18 Ivi, pp. 12-13.
19 M. A. RASCHINI, Maria Teresa Antonelli: una memoria, in A. NOBILI, op. cit., pp. 320-324.
20 M. A. RASCHINI, op. cit., p. 324.
21 M. R. MONTAGNA, L’Antonelli docente e studiosa ricordata da una collaboratrice, “Il Giornale”, 30 agosto 1983, recentemente riedito in “il Ticino”, maggio 2004.
22 Una delle allieve più fedeli, precocemente scomparsa nel 1965, Anna Maria Arbasino, aveva
saputo tradurre l’insegnamento e la dottrina dell’Antonelli in pratica di vita. Di Lei voglio ricordare
questa dedica, emblematica ed incontestabile: “Amare più che la vita è amare al di là di ogni
maniera possibile. Lo testimonia la guglia più alta della vecchia cattedrale e l’eternità sarà locupletante del limite dell’ora”. L’Antonelli l’aveva definita “La iperbolica e la solitaria della verità”. Gli scritti di A. M. Arbasino sono stati pubblicati da me e da M. T. Morano, dall’editore Della Casa, a Genova, nel 1968.
23 M. T. ANTONELLI, Metafisica ed esperienza religiosa, “Archivio di Filosofia”, 1956; ID., Della
Metafisica ovvero della significanza, Morcelliana, Brescia 1957; ID., Se Metafisica. Metafisica e
Metarazionalità Della Metafisica ovvero della significanza, Morcelliana, Brescia 1957; Id., Se Metafisica. Metafisica e Metarazionalità, Bozzi, Genova 1973.
24 Id., Della Metafisica ovvero della significanza, cit., pp. 52-53.
25 L’analisi e l’approfondimento della concezione della Metafisica dell’Antonelli è oggetto di uno
studio che verrà pubblicato, in seguito, sulla rivista di cui è stata per lunghi anni segretaria di redazione.
159
A. ALES BELLO – Ph. CHENAUX (edd.), Edith Stein e il nazismo, Città Nuova,
Roma 2005, pp.120.
160
«Padre Santo! Come figlia del popolo ebraico, che per grazia di Dio è da
undici anni figlia della Chiesa cattolica, ardisco esprimere al Padre della cristianità ciò che preoccupa milioni di tedeschi. Da settimane siamo spettatori, in
Germania, di avvenimenti che comportano un totale disprezzo della giustizia e
dell’umanità, per non parlare dell’amore per il prossimo. Per anni i capi del
nazionalsocialismo hanno predicato l’odio contro gli ebrei. Ora che hanno ottenuto il potere e hanno armato i loro seguaci –tra i quali ci sono dei noti elementi criminali– il seme dell’odio si schiude […]. Tutto ciò che è accaduto e ciò che
accade quotidianamente viene da un governo che si definisce “cristiano”. Non
solo gli ebrei, ma anche migliaia di fedeli cattolici della Germania e, ritengo, di
tutto il mondo, da settimane aspettano e sperano che la Chiesa di Cristo faccia udire la sua voce contro tale abuso del nome di Cristo […]. Noi tutti, che
guardiamo all’attuale situazione tedesca come figli fedeli della Chiesa, temiamo il peggio per l’immagine della Chiesa stessa, se il silenzio si prolunga ulteriormente» (pp. 104-105). In calce la firma: «Dott.ssa Edith Stein – Docente
all’Istituto tedesco di pedagogia scientifica presso il Collegium Marianum di
Münster» (p. 106).
Con la parziale apertura degli archivi vaticani è stata resa pubblica la lettera
che la filosofa fenomenologa scrisse a papa Pio XI per segnalare i pericoli dell’ideologia nazionalsocialista e dell’antisemitismo. Scritta nell’aprile 1933, soltanto tre mesi dopo l’avvento di Hitler al potere, questa lettera rappresenta un
documento di grande valore non soltanto per gli studiosi del pensiero di Edith
Stein, ma anche per gli storici e per gli specialisti della storia della Chiesa in particolare, che lo hanno inserito nel dossier sui “silenzi” in merito alla persecuzione degli ebrei nella Germania nazista. L’appello lucido, consapevole, responsabile, fondato su ragioni etiche, religiose, spirituali e politiche, è stato oggetto di
riflessione nella Giornata di studio (24 ottobre 2003) tenuta presso la Pontificia
Università Lateranense, e recentemente pubblicato nella raccolta di saggi Edith
Stein e il nazismo, con contributi di Philippe Chenaux e Hugo Ott (Parte I: Situazione storica), di Angela Ales Bello e Vincent Aucante (Parte II: Questioni filosofiche), con una Prefazione e una Postfazione dei curatori.
Lo storico della Chiesa Philippe Chenaux pone subito alcune questioni in
forma interrogativa: si può storicamente parlare di un esplicito atteggiamento
di “resistenza” in Edith Stein, o la sua missiva è piuttosto da interpretarsi come
un gesto isolato, preludio di una sorta di disimpegno nei confronti della vita
pubblica, come l’ingresso nel Carmelo di Colonia nell’ottobre di quello stesso
anno sembrerebbe confermare? C’è nel pensiero della Stein una specifica
riflessione filosofico-politica sulla natura del nazismo e sull’avvento Terzo
Reich, di questo male assoluto e radicale, denominato totalitarismo? E ancora: vi sono legami attendibili tra questa lettera, che denuncia i pericoli del
nazionalsocialismo per la fede cristiana, e la condanna del “neopaganesimo”
razzista da parte dell’enciclica Mit brennender Sorge del marzo 1937?
RECEENSIONI
Dichiarando quest’ultima ipotesi «difficilmente dimostrabile» (p. 14) e documentabile da un punto di vista storico, Chenaux si sofferma su alcuni punti dell’enciclica degni di nota: il vile non rispetto del concordato da parte delle autorità del terzo Reich; l’incompatibilità del nazismo (mai nominato esplicitamente) con le verità essenziali del cristianesimo; la condanna della divinizzazione
del popolo (si tratta della degenerazione del concetto di Volk, secondo quanto
attestano più avanti lo studio di Hugo Ott sotto il profilo storico, e quello di Vincent Aucante sotto il profilo filosofico), della razza e dello stato; e infine l’idolatria e il culto neopagano, profanazioni dei concetti religiosi cristiani fondamentali. Chenaux offre preziosi contributi allo studio della prima associazione filosemita della storia della Chiesa, l’Opus sacerdotale “Amici di Israele” (1926),
successivamente condannata dalla Congregazione del Sant’Uffizio (1928); e in
particolare del dossier sul “Syllabus” contro il razzismo del 1938. A quest’ultimo riguardo, egli sottolinea l’impegno di Pio XI che, preoccupato dalla diffusione in Italia delle teorie razziste e antisemite, volle spingersi oltre nella sua
denuncia dell’eresia, definendo senza mezzi termini una vera e propria forma
di apostasia il famoso Manifesto della razza (14 luglio 1938), pubblicato da un
gruppo di scienziati italiani. Nel novembre del 1938 il pontefice scrisse poi a
Mussolini e al re, per protestare vivacemente contro un progetto di legge razziale che impediva i matrimoni tra “ariani” e “non ariani”.
Dobbiamo al puntuale studio di Angela Ales Bello la comprensione delle
nozioni filosofiche di “Stato”, “società civile”, “comunità”, “massa”, così come
Edith Stein le ha elaborate nell’opera giovanile Psicologia e scienze dello spirito (1922), in Una ricerca sullo Stato (1925), e in La struttura della persona
umana (1932). Le analisi condotte negli anni Venti costituiscono un ampliamento di quelle di Adolf Reinach, e tendono a individuare la “struttuta ontica”
dello Stato, il suo essere fondato sul diritto, la sua genesi, la sua funzione e il
suo rapporto con la sfera dei valori. Ales Bello, definendo centrale il ruolo attribuito da Edith Stein alla “comunità”, lo relaziona alla vita politica, sociale e culturale tedesca, dove è determinante, rispetto alla tradizione latina (più individualistica e contrattualistica), l’importanza attribuita al gruppo, all’associazione
umana, e persino alla struttura tribale, nella quale il legame di sangue e quello strettamente familiare forniscono la prossimità. Con la regressione della
nozione di Volk e il ritorno alla prevalenza dei legami di sangue e della razza
è di fatto impedita l’apertura spirituale verso gli altri esseri umani. Nell’età
moderna, il superamento di tale visione avviene proprio sul piano dello spirito,
grazie all’impostazione idealistica (si pensi all’impegno etico segnalato da
Fichte, o al disvelamento dello spirito nel passaggio dalla fase soggettiva a
quella oggettiva in Hegel), molto apprezzata dalla scuola fenomenologica classica, la quale misura con maggiore armonia il rapporto tra il momento della
comunità e quello dell’individualità, assegnando alla persona umana i momenti correlati, costitutivi e inscindibili della corporeità vivente, della psiche e dello
spirito: «Seguendo un’indicazione presente nella sociologia di Tönnies, ma
ripresa dai massimi esponenti della scuola fenomenologica, Husserl e Scheler,
la Stein ritiene centrale la comunità, come luogo di formazione etico-sociale del
singolo, luogo di solidarietà e di coinvolgimento reciproco di responsabilità […].
161
162
È importante notare che è sulla “comunità statale” che si fonda lo Stato. Pur
essendo un’entità giuridica, quest’ultimo non vive, se non è sostenuto da un
consenso che nasce da una visione comunitaria, pertanto, si può parlare dello
Stato come una persona giuridica caratterizzata dalla sovranità, la quale corrisponde alla libertà in senso personale» (p. 69).
Nel pensiero di Edith Stein gioca un ruolo fondamentale la concezione cristiana della persona umana. Si tratta di un’antropologia cristocentrica, che
coglie la complessità dell’essere umano sia nel senso soggettivo individuale
sia in quello intersoggettivo interpersonale. Edith Stein mostra, anzi conferma,
una straordinaria visione d’insieme, capace di tener conto del particolare
essendo sempre orientata all’universale. Spiega Ales Bello: «Secondo Edith
Stein, le forme associative corrispondono all’assolutizzazione degli aspetti
costitutivi umani: se prevale l’attività psichica, allora abbiamo la massa, trascinata dagli impulsi e dalle prese di posizione spontanee puramente reattive, se
prevale l’aspetto intellettuale dell’organizzazione finalizzata a uno scopo si
delinea la società, se prevale la struttura giuridica, allora c’è lo Stato; la comunità mantiene la sua centralità rispetto a tutte queste forme associative perché
coinvolge l’essere umano nella sua complessa articolazione, frutto di legami
psichici e spirituali attraverso i quali si delinea propriamente la vita etica, che
sfocia nel bene del singolo e del gruppo» (p. 110).
In quest’ottica, il momento spirituale-religioso non è una semplice appendice della vita associata, ma il suo fulcro. Se invano si cercherebbe una definizione esplicita di “Stato totalitario” nelle opere di Edith Stein, il suo accorato
appello a Pio XI può però essere letto come denuncia dello smarrimento e
della manipolazione degli autentici valori cristiani; e come lotta alla violazione
dei diritti umani, causata dalla distorsione della fonte ebraico-cristiana che li ha
storicamente determinati e che ora si vorrebbe eliminare. Un tema di grande
attualità, nell’Europa oggi dominata dal dibattito, non sempre lucido né intellettualmente onesto, sulle sue radici e sui suoi fondamenti.
Patrizia Manganaro
L. KOLAKOWSKI, Bergson, a c. e con post-fazione di L. Lestingi, Palomar, Bari
2005, pp.168.
Nella collana “Dia-loghi” dell’editrice barese Palomar è uscita in questi giorni, a cura di Leo Lestingi, una monografia su uno dei più influenti pensatori
della prima metà del Novecento, il francese Henri Bergson (1859-1941). Autore è Leszek Kolakowski, il filosofo polacco divenuto celebre per la sua critica
abbastanza precoce (a partire dalla metà degli anni Cinquanta) delle società
del “socialismo realizzato” dell’Est europeo e soprattutto per la sua vicenda
intellettuale, che può essere considerata esemplare del rapporto tra cultura e
politica proprio dei regimi delle cosiddette “democrazie popolari”. Come tanti
altri intellettuali del dissenso, dopo la repressione della rivolta studentesca del
1968 e di quella operaia del 1970-71, Kolakowski constata da un lato l’allergia
RECEENSIONI
delle élites di potere dominanti alle istanze del revisionismo da loro propugnate che andavano nella direzione di un marxismo antidogmatico e antitotalitario,
dall’altro l’irriformabilità dei sistemi socialisti.
Come sottolinea Lestingi nella sua puntuale e documentata Postfazione,
Kolakowski recupera le fonti morali del socialismo classico, che pone l’accento sulla libertà e la responsabilità degli individui nella storia, e in testo monumentale, Cristiani senza Chiesa (1962), rilegge la storia del cristianesimo alla
luce dell’“antagonismo tra fede e confessione”. Colpisce in questo lavoro non
solo la convinzione di Kolakowski delle matrici teologiche della cultura occidentale, ma soprattutto l’idea, che diventerà sempre più centrale nella sua riflessione teorica, secondo cui la religione non è una mera sovrastruttura della
base economica e dei conflitti di classe, ma una “forma autonoma della
coscienza sociale”. A Oxford, nella solitudine dell’esilio e degli studi, scriverà i
tre grossi tomi della storia del marxismo, Nascita, sviluppo, dissoluzione del
marxismo (1977-78-79), in cui il filosofo polacco rimarca la dimensione etica
del marxismo, nato dalla rivolta contro lo sfruttamento e l’oppressione.
Sempre più interessato al “senso e non-senso” della tradizione cristiana,
Kolakowski si avvicina a una concezione della religione come quella dello storico delle religioni Mircea Eliade, per il quale il linguaggio dei simboli e dei miti
non è da considerarsi come uno stadio arretrato e primitivo della razionalità
logica e scientifica, ma un aspetto originario della vita spirituale. In Presenza
del mito (1972) il filosofo polacco difende la “necessità” del mito, il suo essere
parte integrante della cultura, la sua funzione ineliminabile rivolta a fornire delle
risposte alle domande ultime dell’esistenza. La dimensione del sacro, sembra
di capire, per Kolakowski non può essere completamente prosciugata dalla
secolarizzazione, pena altrimenti la difficoltà o l’impossibilità di percepire il
“male” nelle forme che oggi assume, ad esempio, relativamente ai paradossi e
alle antinomie del progresso scientifico-tecnologico, ma anche relativamente
alla povertà, alla fame e alla miseria di gran parte degli abitanti del pianeta.
Nella cornice di questo spiccato interesse per il religioso si colloca il volume
su Bergson (1985), caratterizzato da un approccio peculiare: discutere fino a
che punto la critica bergsoniana dell’evoluzionismo e del materialismo del suo
tempo è una critica dello scientismo e delle ideologie su di esso costruite, e non
anche una liquidazione del sapere scientifico tout court. Kolakowski ricostruisce
l’itinerario speculativo di Bergson evidenziando come la fama di questo filosofo
nasce da una sorta di reazione all’egemonia del darwinismo e del positivismo
allora imperanti. Alla celebrazione da parte di questi ultimi dell’intelligenza analitica –“geometrica”, astratta, spazializzante– egli contrappone la facolta dell’intuizione, che coglierebbe il tempo reale della coscienza interiore, la “durée”,
cioè la continuità qualitativa dell’esperienza, con cui possiamo afferrare la realtà “assoluta”, non contaminata da pregiudizi utilitaristici. Ciò che a Kolakowski
interessa in questo efficace ritratto del filosofo francese è verificare quanto sia
sostenibile una concezione della coscienza radicalmente distaccata dal cervello e dagli stati fisici, un tema che oggi ritorna nella polemica tra gli esponenti
delle neuroscienze e coloro che non si arrendono al riduttivismo monistico.
E quanto sia sostenibile una contrapposizione tra le forme puramente
163
sociali della morale e della religione (le religioni e le morali ufficiali) da un lato
e le forme differenti in cui lo spirito umano e l’immaginazione si emancipano
creativamente da vincoli ed obblighi coercitivi dall’altro. Sotto questo profilo, se
le polemiche antiscientifiche di Bergson appaiono datate –come faceva notare
Gaston Bachelard, il maggior epistemologo francese del Novecento–, le sue
avvertenze sui limiti e i pericoli del credo razionalista restano quanto mai attuali contro il sempre risorgente complesso di onnipotenza dell’“homo faber”.
Francesco Fistetti
Identità femminile in formazione – Generazioni e genealogie delle memorie, a
c. di M. Durst. Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 199.
164
Il volume, curato da Margarete Durst, docente di Filosofia dell’educazione
presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata, raccoglie i contributi di un gruppo di studiose accomunate dall’interesse per la
“questione donna”, centrata sui rapporti generazionali e sulle genealogie delle
memorie nei processi di formazione e di auto-formazione femminile, in cui il
modello materno e le memorie femminili, costituiscono esempi di identità e di
riferimento in diversi spaccati generazionali.
Il filo conduttore dei saggi raccolti in questo testo, è quello della costruzione
di un’identità femminile a partire dai processi di formazione e di autoformazione
e dai luoghi e mezzi di educazione, come principali strumenti di crescita, di realizzazione, ma anche veicoli di condizionamento e di inglobamento in un contesto di tradizione che per le donne non ha agito sempre come punto di riferimento e di confronto, ma come meccanismo di omologazione in un immaginario collettivo sociale e culturale, di cui sono rimaste spesso vittime. Le stesse figure
parentali, la madre sin da quando si è bambine, poi il marito successivamente,
fungono in positivo o in negativo da punto di riferimento, a volte di legittimazione, approvazione, consenso, poche volte, invece, di crescita e confronto.
La conquista di una propria identità autodeterminata, che parta da un sano
confronto con queste figure, senza che esse diventino elementi condizionanti,
è un lungo cammino di conquista e di libertà che tutte le donne vivono quotidianamente, qualora se ne rendano conto. Le autrici di questi saggi, ci parlano di donne, protagoniste della storia o dei romanzi, che vivono questa scoperta, spesso anche molto dolorosa, di una propria identità ignorata perché calpestata o perché sopraffatta da ogni tipo di manipolazione.
La stessa storia dell’educazione ci mostra come il modello pedagogico pensato per le bambine sia di genere minore, minore spessore teoretico e contenutistico, maggiore tentativo di veicolare e produrre virtù tradizionali, rassicuranti, mai pericolose nell’attentare gli equilibri sociali e culturali costruiti e manipolati al maschile da secoli di storia e di civiltà; virtù intramontabili e mai in evoluzione e che coincidono sempre con l’amore, l’umiltà, la fedeltà, il rispetto, la
pietà, la cura, ecc.
La relazione con la madre, con una tradizione che attrae, ma da cui si è ten-
RECEENSIONI
tate di distanziarsi è molto presente in tutta la letteratura e la narrativa asiatica
di formazione e di autoformazione, ove il confronto generazionale femminile
(madre-figlia-nonna), è narrato in modo magistrale, sottolineando quanto la
tentazione di porre distanze generazionali, significhi prima di tutto mettere di
nuovo in gioco se stesse, rinascere. Sicuramente ripercorrere la storia delle
genealogie, è un cammino interno alla tradizione, nel tentativo, come è evidenziato da Margarete Durst di valorizzare la tradizione stessa come strumento di
orientamento, ma anche come spinta progettuale proiettata verso il futuro.
Proprio la rimessa in discussione dell’identità di genere socialmente costruita e la conseguente decostruzione e critica degli stereotipi femminili ed anche
maschili, avvenuta con maggiore incisività nel secondo Novecento ad opera
del pensiero femminista, ma iniziata già nel Settecento, ha reso evidente l’ambiguità e le deformazioni dei modelli formativi e di ogni tipo di educazione,
dimostrando così lo stretto nesso esistente tra istruzione femminile, costruzione di “modelli pedagogici muliebri ideali” e consolidamento dei pregiudizi sulla
donna. Vi è altresì un filo conduttore, una coordinata comune a legare pregiudizi e ideali di virtù femminili ai modelli di donna privilegiati, connubio reso
ancor più forte dal collante dell’educazione. Queste virtù, spesso in un passato, ancorché recente, venivano tramandate di generazioni in generazione, di
madre in figlia, senza che spesso vi fosse alcuna elaborazione evolutiva o critica verso questa “eredità genealogica”, ma semplicemente per un “automatismo di nascita”, per lo più di parte materna.
Nella genealogia maschile, tradizionalmente trasmessa, la nascita, ovvero
il passaggio generazionale, acquisisce una valenza di potere, di affermazione
di una continuità storica di stirpe e quindi di conferma di autorità patriarcale che
rimanda però sempre a consolidare un passato, pur proiettandolo nel futuro.
La relazione materna, afferma sempre la Durst, acquista una diversa coloritura poiché la donna, nel mettere al mondo un nuovo essere umano, vive
innanzitutto in sé il cambiamento irreversibile che quella presenza comporta e
che, impedendole di rimanere ancorata al passato, la proietta verso un futuro
che ha in quell’evento le sue radici, ma che assume tutte la connotazione propria della trasformazione.
Trasformazioni che sono argomenti di riflessione del saggio di Heather Gardner dedicato alla narrativa anglo-asiatica, in cui proprio il legame madre-figlia
è il modo centrale di una conflittualità accentuata dai cambiamenti generazionali e che mette in dubbio la validità della tradizione. All’interno della tradizione, come in un caleidoscopico labirinto costituito da cerchi concentrici, non si
può non fare i conti con l’educazione e la sua storia, da cui appunto anche l’immagine e l’identità femminile vengono condizionate con il loro portato di ideali
e valori, tramandati sempre dalla tradizione stessa.
Nel saggio di Caterina Poznanski, come in quello di Anna Rossi Doria, si
mette in luce proprio questa continua operazione, a volte di distanziamento,
altre di assimilazione delle donne rispetto alla tradizione, in un conflitto esistenziale in cui è in gioco un intero sistema di valori. Ovviamente, fa notare ancora Durst, il rapporto critico con la tradizione e con il suo spessore valoriale, ha
profondamente inciso sull’itinerario formativo delle donne che hanno dato
165
166
avvio alle ricerche di genere, femministe, e al femminile. Tant’è che la messa
in discussione di percorsi educativi e di una trasmissione di valori tanto obbligati, quanto negatori dei diritti delle donne, all’autonomia, alla cittadinanza, alla
pari dignità e alla differenza, ha dato inizio a una nuova tradizione educativa
(al femminile, femminista, o alla differenza), che sta curando un proprio canone culturale e metodologico, mantenendosi sempre vigile nei confronti delle
standardizzazioni, con ricadute più o meno indirette sull’immaginario dell’identità femminile e sull’esistenza concreta delle donne. Immagine e rappresentazione femminile fortemente condizionata dalla costruzione simbolica maschile,
finendo finanche per deformare la stessa percezione delle donne, che proprio
attraverso la conferma maschile e l’adesione ad un modello, socialmente e tradizionalmente legittimato, realizzano sin da piccole la propria identità.
Va infatti aggiunto, continua ancora Durst, che parlare di autoformazione
delle donne, significa sempre mettere in campo l’uomo, cioè l’identità maschile vissuta a livello d’immaginario ed esperita nei rapporti di realtà, non solo perché l’identità femminile si è in larga misura determinata in maniera speculare
rispetto a quella maschile, ma anche perché la complementarietà dei due sessi
è tutt’oggi iscritta nella struttura genetica dell’essere umano. Di certo, come
osserva Giovanna Providenti in un altro contributo contenuto nel saggio, il pensiero intuitivo, concreto, la sintesi, la comunicazione psico-affettiva, il linguaggio corporeo, attengono alla dimensione esistenziale femminile e mettono in
gioco la differenza sessuale come criterio ermeneutico con cui analizzare il
reale, contribuendo ad elaborare una nuova cultura, più ricca e complessa,
anche in prospettiva pedagogica.
Diverse voci, quelle presenti in questo testo che rimandano però tutte al
lungo processo di gestazione del divenire donna, reso e testimoniato da differenti storie femminili, forme di narrativa e biografie di donne, riflessione sull’attività di formazione e di rispetto della educazione che sappiano restituire respiro, differenza e dunque libertà ad entrambi i sessi.
M. Camilla Briganti
C. MORÓN ARROYO, Hacia el sistema de Unamuno. Estudios sobre su pensamiento y creación literaria, ed. Cálamo, Palencia 2003, pp. 228
È apparso nelle librerie spagnole il testo di uno dei pionieri e più importanti studiosi di Miguel de Unamuno: Ciriaco Morón Arroyo, colui che ha apportato un decisivo contributo negli studi unamuniani attraverso l’individuazione di
quattro tappe fondamentali nella riflessione dell’autore, necessarie per la comprensione della sua opera.
In realtà, per chi scrive, i contributi apportati da C. Morón Arroyo allo studio di
Unamuno sono molti, perché la sua profonda formazione filosofica e filologica, e
gli studi da lui condotti sul tempo storico in cui s’inserisce e vive don Miguel,
costituiscono un punto di vista fondamentale per comprenderlo appieno.
E ciò lo si può vedere nel modo in cui C. Morón Arroyo interviene sulle sup-
RECEENSIONI
poste contraddizioni unamuniane, e la sua asistematicità, distinguendo fra ciò
che la cultura centroeuropea intende per sistema (= Hegel) e ciò che è sistema in Unamuno, che è invece pensatore spagnolo; un modo diverso quindi di
svolgere la propria riflessione, ma non per questo meno sistematica, ed in ciò
rivelando una particolarità tutta spagnola, e dei pensatori più in generale. Ed
anzi proprio a proposito dei pensatori (Unamuno, Ortega, Borges, Servet…, L.
Valla, Machiavelli…), di coloro che hanno cambiato la direzione del pensiero
occidentale, C. Morón Arroyo coglie l’occasione per lamentare un’assenza di
un’attenzione della Storia della filosofia nei loro confronti, oltre che di studi o
cattedre universitarie dedicate allo studio del loro fondamentale apporto.
Altri argomenti trattati nel testo, che raccoglie saggi pubblicati nel corso
degli anni in riviste o atti di convegni, sono studi analitici su: En torno al casticismo (1895) nel quale viene illustrata la prima tappa del pensiero di don
Miguel (1884-1897) dedicata allo studio dei problemi della Spagna del tempo,
presa nel dibattito fra tradizionalisti e progressisti per ciò che concerne la rigenerazione della patria. Rispetto ad essi, Unamuno preferirà, come sottolinea
l’autore, la tradizione eterna: paradosso che esprime la volontà di cercare un
concetto nucleo che unisca due contrari quali sono tradizione e modernità. Tale
tradizione eterna si trova nel popolo contadino, ossia nell’intrahistoria, opposta
alla historia, costituita invece dagli avvenimenti esterni che non lasciano traccia profonda nel popolo, ossia da ciò che è passeggero e superficiale e non
influisce nella lingua del popolo, vera fonte della sua storia. Una posizione che
tuttavia cambierà con il 1901, quando sparirà il dualismo historia/intrahistoria
ed i significati prima attribuiti all’intrahistoria saranno assorbiti dalla historia,
oltre al fatto che ora il simbolo della civilizzazione storica viene scoperta nella
città, e nei cittadini, anziché nelle campagne e nei contadini.
La novella Niebla è occasione per C. Morón Arroyo di un’altra acuta riflessione nella quale, inseguendo la ricostruzione scientifica del sistema di Unamuno, parte dalla definizione di scienza quale studio dell’essenza ed apparenza delle cose, che prescinde dalla causa esistenziale che le produce, per proporre, contrariamente ad altra critica, uno studio della novella distaccato dalla
biografia del suo autore. Questo perché, proprio quando si prescinde dall’autore, l’opera artistica che pure resta individuale ed in ultima istanza incomprensibile come la vita, si tesse con altre, assume esistenza autonoma, e va a formare quella che definiamo come la cultura di quel particolare momento. E siccome per lo studio di un’opera d’arte occorre un metodo morfologico, se tale
metodo viene utilizzato per riordinare l’opera unamuniana, l’autore ritiene che
ciò possa permettere di ricostruirne il sistema. Un sistema in cui le note principali sono: l’eliminazione di elementi descrittivi nella presentazione dei drammi
umani, la fusione di finzione e realtà, il richiamo alla teoria tomista della visione beatifica, come al mito della caverna platonico. Un sistema che troverà la
sua sintesi nell’altra novella San Manuel Bueno, mártir (1930) e che «risulta un
inventario –afferma l’autore– delle idee di Unamuno. Ed è fino a tal punto un
inventario e sunto, che ci sono frasi indecifrabili, perché sono ritagliate da contesti più ampli» (p. 123). Insomma Niebla è l’espressione della problematica
radicale della persona umana: essere/non essere, che si struttura in base agli
167
168
elementi della filosofia classica, precedente all’esistenzialismo, come sottolinea l’autore, e finisce per essere –nell’opera complessiva di don Miguel– «l’incrocio in cui si passa a trattare esplicitamente un nuovo nucleo di temi: i problemi della personalità» (p. 85).
Ma Unamuno è anche poeta, ed il suo poema forse più importante è El Cristo de Velázquez che Morón Arroyo analizza nell’intenzione di rilevare come
s’inserisca il poema nel pensiero di don Miguel ed in cosa consiste il poetico
rispetto alla poesia spagnola del tempo. La divisione del poema in quattro parti
ed i temi in esse trattati corrispondono a quelli che pre-occuparono Unamuno
durante tutta la sua vita: il Cristo crocefisso/redentore dell’umanità (= Dio); il
Cristo che vince la morte donando al mondo la speranza (= la cultura ed il
posto svolto dalla Spagna); descrizione del quadro di Velázquez in quanto tale
(= arte e quindi la scrittura); speranza della resurrezione, per cui don Miguel
chiede di identificarsi con Cristo per sempre. Nel poema si rispecchiano però
anche problemi su cui Unamuno si concentrò negli anni che vanno dal 1913 al
1920 e quindi il contrasto parola/lettera, la relazione universale vita-coscienza/vita-cultura; il dibattito con i protestanti sulla concezione di Cristo come eroe
morale/garante dell’immortalità di ogni individuo e perciò senso ultimo per la
vita e l’universo; da qui che il Cristo che si consegna alla morte, non solo dà
vita alla cultura della manifestazione di Dio, ma con la fede nella resurrezione
della carne, dà vita ad una specie di dualismo o distinzione fra quel tipo di fede
dei primi cristiani e la fede nell’immortalità dell’anima introdotta da S. Paolo.
Insomma il poema si configura come una meditazione o un dialogo dell’autore
con Cristo e come contemplazione nella misura in cui ha davanti a sé il quadro. Inoltre nel poema parla l’autore con la carne y hueso della sua anima e
quale espressione, portavoce di tutto un popolo ed anzi dell’umanità. Il fatto poi
che Unamuno lavorò a tale poema per sette anni e che le sue parti siano collocate in ordine logico, fa ritenere a Ciriaco Morón che sia questo un poema
sistematico, nel quale don Miguel pur parlando tante volte contro la ragione,
opta per una poesia densa, di pensiero che sente. Ciò sta a dire che la ragione è per Unamuno la facoltà suprema dell’uomo –sulla concezione della quale
poi l’autore ritorna in un altro capitolo in cui la illustra parallelamente a quella
di Ortega (pp. 209-228)–, quella che ignora e cerca il fine dell’universo e non
certo quella che amputa la questione umana per eccellenza: da qui l’accusa di
sadduceismo per H. Cohen e la proposizione del Cristo corpo come risposta
alla conoscenza pura ed alla volontà pura e contro cui realizza un poema:
riflessivo, figlio del sentimento (= attitudine totale dell’uomo), in cui la lingua è
primo scoppio di significato e riverbera in tutte le sue possibilità di significazione, e dove la storia è assunta a centro imprescindibile perché la vita dell’uomo
abbia senso. Il poema di Unamuno è allora, secondo Morón Arroyo, un
«modello di poesia classica: realizzazione di un mondo di senso, non semplice espressione di sentimenti personali né ricerca d’immagini senza riferimento alla realtà» (p. 100) come era invece per i coltivatori della poesia pura della
Spagna intorno al 1916, e motivo per cui l’uscita del poema di don Miguel
passa sotto silenzio.
Ed a proposito di scrittura e di essere, un’altra illuminante analisi è quella
RECEENSIONI
che l’autore ci offre in Ser y escribir: consistencia de Unamuno y paradojas de
la realidad, nel quale si ribadisce la fondamentale consequenzialità dell’Unamuno pensatore, unitamente alla sua asistematicità, se si considera il termine
sistematico nel suo senso convenzionale. Una consequenzialità che resiste
nonostante apparenti contraddizioni come quella che si potrebbe riscontrare
nella visione ora negativa, ora positiva circa la scrittura; ciò infatti riguarda
sempre il libro che si legge, perché ci sono libri vivi che sono fonte di vita, altri
invece che mortificano la vita. Così possono sembrare contraddizioni le contrapposizioni: verbo/palabra, sempre celebrata da don Miguel come spirito e
vita e contemporaneamente la sua volatilità fuggitiva; letra que mata/vivifica e
da qui la tendenza di Unamuno a scrivere come «scrittore oviparo che feconda le proprie posizioni con lavoro, mediazione e costanza» (p. 116). «La preferenza per la parola parlata sulla scrittura –continua l’autore– si fonda sul fatto
che certamente la prima è spontanea, sincera ed autenticamente nostra; mentre la seconda è artificiosa, libresca e non personale […]. Parlare e scrivere
sono due forme di realizzare la lingua, che nulla hanno a che vedere con la
spontaneità e la sincerità. La sincerità dell’uomo non è il suo primo movimento davanti ad uno stimolo, ma la decisione che si prende per un motivo ragionevole» (p. 117). Insomma la relazione palabra/escritura in Unamuno riflette
una «lotta fra il dovere, il volere ed il poter dire. Il testo è il risultato di quella
lotta» (p. 119); qualcosa che si riflette in ognuno di noi e che quando si realizza, in testo appunto, si fa forza storica, l’anima del proprio autore. E proprio
partendo dalla scrittura, si può cercare di definire l’opera di Unamuno; e forse
il termine che più la indica è quello di differenza, come sostiene Ciriaco Morón,
spiegando la scelta di questo termine con l’uso che don Miguel fa della Y (= e),
non solo come congiunzione copulativa, bensì come «una forma di presenza
dell’autore nel proprio scritto» (p. 145). Quest’uso della Y che è topico di Unamuno, spiega la differenza come punto di convergenza di due concetti contrari che se da un lato si respingono, dall’altro invece si richiedono a vicenda per
negarsi. La Y è allora il vincolo che fonda i contrari e la differenza è una rielaborazione del concetto hegeliano –ed a proposito di Hegel, l’autore si preoccupa anche di stabilire l’influenza e la presenza nei vari periodi intellettuali di don
Miguel (pp. 179-207)– e marxista di dialettica. Ora don Miguel, sui temi fondamentali di cui si occupa la filosofia e che afferiscono all’esistenza umana (identità, senso dell’esistenza, tempo ed eternità…), scrive dei poemi. Da questo
punto di vista si può quindi affermare che la sua poesia è filosofica, ma contemporaneamente che si tratta di una poesia autentica. Ecco allora che la E di
filosofia e poesia va ad esprimere un’identità ed al contempo una differenza,
perché ognuna fa riferimento ad una funzione diversa espressa dalla parola
umana: comunicazione d’idee, di sentimenti, di sensazioni di musica e colore,
e di tipo strutturale. Don Miguel, come afferma Ciriaco Morón, nelle sue contorsioni linguistiche esprime «l’anelito di fusione di contrari presenti nei primi
archetipi dell’immaginazione» (p. 157). Se infatti la filosofia trova la sua origine nello studio delle categorie primarie della mente (essere/non essere,
io/altri…); e la poesia incarna le immagini che incarnano le forze della vita e
della morte (Dionisio/Apollo, ragione/istinti…); ecco che la poesia di Unamuno
169
non fa altro che drammatizzare le immagini primarie della mente. «È una poesia –dice Ciriaco Morón– filosofica nel più stretto senso; da una parte, perfettamente razionale, ma non puramente razionale, perché realizza le quattro
funzioni del linguaggio» (p. 156).
Da qui che si può intendere il lemma usato da don Miguel: siente el pensamiento, piensa el sentimiento.
Carmine Luigi Ferraro
Marialuisa Pulito, Identità come processo ermeneutico. Paul Ricoeur e l’Analisi Transazionale, Armando, Roma 2003.
170
Il testo di Maria Luisa Pulito costituisce il lucido tentativo di tracciare una
linea trasversale tra filosofia e psicoanalisi non tanto e solo per sondarne
l’aspetto interdisciplinare, quanto per rinvenire, attraverso la specifica opera di
Paul Ricoeur e di Maria Teresa Romanini, una zona di convergenza profonda,
rappresentata dalla questione della identità personale. Il complesso lavoro
dunque, più che interdisciplinare, potrebbe definirsi con-disciplinare, o fondativo quanto alla legittima possibilità tanto per il discorso filosofico quanto per la
teoria/pratica psicoteraupeutica di collocare rettamente e, conseguentemente,
trattare la persona nel rispetto e nella prospettiva della sua identità.
A dispetto di una tale complessità della sfida proposta, il linguaggio utilizzato dall’autrice è fluido, semplice e lineare pur senza risultare mai riduttivo. Grazie alla felice confluenza della formazione filosofica con la sua intensa attività
professionale di psicoterapeuta, Maria Luisa Pulito riesce inoltre ad enucleare
e tenere nel discorso linee teoretiche complesse come quelle relative alla dottrina della sostanza, alle teorie del corpo, del linguaggio, dell’ermeneutica e
della ontologia, accanto a frequenti esemplificazioni pratiche, di fenomeni vitali quotidiani –vere e proprie Lebensformen– tentando costantemente di mostrare l’operatività della teoria nella prassi, e la possibilità di rinvenire, con metodo, il nucleo di senso soggiacente a manifestazioni, situazioni, modi di dire e
di agire, relativi al sempre vivo relazionarsi dell’io con sé attraverso l’altro e dell’io con l’altro attraverso di sé.
La questione centrale, come emerge dal titolo, è cogliere l’identità della persona, quale processo ermeneutico. Tale processo, come insegna Ricoeur, e
come attentamente mostra l’Autrice specie nella prima parte della sua opera,
pur oscillando tra volontario ed involontario, pur marciando attraverso le strettoie di una identità in bilico tra la pura autouguaglianza dell’io con se stesso
(idem) ed il fuggevole e dinamico tratto dell’io che agisce, gioisce e soffre, contaminandosi con gli altri pur rimanendo il medesimo sé (ipse), costituisce fondamentalmente un processo unitario, che si snoda nella complicata trama narrativa del tempo, nell’intreccio di vita destinato poi a diventare materiale di racconto nelle sedute di analisi psicoterapeutica (cfr. p. 178).
Dunque, la persona non ha una sostanza già costituita, né una essenza
identica e singolare che brillerebbe di per sé nella costellazione di altre analo-
RECEENSIONI
ghe identità personali. L’identità è la risultante di un processo, ciò che deriva
da una ampia articolazione di elementi mobili come la mente, il corpo, gli stati
dell’io, la coscienza, gli atti linguistici, le pulsioni, i vissuti, la trama di vita condivisa attraverso Altri.
Riprendendo Ricoeur, l’identità dunque, inerisce il cogito integrale (cfr. p.
173), sospeso tra il «volontario» articolato in progetti, decisioni, motivi razionali e moventi pulsionali (tale differenza, non teorizzata da Ricoeur, viene inserita dall’A. – cfr. p. 45) e l’«involontario» rappresentato in primo luogo dal corpo
inteso come luogo della passività e affettività, delle emozioni, delle sorprese e
delle abitudini (cfr. pp. 49 ss.) e in secondo luogo dal carattere che, lungo l’evoluzione del pensiero di Ricoeur (da Il volontario e l’involontario, lungo Finitudine e Colpa sino a Sé come un altro), ha inizialmente rivestito il lato immutabile dell’identità personale per poi invece, in modo più elastico, venire definito
come quell’“insieme della note distintive che consentono di reidentificare un
individuo umano come il medesimo” lungo la “continuità ininterrotta e la permanenza nel tempo” (cfr. p. 59).
La questione dell’identità è dunque una trama compartecipata da molte
linee di attività e passività, dove la mediazione dell’Altro, interviene sempre e
costantemente, in senso discorsivo, etico ed ontologico, nella mutevolezza del
Sé: proprio dall’incidenza di molte variabili, è possibile dunque pensare ad una
identità della persona, e, in senso reversivo, tracciare a partire da questa identità una ipotesi di comprensione umana.
Nella seconda parte del libro e dettagliatamente dal capitolo quarto, l’A. tenta
di traslare i contenuti forti della questione dell’identità tracciata da Ricoeur entro
la teoria analitico-transazionale teorizzata, nello sviluppo della psichiatria sociale, da Berne e, successivamente, in maniera originale, da Maria Teresa Romanini. Tale teoria, nata negli anni ’50 analizza, nel senso ermeneutico di adagiarfuori secondo il significato proprio dell’Auslegung, i singoli Stati dell’Io. Nel raccontarsi, e nello scambio di comunicazione con il terapeuta, l’analizzato, attraverso l’attività linguistica/emozionale intersoggettivamente articolata nel tono della
voce, nel modo di espressione, nei significati e segni emergenti, lascia scaturire
una serie di informazioni che rivelano i mutevoli quanto strutturali, Stati dell’Io,
intesi, secondo Berne, come sistemi compatti di sentimenti o comportamenti riferiti a un determinato soggetto o come schemi uniformi di sensazione e esperienza cui corrispondono schemi di comportamento (cfr. p. 112). Entro questa visione, la personalità si sviluppa in un tempo condiviso ed interpolato con altri, attraverso transazioni, attraverso in particolare giochi più o meno consapevoli e normalmente ricorrenti, allo stesso modo di un copione scritto diretto e interpretato
dall’io stesso nel ritmo dei suoi progressivi vissuti, attraverso l’articolazione del
corpo e della mente interagente con altri (cfr. p. 124).
L’idea del copione, si riferisce a quel processo ermeneutico in ordine al
quale, noi cerchiamo di attuare un programma di vita inconsapevolmente autodeterminato, di realizzare la nostra propria identità nella autoesplicitazione di
una vita, seguendo spesso modelli definiti di personalità o di destino, di cui,
secondo Berne, i miti come quelli di Ercole, Damocle, Tantalo, Aracne, Sisifo
costituiscono precise esemplificazioni (pp. 125-126).
171
172
Su questa scia, Maria Teresa Romanini, approfondisce il discorso sullo sviluppo e sulla struttura della personalità, passando attraverso la teoria dell’attaccamento, a partire dall’attività protomentale dell’embrione e della vita prenatale, lungo l’attività motoria e conoscitiva del bambino, culminante nella pronuncia del proprio pronome personale “io”. Riprendendo la dinamica temporale della personalità, la Romanini, come in modo preciso e accurato mostra l’A.,
assume l’idea di copione come processo fisiologico di interpretazione/comprensione della vita personale, che si struttura e si mantiene attraverso progressive identificazioni. Nelle parole stesse di Maria Teresa Romanini, il copione, che mantiene il significato teatrale di una identità che si vuole costante, è
un programma di vita, il migliore possibile lungo cui si snoda congiuntamente
la crescita psicologica e la parabola biologica (cfr. p. 136): il che comprende,
nel senso di Ricoeur, la questione ontologica della identità avvinghiata alla
istanza etica, ripresa sulla scia di Aristotele, del vivere con e attraverso gli altri
una vita buona all’interno di istituzioni giuste (cfr. pp. 84 ss.).
In questa parte del libro particolarmente densa e palpabilmente sentita dall’A., Maria Luisa Pulito esplora, attraverso la reinterpretazione dell’opera della
Romanini, la triplice dimensione bio-psico-esistenziale della persona, la costituzione della mente umana e dell’autoconsapevolezza, intesa come autonomia, autenticità dell’essere, piena accettazione della propria ed altrui identità.
Il contributo del testo è chiaro: tentare una strada omnicomprensiva, di
accerchiamento della comprensione umana, dove si mostra che nella cura
degli altri siamo implicitamente inclusi, così come siamo avviluppati alle dinamiche interattive della costituzione del nostro sé. L’Analisi Transazionale permetterebbe, una volta individuati gli Stati dell’Io interagenti nelle varie situazioni, di liberare la persona dalle strettoie copionali.
In questo senso, Maria Luisa Pulito, propone di operare, nell’ambito della
ricerca psicoterapeutica, una sostituzione prototipica, sovrapponendo la tragedia e il modello dell’Antigone a quello di Edipo, giacché, a differenza dell’Edipo, tragedia afferente al potere della verità e al tentativo inconscio di mascherarne gli ineluttabili effetti, Antigone esprime, entro il dramma della giustizia,
quel conflitto tra autorità del diritto vigente e legge eterna del sentimento
umano, tra quello che siamo e quello che vorremmo essere o che saremmo,
che lascia risaltar fuori, ancora più forte di un destino, la nostra fragilità affettiva e la nostra aperta, precaria identità.
Pier Paolo Fiorini
G. INVITTO, Sartre. Dio: una passione inutile, Edizione Messaggero, Padova 2001,
pp. 96.
J.-P. SARTRE, La mia autobiografia in un film. Una confessione, traduzione e cura
di Giovanni Invitto, Cristian Marinotti Edizioni, Milano 2004, pp. 160.
Giovanni Invitto è certamente uno dei più attenti e dei più costanti cultori
della filosofia francese del Novecento. I suoi studi su “Sartre e dintorni” sono
RECEENSIONI
notissimi, e non solo in Italia. È stato ed è un protagonista di prim’ordine nel
dibattito filosofico e storiografico da oltre un quarto di secolo. I suoi più recenti contributi alla migliore comprensione dell’autore di L’être et le néant riguardano il tema della religione, affrontato in una bella monografia, Sartre. Dio: una
passione inutile, e la cura e la traduzione, accompagnate da una puntuale
“Nota in premessa”, di una sorta di autobiografia tracciata da Sartre nella sceneggiatura del documentario Sartre par lui même: Jean-Paul Sartre, La mia
autobiografia in un film. Una confessione.
La monografia del 2001, inserita in una raffinata collana diretta da Giorgio
Penzo: “Tracce del sacro nella cultura contemporanea”, percorre tutta la consistente e corposa produzione del filosofo francese per evidenziare il tipo di
approccio al sacro e al tema di Dio. Le analisi di Invitto non si fermano alla semplice sottolineatura del ben noto ateismo sartriano. Non vogliono ribadire la
natura “pregiudiziale” di questo ateismo e l’impegno del filosofo a progettare un
mondo senza Dio, un mondo che abbia al suo centro la coscienza umana, intesa come libertà, e l’esistenza, concepita come contingenza. E neppure intendono recuperare e riproporre l’affermazione secondo cui Dio è l’idea di un essere
verso cui tende l’uomo, in quanto “Dio è la realtà umana come totalità”, con la
conseguenza di sentire il sentimento religioso come una “struttura permanente
del progetto umano”. E, nonostante il titolo, non si propongono come finalità
esplicita di mostrare la faccia negativa, il rovescio dell’impegno a considerare
l’ateismo come il segno dell’emancipazione umana, vale a dire la “solitudine” e
lo “spaesamento”, prodotti dalla convinzione che “l’uomo è un creatore e che è
abbandonato, solo, nel mondo”, e che, pertanto, “l’ateismo non è un allegro ottimismo, ma nel suo senso più profondo, una disperazione”.
L’indagine fine e acuta del “cattolico” Invitto non è neppure sfiorata dalla
tentazione di un eventuale “recupero” ad un qualsivoglia spirito di religiosità la
ricca e complessa riflessione sartriana dalla metà degli anni Trenta agli anni
Settanta. Punta, invece, intelligentemente a capire e ad evidenziare le motivazioni profonde, le movenze concettuali e le procedure logico-zetetiche che giustificano e sottendono la scelta di ingaggiare la lotta contro quella che il filosofo parigino considera come la grande “illusione trascendentale”, come il “rovesciamento” della “passione” di Cristo, del Dio, cioè, che muore perché “l’uomo
viva”. Al contrario di quella del Cristo, infatti, la “passione” dell’uomo, consistente nel sacrificarsi perpetuamente perché Dio esista, è “inutile e dannosa”.
Per meglio procedere in questa indagine, Invitto procede ad un’attenta e
rigorosa contestualizzazione del pensiero sartriano all’interno della fitta rete di
relazioni, comprendente non solo l’articolato mondo dell’esistenzialismo e della
fenomenologia, da Kierkegaard a Merleau-Ponty, ma anche la filosofia tedesca
da Marx a Feuerbach a Nietzsche. Questa ricostruzione del reticolo culturale
europeo gli consente di recuperare e di evidenziare il senso profondo del termine “umanismo” usato da Sartre per qualificare il suo esistenzialismo, e di
comprendere le strutture portanti di un tipo di moralità e di responsabilità etica
che, proprio da parte di un pensiero fondato sulla negazione di Dio, richiede di
essere attentamente indagato nella sua genesi e nel suo costituirsi. Il punto
centrico della domanda su Dio anche da parte di un pensiero dichiaratamente
173
174
e pregiudizialmente ateo sta, infatti, proprio nel bisogno di fondare una morale a partire dal grido di Zarathustra, “Dio è morto”. A Invitto, infatti, interessa
evidenziare proprio i risvolti umani e morali della “fede” sartriana nell’ateismo.
Ed interessa, altresì, mostrare che l’affermazione nietzschiana relativa alla
morte di Dio non è assunta in proprio dal filosofo francese per il semplice gusto
di essere irriverente o comunque eccentrico, ma con tutta la serietà possibile,
con la conseguenza di tentare di fondare, a partire da essa, un’antropologia
filosofica e una morale antisistematica e antiprecettiva, che abbiano, entrambe, come punto fondante la contingenza dell’esistenza e l’essere in situazione
dell’uomo.
La morale è al centro anche dell’altro volume curato da Invitto ed inserito
nella collana “Sartriana”, di cui è responsabile Gabriella Farina. La mia autobiografia in un film, infatti, non rappresenta soltanto l’ampliamento dell’arco di
tempo della vita del filosofo ricostruita da Sartre stesso attraverso i ricordi. È,
come tutti i suoi scritti, un libro di filosofia. È un’autobiografia costruita con finalità e procedure filosofiche. Sartre intesse con Simone di Beauvoir, con André
Gorz, con Michel Contat e con altri, un “dialogo”, che a Invitto sembra assumere l’andamento dei dialoghi platonici. E lo fa al fine di fare chiarezza non soltanto al proprio interno, illuminando il suo passato, il suo formarsi come “borghese” avverso alla borghesia, ma soprattutto per illuminare un periodo storico, un
arco di tempo denso di eventi e di scelte assai significative. Se è vero che ad
essere preso in considerazione da Sartre è tutto l’arco della sua vita, dall’infanzia fino al 1972, è vero anche che gli anni fino al 1962 erano già stati ricostruiti
e ripensati in Les mots. La novità vera, perciò, è rappresentata dal decennio
1962-1972. Sono gli anni in cui il filosofo aveva scelto di “essere con” il popolo,
di mettere a disposizione dei giovani attivi nella primavera del ’68 tutto il suo
prestigio di intellettuale “intoccabile” e tutto il “suo intemerato coraggio civile”.
Nel far luce sul periodo storico indagato, da analista attento, capace di far
risaltare la tessitura relazionale che lega il soggetto alla situazione e agli altri,
Sartre riflette su se stesso, sulla sua “ambiguità” di uomo dalla “pelle borghese”, che si affianca a quanti vorrebbero liquidare la società borghese, con la
piena presagita consapevolezza che non starà poi “molto comodo” nella società che augura agli altri. Egli sa che è questione di “pelle” e che, perciò, la scelta intellettuale e morale di impegnarsi in una lotta a favore delle masse si scontra –come annota acutamente Invitto– con “l’impossibilità ‘situazionale’ d’impegnarsi in maniera decisiva e ‘appartenente’”. Nella densa e acuta “Nota in premessa”, Invitto coglie e discute tutti i temi affrontati nel testo: dal rapporto letteratura-filosofia a quello autobiografia-filosofia; dall’esame della “personalizzazione” della libertà e della responsabilità individuale del singolo all’orizzonte
civile, politico e morale in cui maturano le sue scelte e che fanno del soggetto
l’“universale singolare”; dal ruolo dell’intellettuale alla “più volte ribadita imprescindibilità della morale”.
Lo scenario non è una pratica psicanalitica, con tutti gli addenda che l’accompagnano. Sartre non crede al subconscio né ai condizionamenti che irretiscono la coscienza menomandone o frustrandone la libertà. Lo scenario è
la ricostruzione e la riaffermazione di un percorso di pensiero che affonda le
Aniello Montano
MICHELE BRACCO, Sulla distanza. L’esperienza della vicinanza e della lontananza nelle relazioni umane, con uno scritto di Lorenzo Calvi, Stilo Editrice, Bari
2003, pp. 124.
Non si può non provare una piacevole sorpresa nel leggere, con gusto e
con profitto, un libro di filosofia dalla scrittura scorrevole, semplice, eppure
rigorosa e impegnata. Tanto più se opera di un giovane studioso: le opere giovanili, specialmente se filosofiche, risentono, si sa, di forme di scrittura mutuate dalla scuola e dai maestri da cui si proviene e si dipende. Al contrario è la
maturità che, di solito, consente libertà di pensiero e di stile. Nel libro di Michele Bracco, giovane e filosofo, non si avverte, se non per qualche dovuto riferimento teorico, l’area culturale di formazione. La lettura, agevole e veloce,
passa con libertà e, insieme, con pertinenza, dalla filosofia alla pratica psicologica e psichiatrica, ai temi della più attuale riflessione morale, senza condizionamenti di scuola e dimostrando la capacità dell’Autore non solo di muoversi in maniera agile e sicura tra le righe degli autori citati, ma anche di saper
pensare con la propria testa.
Nella libertà intellettuale che l’Autore rivendica nei riguardi dei suoi stessi
auctores, l’approccio al tema della distanza –nozione che assieme a quella di
vicinanza e di lontananza proviene dall’ambito della geometria e della fisica,
ma che qui viene indagata e discussa in una chiave tutta filosofica– assume
una valenza eminentemente etica, le cui tracce mi pare di cogliere fin dall’Introduzione, nella quale, come è d’uso, si riversano le personali dichiarazioni
d’intenti e di princìpi. È qui che egli si impegna a dare particolare risalto a quella distanza dell’Altro, “la cui prossimità… rende possibile la dimensione etica”
(p. 10): distanza, prossimità, dimensione sono componenti di un discorso etico.
Infatti, “senza distanza non potremmo mai andare incontro all’altro” e “senza
distanza non ci sarebbe per l’uomo alcuna libertà” (ibidem).
La distanza, dunque, come supporto della differenza e della libertà; ma differenza e libertà, tra loro connesse, sono componenti della democrazia. Senza
la distanza esistenziale tra l’uno e l’altro verrebbe meno la precondizione di
libertà, che rende irripetibile il singolo: scomparirebbero le differenze e prevarrebbe il conformismo. Tutti eguali. Si vedano le pagine dedicate al tema della
molteplicità delle lingue e del pluralismo dei costumi e dei valori che caratterizza il nostro tempo, nel capitolo su “La distanza culturale”. Qui spazio, differenza, multiformità linguistica si contrappongono alla “desolante omologazione”
RECEENSIONI
sue radici nella fiducia antidealistica che l’esistenza è il primum da cui tutto
discende: “je suis donc je pense”; di un percorso che consuma anche attese
e aspettative, amicizie e collaborazioni (come nel caso di Merleau-Ponty e di
Camus), ma che sintetizza “paradossalmente e forse involontariamente”
–come finemente annota Invitto– “circa sessant’anni di un engagemet radicalmente etico”.
175
176
che è la necessaria conseguenza di una “imposizione totalitaria”: le uniformi
delle organizzazioni fasciste e naziste.
Privilegiando il tema del rapporto tra noi e gli altri, Bracco per un verso
manifesta la sua sensibilità intellettuale verso la contemporanea antropologia
filosofica (dalla Kristeva a Todorov, e, in Italia, da Remotti a Fabietti), per la
quale identità e diversità sono prodotti culturali, così come per Bracco è lo spazio; per un altro verso, l’insistenza con cui egli attribuisce al linguaggio la funzione di esplicitare non solo un “modo di dire”, ma anche un modo di “dischiudere e di significare qualcosa” (pp. 16-17) mi pare che lo sospinga, in modo
per dir così naturale, al di là di quei confini di scuola, ai quali pure rivolge “l’onore delle armi”, mostrando di non rifiutare a priori un confronto con indirizzi teorici che, partendo dalla svolta linguistica avviata da Wittgenstein, usano il linguaggio come uno strumento più idoneo a denotare i percorsi delle relazioni
tra gli uomini di oggi, per una soluzione dell’intricato problema della convivenza tra culture, religioni, tradizioni, che nell’èra della globalizzazione è quanto
mai urgente per mettere fine alle tremende e preoccupanti deflagrazioni che
hanno aperto il terzo millennio.
Filosofi appartenenti all’area culturale anglosassone hanno riconsiderato
infatti da circa mezzo secolo, in termini di filosofia morale e politica, l’impianto
teorico delle relazioni interpersonali senza essenzialismi, né irrigidimenti
sostanzialistici, che quasi necessariamente portano a trasformare il dialogo in
un duello. Non è un caso che la critica alla filosofia come specchio della natura e la sua riformulazione come un insieme di “vocabolari,” più semplicemente
di linguaggi differenti, condotta da Richard Rorty –o, ancora meglio, la definizione di Jürgen Habermas del dialogo come un discorso volto all’intesa e dell’umanità come comunità di dialoganti– caricano sulle spalle dei singoli la
responsabilità di un raccordo tra gli uomini.
È quanto mi sembra voglia dire l’Autore (pp. 32-37) a proposito dei diversi significati dell’“abitare”, come rapporto di familiarità, di condivisione della
quotidianità, un prendersi cura di persone e cose che ci circondano. Vivere
lo spazio, osserva appunto Michele Bracco, induce a ripensare “in termini
assolutamente nuovi la prossimità e la distanza”. Riferendosi, d’altro canto,
alla nozione heideggeriana di “visione ambientale preveggente”, egli conclude che “non esistono affatto cose né tantomeno spazi neutri” e che pertanto
non può non esserci un “rapporto costitutivo” che faccia da cerniera al rapporto tra noi e le cose. Ma, al di fuori del linguaggio heideggeriano, in cosa
consiste questo rapporto? Su questo motivo l’autore ritorna più volte e, forte
di una sua dimestichezza con pratiche pedagogiche e psichiatriche, si richiama ad alcune figure: l’alunno annoiato e angosciato dalla scuola e lo schizofrenico chiuso in se stesso, ambedue precipitati al fondo della loro esistenziale “distanza inattingibile”, che –pur nella diversità dei due casi esemplificati e prescindendo da aspetti di natura patologica– si può tradurre con
“chiusura del dialogo”, che invece andrebbe ad ogni costo riaperto, giacché,
io credo, solo il dialogo consente di scavalcare la rigidità esistenziale della
costitutività dell’esserci.
Mi permetto di aprire questa breve e cordiale discussione con l’Autore a
Franz Brunetti
M. T. RUSSO, Corpo, salute, cura. Linee di antropologia biomedica, Rubettino,
Cosenza 2004, pp. 252.
Per coloro che dubitano dell’utilità della riflessione filosofica circa questioni ormai padroneggiate con crescenti successi dal sapere scientifico e tecnologico, questo libro può valere come una provocazione. Certamente ogni provocazione è sempre in qualche modo enigmatica, soprattutto in quanto alle
RECEENSIONI
proposito di quell’incontro con l’Altro, su cui si sofferma con efficace capacità argomentativa nel capitolo su “La distanza assoluta”. A me pare, infatti,
che non sia il caso di andare alla ricerca di una costituzione preordinata, di
un fondamento cioè di natura ontologica. Secondo me il rapporto nasce dalla
necessità od opportunità di conoscersi e di convenire su qualcosa, parlando,
discutendo, magari anche azzuffandosi. Ciò che serve all’intesa è che non ci
sia nulla di preordinato, se non la volontà di concludere. Non mi pare che la
prossimità sia qualcosa di antecedente alla volontà, comunque determinata,
di contattare l’altro, come si sostiene sulla scia di Emmanuel Lévinas (p. 99).
Ritengo invece più convincente il richiamo che J. Habermas fa in Etica del
discorso ad una volontà volta all’intesa. Nulla di trascendentale anche qui,
ma solo un’esigenza della nostra società che, sempre secondo Habermas,
per un agire coordinato ha bisogno di un determinato quantitativo di comunicazione.
È un bisogno che si è accentuato oggi, nelle condizioni di un mondo non più
separato nelle sue parti. Con i viaggi intercontinentali, con la trasmissione
istantanea di somme di denari da un capo all’altro del pianeta, con gli scenari
di guerra o di distruzioni immani, come l’attacco alle Torri di New York, che le
immagini televisive ci hanno dato in tempo reale coinvolgendoci drammaticamente, la distanza non divide e non sgomenta, così come la prossimità non riesce a tenerci legati al nostro villaggio, indifferenti e ostili all’altro, al nuovo, al
diverso, al forestiero. Oggi, Ulisse o Robinson Crusoè non sono più modelli
suggestivi di vita. Dal telefono alla radio, dal computer a Internet e alla posta
elettronica, il mondo è percorso da flussi d’informazione e di input che si sottraggono ad ogni controllo. È la via percorsa ogni giorno dal mondo degli affari, della cultura e della scienza, ed anche, è vero, dalla criminalità internazionale. L’infittirsi della rete di interconnessioni, la velocità e la quantità di implicazioni che ne derivano, conducono ad una intensificazione delle reciproche
dipendenze e il modello dei mondi separati viene sostituito da un’interdipendenza transnazionale.
In questo bel libro, Michele Bracco, partendo dai luoghi austeri della filosofia, non chiude gli occhi dinanzi a questo scenario e, mettendo in discussione la nozione di distanza e dei suoi correlati, ha aperto un itinerario che
obbliga la ricerca teorica a non sottrarsi alla valutazione di quanto ormai è
sotto gli occhi di tutti.
177
178
reazioni che può effettivamente suscitare e, in questo caso, è lecito immaginare che l’eventualità più immediata possa essere di segno negativo. Infatti,
leggendo i tre termini che compaiono nel titolo del volume –corpo, salute,
cura–, viene subito da chiedersi se farne oggetto di una discussione basata
su problematiche, strumenti concettuali e semantici inevitabilmente differenti da quelli più ‘esatti’ della scienza biomedica, non equivalga infine ad un
mero esercizio retorico: uno dei tanti con cui certi filosofi tentano di arginare
l’orgogliosa eppur incoraggiante convinzione della comunità scientifica
moderna di riuscire, prima o poi, a risolvere tutte le questioni che maggiormente inquietano la vita umana.
Sennonché, proprio rivolgendo un’attenzione costante e rispettosa a questa
sorta di promessa che impronta il ‘metaracconto’ della scienza moderna, la
Russo riesce in effetti a provocare una risposta positiva alla questione dell’utilità della filosofia –disciplina che ella tende assimilare all’antropologia filosofica
(cfr. cap. II)– rispetto ai temi presi in esame. È appena il caso di ricordare, per
inciso, che la categoria dell’utile è forse la più denigrata dai filosofi stessi, nonostante costituisca di fatto una sorta di leit motiv delle nostre pratiche di giudizio
e di valorizzazione. Ebbene, gran parte di ciò che Maria Teresa Russo scrive, a
dispetto di qualche espressione di diffidenza verso tale concetto, non fa che
riproporne la insormontabile validità nel nostro modo ordinario di pensare, di
giudicare i nostri e gli altrui atteggiamenti mentali e comportamentali. Ciò tanto
più in quanto si tratta, nel suo discorso, di discutere lo spessore esistenziale di
una serie di attitudini socio-culturali che, a ben guardare, molti di noi non esiterebbero a definire inutili o, quanto meno riduttive, rispetto al pieno riconoscimento della complessa realtà dell’essere umano. In questa luce, infatti, la
Russo si impegna man mano in un approfondimento della domanda filosofica
forse più scomoda da maneggiare: quella circa una definizione sufficientemente motivata di ciò che può dirsi ‘umanamente utile’ nel corso delle circostanze
più dolorose e inquietanti di quelle entità tanto fragili che, nonostante i meravigliosi progressi scientifici, noi continuiamo ad essere.
Così, già nel primo capitolo, dopo aver illustrato con cura e senza eccessi
polemici le ambiguità che circondano la semantica delle nozioni di corpo, salute
e malattia nell’orizzonte post-moderno, l’autrice lascia emergere la sua proposta:
occorre “recuperare un approccio antropologico alla malattia, per valutarla nel
suo spessore di esperienza biografica, nonché un approccio morale, che la consideri dal punto di vista del malato”. È però importante non confondere il primo
aspetto con l’antropologia culturale –cioè con una descrizione delle usanze relative alla malattia– così come è importante non confondere il secondo aspetto con
l’etica medica o l’etica della relazione clinica. Piuttosto, si tratta di mettere mano
ad una “teoria della malattia come esperienza, nella quale il malato si rapporti a
se stesso” e questo compito passa, a suo avviso, attraverso un appello alla tendenza a comprendere e riflettere che è propria di ogni persona (cfr. p. 37).
Il punto di vista specifico cui si intende far spazio è comunque quello di un
tipo di riflessione antropologica che riesca ad emanciparsi dalle strettoie del
nichilismo e dello scientismo materialista e, soprattutto, che sappia accogliere
l’interrogazione filosofica sul senso e sul valore della vita umana. A sostegno
Rosa Calcaterra
RECEENSIONI
di tale prospettiva, risulta senz’altro efficace il capitolo III del volume, intitolato
“L’enigma del corpo”. Suddiviso in due sezioni, la prima dedicata all’inquadramento storico e l’altra alle discussioni teoretiche del tema della corporeità,
esso fornisce una rassegna delle diverse teorie del rapporto corpo-mente (corredata anche da utili schematizzazioni) nonché un resoconto degli aspetti
maggiormente indicativi della difficoltà di ridurre la componente fisica dell’essere umano ai meri meccanismi dei fattori materiali. A quest’ultimo riguardo, si
istituisce un proficuo intreccio di osservazioni filosofiche e storico-antropologiche, che aiutano a chiarire alcune specifiche funzioni della corporeità (ad
esempio la sua carica espressiva e comunicativa) ma anche una serie di atteggiamenti concreti dai quali traspaiono i vissuti individuali e collettivi per cui essa
acquista la sua multiforme valenza semantica.
È tuttavia soprattutto negli ultimi due capitoli del volume –il V e il VI, rispettivamente dedicati al binomio salute/malattia e al tema della morte– che si può
ritrovare il significato più intenso di quel potenziale di ‘provocazione’ che si
segnalava all’inizio di queste note. Se, infatti, il suggerimento esplicito dell’autrice di recuperare lo spessore etico della corporeità, nella sua duplice possibilità
di salute e di malattia, implica –come si è detto– un’apertura alla domanda sul
senso e il valore della vita, è certo giusto indicare –secondo il suo approccio
fenomenologico alla questione– la sofferenza e il dolore come la sorgente più
propria da cui tale domanda può e di fatto tende a nascere. Ma il problema vero
è di vedere quali risposte si possono dare a tale domanda e qui ciò che la filosofia può offrire è essenzialmente la lucida consapevolezza della propria finitudine.
Non è poco, perché è solo a partire da questa elementare verità, cui tutti apparteniamo, che si può infine parlare sensatamente di etica della sofferenza, di partecipazione e di compassione, di cura e consolazione.
Eppure, affinché il riconoscimento dell’umana finitudine non rischi –come in
realtà sovente accade– di convertirsi in sentimenti inesorabilmente negativi o in
opzioni nichilistiche più o meno devastanti –quel che più conta è forse proprio ciò
che definisce lo spirito autentico della filosofia: la sua riluttanza ad accontentarsi
di risposte definitive ovvero la sua attitudine a spostare sempre in avanti ogni singola domanda, il che significa qui interrogarsi circa il senso della morte mettendone in questione proprio la sua figura più scontata, quella di mero culmine e
attestato della nostra limitatezza. Ma allora la vera provocazione della Russo
sembra essere questa: in una atmosfera di ‘nomadismo’ culturale, teorico ed esistenziale, nonché di arroganza della ragione scientifico-tecnologica, atmosfera
che ella descrive e analizza con molteplici riferimenti, è ancora possibile aprirsi
ad una interrogazione profonda sulla nostra finitudine e sulla morte, che è poi
l’unica vera certezza di cui disponiamo e non solo, per parafrasare Heiddeger,
“la possibilità più propria” dell’essere umano? E ancor più: fino a che punto possiamo parlare di dolore e di malattia trattandoli solo ed esclusivamente come
eventi e non piuttosto anche come misteri da accogliere con tutta l’umiltà che il
riconoscimento della nostra finitezza dovrebbe dettarci? Ma è evidente che qui
la riflessione filosofica resta e non può che restare un’utile attività propedeutica.
179
ROSARIA LONGO, Figure dell’anti-hegelismo in Italia. Martinetti, Rensi, Pareyson,
Bonanno, Acireale-Roma 2004, pp. 168.
180
È tendenza comune dei libri presentarsi come più coesi, omogenei ed esaustivi di quanto in realtà essi siano. È quindi con una certa sorpresa che ci si
trova, leggendo Figure dell’anti-hegelismo in Italia. Martinetti, Rensi, Pareyson
di Rosaria Longo, presentato come una trilogia di saggi e con una comunanza
data dall’anti-hegelismo dei tre pensatori, a rilevare l’intricata ragnatela di
rimandi che si stende da un saggio all’altro, e a coltivare l’impressione che
esso sia stato concepito già “intero” nella mente dell’autrice. È la stessa introduzione ad indurre nel lettore avvertito questi pensieri. L’anti-hegelismo, infatti, vero per tutti e tre i pensatori qui presi in esame, finisce con il costituire un
insieme prudenziale, quasi l’autrice abbia voluto predisporre gli elementi di affinità, li abbia messi in rilievo, ma voglia che sia il lettore ad attivarsi per scoprire l’ordito che li lega.
Innanzi tutto viene ridotta la distanza cronologica fra i tre attraverso il taglio
particolare dato al saggio su Pareyson, imperniato sulla formazione del filosofo fino a contenere un “sotto-saggio” sul suo maestro Augusto Guzzo, e finendo con il collocarsi quindi nel periodo della piena attività di Rensi e Martinetti.
Non che la Longo, dei tre pensatori in esame, rammentandoci che «diverse sono le prospettive che ne caratterizzano i rispettivi percorsi» (p. 8), taccia
differenze ed estraneità, spesso anzi le evidenzia (si veda la messa in rilievo
dell’ammirata ma recisa critica martinettiana all’interpretazione che Rensi dà
del pensiero di Kant) ma lo fa anche, seppure con estrema discrezione, nei
confronti delle non casuali tangenze: la comune attenzione di Martinetti e
Pareyson al pensiero di Fichte come possibilità di un idealismo “altro” rispetto
a quello hegeliano, oppure la segnalazione in nota di come, proprio Martinetti,
sia stato presente tra le prime letture di Pareyson.
Ma non è su questo piano che si gioca la questione. Non è semplicemente la
confutazione di Hegel (magari con l’acrobatico e sofistico “tutto ciò che è reale è
irrazionale” di Rensi) né la sua rilettura in sede storiografica (problema che
comunque Pareyson affrontò magnificamente) a costituire l’anima di questo volume. Pareyson, Martinetti e Rensi sono prossimi non negli esiti, ma in un aspetto
più profondo, che Rosaria Longo fa emergere con una precisa strategia.
Nell’introduzione, infatti, la studiosa mostra la vicinanza tra le filosofie di
Croce e Gentile rispetto allo “schiacciamento” della storia nella contemporaneità che essi, pur separatamente, mettono in atto presentando «elementi comuni che le rendono riduttive dell’idea di storicità, così come dell’idea di realtà»
(p. 9). A fronte di questa riduzione Rensi, Martinetti e Pareyson disegnano strategie che mirano ad affrontare «il rapporto problematico tra essere e pensiero,
ragione e realtà, verità e storia, filosofia e religione» (p. 9). In costoro vi è chiara coscienza, come precisa l’autrice, che «il negativo non può essere né opposizione logica da superare, secondo una dialettica di stampo palesemente
hegeliano, […], né tanto meno errore veritativo da comprendere nella sintesi
interpretativa del presente, perché esso domina la storia e costituisce una continua minaccia per la vita» (p. 10).
RECEENSIONI
La vasta categoria dell’anti-hegelismo va precisandosi sino a far emergere
la piena consapevolezza che il problema possa essere, piuttosto, quello di illuminare con una luce pietosa lo scandalo del male e della morte. Conoscendo
l’itinerario di ricerca di Rosaria Longo credo non si sbagli collocando le radici
di questo lavoro nella seconda parte della sua precedente monografia su
Pareyson (L’abisso della libertà, F. Angeli, Milano, 2000), laddove scandagliava con attenzione i temi del tragico o del negativo. È forse la genesi pareysoniana del problema a permetterle di contestualizzare la questione: «L’identità
di pensiero ed essere si è scissa con la crisi dell’attualismo» (p. 146), senza
arrestarsi però alla sola ricostruzione storica.
L’irriducibilità del negativo al pensiero, a fronte dell’idea rensiana che vi
siano «intere filosofie costruite apposta per non far pensare gli uomini al negativo della vita» (p. 90), viene più volte sottolineata. Per Martinetti, che insisterebbe «sulla trascendenza del mondo ideale rispetto a quello storico […] e
sulla irriducibile realtà del male nel mondo» (p. 10), come per Rensi, il cui pensiero «si fa inevitabilmente dualistico, esplicitandosi come radicale “esperienza teologico-negativa del malum mundi”» (p. 11). E infine per Pareyson, secondo cui vi è un «tragico che si annida nella conoscenza ovvero la drammaticità
dell’atto interpretativo, […] nella possibilità che l’interpretazione fallisca e la
verità dilegui, lasciando il posto all’ideologia, alla menzogna, al male» (p. 13).
In tutti loro la tentazione del dualismo è presente, sebbene diversi saranno gli
esiti: per Rensi e Martinetti, «la restaurazione di un impianto dualistico» (p.
108), per Pareyson non la «coincidenza tra pensiero ed essere, ma una paradossale convergenza» (p. 147) espressa «infinitamente nelle forme storiche
senza mai ridursi ad esse» (p. 148).
La centralità del negativo e del tragico in questi autori è solida e sembrerebbe configurarsi in una dimensione che definirei quasi pre-teoretica (nel
senso in cui per Fichte era pre-teoretico decidersi tra idealismo e dogmatismo
o per Unamuno usare il corpo per produrre una filosofia che avesse un valore). È già la stessa autrice a instradarci lungo questo itinerario attraverso un
passo dei rensiani Lineamenti di filosofia scettica in cui si collegano le posizioni filosofiche “al temperamento del pensatore”. Ed è nella categoria del preteoretico che mi sembra si possa inserire l’attenzione per gli aspetti biografici,
posti sotto l’occhio del lettore con un taglio mirato e non certo aneddotico. Più
volte viene posto in evidenza il carattere di contrapposizione frontale, di inflessibilità, tipica della figura di Martinetti. Di Rensi, la Longo sottolinea con delicata attenzione le oscillazioni, i mutamenti, direi quasi le convulsioni di chi non
trova pace in alcuna parziale posizione e non crede a sufficienza nella ragione
da poter pensare che possa esisterne una imparziale.
Le sofferenze di Giuseppe Rensi (la sua speculazione è, non a caso,
definita tragica dall’autrice) nei confronti dei temi del male, del dolore, del
negativo, della storia che lo strazia con la sua contraddittorietà si rispecchiano nella messa in evidenza della radice dello scandalo, della tensione
tra spirito e mondo che spinge a quello gnosticismo solitario, splendidamente anacronistico, cui indulge Martinetti, e nelle accorate ricerche sull’essenza del male dell’ultimo Luigi Pareyson.
181
Qui, nella capacità di non espellere il negativo, di non risolverlo, ma di “sopportarlo” all’interno delle proprie decennali riflessioni, sta il segno della profonda vocazione teoretica dei tre pensatori, ed anche, se è vero quello che ci
ricorda Figure dell’anti-hegelismo, cioè l’idea rensiana «che la grandezza spirituale di un uomo si possa ben valutare con la quantità di assurdo che questi
riesce a sopportare» (p. 103), la loro grandezza umana.
Davide Miccione
E. DE MARTINO, Vita di Gennaro Esposito napoletano. Appunti per una biografia di Ernesto De Martino, a c. di L. Chiriatti, Kurumuny, Calimera 2004, pp. 52.
182
Le Edizioni Kurumuny, curate con coriacea passione dal sempre attento
Luigi Chiriatti, hanno pubblicato un percorso nelle parole più intime di Ernesto
De Martino, assaporate dalla viva voce della compagna Vittoria De Palma, che
con lui condusse numerose ricerche, accompagnandolo sempre nei suoi viaggi-studio nel Sud amaro di un’Italia che poneva le basi per il boom economico
degli anni ’60, ma che conservava in alcuni luoghi –anche mentali– caratteri
ancora arcaici e poco indagati.
“Vittoria ci racconta, come se niente fosse, che Ernesto aveva già cominciato a scrivere la sua biografia e le aveva dato anche un titolo: ‘Gennaro
Esposito’. Ci consegna un indice di argomenti: Coscia e bancarella e merda e
cane; L’ingegnere di Porta Nuova; La controra; Il miracolo di San Gennaro”. In
Vita di Gennaro Esposito napoletano, De Martino racconta la notte della propria nascita, i riti antecedenti il travaglio e gli auspici, mentre in strada (Via Fonseca) rumoreggiava la napoletanità fragorosa di una processione che chiedeva indumenti per i terremotati di Calabria e Sicilia. E leggendo questo racconto si compie il miracolo della scrittura: alzando lo sguardo dalla pagina, ci si
sprofonda in quel presepe suburbano, si cammina con gli occhi nel travaglio di
una quasi-madre che dona “le cose” ad altre madri o a donne sopravvissute ai
propri figli dopo il tremore della terra. Il ricordare, il dire di Vittoria su Ernesto
non è mai al passato; mai scomparso o perso nella memoria. Dai suoi racconti traspare un amore, un ideale, che non sono mai venuti meno sia nei confronti di Ernesto, sia per i tanti soggetti e luoghi “indagati” e visti insieme.
Lo stesso De Martino lamentava che di lui fossero stati scandagliati gli
aspetti politici, etnologici, intellettuali, ma non la sua dimensione umana, fatta
di paure, amori, ansie, delusioni, rabbia, gioie, lotte, passioni. Un lamento interiore che si fa parola negli occhi e nella bocca di Vittoria. E nello scorrere delle
parole, Ernesto De Martino affiora per davvero dalle pagine di una quasi biografia che lo rende vivo ancora, in tutta la propria umanità e nell’impegno
costante, concretizzati in un’esistenza dedicata ai lati “minimi” della società,
alle genti umili e umiliate. Al riscatto del Sud.
Il racconto di una vita, sciolto all’inseguimento dei ricordi di Vittoria De
Palma, è tenero e duro. Di quella durezza autentica che il Sud soltanto sa cucire alla pelle di chi ne incontra i colori e i dolori. Colpisce un passo d’intenso
Alessandro Errico
RECEENSIONI
amore postumo fra i due: “lei, anticonvenzionalista per eccellenza, tanto che
per amore di Ernesto aveva abbandonato gli agi e i valori etici e sicuri di una
classe benestante e borghese, davanti alla perdita della persona amata e al
dolore della morte, si veste dei colori tradizionali del lutto e tradizionalmente li
porta per anni e per moltissimo tempo si rifiuta di raccontare di Ernesto e del
loro rapporto”. Ogni episodio è poesia visiva, amara e tenue vita vissuta da
guardare a fior di labbra.
Il rapporto di De Martino con la religione è fatto di rispetto e ricerca sul filo
del dubbio: “Attraverso la religione l’uomo cerca un compenso alla sua debolezza. Non ho difficoltà a riconoscere che la religione cattolica risponde storicamente nel modo migliore alla situazione psicologica di chi si sente miserevole e fragile in un mondo che lo schiaccia col suo mistero e la sua estraneità.
La religione cattolica dà una risposta al dolore degli oppressi e offre un lenimento all’anima affranta e al mondo che non va. Essa spiega che l’uomo è una
creatura di caduta che invano potrebbe con le sole sue forze vincere la propria
condizione di limitazione e di miseria. Essa insegna che attraverso il sacrificio
del dio uomo è stata inserita nella storia una promessa di redenzione e di salvezza, promessa che si attua attraverso la chiesa depositaria legittima degli
strumenti di salvezza. Io non posso quindi darti torto, piccola mia, se credi fermamente nella religione cattolica […]. Io ti comprendo, mia cara, e non verrà
mai da me il consiglio di rinnegare il tuo dio, di abbandonare la tua religione.
[…] Ma non credere che io faccia professione di ateismo, e che con leggerezza voglia distruggere ciò che nella società presente con le sue ingiustizie e i
suoi dolori è inevitabile, cioè la consolazione, della preghiera fatta al padre, e
anche io, in dati momenti, come figlio di questa società, come figlio del dolore
e dell’oppressione dico a dio la mia preghiera”.
In un’altra, struggente, lettera di Ernesto a Vittoria affiora l’ardore e l’ardire
della leggerezza che solo l’innamorato con la penna intinta nell’inchiostro dell’Amore totale può scrivere. Bastano quelle parole a comporre un ricordo dell’uomo Ernesto De Martino, testimone del passato di un Sud ancorato a se
stesso. Un uomo di straripante umanità. E l’unico limite e peccato del libro è il
tempo. Tempo che accarezza i pensieri mentre si legge. Tempo che è durato
troppo poco quando si rigira l’ultima pagina.
183
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA «SEGNI E COMPRENSIONE»
Volumi:
184
F. AFFERGAN, S. BORUTTI, C. CALAME, U. FABIETTI, M. KILANI, F. REMOTTI, Figure dell’umano. Le rappresentazioni dell’antropologia, Meltemi, Roma 2005, pp. 426.
T. ANDINA, Il problema della percezione nella filosofia di Nietzsche, prefazione di M. Ferraris, Abo Versorio, Milano 2005, pp. 419.
N. BADALONI, Laici credenti all’alba del moderno. La linea Herbert-Vico, Le Monnier,
Firenze 2005, pp. 196.
C. BARBERO, Madame Bovary: something like a melody, Albo Versorio, Milano 2005, pp.
124.
M.L. BIANCHI, Commento alla “Critica della facoltà di giudizio” di Kant, Le Monnier, Firenze 2005, pp. 260.
V. CAMERINO, Nelle utopie del Sud e del Cinema. La vita, le passioni, le speranze, Icaro,
Lecce 2005, pp. 246.
Ch. FOURIER, Il nuovo mondo industriale e societario, introd. di L. Tundo Ferente, trad.
M.A. Sarti, RCS, Milano 2005, pp. 444.
B. LATOUR, Il culto moderno dei fatticci, trad. e c. di C. Pacciolla, Meltemi, Roma 2005,
pp. 120.
S. MASCHIETTI, L’interpretazione heideggeriana di Kant sulla disarmonia di verità e differenza, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 240.
S. SALVATORE, Visioni di università. Indagine sulle culture di ruolo di docenti e ricercatori, Carlo Amore, Roma 2005, pp. 18.
Periodici:
Acta philosophica, f. I, n. 14, 2005; Pontificia Università della Santa Croce, Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali, Pisa-Roma.
Aesthetica Preprint, n. 73, aprile 2005: T. ANDINA, Percezione e rappresentazione. Alcune ipotesi di Gombrich e Arnheim C.I.S.d.E., Palermo.
Annuario filosofico, n. 19, 2003; Musia, Milno.
Foedus, n. 10, III quadrimestre 2004; Associazione Artigiana e Piccole Imprese, Mestre.
L’immaginazione, n. 211, 2005; n. 212, 2005; Manni, San Cesario di Lecce.
Notes et documents, n. 1, janvier-avril 2005; Institut International Jacques Maritain,
Roma.