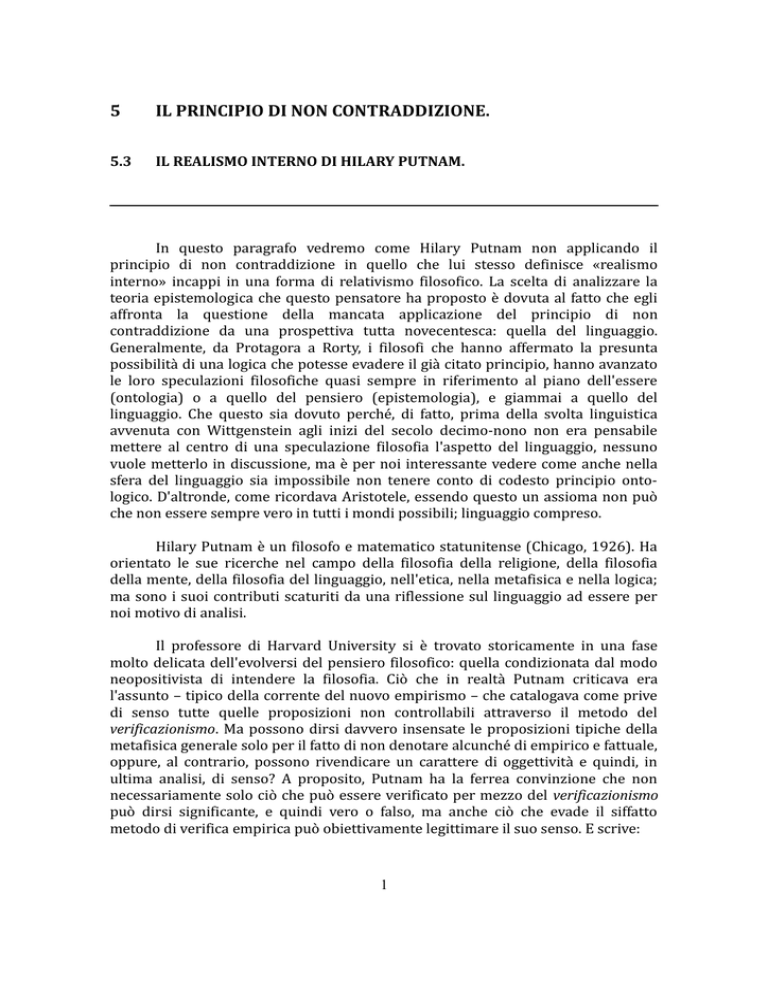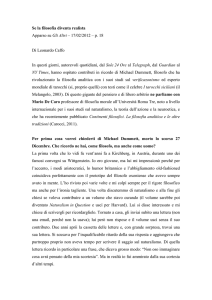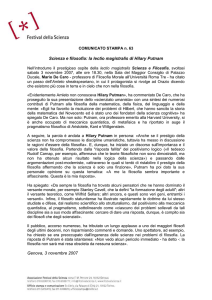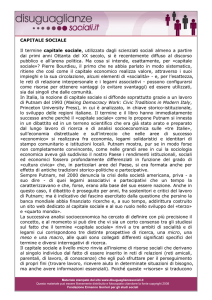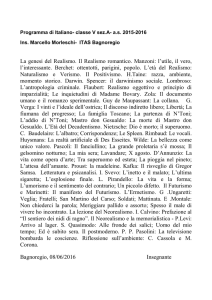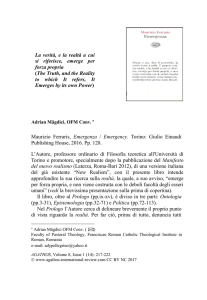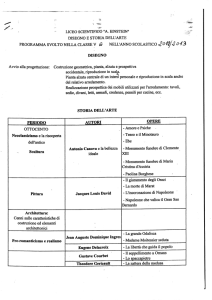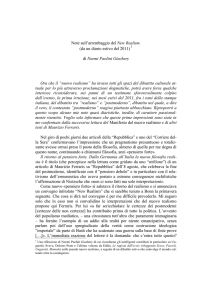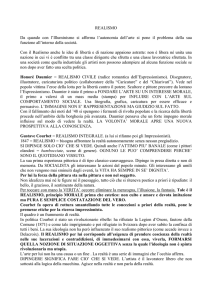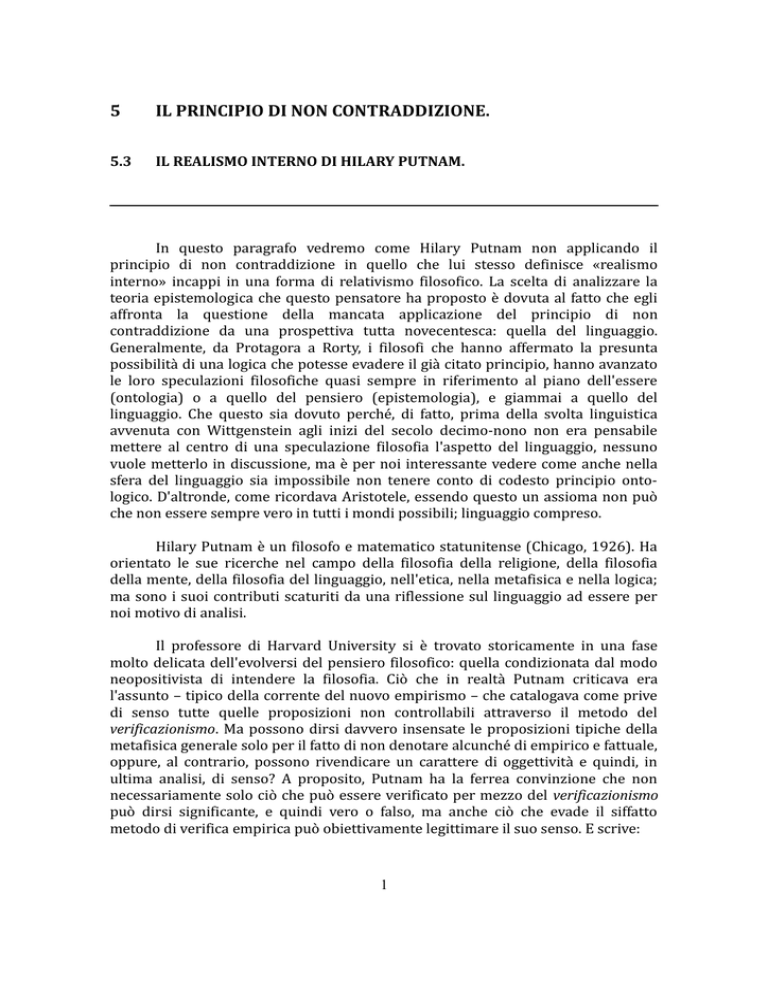
5
IL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.
5.3
IL REALISMO INTERNO DI HILARY PUTNAM.
In questo paragrafo vedremo come Hilary Putnam non applicando il
principio di non contraddizione in quello che lui stesso definisce «realismo
interno» incappi in una forma di relativismo filosofico. La scelta di analizzare la
teoria epistemologica che questo pensatore ha proposto è dovuta al fatto che egli
affronta la questione della mancata applicazione del principio di non
contraddizione da una prospettiva tutta novecentesca: quella del linguaggio.
Generalmente, da Protagora a Rorty, i filosofi che hanno affermato la presunta
possibilità di una logica che potesse evadere il già citato principio, hanno avanzato
le loro speculazioni filosofiche quasi sempre in riferimento al piano dell'essere
(ontologia) o a quello del pensiero (epistemologia), e giammai a quello del
linguaggio. Che questo sia dovuto perché, di fatto, prima della svolta linguistica
avvenuta con Wittgenstein agli inizi del secolo decimo-nono non era pensabile
mettere al centro di una speculazione filosofia l'aspetto del linguaggio, nessuno
vuole metterlo in discussione, ma è per noi interessante vedere come anche nella
sfera del linguaggio sia impossibile non tenere conto di codesto principio ontologico. D'altronde, come ricordava Aristotele, essendo questo un assioma non può
che non essere sempre vero in tutti i mondi possibili; linguaggio compreso.
Hilary Putnam è un filosofo e matematico statunitense (Chicago, 1926). Ha
orientato le sue ricerche nel campo della filosofia della religione, della filosofia
della mente, della filosofia del linguaggio, nell'etica, nella metafisica e nella logica;
ma sono i suoi contributi scaturiti da una riflessione sul linguaggio ad essere per
noi motivo di analisi.
Il professore di Harvard University si è trovato storicamente in una fase
molto delicata dell'evolversi del pensiero filosofico: quella condizionata dal modo
neopositivista di intendere la filosofia. Ciò che in realtà Putnam criticava era
l'assunto – tipico della corrente del nuovo empirismo – che catalogava come prive
di senso tutte quelle proposizioni non controllabili attraverso il metodo del
verificazionismo. Ma possono dirsi davvero insensate le proposizioni tipiche della
metafisica generale solo per il fatto di non denotare alcunché di empirico e fattuale,
oppure, al contrario, possono rivendicare un carattere di oggettività e quindi, in
ultima analisi, di senso? A proposito, Putnam ha la ferrea convinzione che non
necessariamente solo ciò che può essere verificato per mezzo del verificazionismo
può dirsi significante, e quindi vero o falso, ma anche ciò che evade il siffatto
metodo di verifica empirica può obiettivamente legittimare il suo senso. E scrive:
1
«La critica che il verificazionismo è sbagliato in sé non ha bisogno di grandi discussioni.
Semplicemente, non è vero che, in qualsiasi senso abituale del termine “significato”, solo le
espressioni linguistiche per le quali esiste un metodo di verificazione sono significanti» 1.
La forte critica mossa nei confronti della forma mentis tipicamente
neopositivista di inizio '900 fa – almeno all'apparenza – sembrare che Putnam
tenda verso il realismo filosofico. Il voler dare un senso alle proposizioni della
metafisica generale suppone l'aver precedentemente accettato quell'idea che
asserisce l'esistenza di una realtà ontologicamente ed indipendentemente intesa e
che, di conseguenza, in un modo o nell'altro possa di fatto essere conosciuta.
Putnam dice testualmente che «le cose “esterne” in generale possono essere
esperite»2, e questa è decisamente una critica non solo al neopositivismo ma anche
al trascendentalismo kantiano e a tutte quelle epistemologie ti matrice empiricorappresentazionista.
Altra confutazione che il Professore di Harvard muove nei confronti del
neopositivismo è rintracciabile nella critica della teoria dell'isomorfismo logico.
Riprendendo il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche e della teoria dei giochi di
lingua è possibile notare come l'idea di un linguaggio duttile, dove i termini
linguistici possono assumere una pluralità di significati, fosse presente anche nel
pensiero del filosofo di Chicago. Questa presa di distanza sulla concezione del
linguaggio va a segnare ancor più prepotentemente il netto contrasto che si
interpone con il movimento del nuovo empirismo. Invero, la tesi impugnata dagli
estimatori di questo modo di intendere la filosofia circa la condizione statica e
cristallina del linguaggio – dove ad ogni termine linguistico doveva
necessariamente corrispondeva un unico e ben determinato significato – è
scardinata nel profondo da Putnam, il quale, al contrario, sostiene che i termini
linguistici possono assumere innumerevoli significati, per l'esattezza tutti i
significati che il parlante intende attribuirgli. Seguendo il pensiero del secondo
Wittgenstein, Putnam sostiene che non esiste un unico modo per descrivere la
realtà e che, allo stesso modo, non esiste un unico linguaggio vero e significante per
esprimere i fatti del mondo. Essendo il significato condizionato dall'uso, emerge
con tutta franchezza che il significato che viene attribuito ad un oggetto è sempre
definito sulla base dell'uso che se ne fa dell'oggetto stesso.
Ciò significa che è l'uso a condizionare il significato di un oggetto, ed
essendo l'uso a sua volta determinato dalla volontà e dalla capacità dell'agente
epistemico che ha nell'attribuire significati, è chiaro che in ultima analisi è il
parlante a rendere sensato o privo di senso un determinato termine linguistico od
una più complessa e articolata proposizione. Cercando di scavare ancora più in
profondità sarebbe opportuno domandarci cosa condiziona il parlante nel
momento in cui attribuisce significati – o detto in maniera diversa, che cosa è che
1 Hilary PUTNAM, Mind, Language and Reality, Cambridge University Press, Cambridge
(Massachussets), 1975; trad. it.: Mente, linguaggio e realtà, Adelphi, Milano, 1987, 474.
2 Hilary PUTNAM, The Threefold Cord: Mind, Body and World, Columbia University Press, New
York, 1999; trad. it.: Mente, corpo, mondo, Il Mulino, Bologna, 2003, 39.
2
determina l'uso –, e a questo punto Putnam da un'ulteriore risposta. Sicché, il fatto
che un dato oggetto possa assumere significati differenti, è dovuto al fatto che può
essere esperito in contesti differenti, dove anche la più piccola delle differenza può
causare un enorme slittamento semantico del significato dell'oggetto esperito.
Scrive Putnam:
«Il significato è interattivo e l'ambiente gioca un ruolo nel determinare a che cosa si
riferiscono le parole di un parlante o di una comunità» 3.
Non andremo ulteriormente ad analizzare questa questione per un duplice
motivo: il primo perché tutto sembra indirizzarsi direttamente verso il campo della
psicologia; il secondo perché non esplicitamente utile ai fine dell'opera. La cosa
importante da sapere per noi infatti non è ciò che condiziona l'agente epistemico
nell'assegnare un significato piuttosto che un altro ad un determinato termine
linguistico, bensì è avere cognizione che, di fatto, con siffatta teoria del significato si
re-introduce nell'atto cognitivo il fattore dell'intenzionalità.
L'analogia con la filosofia del “secondo” Wittgenstein si riflette nelle molte
tesi promosse da Putnam circa il ruolo che la pragmatica viene ad assumere nella
determinazione del significato. Ma prima di addentrarci nel cuore della teoria della
conoscenza esposta dal Professore di Harvard è bene fare un'ulteriore ex-cursus al
fine di avere coscienza del percorso intellettuale intrapreso da questo pensatore.
Così, la domanda che dobbiamo porci è come il neopragmatista americano,
avviando le sue speculazioni filosofiche dall'interno della filosofia del linguaggio,
sia riuscito a riagganciarsi alla metafisica generale. La soluzione, che è
rintracciabile in alcune pagine del testo The Threefold Cord: Mind, Body and World,
è riconducibile alla correlazione che sussiste tra linguaggio e realtà. Scrive Putnam:
«Perché ho detto che tutto questo ha molto a che fare con la questione del realismo in
filosofia del linguaggio? […] Come possiamo anche solo percepire cose esterne al nostro
corpo? […] Come possiamo anche solo riferirci a cose esterne al nostro corpo?» 4.
Fino al 1981, anno in cui pubblicò Ragione, verità e storia, Putnam era certo
che le suddette domande sfociassero in una duplice risposta: o l'uso del linguaggio
fissa già le interpretazioni delle nostre parole o nulla può farlo 5. Prima di tale data
non a caso Puntman sposava l'idea del funzionalismo, ma resosi conto dell'assenza
di una risoluzione esaustiva a questo dicotomico e paradigmatico quesito 6, pensò
bene di abbandonare una simile concezione indirizzandosi piuttosto verso quello
che sarà da li a poco definito “realismo interno”.
3 Hilary PUTNAM, Representation and Reality, Mit Press, Cambridge (Massachussets), 1988; trad.
it.: Rappresentazione e realtà, Garzanti, Milano, 1991, 60.
4 Hilary PUTNAM, Mente, corpo e mondo, cit., 33.
5 Ibidem.
6 «Un mondo che interpreta per noi le nostre parole, un mondo in cui vi sono, per così dire «raggi
noetici» che si propagano dall'esterno fin dentro le nostre teste è un mondo magico, un mondo
di fantasia. Non riuscivo a capire come tale fantasia potesse avere senso, ma a quel punto non
riuscivo neppure a capire come, senza di essa, fosse possibile il riferimento». Ibidem.
3
Non convenendo nell'assunto di una interfaccia tra soggetto e mondo 7 per
tutte le motivazioni fatte presenti nella precedente nota in calce, ma non
convenendo oltremodo in un accesso diretto all'ente di conoscenza così come
invece sostiene il realismo della tradizione, il filosofo di Chicago prova ad elaborare
una teoria della conoscenza che si presenti come il giusto compromesso tra questi
due estremi. Egli sostiene infatti che né una epistemologia di matrice realista, né
una anti-realista, possa essere la soluzione che slega il nodo di questa matassa.
Scrive:
«Molti filosofi oggigiorno si trovano perfettamente a loro agio o con una concezione
realista dogmatica o con una altrettanto dogmatica concezione anti-realista. Da parte mia,
sono del parere che il progresso in quest'area di problemi sarà possibile solo se ci si
renderà conto che entrambe le concezioni sono ugualmente insoddisfacenti, che ciascuna
di esse è fatta ad immagine speculare dell'altra e dipende dall'idea che l'altra sia l'unica
alternativa»8.
Ciò che cerca di ristabilire il professore di Harvard è il carattere intenzionale
che spetta di diritto all'atto cognitivo. Giustamente sostiene che ammettere
un'interfaccia tra mondo e soggetto in un certo qual modo annulla ogni possibile
trascendenza dell'oggetto (intenzionale) di conoscenza e, secondariamente, il
carattere intenzionale dell'atto cognitivo. Per questo ha la ferrea convinzione che
non è possibile in alcun modo identificare il mentale con il fisico, lo spirito con il
cervello, poiché una simile con-fusione eliminerebbe l'approccio intenzionale della
conoscenza e ridurrebbe quest'ultima alla pura relazione – tipica della fisica
meccanica – di causa-effetto. Scrive:
«I materialisti hanno ragione ad insistere sulla nostra ragione incarnata; hanno ragione ad
insistere che il legame tra mente e corpo è troppo stretto perché si possa parlare di spiriti
disincarnati […] ma si sbagliano quando il loro scientismo li porta a sostenere che
possiamo concepire l'avere una mente come qualcosa che agisce nel e per il tramite del
nostro corpo solo se possiamo ridurre i termini del linguaggio psicologico ordinario ai
termini della chimica, fisica, neurologia, informatica, ecc.» 9.
7 «L'assunzione chiave responsabile del disastro è l'idea che debba esistere un'interfaccia tra le
nostre capacità cognitive e il mondo esterno – o, per dirla in modo diverso, l'idea che le nostre
capacità cognitive non possano raggiungere direttamente gli oggetti stessi. […] Anche nelle
scienze cognitive attuali, ad esempio, va di moda ipotizzare l'esistenza di «rappresentazioni» nel
computer celebrale. Se si assume che la mente sia un organo e se si identifica poi la mente con il
cervello, non si potrà fare a meno di (1) considerare alcune delle «rappresentazioni» analoghe
alle «impressioni» del teorico classico (il computer celebrale, o mente, compie inferenze da
alcune «rappresentazioni», gli output dei processi percettivi, allo stesso modo in cui, nella
concezione classica, la mente compie inferenze dalle impressioni) e (2) ritenere che queste
«rappresentazioni» siano connesse agli oggetti dell'ambiente dell'organismo solo causalmente e
non cognitivamente (proprio come le impressioni erano connesse agli «oggetti esterni» solo
causalmente e non cognitivamente)». Ivi, 22-23.
8 Ivi, 28.
9 Ivi, 228.
4
Il punto è che sebbene Putnam critichi aspramente ogni forma di teoria
della conoscenza di questo tipo, la soluzione da lui proposta del “realismo interno”
può dirsi, concretamente, una teoria della conoscenza consistente? Se il “realismo
interno” nasce come il – diciamo noi – maldestro tentativo di conciliare realismo e
anti-realismo, come può solo pensare di non incappare nel relativismo filosofico?
La sua cognizione del processo cognitivo come essenzialmente intenzionale, e
quindi il distacco dalle spiegazioni fisicaliste dell'atto cognitivo, risale al 1981 con
la stesura del testo Ragione, verità e storia, ma solo nel 1994 trova una stretta
analogia e correlazione col realismo Aristotelico, pur non condividendone
quell'oggettività assoluta (God's eye view) dalla quale quest'ultimo non poteva, e
non può, prescindere.
«In verità avrei potuto intitolare queste lezioni «Il realismo aristotelico senza la metafisica
aristotelica». Ma le avrei potute intitolare anche «Il realismo deweiano». Dewey, infatti, per
come lo leggo io, voleva mostrare che possiamo conservare qualcosa dello spirito della
difesa di Aristotele del mondo del senso comune, contro gli eccessi sia dei metafisici che
dei sofisti, senza tuttavia abbracciare una qualche variante dell'essenzialismo propugnato
da Aristotele. Sono convinto che il proposito che mi prefigge in queste lezioni – ossia la
ricerca di una via intermedia tra la metafisica reazionaria e il relativismo irresponsabile –
abbia impegnato anche Dewey nel corso della sua esemplare carriera filosofica» 10.
In questa nota Putnam cita un'importante figura filosofica – conosciuta
sopratutto nel mondo anglofono per i suoi contributi nel campo della pedagogia –
da cui, per certi versi, riprende degli aspetti essenziali per la costituzione della
teoria del “realismo interno”. Come Dewey, il neopragmatista di Chicago sostiene
che seppur il mondo – inteso come la totalità di tutto ciò che è – non sia il prodotto
delle nostri menti, non si deve alludere a nessuna “fantasia metafisica” che porta a
credere che vi è una totalità di forme, di essenze, di universali, fissata una volta per
tutte. Questa, che è la critica che Putnam fa alla filosofia prima aristotelica, è il
primo passo che conduce il professore di Harvard University al rigetto del principio
di non contraddizione e, infine, al relativismo filosofico.
Tale asserzione – che è la confutazione dell'aspetto metafisico del realismo
aristotelico – è avanzata sul fatto che, secondo Putnam, non si da una volta per
tutte e in modo esaustivo la Verità dell'oggetto di conoscenza, ma al contrario è
possibile descrivere l'oggetto in esame in innumerevoli modi possibili e che,
nonostante tutto, le possibili descrizioni avanzate possono risultare tutte vere allo
stesso tempo. Ciò che egli precisa è che la verità non è qualcosa di oggettivo con la
“O” maiuscola, ossia indipendente dal soggetto, quanto piuttosto è oggettiva con la
“o” minuscola dato che questa è sempre ricavata dall'interno di uno schema
concettuale11. Ciò che sostiene il filosofo americano è che la realtà tutta, o se
10 Ivi, 13-14.
11 Asserire che la verità è logicamente indipendente da ogni schema rappresentazionale della
realtà o che, al contrario, essa è ciò che la maggioranza delle persone crede come vero (a
prescindere se ciò è stabilito su criteri empirici, psichici, mentali ecc) è pur sempre
un'affermazione elaborata dall'interno di un dato schema concettuale. Per questo Putnam
5
vogliamo il mondo nella sua complessa struttura, giacché esperita sempre in
contesti ben determinati e irriducibili a sé stessi, mostrandosi ogniqualvolta in
modo originale ed esclusivo, nel suo essere conosciuta mai può prescindere
dall'aspetto soggettivo dell'agente epistemico. In questo modo può essere
preservato sia il lato oggettivo (la realtà) che quello soggettivo (il modo di
rappresentare la realtà, ovvero il pensiero prima ed il linguaggio poi) risolvendo
apparentemente il binomio dicotomico che portò a parlare dei dualismi della
portata realismo/anti-realismo, io/mondo, soggetto/oggetto, ecc..
Per Putnam è la struttura della mente insieme alla struttura delle cose a
costruire la verità. A sottolineare questa rilevante questione il filosofo
neopragmatista statunitense dichiara esplicitamente che:
«Ci sono “fatti esterni”, e noi possiamo dire come sono. Ciò che non possiamo dire, perché
non ha senso, è quello che i fatti sono indipendentemente da ogni schema concettuale»12.
Se applicassimo la teoria del «significato è l'uso» alla nozione di «verità»
ben comprendiamo che la definizione stessa di «verità» non può essere fissata una
volta per tutte. Questa apertura ad un relativismo concettuale appare come un
deciso allontanamento dal realismo della tradizione che al contrario, non
ammettendo alcuna interpretazione per quelle nozioni assiomatiche sulle quali il
suddetto movimento di pensiero viene a forgiarsi, ribadisce a gran voce la
necessità di un'unica definizione. Con ciò il professore di Harvard conclude che mai
si può parlare di una visione oggettiva (intesa sotto una forte pregnanza
ontologica) della realtà poiché sarebbe il frutto di un dogmatismo metafisico che,
nello specifico, egli definisce come il punto di vista dell'«Occhio di Dio».
«Se la verità non è una corrispondenza univoca, si presenta allora la possibilità di un certo
pluralismo. Ma il fine del realista metafisico è quello di salvare la nozione del punto di vista
dell'Occhio di Dio, ossia l'unica teoria vera»13.
Sembra di capire che ciò che è sostenuto da Putnam è qualcosa di assai più
vicino ad un'oggettività-per-noi piuttosto che ad un'oggettività in senso forte.
Invero, non condividendo con il realismo della tradizione (quello con la «R»
maiuscola per intenderci) l'esistenza di una realtà ontologicamente extrasoggettiva con una propria e ben determinata quidditas, non può che non rigettare
l'altro punto cardine che caratterizza tutta la scolastica quale è la teoria della verità
come «adaequatio». Così facendo non solo finisce per promuovere l'ennesima
epistemologia relativista, ma va a contraddire anche quei principi assiomatici – uno
fra tutti il principio di non contraddizione – che Aristotele classificò come
apodittici ed incontrovertibili. Avere cognizione della nozione di verità sempre ed
ribadisce che la verità deve essere concepita sempre come una oggettività-per-noi.
12 Hilary PUTNAM, The Many Faces of Realism, Open Court, La Salle (Illinois), 1987; trad. it., La
sfida del realismo, Garzanti, Milano, 1991, 47.
13 Hilary PUTNAM, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, Cambridge
(Massachussets), 1981; trad. it.: Ragione, verità e storia, Il Saggiatore, Milano, 1985, 82.
6
imprescindibilmente dal punto di vista del soggetto (la verità è già postulata
all'interno dello schema concettuale di riferimento) fa sì che il significato di
codesta è sempre dipendente dall'uso che l'agente epistemico ne vuole fare. Tale
considerazione è una pregnante discrepanza nei confronti di quella concezione che
fa della verità un trascendentale (nel senso tommasiano del termine) dell'oggetto
di conoscenza. In ultima analisi è questa l'abissale differenza che si viene ad
installare tra realismo “classico” ed “interno”; sicché, per quest'ultimo, a differenza
del primo, la verità non trascende mai e per nessun modo l'«uso». Ecco l'apertura
al relativismo filosofico.
Asserendo che la verità non trascende i fenomeni ma che è l'uso che si fa dei
fenomeni stessi, il professore di Harvard fa emergere il suo dissenso dalla
metafisica classica. Se per la filosofia scolastica la nozione di verità non era
riducibile in alcun modo al soggetto di conoscenza – seppur si riconosceva un ruolo
attivo di codesto all'interno del processo cognitivo – per Putnam le cose non stanno
propriamente così. L'aspetto copernicano della filosofia putnamiana ha fatto sì che
la verità dipendesse in tutto e per tutto dall'agente epistemico. Proferendo infatti
che è il soggetto che esperisce gli oggetti di conoscenza ad attribuire loro il proprio
significato in base all'uso che ne intende fare, significa ammettere indirettamente
l'egemonia dell'agente epistemico e riconoscere a lui e solo a lui la capacità di
misurare l'essere-vero o l'essere-falso dell'oggetto di studio.
Questa considerazione ha portato il neopragmatista americano a
considerare l'oggetto di conoscenza sempre in rifermento al suo significato, che a
sua volta ha senso esclusivamente all'interno dello schema concettuale dove è stato
elaborato. Similmente, quindi, al “fatto” di Wittgenstein, anche per Putnam non è
possibile dare un significato oggettivo e trascendente lo schema concettuale (o
gioco linguistico) di riferimento. Ma eliminando la possibilità di un significato «per
sé» dell'oggetto di conoscenza, eliminandone una valenza ontologica forte, sorge
spontanea la domanda circa il fondamento che da consistenza allo stesso schema
concettuale e, di riflesso, alla relativa nozione di verità. Se si elimina la possibilità
da parte di un “qualcosa” di essere indipendentemente ed ontologicamente inteso,
come è possibile trovare quel fondamento ontologico prima, ed epistemologico poi,
che da consistenza a tutti i significati – pur sempre innumerevoli – di ciò che è
esperito?
Ogni oggetto di conoscenza, in base al suo modo di essere esperito, può di
fatto assumere molteplici significati, ma è fondamentale riconoscere che ci deve
essere necessariamente un significato – per utilizzare il linguaggio di Putnam – che
è fondamento di tutte le sue interpretazioni possibili. Negare un simile fondamento
vuol dire inesorabilmente aprire le porte al relativismo filosofico in quanto si va a
negare il principio della non contraddizione.
Analogamente al “realismo interno” anche il realismo della tradizione
sosteneva che dello stesso oggetto di studio si possono fare diverse esperienze (e
7
ciò è dovuto all'irriducibilità dei contesti mediante i quali viene esperita la realtà),
ma di controparte, a differenza di quest'ultimo, la teoria promossa dal filosofo di
Chicago sostiene che si possono fare anche esperienze contraddittorie del
medesimo oggetto, causa la mancata e obiettiva referenza di un significato per sé
inteso come fondamento della pura oggettività. Così, se il realismo con la “R”
maiuscola ammette per i motivi appena menzionati un autentico pluralismo, il
realismo con la “r” minuscola cade in uno sterile relativismo, in quanto, appunto,
ammettendo il contraddittorio come condizione di possibilità, ammette
trasversalmente che l'oggetto di studio è esso stesso paradossalmente
contraddittorio. Difatti, a prescindere dallo schema concettuale di riferimento, se
d'innanzi lo stesso oggetto preso ad esame un soggetto ha le capacità di esperirlo
come «A» ed un altro come «¬A», significa che l'oggetto di esperienza ha cessato di
essere come tale divenendo altro da sé.
Ci tengo a precisare che non è importante se ciò avviene all'interno di uno
schema concettuale o meno perché, in entrambi i casi, non è pensabile
un'esperienza contraddittoria dello stesso ente. Se ciò avvenisse all'interno dello
stesso schema concettuale mi domando come fosse, de facto, possibile avere dallo
stesso «punto di vista» esperienze contraddittorie dell'oggetto esperito; ma allo
stesso modo mi domando come fosse possibile la stessa cosa in contesti differenti
(riferendoci sempre allo stesso oggetto). Se due o più soggetti si trovassero nello
stesso punto di vista infatti non sarebbe possibile avere dello stesso oggetto
nemmeno un'esperienza contraria (tutti i soggetti esperirebbero l'oggetto come
«A»), se invece più soggetti si trovassero in contesti – chiamiamoli anche punti di
vista o schemi concettuali – diversi, è possibile che dello stesso oggetto abbiano
esperienze contrarie (c'è chi può vederlo come «A», chi come «B», chi come «C»,
ecc.,). Ma in tutti questi casi, riferendoci allo stesso oggetto, non è realmente
possibile che qualcuno ne faccia un'esperienza contraddittoria («¬A»). Così,
quando Putnam parla della reciproca sussistenza che si viene ad intessere tra
realismo ed anti-realismo viene da pensare che si riferisca a due cose
ontologicamente diverse, esprimendo un'aberrante assurdità.
Avere dello stesso oggetto una cognizione contraddittoria sta a significare
che l'oggetto stesso è contraddittorio; ma abbiamo visto nel paragrafo dedicato a
Parmenide ed a Aristotele che questo è palesemente impossibile 14. Ecco, dunque, la
mancata applicazione del principio di non contraddizione nel “realismo interno”:
14 Tengo a precisare che il problema di cui ci stiamo occupando non è quello circa la
possibilità/impossibilità d'essere o non essere di una determinata cosa in quanto al nome, bensì
in quanto alla cosa stessa. Per ulteriori informazioni circa la differenza tra il nome delle cose e la
loro essenza per quel che concerne la loro contraddittorietà, rimando a: ARISTOTELE, Metafisica,
IV, 4, 1006b, 20-30. Invero, non è importante che, consapevolmente o inconsapevolmente, due
soggetti definiscano terminologicamente il medesimo oggetto di conoscenza in modo
contraddittorio, giacché l'eventuale contraddittorietà presente nel piano linguistico non va a
ledere la contraddittorietà del piano ontologico. Sono le caratteristiche essenziali a non poter
essere per alcun motivo contraddittorie, non i nomi che di volta in volta vengono “etichettati”
nella definizione dell'oggetto di conoscenza.
8
questione che ha fatto siffatta (e presunta) teoria della conoscenza decisamente
paradigmatica, inconsistente e relativista.
Alessandro Belli
9