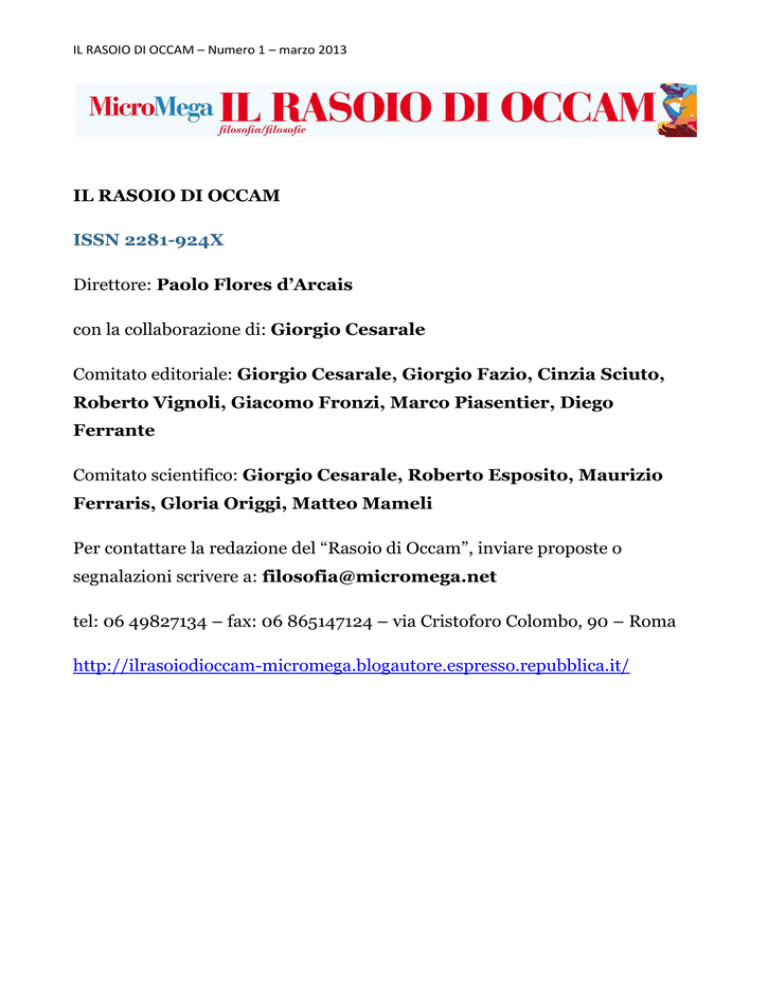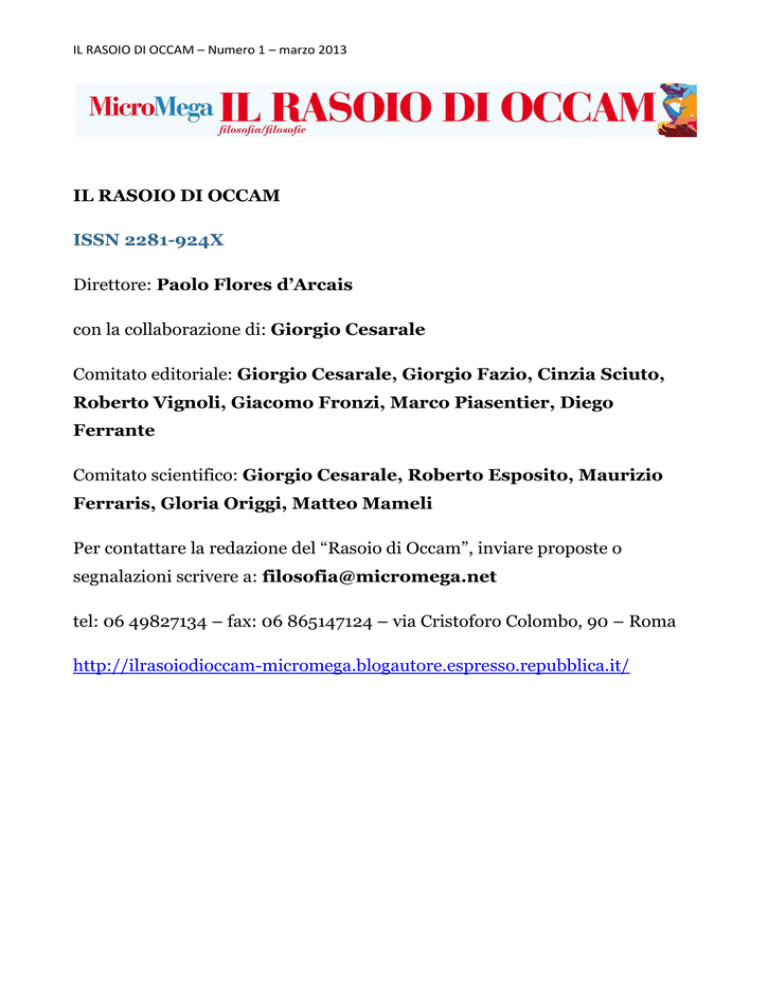
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
IL RASOIO DI OCCAM
ISSN 2281-924X
Direttore: Paolo Flores d’Arcais
con la collaborazione di: Giorgio Cesarale
Comitato editoriale: Giorgio Cesarale, Giorgio Fazio, Cinzia Sciuto,
Roberto Vignoli, Giacomo Fronzi, Marco Piasentier, Diego
Ferrante
Comitato scientifico: Giorgio Cesarale, Roberto Esposito, Maurizio
Ferraris, Gloria Origgi, Matteo Mameli
Per contattare la redazione del “Rasoio di Occam”, inviare proposte o
segnalazioni scrivere a: [email protected]
tel: 06 49827134 – fax: 06 865147124 – via Cristoforo Colombo, 90 – Roma
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Quant’è moderna questa reazione: i matrimoni gay e i nuovi
argomenti della destra
di RICCARDO ANTONIUCCI
Il dibattito sul riconoscimento legale del matrimonio tra omosessuali, che infiamma la Francia,
mette in questione l’eredità del pensiero filosofico francese della seconda metà Novecento
C’è chi sostiene polemicamente, come Yves-Charles Zarka, che è ormai l’unico tema su cui destra e
sinistra sono ancora chiaramente distinguibili, in mancanza di progetti realmente alternativi alla
politica neoliberista. Ad ogni modo, come spesso accade in Francia, il dibattito sulla legge che
estende il diritto al matrimonio alle coppie omosessuali (già approvata alla Camera e in attesa di
essere discussa al Senato il 2 aprile con il suo corollario di norme sulla possibilità per gli
omosessuali di avere figli tramite affitto di utero o inseminazione artificiale), si accompagna a
un’intensa querelle filosofica.
Sì, perché la posta in gioco, in questa discussione sul riconoscimento dei matrimoni gay, non è solo
politica, ma anche filosofica. Si assiste, infatti, allo scontro campale fra le cosiddette “teorie di
genere”, rodate da anni di dibattito negli Stati Uniti, e concezioni più tradizionali basate sulla
differenza sessuale tra uomo e donna. Le prime affermano la convenzionalità dei costumi sessuali in
quanto dipendenti da norme sociali storicamente determinabili; le seconde pretendono di fondare la
differenza dei sessi sulla biologia, sullo sfondo di una caratterizzazione ontologica incontrovertibile
della “natura umana”.
Senz’altro, il primo punto di interesse suscitato dalla campagna per il riconoscimento di pari dignità
alle unioni omosessuali sta nel fatto che si tratta del più avanzato fronte pratico della battaglia,
filosofica e politica, per scombinare l’ordine del discorso teso a normalizzare le condotte
sessuali(1).
Tuttavia, questa versione francese del dibattito sui diritti civili è interessante anche dal lato
dell’opposizione al progetto di legge. Per l’originalità di alcune tesi avanzate.
Leggendo gli interventi, ci si rende conto, infatti, che gli argomenti che vanno per la maggiore tra
gli oppositori non sono soltanto di ascendenza religiosa. Non vengono avanzate, insomma, proprio
quelle posizioni che siamo abituati a riconoscere agli oppositori del riconoscimento dei diritti degli
omosessuali (nel nostro Paese come negli Stati Uniti), e che rimandano a una teologia che assegna
stabilmente i ruoli sessuali e il senso di questi ruoli. Al contrario, la parte più attiva del fronte di
opposizione alla legge si avvale di riflessioni che fanno riferimento a un universo concettuale del
tutto laico, ancorato a dei saperi decisamente “contemporanei” come l’antropologia e la
psicoanalisi. Ma l’originalità di questa ripresa sta nel fatto che conferma una tendenza che ha
caratterizzato, negli ultimi anni, il panorama culturale francese, e non solo. È una tendenza che si
potrebbe definire del “richiamo all’ordine”(2), e che si può chiarire attraverso l’analisi di alcune tesi
dei conservatori.
Invarianti antropologiche e normalizzazione della sessualità
Il testo più citato in questo campo non è la Genesi, ma Le strutture elementari della parentela di
Lévi-Strauss. Il riferimento all’antropologia strutturale è incentrato sulla questione dell’incesto, la
cui proibizione è determinata come un invariante strutturale, perno del sistema di scambi di donne e
di costituzione della parentela.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Ora, questa analisi levistraussiana è assunta, nei discorsi anti-matrimoni gay, come la prova
dell’impossibilità di riconoscere socialmente un’unione omosessuale, perché ciò pregiudicherebbe
l’intera organizzazione della parentela. È quanto afferma, ad esempio, Sylviane Agacinsky,
insegnante fino al 2010 all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, che ha fondato,
con Jacques Derrida, il Collège International de Philosophie. Alla radio il 29 gennaio (3) e, qualche
giorno dopo, dalle colonne di Le Monde, la compagna di Lionel Jospin ha dichiarato che “la
filiazione legale riproduce analogicamente la coppia procreatrice, asimmetrica e eterogenea. Ne
mantiene la struttura, o lo schema, che è quello della generazione biologica da sue sessi. È in questi
termini che si può comprendere l’antropologo e etnologo Claude Lévi-Strauss quando scrive che “i
legami biologici sono il modello sul quale si concepiscono le relazioni di parentela”. Ora, si noterà
che questo modello […] [è] biologico e quindi qualitativo (uomo + donna), poiché i due [ruoli] non
sono interscambiabili”(4). Negare l’esistenza di un invariante antropologico fondato sulla differenza
tra i sessi concepita come naturale e astorica, sarebbe dunque, sempre per Agacinscki, una
“negazione [dénégation] violenta della finitezza e dell’incompletezza di ciascuno dei due sessi”.
Ma, a ben vedere, questa lettura opera una forzatura della logica dell’antropologia strutturale,
spostando il fuoco dell’invarianza antropologica: dalla proibizione dell’incesto al rigetto
dell’omosessualità come istituzione sociale. In molti hanno segnalato l’indebito salto logico,
confutando l’idea che Lévi-Strauss abbia sostenuto l’invarianza del rapporto uomo-donna nelle
società umane. Fra gli altri, Françoise Héritier, la più fedele allieva dell’etnologo, che ricorda che il
matrimonio è una costruzione sociale, e che come tale Lévi-Strauss l’ha analizzata. Tutt’al più, Le
strutture elementari della parentela dimostra che il modello eterosessuale è una costruzione sociale
antichissima, istituita per rispondere al problema (economico, come insegnava già Mauss)
rappresentato dal fatto che solo le donne possiedono il dono della procreazione, per entrambi i
sessi(5). Per l’antropologia strutturale, il modello di base del matrimonio è quello dell’alleanza:
niente impedisce, a rigore, che questo patto si possa stipulare fra due donne o due uomini. E tanto
basta a confutare la tesi dell’allineamento di Lévi-Strauss nelle fila del partito del no al matrimonio
gay.
Tuttavia, al di là della fondatezza della tesi di Agacinsky, ciò che resta del suo discorso è il tentativo
di “richiamare” l’antropologia strutturale alla causa della difesa dell’ordine sociale costituito.
Ma il “richiamo all’ordine” investe ancora più radicalmente la psicoanalisi. Sull’argomento
dell’unione omossessuale, infatti, ma ancor di più sulla questione della procreazione assistita per
coppie gay, si è prodotta in questa scuola una vera e propria frattura.
L’oggetto di scontro è rappresentato dalla genitorialità omosessuale. Molti psicoanalisti si
oppongono al suo riconoscimento sostenendo, in sostanza, che essa comprometterebbe lo sviluppo
della personalità del bambino in quanto comporterebbe l’abolizione della differenza sessuale
(considerata essenziale) tra i suoi genitori. Già il 3 ottobre 2012, in apertura di dibattito, numerosi
psicoanalisti (tra cui Jean-Pierre Winter e Aldo Naouri) si affidavano alle pagine di Le Figaro per
affermare l’inammissibilità della cosiddetta homoparentalité. Un mese dopo, appariva su Le Monde
un documento di impostazione affine, intitolato significativamente “Touche pas à père-mère”, e i
cui primi firmatari erano Chantal Delsol e Pierre Lévy-Soussan. Si dichiarava esplicitamente che
“Tutti i bambini del mondo hanno diritto a sperimentare la differenza tra genitori sessuati, che gli
conferisce un’origine psichica fondante la loro individualità”(6).
Non tutti sono d’accordo. In risposta alla tribune di Le Monde, infatti, l’École de la Cause
Freudienne (associazione sorta dalle ceneri della scuola fondata da Lacan nel 1964) ha pubblicato
un documento “contro la stumentalizzazione della piscoanalisi” che sostiene chiaramente che “al
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
livello dell’inconscio, i due sessi non sono legati da alcuna complementarità originaria, come
espresso dall’aforisma di Lacan secondo cui il rapporto sessuale non esiste”(7).
La psicoanalisi contemporanea, del resto, anche sulla scorta delle importanti rielaborazioni critiche
condotte nell’ambito delle teorie femministe, non può concepire l’“ordine simbolico” come un
invariante astorico, immutabile e trascendente rispetto alla società: affermarlo costituirebbe una
regressione teorica. Le leggi del simbolico, piuttosto, sono costituite a partire da rituali e forme che
provengono dalla società, e mutano secondo il divenire storico di quest’ultima.
Nella posizione contraria al riconoscimento del matrimonio omosessuale emerge, così, oltre alla sua
funzione descrittiva, un valore prescrittivo della psicoanalisi, che eleva la semplice constatazione
della “norma” dell’eterosessualità a principio di normalizzazione delle condotte atipiche. Secondo
la logica di questa lettura, la disciplina dovrebbe riprendere di diritto quella funzione normativa da
cui i seguaci di Lacan si erano impegnati a liberarla.
Inversione retorica e richiamo all’ordine
Accostandosi con uno sguardo d’insieme al dibattito francese sul riconoscimento del matrimonio
omosessuale, quello che si può distinguere è il manifestarsi di una tendenza: “assimilare” al fronte
culturale conservatore concetti e teorie appartenenti a una stagione della riflessione filosofica
(quella di Lévi-Strauss, di Lacan, ma anche di Foucault, Deleuze, Derrida e Lyotard) nata sotto
tutt’altra stella che quella della conferma dello stato di cose esistenti.
In questo senso, la tendenza attuale sembra come il prolungamento di un processo “revisionistico”
già avviato in Francia con la presidenza Sarkozy. Quando la destra si appropriò del tema
dell’uguaglianza, debitamente edulcorato del suo potenziale critico, per giustificare i progetti di
contrasto all’immigrazione e di affermazione dell’“identità nazionale”, cominciando anche a
infarcire i propri discorsi di citazioni di Jean Jaurès o Guy Moquet.
Oggi, il dibattito sul matrimonio gay rende manifesto il fatto che questo processo è arrivato a
lambire il discorso filosofico, mettendo in discussione l’eredità critica lasciata dal pensiero francese
del Novecento.
E il discorso va ben oltre i confini dell’antropologia e della psicoanalisi. Finora, a tutte quelle teorie
che, nei più diversi campi del sapere, mettevano in crisi l’ordine di pensiero costituito (la
concezione del soggetto, della storia, dell’ontologia, dell’uomo), si era reagito con la rimozione.
Ora, invece, superato questo stadio, sembra cominciare, un processo di revisione: un “richiamo
all’ordine” il cui cardine sarebbe costituito, come nota il sociologo Eric Fassin, da un’operazione di
“inversione retorica”(8) dei concetti.
Di fronte a questo stato di cose, non si può non constatare la complessità del compito di chi non
accetta questa riduzione della critica al servizio della conservazione. Da un lato, si impone il dovere
di una “battaglia della memoria”; dall’altro, la necessità di riattivare una possibile “attitudine
critica”, orientata verso nuovi orizzonti.
Note
(1) Si fa riferimento alla teoria radicale di Judith Butler. Una buona sintesi del suo pensiero
politico si può trovare nell’articolo “Faire et défaire le genre”, consultabile all’indirizzo
http://multitudes.samizdat.net/Faire-et-defaire-le-genre.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
(2) Riprendiamo con quest’espressione la formula che intitola il libro dello storico Daniel
Lindenberg, Le rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux reactionnaires, Éditions du Seuil, Paris
2002. Pur nell’apprezzamento dell’approccio complessivo che caratterizza l’opera di Lindenberg,
occorre tuttavia ricordare che essa resta, in molte sue parti, decisamente discutibile.
(3) http://www.rtl.fr/emission/l-invite-de-rtl/ecouter/la-philosophe-sylviane-agacinski-donner-aun-orphelin-deux-parents-du-meme-sexe-c-est-creer-une-inegalite-7757428401
(4) Cfr. l’articolo «Deux mères= un père?» su Le Monde del 3 febbraio 2013, consultabile
all’indirizzo: http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/03/deux-meres-unpere_1826278_3232.html.
(5) Cfr. l’intervento pubblicato nel blog Feministes en tous genres:
http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/11/23/francoise-heritier-lafamille-heterosexuee-est-tout-autant-u.html.
(6) Il testo del documento uscito su Le Monde è consultabile qui:
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/11/08/touche-pas-a-pere-et-mere_1788107_3232.html.
(7) Il testo è consultabile all’indirizzo: http://www.causefreudienne.net/psychanalyse-etpolitique/2013-01-13.
(8) http://blogs.mediapart.fr/blog/eric-fassin/030213/mariage-et-homosexualite-l-inversionrhetorique-de-la-droite-catholique.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
L’autunno del Pop e l’equivoco estetico: Britney Spears at the
edge of time
di LORENZO MARRAS
Ognuno sa che cosa è il Pop, ma pochi ne conoscono la grammatica e la logica, spesso
confondendo il fenomeno con alcune sue manifestazioni esemplari, ma limitate e discutibili. Ma
allora cosa ne è del Pop nell’epoca del compiuto interazionismo informatico? Ce lo rivela il
fenomeno Britney Spears. Riflessioni a partire dal libro "L’estetica del pop" di Andrea Mecacci.
L’ARTICOLO IN PDF
Più un epitaffio che una celebrazione, come ad un primo superficiale potrebbe apparire, L’estetica
del pop di Andrea Mecacci (Donzelli 2011, pp. 197) cerca di mettere ordine nella percezione di un
fenomeno del quale in verità si conosce ben poco, se non per interposte, e spesso superficiali,
interpretazioni.
L’intento del libro è proprio quello di storicizzare un’idea che nella vulgata massmediologica ha
perso totalmente il suo significato originario. Nel fare ciò, Mecacci sembra voler prendere alla
lettera l’affermazione di Warhol per la quale il Pop è morto nel 1965. In questo senso, la
conclusione a cui il volume giungerà è che la “logica del Pop” risulta non del tutto capace di
rendere conto dei radicali mutamenti sociali ed estetici intervenuti a partire dalla fine degli anni
settanta.
Tale storicizzazione è resa possibile da una meticolosa ricostruzione della grammatica e logica
dell’idea Pop. Quindi, cosa è ciò che si è soliti definire come Pop?
Il Pop ha rappresentato un’estetica precisa, una sensibilità ben definita con una sua geografia (il
mondo anglosassone) ed una sua cronologia (gli anni ’50 e ’60). Il percorso del Pop affonda le sue
radici nelle prime concezioni della modernità di Baudelaire, là dove la transitorietà della metropoli
dà vita ad un’estetica dell’artificio. Si viene così a delineare sempre di più la rilevanza delle masse
nel processo della fruizione estetica, un ruolo che condurrà a una serie di categorie socio-estetiche
che alimenteranno il dibattito culturale del Novecento, dall’industria culturale teorizzata da
Adorno/Horkheimer al kitsch. È con l’Independent Group - un circolo intellettuale inglese di artisti,
architetti e teorici e critici dell’arte in genere, e che nei primi anni cinquanta rifletteva sulla
decadenza del modernismo come espressione estetica della società del secondo dopoguerra – che il
Pop acquista una sua prima identità. In particolare fu la figura del critico e storico dell’architettura
Reyner Banham colui che colse pienamente come il Pop sia un’estetica del consumabile (e
dell’iconico) la quale permea tutte le manifestazioni della cultura industriale dell’epoca. Ma non
solo questo: il Pop nella riflessione degli anni sessanta assurge a manifestazione e giustificazione
ultima dell’utopia democratica del capitalismo, cioè quella di rendere tutti uguali davanti alla
merce.
Il problema, però, è che il Pop sfugge sempre a una sua messa a punto concettuale, come
testimoniano le riflessioni di Danto e Baudrillard, i quali tendono a leggere questo fenomeno
esclusivamente tramite Warhol e quindi tramite un’espressione certo significativa, ma allo stesso
tempo limitata dell’intera estetica e della cultura Pop. In questo senso, significativa è l’attenzione
che Mecacci riserva ad un autore tanto fondamentale quanto poco considerato – almeno in Italia –
come John McHale, con la sua estetica transumanista della Singularity (fusione del biologico e del
tecnologico), dell’H+ (Human Plus) e del “futuro del futuro”, estetica forse più attuale oggi che
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
all’epoca della sua elaborazione. Mecacci può così rendere conto di un malinteso ricorrente sia nella
critica sia nella percezione comune: sovrapporre Pop con Pop Art, identificare un’intera cultura con
la sua manifestazione highbrow, alta.
E tale aspetto, cioè il non ridurre il Pop alla Pop-art, non vuole certo sminuire il valore estetico ed
artistico della Pop-art stessa. Anche perché, il rischio di leggere la Pop Art in chiave esclusivamente
di critica estetico-culturale dell’arte, potrebbe essere quello di reiterare quel luogo comune per il
quale essa non avrebbe un effettivo valore “artistico”, luogo comune che spesso conduce a
demenziali asserzioni quali “Andy Warhol era un personaggio di tendenza, una mera rockstar
dell’arte, ed alla fine quelle cose le potevo fare anche io”. Peraltro lo stesso potrebbe valere per ciò
che si è soliti definire “minimalismo” ed autori come Truitt, Flavin e Judd.
Nel medesimo rispetto - rispetto, cioè, alla confusione tra Pop e Pop Art – Mecacci cerca di offrire
una diversa concettualizzazione di tale estetica, non per questo più complessa, ma di certo
stratificata e, per così dire, filologica e storica. Infatti è nell’applicazione che il Pop mostra la sua
forza pervasiva. Ciò accade non solo nella Pop Art, che è definibile più come una riflessione metaPop sulla cultura di massa, ma anche nella riflessione architettonica, la quale proietterà il Pop fino
alle soglie del postmoderno, facendolo diventare un’estetica ponte tra il modernismo e il
postmodernismo. Los Angeles e Las Vegas testimoniano questo passaggio grazie a geografie
urbane che si fanno sempre più segno, sempre più immagine. Il Pop diventa così un’atmosfera, un
inevitabile spazio vitale, e non un semplice fenomeno artistico. Anche la moda ed il design
documentano questa estetica come esercizio di arretramento anagrafico attraverso cui i giovani,
nella sospensione esistenziale di quel periodo della propria vita nel quale non si è più ragazzi ma
non si è ancora uomini, diventano i protagonisti assoluti delle nuove direzioni dell’estetico. È
sempre Banham che riconosce come la cultura Pop sia la sospensione atemporale di una dimensione
esistenziale adolescenziale, quella di aspirare unicamente al presente annullando ogni idea di
maturazione e con essa di morte. Sarà nella musica e nella stesura di una ben riconoscibile
mitologia americana che tale processo troverà il suo compimento. In altre parole, la dimensione
mitologica americana incarnata dal manifesto assoluto del Pop: Good vibrations dei Beach Boys del
1966.
In questo quadro le arti che non si appoggiano all’immediatezza dell’immagine e alla forza iconica,
come la letteratura e il cinema, faticano a trovare una loro grammatica Pop, consolidando l’idea che
il Pop sia un’estetica non solo anti-concettuale, ma soprattutto anti-narrativa. Il cinema risulta
esemplare nella definizione di una specificità del Pop: non esiste la possibilità di un cinema Pop,
che non si è mai dato, se non – così veniamo a scoprire – nei 14 minuti di Broadway by Light di
William Klein del 1958. Soprattutto un cinema Pop non si è dato proprio nella cinematografia di
Warhol, che tutto è definibile tranne che Pop. E lo stesso può dirsi della letteratura: esiste od è mai
esistita una narrativa Pop? La risposta è perentoria: no. Il narrativo è il contraddittorio stesso di ogni
fenomenologia Pop. Ciò non toglie che vi sia stato e continui ad esservi un profluvio di opere che
utilizzano questo o quest’altro elemento Pop, ma tecnicamente – stando alla grammatica ed alla
logica descritta da Mecacci - non esistono e non possono esistere opere propriamente etichettabili
come Pop in “quanto tali”.
È attraverso la problematizzazione di tali questioni – l’architettura, l’anti-concettualismo e l’antinarrativa - che il libro riesce a distinguersi dalla media degli studi sul Pop e la Pop art. A nostro
modo di vedere, infatti, gli aspetti più significativi de L’estetica del pop non sono solo rappresentati
dalle analisi di Warhol (al quale l’autore ha già dedicato un’esaustiva monografia), dei Beatles od
anche da quelle a proposito dell’industria culturale, ma appunto da quelle a proposito del cinema,
della narrativa e dell’architettura, cioè il cuore stesso del campo di applicazione (practical field) del
Pop. Certo, l’intro e l’epilogo dedicati ai Beatles ed a Warhol, sono forse sospinti da un eccessivo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
afflato retorico, con il rischio, del quale l’autore è però ben avvertito, di scivolare “nella
perversione contemporanea delle classifiche private, del gusto momentaneo (e soggettivo) elevato a
norma eterna (e oggettiva)”. Ma questo certo non distoglierà il lettore attento da quanto il testo ha di
meglio e di più originale da offrire.
Insomma, il contributo storico-critico che riteniamo indiscutibile de L’estetica del pop è l’aver
riconosciuto che tale estetica sembra aver smesso di funzionare come espressione della società tardo
capitalistica fin dai primi anni ottanta: le sue ultime propaggini mito-iconiche – Michael Jackson e
Madonna – proprio nel loro successo planetario sembrano invece manifestarne il declino. Hegel
direbbe, forse, che più che espressione di un’estetica Pop, Madonna e Jackson esprimono un mero
estetismo Pop, un “Pop pour Pop”.
Si è così andata sempre di più evidenziando – e ci allontaniamo qui dai contenuti propriamente
tematizzati da Mecacci – la necessità di nuove figure più adatte a rappresentare, nella sua forma
sempre più pervasivamente sociale e ludica, l’evoluzione del capitalismo neoliberale; evoluzione
derivante anche, se non soprattutto, dall’avvento dell’informatizzazione di massa. A questo
proposito non è un caso che siano dovuti passare quasi quindici anni - dal 6 novembre 1984 al 30
settembre 1998 – affinché emergesse una figura iconica adatta al nuovo Zeitgeist: Britney Spears.
E si faccia attenzione a non sottovalutare l’arco temporale, quindici anni, poiché rappresenta
un’eternità nel mondo dei mass media; infatti è in questi anni che si compie il passaggio completo
ed irreversibile dall’analogico al digitale e dal digitale al partecipativo, con tutto il riflesso che se ne
ha sulla relativa ontologia delle immagini. Da notare, infatti, che questo è anche uno dei
fondamentali cuts – archi temporali come cesure – della diffusione della videoludica su scala
mondiale. Come non è un caso, anche, che negli anni che hanno preparato l’avvento di Britney, le
super “top-model” (Claudia e Naomi) e le eroine dei videogiochi (Lara Croft) hanno sostituito le
popstar e le dive del cinema nell’immaginario popolare (con in mezzo effimeri interludi di starlet
televisive). Un passaggio, quasi un limbo del Pop, di solito poco considerato dai teorici della società
dei consumi e della celebrity in genere.
Al medesimo tempo (gli anni novanta) un personaggio come Jenna Jameson è riuscita a veicolare,
sempre nell’immaginario popolare, la trasformazione della pornografia in pornologia, apprendo le
porte del porno al “libero mercato” digitale. Verità, questa, che trova una sua espressione nella
famosa tesi di Fredric Jameson per il quale “il visuale è essenzialmente pornografico”.
Da un punto di vista “dialettico” Britney Spears può essere considerata come il fine e la fine di
questo movimento (Hegel direbbe Endzweck), ed allo stesso tempo il suo superamento, la Sleeping
Girl (Lichtenstein, 1964) che l’America attendeva dalla morte di Marilyn e la personificazione di
una nuova dimensione dell’immagine. Infatti è in questo senso che con Britney si viene a
manifestare una trasformazione nella natura dell’immagine, la quale non è più definibile né come
reale né come virtuale, cioè né come meramente analogica né come meramente elettronica.
L’immagine diventa d’ora in avanti compiutamente informatica, simulativa, massimamente
indeterminata e quindi proprio per questo sempre maggiormente determinabile: un’immagine, per
dire così, quantistica (Weibel), ed il cui flusso, in un mondo appunto totalmente informatizzato e
centrato su di una sua onnipervasiva ed ininterrotta fruizione di dati, appare sempre più dionisiaco,
radicalmente riflessivo al punto di mettere in crisi ogni riflessività propria dell’immagine analogica
e/o elettronica, financo quella percettiva, rendendo così la propria trasformatività essenziale e
reversibile, continuamente riscrivibile nella sua immediatezza (Spielmann).
Figura di una complessità socio-antropologica difficilmente esagerabile, e dalla potenza iconica
devastante, paragonabile forse solo a quella di Garbo e Marilyn, Britney è la manifestazione
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
assoluta della configurazione ludica, interattiva e creativa degli attuali rapporti estetico/sociali
angloamericani, e per questo mondiali; rapporti oramai totalmente informatizzati e virtualizzati,
naturalizzati, e quindi gli unici oggi possibili. La stessa categoria di “cultura di massa” sembra
risultare solo parzialmente utilizzabile al fine di rendere conto di un fenomeno come Britney, per il
quale ben più utile risulterebbe l’elaborazione di una ludica partecipativa di massa.
Britney, dopo un periodo di esilio di apprendistato pedagogico nel deserto storico/culturale
disneyano, è emersa fin dai suoi 17 anni come l’incarnazione ultima di quell’ordine religioso – il
più influente e numeroso in USA – chiamato americanismo. Se, come afferma Mecacci, Elvis
rappresentò l’archetipico americano e Marilyn l’iconico, Britney fin dalla sue prime apparizioni
globali e già da sempre globalizzate, apparve non solo incarnare ambedue questi aspetti per il
medesimo rispetto, ma anche sublimarli nella forma estetica pura dell’americanismo: il dionisiaco.
Al punto, ed è questa la questione che ci appare come decisiva, che Britney – per dirla parafrasando
il teologo Von Balthasar – copre con la sua ombra l’intero spettro sociale dell’immaginario Pop,
ma allo stesso tempo lo supera e lo mette tra parentesi.
Britney risulta manifestare chiaramente l’inapplicabilità odierna di ogni estetica propriamente Pop
al fenomeno dal lei incarnato e rivelato. Le categorie Pop, infatti, pur magistralmente esposte da
Mecacci, non sembrano essere più sufficienti a rendere conto della natura iconica di Britney e della
nuova configurazione eminentemente ludica e partecipativa dei rapporti sociali del capitalismo
avanzato.
Non deve sorprendere, quindi, che a Britney L’estetica del pop riservi solo qualche rapido accenno,
derubricandola, anzi, ad epifenomeno di Madonna, al pari di una Lady Gaga qualsiasi.
Questo non è certo un problema dell’elaborazione teorica di Mecacci, ma anche di molte
grammatiche della società dei consumi novecentesche nel momento in cui vengono applicate a
quella che abbiamo provvisoriamente definito come una ludica di massa. Siano pure, queste
grammatiche, quelle di un Eco o di un Baudrillard – il quale negli anni novanta pur aveva intuito
alcuni aspetti del carattere partecipativo e creativo dei consumatori, non tematizzandoli, però, nel
senso della possibilità di una ininterrotta ed irreversibile modificazione dello stesso oggetto
percepito e consumato dai fruitori. Ebbene, tali raffinate e complesse riflessioni sembrano mostrare
il fianco all’usura del tempo. Infatti, proprio nella sua natura essenzialmente interattiva, cioè
videoludica, Britney sembra far saltare ogni pretesa ad un controllo semiotico dell’oggetto: è stata
ed è la prima icona universale ed onnipervasiva creata e determinata nella sua esistenza dai suoi
stessi fruitori in maniera partecipativa; fruitori che si sono assunti poteri e responsabilità di
riscrittura della sua immagine (e quindi della sua vita, financo quella privata) forse mai avuti dal
pubblico del secolo scorso, il quale si limitava appunto a consumare la merce estetica e perciò a
determinarne il successo. È la totalità dell’esistenza di Britney che in questo atto di continua ed
ininterrotta riscrittura mediale, in questo “gioco”, diviene totalmente trasparente a noi, come noi a
lei, lei a se stessa e noi a noi stessi. Si può vedere in ciò la parabola stessa della celebrity,
cominciata alla fine degli anni venti con l’avvento di Greta Garbo, prima celebrity universale. Ma in
Garbo la vicinanza a noi, la sua consumabilità, assumeva i tratti i tratti paradossali della lontananza:
Greta era partecipata (consumata) proprio nel suo essere non partecipabile, distante, inaccessibile.
Con Britney Spears tale configurazione del divismo appare come annullata, trasfigurata: la mistica
del divismo è, per la prima volta nella storia della celebrity, totalmente fusionale, unitiva,
partecipativa in maniera ontologicamente sociale.
Ed è per questo che, come acutamente sottolineato da Christopher R. Smit in “The Exile of Britney
Spears” (2011), un testo come “La retorica delle immagini” di Barthes non risulta più adeguato per
una comprensione dell’immagine spearseana; ben più adatta sarebbe una retorica videoludica, cioè
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
una “retorica procedurale”. Tutto ciò si evidenzia in maniera esemplare nel famoso scatto in cui,
con una studiatissima involontarietà dell’esposizione, i genitali di Britney divennero un fatto di
“dominio” pubblico; evento che scosse l’opinione pubblica statunitense per settimane, se non mesi,
e lo fece ben oltre il mero ambito dei rotocalchi di gossip. Oramai totalmente trasparente al
pubblico – al quale offrì l’ultima cosa “privata” che possedeva – fu quello scatto a determinare, o
meglio rendere pubblico, il principio della “tragedia” di Britney Spears, l’inizio della presunta fine,
la caduta in una perdizione che sembrava indicare la sua prossimità alla morte (uno dei baluardi
strutturali della stessa celebrity). Ma tale tragedia, ed è questo il punto, non è stata percepita come la
tragedia di Britney, ma come una vera e propria tragedia generazionale, una tragedia americana. A
differenza di molte delle tragedie del divismo, questa è apparsa appunto come una tragedia
dell’America stessa, della quale Britney è la rappresentazione più dionisiaca, ed appunto per questo
assoluta; una tragedia, cioè, dove il genitivo deve essere inteso in senso sia soggettivo sia oggettivo.
La presunta tragedia di Britney, diventa quindi una “nostra” tragedia, perché noi l’abbiamo creata, e
quindi siamo noi ad essere responsabili della sua eventuale morte, come anche della sua eventuale
resurrezione. Ed è per questo che a differenza delle celebrity del passato neanche la morte
appartiene più al divo: Britney non ha il diritto di morire, a meno che tale morte non sia da noi
stabilita. Britney è allo stesso tempo precorritrice, profetessa ed epifania del WEB 2.0, il suo,
direbbe sempre Hegel, Beiherspielendes, cioè un gioco/esempio che tanto più è inessenziale (in
quanto gioco), tanto più manifesta (in quanto esempio) l’essenziale.
Essendo più un evento creativo di massa che un fenomeno estetico, se non in senso equivoco,
Spears non si limita quindi a utilizzare un medium ed esservi veicolata (violentata?), ma è essa
stessa un media partecipativo; e lo è al punto che la sua (presunta) resurrezione del 2008 si nutre
della medesima logica della sua creazione (una logica appunto partecipativa e sociale), e appare
come una vera e propria ri-mediazione di se stessa; mediazione che ovviamente si dà ed accade solo
nella sua sparizione, e che solo in questa continua sparizione ne permette l’esistenza: in quanto
immagine completamente trasparente a sé per il nostro tramite (mediale e mediatico), e quindi una
nostra responsabilità, la sparizione della mediazione veicola il nostro rapporto con l’oggetto
esistente e la sua riproducibilità. Un’immagine così fatta determina una relazione talmente
immediata, che è mediata solo dallo sparire della mediazione stessa. La negazione degli opposti
nella relazione simbolica e partecipativa dell’immagine informatica genera quindi una mediazione
che non è alcuna mediazione, una mediazione assoluta. L’esilio di Britney Spears, quindi, non è un
qualcosa che avrebbe a che fare solo con la fase tragica della sua vita (2006/2008), ma anche con la
sua fase paradisiaca (1999-2004) e con la sua rinascita (2008/2012): è Britney stessa, fin dalla sua
creazione come media partecipativo, ad essere una forma di esilio, quello appunto determinato dalla
nuova categorizzazione dell’immagine, informatica e modificabile in maniera partecipata e sociale.
Ciò che risulta determinante, si faccia attenzione, non sta però solo nella natura informatica
dell’immagine, e neanche nella sua essenziale modificabilità. Ciò che determina uno scarto, per così
dire “ontologico”, risiede nell’accelerazione temporale e sociale della possibilità di tale
modificabilità. Con l’informatizzazione di massa, tale possibilità diventa accessibile a tutti noi, e lo
è ad velocità prossima a quella dell’istantaneità: Britney diventa, e quindi è, un mezzo di
(ri)produzione completamente socializzato e, quindi, una nostra inviolabile proprietà. Ed è questo
suo stesso essere una sorta di user generated content – o, in una corrispondenza isomorfica tra
naturale e digitale, "lo" user generated content perfetto – che si rivela la natura della sua (o della
nostra?) “tragedia”.
Si viene così a mostrare, una curvatura nella natura della consumabilità, la quale non conduce
unicamente alla “distruzione” per il tramite della “digestione”, come nell’ontologia propriamente
Pop, ma anche ad una continua creazione e modificazione, cosa che quindi determina uno
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
sfasamento, uno smarcamento, appunto una trasfigurazione dell’idea Pop per come la siamo andati
definendo insieme con Mecacci.
Per questa ragione – almeno in una percezione di tipo capitalistico – sembra manifestarsi un
cambiamento nella stessa essenza dell’essere umano; cambiamento del quale ad oggi è difficile
determinarne l’effettiva portata e le reali conseguenze.
Lorenzo Marras ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi
di Roma “Tor Vergata”.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Pensare la crisi con Jacques Derrida. Intervista a Marc
Crépon
di RICCARDO ANTONIUCCI
Il valore politico del pensiero di Derrida sta nella decostruzione della sovranità e nell’elaborazione
di una pratica di giustizia che sia incondizionale. La responsabilità come vero antidoto alla
violenza.
Tra il 24 e il 26 gennaio scorso si è svolto all’Università di Atene, in collaborazione con l’Institut
Français de Grèce, un convegno internazionale dal tema “Il pensiero politico ed etico di Jacques
Derrida”. Al centro della tre giorni di lavori, la riflessione sulla condizione critica che caratterizza il
presente dell’Europa; all’insegna dell’esperienza della “crisi”. In questo contesto, il pensiero di
Derrida si rivela particolarmente efficace per pensare la congiuntura storica attuale. Ne parliamo
con uno dei relatori del convegno: Marc Crépon, filosofo, allievo di Jacques Derrida e attualmente
direttore del dipartimento di filosofia dell’École Normale Supérieure di Parigi.
Professor Crépon, la prima domanda che vorrei porle, e che, trattandosi di una questione sul
senso, non è aliena da una certa “bêtise”, riguarda proprio i due aggettivi con cui si è voluto
qualificare il pensiero di Derrida durante questo convegno: “politico” ed “etico”. Possiamo
tentare di chiarire meglio il nesso esistente tra il pensiero di Derrida e i campi descritti dai due
termini. “Pensiero politico” e “pensiero della politica” non sono la stessa cosa, ovviamente.
Eppure, di solito, un pensiero non è detto “politico” se non è anche riconosciuto, parallelamente,
come “pensiero della politica”, o del politico. Cioè come pensiero delle condizioni e delle tecniche
proprie all’azione politica in un contesto storico determinato. Per cui spesso la “filosofia
politica” si riduce a una serie di riflessioni su problemi che sono posti dall’attualità della pratica
di governo o dell’amministrazione della società. Tuttavia, questo parallelismo non sembra
operativo nel pensiero di Derrida: la sua riflessione, senza essere stata “condizionata” da temi
provenienti dal dibattito politico, li ha piuttosto “rilanciati”, riverberati, in un'altra forma;
addirittura, in alcuni casi, li trasformati, passandoli al filtro del suo singolare approccio
filosofico. Per esempio, ha rilanciato il problema della democrazia attraverso il concetto di
ospitalità. Insomma, il pensiero di Derrida si presenta come un caso singolare di pensiero
“politico” che non è un pensiero della politica. La sua battaglia, dunque, si muove piuttosto
nell’elemento della filosofia politica oppure della “politica della filosofia”, che non si interessa
delle pratiche concrete di governo?
Marc Crépon – È vero che nell’opera di Derrida non si trova una riflessione sviluppata intorno alle
forme di governo. Eppure, la possibilità di qualificare il suo pensiero come “politico” è innegabile,
a dispetto di tutte le riserve che impone l’idea stessa di “qualificazione” in generale. Ed è innegabile
almeno per due ragioni. La prima è che, se è vero che, a partire dai tre grandi libri del 1967 (1), uno
dei fili conduttori del suo pensiero è stata la decostruzione del soggetto sovrano, era allora
inevitabile che Derrida incrociasse la questione della sovranità in sé, nella sua accezione politica. Il
“pensiero politico” di Derrida, se ce n’è uno, si dà dunque prima di tutto come “decostruzione della
sovranità”. Per questo esso è impostato su un confronto capitale con colui che ha pensato la
sovranità come eccezione: Carl Schmitt. Ma questo orientamento è anche la ragione per cui il
pensiero di Derrida incontra, come problema fondamentale, la questione del perdono, del diritto alla
grazia e quindi della pena di morte.
La seconda ragione è l’opposizione tra diritto e giustizia, analizzata in Forza di legge (2) e, nello
stesso ordine di idee, la messa in luce della “messianicità senza messianismo” di una giustizia a
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
venire avanzata da Spettri di Marx (3). Creando, sul filo di una lettura serrata del saggio di
Benjamin “Per la critica della violenza”, l’opposizione fra diritto e giustizia, Derrida apre le porte a
qualcosa che gli permetterà di interrogare nuovamente, e in maniera inedita, l’articolazione
dell’etica e della politica, cioè la tensione aporetica, irriconciliabile, tra un diritto sempre
condizionale [conditionnel] e un’esigenza e un principio di giustizia incondizionali
[inconditionnels] – disegnando così l’orizzonte di una democrazia “a venire” (4). Ne deriva una
responsabilità che è insieme etica e politica, dove la copula designa precisamente il luogo
dell’aporia. La responsabilità è rendere possibile l’impossibile: per esempio, piegare gli imperativi
di un’ospitalità condizionale all’esigenza di un’ospitalità incondizionale. Si tratta, in altri termini, di
evitare che il diritto si spacci per giustizia; denunciare, in particolare, l’escalation vertiginosa delle
condizioni poste all’ospitalità, in Europa e altrove, con la quale si pretende di far valere un principio
di giustizia quando, invece, si produce l’esatto contrario.
Durante il convegno si è tenuta una tavola rotonda sul tema specifico “Pensare la crisi con
Jacques Derrida”. Con la nozione di “crisi” si faceva evidentemente riferimento alla crisi
economica e sociale che affligge attualmente l’Europa. In questo contesto, quali concetti offre il
pensiero di Derrida alla riflessione politica?
M. C. – Nel pensiero di Derrida c’è un altro filo conduttore, che bisogna concepire come una quasiresistenza a tutti i tipi di invocazione di appartenenza a un’identità collettiva, qualunque essa sia. In
maniera quasi idiosincratica, Derrida non si fida dei concetti di comunità, identità (singolare o
collettiva) e di appartenenza. La crisi, oggi, minaccia di riattivare, non senza violenza estrema, tutti
i fantasmi identitari e, con loro, tutte le tentazioni di ripiegamento comunitario su identità
fantomatiche [fantasmées]. Una delle traduzioni più immediate di questo tipo di movimenti di
ripiegamento è il ritorno delle mono-genealogie culturali, come se una qualunque restaurazione di
presunte identità in pericolo potesse costituire un rimedio alla crisi. Da Oggi l’Europa. L’altro capo
(5) a Il monolinguismo dell’altro (6), la questione dell’identità è centrale nella riflessione di
Derrida. È dunque a questo titolo che il pensiero di Derrida può orientare una riflessione intorno al
tema della crisi, e non a titolo di un pensiero dell’economia e della società, temi che non sono stati
direttamente al centro delle sue preoccupazioni. In fondo, di fronte alla crisi potremmo fare nostra
questa frase di Oggi l’Europa, che cito spesso ai miei studenti europei e americani: “Ciò che è
proprio di una cultura è il non essere identica a se stessa. Non di non avere identità, ma di non
potersi identificare, dire “io” o “noi”, di non poter assumere la forma di un soggetto che nella nonidentità a sé, o, se preferite, nella differenza da sé”. Tutto questo sembra apparentemente lontano
dalla “crisi” e dai suoi effetti distruttivi, e invece riguarda proprio il cuore della crisi, ovvero la
minaccia portata, in modo assolutamente regressivo, a quel legame che, a mio giudizio (ed è uno dei
punti che mi lega alla lettura di Derrida) unisce l’Europa all’avvenire di un certo “cosmopolitismo”.
Questi temi sono anche al centro del suo lavoro, almeno a partire dai due volumi de La culture
de la peur (Galilée, Paris 2008 vol. I «Démocratie, identité, sécurité» e 2010 vol. II «La guerre
des civilisations»). Il suo ultimo libro, invece, Le consentement meurtrier (Éditions du Cerf,
Paris 2012), prosegue l’analisi interrogando le ragioni del ripiegamento identitario che interessa
attualmente i popoli dell’Europa (e non solo). In questo libro lei mostra che la violenza è una
conseguenza necessaria della sovranità, e suggerisce di contrastare la logica sovrana dello
“stesso” con la logica non identitaria della “comunità degli esseri viventi”. Ma ci si potrebbe
chiedere se una politica senza violenza è davvero possibile come tale. Oppure questa prospettiva,
come anche nel caso della “comunità che viene” di Giorgio Agamben, finisce per abolire la
politica?
M. C. – La questione della “comunità dei viventi” è introdotta verso la fine nel libro, e più che altro
rimanda ai prolungamenti a venire di Le consentement meurtrirer, e al confronto che voglio
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
intavolare, già da molto tempo, con le tesi di Giorgio Agamben. La questione al centro di Le
consentement meurtrier è più che altro questa: come non rimanere vittima della stessa morale che si
invoca ogni volta che si fa appello – anche sulla scena internazionale – all’articolazione della
politica su dei principi etici. Si parte dal principio che, se è vero che le relazioni intersoggettive
sono fondate sulla responsabilità della cura, del soccorso e dell’attenzione che, dovunque e per
chiunque, la vulnerabilità dell’altro esige, la politica continua tuttavia a imporci dei compromessi
che eclissano questa responsabilità. Ci tappiamo le orecchie, chiudiamo gli occhi, preferiamo non
vedere e non sapere, quando proprio non partecipassimo attivamente all’una o l’altra forma di
violenza, di insicurezza e di fragilizzazione delle condizioni dell’esistenza che chiamano alla
responsabilità. È quello che chiamo il “consenso mortale” (consentement meurtrier), che è una
dimensione della nostra appartenenza al mondo. Non è sicuro che riusciamo a uscirne; che si possa,
in altri termini, sfuggire alla violenza, ma conviene almeno provare a immaginare le forme etiche e
politiche che permettono di risponderne; forme che chiamo “eticosmopolitiche”. La rivolta, la
bontà, la critica, la vergogna sono alcune delle forme che può assumere questa risposta. Come si
vede, sono molto lontano dall’idea di un’abolizione della politica. La politica, la definisco come
l’organizzazione istituzionale e conflittuale di un [tipo di] “essere-contro–la-morte” che si rivela
sempre selettivo, parziale, calcolato a reversibile. È in questa parzialità, in questo calcolo e in
questa reversibilità che si annida la possibilità della violenza e di tutte le forme di consenso mortale
che l’accompagnano. L’etica, allora, è la contestazione di tutto ciò, perché [il tipo di] essere-controla-morte che è al suo fondamento non può accontentarsi delle mappe della vulnerabilità e della
mortalità che produce la politica. Per il momento, sono ancora fermo al punto di pensare le
condizioni di questa contestazione. Rimane da pensare come essa possa, e debba, tradursi nelle
istituzioni.
Nel 1983, a proposito della nozione di crisi, Derrida diceva che, se “la krisis rinvia al giudizio,
alla scelta, alla decisione, [la] crisi è un momento in cui la krisis sembra impossibile. La crisi
non è un incalcolabile qualunque, è l’incalcolabile come momento del calcolo”(7). Qui la
nozione di crisi sembra assimilata a quella di indecidibile, che è una delle nozioni essenziali del
pensiero di Derrida. Se è cosi, si può allora definire a tutti gli effetti Derrida un “pensatore della
crisi”? La decostruzione, in fondo, non sarebbe nient’altro che una crisi permanente, una messa
in crisi permanente? Una filosofia della crisi contro una filosofia dell’affermazione?
M. C. – Non sono sicuro che sia esattamente questo che dica e faccia Derrida. perché quella che lei
chiama “crisi permanente” non dà diritto a una cosa che, mi sembra, è invece essenziale nel lavoro
di Derrida a partire dalla metà degli anni ’80, e che riguarda ciò che lui stesso ha definito le
“questioni di responsabilità”. Il calcolo rimanda alla figura del programma, e l’incalcolabile come
momento del calcolo all’esaurimento del programma. La crisi sorge quando i programmi non
funzionano più, quando non possono neanche più dare l’illusione di proporre, se non una
“soluzione”, almeno un “esito”, una “via d’uscita”. La crisi è la moltiplicazione dei calcoli che
girano a vuoto perché riempiono dei programmi che non implicano alcuna decisione: nel senso in
cui, per Derrida, non c’è decisione responsabile se non sulla base di un indecidibile che è
un’esperienza dell’aporia. Si ricordi la definizione che dà Derrida della responsabilità, sempre in
Oggi l’Europa: “Oserei suggerire che la morale, la politica, la responsabilità, se ce n'è, non
sarebbero mai cominciate senza l'esperienza dell'aporia. Quando la via è aperta, quando un sapere
apre anticipatamente il cammino, la decisione è già presa, e tanto varrebbe dire che non c'è
decisione da prendere: irresponsabilità, buona coscienza, si applica un programma. Forse, e questa
sarebbe l'obiezione, non si sfugge mai al programma. Allora però bisognerebbe riconoscerlo e
smetterla di parlare con autorevolezza di responsabilità morale e politica. La condizione di
possibilità di qualcosa come la responsabilità è una certa esperienza della possibilità
dell'impossibile: la prova dell'aporia a partire da cui inventare la sola invenzione possibile,
l'invenzione impossibile" (8). Come si vede, è tutt’altra cosa di quell’indecisione che è invece
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
l’effetto di programmi che non hanno più niente da promettere. Indecisione e indecidibile non sono
la stessa cosa. Ciò che è in questione è la possibilità di ridare senso a una promessa che
l’incalcolabile annidato nel cuore del calcolo (è l’essenza della crisi) sembra condannare.
Un’ultima domanda che ci allontana un po’ da questo insieme di questioni. L’anno prossimo
sarà il decimo anniversario della morte di Jacques Derrida, e il trentesimo di quella di Michel
Foucault. Il rapporto, per così dire, non lineare tra i due è stato molto studiato. Eppure,
guardando all’attualità francese, l’impressione è che anche la sorte delle due opere sia stata
divergente. Che, diversamente da quella di Foucault, l’opera di Derrida non sia stata, in altri
termini, inserita in un processo di “integrazione”, o appropriazione, all’interno della ricerca
delle scienze umane. Si potrebbe quasi dire che l’opera Derrida non abbia “fatto scuola” o,
meglio, che non abbia lasciato quel tipo di lascito metodologico per cui sarebbe possibile, in tutti
i campi del sapere, dirsi “derridiani”. Almeno non nel senso in cui molti si definiscono
“foucaultiani” o “deleuziani”. Forse il pensiero di Derrida è per essenza estraneo a questo tipo di
tradizione. Che tipo di eredità ha lasciato ai suoi lettori? È possibile oggi definirsi “derridiani”, e
in che senso?
M. C. – La domanda mi sorprende, perché penso che, al contrario, il pensiero di Derrida ha proprio
“fatto scuola” nel senso che dice lei, e che la sua diffusione è notevole, anche nelle scienze umane.
Ci sono delle discipline che devono in parte la loro stessa esistenza al lavoro di Derrida, come i
“gender studies” negli Stati Uniti o gli studi postcoloniali. I suoi testi sono studiati, specialmente
nelle università americane, nei dipartimenti di scienze politiche, di studi cinematografici, di studi
africani, di letteratura comparata, di analisi dei media, di storia dell’arte ecc. Il lascito, consiste
prima di tutto in un’opera dalla mole considerevole, che resta una fonte di ispirazione per molti.
Un’opera che resta in gran parte ancora da pubblicare: fatta di quarant’anni di corsi e seminari, di
cui solo una minuscola parte è stata finora pubblicata. Il corpus è dunque immenso e aperto. Esso fa
di Derrida, come degli altri pensatori della sua generazione (Deleuza, Foucault), un “classico” della
filosofia, alla pari dei pensatori della generazione precedente (Sartre, Merleau-Ponty, Simone
Weil…). Le opere di Derrida sono studiate ma anche discusse, criticate, al di là di ogni forma di
mimetismo e ripetizione; iscritte, in altri termini, in un loro specifico “momento”. Il lascito è anche
un cantiere: quello di quest’etica iperbolica – le questioni di responsabilità di cui parlavo – senza la
quale l’idea stessa di una “democrazia a venire” non ha senso. Quest’ultima idea apre numerose
piste di lavoro che molti giovani ricercatori riprendono per conto loro. Voglio dire che l’opera di
Derrida costituisce oggi per molti un punto di partenza, anche se in seguito si producono delle
rotture. È un’opera, infine, con la quale molti filosofi della mia generazione si sono confrontati nel
loro percorso personale: Catherine Malabou, Serge Margel, Peter Szendy, Frdéric Worms, per
citarne solo qualcuno, sanno quanto devono alla lettura dei testi di Derrida.
NOTE
(1) Jacques Derrida, De la grammatologie, Minuit, Paris 1967; tr. it. Della grammatologia, Jaca
Book, Milano 1968, 1998²; L'écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, 1979²; tr. it. La scrittura e
la differenza, Einaudi, Torino 1971, 19903; La voix et le phénomène. Introduction au problème du
signe dans la phénoménologie de Husserl, P.U.F., Paris 1967, 1993²; tr. it. La voce e il fenomeno.
Introduzione al problema del segno nella fenomenologia di Husserl, Jaca Book, Milano 1968,
1997³.
(2) Id., Force de loi. “Le fondement mystique de l’autorité”, Éditions Galilée, Paris 1994 ; tr. it.
Forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità, Bollati Boringhieri, Torino 2003.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
(3) Id. Spectres de Marx, Galilée, Paris 1993 ; tr. it. Spettri di Marx, Raffaello Cortina, Milano
1994.
(4) Il riferimento è al “lessico dell’incondizionalità” derrridiano, per cui cfr. anche Id., Voyous,
Éditions Galilée, Paris 2003; tr. it. Stati canaglia, Raffaello Cortina, Milano 2003.
(5) Id., L'autre cap, Minuit, Paris 1991; tr. it. di M. Ferraris, Oggi l'Europa. L'altro capo.
Memorie, risposte e responsabilità, Garzanti, Milano 1994.
(6) Id., Le monolinguisme de l'autre, Galilée, Paris 1996; tr. it. Il monolinguismo dell’altro,
Raffaello Cortina, Milano 2004.
(7) Id., Économies de la crise. Entretien avec Jacques Derrida, in «La Quinzaine littérarire», n°
399, agosto 1983.
(8) Traduzione di Maurizio Ferraris: Oggi l’Europa, cit.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Governo tecnico o governo politico? Una falsa alternativa
di GIUSEPPE DUSO
Le difficoltà che si incontrano nel distinguere il “governo tecnico” da quello “politico” sono la
spia di difficoltà ancora più grandi, quelle che riguardano il processo di legittimazione del
governo. È perciò la stessa categoria del governo che deve esser ripensata, fuori da ogni sua
riduzione a “potere esecutivo” e dentro un modo diverso di intendere il comando e la dimensione
politica dei cittadini.
In relazione alla situazione politica che si è determinata nell’ultimo anno si può tentare un
esperimento inconsueto. Non tanto cioè di dare per scontato che si è trattato di una situazione
eccezionale e che è ben diverso un governo “tecnico” da uno “politico”, e nemmeno di giudicare
l’operato di questo governo tecnico (cosa che si può e si deve fare), ma piuttosto di trarre motivo da
questa esperienza per una riflessione critica sulla modalità diffusa di pensare la politica, condivisa
anche da coloro che si contrappongono nella lotta politica. Il piano in cui si dà la lotta culturale e
politica e la forma della democrazia rappresentativa devono essere accettati come inevitabili e
necessari, oppure emerge l’esigenza di nuove categorie per pensare la politica?
Possiamo partire dalla definizione di “governo tecnico” che è stata usata, sia pure con giudizi
diversi, per indicare una tale vicenda politica. In questa espressione il termine “tecnico” vuole
segnalare la presenza diretta nel governo delle competenze e conoscenze necessarie a risolvere i
problemi che ci assillano. L’identificazione del governo con queste competenze e saperi non appare
tipica della forma democratica, al punto che spesso si sente parlare di una “sospensione della
democrazia”. Cosa significa ciò? Che di norma si pensa che il governo che non è tecnico, ma è
invece “politico”, può essere privo delle conoscenze necessarie a governare i processi e a risolvere i
problemi? Si è tentati di rispondere di no; ma in realtà, anche se sembra ovvio che nei ministeri e
nel personale amministrativo ci sia competenza tecnica, si è costretti ad ammettere che tale sapere
non è ritenuto necessario per la guida politica, in quanto si pensa che questa debba essere
determinata dalla scelta della linea di fondo e dei valori che connotano una politica in luogo di
un’altra. Ciò porta ad una situazione ricorrente, accolta senza indignazione, di ministri che hanno la
più totale mancanza di competenza, di sapere e di esperienza in relazione alle tematiche del
ministero che devono guidare.
Ma è pensabile che l’aggettivo “tecnico” assorba totalmente in sé il sostantivo a cui si riferisce, il
quale ha un indubbio significato politico? O non sta nelle cose che governare comporta trovare una
via, fare delle scelte, avere dei punti di riferimento? Questa realtà dell’agire governativo non è
dunque irriducibile alla presunta oggettività di un sapere, astratto dalle situazioni e dalla sfera della
prassi? Allora non siamo di fronte ad un mero esercizio di sapere, non ci muoviamo all’interno di
discipline scientifiche, magari addirittura accademiche (si dice “il governo dei professori”), ma si
tratta del governo degli uomini e delle cose, cioè di una prassi che non può che essere politica. Ma
allora, se governare è in ogni caso prassi politica, anche se riguarda un cosiddetto governo tecnico,
in cosa si differenzierebbe da quest’ultimo un presunto “vero” governo politico? Quale è il preciso
significato di “politico” contrapposto a “tecnico”?
Dal momento che la riflessione che tentiamo di fare riguarda i concetti fondamentali con cui si
pensa la politica, si deve riconoscere che, per comprendere il significato che si attribuisce nel
dibattito corrente al termine “politico”, bisogna partire da lontano, cioè dalla nascita del dispositivo
moderno con cui si concepisce la politica, avvenuta in quel laboratorio concettuale che è il
giusnaturalismo moderno. In esso si è negato che sia razionale il fatto che tra gli uomini si ponga
inevitabilmente la relazione tra chi governa e chi è governato: questo era il problema su cui per
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
secoli si sono differenziate le diverse concezioni politiche, tese a determinare le modalità secondo le
quali un governo poteva essere buono e giusto. Nelle dottrine del diritto naturale una tale relazione
è stata considerata irregolare e irrazionale e, sulla base dei nuovi concetti di uguaglianza e di libertà,
si è costruito nella teoria il concetto di potere legittimo (la sovranità moderna). Da allora non è più
la virtù e la capacità di chi governa ad essere decisiva, ma piuttosto la sua legittimità, consistente
nel fatto che la persona che esprime il comando necessario alla vita in comune degli uomini è il
risultato della volontà di coloro che dovranno ubbidire. Unica legittimità dell’autorità è di essere il
risultato di un processo di autorizzazione, di essere da tutti voluta.
Dunque ciò che caratterizzerebbe il termine politico come contrapposto a tecnico sarebbe da una
parte un’ottica complessiva e generale sulle finalità del governo, svincolata da ciò che i processi
stessi e le cose mostrano di richiedere (aspetto tecnico) e legata ad una Weltanschauung, una
visione del mondo teoricamente elaborata come presupposto (una ideologia?), e dall’altra
(soprattutto) quel processo di autorizzazione che caratterizza ancora ciò che si suole indicare come
“legittimazione democratica”. Il fatto cioè che ci siano elezioni, a cui in modo uguale partecipano i
cittadini, e che attraverso queste si costituisca un’assemblea di attori politici con il compito di
esprimere la volontà che è attribuita al popolo, volontà che diviene legge a cui si deve obbedire; e
infine che ci sia un governo inteso come mero “potere esecutivo”, tale cioè da mettere in atto la
legge decisa dalla maggioranza parlamentare. In tal modo il governo metterebbe in atto
rappresentativamente la volontà del popolo. In ciò consiste il meccanismo formale della
democrazia rappresentativa, anche se ad esso non si riducono certamente tutte quelle esigenze e
quelle istanze che comunemente si riferiscono al termine di “democrazia”. Nell’ottica della presente
riflessione si può dire che molte di queste istanze, in modo particolare quella della partecipazione
dei cittadini (ma anche quella del riconoscimento di una pluralità di soggetti), non trova nel
meccanismo formale indicato una via per la sua realizzazione.
Se è così, allora l’aggettivo “politico” indica bensì che il governo è legittimato da una maggioranza
(si badi bene, dei voti espressi, non della totalità dei cittadini), ma non ci dice niente sul fatto che
questo possa essere un buon governo, e che chi è stato scelto abbia la conoscenza, l’esperienza, la
capacità, (per usare una parola complessiva che ha una lunga tradizione, la virtù) per governare
effettivamente i processi in atto per il bene dei cittadini. La sterminata discussione contemporanea
sulla governance e la sempre più diffusa pratica di ricorso alle autority, lungi dall’indicare una
nuova forma di legittimità coincidente con l’efficienza, mi pare indichino la difficoltà di fondo della
logica della democrazia rappresentativa, soprattutto in merito a due problemi: quello della reale
capacità di governare i processi, e quello del coinvolgimento e della partecipazione dei soggetti in
essi implicati. Per questi due problemi lo schema di base della democrazia rappresentativa non ha,
in quanto tale, uno strumentario adeguato. Già a questo proposito sarebbe da riflettere sul fatto che
sempre più le democrazie contemporanee hanno bisogno per il loro funzionamento di organi non
fondati democraticamente, non basati sul voto, dunque non “politici” secondo l’accezione determinata, particolare, storicamente segnata, e non certo universale come si crede - del termine
che stiamo interrogando.
Lo schema della legittimazione che abbiamo ricordato non si dà tuttavia in modo semplice, non si
svolge in uno scenario determinato immediatamente dalla dialettica in atto tra i cittadini e lo Stato.
Tale schema è radicalmente complicato dalla presenza dei partiti. In quello che già nel primo
Novecento è chiamato lo “Stato dei partiti” la rappresentanza e le elezioni passano attraverso
l’operare dei partiti. Questi tendono ad occupare totalmente lo scenario politico e ad offrire una
mediazione per risolvere lo iato che si viene paradossalmente a creare proprio a causa del processo
di autorizzazione. In questo infatti tutti si proclamano bensì, come già diceva Hobbes, autori delle
azioni che l’attore, il rappresentante appunto, farà e dunque fondano dal basso la sua autorità, ma,
proprio per questo, non agiscono essi stessi politicamente e nemmeno forniscono istruzioni per
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
l’agire del rappresentante. Sulla base di questo processo – che caratterizza ancora lo strumento delle
elezioni, in cui si realizza il concetto moderno di rappresentanza nelle costituzioni moderne a partire
da quella del 1791 della Francia rivoluzionaria – i rappresentanti non devono tanto rappresentare
parti della società, o i propri elettori, ma la volontà unitaria del popolo. Non c’è allora una
trasmissione di volontà politica dall’elettore a quello che sarà l’attore politico: non c’è istruzione,
non c’è vincolo, ma appunto mandato libero. Si esprime solo fiducia in relazione a ciò che il
rappresentante farà. Appare qui con evidenza una forma di spoliticizzazione, in quanto i cittadini
diventano protagonisti e non solo sudditi solo a patto di delegare l’agire politico ad altri, senza
determinare questo agire nei suoi contenuti. E’ appunto questo iato che dovrebbe essere riempito
dalla mediazione partitica in quanto, anche se gli elettori non esprimono volontà particolari ma solo
i nomi di coloro che dovranno diventare rappresentanti, tuttavia il ponte che unirebbe la volontà
degli elettori a quella dei rappresentanti sarebbe costituito dai programmi dei partiti. Sono questi
che dovrebbero rassicurare gli elettori che i deputati in Parlamento tenderanno ad operare nella
direzione che è stata promessa e sulla cui base i cittadini hanno espresso il loro voto. Tale logica
coinvolge il governo, che è espressione della maggioranza parlamentare. L’accezione di “politico”,
che intendiamo qui mettere in questione, viene allora ad identificarsi con l’elemento “partitico”,
come mostra il fatto che a gran voce oggi si definisce la critica ai partiti come “antipolitica”.
Ma è da chiedersi se i programmi dei partiti, sempre più simili e in concorrenza tra loro nel
promettere cose che dovrebbero incontrare i desideri degli elettori, possano costituire un legame tra
la volontà dei cittadini e ciò che costituirà l’effettivo operato del Parlamento e del governo, o non
abbiano piuttosto il fine di allargare il consenso, un consenso previo, concesso sulla fiducia, che
dovrebbe essere il più possibile ampio e totalitario. Tutti i partiti affermano, o in ogni caso
ritengono, che avendo la maggioranza del 51% potrebbero veramente fare quello che promettono e
dunque il vero bene dei cittadini. In ogni caso, al di là di questa considerazione, bisogna anche
riconoscere che la presenza dei partiti complica quella che appare essere la logica, ma anche la
lettera, della carta costituzionale in alcuni punti rilevanti. Infatti qualora il legame tra elettore ed
eletto si ritenesse garantito dal fatto che gli eletti restano fedeli alle decisioni dei partiti, ci si può
chiedere se il rappresentante sia da intendersi libero da vincoli di mandato, come afferma la nostra
Costituzione, oppure legato al mandato dei partiti. E non si tratta di un mandato imperativo che
proviene dalla costituzione materiale della società e delle sue parti, ma da soggetti che hanno una
loro separatezza, una loro organizzazione burocratica, anche se tendono a mantenersi mediante il
cosiddetto “consenso”. Ma si pensi poi a quanto i partiti decidano per i cittadini quali debbano
essere i loro rappresentanti, non solo nella situazione prodotta dalla attuale legge elettorale in Italia,
ma anche in quella in cui si possono esprimere le preferenze. Quando infatti un cittadino può
decidere lui chi lo rappresenta? E quanto è condizionato, anche nel caso di possibile scelta, dalla
proposta di candidati da parte dei partiti e dalle decisioni che questi ultimi prendono in relazione
alla posizione dei candidati nelle liste elettorali e ai seggi nei quali presentarli? E’ poi da ricordare
che il partito, nella funzione di rappresentare interessi presenti nella società, ha in ogni caso
l’interesse primario alla propria esistenza e allargamento, anche quando ciò ha una motivazione
nobile e non quella, purtroppo diffusa e più squallida, del mantenimento di privilegi, di quote di
potere, di seggi, di prebende e vitalizi.
Non intendo qui prolungare una riflessione sui partiti, che sarebbe per altro assai urgente, perché
non è detto che i partiti debbano essere i soggetti esclusivi dell’agire politico come è stato, anche
meritoriamente, dalla nascita dei grandi partiti di massa fino ad ora. Ciò non significa che i partiti
debbano scomparire, ma che forse si devono trasformare, in modo da essere promotori dell’agire
politico degli stessi cittadini mediante le forme di aggregazione che hanno luogo nello spazio che
viene solitamente indicato come “società civile”. Ma, per capire come la presenza dei partiti – che
in realtà secondo le costituzioni contemporanee non sono veri e propri soggetti politici (cioè attori),
ma piuttosto organizzazioni che servono a dar forma al corpo rappresentativo, in cui dovrebbero
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
trovarsi i veri attori del processo di autorizzazione – renda inefficace la logica che soggiace alla
lettera della Costituzione, si pensi a cosa può significare nella attuale situazione la divisione dei
poteri, che per Kant era il requisito indispensabile di una costituzione repubblicana e dunque non
dispotica. Il Parlamento dovrebbe infatti essere l’organo che istituisce e controlla l’azione del
governo. Ma se si riflette sul fatto che le leggi del Parlamento sono il frutto della volontà concorde
della maggioranza parlamentare, il che equivale a dire delle decisioni prese, fuori dal Parlamento,
dai partiti (come mostra l’aula deserta in occasione della discussione – non della votazione – di
leggi rilevanti), quale dialettica può esserci tra questa volontà e quella che determina l’azione di
governo, se è proprio il governo il luogo in cui i partiti di maggioranza verificano quotidianamente
la loro possibilità di agire unitariamente?
Inoltre, se le cose stanno così, è proprio da meravigliarsi che le leggi le faccia il governo? Non solo
mediante i decreti legge, ma anche per quanto riguarda le leggi normali, che non a caso cambiano
con il cambiare dei governi? In uno Stato dei partiti il Parlamento riesce a svolgere la funzione di
controllo effettivo dell’operato del governo? Quando sembra che ciò succeda, in realtà si tratta della
decomposizione dei partiti di maggioranza o del loro accordo, che determina insieme crisi di
governo e crisi della maggioranza.
Queste brevi considerazioni vogliono solo indicare un compito per la riflessione. Forse è il terreno
stesso sul quale avviene la lotta politica a dover essere messo in questione. Qui sta forse il vero
problema che gli schieramenti in lotta tra loro non vedono. Se fosse così, si mostrerebbe urgente un
rinnovamento radicale del modo di pensar la politica, emergerebbe l’esigenza di nuove categorie, al
di là dei concetti che si condensano nella formula della legittimazione democratica. Innanzitutto è la
categoria del governo a dover essere pensata, come modo diverso di intendere il comando e la
dimensione politica dei cittadini, al di la della riduzione del governo a semplice “potere esecutivo”.
Una prassi di governo non può non implicare la capacità, la conoscenza, l’esperienza da parte di chi
governa, e non è pensabile se non in relazione ad un orizzonte di senso che non dipende dalla
semplice volontà e dall’arbitrio di chi governa, secondo quanto evidenzia l’antica immagine,
presente in secoli di pensiero politico, del gubernator della nave della repubblica. In che direzione
governare? Secondo quale modo di pensare la giustizia? con quale livello di azione e responsabilità
politica non solo dei governanti, ma anche dei governati? La responsabilità di chi governa e la
determinazione dell’orizzonte di giustizia all’interno del quale è vincolato il governo richiedono di
andare oltre la logica formale che determina la legittimazione democratica. In questa non sono
veramente responsabili i rappresentanti, in quanto gli autori delle loro azioni sono coloro che li
hanno eletti, ma non sono responsabili nemmeno gli elettori, perché sono autori di azioni che essi
stessi non compiono. Quale paradosso in questa forma prodotta dal moderno principio della
soggettività politica!
Pensare veramente il governo è possibile solo se si mette in discussione la certezza che la
razionalità formale propria della democrazia rappresentativa costituisca la tappa universale e
invalicabile del pensiero politico, e se si supera la convinzione che i problemi che si presentano
dipendano semplicemente dal fatto che il meccanismo della democrazia non è pienamente attuato.
Forse solo mettendo in questione la razionalità formale che soggiace alla democrazia
rappresentativa è possibile soddisfare esigenze che spesso si presentano proprio attraverso il termine
di democrazia.
Un governo unitario, che abbia autonomia nei confronti della pluralità delle forze (e anche dei
partititi), responsabile, forte e capace di decidere al di là del ricatto costituito dalle successive
elezioni, non è un’eccezione o un pericolo, ma ciò di cui c’è bisogno. La categoria del governo
esprime una funzione unitaria che è richiesta dalla pluralità costitutiva della realtà politica: implica
la pluralità contro la chiave monistica che caratterizza la sovranità. Il vero problema è come
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
concepire l’organo collegiale, il Parlamento, in modo tale che sia effettivamente superiore al
governo e riesca a controllarne e a indirizzarne l’azione mediante la determinazione di principi di
equità e giustizia. E’ in questo organo che devono essere presenti le diverse istanze della società,
secondo una pluralità che non è riducibile al pluralismo ideologico delle opinioni. Si può forse
discutere se sia il “Senato delle regioni” la via migliore per dare una forma a tale pluralità, ma
l’espressione della pluralità appare necessaria assieme alla responsabilità delle parti del Paese. E’
miope, in relazione alla realtà in cui viviamo, temere la forza del governo, come pure meravigliarsi
che sia il governo a fare le leggi. Il vero problema consiste nella forma e nelle funzioni che deve
avere l’organo più ampio e rappresentativo previsto dalla costituzione.
Accanto allora al problema di ripensare il governo con la sua responsabilità, si pone dunque il
problema di come ripensare il Parlamento. Anche in relazione alla attività legislativa si potrebbe
cominciare a riflettere se è vero, come sopra si è detto, che le leggi necessarie per governare
provengono dal governo. Forse allora vera azione legislativa del Parlamento dovrebbe riguardare le
leggi fondamentali, che danno determinazione (continua) a ciò che si considera giusto e che devono
indicare la direzione all’operare del governo. E questo è forse un compito che non può sempre
essere assolto con la regola democratica della maggioranza, che vede costantemente e
aprioristicamente contrapposte le forze in campo. E’ l’orizzonte necessario di condivisione,
all’interno del quale è possibile la vita civile, a dover essere determinato assieme dalla pluralità
delle parti, nel tentativo di trovare l’accordo piuttosto che manifestare lo scontro continuo. Si badi
bene che nel dire questo non si immagina una situazione idilliaca in cui tutti la pensano allo stesso
modo o in cui non ci sono interessi contrapposti. Al contrario, sono proprio le contrapposizioni e i
conflitti, che non possono non caratterizzare la pluralità e che hanno una loro produttività, a
richiedere, per non lacerare l’entità politica, la determinazione di un orizzonte comune; altrimenti
non si può parlare di una entità politica e nemmeno della possibilità dello stesso conflitto. E’ quello
che hanno fatto, con idee diverse e con la volontà di rappresentare parti diverse della società, i padri
costituenti uscendo dall’esperienza fascista. L’accordo è difficile, ma si pensi a quanto nel continuo
scontro tra i partiti sia dovuto ai contenuti e alle finalità che ci si propone e quanto invece al fine di
costituire il soggetto che legittimamente esercita ( e occupa) il potere. Chi pensa impossibile tendere
ad un tale accordo, non può che rifugiarsi nella logica formale della legittimazione, la quale
comporta l’assolutizzazione della volontà e dell’opinione e quella relazione maggioranza minoranza che non a caso è presente nello stesso capitolo XVI del Leviatano di Hobbes, in cui per
la prima volta ci troviamo di fronte al concetto moderno di rappresentanza politica.
Il compito di pensare lo spazio di azione politica dei cittadini (questo il vero nodo centrale di una
riflessione sulla categoria di governo), ci spinge a due ultime considerazioni, che sono in parte tra
loro collegate. La prima riguarda il fenomeno che oggi viene indicato con il termine
dell’indignazione. Gli indignados, gli indignati, il movimento delle masse che si è recentemente
manifestato nelle diverse parti del mondo. E’ un termine che ha anche una lunga storia nel pensiero
politico, si pensi ad esempio a Spinoza. Si tratta di un fenomeno rilevante, in cui compare un agire
spontaneo delle masse e un condiviso senso della giustizia, o meglio e più precisamente
dell’ingiustizia contro cui si muove. Ciò ha una forte rilevanza politica, ma che rimane solo
negativa. Anche quando compaiono esigenze largamente condivise, non compaiono in una forma
che si possa tradurre immediatamente in azione di governo, che faccia delle masse il soggetto del
governo. L’agire spontaneo delle masse esprime certo esigenze e bisogni, oltre ad un senso comune
di ciò che non è considerato giusto, ma in ogni caso implica un’azione di governo che un tale agire
non riesce a risolvere in sé. Se si pensasse che questo atteggiamento con la sua spontaneità fosse
passibile di tramutarsi in governo e le masse si tramutassero nel soggetto che governa, si perderebbe
proprio quella tensione strutturale tra governo e governati nella quale è sempre possibile e
insopprimibile l’indignazione.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Problema a questo collegato, anche se diverso, è quello delle forme di aggregazione di cittadini che,
sulla base di problemi, bisogni e interessi determinati che li riguardano, si oppongono alle decisioni
del governo. Questo fenomeno è uno spiraglio attraverso il quale si può comprendere con evidenza
la necessità di andare oltre l’attuale modo di intendere la democrazia. Sulla base di questo infatti
non si possono non considerare legittimate democraticamente le decisioni di un esecutivo che
dipende dalla maggioranza parlamentare e dunque dalla maggioranza dei voti dei cittadini, perché
proprio questo richiede la legittimazione democratica. Purtuttavia anche l’espressione della volontà
dei cittadini sembra avere a che vedere con ciò che si intende per democrazia, che sembra
promettere una partecipazione attiva dei cittadini alla politica. Ma ci si chieda come mai i cittadini
hanno una loro volontà politica di fronte ai poteri dello Stato, autonoma in quanto non riassorbita ed
espressa da quelli, solo quando resistono e manifestano contro. Ciò dipende dal fatto che nel voto,
in cui si realizza il loro diritto politico, essi, se votano, esprimono opinione e fiducia in qualcuno;
come sopra si è detto autorizzano qualcuno ad esprimere con gli altri eletti per tutti la volontà del
popolo. Il voto si basa sulle loro opinioni, ma non li coinvolge per quello che concretamente sono,
per i bisogni, gli interessi e le competenze che hanno. In base all’immaginario della distinzione di
società civile e Stato che soggiace alle costituzioni, i soggetti che manifestano una loro dimensione
politica resistendo si sentono giustificati ad esprimere la loro volontà in modo assoluto, senza
prendere parte con altri alla responsabilità della soluzione dei problemi della collettività. In tal
modo l’indignazione e la resistenza esprimono il bisogno di una politica diversa, ma, a causa di
questa assolutizzazione della volontà, rischiano di restare ancora all’interno della logica della
sovranità, che comporta una decisione assoluta e unitaria, che è insieme negazione della pluralità e
della complessità dei processi reali.
Questo fenomeno, delle aggregazioni che intendono intervenire nelle decisioni politiche, mostra un
mutamento della realtà politica, che richiede al pensiero innovazione e ripensamento della
costituzione, anche nel senso della carta costituzionale. Questi gruppi e forme di aggregazione non
tendono tanto a sostituire i rappresentanti e chi governa, o a rafforzare un partito che sentirebbero
più vicino invece che un altro: non tendono alla modificazione degli organi rappresentativi (si pensi
ai lavori di Rosanvallon). Vogliono invece direttamente contare nei confronti delle decisioni del
governo. Anche per questa appare che il problema centrale non è più quello della sovranità del
popolo e della rappresentanza politica, non è risolto dalle elezioni democratiche: insomma non è
quello della legittimazione democratica del potere. Ciò che è da pensare è invece il rapporto tra
governo e governati, e questo pensiero, se venisse portato avanti, potrebbe mostrare la necessità
intrinseca che siano i governati la dimensione politica maggiore e più rilevante, e questo non in
senso ideale, ma in quello costituzionale (nel senso etimologico del termine e anche in quello della
costituzione scritta) del concreto agire politico dei cittadini oltre il diritto politico del voto. I
cittadini non possano non essere coinvolti politicamente per quello che concretamente sono, per i
bisogni, le conoscenze e le competenze che hanno, il che non avviene certo nelle elezioni, in cui si
esprimono solo opinioni, che, in quanto tali, non possono non dipendere dai mezzi che hanno la
capacità di influenzarle e di determinarle.
In questo momento di elezioni, dove sembra che tutto dipenda dal loro esito, è importante tenere
presente queste aporie intrinseche della rappresentanza moderna. Non può non creare turbamento
alla coscienza autenticamente democratica la consapevolezza che le campagne elettorali si fanno
sulla base delle indicazioni che forniscono i guru della comunicazione, quegli stessi che si occupano
delle strategie di vendita dei prodotti nei supermercati. Ciò non significa che non ci siano ragioni e
argomenti più o meno seri e legati alla realtà e ai bisogni dei cittadini, ma - al di là di chi mostra di
ritenere che sia il dibattito democratico delle ragioni ad essere risolutivo - è evidentemente decisiva
l’immagine che si produce nella mente degli elettori, e questa immagine dipende dalle forze e dai
poteri che detengono i mezzi di comunicazione e incide sulla fantasia e sull’arbitrio,
indipendentemente dalla forza delle ragioni.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Una annotazione finale a questa riflessione, scritta prima della caduta del “governo tecnico”: quanto
è successo a seguito di questa caduta mostra che tale esperienza non ha costituito motivo di
riflessione per un mutamento nel modo di pensare la politica, per nessuno, nemmeno per chi a tale
esperienza ha dato luogo nel bene e nel male.
Il retroterra argomentativo e analitico più immediato in relazione al contenuto di queste pagine è
costituito da:
- G. Duso ( cura di), Oltre la democrazia, Carocci, Roma 2004;
- “Democrazia”, n. 3/2006 della rivista “Filosofia politica” del Mulino;
- M. Bertolisssi, G. Duso, A. Scalone, Ripensare la costituzione: la questione della pluralità,
Polimetrica, Monza 2008 www.polimetrica.com);
- M. Cacciari, G. Duso, M. Bertolissi, G. Napolitano, La costituzione domani, Marsilio, Venezia
2008 ;
- G. Duso, A. Scalone, Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni
costituzionali, Polimetrica, Monza 2010.
Giuseppe Duso è Professore ordinario di Filosofia politica all’Università degli Studi di Padova.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
L’imbarazzo dell’identità: la questione del soggetto nella
ricerca di Vincent Descombes
di RICCARDO ANTONIUCCI
Esce "Les embarras de l’identité", ultimo lavoro del filosofo francese Vincent Descombes, in cui
l’autore prosegue la sua elaborazione di una teoria complessiva del soggetto sulla base del metodo
logico-analitico. Dopo la “crisi” attraversata dalla nozione nella seconda metà del Novecento.
«Come mai, allora, cercando il proprio pensiero, la propria personalità come si cerca un oggetto
perduto, si finisce per ritrovare proprio il nostro “io” piuttosto che un altro?» chiedeva Proust.
Se è vero che la domanda primigenia della filosofia è “che cos’è?”, senz’altro la seconda (e non è
detto che non sia quella definitiva) riguarda invece il “chi?”. Forse, anzi, la questione del soggetto
(conoscente, agente…), nella sua combinazione del piano gnoseologico, etico e, non ultimo,
politico, potrebbe essere ritenuta la domanda per eccellenza della filosofia da Cartesio in poi. È
sulla base della possibilità di trovarle un ancoraggio antropologico che, nel Novecento, sono nate le
cosiddette “scienze umane”. Ed è contro questa stessa operazione, poi, che, nella seconda metà
dello stesso secolo, si è scagliato il pensiero della differenza. Senza, tuttavia, che l’intrinseco
carattere problematico della domanda si sia mai attenuato.
Questo problema, anzi questo “imbarazzo” della definizione del soggetto, Vincent Descombes l’ha
ben presente. Classe 1943, autore di un’opera dalla mole consistente cominciata a metà anni ’70 (il
primo libro, L’inconscient malgré lui, 1977, tratta di psicoanalisi) ha da poco pubblicato un ultimo
lavoro, intitolato appunto Les embarras de l’identité, in cui la questione del “chi” è ripresa per
essere affrontata in maniera trasversale, a partire dalla nozione di «identità».
In un certo senso, il libro chiude il cerchio di una ricerca il cui primo impulso risale già agli anni
‘70, all’inizio dell’attività del filosofo, come testimonia il titolo del suo secondo lavoro, Le même et
l’autre (1) (che resta la sua opera più famosa), ma che trova senz’altro il suo culmine
nell’imponente Le complement de sujet (2) dove il filosofo tenta una vera e propria “rifondazione”
della teoria del soggetto sulla base di una rilettura in chiave analitica delle maggiori concezioni
contemporanee (da Ricœur a Foucault).
Dopo una formazione avvenuta nel solco della filosofia francese degli anni ‘60-’70 (ne sono
testimonianza il libro sulla psicanalisi, Le même et l’autre), la ricerca di Descombes è segnata da
una “svolta analitica” all’altezza degli anni ’80, quando l’autore scopre Wittgenstein. Da allora il
suo lavoro transiterà per i lidi della “grammatica filosofica”(3), assumendo l’obiettivo di costituire,
a partire dal metodo logico-grammaticale, una filosofia pratica, che Descombes stesso definisce
“antropologia della modernità”.
Il suo lavoro, in effetti, non nasconde mai una forte istanza etica e politica, che in questo nuovo
libro è forse ancora più evidente che negli altri casi.
Del resto, Les embarras de l’identité prosegue di fatto la ricerca avviata con Le complement de
sujet, spostando però l’attenzione non tanto sulla definizione logico-grammaticale del soggetto, ma
sul problema pratico costituito dalla sua identificazione.
L’imbarazzo del titolo è generato dalla constatazione della confusione relativa alla nozione di
identità: dovuta, da un lato, alla mancanza di una definizione chiara del termine e, dall’altro,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
all’apparente inconciliabilità tra il concetto stesso di identità e il suo uso ordinario. Che rapporto c’è
tra il processo logico di identificazione di un oggetto e la pratica poliziesca, per esempio, di
chiedere i documenti di identità?
Per risolvere il problema, si deve scindere il significato logico di “identico” e quello invece adottato
nell’uso empirico della nozione, che ha invece a che fare un senso che Descombes definisce
“identitario”, e che è relativo alla costituzione e al mantenimento di un’identità propria. È questo
secondo senso, a prima vista opaco, che bisogna indagare. Si tratta di stabilire in che modo la
nozione di identità è applicata “in questo mondo”; in che modo sia possibile chiamare un’identità
mia oppure nostra.
L’identità come presentazione di sé
Per Descombes, che si richiama qui esplicitamente alla logica di Frege, questa possibilità è chiarita
se si intende l’identificazione come un atto di “presentazione” attraverso il nome proprio. Il senso
identitario dell’identità coincide dunque con la “presentazione si sé”. Questo atto è un
un’appropriazione dell’identità da parte del soggetto, ma anche un apprendimento di un modo di
presentazione di sé, che Descombes definisce “idioma identitario”, e che è relativo alla possibilità
di parlare di sé in quanto soggetto: di chiamarsi alla prima persona del singolare.
La presentazione di sé è da intendere come espressione della propria particolarità: «è soggettivo ciò
che, provenendo da un particolare, dice qualcosa di questo soggetto particolare perché ciò lo
esprime […] nel senso in cui è lui stesso a esprimersi attraverso il suo atto o il suo gesto, come se
parlasse alla prima persona»(4).
Ora sul piano pratico, questa particolarità si esprime concretamente nella capacità di prendere una
decisione, negli atti decisionali. Nessuno, infatti, può decidere al posto del soggetto, perché
dovrebbe allora dire “io” al posto suo.
Entro dei limiti ben precisi, tuttavia. Per Descombes, infatti, si deve evitare di concepire l’atto di
decisione del soggetto in modo troppo radicale, in una logica del fondamento che ne farebbe in
ultima istanza una decisione sull’essere del soggetto (come vorrebbe un approccio cartesiano o
post-cartesiano). Ciò significherebbe, infatti, dice l’autore, porsi la questione della decisione nei
termini di un dubbio amletico sull’essere o il non essere (se stessi). A questa operazione egli
riconduce il percorso incessantemente intrapreso dalla filosofia nel Novecento, da Heidegger a
Derrida.
Per lui, invece, la via amletica all’identità è un’impasse. Il problema è che essa risale “troppo
indietro”, scadendo nella sfera del pre-individuale, al di qua di ogni prassi possibile. Perde così ogni
contatto con quel piano normativo che presiede a ogni decisione effettiva. Quella di Amleto non
può dunque considerarsi una decisione individuante: «spogliandosi di ogni identità pratica, Amleto
si priva delle ragioni che potrebbe avere per preferire una possibilità all’altra. Ha fatto un passo di
troppo al di qua di sé stesso qualunque cosa scelga, non la sceglierà per le sue ragioni, poiché,
essendo divenuto illimitato e indeterminato nella sua identità, non ha più ragione di preferire una
cosa o l’altra» (5). Al contrario «La sola scelta che un soggetto possa esprimere è la scelta
deliberata, cioè quella che fa per le proprie ragioni» (6).
Come a dire che il fondamento è sempre già dato per il soggetto, e questi non può renderne ragione.
Al contrario, per affermarsi nella sua identità, il soggetto «deve accettare il dato di fatto ontologico
della sua individuazione» (7), che è insieme naturale e storica, ma soprattutto sempre già data. Il
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
metodo di Descombes è chiaro: l’analisi non deve oltrepassare i confini tracciati dal nostro essere
sociale. È infatti solo su questo piano che si possono stabilire dei criteri normativi di azione.
L’identità collettiva
La questione dell’identità individuale è preliminare, nel libro, all’analisi del lato più problematico
del concetto: quello dell’identità collettiva. Sul piano sociale, infatti, un’identità, è innanzitutto il
contrassegno di un’appartenenza a un insieme di individui: a un corpo sociale definito, sia esso
chiamato nazione o semplicemente comunità. «Un popolo che rivedessimo dopo due generazioni:
sono ancora i Francesi, ma non gli stessi», rifletteva Pascal (Pensées, Br. 122).
I problemi sono molti, e riguardano soprattutto il piano politico: quando l’identitario assume i tratti
dell’invenzione di una comunità immaginaria, spesso in ordine razzista del discorso.
Descombes esce dal dilemma ricorrendo ancora alla teoria dei nomi propri, da applicare questa
volta alle comunità. Il problema muta dunque i suoi termini: come si fa a comporre un’identità
collettiva a partire da se stessi?
La questione è affrontata sul piano politico. Descombes afferma che individuare il “noi” significa
fissarne i contorni, e ciò non può realizzarsi tramite un’operazione di esclusione. E infatti sostiene
che «prima di poter essere inclusivo, il “noi” […] deve essere esclusivo» (8). L’autore assume
dunque la funzione di esclusione propria della comunità politica, senza però problematizzarla come
aporia del potere (come accade ad esempio in Agamben), ma al contrario (attraverso la mediazione
della sociologia di Louis Dumont) accettandola come elemento “ineliminabile” della costituzione di
un qualsiasi corpo sociale. Anche l’identificazione del “noi” trova dunque il suo principio
nell’affermazione di un particolarismo: un particolarismo sovrano.
Ma Descombes è comunque molto lontano da una visione comunitarista o nazionalista. Il problema
della comunità deve per lui seguire il tracciato segnato da Aristotele nella Politica (1276a 10-13),
che collocava la definizione del principio dell’unità della polis non nel dato naturale dell’ethnos, ma
nel principio della politieia, che indica, in una collettività storicamente e geograficamente
determinata, una modalità specifica di riconoscimento degli individui come appartenenti allo stesso
insieme. È il principio ripreso in ambito sociologico da Marcel Mauss, nel suo articolo La nation
(9).
Nel solco di questa concezione, Descombes propone di individuare il principio di identità della
comunità in una “disposizione collettiva verso il bene”. A patto che non si intenda questo bene
come qualcosa di ontologicamente predeterminato, ma invece come oggetto di scelta contingente da
parte della collettività. In altre parole, deve essere la “volontà generale” a stabilirlo. Di
conseguenza, i criteri di identificazione collettiva cambiano e possono cambiare non solo da un
luogo a un altro, secondo i costumi di ognuno, ma anche all’interno di una città stessa, per esempio
al mutare dei regimi politici.
L’ultimo passo dell’analisi di Les embarras de l’identité attiene proprio alla questione della
“volontà generale”. Descombes ribalta la genesi di Rousseau: essa non deve essere intesa come il
prodotto di una comunità politica, ma proprio come la sua origine, nonché come il principio della
sua individuazione. La volontà generale che ha in mente Descombes, infatti, è plasmata sul concetto
di “potere istituente” formato da Cornelius Castoriadis (contrapposto a quello “costituente”):
La vita sociale non consiste nell’applicare delle regole che siano state decise in anticipo in
un’assemblea di cittadini. Conviene ribaltare la prospettiva. Se è possibile riunire un’assemblea di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
cittadini e organizzare una deliberazione comune sulla politica da seguire, è perché c’è già una vita
sociale, quella di una società già istituita. Tutto questo è reso possibile dall’esercizio di un potere
che precede ogni esercizio propriamente politico di un’autorità pubblica (10).
L’autore intende il potere istituente come la “potenza espressiva dell’individuo” realizzata su scala
sociale. Così, l’idioma identitario garantisce il passaggio dall’io al noi: «L’individuo si definisce
dichiarando ciò che, ai suoi occhi, fa parte della sua identità. Ma ciò che fa parte della sua identità è
ciò di cui lui stesso fa parte» (11).
Ricorrendo al potere istituente, può così rispondere al quesito di Pascal: «non ci si può accontentare
di ricevere una tradizione, come una sorta di lascito. Per parlare la stessa lingua dei nostri antenati,
bisogna re-istituirla, ricrearla, e questo significa che la tradizione non può essere trasmessa senza
essere, nello stesso tempo, alterata, rinnovata, trasformata» (12).
In questa conclusione si rivela tutto l’interesse politico della ricerca di Descombes. Egli sostiene,
contro la rappresentazione mitica della fondazione della comunità in una prodigiosa autoposizione
inaugurale, il paradigma rappresentato dalla «maniera in cui ciascuno esercita il potere istituente
riproducendo, e anche modificando, gli usi innumerevoli che costituiscono la cultura» (13). Questa
visione pragmatica intende in questo modo eliminare dal discorso sul potere istituente e sulla
sovranità ogni aporia dell’autoposizione della legge.
La fine dell’imbarazzo del soggetto
Ciò che colpisce nell’opera di Descombes è la sua visione d’insieme sul dibattito filosofico
contemporaneo. Dopo la svolta logico-analitica, il suo lavoro assume con consapevolezza una
posizione obliqua rispetto alla tradizione del pensiero francese del Novecento. Pur avendo rigettato
gli esiti di tale percorso, Descombes non dimentica tuttavia di provenire proprio da lì. Perciò si
rifiuta di fare tabula rasa dei problemi cari alla riflessione della filosofia francese, ma intende
proprio riprenderli e dare loro risposta attraverso un metodo analitico.
Il problema capitale, per lui, è quello della soggettività. Già in Le complement de sujet, infatti,
facendo la storia delle diverse concezioni del soggetto nella filosofia e delle critiche mosse loro,
Descombes voleva sancire la “fine delle ostilità” contro questa nozione (14). Si proponeva allora di
stabilire una «conclusione filosofica» della questione, che fosse nello stesso tempo il punto di inizio
di un nuovo modo, pacificato, di pensare. Fuori dall’aporia amletica, si potrebbe dire con i termini
del suo ultimo libro.
In effetti, sembra essere questa la cifra complessiva dell’opera di Descombes: ridurre l’aporia a un
“imbarazzo”, per poterne di trovare più facilmente la soluzione. Il filosofo lavora per costituire un
panorama conciliato e conciliante della filosofia, attraverso un approccio pragmatico e normativo
che elimina le questioni “infinite”. Lo sforzo, si deve riconoscerlo, è notevole. Resta però da
verificare se renda un’immagine fedele dello stato della riflessione contemporanea. Se, cioè,
davvero, oggi, l’essere non faccia più clamore.
(1) Vincent Descombes, Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française, Minuit,
Paris 1979.
(2) Id., Le complement de sujet. Enquête sur le fait d’agir de soi-même, Gallimard, Paris 2004.
(3) Cfr. Grammaire d’objets en tous genres, Minuit, Paris 1983.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
(4) Ivi, p. 119.
(5) Ivi, p. 130.
(6) Ivi, p. 184.
(7) Ivi, p. 168.
(8) Ivi, p. 229.
(9) La nation, in «L’année sociologique», 1953-1954, pp. 7-68; in Marcel Mauss, Oeuvres, Minuit,
Paris 1969, vol. III, pp. 573-625; tr. it. di R. di Donato, La nazione, in Marcel Mauss, I fondamenti
di un’antropologia storica, Einaudi, Torino 1998.
(10) V. Descombes, Les embarras de l’identité, cit., p. 246.
(11) Ivi, p. 253.
(12) Ivi, p. 248.
(13) Ibidem.
(14) Cfr. Le complement de sujet, cit., pp. 11 sgg.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Bellezza e città. Osservazioni sul rapporto tra estetica ed etica
negli spazi urbani
di GIACOMO FRONZI
L’estetica, intesa come disciplina filosofica, è sempre più frequentemente sollecitata a rinnovare e
aggiornare i propri strumenti d’analisi e il proprio campo d’azione. Tanto come teoria della
sensibilità (contemporanea) quanto come riflessione sulle arti non può quindi rinunciare a
riflettere sulle condizioni di vita dell’uomo d’oggi, quando su queste ultime sembrano influire
anche questioni (etiche ed estetiche) connesse all’abitare.
In apertura di una conferenza intitolata La pratica della bellezza, James Hillman lamenta il fatto che
generalmente parlare di “bello” e di “bellezza” in filosofia ha significato per troppo tempo, e in
maniera piuttosto retorica, riferirsi a una dimensione ideale, elevata, così elevata da rendere la
discussione su questi temi «noiosa, ottundente, narcotizzante». Molto più interessante potrebbe
essere, quindi, parlare di bellezza come «pratica», soprattutto in un momento storico (eravamo
all’inizio degli anni Novanta) in cui – sostiene Hillman – il represso non è ciò che abitualmente si
immagina (la violenza, la misoginia, la sessualità, l’infanzia, le emozioni, i sentimenti, lo spirito),
ma la bellezza[1]. Questa idea di repressione della bellezza sollecita l’esercizio della ricerca dei
luoghi in cui tale repressione sembra essere più vistosa, più profonda, più radicale. Lo spettro è
decisamente ampio, ma credo che uno dei contesti in cui la repressione della bellezza ha provocato
conseguenze radicali sul piano pratico, della qualità della vita e, in definitiva, etico sia la città.
Procedere in questo senso, tuttavia, comporta un ripensamento critico del profilo della città, delle
sue modalità di sviluppo, delle sue profondità, della sua anima, partendo dall’idea che essa sia il
prodotto visibile (la «parvenza sensibile», si direbbe hegelianamente) di un’idea architettonica e
urbanistica. Ciò significa collocare tali due dimensioni tecnico-pratiche lungo la linea di confine tra
l’estetica e l’etica, tra pratiche della bellezza e modalità d’esistenza, tra stili espressivi e stili di vita.
In questo quadro, componenti estetiche, etiche, politiche, sociali e funzionali si intrecciano,
acquistando un senso complessivo del tutto nuovo.
Rispetto alla connessione tra bellezza e moralità, tra estetica e comunità, è inevitabile ripartire da
un testo chiave, autentico spartiacque nella storia dell’estetica, la Critica del Giudizio (1790) di
Immanuel Kant[2]. Secondo una linea interpretativa che, tra gli altri, ha visto impegnata Hannah
Arendt (mi riferisco naturalmente alla serie di lezioni che ella tenne, nel 1970, presso la New York
School of Social Research, nelle quali si interrogò sui legami tra estetica e politica), la Critica del
Giudizio rappresenterebbe il tentativo di Kant di intraprendere un nuovo e originale percorso
rispetto a quanto aveva caratterizzato le due precedenti Critiche. Essa inaugurerebbe una
dimensione etica e intersoggettiva non più normativa, ma politica, nella quale si renderebbe
manifesto un «ripensamento complessivo della filosofia trascendentale, più precisamente […] un
ripensamento che ne [riqualificherebbe] in modo più esplicito e radicale il punto di vista,
presentandolo come uno sguardo indissociabile dal movimento di un’esperienza in atto, con un
correlativo passaggio da un pensiero che tematizza l’Uomo a un pensiero che tematizza la pluralità
degli uomini»[3].
Tale ripensamento (e il corrispondente passaggio dalla singolarità alla pluralità) è da ricondurre alla
natura del giudizio estetico (disinteressato, contemplativo, necessario e universale), il quale vale
universalmente e necessariamente senza poter essere dimostrabile logicamente, senza potersi
richiamare a un concetto dell’intelletto che dimostri questa sua universalità e necessità. Il giudizio
di gusto gode però di una particolare universalità, che non è né concettuale né oggettiva bensì
soggettiva, fondata «sulla comunicabilità del sentimento, su un “senso comune” che non deriva da
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
considerazioni d’ordine empirico-psicologico bensì dalla trama trascendentale dell’accordo
intersoggettivo che fonda la soggettività universale e necessaria del giudizio estetico»[4].
Nelle pagine kantiane della terza Critica emerge quindi un soggetto aperto e orientato verso la
comunicazione con gli altri soggetti; in esse si fa strada «una nuova teoria della soggettività
comunicabile attraverso il sentimento e non i concetti»[5]. Visto sotto questo angolo visuale, il
soggetto, senza ledere la propria e altrui individualità, è teso verso l’istituzione della comunità.
Ma oggi, i temi legati alla comunità e alla vita metropolitana, nelle loro relazioni con la dimensione
etica ed estetica, acquisiscono nuovi e inediti caratteri. Basti pensare alla positiva relazione
(perduta) tra spazi urbani ed equilibri sociali, architettonici e comunitari. Tale relazione è andata
dissolvendosi anche in connessione con l’ambigua dialettica tra apertura e chiusura, che nella
contemporaneità ha assunto caratteri quasi tragici. È nello spazio aperto o nello spazio chiuso che
meglio può generarsi la comunità? Lo spazio chiuso e delimitato favorisce la creazione di comunità,
però, al tempo stesso, segnala un bisogno di isolamento e di privacy. D’altronde, l’apertura richiama
l’idea del flusso, della mobilitazione, della comunicazione, del confronto, del transito, ma anche
l’idea dell’indistinzione e dell’indifferenza. Sebbene la megalopoli contemporanea si sia costituita
come “erede” del modello della civitas[6], l’uomo contemporaneo è posto davanti al seguente
dilemma: coltivare l’idea della pólis, della città-dimora, dello spazio ben delimitato che possa
consentire «scambi sociali, relazioni ricche e partecipate», oppure «la grande idea romana, gente
che viene da tutte la parti, che parla tutte le lingue, che ha tutte le religioni, un’unica legge però, un
senato, un imperatore e una missione?»[7]. L’attuale condizione, per la quale l’uomo non abita più
la città (della quale non esistono più i confini) ma territori, rappresenta il trionfo del cosmopolitismo
e la realizzazione del sogno di unire gli uomini in un’unica sterminata città oppure la fine di «ogni
‘forma’ comunitaria»[8]?
Nella città tradizionale vigeva la «corrispondenza tra i tempi delle funzioni dei lavori, delle
relazioni, e la qualità dell’architettura, dove l’architettura arricchiva, potenziava la qualità
dell’insieme»[9]. Lo sviluppo post-metropolitano, invece, ha distrutto questo equilibrio tra spazi,
temi, luoghi e funzioni, realizzando una falsa democrazia, abbattendo la positiva e identificativa
discontinuità degli spazi e dei volumi, favorendo una continuità che è, in realtà, appiattimento e
omologazione. Tale continuità è anche alla base dell’assenza di spazi ed oggetti architettonici
riconoscibili. Alla forma della città tradizionale si è sostituita la megalopoli informe, dove
l’elemento della misurabilità viene meno e il continuum urbanizzato favorisce la privatizzazione
dello spazio pubblico, la parcellizzazione del vuoto in spazi senza forma, negando le strutture
architettoniche urbane di tipo gerarchico, nelle quale vigano differenti relazioni di importanza
all’interno del sistema.
Sembra, dunque, che le parole chiave della nuova architettura urbana non possano che essere
discontinuità, relazionalità, polivalenza, multifunzionalità. Ma non solo. C’è anche la bellezza. Ed
esattamente al problema, esteticamente ed eticamente rilevante, della bellezza delle città si dedica,
da oltre un ventennio, Marco Romano, il quale ha elaborato un’originale teoria della bellezza
urbana[10]. Le premesse di tale teoria, secondo Romano, sono di natura osservativa e sono
incontrovertibili: tutte le città europee hanno avuto le stesse strade e piazze tematizzate, sempre lo
stesso criterio di costruzione. I temi collettivi si sono presentati, nella storia, in successione, e in
relazione ad essi ci si è posto costantemente il problema di come e in che modo disporli per poter
avere il risultato più bello, esprimendo un profondo ed evidente desiderio di bellezza. «La bellezza,
intesa come “nobile semplicità” e creativa genialità, non è un elemento supererogatorio, ma
sostanziale. Il componimento architettonico palesa i contenuti cultuali, cagiona un’esperienza
estetica, dirige gli animi verso il divino e muove i sentimenti verso la comunione fraterna»[11].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Ha ragione Romano nel sostenere che sullo sfondo dei ragionamenti sull’ecologia c’è forse da
mettere in primo piano il fatto che prima della dimensione tecnica, nella nostra vita, c’è una
dimensione simbolica. In un discorso sull’architettura e sull’urbanistica, questo significa che le
società costruiscono degli ambienti che sono appropriati alla loro organizzazione. La società
europea, sostiene Romano, ha costruito città contraddistinte da temi collettivi che ritornano in tutte
le città e che consentono ad ognuna di esse di collocarsi nella geografia europea: il palazzo
municipale, la strada monumentale, la chiesa principale, il teatro, il museo, la biblioteca, ecc. Da ciò
discende che la mobilità del cittadino europeo (e la possibilità di integrarsi con facilità in qualsiasi
città) è garantita dal fatto che egli nella nuova città riconoscerà quegli stessi temi collettivi che
aveva nella città di provenienza. Si è potuto costruire delle città belle perché si è puntato sulla
realizzazione di sequenze che articolavano in maniera coerente il tessuto urbanistico e che, grazie
alla presenza di temi collettivi analoghi a quelli presenti al centro della città, consentivano la
qualificazione delle aree più lontane dal centro, favorendo nei propri abitanti un senso di
riconoscimento e appartenenza. Esattamente al polo opposto vi è, invece, la periferia
contemporanea, intesa come zona degradata, come deserto di senso che si caratterizza proprio per
l’assenza di temi collettivi e di segni simbolici che possano definire un sentimento di appartenenza.
Sentire di appartenere a una città significa poter portare “dentro di sé” quella città, quel contesto
urbano nel quale i tracciati e gli spazi sono ben identificabili, nel quale si rende possibile ciò che la
megalopoli contemporanea nega: l’interiorizzazione, da parte dell’abitante, della mappa strutturale
della città, per poi poterla identificare con la propria mappa psichica[12].
La sfida dell’architettura contemporanea è, in fondo, quella di creare una reale condivisione, è
quella di favorire l’emergere di un sensus communis, facendo perno sulla forza di quegli elementi
simbolici che la megalopoli contemporanea non presenta, nella quale, invece, «la perdita di ‘valore
simbolico’ […] cresce proporzionalmente; assistiamo, o ci sembra di assistere, a uno sviluppo senza
meta, cioè, letteralmente, insensato, ad un processo che non presenta alcuna dimensione
‘organica’»[13]. Migliorare l’abitare, però, non significa semplicemente realizzarlo sicuro, stabile e
sostenibile, ma anche bello, sostenendo un’architettura che promuova un generale e profondo
processo tanto di rigenerazione etica quanto di «rigenerazione estetica»[14]. Bellezza e funzione
possono convergere.
Il nuovo assetto urbano e architettonico delle megalopoli contemporanee ha avuto numerose
ricadute negative, tanto a livello di efficacia puramente architettonica quanto a livello di relazioni
sociali. I timori manifestati a inizio Novecento, legati ad un irrefrenabile accrescimento del livello
di inumanità e alienazione dei rapporti umani nelle neonate metropoli, emergono chiaramente,
intrecciati in una sintesi esemplare, dalle pagine del saggio di Georg Simmel Le metropoli e la vita
dello spirito (1903). La metropoli di cui parla Simmel presenta caratteri, pericoli e patologie che, al
di là di ovvie e storiche differenze, sono riscontrabili nelle metropoli o nelle megalopoli
contemporanee. Esse, come la metropoli simmeliana, sono i luoghi all’interno dei quali le tendenze
dell’epoca presente si concentrano e si potenziano. La metropoli, sottoponendo l’uomo a inattese
esperienze, a bruschi contrasti, all’alternarsi rapido di immagini e stimoli, creando, in definitiva,
delle nuove e diverse condizioni psichiche in «profondo contrasto con la città di provincia e con la
vita di campagna»[15]. Queste differenze rivelano un carattere duplice, segnale, allo stesso tempo,
di libertà e di solitudine. L’uomo metropolitano si è liberato dalle «piccinerie» e dai «pregiudizi»
tipici dell’uomo di provincia, ma, al contempo, questa stessa libertà fa emergere una profonda
diffidenza e indifferenza tra gli individui, tra i membri di una stessa (seppure elefantiaca) comunità.
Smarrito in un oceano di indistinzione e di conformismo, l’uomo metropolitano è spinto a mettere
in risalto la propria personalità, attraverso le «eccentricità più arbitrarie», le «stravaganze
tipicamente metropolitane della ricercatezza, dei capricci, della preziosità, il cui senso non sta più
nei contenuti di tali condotte, bensì solo nell’apparire diversi, nel distinguersi e nel farsi
notare»[16].
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Lo spazio urbano contemporaneo è uno spazio de-relazionale, difficile da penetrare e comprendere,
che può essere spiegato solo facendo riferimento a categorie tra loro anche opposte. Non è più lo
spazio dai confini certi, delle gerarchie, delle transizioni “soft”, contraddistinto da una generale
monofonia. È, invece, «uno spazio polifonico fatto di situazioni differenti, in cui pezzi di territorio
si muovono, con andature e velocità diverse, intrecciandosi tra loro a diverse scale e diversi livelli,
mediante sistemi di relazioni molteplici, variabili e discontinue»[17]. Tutto è cambiato. Gli spazi
non sono più vissuti, abitati e percorsi allo stesso modo, perché non c’è più un unico modo di
viverli, abitarli e percorrerli. L’eterogeneità dei territori, la multiformità dei volumi, l’impossibilità
di concepire il «tutto unico» indicano che si è compiuto un passaggio. Non si è più attori bensì
semplici comparse, eterodirette in una dimensione incerta, fluttuante e puntiforme. In perfetta
sintonia con questi cambiamenti “strutturali” – sostiene Lidia Decandia – è entrata in crisi anche la
modalità di decodifica percettiva degli spazi che a partire dal Quattrocento ha rappresentato il modo
di leggere, interpretare e comprendere la realtà: lo sguardo prospettico: «La nostra cultura, permeata
dal pensiero visivo prospettico e abituata a leggere la città come un testo sottoponibile a un unico
sguardo, non riesce più a cogliere il senso di questa nuova geografia assurda e inafferrabile»[18]. A
questo corrisponde, poi, la differente modalità di rappresentazione e simbolizzazione di questa
nuova dimensione, nella quale «saltano evidentemente le valenze simboliche attribuite alla stessa
idea di centralità e di marginalità. Spesso sono i luoghi periferici e marginali, i territori “scartati
dalla modernità”, le aree a più denso contenuto di naturalità ad accogliere nuove funzioni
urbane»[19].
La struttura urbana, allora, non è innocente. Vi è un nesso diretto tra tipologie e modalità
dell’abitare e comportamenti sociali, un nesso tale da produrre sviluppi sociali diversi e opposti a
seconda che esso si presenti nella sua versione positiva o negativa («c’è una connessione – sostiene
Franco La Cecla – tra il modo in cui le periferie sono fatte e la bruttezza della vita sociale che
provocano»[20]). È alla relazione, intesa come orizzonte teorico e obiettivo pratico, che è doveroso
richiamarsi, allo scopo di interrompere e riconvertire dinamiche nelle quali tagli, separazioni,
chiusure, assenza di forma vengano spacciate per elogio delle differenze, e, al contrario,
l’omologazione e la mancanza di gerarchie e differenziazioni degli spazi e dei moduli vengano
spacciate per esempi di democrazia sociale ed urbana. Tanto i confini quanto le aperture non
possono e non devono venire meno, dal momento che non si dà apertura se non dei confini e non si
danno confini se non in uno spazio inutilmente illimitato. I territori vanno rivisti e rivissuti nella
loro mobilità, «elastici, deformabili, capaci di accogliersi l’un l’altro, di penetrare gli uni negli altri,
spugnosi, molluscolari. Non si tratta di un’operazione di soppressione del confine: qualsiasi corpo
presenta confini, pena l’annullarsi. Né si tratta di confondere anarchicamente le relazioni fra i
diversi tempi dei diversi luoghi. Si tratta piuttosto di accordare senza confondere, facendo vivere
l’intero nella qualità di ogni parte»[21].
Ecco perché per l’estetica, tanto come teoria della sensibilità quanto come riflessione sulle arti, non
può rinunciare a trattare le questioni connesse all’abitare, inteso come elemento fondamentale e
discriminante per il miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo.
[1] J. Hillman, La pratica della bellezza, in Id., Politica della bellezza, a cura di F. Donfrancesco, trad. it. di P.
Donfrancesco, Moretti&Vitali, Bergamo 20053, pp. 85-101.
[2] Bisogna comunque tenere presente che per Kant «la bellezza è solo un simbolo della moralità, e
tra i giudizi morali ed estetici c’è solo un rapporto di analogia. Kant trattò in modo interessante le
differenze morali ed estetiche in modi sistematicamente paralleli» (P. Pellegrino, La bellezza tra
arte e tradizione. Storia e modernità, Congedo Editore, Galatina 2008, p. 113).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
[3] P. Montani, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione, Carocci,
Roma 2007, p. 21.
[4] E. Franzini, L’estetica del Settecento, il Mulino, Bologna 1995, p. 160.
[5] V. Fazio-Allmayer, «Vico e Kant e l’universale estetico», in Id., Moralità dell’arte e altri saggi,
Sansoni, Firenze 1972, p. 83.
[6] Mentre la pólis era «fondamentalmente l’unità di persone dello stesso génos» (M. Cacciari, La
città, Pazzini Editore, Villa Verucchio 20083, p. 9), rinviando, pertanto, ad un «tutto organico» che
precede l’idea di polítes, la civitas era il risultato dell’aggregazione di persone diverse per religione,
etnia, costumi, e rappresentava un’idea che segue quella di cives. La pólis guardava al passato
(incarnato dal génos) mentre la civitas era proiettata verso il futuro: ciò che reggeva la civitas non
era «un fondamento originario quanto un obiettivo» (ivi, p. 15), un fine, quello dell’imperium sine
fine, della civitas mobilis augescens.
[7] Ivi, p. 24.
[8] Ivi, p. 55.
[9] Ivi, p. 64.
[10] Cfr. M. Romano, L’estetica della città europea. Forme e immagini, Einaudi, Torino 1993;
Costruire le città, Skira, Milano 2004; La città come opera d’arte, Einaudi, Torino 2008; Ascesa e
declino della città europea, Raffaello Cortina, Milano 2010.
[11] C. Chenis, L’architetto poeta dello spazio, in «L’Architetto», a. xvii, n. 151, novembre 2000,
p. 21.
[12] Cfr. K. Lewin, Principi di psicologia topologica, trad. it. di A. Ossicini, Organizzazioni
speciali, Firenze 1980 (2a rist.).
[13] M. Cacciari, La città, cit., p. 58.
[14] M. Romano, Costruire le città, cit., p. 19.
[15] G. Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito, trad. it. di P. Jedlowski e R. Siebert, Armando
Armando, Roma 1995, p. 36.
[16] Ivi, pp. 52-53.
[17] L. Decandia, Polifonie urbane. Oltre i confini della visione prospettica, Meltemi, Roma 2008,
p. 11.
[18] Ivi, p. 144.
[19] Ivi, p. 126.
[20] F. La Cecla, Contro l’architettura, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 60.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
[21] M. Cacciari, Nomadi in prigione, in A. Bonomi, A. Abruzzese (a cura di), La città infinita,
Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 51-59: 58.
Giacomo Fronzi (1981), dottore di ricerca in filosofia, diplomato in pianoforte. Svolge attività di
ricerca presso la cattedra di Estetica dell’Università del Salento. Tra le sue ultime pubblicazioni:
Theodor W. Adorno. Pensiero critico e musica (Mimesis 2011), John Cage. Una rivoluzione
lunga cent’anni (Mimesis 2012), Electrosound. Storia ed estetica della musica elettroacustica
(EDT 2013).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Il femminismo islamico. Una prospettiva postcoloniale
di RICCARDO ANTONIUCCI
La casa editrice La Fabrique presenta una raccolta di saggi che raccontano l’universo del
femminismo islamico inscrivendolo nel solco delle teorie postcoloniali
Femminismo islamico. Che il binomio non costituisca più un ossimoro, è l’evidenza dei fatti a dirlo:
il movimento può ormai vantare una storia ventennale di lotte, una diffusione su scala mondiale e
un’importante produzione teorica (1). Eppure, un giudizio unitario su questa corrente è ancora
lontano dall’affermarsi, e il femminismo islamico finisce per apparire, in fondo, tanto plurale
quanto eterogeneo.
È proprio questo problema di coerenza che è al centro di un recente volume collettaneo pubblicato
in Francia, con il titolo Féminismes islamiques (La Fabrique, 2012). Nel libro compaiono, fianco a
fianco, contributi teorici, firmati da alcune delle maggiori esponenti del femminismo musulmano
(Omaima Abou-Bakr, Margot Badran, Asma Barlas, Asma Lamrabet), e testi dalla prospettiva più
politica, frutto di esperienze militanti come quelle di Zainah Anwar (leader dell’associazione
“Sisters in Islam” in Malesia) Saida Kada (presidentessa della francese FFME, “Femmes Françaises
et Musulmanes Engagées”) Malika Hamidi, Hanane al-Laham, e Ziba Mir-Hosseini.
Nella maggior parte dei casi si tratta di autrici ben note al pubblico, e inoltre alcuni dei contributi
sono traduzioni di interventi già apparsi in lingua inglese. In effetti, per una volta, l’interesse del
libro si deve alla curatela, ad opera della giovane sociologa e militante Zahra Ali. La sua, infatti, è
un’impostazione forte, quasi da “manifesto”, tutta tesa a individuare una prospettiva unitaria sul
movimento. E tuttavia, il punto di vista avanzato è tutt’altro che esente da critiche.
Nella sua introduzione, Zahra Ali parte proprio dal problema della presunta contraddittorietà della
definizione del “femminismo islamico”. Si tratta, in realtà, come molte autrici hanno sottolineato, di
uscire dal pregiudizio della presunta incompatibilità delle due tradizioni (quella del femminismo e
quella della religione islamica) e di affermare la necessità di trovare un posizionamento autonomo
rispetto a entrambe. In questo modo, il movimento rivendica per sé come una “via stretta” in cui si
possano tenere insieme l’appartenenza religiosa e una prospettiva di emancipazione delle donne.
Successivamente, tentando di approfondire il senso di questo posizionamento, la lente analitica di
Zahra Ali cade sulla questione dei rapporti tra il femminismo islamico e il femminismo di matrice
occidentale. Storicamente, se non possono dirsi sempre pacifici, questi rapporti sono tuttavia meno
tesi di quanto si pensi abitualmente. Peraltro, com’è noto, il mondo arabo non è affatto estraneo a
movimenti politici fondati su principi universalistici e laici affini a quelli occidentali, e spesso legati
a prospettive politiche socialiste o comuniste (3). Ma l’intento di Féminismes islamques è
sottolineare il più nettamente possibile la singolarità del femminismo islamico, e per questo Zahra
Ali si adopera per accentuare il dato dell’estraneità del modello politico laico-universalistico
rispetto alla cultura musulmana. Ora, per rendere conto di questo rapporto l’autrice sceglie di
adottare il punto di vista del confronto tra due “mondi”, l’Occidente e l’Oriente. Il che porta in
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
primo piano, di conseguenza, la questione del colonialismo, come fondo della critica del
femminismo occidentale.
È questo indubbiamente il dato più interessante del libro: il fatto che gli strumenti per questa analisi
non vengono presi dall’interno della tradizione islamica, ma sono invece attinti dalla teoria
postcoloniale e dalla sua critica all’etnocentrismo. Il modello è la denuncia dell’organicità del
discorso femminista rispetto alla logica dell’imperialismo. Analisi che però non si applica solo ai
Paesi del cosiddetto “terzo mondo”, ma anche alle attuali società occidentali multiculturali
(l’obiettivo è sempre puntato sulla Francia), in cui si assiste alla strumentalizzazione di alcuni
argomenti tradizionali del femminismo per giustificare politiche di discriminazione delle minoranze
etniche e religiose. È quello che è accaduto, per esempio, nel caso celeberrimo della legge francese
sul velo islamico.
Così, i riferimenti spaziano da Gayatri Spivak a Chandra Mohanty. Dal classico “Three Women's
Texts and a Critique of Imperialism” (4), in cui si mostra come le teorie universalistiche del
femminismo occidentale ripetano gli assiomi dell’imperialismo, al fondamentale “Under Western
Eyes” (5), che mette in luce come sia il concetto stesso di “donna”, in quanto soggetto universale e
trascendente rispetto ai suoi attributi locali e storici, a costituire la radice dell’etnocentrismo del
femminismo occidentale, anche quando esso si pretende critico rispetto alla sua società di
riferimento.
La teoria postcoloniale insegna che la definizione dell’idea di donna nei termini tipici del
femminismo occidentale (libera, colta, padrona del proprio corpo) finisce per implicare la
produzione, per converso, di un’immagine speculare «della “donna media del terzo mondo” [che]
conduce una vita essenzialmente spezzata fra il suo genere femminile (leggi: sessualmente
costretto) e la sua appartenenza al “terzo mondo” (leggi: ignorante, povera, legata alla tradizione e
alla famiglia, vittimizzata)» (6), e quindi per rinforzare l’imperialismo occidentale. La chiave di
volta della critica femminista-postcoloniale al femminismo “classico” è costituita dalla denuncia
della pretesa di pre-determinare (aprioristicamente, etnocentricamente) la condizione della donna
non occidentale e le modalità della sua emancipazione (per esempio: la priorità politica della
questione dell’aborto, del rifiuto dei costumi tradizionali).
Richiamandosi a questo fondo teorico, Féminismes islamiques intende inscrivere il femminismo
islamico nel solco di una strategia anticoloniale. Nei termini di Zahra Ali, il movimento propone di
“decolonizzare” e di “de-essenzializzare” sia la concezione ordinaria del femminismo che quella
dell’islam: “il femminismo islamico si scontra con un duplice essenzialismo: quello che definisce
l’islam come una realtà statica, fondamentalmente dogmatica, e intrinsecamente sessista, e [quello
che propone] il femminismo [di matrice occidentale] come modello unico, avatar di una modernità
occidentale normativa” (p. 16). Parte integrante di questa visione etnocentrica è ciò che definisce
«doxa femminista – che rigetta ogni possibilità di articolazione della lotta per l’uguaglianza dei
sessi con quella per la difesa della religione musulmana». Il suo rifiuto della prospettiva femminista
occidentale è dunque anche una critica della secolarizzazione e la proposta della religione come
leva di emancipazione: «La lotta per l’emancipazione delle donne in Occidente è stata caratterizzata
da una desacralizzazione delle norme religiose, una liberalizzazione sessuale che è si è data
attraverso lo svelamento del corpo, le femministe musulmane propongono una liberazione che
propone tutt’altro rapporto al corpo e alla sessualità, un rapporto segnato da delle norme e una
sacralizzazione dell’intimità, e da una difesa del quadro familiare eterossesuale» (p. 32). In questa
prospettiva, il femminismo islamico afferma la differenza specifica della donna musulmana
credente.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Secondo Zahra Ali, queste ragioni permettono di concludere che le femministe islamiche
condividono oggi la stessa condizione delle femministe afro-americane degli anni ’70, che si
trovarono a costituire parte attiva nei movimenti antirazzisti e di liberazione dei neri negli Stati
Uniti, criticando però dall’interno la loro deriva sessista (7). Viene citato così il famoso testo
Challenging imperial feminism, di Valérie Amos et Pratibha Parmar, quando afferma chiaramente
che: «la teoria femminista mainstream, bianca […] non parla alle esperienze delle donne nere, e
quando ci prova adotta spesso ragionamenti e punti di vista razzisti» (8).
L’autrice propone quindi di leggere il femminismo islamico come una ri-attualizzazione di questo
fondamentale momento politico, che unisce intimamente lotta contro il razzismo e lotta contro il
sessismo.
Come si vede, tentando di costituire una base critica di partenza comune per il femminismo
afroamericano, anticoloniale e islamico Zahra Ali vuole andare oltre il momento critico: la sua
lettura ambisce a costituirsi come vero e proprio modello per lo sviluppo del femminismo nei paesi
non occidentali.
È su questo punto che la prospettiva di Zahra Ali si distanzia anche da quella teoria postcoloniale
che, pur riconoscendo la necessità di accompagnare al momento critico-negativo una pars
construens in cui dare un contenuto all’aspirazione e alla teoria dell’emancipazione della donna
non-occidentale, rimane tuttavia molto più legata all’imperativo teorico di tenere aperto lo spazio di
esercizio di una logica alternativa all’etnocentrismo che a quello pratico di percorrere
effettivamente, all’interno di questo spazio, una via precisa per il suo consolidamento.
Il femminismo islamico, invece, per il suo carattere primariamente militante, risponde a questo
secondo imperativo con chiarezza: affermando una prospettiva religiosa. Infatti, basandosi sulle
critiche all’universalismo etnocentrico, esso riempie la differenza specifica della donna del terzo
mondo (musulmana) con i contenuti di un islam riformato in senso egualitario. Che resta, tuttavia,
essenzialmente legato a un ordine teologico del discorso.
Il maggior pregio di Féminismes islamiques, in fondo, è proprio la nettezza delle posizioni espresse.
Eppure, il tentativo che esso mette in atto di innestare il femminismo islamico sul femminismo
postcoloniale risulta, a ben vedere, alquanto difficoltoso.
Una prima obiezione potrebbe essere, semplicemente, quella che emerge dalla constatazione che le
stesse autrici partecipanti al volume, e specialmente quelle fra loro che maggiormente si occupano
di teoria, non hanno mai esplicitato questo legame, collocando spesso, anzi, le loro riflessioni in
tutt’altri contesti filosofici.
Ma, andando più in profondità, la prospettiva “islamica e postcoloniale” lanciata da Féminismes
islamiques non può non sollevare delle questioni, che interrogano non tanto il femminismo islamico
quanto proprio l’universo delle teorie cui fa riferimento. In una prospettiva postcoloniale, ad
esempio, ci si potrebbe chiedere se la via d’uscita religiosa, ermeneutica e, in fondo, teologica, per
quanto animata da istanze progressive, sia compatibile con un approccio teorico che fa della
storicizzazione e della relativizzazione dei concetti e delle rappresentazioni il suo metodo. O, anche,
traducendo la questione sul piano pratico, si potrebbe dare risalto a tutte quelle esperienze di
autodeterminazione da parte delle donne non occidentali alternative rispetto alla scelta religiosa.
Il fatto stesso che sia emerso nel panorama filosofico questo tentativo di convergenza, comunque,
induce a riflettere sullo stato della riflessione filosofica nel femminismo. Forse sarebbe legittimo
ritenere l’operazione di Zahra Ali come un (estremo?) tentativo di rilancio di una prospettiva teorica
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
che negli ultimi tempi sembra segnare il passo, anche alla luce della “fuga in avanti” rappresentata
dalla primavera araba. Forse, però, si dovrebbe riconoscere soprattutto che l’indebolimento teorico
caratterizza in modo più evidente l’approccio laico-universalistico (repubblicano, si direbbe in
Francia), sempre più esposto al rischio di strumentalizzazione da parte delle forze reazionarie, come
è accaduto (almeno nel caso francese) nei maggiori appuntamenti politici degli ultimi tempi, dalla
legge sul velo a quella del “matrimonio per tutti”.
È così che, infine, la lettura di Féminismes islamiques spinge in realtà a domandarsi dello stato di
salute di quella concezione “critica” illuminista che pone la secolarizzazione come fondamento
dell’emancipazione (non soltanto delle donne), tentando di individuare i possibili punti di resistenza
contro la sua strumentalizzazione a fini razzisti o reazionari. Ma spinge anche a ritornare sul senso
di quella critica all’etnocentrismo occidentale, fondamentale per lo sviluppo di molti fra i più
recenti approcci di filosofia politica, a rivalutarne le condizioni di emergenza e il contesto di
affermazione. Per evitare, anche in questo caso, il rischio di una seconda strumentalizzazione,
speculare rispetto alla prima, dettata da un “essenzialismo di ritorno” non meno riduttivo
dell’occidentalismo.
NOTE
(1) Ne sono una testimonianza il Congresso Internazionale del Femminismo Islamico, organizzato
in Spagna nel 2005, 2006, 2008 e 2010, e il convegno “Feminism and Islamic Perspectives: new
Horizon of Knowledge and Reform”, proposto dal Woman and Memory Forum e tenutosi al Cairo a
marzo 2012. A parte una nutrita letteratura in inglese, è possibile consultare due importanti lavori di
sintesi sul fenomeno del femminismo islamico in lingua italiana: Renata Pepicelli, Femminismo
islamico. Corano, diritti, riforme, Carocci, Roma 2010; e Anna Vanzan, Le donne di Allah. Viaggio
nei femminismi islamici, Bruno Mondadori, Milano 2010.
(2) Il Francia il tema era già stato posto da Existe-t-il un féminisme musulman?, Paris, L'Harmattan,
2007 (atti del convegno sul femminismo islamico organizzato dalla commissione “Islam e Laicità”
dell’UNESCO nel 2006) e da due numeri monografici di rivista: « Féminismes islamiques », nella
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée n° 128, 2010, e «Le féminisme islamique
aujourd'hui», in Critique internationale, n° 46, 2010.
(3) Lo dimostra la storia dei movimenti anticoloniali sorti nel mondo arabo lungo tutto il
Novecento. Per rimanere nell’ambito delle rivendicazioni femministe, si può trovare un elenco di
alcune attiviste e teoriche arabe “laiche” in Renata Pepicelli, Islam femminista e riletture del
Corano in una galassia plurale, «Il manifesto», 09/01/2011, ripreso online in http://reteeco.it/2011/fr/documenti/35-riflessioni/18512-islam-femminista.html.
(4) Gayatri Chakravorty Spivak, Three Women's Texts and a Critique of Imperialism, in «Critical
Inquiry», n° 12, 1985, pp. 235-61. Non occorre ricordare le opere della più nota pensatrice
postcoloniale, la cui opera è tutta irrorata da una riflessione sul femminismo e sulla condizione della
donna. Risale al 1985 anche il fondamentale Can the Subaltern Speak? Speculations on WidowSacrifice, «Wedge», 1985, pp. 120-130 (reperibile anche all’indirizzo
http://www.mcgill.ca/files/crclaw-discourse/Can_the_subaltern_speak.pdf).
(5) Chandra Moanthy, «Under western eyes: feminist scholarship and colonial discourses»,
Feminist Review, n° 30, 1988, ora in Chandra Mohanty, Feminism Without Borders: Decolonizing
Theory, Practicing Solidarity, Duke University Press, 2003, pp. 17-42.
(6) Ivi, p. 22.
(7) Cfr. a questo proposito anche l’intervista http://www.contretemps.eu/interviews/«-femmesmusulmanes-sont-vraie-chance-féminisme-»-entretien-zahra-ali.
(8) Valérie Amos et Pratibha Parmar, Challenging imperial feminism, «Feminist Review», n°17,
1984, p. 4.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Una crisi italiana. Alla radice della teoria dell'autonomia del
politico
di DARIO GENTILI
La questione dell’“autonomia del politico” esplode in Italia nel corso degli anni Settanta e rientra
nel dibattito se attribuire il primato o all’organizzazione o all’autonomia, e cioè o al luogo del
conflitto (Tronti, Cacciari) o alla soggettività antagonista (Negri). Tuttavia, ciò che queste posizioni
hanno in comune è il fatto di poter essere comprese all’interno di un dispositivo della crisi.
L’ARTICOLO IN PDF
1. Dentro e contro: Tronti
Per limitare la questione dell’“autonomia del politico” nella tradizione filosofico-politica italiana a
tre autori (Mario Tronti, Antonio Negri e Massimo Cacciari) e a un arco di tempo determinato (gli
anni Settanta), prendo lo spunto iniziale da Operai e capitale. Mi riferisco in particolare al punto in
cui Tronti passa dall’analisi operaista del rapporto economico classe operaia-capitale alla proposta
politica. Innanzitutto, egli prende criticamente le distanze – anzi rovescia – il paradigma gramsciano
(fatto proprio a suo modo da Togliatti) per la conquista dell’egemonia politica da parte della classe
operaia: il passaggio politico da compiere non è tanto quello dalla classe operaia al popolo, ma,
viceversa, dal popolo alla classe operaia. Lo scopo è quello di definire l’organizzazione politica
operaia, il partito di parte operaia. Tronti scrive:
Come far funzionare il popolo dentro la classe operaia è problema tuttora reale della rivoluzione in
Italia. Non certo per conquistare la maggioranza democratica nel parlamento borghese, ma per
costruire un blocco politico di forze sociali, da usare come leva materiale per far saltare una per una
e poi tutte insieme le connessioni interne del potere politico avversario […]. Così, su questa base,
dai compiti del partito rimane escluso proprio quello che sembra averlo finora caratterizzato: il
compito di mediare i rapporti tra classi affini, e cioè tra ceti diversi, con tutte le loro ideologie, in un
sistema di alleanze.[1]
Il problema è pur sempre quello gramsciano della conquista dell’egemonia politica. Per Tronti, il
popolo – in quanto “sintesi dialettica” e, al di là delle intenzioni di Gramsci, prodotto di una cultura
della mediazione se non proprio del compromesso – non è la soluzione, perché neutralizza al suo
interno la classe operaia, l’unica contraddizione del sistema capitalistico davvero rivoluzionaria.
Eppure, come a suo modo già sapeva Gramsci, l’antagonismo della classe operaia dentro e contro il
capitale, la lotta in fabbrica, la lotta sindacale, non si traducono immediatamente in lotta per la
conquista del potere politico. C’è bisogno, a questo punto, di uscire fuori dal rapporto di produzione
capitalistico, di natura esclusivamente economica, e quindi controllabile e gestibile dalla posizione
dominante del capitale. Affinché ci sia politica, la classe deve andare contro se stessa, contro la sua
stessa natura economica: «È propriamente la separazione della classe operaia da se stessa, dal
lavoro, e quindi dal capitale. È la separazione della forza politica dalla categoria economica»[2]. E
deve rendersi autonoma: «Una separata autonomia politica dei movimenti di classe delle due parti è
tuttora il punto di partenza da imporre alla lotta: di qui, di nuovo, tutti i problemi di organizzazione
della parte operaia. Lo sforzo del capitale è di chiudere entro la relazione economica il momento
dell’antagonismo, incorporando il rapporto di classe nel rapporto capitalistico, come suo oggetto
sociale. Lo sforzo di parte operaia deve all’opposto tendere continuamente a spezzare proprio la
forma economica dell’antagonismo»[3]. Il problema politico diventa discriminante per portare
l’antagonismo dalla fabbrica alla società. Cambia il luogo, ma il soggetto deve restare lo stesso: la
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
classe operaia. E tuttavia, il rendersi autonoma della classe operaia dal rapporto economico che la
lega al capitale non ne fa immediatamente un soggetto politico. All’autonomia della classe operaia
deve corrispondere allora un’organizzazione politica dove possa aver luogo la sua soggettivazione
politica senza neutralizzarne – come popolo – la peculiarità dell’antagonismo. Questo luogo però
non può essere – o non è più – la fabbrica, dove la forma di antagonismo è ormai esclusivamente
economica. Stringere insieme classe operaia, antagonismo e organizzazione politica: ecco il
compito.
È possibile tuttavia pensare la classe operaia al di fuori della fabbrica, come soggetto politico
autonomo, senza scendere a compromessi con la forma-popolo e senza accettare le logiche
democratiche e riformistiche che la ridurrebbero a una parte tra le altre, che deve negoziare il
proprio “interesse di parte” in nome dell’interesse generale? Può la società, ambito costituito e
dominato dalla tendenza uniformante delle ideologie borghesi, dar luogo al conflitto di due parti?
Che ne sarebbe, infine, della classe operaia al di fuori del contesto determinato in cui ha luogo
quella forma di antagonismo che ne determina la soggettivazione? Queste sono le questioni che
Operai e capitale lascia sul terreno del dibattito filosofico e politico del marxismo italiano, e non
solo[4]. Se con la teorizzazione della centralità della classe operaia di fabbrica e con la
determinazione del soggetto antagonista Tronti ha definito le peculiarità di una scienza operaia, ha
invece dovuto riscontrare la difficoltà di trasporre tutto ciò a livello di organizzazione politica. “La
classe operaia è il segreto del capitalismo”, segreto che la scienza operaia ha svelato[5]; resta
tuttavia da svelare il segreto del Politico, che non è – come insegna, per Tronti, la regola dei
fallimenti delle iniziative politiche operaie, la cui unica eccezione è la rivoluzione d’Ottobre – a
disposizione della scienza operaia. Il segreto del successo politico di Lenin non va ricercato
nell’esperienza delle lotte operaie, bensì nella grande tradizione del realismo politico, appannaggio
della classe avversa. Siamo nel 1970 e, nel Poscritto di problemi aggiunto alla seconda edizione di
Operai e capitale, si sta consumando la deviazione di Tronti dall’operaismo degli anni Sessanta –
deviazione che non implica affatto un disconoscimento delle sue conquiste teoriche, bensì la
consapevolezza che, per poter proseguire la ricerca all’altezza della politica, bisogna trasporla su un
altro piano:
Contrapponendo un tipo di organizzazione all’altro, Lenin elabora la teoria di entrambi. Ne aveva
bisogno, perché il suo discorso era veramente tutto politico, non partiva dalle lotte, non voleva
partirci, la sua logica era fondata su un concetto di razionalità politica assolutamente autonoma da
tutto, indipendente dallo stesso interesse di classe, comune semmai alle due classi, il suo partito non
era l’anti-stato; anche prima della presa del potere era l’unico vero stato della vera società. […] Pur
senza essere mosso dalla spinta della lotta operaia, Lenin centra in pieno le leggi della sua azione
politica. Per questa via subisce un processo di rifondazione, da un punto di vista operaio, il concetto
borghese classico di autonomia della politica.[6]
La fase operaista di Tronti – e il cosiddetto primo operaismo – si esaurisce con la conclusione
dell’esperienza della rivista “classe operaia”, nel 1967[7]. Dopo quegli ultimi bagliori di “vera”
politica (nota bene: prima del ’68) inizia il suo lungo tramonto[8], cominciato proprio con
l’indebolirsi e il disgregarsi della concentrazione di luogo, epoca e soggettività antagonista. Sul
piano teorico, dunque, il primo operaismo si esaurisce con la rottura dell’unità di soggetto
antagonista e luogo dove tale antagonismo si mostra nella massima intensità, la fabbrica. È la fine
dell’epoca della forma di produzione fordista – e, con essa, dell’epoca moderna stessa – a
determinare l’estinguersi della figura storica dell’operaio della fabbrica fordista, il cosiddetto
operaio-massa. In fondo, è la collocazione del conflitto a sembrare prioritaria rispetto
all’individuazione della soggettività antagonista. Anzi, una soggettività antagonista è stata possibile
finché la fabbrica era ancora luogo di soggettivazione politica[9]; ha avuto una potenzialità politica
finché la fabbrica era ancora luogo di divisione e, al contempo, di aggregazione sociale, finché
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
soddisfaceva il criterio del politico: quel “criterio” che definisce crisi e scissione come costitutive
del politico. Il criterio del politico è dunque la contrapposizione più intensa amico-nemico[10]; ed è
stato pienamente soddisfatto finché, in fabbrica, Lenin ha incontrato Carl Schmitt, la lotta di classe
il realismo politico: «La contrapposizione è la più intensa ed estrema di tutte e ogni altra
contrapposizione concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al punto estremo, quello del
raggruppamento in base ai concetti amico-nemico»[11]. Ecco perché Tronti, in conclusione al
Poscritto di Operai e capitale, critica le posizioni di coloro che vogliono collocare la classe operaia
dopo e fuori la fabbrica. Ma non solo. La critica più sottile e profonda è rivolta alla possibilità di
rintracciare un’altra “definizione oggettiva” della soggettività antagonista al di fuori della classe
operaia caratterizzata dall’operaio-massa:
Si può, ad esempio, abbandonare una definizione “oggettiva” di classe operaia? E definire “classe
operaia” tutti quelli che lottano soggettivamente in forme operaie contro il capitale dall’interno del
processo di produzione sociale? […] Vanificare la materialità oggettiva della classe operaia in pure
forme soggettive di lotta anticapitalista è appunto un errore di nuovo ideologico del neoestremismo.
Non solo. Ampliare i confini sociologici della classe operaia per includervi tutti coloro che lottano
contro il capitale dal suo interno, fino a raggiungere la maggioranza quantitativa della forza-lavoro
sociale, e addirittura della popolazione attiva, è una grave concessione alle tradizioni
democratiche.[12]
Per Tronti, invece, il problema non è tanto quello dell’individuazione di una nuova soggettività
antagonista, quanto piuttosto quello di una nuova collocazione del conflitto, all’altezza stavolta
della tradizione del realismo politico, del Politico moderno. Il passo che lo condurrà a tematizzare
l’“autonomia del Politico” è, a questo punto, davvero breve.
2. Contro e fuori: Negri
Le nuove soggettività antagoniste sono figlie della crisi economica. Sotto la pressione del
succedersi continuo delle crisi, la produzione – e con essa il rapporto più intensamente
antagonistico capitale-classe operaia – abbandona la fabbrica fordista come suo luogo privilegiato e
investe l’intera società: il soggetto della crisi non può essere più l’operaio-massa di Tronti, ma
diventa l’operaio sociale. Durante gli anni Settanta, è Antonio Negri a essere impegnato nel
delineare la figura dell’operaio sociale e, di conseguenza, a marcare la discontinuità rispetto alla
fase del primo operaismo. Ecco come, in Proletari e Stato del 1976, Negri delinea il passaggio
dall’operaio massa all’operaio sociale:
È un’ipotesi sconvolgente quella che comincia a configurarsi, la categoria “classe operaia” va in
crisi ma continua a produrre tutti gli effetti che gli sono propri sul terreno sociale intero, come
proletariato. […] Dopo che il proletariato si era fatto operaio, ora il processo è inverso: l’operaio si
fa operaio terziario, operaio sociale, operaio proletario, proletario. […] Avevamo visto l’operaiomassa (prima concretizzazione massificata dell’astrazione capitalistica del lavoro) produrre la crisi.
Ora vediamo la ristrutturazione che, lungi dal superare la crisi, ne distende e allunga l’ombra su
tutta la società.[13]
Non è semplicemente il passaggio dall’operaio massa all’operaio sociale a determinare la
deviazione di Negri dalle posizioni del Tronti di Operai e capitale, anzi è evidente l’intento di
avvalersi del metodo operaista: la precedenza delle lotte operaie – quelle dell’operaio massa dei
primi anni Sessanta – rispetto alla ristrutturazione capitalista è pienamente rispettata; come è in
accordo con l’insegnamento operaista ritornare, in seguito alla trasformazione del modo di
produzione capitalistico che stava avvenendo in quegli anni, ad analizzare la composizione di classe
operaia. Anche la problematica rimane la stessa: individuare il soggetto antagonista. Che cosa
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
emerge allora nell’operaio sociale di così radicalmente divergente dalla precedente analisi operaista
della composizione di classe, tanto che lo stesso Negri scrive vent’anni dopo di averne introdotto la
figura in modo, a volte, “troppo timido”[14]? È il termine stesso, “operaio sociale”, che, come
“fabbrica sociale”, lo spiega: è un ossimoro, sosterrebbe Tronti, per il quale la classe operaia e la
fabbrica si oppongono radicalmente a ogni dimensione sociale e a ogni possibile assorbimento nella
società. Per Tronti, infatti, la società è la dimensione dell’ideologia borghese, che neutralizza il
conflitto e l’antagonismo: nella società il punto di vista di parte operaia viene compreso all’interno
dell’idea sintetica di popolo. Magari anche Tronti ha riconosciuto il dissolversi della fabbrica nella
società, ma, a differenza di Negri, vi ha visto il tramonto definitivo della classe operaia e non, con la
sua proletarizzazione, una nuova potenzialità politica. Politica si poteva dare nella fabbrica in
quanto luogo in cui si concretizzava il criterio schmittiano del politico come contrapposizione
amico-nemico; la società – come la forma politica a essa corrispondente, la democrazia moderna –
ne è esattamente l’opposto: un non-luogo. In essa è impossibile prendere parte e partito in quanto
per Tronti ciò equivale a dar luogo al conflitto. È nel passaggio al postfordismo che si compie
quindi il tramonto della politica; infatti, in quanto movimento generato e diffuso nella società, il ’68
rappresenta, per Tronti, un’accelerazione della ristrutturazione capitalistica. Negli stessi anni in cui
Negri teorizza con la figura dell’operaio sociale una soggettività antagonista fuori dalla fabbrica,
Tronti continua quella ricerca di una politica operaia che aveva lasciato in sospeso nel Poscritto di
Operai e capitale, con la consapevolezza qui acquisita che, mentre il segreto del capitalismo è stato
svelato dalle lotte della classe operaia, il segreto della politica è custodito nella teoria e nei luoghi
appannaggio del nemico di classe. Il presupposto indiscusso è che vera politica si dia
esclusivamente nelle modalità e nei luoghi della politica moderna e, quindi, l’unico modo per la
classe operaia di conquistare davvero l’autonomia politica e uscire dall’aporia in cui la costringeva
il rapporto economico di fabbrica – essere dentro e contro il capitale – è farsi Stato. Ecco
configurarsi la svolta trontiana degli anni Settanta, ecco l’autonomia del Politico:
L’obiettivo è quello di ricreare un effettivo dualismo di potere; però in grande, non più nella
fabbrica, cioè non più nel rapporto di produzione, e neppure più nella società, ma addirittura tra
società e stato. Per concludere. L’autonomia del politico risulta addirittura un’utopia, una volta
presa come progetto politico direttamente capitalistico; risulta addirittura l’ultima delle ideologie
borghesi; diventa realizzabile, forse, soltanto come rivendicazione operaia. Lo stato moderno
risulta, a questo punto, nientemeno che la moderna forma di organizzazione autonoma della classe
operaia.[15]
Non potrebbe esserci distanza maggiore rispetto a quanto Negri scriveva in quegli stessi anni; anzi,
le concezioni della politica che ne scaturiscono sono esattamente agli antipodi: sebbene per
entrambi lo Stato sia il luogo del potere, per Tronti, la politica è essenzialmente scontro per il
potere che si svolge quindi a livello del Politico, dello Stato; per Negri, al contrario, politica è la
potenza immanente alla dimensione sociale, che si contrappone al potere dello Stato, la cui funzione
capitalistica – e quindi di parte – è ormai pienamente manifesta. Negri rivendica allora
un’autonomia operaia proprio dallo Stato in quanto “impresa capitalista”, in quanto forma del
dominio e del controllo del capitale sulla società, quella società che invece diventa
progressivamente il terreno di germinazione dei nuovi antagonismi. Ed è, infatti, fuori dalla
fabbrica, nella società, che si vanno formando le nuove soggettività antagoniste ed è sempre dentro
la società che si creano nuove potenzialità politiche[16]. Scrive Negri in Proletari e Stato: «A
questo punto qualsiasi operazione trasformistica a livello di “autonomia del politico” cozza contro
l’irrealtà della categoria, contro la sua mera adeguatezza all’ideologia e alla pratica mistificatoria
del capitale. Un uso operaio delle istituzioni statali è oggi inconcepibile»[17]. E ancora, in Il
dominio e il sabotaggio, dove si congeda esplicitamente da Tronti: «Dice bene l’ultimo Tronti che
lo Stato moderno è la forma politica dell’autonomia della classe operaia. Ma in che senso? Nel
senso, anche per lui, del suo rinverdito “socialismo”, di compatibilità e convergenza? No davvero,
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
caro compagno: qui la metodologia della critica dell’economia politica va modificata a partire
dall’autovalorizzazione proletaria, dalla sua separatezza, dagli effetti di sabotaggio che
determina»[18].
Lo schema trontiano del lavoro di fabbrica, “dentro e contro il capitale”, per Negri, non può più
funzionare, tantomeno come presupposto per la determinazione di una soggettività politica,
soprattutto se pensata con i criteri della politica moderna. Il processo di soggettivazione che aveva
luogo in fabbrica determinava, infatti, un soggetto omogeneo e uniforme: la classe operaia. Il nuovo
soggetto di Negri, invece, si costituisce politicamente fuori dalla fabbrica e dentro la società
capitalistica in quanto spazio della produzione dove sono messe a lavoro la conoscenza e le capacità
relazionali (quel General Intellect su cui si concentrerà la riflessione post-operaista). La nuova
soggettività assume pertanto proprio quel carattere “plurale”, “multilaterale” e “differenziato” che
per Tronti è il contrassegno del sociale in contrapposizione al politico. Ma il criterio del politico
moderno per Negri è ormai inefficace; non è più la contrapposizione il criterio della soggettivazione
politica operaia, bensì la separazione: «Dentro quest’intensità della separazione c’è il massimo di
libertà. L’individuo sociale è la multilateralità. Il massimo di differenza è il più alto approccio al
comunismo. […] Ogni omogeneità è dissolta. Lo schema metodologico “plurale”, multilaterale,
trionfa»[19]. Il nuovo soggetto antagonista non ha bisogno del nemico di classe per definirsi, non è
nella contrapposizione che si valorizza politicamente: si autovalorizza, è autonomo. Il criterio del
politico moderno non può più fare da riferimento per un uso operaio della crisi perché non ha più
presa su una realtà economica e sociale ormai postfordista e postmoderna. È il capitale piuttosto ad
avvalersi del “criterio del politico”, ad aver bisogno della dialettica amico-nemico, della negazione
da togliere nella sintesi, della crisi da superare con lo sviluppo. Inoltre, come non è da dentro il
capitalismo fordista che il soggetto antagonista si definisce, è nemmeno da dentro il corrispettivo
pensiero borghese che si costituisce un pensiero antagonista, un “pensiero negativo”. Non il
rovesciamento dall’interno, bensì la separazione è la prassi politico-teorica dei nuovi antagonismi:
Si tratta di cogliere il progresso dell’accumulazione capitalistica in forma rovesciata. Ma non c’è
possibilità di farlo se questo concetto di rovesciamento non viene ridotto a quello di separazione. Il
rapporto di capitale è un rapporto di forza che si tende verso l’esistenza separata e indipendente del
suo nemico: il processo di autovalorizzazione operaia, la dinamica del comunismo. L’antagonismo
non è più una forma della dialettica: la sua negazione. Si parla tanto di “pensiero negativo”: bene,
il pensiero negativo è – strappato dalle sue origini borghesi – un elemento fondamentale del punto
di vista operaio. Cominciamo ad usarlo, anziché nella critica dell’ideologia, nella critica
dell’economia politica.[20]
C’è da chiedersi – e Negri se lo chiede in conclusione di Marx oltre Marx – se il dispositivo della
crisi, fondamentale per manifestare e radicalizzare il dualismo di potere insito nel sistema
capitalistico, e così porre il conflitto, non debba essere abbandonato nel momento in cui si cerca,
attraverso la pratica della separazione, di affermare l’autonomia e l’antagonismo del potere
costituente della nuova soggettività al di fuori della dinamica binaria e, quindi, al di fuori del
legame costitutivo con il nemico di classe. La crisi è l’inizio, rappresenta l’occasione e l’opportunità
per uscire dal sistema capitalistico-borghese. Perché la via d’uscita indicata dalla crisi possa essere
percorsa bisogna, al contempo, che qui e ora sia determinato un fuori, un altrove: Negri schiva così
il problema – l’individuazione e la determinazione del luogo del conflitto – che ha indotto Tronti a
cercare nello Stato le potenzialità di conflitto politico che la fabbrica e poi il partito avevano
perduto. È su questo passaggio, il passaggio dalla logica del “dentro e contro” il capitale a quella
del “contro e fuori” il capitale – tra le quali intercorre lo scarto decisivo fra pensiero della crisi e
autonomia del potere costituente – che si gioca la sfida teorica di Negri sia all’operaismo di Tronti
sia al “pensiero negativo” di Massimo Cacciari: «Su questo passaggio, dentro questo metodo la
soggettività operaia diviene classe rivoluzionaria, classe universale. Su questo passaggio il processo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
costitutivo del comunismo si sviluppa con pienezza. E va subito sottolineato che, posta in questa
luce, la logica antagonistica smette di svolgersi su un ritmo binario, smette anche di accettare la
realtà fantasmatica dell’avversario sul suo orizzonte. Cancella la dialettica anche solo come
orizzonte. Rifugge ogni formula binaria»[21]. Ci sarebbe da chiedersi, tuttavia, come farò in
conclusione, se il dispositivo della crisi renda effettivamente possibile il passaggio dalla decisione
di separazione alla decisione di autonomia di una parte rispetto all’altra.
3. Dentro è contro: Cacciari
Nel 1977, in Pensiero negativo e razionalizzazione, sembra quasi che Massimo Cacciari anticipi la
risposta alla critica che Negri gli avrebbe mosso nelle conclusioni di Marx oltre Marx; se – come lo
stesso Negri arriva a sostenere seppure in senso riduttivo – il “pensiero negativo” rappresenta la
“teoria” della crisi, per Cacciari è proprio questa teoria, cioè la “critica della sintesi dialettica”,
l’essenza della crisi. La critica dell’economia politica, dunque, ne è soltanto la conseguenza: «La
crisi della sintesi classica è ben più radicale della crisi della political economy. Essa è altresì la crisi
di ogni “teoria generale” del Politico. La critica della economia politica non si “avvera” nel
Politico, ma nella critica del Politico. Se qui riscontriamo le “assenze” più significative nella stessa
teoria marxiana, a maggior ragione concepire tale critica è oggi finalmente il problema»[22]. La
critica dell’economia politica si basa sul medesimo presupposto di Negri: lo sviluppo come risposta
alla crisi non ne comporta il superamento dialettico; anzi, la sintesi dialettica fallisce come
riequilibrio del sistema: è infatti come squilibrio che si ristabilisce il ciclo capitalista. Tuttavia, per
Cacciari, a differenza di Negri, la crisi non rappresenta l’esplosione della contraddizione
fondamentale intrinseca al sistema capitalistico a cui il potere operaio deve imporre il proprio,
autonomo “uso politico”: potere contro potere, ovvero potenza del sociale contro potere del
politico. Il dispositivo della crisi, piuttosto, è già tutto compreso nella dimensione del Politico
moderno: nulla resta al di fuori di esso e, quindi, nessuna via d’uscita. La decisione che
dall’antagonismo conduce all’autonomia resta dentro la crisi, non ne fuoriesce. La crisi ha sì
travalicato i confini dell’economico, e in particolare l’ambito della “produzione immediata”,
permeando la totalità del sistema – tanto che il capitale stesso ha imparato a farne un uso politico –
ma appunto per questo la conflittualità che si produce e si diffonde al suo interno non può essere
agita dal di fuori. La critica del Politico, per Cacciari, non rappresenta allora un ambito tra gli altri,
ma denomina la condizione stessa di conflittualità, immanente al sistema. Se il Politico moderno
definisce con Hegel il proprio vertice prospettico nella Forma che supera le contraddizioni e toglie
il conflitto, la critica del Politico mostra l’impossibilità di tale Forma e l’irriducibilità del conflitto –
anzi, rappresentando il Politico la sintesi dialettica per eccellenza, la sua critica diventa critica di
ogni pretesa di sintesi.
La triade filosofica del pensiero negativo è composta, nell’ordine, da Schopenhauer, Kierkegaard e
Nietzsche. Ma è con Nietzsche che si raggiunge l’esito estremo: «La sintesi è divenuta per
Nietzsche soltanto il dominio, la vittoria della più “perfetta” volontà che agisce nella pura
immanenza. Tale sintesi non avrà, quindi, alcun carattere di “valore”, non cercherà alcuna
“giustificazione” nell’universale – sarà, anzi, il rifiuto di ogni valore, sia estetico, che etico, che
religioso»[23]. La “volontà di potenza” nietzschiana rappresenta pertanto la s-valutazione di ogni
valore e l’assunzione consapevole del potere – e non della potenza come invece sostiene Negri[24]
– in quanto capacità di dominio non sul mondo, che comporta ancora la Sintesi dialettica del
Soggetto, bensì nel mondo: “pura immanenza”. Nietzsche è oltre sia rispetto alla Volontà come
“rinuncia” al mondo di Schopenhauer, sia rispetto al Singolo di Kierkegaard che trascende il mondo
nel Religioso. “Potere è integrarsi nel sistema”, scrive Cacciari in Krisis, il libro del 1976 dove si
conclude e si compie la sua ricerca sul pensiero negativo. Ma per integrarsi nel sistema nulla deve
rimanerne fuori, nulla può affermarsi come “autonomo”: neanche il Soggetto. L’“organizzazione”
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
si afferma sull’autonomia. Perché il suo potere sia pienamente dispiegato, il Soggetto stesso deve
perdere la propria posizione privilegiata, la propria “autonomia”:
Il soggetto pare così ritrovarsi in una situazione paradossale. Da una parte, esso riscopre una sua
funzione attiva, “creativa”, prima impensabile – dall’altra, però, perde qualsiasi posizione
“prospettica”, qualsiasi “privilegio” gnoseologico. Esso pone il sistema nella sua dinamica e
contraddittorietà – ma, insieme, non ne risulta più in alcun modo distinguibile. […] Ma ponendo
tale processo, il soggetto ha perduto ogni auratica “autonomia”, ne è divenuto parte, proprietà. […]
Potere è integrarsi nel sistema.[25]
Non è più pensabile nessuna soggettività al di fuori del sistema; la decisione del soggetto che, alla
Schmitt, deve imporvi la propria sovranità non mostra altro che l’ineffettualità di tale decisione. La
crisi del Politico moderno produce il Sistema di Potere. Ma non solo: essendo le prerogative
soggettive di trasformazione, innovazione, produzione, creazione – di antagonismo stesso – passate
al Sistema, quest’ultimo è caratterizzato da conflitto e crisi: è a questo potere che si partecipa
integrandosi nel sistema. Non è più il soggetto a essere antagonista, lo è il sistema stesso; non c’è
conflitto fuori dal sistema: dentro è contro. E tuttavia, in quanto Soggetto, proprio garantendo la
conflittualità al suo interno, il Sistema la sussume e la domina. Il problema che l’esito del pensiero
negativo lascia aperto è dunque: è possibile una politica rivoluzionaria – o almeno la decisione per
una politica di innovazione all’interno di un Sistema politico la cui organizzazione converte, pur
senza risolverlo e superarlo, il conflitto in conservazione? In che modo una soggettività che non ha
più potere sul sistema, pur partecipando alla sua conflittualità, può decidere e rendere effettuali le
proprie rivendicazioni? Insomma, dal momento che il disincantamento non trasforma il sistema in
quanto tale, come si può invertire il segno conservatore delle trans-formazioni al suo interno? È
questo il problema di Krisis: «Il problema è: come [il soggetto] vi partecipa?, perché, con quale
scopo? […] In che misura e in che modo [le forme di questa sua “partecipazione”] sono ancora
effettuali? Con quali parametri andrà ora misurata questa effettualità? Il nihilismo radicale può
giungere fino a quel “disincantamento” – ma non può affrontare e tantomeno risolvere queste
domande»[26]. Sono domande “politiche”, queste, che tuttavia non sono rivolte ad alcuna
soggettività politica, vecchia o nuova che sia. Weber ha infatti integrato compiutamente il Soggetto
politico all’interno del sistema, facendone una sua funzione a discapito di ogni sua “qualità”: il
politico diventa “funzionario” e quello dell’intellettuale è un Beruf, una “professione”.
Se il Politico è per coerenza “funzionale” all’amministrazione del sistema; se, parafrasando il
Wittgenstein del Tractatus, fondamentale in Krisis, “su ciò di cui non si può parlare – su ciò che
non è integrato nel sistema – si deve tacere”, come può darsi trasformazione innovatrice entro questi
limiti? Ovvero: come pensare la crisi non in quanto conservazione, oltre quindi lo stesso pensiero
negativo? L’esito sul piano della critica del Politico moderno, del tutto corrispondente a quello di
Krisis sul piano logico-epistemologico, è rappresentato dall’Impolitico, che, in Dialettica e critica
del Politico (1978), rappresenta la “soluzione” nietzschiana alla crisi dello Stato dialettico
hegeliano: «L’impolitico nietzschiano è […] critica del Politico. Che nessun soggetto e nessuna
Verità si esprimano nello Stato non comporta l’utopia del Singolo – ma il problema della grande
Politica. […] Ma proprio perché il Politico non appare più come il Linguaggio capace di pro-durre
nello Stato la Verità del soggetto, questo Stato è trasformabile – quel Politico è continua
rivoluzione delle sue forme»[27]. Il Politico si è compiuto in Hegel, nello Stato dialettico; una volta
constatata la sua crisi irreversibile e l’irresolubilità delle sue contraddizioni (di classe, prima di
tutto), non resta che l’Impolitico come critica di ogni ritorno del Politico in quanto Sintesi e Valore
e, di conseguenza, l’assunzione della trasformabilità dall’interno dello Stato. Sembrerebbe quasi
che, seppur seguendo una linea in origine diversa, Cacciari finisca per convergere, almeno nell’esito
politico, sulle posizioni del Tronti di Sull’autonomia del politico. Eppure, la concezione di Cacciari
dell’autonomia del politico si differenzia per diversi aspetti da quella trontiana, ma principalmente
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
perché non conferisce alcun primato al Politico, ma rappresenta piuttosto una modalità del discorso
sull’impolitico, come si può evincere da questo passo dell’Introduzione a Pensiero negativo e
razionalizzazione:
Autonomia del Politico e sua ri-definizione (nel senso suddetto del termine) costituiscono, dunque,
il tema obbligato di ogni introduzione al problema storico del Politico. L’“autonomia” di cui “gode”
non conferisce al Politico alcuno statuto prospettico privilegiato. Essa definisce la particolarità delle
funzioni, il “valore” delle funzioni, che esso è chiamato a svolgere nei confronti e a causa delle
limitazioni intrinseche agli altri elementi del sistema. Senza tali limitazioni, e dunque senza tali
elementi, non si darebbe “autonomia” del Politico. Un sistema complesso di “autonomie”, del quale
differenze-conflitti-contraddizioni non sono che “altri nomi”, subentra alla struttura omogenea e
centripeta della Rationalisierung dialettica. Il Politico è-in questo universo.[28]
Il Politico è un elemento tra gli altri dentro il sistema; ogni elemento ha una propria “autonomia” in
conflitto con quella degli altri, che ne limita le pretese egemoniche. In sostanza, il Politico non può
rappresentare il luogo per eccellenza del conflitto per il potere, perché il conflitto è tra le diverse
“autonomie” poste sul medesimo piano, all’interno del sistema: insomma, l’autonomia del politico
di Cacciari non colloca lo Stato nel luogo centrale che invece vi attribuiva il Politico moderno. Si
potrebbe anzi sostenere che, nella sua crisi, il Politico moderno si sia diviso in due e lo Stato
corrisponde alla sua unica collocazione possibile, quella burocratico-amministrativa, mentre l’altra,
quella del progetto rivoluzionario, è pura Utopia: ou-topia, non-luogo[29]. Quello di cui scrive
Cacciari è dunque lo Stato che risulta dalla crisi del Politico moderno. È l’organizzazione dispiegata
– sulla scorta di Heidegger – dalla Tecnica che si fa politica: organizzazione funzionale non alla
conquista del Potere, bensì a che nessuna forma di potere si possa sottrarre alla trans-formazione e
imporsi così sulle altre. Soltanto all’interno di tale organizzazione della crisi – logicoepistemologica e statuale – si danno autonomie e antagonismi[30].
***
Nel corso degli anni Settanta, in Italia, come risulta dall’itinerario attraverso il pensiero di Tronti,
Cacciari e Negri che ho provato a tracciare, la questione dell’“autonomia del politico” viene
compresa all’interno del dibattito sul primato da attribuire all’organizzazione o all’autonomia –
ovvero sul primato politico da attribuire al luogo del conflitto (Tronti, Cacciari) o alla soggettività
antagonista (Negri). Tuttavia, ciò che hanno in comune ognuna di queste posizioni è il fatto di
essere comprese all’interno di quello che ho chiamato dispositivo della crisi; un dispositivo la cui
influenza, nel pensiero filosofico e politico italiano, travalica l’arco di tempo preso in
considerazione, arrivando fino a oggi. In che cosa consiste il dispositivo della crisi? L’analisi
etimologica del termine “crisi” può fornire indicazioni importanti. In greco, krisis significa: “forza
distintiva, separazione, scissione”; ma anche: “decisione, risoluzione, giudizio, elezione, scelta”. Ne
risulta che: la “scelta” di un aspetto rispetto all’altro che la “separazione” della krisis
“distingue”, il tentativo di “risolvere” la crisi, non rappresenta affatto l’uscita dalla crisi, ma ne
resta all’interno in quanto suo elemento costitutivo. Vengo adesso alla nostra questione. La crisi è
la condizione di possibilità dell’autonomia del politico, il presupposto su cui poggia ogni
collocazione del conflitto. Prima di ogni autonomia del politico – prima cioè dell’individuazione del
luogo dove il conflitto produce soggettivazione politica – c’è una divisione, una separazione in due
parti: ecco la crisi. E tuttavia, il dispositivo della crisi comprende anche la decisione per
fuoriuscirne, non esclusa quella finalizzata all’autonomia e all’autovalorizzazione del soggetto, che
vi resta altrettanto implicata. Ogni decisione pone dunque un’ulteriore separazione e un ulteriore
dualismo: un’ulteriore crisi – e così all’infinito. La soluzione della crisi è pertanto indistinguibile
dalla produzione stessa di crisi. Certo, di contro a tante concezioni tecnocratiche e procedurali della
politica, il dispositivo della crisi contempla il carattere produttivo del conflitto. Ma se, catturato
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
all’interno del dispositivo della crisi, il conflitto fosse funzionale soltanto alla produzione di crisi e,
quindi, all’assunzione dell’impossibilità di una scelta effettiva, di una decisione risolutrice?
Bisognerebbe forse svincolare il conflitto dalla crisi, cioè porre radicalmente in questione l’idea –
maturata in Italia proprio negli autori e nel periodo che ho trattato, ma oggi più che mai d’attualità –
che una politica in quanto conflitto sia inconcepibile senza presupporre la crisi.
[1] Tronti, Operai e capitale, DeriveApprodi, Roma 2006, pp. 114-5.
[2] Ivi, p. 262.
[3] Ivi, p. 219.
[4] Di tal genere sono le questioni che solleva Roberto Esposito nella sua interpretazione di Operai
e capitale: porre la classe operaia al contempo “dentro e contro” il capitale – nei termini di
Esposito: tenere insieme “immanenza e conflitto” –, nel passaggio dal piano economico a quello
politico, comporta un’aporia e una contraddizione che ricade sulla sostenibilità filosofico-politica
della stessa classe operaia in quanto soggetto antagonista. Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente,
Einaudi, Torino 2010, pp. 207-12.
[5] «Quando ci si chiede perché solo dal punto di vista operaio si può cogliere il segreto del
capitalismo, ecco l’unica risposta possibile: perché la classe operaia è il segreto del capitalismo»
Tronti, Operai e capitale, cit., p. 230.
[6] Ivi, p. 279.
[7] Cfr. Tronti, Noi operaisti, DeriveApprodi, Roma 2009, p. 7.
[8] Tronti tematizza compiutamente tale periodizzazione in La politica al tramonto, in cui colloca le
lotte degli anni Sessanta nella fase crepuscolare dell’Occidente, che proprio allora si compie
definitivamente: cfr. Tronti, La politica al tramonto, Einaudi, Torino 1998.
[9] Oggi, infatti, Tronti scrive: «La grande fabbrica è il contrario dei non-luoghi, che oggi
configurano la consistenza, o meglio l’inconsistenza, del post-moderno. La grande fabbrica è il
classico del moderno. La concentrazione dei lavoratori nel luogo di lavoro determinava le masse,
senza fare massa» Tronti, Noi operaisti, cit., pp. 94-5.
[10] Ancora in Noi operaisti: «L’amico-nemico operai-capitale non era un’invenzione filosoficoletteraria. Era un dato di fatto economico-sociale. Stava lì, sotto gli occhi di tutti e nessuno lo
vedeva. O meglio, si vedeva con gli occhiali del padronato o con i binocoli del sindacato, ma con
gli occhi della politica, e del pensiero politico, non si vedeva niente, perché si guardava altrove.
Ecco, l’operaismo mise a fuoco un’immagine, accese una lampada in un interno di fabbrica: e
fotografò» Ivi, p. 39.
[11] C. Schmitt, Il concetto di ‘politico’, in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P.
Schiera, il Mulino, Bologna 1972, p. 112.
[12] Tronti, Operai e capitale, cit., p. 314.
[13] A. Negri, Proletari e Stato. Per una discussione su autonomia operaia e compromesso storico
(1976), in I libri del rogo, DeriveApprodi, Roma 2006, p. 144-5.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
[14] Cfr. A. Negri, 1997: vent’anni dopo. Prefazione alla seconda edizione, in I libri del rogo, cit.,
p. 7.
[15] M. Tronti, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, Milano 1977, p. 20.
[16] Per un confronto tra Tronti e Negri, cfr. A. Toscano, Chronicles of Insurrection: Tronti, Negri
and the Subject of Antagonism, in L. Chiesa e A. Toscano (a cura di), The Italian Difference.
Between Nihilism and Biopolitics, re.press, Melbourne 2009, pp. 109-28.
[17] A. Negri, Proletari e Stato, cit., p. 166.
[18] A. Negri, Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale, in I
libri del rogo, cit., pp. 256-7.
[19] Negri, Marx oltre Marx (1979), manifestolibri, Roma 1998, p. 200.
[20] Ivi, p. 250.
[21] Ivi, pp. 251-2.
[22] M. Cacciari, Pensiero negativo e razionalizzazione, Marsilio, Venezia 1977, p. 12.
[23] Ivi, pp. 172-3.
[24] A differenza di Cacciari, Negri pone Nietzsche sulla linea spinoziana della potenza e del potere
costituente. Tale divergenza interpretativa è in parte giustificata dall’ambivalenza e ambiguità dello
stesso termine tedesco Macht, che può essere tradotto in italiano sia con “potere” che con
“potenza”.
[25] Cacciari, Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein,
Feltrinelli, Milano 1976, p. 66.
[26] Ivi, p. 63.
[27] Cacciari, Dialettica e critica del Politico. Saggio su Hegel, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 73-4.
[28] Cacciari, Pensiero negativo e razionalizzazione, cit., p. 11.
[29] Cfr. Cacciari, Progetto, in “Laboratorio politico”, anno I, n. 2, 1981, pp. 88-119.
[30] Per un confronto tra Cacciari e Negri a partire da Krisis, cfr. M. Mandarini, Beyond Nihilism:
Notes towards a Critique of Left-heideggerianism in Italian Philosophy of the 1970s, in Chiesa e
Toscano (a cura di), The Italian Difference, cit., pp. 55-79.
Dario Gentili (Napoli, 1975) è stato borsista post-dottorato in Filosofia e storia delle idee presso
l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM). Su questi temi, di recente ha pubblicato: Italian
Theory. Dall’operaismo alla biopolitica (Il Mulino, 2012). Collabora con la cattedra di Filosofia
Morale dell’Università di Roma Tre.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Il Papa viene da Marte e la Curia da Venere?
di PERRY S. HUESMANN
La Chiesa Romana Cattolica e Apostolica vive in virtù di un dualismo interno, quello fra religioso e
secolare, sacro e profano. Questo dualismo si esprime anche in termini strettamente ecclesiastici:
la Chiesa è sia “cattolica” sia “romana”, sia universale sia particolare. Perché la rinuncia al
soglio pontificio di Ratzinger non scioglie la tensione fra universalità e particolarità all’interno
della Chiesa.
In un libro ampiamente discusso sulla natura delle relazioni tra uomo e donna, la metafora
dell’origine planetaria è stata usata per illustrare la profonda alterità che gli uomini e le donne
sperimentano nella loro umanità, sia come fonte di piacere che di difficoltà. Per secoli, la Chiesa
Romana Cattolica e Apostolica ha vissuto un’ostilità/separazione interna: non come in una sana
relazione di alterità complementare tra due partner, ma come una schizofrenia interna al corpo. Si
deve pensare alla schizofrenia nel senso strettamente etimologico del termine: una “divisione della
mente”. Questo sdoppiamento della ragione sacra della Chiesa fonda le proprie radici in un
dualismo metafisico che è stato alla base della teologia e del modo di essere della chiesa per più di
un millennio. La Chiesa Romana non sarebbe quella che è senza la propria visione manichea del
mondo e senza le proprie divisioni tra religioso e secolare, eterno e temporale, sacro e profano,
celibe e non celibe, anima e corpo.
Questo dualismo viene espresso anche ecclesiasticamente. Un’unica ragione sacra, ma due nature.
La Chiesa è “Cattolica” ed è “Romana”. In altre parole, è “universale” ma si identifica con “una
cultura- quella Romana”. In termini filosofici, è totalmente universale, ma è anche in tutto e per
tutto particolare. Come può un corpo sperimentare sia un’universalità che una particolarità in
termini assoluti? Non sono forze in competizione destinate a un conflitto eterno e irrisolvibile? La
Chiesa Cattolica Romana è orgogliosa della propria natura et-et. Secondo l’arcivescovo di New
York, Timothy Dolan, l’aspetto migliore della vita cattolica risiede proprio nell’abilità di essere
“sia-sia” (et-et) e non “o-o” (aut-aut).
Il lato universale della Chiesa trova la propria espressione in una cattolicità che enfatizza l’unità
della chiesa. Essa è la stessa in tutto il mondo. Ci sono “una sola fede, un solo Signore, un solo
battesimo”, secondo le parole dell’apostolo Paolo. L’allora cardinale Josef Ratzinger ha
personalmente espresso questa universalità quando era Prefetto della Congregazione per la Dottrina
della Fede nella dichiarazione Dominus Iesus, nella quale ha sottolineato il dogma dell'Extra
ecclesiam nulla salus: non vi è salvezza al di fuori della chiesa universale. Questo lato cattolicouniversale della chiesa è stato supportato dalla globalizzazione dell’ultimo decennio, così che il
fedele, anche nei paesi in via di sviluppo, si identifica profondamente con questo lato universale
della natura dualistica della chiesa.
La natura particolaristica della Chiesa è quella culturale Romana. Non è quindi la Chiesa Cattolica
di Londra e, di certo, non è nemmeno la Chiesa Cattolica di New York, ma trattasi della Chiesa
Cattolica di Roma: dal suo punto di vista, New York è libera di globalizzare la propria cultura
secolare, ma l’unica cultura sacra globale voluta da Dio è quella Romana. Anche se la Chiesa
riconosce come valide le espressioni culturali indigene della spiritualità, esse sono tuttavia realtà
culturali secondarie a quella romana. Così, la Chiesa mantiene una natura totalmente Romana: è
definita dalla legge canonica romana, è governata dalla Curia Romana, il latino è la sua lingua
ufficiale e il vescovo di Roma gode di una posizione suprema.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Data questa natura particolaristica della Chiesa, non è difficile comprendere quella relazione di
conflitto di lunga data che ha caratterizzato i rapporti con Gerusalemme. Di certo Gesù non era
romano; la sua unica relazione con Roma, contatto che ha evitato fino alla fine del suo pubblico
ministero, lo ha portato a una morte brutale su una croce romana. E anche Paolo, cittadino romano,
ha avuto grosse difficoltà nel tentativo di spiegare le questioni della cultura greco-romana relative
all’umanità e al significato della vita a partire dalle scritture ebraiche. Anch'egli, alla fine, ha sentito
il peso della cultura legale romana come prigioniero a Roma.
Nelle scorse settimane il Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Universale ha rassegnato le proprie
dimissioni. E la questione che sorge è: questa è stata un’espressione della natura Romana o di quella
Cattolica della Chiesa? Qualunque siano le specificità delle ragioni interne, il Pontefice non è stato
in grado di portare avanti il proprio mandato divino come Vescovo di Roma e Papa della Chiesa
Universale. In apparenza, avrebbe potuto continuare a esercitare il ruolo di Vescovo di Roma,
nonostante la salute precaria, ma la legge canonica non permette questa particolare espressione,
perché il Vescovo di Roma è, lui solo, espressione universale della sacralità. La spiritualità
universale romana domina sulle espressioni indigene della Cristianità, questo vale anche per il
papato. In tal senso, il volto romano della chiesa è una forza colonizzatrice della e nella Cristianità.
A nessuna cultura viene chiesto se preferisce diventare romana nella propria espressione della fede.
La natura romana particolaristica della chiesa non è negoziabile: la gerarchia romana, la liturgia
romana, il magistero romano e la legge canonica di Roma impongono, ovunque, la cultura romana a
tutti i fedeli.
Questo perpetuo conflitto interno dell'et-et tra due nature assolute - una universale e una particolare
- all’interno della Chiesa, si è palesata al mondo in modo drammatico. Parafrasando la canzone di
Bobby Fuller, “Ho combattuto la legge e la legge ha vinto”, per Papa Benedetto si potrebbe
affermare “Ho combattuto Roma e Roma ha vinto”. Joseph Ratzinger è un Papa tedesco, quindi
proveniente da una moderna cultura riformata che, negli ultimi cinque secoli, da quando ha
contrastato le forze della Controriforma, ha convissuto con il pluralismo religioso. Nel periodo del
dopoguerra egli ha vissuto in un sistema fatto di trasparenza, checks and balances, etica pubblica,
facendo propria la capacità di riconoscere un forte senso di pericolo nei confronti di un potere
politico senza controllo. Ed è logico che tutto questo sia penetrato nella sua psiche. Egli ha portato
questa parte della propria umanità di fronte al Santo Vescovato, rappresentando, in tal senso, la
natura universale della Chiesa, qualcosa che è al di fuori di Roma.
Il suo mandato da Pontefice, come dichiarato dallo stesso Benedetto XVI, avrebbe dovuto
concentrarsi sulla purificazione della chiesa, anche se ciò avrebbe significato ridimensionarla,
renderla cioè più piccola. Persino l’eros aveva bisogno di essere disciplinato e purificato, secondo
l’enciclica Deus caritas est. Nella sua prima omelia da pontefice, nell’aprile 2005, Benedetto XVI
ha chiesto di pregare per lui affinché “non fuggisse per paura dei lupi”. La necessità di purificazione
era un riconoscimento della tensione tra le due nature della Chiesa e del suo desiderio di rispondervi
con trasparenza. Ma la sua lettera di dimissioni rappresenta un’ammissione di sconfitta, una
mancanza di energie o un’incapacità di portare avanti tale progetto? E quale interpretazione
potremmo trarre da una tale scelta? Egli, in qualità di Cardinale tedesco proveniente dalla natura più
universale della chiesa, non può riformarne la natura romana. Quest’ultima non è attestata da
certificati di nascita conservati dai più alti prelati, la natura romana della Chiesa è lo spirito duraturo
dell’istituzione; è l’espressione di un potere politico assoluto e del peso della Tradizione che
sopravvive a qualsiasi pontefice, sotto il peso della quale il Papa stesso, in qualità di capo
universale, sembrava vacillare fisicamente.
Cosa significa affermare che papa Benedetto XVI non è stato in grado di riformare la Curia
romana? Il papato è la più alta espressione dell’assolutismo monarchico nel continente europeo. Ma
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
neanche questi poteri papali assoluti, universali e incontestabili sono stati sufficienti a riformare la
natura romana della chiesa. Sembra siano all’opera forze e poteri molto più potenti della stessa
autorità pontificia. Ironicamente, la tiara papale è l’espressione cerimoniale dell’assoluta e
universale autorità esecutiva, giuridica e legislativa del Papa. Egli solo detiene questi poteri nella
Chiesa Cattolica Romana. Basti pensare, per esempio, al potere giuridico assoluto del Pontefice,
esercitato pochi mesi fa nel concedere il perdono al proprio maggiordomo (forse un discreto
riconoscimento che la preoccupazione di quest’ultimo nei confronti della corruzione della Curia era
anche la propria). Il suo potere legislativo assoluto è stato visto all’opera ancor più di recente,
quando ha nominato vescovo il proprio segretario personale Georg Gänswein. E la decisione del
Papa di rassegnare le dimissioni dal pontificato è stato il suo atto esecutivo pubblico finale e
assoluto – e non può essere contestato proprio perché egli, in qualità di papa, è un monarca assoluto.
Non tutti, però, vedono la rinuncia del Pontefice alla propria posizione come l’espressione di un
irrisolvibile conflitto interno tra le due nature della Chiesa. La parte non-ecclesiastica di questa
disputa si è soffermata su questa questione. La scelta del Papa è stata etichettata come
“rivoluzionaria” dalla maggior parte della stampa internazionale e, da alcuni, persino “moderna”,
soprattutto dalla stampa italiana. Forse perché quest’ultima vive e respira la natura romana della
chiesa che, nella sua realtà contro-Riformatrice, è tagliata fuori dalla modernità.
Ma, ricorrere ai propri poteri esecutivi, legislativi e giudiziari in modo assoluto e incontestabile è
stato un gesto così rivoluzionario per il Papa? Forse sì, se pensiamo a “rivoluzione” nel senso
francese del termine, la cui maggiore conseguenza è stata quella di rimescolare il mazzo dei
detentori del potere all’interno dello stesso quadro politico e perciò, alla fine, ha sostituito, sotto
Napoleone, un potere assolutistico con un altro. Il Papa stesso non potrebbe considerare come
rivoluzionaria la decisione di rinunciare alla propria carica, almeno non nel senso di introdurre
qualcosa di non ancora consentito all’interno del codice canonico romano; una “rivoluzione” si può,
però, esprimere attraverso una delle due nature della chiesa: quella universale. In un’intervista con
Vittorio Messori, pubblicata nel 1985, l’allora Cardinale Ratzinger ha definito la chiesa come
semper reformanda, chiarendo però immediatamente che il documento del Concilio Vaticano II
Gaudium et Spes (n.43) specifica che “la fedeltà della Sposa di Cristo” non è messa in discussione
dall’infedeltà dei suoi membri. La Sposa di Cristo è romana e fedele e forse, occasionalmente,
bisognosa di “modernizzazione” o di “purificazione”, ma, almeno in apparenza, non di una riforma.
I suoi membri universali necessitano, comunque, di costanti correzioni. Perciò, la missione del
pontefice di “purificare” la Sposa di Cristo e la sua decisione di lasciare l’ufficio secondo le
prescrizioni del codice canonico romano non possono essere ritratte come rivoluzionarie.
Sarebbe difficile definire la scelta del Papa di rinunciare al proprio trono come qualcosa di diverso
da un’espressione della sua autorità esecutiva assoluta, già riconosciuta all’interno del codice
canonico romano. Cosa c’è di moderno o di rivoluzionario in tutto questo? Certamente può essere
considerata come una scelta raramente adottata, ma non di certo moderna. Il papa ha semplicemente
concretizzato un diritto legale che gli viene garantito all’interno della struttura della Chiesa
Romana; questo difficilmente può essere descritto come rivoluzionario. Non introduce niente di
nuovo nell’equazione. Intendere rivoluzionario, nel senso di riformatore, equivarrebbe a rinunciare
all’insieme delle realtà (greco-)romane che hanno sopraffatto il Vangelo e lo hanno quasi soffocato.
Vorrebbe dire relativizzare l’espressione assolutistica della natura romana della chiesa e ascoltare le
voci del lato universale che richiedono cambiamenti in molte materie: l’infallibilità del papa; la
monarchia assoluta come la più sacra espressione della leadership della chiesa; lo status di
inferiorità delle donne; la mancanza di autorità della chiesa locale nel scegliere i preti; il celibato
obbligatorio come unica forma di espressione sessuale nel ministero pastorale; il dualismo
metafisico sacro-secolare come base della spiritualità umana; e l’accumulo di ricchezze e di potere
politico a Roma, tanto per citarne qualcuna. Queste realtà sono il frutto di secoli di romanizzazione
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
della chiesa universale. Nessuna di queste trae origine dalle radici culturali ebraiche di Gesù
riscontrabili nella Torah e nei suoi comandamenti fondamentali di amare Dio e il prossimo.
Nel tentativo di etichettare la scelta del Papa come “rivoluzionaria”, il mondo, con il suo occhio
sempre all’erta, sta probabilmente cercando di capire le dinamiche in gioco tra le due nature della
Chiesa e il dualismo metafisico sul quale è fondata. La sua decisione ha rivelato l’irrisolvibile
natura del dualismo metafisico al pubblico internazionale. Dato che il soggiacente dualismo dipende
dall’autorità del papato, le dimissioni hanno dato adito a nuove domande. L’uso da parte del Papa
della propria fragilità fisica come pretesto per rassegnare le dimissioni è una forte negazione di
questo dualismo, sul quale la Chiesa si fonda intellettualmente. In altre parole, la metà superiore del
Papa, la sua anima eterna e immateriale, dominata dalla ragione purificata, dovrebbe essere in
grado di guidare la metà inferiore della sua umanità, la sua fragilità fisica, per adempiere al proprio
mandato fino alla morte. Questo è ciò che, secondo il Cardinale Dziwisz, ha fatto Papa Giovanni
Paolo II quando ha agito come Gesù, rifiutando di scendere dalla croce. Egli non ha voluto piegarsi
alle pressioni esterne della modernità né riconoscere una concezione più olistica, integra e
scientifica dell’umanità. Questo è il motivo per cui ci sono state invocazioni di “santo subito” dopo
la sua morte. Papa Giovanni Paolo II è stato il più grande testimone vivente del dualismo metafisico
che regge l’intero modo di essere della Chiesa Cattolica Romana.
Nella sua lettera di dimissioni, comunque, Papa Benedetto XVI ha espresso un’anomalia ed è
questo l’aspetto rivoluzionario del suo atto, cioè il suo essere estrinseco al dogma della Chiesa. Non
è l’atto stesso di aver dato le dimissioni, ma l’avere espresso una visione integra della propria
umanità, nella quale l’elemento fisico e quello spirituale sono completamente integri e soggetti alle
forze esterne della cultura e del tempo. Questa testimonianza di umanità non-sacra da parte di un
custode romano della sacralità universale deve certamente preoccupare la gerarchia della chiesa,
perché mette in discussione tutto il suo fondamento metafisico: il dualismo sacro-profano. Una
visione integra dell’umanità è un’implicita ammissione dell’inabilità del sacro, anche nella sua più
elevata espressione del pontificato, di mostrarsi superiore al lato secolare e fisico. Questa può essere
una delle ragioni dell’ammissione del Papa della propria consapevolezza in relazione alla “serietà di
un tale atto”. Dopo la morte di Ratzinger non ci saranno invocazioni di “santo subito”, almeno non
immediatamente dopo. Con l’esposizione delle ragioni per le proprie dimissioni, questo Papa ha
posto le esigenze antropologiche sullo stesso piano, se non al di sopra, di quelle ecclesiasticoistituzionali.
Quindi, tornando al problema originario: la scelta del Papa è stata un’espressione della natura
Cattolica della Chiesa o di quella Romana? La questione, ovviamente, scaturisce dall’interno del
pensiero dualistico tipico della chiesa. Per rispondere alla domanda, è necessario considerare la
visione del potere politico dell’antica Grecia come opposizione del centro-periferia, che è stata
adottata dai romani e, in seguito, anche dallo stesso sistema di governo ecclesiastico romano. Essa
pone le proprie radici nel pensiero della legge naturale, il quale sostiene che, quando questa legge
governa il mondo, se indisturbata, porterà all’emergere di relazioni di potere naturali in ogni sistema
di governo; questo riflette una vera aristocrazia del migliore e del più brillante, come ordine
naturale delle cose, con il potere al centro. Ma il sistema di governo della chiesa romana è anche
espressione del sistema di governo faraonico dell’antico Egitto, simboleggiato dalla piramide e
gerarchico nella struttura, con il potere in cima. La struttura di governo faraonica con il Papa
all’apice è la natura universale del sistema di governo della Chiesa, mentre la visione greca del
centro-periferia rappresenta la natura romana, dove la Curia e il pontificato sono in costante
tensione.
In qualità di Papa della chiesa universale, Benedetto XVI ha rappresentato l’apice della piramide di
potere; ritrovandosi allo stesso tempo ad avere costantemente a che fare con la periferia del potere
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
della Curia romana, che contrasta e si pone in competizione con il centro dal momento che essa
rimane anche dopo il passaggio di qualsiasi capo della chiesa. Perciò, sembrerebbe che, ancora una
volta, il lato romano abbia soppresso il lato universale della Chiesa. In questa lettura, ciò che vi è di
così drammatico e senza precedenti è che il lato culturale romano della Chiesa ha colpito anche la
sua stessa guida. L’espressione della legge naturale e organica della struttura di governo ha
sconfitto l’aspetto faraonico gerarchico.
A complicare ulteriormente la situazione dell’ufficio stampa del Vaticano nel suo tentativo di
“spiegare” la complicata saga al pubblico, il Papa ha risposto a questa struttura gerarchica interna e
schizofrenica della chiesa con una vera e propria rivendicazione nominalista della propria libertà, in
qualità di essere umano, di andare alla ricerca di una vita migliore di quella del pontificato! La sua
scelta libera non emana una “fragranza di sacralità”, ma una spiritualità integra e terrena che non
mostra preferenze nei confronti di una nozione astratta del sacro che considera secondario il corpo
umano. Questo non è molto romano. La scelta del Papa è anche un chiaro riconoscimento di una
particolare realtà personale che ha avuto la precedenza sulla sua chiamata come capo della chiesa
universale. Nella sua scelta, il particolare ha definito l’universale e non viceversa. Questo non è
molto cattolico. Benedetto XVI è certamente consapevole che la sua scelta come Papa rischia di
essere intesa come un aperto rimprovero al fondamento dualistico sia romano che cattolicouniversale della chiesa. Sembra però che non abbia avuto altra scelta. E questo è la ragione per cui
la situazione è tanto drammatica. Le sue dimissioni sono un esplicito riconoscimento
dell’irrisolvibile conflitto interno al sistema. Nemmeno il potere sacro e assoluto può risolvere la
disputa per la supremazia tra la natura romana e quella universale della Chiesa. La scelta del
prossimo Papa e le sue priorità come pontefice riveleranno l’entità del danno che il Collegio dei
Cardinali e la Curia credono sia stato arrecato alla Chiesa da questo atto decisamente non-Romano e
non-universale compiuto dal capo della Chiesa Cattolica Romana.
Perry S. Huesmann è ricercatore presso la Vrije Universiteit di Amsterdam ed è docente presso
l'Università degli Studi di Milano. È autore di Covenant as Ethical Commonwealth.
Possibilities for Trust in a Age of Western Individualism and Disintegration (IPOC, 2010).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Ritorno a Maderna
di GIACOMO FRONZI
Il 2013, per quel che riguarda le celebrazioni, continua (e continuerà) ancora a offrirci motivi di
discussione su alcuni dei maggiori protagonisti della musica contemporanea. Dopo Luciano Berio,
è il momento di un suo indimenticabile amico, prima che grande collega, Bruno Maderna,
scomparso improvvisamente il 13 novembre 1973, colpito da un male incurabile.
Il mondo italiano dell’arte e della cultura del Novecento ha visto avvicendarsi figure ed esperienze
sperimentali del tutto centrali nel panorama internazionale. Un’intera generazione, quella nata a
ridosso del primo conflitto mondiale, ha segnato indiscutibilmente un’epoca, attraversando le
stagioni dell’avanguardia e della neoavanguardia – in tutte le arti, dalla letteratura alla musica, dal
cinema alle arti figurative –, finendo col comporre un quadro estremamente ricco. All’interno di
questo quadro, troviamo anche Bruno Maderna, protagonista di punta della stagione
dell’avanguardia musicale internazionale, improvvisamente scomparso nel novembre 1973, a soli
cinquantatré anni, colpito da un male incurabile.
Tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, si tendeva a pensare a Maderna come a un
infaticabile direttore d’orchestra che sarebbe potuto essere un grande compositore. Oggi possiamo
invece dire che si è trattato di un grande compositore che si è dedicato anche alla direzione
d’orchestra. Di lui, nel 2013, si sono celebrati i quarant’anni dalla morte e, per quanto ci è possibile,
vorremmo qui ricordarlo. Ricordare sinteticamente Maderna – come faremo noi – non significa
liquidare questo grande personaggio allo scopo di tenere fede a una qualche doverosa ricorrenza né
rispondere a una diffusa esigenza celebrativa. Nonostante la rilevanza della figura, occorre che se ne
parli e, soprattutto, si ascolti la sua musica, così da offrire una possibilità di conoscenza e
approfondimento in particolare ai “nuovi” ascoltatori di Maderna, a coloro che – per età o per
formazione – non hanno ancora avuto modo di entrare in contatto con l’universo sonoro
maderniano.
Il nome, innanzitutto. Maderna fa un po’ come il filosofo Theodor Wiesengrund Adorno, nato
Wiesengrund e morto Adorno. Bruno nasce a Venezia nel 1920 e di cognome fa Grossato, cognome
che alla fine degli anni Venti campeggia nel nome della “The Happy Grossato Company”, ensemble
d’intrattenimento messo su dal padre Umberto. Bruno rimane molto presto orfano della madre
(Carolina Maderna) e, sostenuto da un indiscusso talento e dall’attività del padre, prima di compiere
dieci anni si avvicina al mondo della musica, come violinista e come direttore d’orchestra. Verrà
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
poi la formazione, in un primo momento, con Arrigo Pedrollo e, in un secondo momento, con
Alessandro Bustini, Gian Francesco Malipiero e Antonio Guarnieri, studiando contemporaneamente
Composizione e Direzione d’orchestra.
Alla fine degli anni Quaranta, Maderna approfondisce la tecnica dodecafonica e – inevitabilmente –
si avvicina ai «Ferienkurse für Neue Musik» di Darmstadt, fondati da Wolfgang Steinecke, finendo
col diventarne uno degli animatori principali e dei punti di riferimento per buona parte degli anni
Cinquanta, non solo in virtù della sua grandezza, ma anche perché tale grandezza troverà
concretizzazione nella nascita dello Studio di Fonologia della Rai di Milano. Lo Studio – istituito
insieme al suo grande amico e collega Luciano Berio – sarà attivo dal 1955 al 1983,
caratterizzandosi fin dall’inizio per un nuovo e proficuo rapporto tra compositori e musicologi. La
situazione dell’elettroacustica vede profilarsi una divaricazione tra la musique concrète di Pierre
Schaeffer e l’elektronische musik di Karlheinz Stockhausen, una divaricazione che però si pone solo
agli inizi di queste due esperienze, ma che dopo qualche anno (già dalla fine degli anni Cinquanta)
non ha più ragion d’essere, se non per riferire un lavoro o un autore a una certa tradizione piuttosto
che a un’altra. Rispetto a questa iniziale divaricazione, tra concreta ed elettronica, lo Studio di
Milano si colloca in un ideale punto intermedio, alternativo all’una e all’altra tendenza, ma
ugualmente vicino ad ambedue. Per un verso, nello Studio si punta a una maggiore emancipazione
tecnologica della musica, per altro verso, si apre a un approccio più profondo, speculativo, al
materiale sonoro, anche – come abbiamo detto – avvalendosi della vicinanza attiva di intellettuali
come Piero Santi o Luigi Rognoni.
Un’altra caratteristica che offre allo Studio milanese una fisionomia peculiare è anche il livello di
sviluppo tecnologico che esso garantiva. I compositori che vi lavoravano erano supportati, da un
lato, dal lavoro di Marino Zuccheri e Alfredo Lietti, responsabile degli impianti tecnici e del loro
coordinamento. Dall’altro lato, vi è una notevole disponibilità di risorse tecnologiche, disponibilità
del tutto funzionale a un’idea, a una concezione etica, umana della musica tecnologica, che prende
corpo in una forma critica della ricerca e della sperimentazione.
In questo contesto si colloca Maderna, uno dei padri indiscussi dell’avanguardia musicale europea,
alla quale, nella seconda metà degli anni Cinquanta, presenta un’opera come Notturno (1956)[1],
eseguita per la prima volta a Darmstadt il 20 luglio 1956, e rimasta per lungo tempo stretta tra altre
due opere, una precedente, Musica su due dimensioni (1952), e una successiva, Continuo (1957).
Essa si caratterizza per una particolare attenzione al timbro e all’“espressività della macchina”,
esemplificata dall’uso “umano” di strumenti di controllo come il volume, che concorre a
determinare gli inviluppi degli eventi sonori, e la velocità, che produce glissandi; fa uso di suono
bianco filtrato in diversi spessori di banda e su diverse altezze di frequenza. L’effetto simile al
flauto è ottenuto lavorando sullo spessore di banda (2 Hertz). Secondo Fred Prieberg, il pezzo non
ha nulla a che fare con il “notturno” – per intenderci, quello nato con John Field e che poi ha trovato
la massima espressione con Chopin –, quanto al lavoro compositivo di Maderna, concentrato, in
questo come in altri casi, nelle ore notturne. È anche vero, però, che il titolo è programmatico e
significativo di un’ispirazione poetica ed espressiva. In Notturno, «non si avverte nessun
diaframma, nessun faticoso lavoro di conquista del mezzo tecnico in questo artificiale fischiar di
flauti nella nebbia, dilatato in spessore polifonico di strati sovrapposti»[2].
Notturno, dicevamo, è rimasto schiacciato tra Musica su due dimensioni e Continuo. Il primo di
questi due lavori ha un’importanza storica notevole, nella misura in cui dimostra efficacemente
l’inconsistenza dell’idea per la quale la musica elettronica rappresenta la negazione, il superamento
definitivo e, ancor di più, l’annullamento degli strumenti musicali tradizionali. Musica su due
dimensioni delinea un particolarissimo dialogo tra uomo e tecnica, tra suono del flauto realizzato
dal vivo e suono del flauto registrato su nastro. Ambedue le parti, inoltre, hanno un carattere e una
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
struttura spiccatamente “aperti”: «mentre il flautista alterna parti scritte in notazione tradizionale ad
altre aleatorie, così egli si accorda con il tecnico anche per scegliere quale parte del lungo nastro a
disposizione utilizzerà in quanto idonea ad essere “solcata” dalle figurazioni strumentali»[3].
Anche Continuo costituisce un passaggio importante nell’evoluzione della poetica e dell’estetica di
Maderna, così come anche negli sviluppi della musica elettronica. L’opera – il cui titolo «fa
riferimento chiaramente all’insistenza su sonorità lungamente tenute, assaporate in tutto il loro
fascino timbrico, e inoltre su proprietà per così dire immanenti alla struttura elettronica pura»[4] e
sta a indicare che tempo compositivo e materiale acustico in successione sono in relazione reciproca
e sono accordati l’uno all’altro – manifesta un impianto tecnico-linguistico molto efficace e inedito,
«che nell’apparente semplificazione della contrapposizione dialettica tra elementi fluidi e continui,
con elementi granulosi e pulviscolari, determina una struttura dialogica che definisce un corpo
sonoro suggestivo, attraversato da innervature, a loro volta percorse da vere e proprie correnti
elettriche che lo scuotono fino alla drammatizzazione piena dell’ascolto»[5]. Continuo ha dischiuso
nuovi orizzonti alla dimensione poetica nella musica elettronica. Massimo Mila è stato tentato dal
pensiero che sarebbe potuta essere la «musica della notte» che Béla Bartók avrebbe creato se avesse
avuto a disposizione il mezzo elettronico. È una composizione dalla forma ternaria, pur nella sua
libertà e nella sua ampia articolazione. Tale forma è determinata dalla dinamica, la quale disegna
una curva parabolica che, partendo dal pianissimo, vi ritorna, dopo aver attraversato una zona di
maggiore intensità sonora.
L’opera di Maderna (dai Concerti per solista e orchestra alle opere elettroacustiche, da quelle
cameristiche a quelle radiofoniche) è emblematica di una «poetica della relativizzazione», frutto di
un costante lavoro di collocazione e ri-collocazione di suoni e di processi. Vi è una accentuata
tendenza alla ricerca di un significato altro e diverso del materiale sonoro che poteva scaturire da
tali spostamenti e trasferimenti, materiale oggetto di una meticolosa attività di ripensamento,
trasformato non in una ipotesi assoluta, ma in qualcosa «capace di circolare tra le esperienze
compositive per arrivare forse alle soglie di un linguaggio realmente praticato»[6].
Dalle opere di Maderna emerge la raffinatezza del lavoro sulla materia sonora, soprattutto a livello
microformale, generando ed organizzando – musicalmente, tecnicamente e poeticamente –
microstrutture pulviscolari. Maderna si interroga sul ruolo musicale delle diverse sorgenti sonore, in
un momento delicato dello sviluppo della musica tecnologica, nel quale la dimensione elettronica
del suono sembrava stringere in un abbraccio mortale la dimensione acustica. La ricerca di Maderna
si presenta, così, come un’investigazione incessante e in continua trasformazione delle diverse
dimensioni alle quali si può aprire il materiale sonoro, tentando un inedito e proficuo dialogo tra
livello naturale e livello sintetico (in Notturno, ad esempio, l’effetto come di flauti «propone – per
dichiarazione del compositore – un aspetto di continuità tra i corpi sonori naturali e i mezzi sonori
della musica elettronica»[7]), tra passato, presente e futuro, tra composizione, interpretazione ed
esecuzione, all’interno di una assiomatica che ha al proprio centro l’impegno morale dell’artista o,
per usare un’espressione di Mila, il «cattolicesimo dell’esecutore»[8].
Maderna direttore d’orchestra, Maderna compositore, Maderna esecutore, Maderna maestro. Sotto
qualsiasi profilo lo si guardi, egli costituisce un modello esemplare, in quegli anni roventi, di
intelligente e lucida attenzione all’apparizione della musica in tutte le sue forme. Nella sua
esperienza la presenza costante del passato convive con la «più spregiudicata esplorazione
dell’avvenire»[9].
Maderna non scivola mai nel feticismo della tecnologia, nel pericolo di sacralizzare il novum purché
sia, con il solo obiettivo di aprire nuove strade, per il gusto di inventare un nuovo linguaggio.
L’invenzione, per il compositore di Chioggia, deve sempre essere subordinata a un preciso intento
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
comunicativo, deve puntare alla combinazione e all’equilibrio tra contenuti espressivi e mezzi
tecnici. L’elettronica, dunque, non è un fine, bensì un mezzo, uno strumento che va incontro «alla
sensualità acustica di Maderna, alla sua fame del suono, alla sua brama di esplorarlo, sezionarlo,
sapere com’è fatto, inventarlo e crearlo di sana pianta aggiungendo una nuova dimensione al
mestiere di compositore: non più inventare solo delle idee musicali da esternare attraverso le risorse
foniche della voce o degli strumenti, bensì creare, insieme con l’idea, anche il suono in cui essa si
estrinseca»[10]. La sensualità acustica si manifesta anche nell’utilizzo del “canto”, di una rarefatta
linea melodica, volendo utilizzare il vocabolario tradizionale, che, con le parole di Maderna,
possiamo chiamare «aulodía», il «canto di uno strumento a fiato[11], e pertanto univoco, incapace –
in linea di massima – di produrre suoni simultanei, come accade invece agli strumenti a corde.
Melodia assoluta, dunque»[12]. Ancora una volta una prova di incontro, il tentativo di ricombinare,
creare e ricreare oscillando tra natura e sintesi, tra passato, presente e futuro.
Per concludere, non ci resta che augurarci ciò che Raymond Fear si augurava diversi anni addietro,
auspicando un costante ritorno a Maderna attraverso la sua musica: «It is to be hoped that a fuller
and more just appreciation of Maderna’s music will be made possible, and this can only come about
through greater opportunities to hear them: taking into account his unique position as an object of
admiration and affection from the composers of his generation, it is only to be regretted that the
highly attractive and approachable works of this genial personality are today so neglected»[13].
NOTE
[1] Per una approfondita analisi di Notturno, cfr. N. Scaldaferri, Musica nel laboratorio
elettroacustico. Lo Studio di Fonologia di Milano e la ricerca musicale negli anni Cinquanta,
Quaderni di «Musica/Realtà», n. 41, lim, Lucca 1997, pp. 89-130.
[2] M. Mila, Maderna musicista europeo, Maderna musicista europeo, Einaudi, Torino 1976, p. 22.
[3] A. Gentilucci, Introduzione alla musica elettronica (1972), Feltrinelli, Milano 1982, p. 59.
[4] Ivi, p. 58.
[5] F. Galante, N. Sani, Musica espansa. Percorsi elettroacustici di fine millennio, Ricordi-Lim,
Milano 2000, p. 78.
[6] Ivi, p. 77.
[7] M. Mila, Maderna musicista europeo, cit., p. 22.
[8] Ivi, p. 5.
[9] Ivi, p. 7.
[10] Ivi, p. 21.
[11] La preferenza per gli strumenti a fiato e, in particolare, per il flauto è da ricondurre anche
all’intenso rapporto umano e professionale che Maderna ha intrattenuto con Severino Gazzelloni,
ma anche con l’oboista Lothar Faber, il quale gli ispira i Pezzi per oboe solo del 1962 e i tre
Concerti (1962, 1967 e 1973).
[12] M. Mila, Maderna musicista europeo, cit., p. 36.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
[13] R. Fearn, Bruno Maderna: From the Cafè Pedrocchi to Darmstadt, in «Tempo», n.s., no. 155
(Dec., 1985), pp. 8-14: 14.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Il caso Strauss-Kahn e la discussione femminista francese
Intervista a SYLVIA DUVERGER di RICCARDO ANTONIUCCI
Lo scandalo sessuale che ha investito Dominique Strauss-Kahn ha acceso un importante dibattito
sulla questione della sessualità nella società contemporanea e sulle sfide attuali del femminismo.
Anche per questa corrente, infatti, il rischio che idee progressive passino al servizio della reazione
è dietro l’angolo: incarnato da Marcela Iacub.
Tra i principali eventi registrati nella cronaca francese degli ultimi tempi, e tra quelli che
maggiormente hanno avuto un riflesso nel dibattito intellettuale, c’è senz’altro lo scandalo che ha
investito Dominique Strauss-Kahn. Dal momento dello scandalo, nella primavera del 2011, le voci
che sono intervenute sono state moltissime. Una delle più interessanti, tanto per la sua posizione di
spicco nel contesto intellettuale francese che per il carattere estremamente provocatorio delle sue
tesi, è quella di Marcela Iacub.
Risale a pochi giorni fa la notizia che il premio letterario della “Coupole” 2013 (che da dieci anni
incorona in Francia un libro «che dà prova di spirito») è stato assegnato al suo Belle et bête,
racconto senza reticenze della relazione della nota sociologa di origini argentine con il tanto famoso
quanto famigerato ex presidente del FMI. Al momento della sua uscita, lo scorso febbraio, questo
testo ha suscitato delle reazioni esplosive. Da parte dei quotidiani, prima di tutto, che ne hanno
osannato il valore letterario sottolineando anche il peso politico del gesto di mettersi, letteralmente,
“a nudo”. Poi da parte di Strauss-Kahn, che ha denunciato l’autrice del libro e il suo editore (Stock)
per violazione della privacy, vincendo la causa. E, infine, da parte delle teoriche e delle attiviste
femministe francesi, che, andando oltre la questione della vita privata di DSK, l’hanno interpretata
come conseguenza della sottomissione delle donne all’immaginario maschilista dominante.
Di questa vicenda e del contesto sociale e teorico in cui si inscrive, si è parlato con Sylvia Duverger,
giornalista, femminista e curatrice del blog “feministes en tous genres” ospitato dal Nouvel
Observateur, attualmente dottoranda in filosofia all’università di Paris 8 con Elsa Dorlin.
Partendo da una ricostruzione sintetica del caso di cronaca e della figura di Marcela Iacub, si è poi
preso lo spunto per parlare dello stato della teoria femminista francese e delle ultime sfide
rappresentate dalle questioni della laicità e dell’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali.
Una versione più lunga di questa intervista è disponibile (in più parti) qui.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Dalla sua posizione di giornalista, lei si è occupata del più recente fra gli scandali riguardanti
Dominique Strauss-Kahn. Quello della sua battaglia giudiziaria contro Marcela Iacub, autrice di
un libro (Belle et bête, Stock, Paris 2013) che ha fatto scalpore e indignato l’ex patron dell’FMI,
perché rendeva pubblici i particolari di una relazione amorosa tra i due. Per prima cosa le
chiederei di riassumere i termini della vicenda per i lettori italiani.
Sylvia Duverger – Dopo alcuni articoli della Iacub, pare che Anne Sinclair, all’epoca ancora
sposata con DSK, abbia scritto a Marcela Iacub per ringraziarla di aver preso le difese di suo
marito. DSK le avrebbe scritto a sua volta per ringraziarla. Dopo qualche esitazione, lei alla fine gli
ha chiesto di poterlo incontrare. È quanto racconta in Belle et bête, uscito il 27 febbraio scorso, che
è valso al suo editore e a «Le Nouvel Observateur» una condanna per violazione della vita privata
di DSK.
«Le Nouvel Observateur», infatti, aveva pubblicato il 21 febbraio a tutta pagina degli stralci di Belle
et Bête in anteprima, insieme a un’intervista esclusiva con Marcela Iacub. Anche la prima pagina
era dedicata all’affaire Iacub-DSK, con un titolo da tabloid “La mia storia con DSK”. Teoricamente
«Le Nouvel Observateur» dovrebbe essere un settimanale di sinistra e mantenere un certo livello
politico, culturale e perfino morale – Jean Daniel, che ha fondato la rivista, si dice discepolo di
Albert Camus.
Vari critici letterari stimati hanno incensato Belle et bête, sul «Nouvel Obs» e su «Libération»,
anche se gli estratti che si potevano leggere su «Le Nouvel Observateur» non permettevano di
giudicare veramente la qualità letteraria dell’opera. In realtà, la cosa che attirava l’attenzione di tutti
era il fatto che si trattava di un racconto, romanzato, della relazione tra i due. Anche se il nome di
DSK non è citato espressamente nell’opera, nell’intervista al «Nouvel Obs» l’autrice ha precisato
che l’«uomo-porco» di cui parla nell’autofiction è effettivamente DSK.
Cosa pensa dell’esito della vicenda giudiziaria, cioè della condanna di Marcela Iacub e del suo
editore a risarcire Dominique Strauss-Kahn? In fondo, non si tratta di una misura un po’
“tardiva”, se è intesa veramente a proteggere la privacy di DSK? Ormai le cronache scabrose
della sua vita privata sono già di dominio pubblico.
S. D. – Jean-Marc Roberts, l’editore, e Marcela Iacub sapevano benissimo di esporsi a un processo.
La cosa peggiore sarebbe stata il divieto di circolazione dell’opera, che vende bene, molto bene.
Jean-Marc Roberts è morto lo scorso 25 marzo, ma aveva dichiarato più di una volta che lo avrebbe
rifatto. Marcela Iacub, invece, ha ricevuto molte critiche da parte di intellettuali, amici e amiche.
Per rispondere a queste critiche, ha indossato la maschera da dozzinale psicanalista, dicendo che la
levata di scudi contro il suo libro è causata dalla denegazione da parte dei suoi critici
dell’«eccitazione sessuale» suscitata in loro dal suo racconto. In altre parole, secondo la Iacub chi la
attacca lo fa soltanto perché lei avrebbe avuto il coraggio di scendere dal piedistallo di intellettuale
profeta di paradossi e di aver fatto della sua passione amorosa qualcosa di «creativo» e di «storico».
Io direi piuttosto, come ha detto Peggy Sastre a questo proposito, che «l’ego è decisamente un
flagello», e che la pomposità narcisistica di Marcela Iacub, alla fine, non è più divertente
dell’insussistenza del suo discorso. A dire la verità, ho l’impressione che questo sia l’ultimo atto
della commedia del suo screditamento. Ma, forse, sono troppo ottimista, e non è così impossibile
che la nostra epoca si lasci affabulare ancora per un po’ da questa vacuità fregiata di sofismi.
Per tornare alla sentenza, in virtù della quale DSK ha ottenuto l’ingente somma di 75000 euro, il
problema è che essa dà l’impressione che quest’uomo possa legittimamente invocare la morale e il
rispetto della privacy… mentre è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale in Francia, nei
confronti della scrittrice Tristane Banon, e che ha verosimilmente aggredito e violentato anche
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Nafissatou Diallo vista la somma che le ha versato. Inoltre, l’ultima notizia è che anche la
giornalista italiana Myrta Merlino ha accusato DSK dello stesso comportamento. Ricordo che
Marcela Iacub, che è in un’ottima posizione per poter sapere l’ordine di questa somma, non ha
negato la sua esistenza, anzi. Personalmente sono d’accordo con la sociologa femminista Christine
Delphy, quando sostiene che il solo fatto che ci sia stato un accordo finanziario con Nafissatou
Diallo costituisce una confessione di colpevolezza.
Ad ogni modo, c’è chi ha parlato di violazione della libertà di stampa…
S. D. – In termini di libertà di stampa, questa decisione costituisce un precedente. Tant’è che la
maggior parte degli avvocati specializzati in questo settore sono rimasti sorpresi dalla severità della
sentenza. Ma alla fine né l’editore, né Iacub, né «Le Nouvel Observateur» hanno fatto ricorso in
appello. Ritengono che sarebbe stato controproducente, e che senz’altro le vendite compensano i
danni e gli interessi.
La mia impressione è che la nota che Strauss-Kahn ha ottenuto di far inserire nell’esergo di Belle et
Bête sia in realtà da intendere come un modo per rivendicare il suo carattere di protagonista della
favola, dato che ha fatto scrivere che quest’ultima «viola la sua vita privata». Avrebbe potuto riderci
sopra, accontentarsi di dire che era tutto frutto di invenzione. Ma non l’ha fatto. Preferisce quasi
apparire come il co-autore del “romanzo” di Marcela Iacub, come se quei 75000 euro di indennizzo
fossero i suoi diritti di autore.
Ma il punto è che Belle et bête riesce a convincere definitivamente che Strauss-Kahn è un uomo che
non rispetta né gli uomini né le donne. Non persegue altro che il suo bene, o piuttosto il suo piacere
perverso. Un’emulo di Sade. Un cinico e un violento. Per questo ha ritenuto necessario querelare. In
realtà per dare al libro quella pubblicità che gli è tanto più necessaria tanto più quello che racconta è
privo di interesse, sia dal punto di vista letterario che intellettuale, ci sarebbe stato bisogno di un
divieto di pubblicazione. Strauss-Kahn invece non l’ha chiesto, o meglio lo ha chiesto solo a titolo
sussidiario; sapeva, cioè, che avrebbe prevalso il principio di libertà di espressione.
Per il resto, l’immagine del «Nouvel Observateur» non ne esce gran che bene da questa storia. Gli
esperti di media dicono che se è assunto questo rischio è solo perché finanziariamente la stampa è
messa molto male.
Al di là della cronaca, la cosa interessante di questo libro sono anche le tesi che sostiene. Perché
la posizione della Iacub sembra fondarsi su una prospettiva teorica che, partendo dall’idea della
liceità di qualunque modalità di soddisfazione del piacere sessuale, va poi di fatto a negare
l’esistenza del dominio maschile. Lei citava poco fa i discorsi di Iacub sulla liberazione sessuale,
in rotta di collisione con la teoria femminista…
S. D. – Marcela Iacub ha scritto una serie di libri notevoli, L’empire du ventre in particolare. In
queste opere, dà prova di «giurista esperta e rigorosa», come ha detto Yvonne Knibiehler,
femminista e storica della maternità, che ha dedicato a questo libro una recensione elogiativa sulla
più importante rivista di storia femminista francese, «Clio». (1)
Inoltre ha lavorato a fianco di studiosi di politica sessuale, come il brillante sociologo Eric Fassin,
di cui bisogna assolutamente leggere L’inversion de la question homosexuelle se si vogliono
comprendere le polemiche sorte intorno al matrimonio per tutti e tutte, oppure come Daniel
Borrillo, professore di diritto all’università di Nanterre. Ma la Iacub è anche, da molti anni, una
firma di «Libération», dove invece fa di tutto per “fare notizia”. I suoi strumenti ricorrenti per
raggiungere questo scopo sono il paradosso insostenibile, la provocazione e la malafede.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Dalle sue colonne si scaglia contro le femministe abolizioniste. Le abolizioniste, riunite in gruppi
come Osez le féminisme, Collectif national du droit des femmes, o il più noto Femen, si propongono
di debellare la prostituzione attraverso la penalizzazione del cliente (il che è contestabile, ed è in
effetti una questione molto dibattuta in Francia). Dal canto suo, Marcela Iacub si guarda bene dal
parlare della tratta delle donne. La gran parte delle prostitute non sono donne che hanno scelto
questo mestiere, ma che vi sono state obbligate. La Iacub ritiene che la prostituzione sia un mestiere
come un altro, non più rischioso e probabilmente più gratificante e molto più remunerativo di altri.
Anche se afferma di proteggere la libertà sessuale, nei suoi articoli difende in realtà l’impunità degli
sfruttatori, degli aggressori sessuali. E accusa le donne che denunciano di mentire, di non accettare
il proprio desiderio, di voler recuperare quel potere sugli uomini che nella sessualità verrebbe loro a
mancare. Cito da Une société de violeurs, che riprende e sviluppa idee già esposte su Libération o
in Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle? (Flammarion, 2002):
«Quando ha c’è stato un atto sessuale, il consenso può essere tolto in modo retroattivo, come presa
di coscienza della propria libertà, della dominazione, e trasformarsi così in un atto di
emancipazione. Dietro l’espressione dello stupro come estremo atto di dominazione, si deve
intendere, in verità, il fatto che qualificare una relazione sessuale come obbligata è un potere
supremo di cui la donna deve disporre in una società giusta e che aspira all’uguaglianza dei sessi. E
questo potere supremo si manifesta nella denuncia per stupro. È quindi quel discorso che non può
essere contraddetto, ma che deve essere registrato come vero. Conferire un simile potere alle donne
significa trasformare il luogo della loro massima oppressione nel luogo del ribaltamento della
dominazione. (pp. 109-110)
La Iacub non si cura del fatto che il numero delle denunce per stupro è di gran lunga inferiore al
numero degli stupri effettivi, stando a quanto si evince dalle indagini condotte da organismi statali:
secondo una statistica del 2010, in Francia solo il 9,3% delle vittime denunciano, e il numero reale
degli stupri potrebbe avvicinarsi a 100 000. (2)
Una delle tesi sviluppate in Une societé de violeurs?– non ci stupiremo – è che le dichiarazioni rese
dalle donne che denunciano violenze sessuali sono poco attendibili. La Iacub appare così prostrata
al piacere maschile – quale che sia – che non le passa per la testa di immaginare che delle donne
possano rifiutarsi di subire rapporti sessuali violenti. In ogni caso, preferisce dar credito alle
dichiarazioni degli accusati di aggressione piuttosto che a quelle delle vittime, come se ignorasse
quello che le inchieste invece confermano, anno dopo anno, vale a dire che in larghissima parte
sono gli uomini ad aggredire le donne, e la reciprocità è rarissima.
Per esempio, l’81% delle vittime dei 425 casi di stupro studiati dalla sociologa Véronique Le
Goaziou riguardano donne, e il 98% degli imputati sono uomini (e tra le 9 donne imputate, 4 lo
sono state soltanto per complicità nello stupro) (3).
In ultima istanza, forse la cosa più interessante del discorso della Iacub – e che permette anche
di tracciare una linea di continuità tra le sue opere – è ciò che si potrebbe definire, con qualche
forzatura, una “teoria del porco” (théorie du cochon). Che consisterebbe, se ho ben capito, nel
ridurre il godimento sessuale dell’individuo a un piano di espressione dell’onnipotenza del
desiderio, oltre e indipendentemente da ogni norma sociale. Su questo piano, ogni maniera di
godere è ammessa. È su questa concezione che si fonda la sua critica alle femministe “radicali”
che si battono contro la prostituzione, che porta a quella strana parafrasi che ha citato, e con la
quale Iacub arriva a sostenere che, dal punto di vista strettamente teorico, “non c’è veramente
stupro”. Come risponde il femminismo a questo attacco, senza cadere nel moralismo?
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Il problema in questo “sistema” iacubiano è il totale misconoscimento dei rapporti sociali tra i sessi;
anzi, la loro negazione pura e semplice. Come se gli individui, di qualunque sesso, classe sociale,
etnia di appartenenza, disponessero della stessa libertà, delle stesse possibilità di partenza. Marcela
Iacub pretende di essere di sinistra, ma in realtà è una liberale, perché in fondo non fa altro che
difendere la volpe nel pollaio. Ci si dovrebbe inoltre interrogare sulla posizione politica di
«Libération» e del «Nouvel Observateur», dal momento che in questi anni le hanno steso un tappeto
rosso. E che non si venga a dire che non ci sono rapporti tra il liberalismo dei costumi e il liberismo
economico e politico, perché la concezione che li sottende è una e soltanto una: quella del soggetto
autonomo, responsabile dei propri desideri, delle proprie relazioni sessuali così come dei suoi atti, e
che si merita quello che gli accade, che sia un rapporto di dominio o di sottomissione, ricchezza o
povertà, gloria o esclusione sociale.
In Une société de violeurs? Iacub è andata anche più in là con queste tesi dal sapore decisamente
maschilista: nega che gli uomini godano ancora della maggior parte dei poteri – politico,
economico, mediatico, intellettuale, culturale ecc. – e accusa in particolare le femministe radicali.
Ho dedicato a questo libro sconcertante un lungo articolo, un po’ traboccante, a dire la verità.
Voglio citarne alcuni passaggi: “il femminismo radicale ci invade con la sua moralità e il suo odio
del sesso” (p. 133); “il fatto di concepire lo stupro come un atto di dominazione serve in primo
luogo a giustificare la creazione dei divieti generali di intrattenere alcuni tipi di rapporti per il
motivo che questi ultimi andrebbero a nuocere tutte le donne poiché attenterebbero alla loro
dignità” (p. 108). Per la Iacub, in altri termini, non è lo stupro che le femministe radicali vogliono
rendere impossibile, ma delle determinate pratiche masochiste. Pratiche cui è difficile consentire,
salvo essere Marcela Iacub, visto l’evidente carico di umiliazione delle donne che le subiscono.
Nell’universo iacubiano, è come se le donne stuprate avessero desiderato di essere negate in quanto
persone. In questi casi di stupro, la giurista si accontenta di sofisticazioni, in tutti i sensi del termine.
Iacub non sembra essere in grado di concepire una sessualità femminile che non sia masochista.
Che concetto sovversivo! È molto meglio a questo punto leggere Ovidie, l’ex attrice porno laureata
in filosofia, che ha scritto Sexe & Philo con Francis Métiver. Lei ha una visione molto più
stimolante e allegra della sessualità femminile, e anche dalla portata molto più emancipatrice (4).
La difesa delle femministe contro le accuse di Iacub è innanzitutto la decostruzione dei sofismi di
cui si serve (cosa che tento di fare anch’io). Sulla questione del moralismo e del puritanesimo: basti
ricordare, come ha fatto Clémentine Autain (5), che Iacub lavora perché le donne non possano
godere liberamente del loro corpo. Denunciare lo stupro non è puritanesimo, non è moralismo, è
difendere la libertà sessuale delle donne, dei bambini, e degli uomini considerati effeminati solo
perché non si mettono in mostra con quella pagliacciata della virilità. Non difendere la libertà dei
dominati e delle dominate, dei non violenti e delle non violente significa confiscarla a beneficio dei
dominatori e dei violenti. I desideri dei dominati e delle dominate non valgono di meno di quelli dei
dominatori. Ma soprattutto il loro desiderio, eccezione masochista a parte, non è di essere dominati.
Perciò, la democrazia dovrebbe essere femminista. Oppure, per dirlo in un altro modo: finché uno
Stato, una legislazione non saranno femministi, cioè finché non mireranno ad assicurare
l’uguaglianza effettiva di tutti e di tutte, non saranno democratici. Il 2 aprile 2011, quindi più di due
anni fa, «Libération» pubblicò un manifesto firmato da 343 femministe, tra cui la sottoscritta, che
chiedeva «l’uguaglianza ora». Bisogna che la legittimità di questa esigenza di giustizia sia
pienamente riconosciuta e messa in pratica da tutti, sempre e dovunque.
Forse a partire da qui possiamo distanziarci un po’ rispetto a questo caso specifico, e parlare, più
in generale, dello stato di salute del femminismo in Francia. Si potrebbe partire dai recenti eventi
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
politici e sociali che hanno interpellato fortemente le teorie femministe: mi riferisco al dibattito
sul matrimonio per tutti e tutte. Allora, per farla breve, che ne è del femminismo francese?
S. D. – Allo stato attuale, in Francia esistono molte correnti femministe. Le femministe
abolizioniste, innanzitutto, spesso materialiste e radicali, che vogliono debellare la prostituzione, e
per questo stimano che la penalizzazione del cliente sia un buon metodo. Sono queste femministe
che denunciano la pornografia nel suo insieme, perché tratta le donne come oggetti esprimendo e
riconfermando la dominazione maschile. È una corrente molto presente anche in Quebec. Penso in
particolare alla femminista Sisyphe (6).
Poi ci sono le femministe sex-positive o pro-sex, che ritengono dal canto loro che le abolizioniste
neghino il fatto che le «lavoratrici del sesso» siano soggetti dotati di capacità di analisi e di scelta.
Per esempio, in un’intervista che ho recentemente realizzato, Emilie Jouvet, regista di film porno
lesbici femministi, qualifica le Femen (che sono contro qualunque religione, contro qualunque
prostituzione e contro qualunque pornografia) come machisti inconsapevoli.
Però, oltre a quella della sessualità, c’è anche un’altra questione, anch’essa molto presente nel
dibattito politico francese, che ha diviso le femministe. Mi riferisco alla questione della «laicità»,
in particolare nel senso della posizione da assumere rispetto alla nuova modalità conservatrice di
recupero di questo concetto in un quadro discorsivo che tende a giustificare politiche razziste o di
esclusione delle minoranze. Penso, per esempio, al dibattito intorno alla legge di Sarkozy che
vieta di indossare il velo islamico nei luoghi pubblici.
S. D. – Tra le femministe radicali, alcune si sono impegnate molto nella lotta antirazzista. Come
Colette Guillamin e Christine Delphy, con la quale ho realizzato tra l’altro una lunga intervista
tempo fa (7). Nella sua raccolta di testi intitolata Classer, dominer: qui sont les «autres»?
quest’ultima ha denunciato il modo in cui Chirac, Sarkozy e anche altri uomini politici di destra,
oppure intellettuali neo-reazionari come Alain Finkielkraut, si sono impadroniti della questione dei
diritti delle donne musulmane, autoproclamandosi addirittura femministi, salvo poi dare prova, in
Parlamento, sui giornali o alla radio, di un sessismo spesso strabiliante (8). Christine Delphy
assimila questo atteggiamento a quello dei coloni che attribuivano ai colonizzati un regime sociale
arretrato e patriarcale, proprio mentre il codice civile napoleonico trattava le donne come delle
minorate, non molto più libere rispetto ai loro mariti delle donne musulmane (9). I coloni cercarono
di impadronirsi delle donne dei colonizzati. «I coloni hanno squillato le trombe della liberazione
della donna solo per distruggere l’identità indigena» (10). Dopo l’indipendenza, prosegue Delphy, i
bambini delle ex-colonie che vivevano in Francia sono diventati francesi. Ora, stigmatizzando
l’Islam, si vogliono relegare questi cittadini su un piano secondario. Dal 1989, lo hijab, il burqua e
la poligamia rappresentano l’alibi perfetto per questo tipo di politica (11).
Nel 2011, in un’intervista con Daniel Bertaux, Catherine Delcroix e Roland Pfefferkorn (12),
l’autrice afferma che «la società francese nel suo insieme, con l’aiuto della gran parte delle donne
che si dicono femministe, è riuscita a prendere due piccioni con una fava: da un lato stigmatizzando
una parte della popolazione come portatrice di difetti ignobili – di sessismo, omofobia e
antisemitismo – e, dall’altro, assolvendo la società dominante dall’accusa di sessismo, con formula
piena. Il risultato è che non si parla più di una generale impostazione sessista della nostra società,
considerando gli uomini a monte della loro appartenenza a gruppi etnici. Per esempio, Élisabeth
Badinter dice che “nei francesi bianchi, che siano ebrei o cattolici, non si può davvero parlare di
oppressione delle donne”» (13).
Ma la realtà dei fatti mi sembra ancora più complessa di così, perché la posizione di Élisabeth
Badinter, a favore di un féminisme à la française è in realtà molto lontana da quanto sostengono in
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Francia le femministe… femministe. Direi quasi che questo “femminismo alla francese” è così poco
femminista che preferisce, come nel caso di Marcela Iacub, prendere le difese dei «seduttori» sullo
stile di Dominique Strauss-Kahn, piuttosto che delle donne che li denunciano (a torto, secondo loro)
per violenza sessuale. Perché – è ovvio, no? – in un Paese civile come il nostro simili violenze non
possono verificarsi che tra gli immigrati, di prima o seconda generazione…
Una cosa è sicura: la questione dello hijab nelle scuole posta nel 1989 e, poi, quella del burqua nei
luoghi pubblici posta nel 2010 hanno senza dubbio messo il femminismo francese in crisi (14). Nel
momento in cui si esce dal terreno della caricatura polemica, si deve necessariamente prendere atto
del fatto che «più di una femminista ha sperimentato l’impressione dolorosa di ritrovarsi davanti a
una scelta impossibile, per cui una cosa o l’altra andavano sacrificate». La scelta obbligata tra la
lotta contro il sessismo e quella contro il razzismo.
Non si deve tacere il fatto che nel 2004 le femministe laiche schierate contro la legge sul divieto del
velo nei luoghi pubblici, e riunite sotto lo slogan «ni loi ni voile» hanno escluso le donne con il velo
dalla manifestazioni per i diritti delle donne e contro la violenza. Lo stesso comportamento hanno
tenuto anche le femministe della Marche mondiale des Femmes (MMF) o, in tempi più recenti, il
gruppo Osez le féminisme (15). «Quante feste delle donne, iniziative femministe, convegni,
conferenze, manifestazioni sono state segnate negli ultimi anni dall’esclusione di alcune donne da
parte delle “femministe”, solo perché indossavano il velo», ha scritto la sociologa e femminista
islamica Zahra Ali (16).
È logicamente impossibile difendere in nome dell’uguaglianza dei sessi la possibilità di negare
l’accesso alla scuola pubblica per le ragazze con il velo, soprattutto perché questa misura si rivolge
unicamente alle ragazze. Una posizione davvero femminista rispetto a questo punto è invece quella
di battersi perché queste stesse donne possano contare quanto gli uomini in tutti i tipi di corso o di
insegnamento, dallo sport alle scienze naturali.
Da parte mia, ho firmato l’appello contro la legge che vietava il velo nei luoghi pubblici, e dopo
aver letto il libro curato da Zahra Ali (Féminismes islamiques) mi sono convinta ancor più del fatto
che le femministe islamiche non sono per nulla arretrate nella lotta contro il sessismo. Anzi, stanno
facendo un lavoro considerevole in favore dei diritti delle donne nei paesi musulmani o nelle
comunità musulmane occidentali. Lavorano perché le donne prendano in mano il loro destino,
privato, pubblico e religioso.
NOTE
(1) http://clio.revues.org/1492
(2) Sintesi del rapporto 2010 dell’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales
(ONDRP) realizzata dal Collectif Féministe Contre le Viol e dalla Fédération Solidarité Femmes.
Fonte: http://www.observatoire-parite.gouv.fr/violences/reperes-statistiques-79/
(3) V. Le Goaziou, Le Viol, aspects sociologiques d’un crime, La documentation française, 2011, p.
41
(4) http://www.liberation.fr/societe/2012/12/14/prostitutionnellement_867737
(5) Giornalista co-direttrice della rivista «Regards» e militante comunista, vicina al Nouveau Parti
Anticapitaliste.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
(6) http://sisyphe.org/.
(7) Disponibile all’indirizzo: http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RDM_039_0308.
(8) Cfr. C. Delphy, Antisexisme ou antiracisme? Un faux dilemme, in Classer, dominer. Qui sont les
autres ? La Fabrique, Paris 2008, p. 176.
(9) C. Delphy, Race, caste et genre en France, in op. cit., p. 143.
(10) Ivi, p. 144.
(11) Come sottolineano, oltre alla Delphy, i firmatari della petizione Un voile sur les
discriminations («Le monde», 17 dicembre 2003), tra cui il “Collectif des feministes pour l’égalité
(CFPE); il “Collectif contre l’islamophobie en France” (CCIF); il movimento/partito “Les Indigènes
de la République”; gli “Indivisibles” (guidati da Rokhaya Diallo); il collettivo “TumulTueuses” e
anche gli autori del libro Les féministes blanches et l’empire, La Fabrique, Paris 2012.
(12) Pubblicata in «Migrations et sociétés», XXIII, n. 133, gennaio-febbraio 2011, consultabile
anche sul blog di Christine Delphy all’indirizzo seguente:
http://delphysyllepse.wordpress.com/2011/10/28/la-fabrication-del%E2%80%99%C2%ABautre%C2%BB-par-le-pouvoir/
(13) E. Badinter, La victimisation est aujourd’hui un outil politique et idéologique, «L’Arche», n.
549-550, novembre-dicembre 2003; cit. in ivi.
(14) Si veda a questo proposito il libro di Félix Boggio Éwanjé-Épée, Stella Magliani-Belkacem,
Les Féministes blanches et l’empire, La fabrique, 2012, p. 7.
(15) http://www.zelink.com/profil/MarspourtoutEs. L’MMF è un’associazione che dal 2000 si
batte contro la miseria e le violenze che affliggono le donne nel mondo. Osez le féminisme è
un’associazione creata nel 2009 e vicina al Partito Socialista francese. Cfr.
http://www.osezlefeminisme.fr/article/linterdit-vestimentaire-un-instrument-constant-de-ladomination-masculine-a-travers-les-ages
(16) Z. Ali, Journée des femmes et exclusion des musulmanes. Mais que font les féministes?, 8 mars
2012, http://oumma.com/11650/journee-des-femmes-et-exclusion-des-musulmanes-mais-qu . Cfr.
anche, su questa stessa rubrica, la recensione al libro curato da Zahra Ali Féminismes islamiques,
La Fabrique, 2012: http://ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/05/20/il-femminismo-islamico-una-prospettivapostcoloniale/.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Le prospettive dell'antropologia filosofica. Dignità umana,
pluralismo, sfera pubblica: intervista a Hans-Peter Krüger
di GIORGIO FAZIO
Negli ultimi due decenni si è assistito nel dibattito filosofico tedesco ad una rinascita d’interesse
per i temi e le prospettive dell’antropologia filosofica. A questo proposito, abbiamo intervistato
uno dei maggiori esponenti in Germania dell’impostazione di pensiero dell’antropologia filosofica:
il filosofo tedesco Hans-Peter Krüger. Esperto di Plessner, Krüger è stato anche un intellettuale
attivo nei movimenti di opposizione democratica nella DDR, subendo per anni, per questo suo
impegno, il divieto d’insegnamento e di pubblicazione.
Negli ultimi due decenni si è assistito nel dibattito filosofico tedesco ad una rinascita d’interesse per
i temi e le prospettive dell’antropologia filosofica: un’impostazione di pensiero nata nella prima
metà del XX secolo in Germania, negli anni tormentati ma culturalmente esplosivi della repubblica
di Weimar, e che si è soliti ricondurre ai nomi di Max Scheler, Helmuth Plessner e Arnold Gehlen.
Tra questi tre autori, è stato soprattutto il pensiero di Plessner a essere divenuto oggetto di una
rinnovata attenzione critica. Ciò non deve stupire. Plessner, infatti, oltre ad essere stato il primo ad
elaborare un progetto sistematico di antropologia filosofica - quello di Scheler non vide mai la luce
per la morte del filosofo, avvenuta nel 1928 - è stato anche un ispiratore della sociologia moderna e
un animatore del dibattito culturale e politico della Repubblica federale tedesca. Nel secondo
dopoguerra, ha ingaggiato molti confronti con le altre correnti filosofiche del dibattito tedesco – in
particolare, con la teoria critica e con l’esistenzialismo - nonché con Gehlen, l’altro esponente
dell’antropologia filosofica, macchiato dal coinvolgimento con il nazionalsocialismo e fino
all’ultimo interprete di una declinazione conservatrice di questo indirizzo di pensiero. Analista
acuto dei problemi e delle patologie culturali della storia tedesca, Plessner ha coniato la famosa
locuzione «nazione in ritardo», per indicare quella non contemporaneità della cultura politica
tedesca di inizio novecento, rispetto agli standard della modernità politica europea ed occidentale,
che è stata alla base, secondo la sua ricostruzione - compiuta nel libro del ’35 Die Verspӓtete Nation
- [1] del successo del nazionalsocialismo. Già negli anni di Weimar, però, Plessner aveva sviluppato
una critica del radicalismo politico rivoluzionario di sinistra e di destra, richiamando «i limiti della
comunità» e fondando una concezione della sfera pubblica quale ambito di apertura e di confronto
politico con l’altro e con l’estraneo, mediato dal diritto quale garante del pluralismo e affidato alle
virtù del tatto e della tattica.[2] Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, tornato in
Germania dal suo esilio in Olanda dovuto alle sue origini ebraiche, Plessner ha svolto poi un ruolo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
fondamentale nell’ispirare la redazione del primo articolo della Legge fondamentale tedesca: «la
dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla». Ed è forse
proprio il concetto di dignità umana, insieme a quello, ad esso connesso, d’insondabilità verso il
futuro della natura umana, il canale di accesso più idoneo per entrare nel laboratorio concettuale e
multidisciplinare del suo pensiero.
L’antropologia filosofica in Plessner nasce da un’esigenza fondamentale: ripensare una concezione
“essenziale” della natura umana, un criterio di riconoscibilità dell’identità e dell’universalità
antropologica, dopo che si è sperimentato come le tradizionali immagini religiose e metafisiche del
mondo hanno perso il loro valore universalmente vincolante. E quasi presagendo ciò che, nel giro di
pochissimi anni, si sarebbe consumato con l’eugenetica e la biopolitica nazista, questa rifondazione
ha avuto fin dall’inizio un intento eminentemente “critico”: quello di determinare i limiti oltre i
quali saperi, tecniche, poteri, ideologie, mettono a repentaglio le condizioni di possibilità dell’uomo
quale essere vivente di carattere personale, i presupposti appunto della sua «intangibile» dignità
umana e della sua insondabilità pratica verso il futuro. Plessner sgancia però il concetto di dignità
umana dal riferimento tradizionale ad una destinazione del genere umano all’autodeterminazione
razionale e morale, e ripensa questo concetto come la prerogativa dell’uomo quale essere animale di
un certo tipo, mortale e vulnerabile, la cui specifica autonomia morale può prendere forma solo in
riferimento alla propria determinazione naturale e alla propria dipendenza sociale.
Il principio ispiratore di questa antropologia filosofica è allora che, per riuscire a determinare in
cosa consiste il tratto specifico e peculiare della natura umana, bisogna innanzitutto coglierne gli
aspetti che la legano al resto del vivente: assumere l’umano come un fenomeno che emerge dalla
vita e che da questa non può mai svincolarsi del tutto. Ma che cos’è la vita? L’intuizione
fondamentale di Plessner a questo proposito è stata che il tratto qualificante di ogni essere vivente,
ciò che lo distingue dall’essere inorganico, è la sua «prestazione limite»: il tracciare un limite o un
confine rispetto all’esterno, «che contemporaneamente fa apparire l’ambiente nel modo ad esso
specifico e fa apparire il limite stesso all’interno di un ambiente».[3] E questo già al livello più
elementare della vita: quello di una cellula, che diventa un essere vivente all’interno di un ambiente
inanimato, appunto, soltanto grazie alla membrana. Anche l’uomo, in quanto vivente, quindi, è
inserito all’interno di limiti corporei e in un ambiente corrispondente, è “posizionato”, ma la sua
caratteristica peculiare, la sua differenza rispetto all’animale, è quella di trovarsi nello stesso tempo
al di fuori di questi limiti e aperto al mondo. L’uomo ha una «posizionalità eccentrica»: è un vivente
che può prendere distanza da sé e dal suo ambiente, oggettivare sé stesso e il mondo circostante. In
questo senso, afferma Plessner, è un essere costitutivamente utopico.[4]
Il punto è che l’uomo non può vivere soltanto in questo squilibrio «eccentrico» rispetto ai suoi
fondamenti naturali, ai quali comunque rimane vincolato: per vivere è costretto, a partire dalla sua
eccentricità, a dotarsi di ambienti artificiali, di nicchie culturali, che lo mettono in grado di
fronteggiare l’illimitata contingenza a cui la sua stessa posizionalità – che rimanda ad una natura
biologica povera d’istinti e di risposte geneticamente programmate agli stimoli ambientali – lo
mette in relazione. Da qui il vero e proprio «paradosso» della natura umana, che consiste nel dovere
oscillare continuamente tra due istanze tra loro in contraddizione, ma entrambe necessarie per poter
approntare le condizioni di una vita umana: l’istanza della chiusura ambientale e quella
dell’apertura al mondo. [4bis] In quanto formatore di mondi culturali, linguistici e storici, l’uomo
deve sempre operare processi di delimitazione e di riduzione di complessità rispetto all’illimitata
contingenza del mondo: costruirsi artificialmente ambienti culturali e istituzionali, ogni volta
determinati, in grado di selezionare quelle risposte e quegli schemi comportamentali di cui la sua
natura biologicamente povera di determinazioni non lo provvede. D’altra parte, però, proprio per
costruire questi mondi culturali, o per metterli in questione, quando questi vengono assolutizzati e
scambiati per identità sostantive e ascrittive, esclusive di altre, e che finiscono per abbasare la vita
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
umana al livello dell’animalità, l’uomo deve porsi sempre nello stesso tempo in contatto con
l’illimitata contingenza del mondo, far leva, ai fini della sua creatività, sulla sua posizionalità eccentrica.
Lo stato di buona salute di una cultura coincide con la sua capacità di sapere mantenere un
equilibrio virtuoso tra questi due momenti, quello della chiusura ambientale e quello dell’apertura al
mondo. L’assolutizzazione di uno solo di questi momenti genera invece patologie culturali. E
secondo Plessner, i mali della modernità occidentale ed europea, da ultimo sfociati nel modello di
modernizzazione sociale sostenuto dalle forme del capitalismo avanzato, è quello di soffrire di
un’assolutizzazione univoca del momento dell’eccentricità e dell’innovazione, che alla fine sottrae
costantentemente il terreno alle condizioni di possibilità di qualsiasi condotta di vita personale.
Anche ogni singolo rappresentante della specie umana, infatti, per vivere umanamente, è costretto
per Plessner a trovare un equilibrio tra questi due momenti: quello della chiusura e quello
dell’apertura. Per condurre la propria vita, ciascun uomo deve continuamente ricentrarsi:
incorporare modelli di comportamento e ruoli sociali, esprimersi in forme culturalmente e
socialmente articolate e determinate, tutto ciò insomma che nello stesso tempo svela e nasconde,
agli altri e a sé stessi, le espressioni della propria immediatezza vitale. Per Plessner, è solo in quanto
ciascun singolo apprende a vedersi da una prospettiva oggettivante a partire dai ruoli dello spazio
pubblico in cui è inserito, che egli può disporre del proprio corpo e dare forma personale alla
propria soggettività. Da qui la critica di ogni esaltazione dell’autenticità, dell’immediatezza,
dell’interiorità e, di converso, l’affermazione che gli uomini devono riconoscersi reciprocamente il
diritto a portare delle “maschere”, che tutelino dall’esposizione rischiosa della propria «nudità» e
«vulnerabilità». Laddove però, il presupposto del divenire sé stessi, rimane sempre, però, nello
stesso tempo, l’esperire il proprio corpo come qualcosa di spontaneo e d’indisponibile, di non
trasferibile e di non scambiabile: condizione necessaria per poter identificarsi con esso, per poter
distinguere tra le azioni imputabili a sé e quelle imputabili agli altri. L’uomo è sempre
simultaneamente l’uno e l’altro: un essere vivente animale ed un essere culturale e artificiale, «è un
corpo organico» e «ha un corpo fisico», e ciascun singolo è rimesso al compito ineludibile di
riuscire a bilanciare tra loro, nella propria condotta di vita, questi due aspetti della sua ambivalente
natura. Proprio in questo compito, in cui si rivela la fragilità ma anche la potenzialità di ciascuna
esistenza umana, sta la dignità umana di ogni singolo.
Tutto ciò spiega anche l’attualità di questa antropologia filosofica nell’ambito dei recenti dibattiti
bioetici, divampati attorno alla ricerca e all’ingegneria genetica. Dove passa, nella vita umana, il
confine tra naturale ed artificiale? E in che punto determinato, oltrepassare questo confine, per
esempio con tecniche di manipolazione genetica volte a predeterminare caratteri, predisposizioni e
capacità della futura persona, va a ledere il rispetto della dignità dell’uomo? E d’altra parte, è
applicabile il concetto di dignità umana anche alla vita prima della nascita? Oppure è appunto solo
l’atto, socialmente individualizzante, del riconoscimento pubblico in un mondo di vita
intersoggettivamente condiviso, a rendere l’organismo una vera e propria persona umana? Ma
allora, su quali basi ed entro quali termini si può riconoscere anche al vivente in quanto tale, agli
animali, al nostro ambiente naturale, diritti e riconoscimento, che ci obbligano a rispettarne il tratto
di indisponibilità? Come ha notato recentemente Jürgen Habermas - intervenendo sul dibattito
relativo ai «rischi di una genetica liberale» e riconoscendo, proprio in questo contesto, la
«straordinaria attualità» dell’antropologia filosofica di Plessner – sono tutte domande nuove e
inedite, intrecciate agli sviluppi della scienza e della tecnologia, ma che rinviano nello stesso tempo
alle questione fondamentali della stessa filosofia: al senso del nostro essere umani, della nostra
differenza dagli altri esseri viventi, della «nostra autocomprensione come esseri-di-genere».[5] E
proprio un indirizzo di pensiero come l’antropologia filosofica, con il suo principio fondamentale
secondo cui «una persona ha disponibilità “sul” suo corpo solo nella misura in cui – vivendo – “è”
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
questo stesso corpo in quanto organismo», si rivela un possibile e prezioso strumento di
orientamento in queste questioni. Come scrive Habermas: «il giovane che sia stato geneticamente
manipolato scoprirà il proprio corpo come qualcosa di tecnicamente prodotto. A questo punto, la
prospettiva del partecipante che caratterizza la vita vissuta entra in collisione con la prospettiva
oggettivante di produttori e sperimentatori. Infatti, al programma genetico i genitori hanno collegato
intenzioni che – trasformandosi in aspettative – investono il bambino come destinatario, senza
tuttavia concedergli la possibilità di una presa di posizione revisionistica».[6]
Abbiamo sollecitato su alcune di queste questioni uno dei maggiori esponenti in Germania
dell’impostazione di pensiero dell’antropologia filosofica: il filosofo tedesco Hans-Peter Krüger.
Per anni presidente della Helmuth-Plessner-Gesellschaft, Krüger ha condotto negli anni novanta
un’opera di sistematica riattualizzazione critica del pensiero di questo filosofo, stabilendo dei ponti
con la tradizione del pragmatismo americano (James, Dewey, Mead). Prima di dedicarsi a Plessner,
però, Krüger è stato anche un intellettuale attivo nei movimenti di opposizione democratica nella
DDR, subendo per anni, per questo suo impegno, il divieto d’insegnamento e di pubblicazione. E i
due eventi, quello del suo impegno politico a favore del pluralismo e della democrazia nella DDR, e
quello per la riattualizzazione critica dell’antropologia filosofica, come ci spiega in questa
intervista, non sono tra loro indipendenti, ma sono uniti da un sottile filo di continuità.
Professor Krüger, come è giunto all’antropologia filosofica di Helmuth Plessner?
Nel corso dei miei studi filosofici avevo già approfondito la semiotica di Charles Sanders Peirce e la
sua idea di una trasformazione della filosofia trascendentale kantiana nell’idea della scientific
community. Oltre alla filosofia avevo anche studiato psicologia, in particolare l’interazionismo
simbolico di George Herbert Mead e il programma di ricerca di Vygotskij. Tutto ciò era già in
qualche modo antropologia filosofica, anche se indipendente dalla tradizione dell’antropologia
filosofica tedesca. All’antropologia filosofica in senso stretto sono giunto in seguito, in particolare
attraverso il libro di Axel Honneth e di Hans Joas Soziales Handeln und menschliche Natur
(1980).[7] Tra i testi di Plessner ho letto per primo Die Verspätete Nation, per poter capire meglio
la linea di sviluppo che ha condotto nella storia tedesca all’Olocausto. Poi all’inizio degli anni
Novanta ho cominciato a leggere in modo sistematico Plessner e mi sono convinto che valeva la
pena riattualizzare, ricostruire e rifondare questa forma di antropologia filosofica.
Poco dopo la caduta del Muro, lei ha pubblicato un libro Demission der Helden (Dimissioni
degli eroi) in cui ha compiuto una sorta di bilancio della sua esperienza di intellettuale
dissidente nella DDR. In questo testo ha sviluppato anche una riflessione sul ruolo che gli
intellettuali devono svolgere nella sfera pubblica moderna, senza appunto proporsi come eroi
alla guida del tempo – per poi scoprire magari di essere semplici marionette e casse di
risonanza ideologica del potere di turno – ma ponendosi il compito di allargare i contenuti del
dibattito pubblico, compiendo innanzitutto un lavoro di traduzione tra sapere degli esperti e
mondo di vita dei cittadini. In che modo la sua esperienza di allora ha influito sulla sua
apertura nei confronti dei temi dell’antropologia filosofica?
La partecipazione all’opposizione all’interno della DDR negli anni settanta e ottanta è stata per me
un’esperienza decisiva. Negli anni settanta questa opposizione era ancora prevalentemente interna
al marxismo, negli anni ottanta, sotto il tetto della Chiesa, essa è divenuta sempre più pluralista e, in
un significato filosofico, liberale. C’erano cittadini di differenti orientamenti, religiosi e non
religiosi, di sinistra e di destra, che si trovavano insieme per criticare il regime autoritario e per
cambiarlo. Questa esperienza di pluralismo politico, insieme alla lotta per il valore e per la dignità
di ogni singolo individuo, come ciò che non può essere sacrificato a nessun ideologia, mi ha molto
condizionato. Il motto dell’opposizione nella DDR era il motto di Rosa Luxemburg: «la nostra
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
libertà è la libertà di coloro che pensano diversamente». Questa forma di opposizione aveva però
una qualità nuova, che le derivava dal suo essere non violenta e dal lottare per una democrazia
pluralista. Tutto ciò mi ha aperto per i temi di Plessner, che nella sua epoca non è stato né con
l’estremismo di destra né con quello di sinistra, ma ha rappresentato piuttosto un’idea di politica
pluralista in cui al centro stava il riconoscimento del valore del singolo individuo e la critica di ogni
tentativo di monopolizzare la questione umana, attraverso una comprensione univoca e conclusiva
della sua natura.
Ha fatto riferimento allo studio di Plessner Die Verspätete Nation. In questo testo, Plessner
sviluppa una ricostruzione storico-genealogica delle premesse del nazionalsocialismo,
andandole a ricercare nella storia profonda della Germania, in alcune strutture della
mentalità tedesca, intrecciate a filo doppio all’influsso del protestantesimo luterano. Una certa
«ascesi intramondana», propria in particolare di una borghesia educata al culto luterano
dell’interiorità, secolarizzato in quello delle professioni, e scarsamente educata al confronto
con il terreno ostico e concreto della politica e con una sfera pubblica pluralistica, è stata una
delle cause fatali, per Plessner, della ricettività di molti settori della popolazione tedesca nei
confronti del nazismo. Plessner ricostruisce in questo libro però anche il modo in cui si è
potuti giungere, nella storia intellettuale e filosofica tedesca, all’affermazione dell’ideologia
della razza nazista, e punta l’attenzione su una dinamica che egli denomina, riprendendo una
formulazione di Mannheim, «generalizzazione del sospetto di ideologia». Potrebbe illustrare
questo concetto?
Da più di duecento anni, nella nostra tradizione, gli intellettuali tendono ad assumere un compito
rivoluzionario. Per lo meno in Germania, il modello di questo compito – questa è una delle tesi
centrali di Plessner nel suo studio – è stata la rivoluzione copernicana. Dalla prospettiva esterna
dell’universo si mostra quanto è falsa la presupposizione tolemaica che il sole e la luna ruotano
attorno alla terra. Questo movimento di decentramento nell’universo, l’assunzione del posto dove
un tempo era Dio, comincia a divenire il modello di ciò che è moderno, il metodo attraverso il quale
è possibile smascherare la falsità del punto di vista del senso comune e della coscienza, di ciò che
testimoniano i sensi. Il punto è che nel corso del moderno questo modello è stato radicalizzato: si è
innescato un processo di generalizzazione del sospetto d’ideologia. Questo modello si è riversato
nella sociologia, nella scienza, nella filosofia, nella politica, e questo ha condotto a una battaglia tra
élites di esperti l’una contro l’altra armati, con la conseguenza che alla fine, per esempio nella
repubblica di Weimar, non c’era più alcun terreno di condivisione nella società civile e nella sfera
pubblica critica. E la Germania ha costituito la terra elettiva di questo processo perché in essa
mancava, a differenza di altri paesi occidentali, la consuetudine con un confronto civile con il
pluralismo nella sfera pubblica. Non si può solo decentrare, si deve anche preservare un grado
minimo di condivisione nella sfera pubblica, e i cittadini non possono essere solo smascherati da
avanguardie intellettuali. In questo senso abbiamo bisogno anche di un’attenzione al necessario
ricentramento rispetto alle rivoluzioni intellettuali, senza il quale non si dà alcuna condotta di vita
personale. Trovo tutto ciò molto attuale. Il capitalismo globalizzato ha bisogno continuamente
d’innovazioni per potersi mantenere in vita. Ormai è ben noto il fenomeno per cui esso si serve
delle rivoluzioni culturali annunciate in precedenza dagli intellettuali. Ciò che venti o trenta anni
prima élites di intellettuali annunciano come rivoluzione culturale e politica, venti o trent’anni dopo
diventa un oggetto di mercato, una linea di prodotto, una prestazione pubblicitaria.
L’autocomprensione critica si inverte nel suo contrario nel corso delle generazioni. Si deve quindi
riflettere, si deve ragionare pragmaticamente sulle conseguenze inintenzionali che la filosofia e il
pensiero critico possono avere. Non si può annunciare ingenuamente una rivoluzione, una
promessa, che venti o trenta anni dopo si ribalta nel suo contrario.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Negli anni ’90, parallelamente al suo lavoro di rilettura sistematica di Plessner, Lei ha curato
anche l’edizione tedesca del libro di John Dewey La sfera pubblica e i suoi problemi. Cosa può
insegnarci ancora questo libro, anche rispetto alle dinamiche a cui Lei ha fatto riferimento?
Io trovo che la concezione della sfera pubblica sviluppata da Dewey in questo testo sia ancora la
migliore e la più attuale. Muovendo dalla differenza tra pubblico e privato, Dewey definisce la sfera
pubblica facendo riferimento a tutti coloro che sono influenzati da conseguenze indirette e non
intenzionali di transazioni sociali. Oggi la sfera pubblica viene intesa per lo più in modo privato, ciò
che empiricamente viene inteso come sfera pubblica non dà alcun contributo alla gestione e alla
soluzione dei problemi connessi alle conseguenze indirette e non intenzionali dell’agire sociale.
Facciamo alcuni esempi: l’energia atomica, da Chernobyl fino a Fukushima, oppure le conseguenze
indirette e non intenzionali di molte innovazioni su mercati globali. Per la tematizzazione di questa
dimensione di problemi è necessaria la sfera pubblica, una sfera pubblica globale e una sfera
pubblica continentale. Oggi la sfera pubblica viene intesa però per lo più come un ambito dove si
ricerca la soddisfazione di bisogni narcisistici o privati, smarriamo con ciò la possibilità di
comprendere ciò di cui noi realmente abbiamo bisogno, e siamo spesso sviati in questo dai media,
che si occupano di cose false.
Quali sono oggi i fronti che polarizzano in termini ideologici il dibattito pubblico?
C’è sempre innanzitutto il dilagare del riduzionismo biologico, già ricostruito negli anni passati
dalla genealogia di Foucault. Oggi questo riduzionismo prende la forma di una promessa di
miglioramento della natura organica e sociale delle persone, attraverso psicofarmaci e terapie
mediche. Già da ciò si vede come questo riduzionismo biologico sia intrecciato alle forma di
riduzionismo economico: la promessa di un miglioramento dell’uomo va incontro alle esigenze dei
mercati, e ciò esige a sua volta deregolamentazione, quanto viene predicato dal neoliberalismo.
Oggi si sovrappongono perciò riduzionismi biologici ed economici, e l’intero rapporto tra cultura e
politica è compromesso e falsato. Ciò che manca oggi è la regolamentazione politica dei mercati,
ma anche l’impegno della società civile e della sfera pubblica critica, anche negli ambienti
accademici. Si deve spiegare precisamente quali innovazioni biologiche sono sensate e quali no,
quali sono le false promesse di terapie e quali le false patologizzazioni. Anche la politica deve fare
la sua parte, attraverso la regolamentazione dei mercati, non può semplicemente lasciar andare tutto
al corso delle generazioni. Ma abbiamo bisogno di qualcosa di più di una regolamentazione dei
mercati a livello nazionale: la regolamentazione dei mercati globali esige per lo meno un impegno
continentale europeo, e in più la cooperazione tra Europa, USA e Cina, altrimenti qualsiasi
contrappeso critico non basta per cambiare e regolare i mercati.
Spostando l’attenzione nuovamente sulla filosofia, molti oggi parlano dell’esaurimento della
spinta propulsiva del linguistic turn. In Italia e non solo divampa il dibattito sul Nuovo
Realismo. Lei, muovendo dall’antropologia filosofica, ha parlato per esempio, in relazione alla
teoria dell’agire comunicativo di Habermas e alla grammatologia di Derrida, di diverse
«strategie di denaturalizzazione in filosofia». Potrebbe spiegare questa affermazione?
Io ho letto e apprezzato la teoria dell’agire comunicativo di Habermas e la grammatologia di
Derrida durante gli anni ottanta e credo di aver compreso che dietro questi programmi di ricerca
c’era anche la volontà di ricercare strategie teoriche per congedarsi dalle spaventose premesse e
dalle conseguenze dell’Olocausto e delle dittature totalitarie del Novecento: il nazionalsocialismo e
lo stalinismo. Entrambi questi regimi totalitari si sono richiamati in diverso modo alla natura, ad un
concetto riduttivo di naturalismo: nel caso del nazionalsocialismo con il richiamo alla razza, nel
caso dello stalinismo con il richiamo alla classe, che ha finito anche per svolgere a propria volta una
funzione riduttiva e naturalizzante. Letti a partire da questa prospettiva, i programmi di ricerca di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Habermas e di Derrida, il concetto di ragione intersoggettiva comunicativa e la grammatologia,
possono essere interpretati anche come due tentativi di uscire fuori dalla natura, per produrre un
contrappeso rispetto alla natura. Io credo che questo alla lunga non può essere mantenuto. Ho
l’impressione che entrambi questi programmi di ricerca oggi debbano essere storicizzati. Bisogna
tematizzare la natura inorganica e la natura vivente, e ciò non in una forma riduttiva ma in una
maniera fenomenologica, ermeneutica e critico-ricostruttiva: la natura non deve essere solo
concepita come ciò che viene messo a tema dalle scienze naturali, anche la riflessione filosofica
deve elaborare questo tema.
In che senso allora il programma di ricerca dell’antropologia filosofica può dare una risposta
a questa esigenza?
Io trovo che Max Scheler ha impresso già negli anni venti del secolo passato una giusta svolta al
discorso filosofico, quando, criticando la dicotomia dualistica “o materiale o spirituale”, “o fisico o
spirituale”, ha sviluppato la tesi che il vivente non può essere scisso in regioni ontologiche: esso è
tanto materiale quanto spirituale, tanto fisico quanto psichico. E’ attraverso la negazione della
dicotomia dualistica “o-o” che si giunge dentro la tematizzazione della vita. Ma quando si è dentro
questa tematizzazione, allora servono nuove categorie, nuove differenziazioni. Per Scheler questa
era l’amore, l’estasi nell’amore, il terzo a partire dal quale egli ha compiuto nuove differenziazioni.
Plessner ha preso le distanze dalla metafisica dello spirito che Scheler ha sviluppato a partire da
questo concetto di estasi e ha provato a ricollocare la filosofia della vita su un terreno
fenomenologico e post-metafisico, e in ciò sta per me l’attrattività della sua rifondazione della
filosofia come antropologia filosofica.
NOTE
[1] H. Plessner, Die verspätete Nation. Über die politische Verfügbarkeit bürgerlichen Geistes, in
H. Plessner, Gesammelte Schriften, VI, Berlin, Surkhamp, 2003
[2] H. Plessner, I limiti della comunità. Per una critica del radicalismo sociale, a cura di B.
Accarino, Roma-Bari, Laterza 2001.
[3] Si veda la ricostruzione del pensiero di Plessner sul sito della Helmuth Plessner
Gesellschaft: http://www.helmuth-plessner.de/seiten/se...
[4] «La sua forma eccentrica spinge l’uomo al perfezionamento, stimola bisogni che possono essere
soddisfatti soltanto mediante un sistema di oggetti artificiali e insieme imprime loro il marchio della
caducità. Gli uomini ottengono in ogni epoca ciò che vogliono. E mentre l’ottengono, l’uomo
invisibile che è in loro si è già spostato oltre. Il suo costitutivo sradicamento attesta la realtà della
storia universale». H. Plessner, I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia
filosofica, a cura di Vallore Rasini, Torino, Bollati Bolinghieri, 2006, p. 363.
[4bis] Si veda su questo M. De Carolis, Il paradosso antropologico. Nicchie, mocromondi e
dissociazione psichica, Quodlibet, Macerata 2008.
[5] J. Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, p. 41.
[6] J. Habermas, cit., p. 52.
[7]A. Honneth, H. Joas, Soziales Handeln und menschliche Natur. Anthropologische Grundlagen
der Sozialwissenschaften, Campus-Verlag, Frankfurt a. Main - New York, 1980.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Tra Nichilismo e Illuminismo. Ray Brassier e la sfida del
realismo speculativo
di KNOX PEDEN
Continuando ad approfondire quei nodi di pensiero che, sempre più, sembrano richiedere
l’incontro tra la tradizione analitica e continentale, questo intervento si rivolge ad un lavoro che
coinvolge intenzionalmente queste due correnti del pensiero, intrecciando le filosofie di pensatori
quali Alain Badiou, Quentin Meillassoux, da un lato, e filosofi della mente quali Paul Churchland e
Wilfrid Sellars dall’altro. Ray Brassier – l’autore del testo di cui proponiamo la recensione – è
conosciuto internazionalmente soprattutto per essere uno dei più autorevoli rappresentanti del
Realismo speculativo[1], movimento di pensiero volto a ridefinire le basi del realismo filosofico,
alla luce delle sfide poste dalla filosofia post-kantiana. La recensione che presentiamo è ad opera
di Knox Peden, ricercatore presso il Centre for the History of European Discourses (Australia), ed
è apparsa – in forma parzialmente differente – sulla nota rivista di filosofia Continental Philosophy
Review[2].
Inframmezzato da elogi alla “splendente potenza della ragione” ed alla “forza dissociativa della
negatività non-dialettica”, Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction (Palgrave, 2007) di Ray
Brassier è un lavoro filosofico impegnato “nell’opera di disincanto iniziata da Galileo nel mondo
fisico, continuata da Darwin nella sfera biologica, ed attualmente estesa dalle scienze cognitive
all’ambito della mente” (xi, 45, 40).
Lo sgretolamento del “libro del mondo” realizzato durante l’illuminismo rappresenta “un
corroborante vettore di scoperta intellettuale, piuttosto che un calamitoso impoverimento” (xi),
infatti, “il pensiero ha degli interessi che non coincidono con quelli della vita” (xi). Seguendo tali
interessi, Brassier sviluppa un concetto di “volontà di conoscere” congruente con la “volontà di
nulla” che resiste alle contrapposte forze della “volontà di vivere”.
Animato dalla persuasione che “la filosofia dovrebbe essere più che un debole conforto
dell’autostima umana”, ovvero dovrebbe mettere in questione i presupposti antropocentrici che
ancora popolano il pensiero contemporaneo, Brassier sviluppa un progetto, il cui nucleo polemico
concerne la riabilitazione della scienza, in opposizione al riduttivo e derisorio atteggiamento di
alcuni settori della filosofia continentale: la fenomenologia e la teoria critica. I due assi portanti di
questo progetto sono i seguenti: (1) il recupero del nichilismo come programma filosofico che sia
antitetico al soggettivismo, piuttosto che complice con esso, (2) il riconoscimento che il nichilismo
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
sia la filosofia più adeguata a esprimere la rivoluzione, introdotta da Albert Einstein, inerente la
relazione spazio-tempo, contro quelle filosofie che si proclamano filosofie del tempo e trascurano la
necessaria congiuntura tra queste due dimensioni.
Il libro è diviso in tre sezioni. La prima parte, dedicata a distruggere “l’immagine manifesta”
(“Destroying the Manifest Image”) dell’uomo, rappresenta la critica introduttiva, in cui le scienze
cognitive ed il razionalismo contemporaneo di Quentin Meillassoux sono utilizzati contro la
fenomenologia e la teoria critica di Horkheimer ed Adorno.
Nella sezione centrale, “L’anatomia del negativo” (“The Anatomy of Negation”), Brassier elabora
un concetto non-dialettico di negazione che presuppone la demistificazione dell’ontologia svolta da
Badiou ed il principio ontologico di “unilateralizzaione” ricavato dalla “non-filosofia”di Francois
Laruelle.
La parte finale, “La fine del tempo” (“The End of Time”), conclude il testo con la considerazione
filosofica di Brassier sulla “verità dell’estinzione” (“truth of extinction”), come fatto spaziale che
nega, ed in realtà ha già negato, il tempo umano. Questa conclusione è sviluppata a partire
dall’abbandono della prospettiva heideggeriana e da una dura ed estesa critica della filosofia di
Deleuze. Nonostante l'acutezza della loro riflessione filosofica, Brassier, infatti, rintraccia in
entrambi questi pensatori la radice di un comune problema filosofico: l'aver legato assieme vita e
morte nelle maglie di una sintesi. Al contrario Brassier sostiene che l'unica possibile relazione
ontologica non è la sintesi, ma la negazione.
La tematizzazione della nozione di “negativo” permette anche di introdurre le due tesi cardine
trattate nel libro, le quali vanno adeguatamente distinte. In primo luogo, il nichilismo, “lungi
dall’essere una patologica esacerbazione del soggettivismo, è un inevitabile corollario alla
persuasione dell’esistenza di una realtà indipendente dalla mente” (xi). Sebbene questa prima tesi
nel libro possa a volte assumere i tratti di un principio normativo da cui far logicamente discendere
una politica, in ultima analisi, Brassier riesce a proteggersi da questo rischio.
Le istanze prescrittive per la filosofia contemporanea però non sono aliene al testo di Brassier ed
affiorano quando si esamina la seconda tesi, per la quale il “nichilismo rivisitato” è la più adeguata
filosofia del momento. Questa tesi è ricavata dall’idea che il “disincanto del mondo” sia un
conseguenza della “maturità intellettuale” e non del suo “debilitante impoverimento” (xi).
Celebrare l'Illuminismo come un "progetto" di disincanto contro "il revisionismo anti-illuminista"
promulgato da larga parte della contemporanea tradizione continentale, sembra implicitamente
comportare una serie di assunti che vanno ben oltre la critica al soggettivismo proposto nella prima
tesi.
Ad esempio, se da un lato, Brassier sconfessa la nozione in base alla quale c’è una singola e sovrastorica essenza della filosofia, che può essere chiaramente identificata e criticata in quanto tale,
un'ossessione che è fortemente presente in Heidegger e che rischia di compromette anche la
filosofia di Laurelle.
Dall’altro, egli sembra implicitamente sostenere che fare propria "la convinzione" di celebrare
l'illuminismo implichi anche un’idea di come la filosofa dovrebbe essere, reintroducendo qui
proprio quell'essenzialismo che egli critica a partire dalla nozione di soggettivismo. La radice di tale
ipoteca essenzialista va rintracciata non nella filosofia, ma nel ruolo che in essa sembra debba
giocare la scienza. Per Brassirer la critica all'essenzialismo filosofico è un modo per rifiutare di
leggere la filosofia come una manifestazione singolare di un'unica inedificabile essenza. Al
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
contrario, la scienza sembra possedere una singolare, elementare forza espressa in un concetto
centrale del suo argomento: il disincanto.
Descrivendo la scienza in sé come l’impegno del disincanto, Brassier attribuisce ad essa un
problematico potere normativo. La sua stessa scelta di favorire la neurofilosofia di Paul Churchland
al posto della fenomenologia di Husserl sembra in parte arbitraria, dato che egli stesso riconosce ad
essa gli stessi limiti tautologici della fenomenologia husserliana.
Il progetto di Churchland riguarda la distinzione tra un approccio al problema della coscienza che
cerca di ricondursi all’originaria esperienza pre-predicativa e
l’approccio che, invece,
riconosce l’incommensurabilità tra l’esperienza della coscienza ed il suo sostrato materiale.
Questa distinzione assume particolare valore nel secondo capitolo, quando Brassier discute la scelta
di Adorno ed Horkheimer di favorire, nella Dialettica dell’illuminismo, la mimesis sulla mimica.
La mimesis è superiore alla mimica, in quanto possiede una componente soggettiva, preferibile agli
aspetti automatici ed irriflessivi della mimica. La mimesis è dialettica e storica; la mimica respinge
ogni idea di cambiamento.
Tuttavia, Brassier ritiene che la mimica che inerisce agli animali, agli insetti, ed al mondo
inorganico sia la testimonianza di una negatività senza soggetto che supera la proliferazione
mimeticamente motivata della non-identità tra storia e natura. Infatti, Brassier ritiene che “la storia
culturale sia mediata dalla storia naturale, che include tempo e spazio, biologia e geologia” (48).
Dopo un'esaustiva discussione riguardo al tentativo di Meillassoux di pensare un tempo assoluto
indifferente all'esperienza umana – un progetto la cui prossimità con quello di Brassier verrà in
seguito esaminata – Brassier sposta la sua analisi su Badiou e Laruelle, con l’obiettivo di sviluppare
un concetto di “negazione” che possa servire da valida alternativa alla dialettica. Secondo Brassier,
la virtù del progetto ontologico di Badiou consiste nella demistificazione della nozione di essere,
mostrando che l'essere in quanto essere "è insignificante; non significa letteralmente niente"(116).
La tesi di Badiou che "la matematica è ontologia" funge in questo senso da risposta alla
fenomenologia, dal momento che – sottraendo le qualità fenomeniche – può elaborare una nozione
di pensabilità dell'essere in quanto inconsistente molteplicità infinita. Il gesto critico di Brassier
consiste nel suggerire che Badiou compromette il suo stesso progetto ontologico con il concetto di
"Evento", il quale introduce "un idealismo dell'iscrizione"(“an idealism of inscription”) in ciò che
sarebbe altrimenti un essere insignificante. Brassier rinuncia a sviscerare sino in fondo le
implicazioni della sua critica , vale a dire, che Badiou compromette la sua ontologia per salvare la
sua politica, dal momento che l'evento è, assieme con il soggetto fedele all’evento, una delle
categorie politiche centrali della filosofia del filosofo francese.
Spostando l'attenzione da Badiou a Laruelle, le ragioni della critica che Brassier muove a
quest'ultimo sono due. In prima istanza, l'autore denuncia l'ipoteca essenzialista della nozione di
non-filosofia nel momento in cui ad essa viene attribuita la capacità di definire la natura della
filosofia tout court. In secondo luogo, viene posta in questione l'indulgenza nei confronti del
concetto di "immanenza radicale", così come esso è elaborato da uno dei pensatori che sin dal
principio ha avuto un peso rilevante nel lavoro Laruelle, Michel Henry. Ma nell’economia generale
del libro, l'individuazione di tali punti problematici non toglie nulla all’importanza del “metodo di
unilateralizzazione” proposto da Laruelle: "una logica non dialettica della negazione
filosofica"(120), con le parole di Laurelle, "l'essere-nascosto del reale alla conoscenza, o...l'essere
forcluso di ogni oggetto alla sua propria cognizione...non rende la conoscenza possibile, ma
piuttosto la determina" (139). Ciò di cui Laruelle va in cerca non è niente meno che la messa in luce
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
della sintesi trascendentale che traccia la relazione tra pensiero e il suo correlato come oggetto
fondamentale della speculazione filosofica. Che l'operatore trascendentale sia letto come vita,
coscienza o Dasein, in tutti i casi il momento sintetico è essenziale. Al contrario, Laruelle permette
di definire "le condizioni per cui pensare non significa riflettere, o rappresentare il proprio oggetto
ma piuttosto mimare la sua inoggettivabile opacità, nella misura in cui quest'ultimo è identico-inultima-istanza ad un reale che è forcluso all’oggettivazione"(138). Questa analisi viene arricchita da
ulteriori elaborazioni teoretiche attraverso la lettura della parabola della catastrofe solare in Lyotard,
del concetto di “trauma” in Levinas e della teoria freudiana della pulsione di morte. L'audacia
speculativa di queste analisi permette a Brassier di argomentante in favore di una nozione di
pensiero come risultato o effetto determinato della materialità inorganica piuttosto che come luogo
privilegiato della considerazione riflessiva del problema. Data la sua ostilità nei confronti del
pensiero rappresentativo, Deleuze sarebbe probabilmente un valido alleato per il progetto di
Brassier. Ma pur riconoscendo le grandi virtù di tale progetto, quest'ultimo è – secondo Brassier –
fatalmente compromesso da un vitalismo da cui segue che il pensiero è determinante
essenzialmente organica della materia inorganica. Una tale concezione pone, in ultima analisi,
l'intero progetto di Deleuze a cavallo tra un panpsichismo mistico e un idealismo incoerente.
Oltre a Laruelle, l'interlocutore fondamentale di Brassier è Quentin Meillassoux, il cui lavoro è stato
recentemente introdotto nel mondo anglofono dalla traduzione ad opera dello stesso Brassier[3].
L’obiettivo critico del pensiero di Meillassoux è una malattia filosofica che lui chiama
"correlazionismo". Con “correlazionismo” si definisce ogni filosofia che "afferma l’indissolubile
priorità della relazione tra [il?] pensiero e il suo correlato rispetto all'ipostatizzazione metafisica o la
reificazione rappresentazionalista o entrambi i termini della relazione"(51). Brassier segue
Meillassoux nell'affermare "l'intellegibilità letterale" del fenomeno ancestrale – ovvero,
l’occorrenza cosmica precedente alla manifestazione della coscienza – contro l’inintelligibilità della
realtà in sé per la filosofia post-kantiana. Rimane però aperta una questione. Da un lato, l’autore
critica il correlazionismo poiché esso “sostiene che non ci può essere alcuna realtà intelligibile
indipendentemente alla nostra relazione con la realtà; alcun fenomeno senza qualche operatore
trascendentale – come la vita o la coscienza o il Dasein – che genera le condizioni per la
manifestazione attraverso cui il fenomeno si manifesta a noi"(51). Chiaramente Brassier interpretata
il correlazionismo – sia esso di matrice vitalista, kantiana o heideggeriana – come una forma di
solipsismo. Dall’altro, però, è lecito chiedersi come faccia la scienza – Brassier assume senza
estendervi la stessa critica radicale mossa al correlazionismo – a non ricadere nello stessa trappola
solipsistica.
Cosa sono gli strumenti della sperimentazione scientifica, se non operatori trascendentali, con tanta
variazione tra loro come per vita, coscienza o Dasein, e che "generano le condizioni della
manifestazione" del fenomeno? La tecnologia ad infrarossi "genera le condizioni" che permettono
alla Nebulosa del granchio non di esistere come il resto materiale di una supernova, ma di essere
manifesta grazie alle speciali lenti di un telescopio. Ma quello che importa in ultima istanza non
sono i colori della nebulosa, le sue mere qualità fenomeniche, ma il bruto fatto della sua esistenza.
A partire da tale considerazione si può tracciare una prima differenza tra Brassier e Meillassoux: le
ragioni che conducono Brassier a sostenere una filosofia non correlazionista sono in parte differenti
rispetto a quelle proposte dall’autore di Dopo la finitudine. La forza dell'argomento di Meillassoux
consiste nella riabilitazione del concetto di qualità primarie – esprimibili attraverso il formalismo
matematico. La filosofia non-correlazionista interpreta il "mondo glaciale" ripulito da tutti i
fenomeni eccetto uno: la fatticità stessa. Quello che importa non è la Nebulosa del granchio in
quanto fenomeno, ma il suo apparire. La virtù della matematica secondo Meillassoux non è quella
di essere scientifica, come Brassier sembra implicitamente suggerire, ma , invero, la sua pura
formalità, il suo esser libera da qualsiasi riferimento all’esperienza. Al contrario, la scienza in
quanto tale è condizionata dall’empirico e, infatti, molte delle immagini scientifiche proposte da
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Brassier rafforzano tale argomento: dagli insetti alle catastrofi solari, tutti questi esempi sono
intelligibili solo in quanto sono, appunto, fenomeni.
Un secondo punto che mette in relazione, ma anche divide i due filosofi riguarda la temporalità.
Brassier insiste che ciò che è anteriore al reame ancestrale di Meillassoux deve essere surrogato da
una posteriorità di estinzione cosmica, al fine di consolidare la critica alla filosofia correlazionista
in senso assoluto. In ciò, Brassier sostiene che la prospettiva di Meillassoux è ancora
antropocentrica in quanto legata ad una concezione lineare del tempo. Eppure, va messo in luce
come la tesi dichiaratamente "più assoluta" e radicale di Brassier nello smantellamento della
tradizione metafisica sia a sua volta compromessa da un fondamentale presentismo. Nella visione di
Meillassoux, Dio rimane una possibilità che si può dare nel futuro. Non per via di un sotterraneo
messianismo, ma perché Meillassoux porta alle estreme conseguenze la nozione di contingenza. Lo
stesso non vale per Brassier, il quale trova nei fatti scientifici una prova sufficientemente certa per
sancire l'impossibilità di alcuni eventi, restringendo quindi il campo del possibile e
conseguentemente ponendo in questione la contingenza assoluta.
Se il formalismo abiura la fenomenalità, questo anche spiega la complicità con – e in ultima analisi
la sua utilità per – il nichilismo. Brassier dà il suo meglio nello sviluppare questo argomento
filosofico. Sebbene la decisione di Brassier di abbracciare il nichilismo inauguri la sua analisi,
questa stessa decisione non è il risultato di una investigazione filosofica, ma funziona come
presupposto al suo pensiero. Questo significa che la forza polemica che motiva il suo lavoro
trascura di confrontarsi con altri sforzi intellettuali volti a problematizzare la nozione di nichilismo.
Nonostante ciò, Nihil Unbound rimane un testo che riesce ad essere all’altezza delle sue promesse e
offre al lettore il gusto della vera scoperta filosofica. A prescindere quindi dai suoi punti d’ombra,
il testo conferisce evidenza a una celebre idea di Adorno: “Il pensiero onora se stesso difendendo
ciò che è condannato come nichilismo”.[4]
NOTE
[1] A tal riguardo si veda anche l’intervista rilasciata da Quentin Meillassoux per Il Rasoio di
Occam.
[2] Cont Philos Rev (2010) 42:583–589.
[3] Dopo la finitudine. Saggio sulla necessità della contingenza, trad. it a cura di M. Sandri,
Mimesis, 2012
[4] Theodor W. Adorno. Dialettica negativa, Einauidi, 2004. La traduzione qui proposta è a cura
dell’autore.
Knox Peden ([email protected]è un post-doc presso il Centro di storia europea
dell'Università del Queensland (Australia). I suoi interessi di ricerca riguardano il pensiero
filosofico europeo del ventesimo e ventunesimo secolo, con particolare attenzione alla filosofia
francese. Fra le sue pubblicazioni più recenti si vedano la raccolte, curate con Peter Hallward,
Concept and Form, Volume 1: Key Texts from the Cahiers pour l'Analyse, (London: Verso,
2012) e Concept and Form, Volume 2: Interviews and Essays on the Cahiers pour l'Analyse,
(London: Verso, 2012).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Sesso, desiderio e verità in Grecia e a Roma. Su "Subjectivité
et vérité" di Michel Foucault
di ORAZIO IRRERA e DANIELE LORENZINI
Pubblicato in occasione del trentennale della morte di Michel Foucault, il Corso del 1980-1981
intitolato Subjectivité et vérité costituisce il penultimo dei tredici volumi che documentano
l’insegnamento del filosofo al Collège de France. Il tema esplicito di questo Corso è una
genealogia della nostra morale sessuale, grande questione teorica che, secondo Foucault, è
associata a una questione storica “privilegiata”: cos’è successo durante i primi secoli della nostra
era, nel momento di passaggio dall’etica che si è soliti definire “pagana” alla morale cristiana?
Con il Corso del 1980-1981 intitolato Subjectivité et vérité (a cura di Frédéric Gros,
Seuil/Gallimard, 2014) si aggiunge il penultimo tassello all’imponente impresa editoriale
cominciata nel 1997 e destinata a ricostruire e a restituire al grande pubblico la serie dei tredici
Corsi che Michel Foucault ha pronunciato al Collège de France tra il 1970 e il 1984 – impresa che
presto si concluderà con la pubblicazione del Corso del 1971-1972, Théories et institutions pénales,
l’unico a tutt’oggi ancora inedito. L’uscita di Subjectivité et vérité è coincisa con il trentennale della
morte di Foucault, che in Francia è stato accompagnato da una serie di eventi scientifici e
commemorativi: dai molti convegni (tra i quali la significativa tre giorni Foucault(s) 1984-2014,
organizzata recentemente dall’Université Paris 1 e dall’Université Paris-Est Créteil) ai numerosi
libri, dalle trasmissioni televisive e radiofoniche (il documentario Foucault contre lui-même andato
in onda su Arte e la serie che France Culture ha organizzato attorno alla questione Que faire de
Foucault aujourd’hui?) fino ai dossier su importanti quotidiani e settimanali (Le Monde des livres,
Le Nouvel Observateur, Libération) e ai numeri speciali di alcune riviste culturali a grande tiratura
come Le Magazine littéraire, Sciences humaines e Le Point.
Questa consistente lista di omaggi tributati negli ultimi mesi all’opera di Foucault rischia, tuttavia,
se non di oscurare, quanto meno di attenuare la rilevanza della pubblicazione di Subjectivité et
vérité, il primo di una serie di quattro Corsi interamente consacrati dal filosofo francese alla
questione del rapporto tra soggettività e verità nell’Antichità greca e romana.
Nonostante il titolo forse ingannevole, il tema esplicito di questo Corso è una genealogia della
nostra morale sessuale – grande questione teorica che, secondo Foucault, è associata a una
questione storica “privilegiata”: cos’è successo nel corso dei primi secoli della nostra era, nel
momento di passaggio dall’etica che si è soliti definire “pagana” alla morale cristiana (p. 21)? La
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
risposta di Foucault è sorprendente: molti elementi della cosiddetta morale cristiana sarebbero
infatti stati elaborati originariamente in un contesto diverso, ovvero nei trattati filosofici (in
particolare stoici) sulle “arti di vivere” fioriti in epoca imperiale. Ma le cose sono ben più
complesse di quanto appaiano.
Innanzitutto, da un punto di vista “quantitativo”, il maggiore sforzo di Foucault in Subjectivité et
vérité è rappresentato da una descrizione dettagliata del regime degli aphrodisia (le opere di
Afrodite) nella Grecia classica, e delle principali trasformazioni che tale regime ha subìto nella
Roma imperiale.
Il regime degli aphrodisia, secondo Foucault, è organizzato attorno a due grandi princìpi. Da una
parte, il principio di attività, ovvero la valorizzazione esclusiva, nell’atto sessuale, della posizione
attiva; perciò, il problema dell’etica sessuale classica è rappresentato dalla necessità di una
scrupolosa auto-limitazione, non tanto per rispetto della dignità del proprio partner sessuale, quanto
al fine di restare sempre padroni di sé, nonostante il carattere violento del piacere sessuale (pp. 8692). Dall’altra parte, il principio di isomorfismo socio-sessuale, secondo il quale il “buon” atto
sessuale deve rispettare le gerarchie socio-politiche: se è del tutto legittimo, per un uomo sposato,
avere rapporti sessuali (attivi) con uno schiavo di sua proprietà, non lo sarà però averne con la
moglie di un altro uomo (pp. 79-86). Questi due princìpi, variamente combinati, definiscono
secondo Foucault i criteri di valorizzazione dell’etica sessuale classica, che non si fonda quindi su
una serie di interdetti chiaramente codificati.
Tuttavia, prendendo spunto dalle ricerche di Paul Veyne[1], Foucault sostiene che il regime degli
aphrodisia abbia subìto una profonda trasformazione in epoca romana, cedendo il posto a un’etica
sessuale incardinata sul legame coniugale (pp. 103ss.). In questo contesto, solo l’attività sessuale
che ha luogo all’interno della coppia sposata e che è finalizzata alla procreazione, piuttosto che alla
ricerca del piacere, è considerata “legittima”. I due princìpi che caratterizzavano il regime classico
degli aphrodisia vengono dunque rielaborati: da un lato, la posizione passiva (tradizionalmente
quella della donna) è valorizzata attraverso un’inedita insistenza sull’importanza della reciprocità
dei sentimenti, del “consenso” espresso dal partner e della costruzione di una vita in comune;
dall’altro, il «continuum socio-sessuale» si sgretola, giacché la coppia sposata rappresenta ormai
una realtà specifica, eterogenea e irriducibile a tutti gli altri rapporti sociali (p. 104).
È così che, secondo Foucault, emerge per la prima volta il desiderio in quanto nozione autonoma. Il
nuovo imperativo di fedeltà al quale l’uomo sposato deve attenersi, infatti, lo obbliga a dissociare,
in sé, la virilità “sociale” dalla virilità “sessuale”: le relazioni sociali gerarchiche vengono desessualizzate, mentre l’uomo sposato è chiamato a strutturare il rapporto sessuale con la propria
moglie in modo egualitario, evitando ogni forma di dominazione. Per farlo, egli deve esercitare su
di sé un controllo scrupoloso, al fine di neutralizzare sul nascere ogni desiderio inappropriato. Ed è
proprio attraverso il desiderio, concepito come «principio di soggettivazione/oggettivazione degli
atti sessuali» (p. 293), che emerge la “sessualità” in quanto dimensione permanente della
soggettività.
Se, in Subjectivité et vérité, Foucault mette radicalmente in discussione la tesi di una cesura netta tra
la morale pagana e quella cristiana, non bisogna però affrettarsi a concludere per una continuità
senza differenze. Nel fare la storia della morale, infatti, si può insistere sui «codici di
comportamento» che determinano ciò che è permesso e ciò che è proibito (da questo punto di vista,
una certa continuità tra l’Antichità greco-romana e il cristianesimo è innegabile), ma ci si può anche
concentrare sulle «forme di soggettivazione»[2]. Assumendo tale prospettiva diviene possibile
comprendere non solo come il regime classico degli aphrodisia sia profondamente diverso da
quello elaborato in epoca imperiale, e a fortiori da quello cristiano, ma anche come la stessa etica
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
sessuale romana presenti in realtà una configurazione dei rapporti tra la soggettività e la verità del
tutto incompatibile con quella che emergerà nel cristianesimo.
Attraverso lo studio dell’etica sessuale antica, del resto, è proprio il nesso tra la soggettività e la
verità che Foucault giunge a problematizzare, individuandovi sia un momento di cesura storica, sia
un nuovo orizzonte di ricerca all’interno del quale si svilupperanno le sue analisi future. In effetti,
interrogandosi sullo statuto del regime discorsivo degli aphrodisia in epoca ellenistica e romana,
Foucault mostra come questi discorsi non siano né un semplice riflesso, opportunamente codificato,
di pratiche sociali già esistenti, né un mascheramento ideologico che nasconde causalità storiche più
profonde e materiali, né tantomeno un programma volto ad accordare un fondamento razionale a
sistemi prescrittivi di comportamento che ambiscono all’universalità (pp. 229-248). La
problematizzazione morale degli aphrodisia è invece comprensibile solo all’interno del quadro
costituito dalle technai peri ton bion, le arti di vivere, ovvero quelle “tecniche” che prendono ad
oggetto la vita, l’esistenza (p. 253). Tali tecniche sono pensate da Foucault come procedure regolate
e riflesse volte a operare su un oggetto determinato un certo numero di trasformazioni in funzione di
alcuni fini da raggiungere; esse si esercitano sul bios, ovvero sulla vita in quanto soggettività,
esistenza irriducibile tanto alle proprie determinazioni biologiche, quanto a un qualsivoglia statuto
sociale, a una professione o a un mestiere.
Pensare il bios greco sullo sfondo di queste “tecniche di sé”, delle quali Foucault parla per la prima
volta nell’autunno del 1980 a Berkeley e al Dartmouth College[3], non significa soltanto mostrare
attraverso quali trasformazioni una soggettività possa far propri certi schemi pratici di azione, ma
permette anche di individuare alcune significative differenze tra la soggettivazione antica e la
soggettivazione cristiana (e moderna), così come tra i corrispettivi rapporti tra soggettività e verità.
Se la soggettività, nel cristianesimo, è pensabile solo attraverso il suo rapporto costitutivo con
l’aldilà, mediante un’operazione di conversione in vista della salvezza e sulla base di una verità
profonda che ciascuno è chiamato a scoprire nella propria interiorità, quella dell’Antichità greca e
romana si svolge interamente entro un campo di immanenza definito dagli obiettivi che ogni
individuo si pone; inoltre, lungi dal richiedere un movimento di conversione orientato alla
contemplazione divina e alla rinuncia del mondo terreno, la soggettivazione antica implica un
incessante lavoro di sé su sé; infine, anziché dalla scoperta di un’“autenticità” nascosta negli arcana
conscientiae, il modello antico di soggettivazione è animato da una ricerca continua e indefinita che
mira alla padronanza di sé nelle mutevoli circostanze dell’esistenza individuale e collettiva. Di
conseguenza, la sfera delle attività sessuali, nell’Antichità greco-romana, è inserita da Foucault in
un campo di problematizzazione più ampio, nel quale la padronanza e il governo di sé diventano
condizione imprescindibile per l’esercizio del potere sugli altri, acquisendo dunque un valore
politico (pp. 280-293).
D’altronde, prendendo le mosse da queste analisi è possibile leggere in filigrana anche uno
spostamento relativo alla nozione stessa di verità. Già nel Corso al Collège de France del 1980[4]
Foucault aveva legato l’esperienza cristiana della carne e la dimensione ineliminabile della
concupiscenza all’emergere di obblighi specifici di veridizione a proposito di se stessi che
avrebbero preparato la strada all’oggettivazione del soggetto operata dalle scienze umane. Proprio
in questo frangente, inoltre, Foucault aveva sostenuto che il governo degli uomini è possibile, in
Occidente, solo attraverso la manifestazione della verità nella forma della soggettività. Seguendo lo
sviluppo di tali argomentazioni nei successivi seminari americani del 1980, tuttavia, si fa sempre
più chiaro che la verità legata alle tecniche di sé antiche non è definita né da una corrispondenza
con la realtà, né da qualcosa che si troverebbe nelle profondità della coscienza, in un’interiorità
psicologica da decifrare incessantemente. La verità in questione riguarda piuttosto la forza e la
radicalità grazie alle quali certi discorsi danno forma all’esistenza particolare di ciascuno. Il bios
greco si presenta così come la superficie su cui la verità si manifesta (ed è chiamata a manifestarsi)
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
secondo un rapporto tutto da costruire ed inventare, ma che costituisce nondimeno la cifra
essenziale della stilizzazione etica e politica dell’esistenza nell’Antichità greco-romana.
Questa doppia rivoluzione concettuale operata da Foucault attorno al rapporto tra soggettività e
verità, lungi dal rimanere confinata nella dimensione della pura teoria, mira del resto ad indicarci
l’urgenza di un compito pratico. Foucault, nei suoi lavori degli anni ottanta, utilizza espressioni
diverse per definirlo – “politica di noi stessi”, “etica del sé”, “estetica dell’esistenza” –, ma l’idea è
la medesima: come possiamo prendere coscienza del fatto che la forma della nostra soggettività è
radicalmente storica e contingente, come possiamo prendere coscienza della non-necessità e della
non-naturalità del “regime di verità” in relazione al quale tale forma è stata costituita, senza provare
al contempo il bisogno di cambiare gli aspetti del nostro rapporto con noi stessi, gli altri e il mondo
che troviamo inaccettabili? Senza provare, insomma, il bisogno di trasformare la soggettività che ci
viene imposta e di contestare il regime di verità che “naturalizza” tale imposizione? Il lavoro
storico-filosofico effettuato da Foucault sui testi antichi è dunque correlativo a un compito eticopolitico attuale: mettere continuamente in discussione ciò che siamo e concepire non solo il sesso,
ma lo stesso rapporto di noi stessi con noi stessi non come una fatalità, bensì come «una possibilità
di accedere a una vita creativa»[5].
NOTE
[1] Cfr. P. Veyne, La famiglia e l’amore nell’alto Impero romano (1978), in La società romana,
trad. it. C. De Nonno, Roma-Bari, Laterza, 1995.
[2] M. Foucault, L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, trad. it. L. Guarino, Milano, Feltrinelli,
1984, p. 34.
[3] Cfr. M. Foucault, Sull’origine dell’ermeneutica del sé, a cura di mf / materiali foucaultiani,
Napoli, Cronopio, 2012.
[4] M. Foucault, Del governo dei viventi. Corso al Collège de France (1979-1980), a cura di M.
Senellart, trad. it. P.A. Rovatti e D. Borca, Milano, Feltrinelli, 2014.
[5] M. Foucault, Michel Foucault, un’intervista: il sesso, il potere e la politica dell’identità (1984),
in Archivio Foucault 3. Estetica dell’esistenza, etica, politica, a cura di A. Pandolfi, Milano,
Feltrinelli, 1998, p. 295.
Orazio Irrera si è laureato in Filosofia all'Università di Pisa, proseguendo poi con un dottorato
in Filosofia in cotutela tra l'Università di Pisa e l'Université Paris 8. Attualmente collabora con il
Centre de Philosophie Contemporaine dell'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne ed è abilitato
come maître des conférences in filosofia e scienze politiche.
Daniele Lorenzini si è laureato in Filosofia e storia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ed è
dottorando in filosofia a Paris 12 (in cotutela con la “Sapienza” - Università di Roma).
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
L’altro ‘new realism’: anatomia del revival realista
anglosassone
di ALESSANDRO MULIERI
Da alcuni anni si assiste a un revival del realismo politico nella filosofia politica anglofona. A
differenza dell’addio al post-moderno che caratterizza il new-realism di Ferraris, quello
anglosassone si pone però come obiettivo il contrasto all’egemonia del pensiero di John Rawls e
dei suoi seguaci entro il dibattito filosofico-politico anglosassone.
New-realism non significa soltanto addio al post-moderno. Da alcuni anni, un altro spettro realista
si aggira per l’Europa sfidando ortodossie consolidate e provocando contese animate tra filosofi
analitici e continentali. Si tratta del revival realista che sta interessando il dibattito più recente di
una parte della filosofia politica anglofona. Il new-realism di Maurizio Ferraris, descritto nel
manifesto pubblicato dal filosofo torinese nel 2011, è un approccio basato sulla verità delle nostre
pratiche quotidiane e contrapposto al post-moderno e al pensiero debole. Ferraris rifiuta l’assunto
nicciano alla base di quest’ultimo (non esistono fatti ma solo interpretazioni) e certi luoghi comuni
del post-moderno contemporaneo i cui eccessi avrebbero in qualche modo portato alle
mistificazioni del populismo mediatico berlusconiano. Il new-realism anglosassone si pone invece
un obiettivo molto diverso: contrastare il pensiero di John Rawls e dei suoi seguaci che da almeno
tre decadi dominano il mondo anglofono della filosofia politica. A fare da manifesto informale di
questa nuova tendenza filosofica è stata un’edizione speciale dello European Journal of Political
Theory pubblicata nel settembre 2010[i]. Tra i contributors di questo numero speciale ci sono figure
di spicco dell’accademia britannica come Mark Philp, Richard Bellamy, Glen Newey e Richard
North. Uno dei primi articoli di questa special issue si presenta come una mappa concettuale del
nuovo filone realista anglofono ed è a firma di William Galston, filosofo affiliato alla Brookings
Institution[ii].
Che cosa contraddistingue il new-realism anglosassone? Un primo dato essenziale è la sua estrema
varietà. Lungi dall’essere una semplice critica della filosofia politica tutta interna al dibattito
analitico, il new-realism sfida certi luoghi comuni relativi alla distizione tra le cosiddette filosofie
politiche analitiche e continentali nel mondo anglofono. Alcuni esponenti di questa corrente
tendono a presentarlo come una reazione di alcuni filosofi britannici alla filosofia politica liberale
americana[iii]. Tuttavia il quadro della sua nascita e del suo sviluppo è più articolato. In sintesi,
direi che la svolta realista anglosassone e’caratterizzata da due tendenze che riassumono
efficacemente la mappa concettuale proposta da Galston nel suo articolo. Una prima tendenza si
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
sviluppa tra coloro che potremmo definire analitici eterodossi. Bernard Williams, definito dalla New
York Review of Books come un filosofo analitico con l’anima di un umanista, è certamente il
simbolo di questa prima tendenza del new-realism[iv]. La sua critica al liberalismo rawlsiano e, più
precisamente, alla priorità del concetto di giustizia costituisce il nocciolo della critica realista alla
filosofia di Rawls. Williams contrappone moralismo politico a realismo politico attribuendo a
quest’ultimo una funzione di rottura col primo[v]. Secondo la posizione realista di Williams,
standard appropriati di analisi e valutazione dell’azione politica non possono che emergere
dall’interno della sfera stessa del politico e non da norme di comportamento extra-politiche o
provenienti da altri ambiti del sapere o della realtà. Questa critica di Williams a Rawls non porta
necessariamente a esiti radicali: vari filosofi politici contemporanei analitici non respingono in toto
il pensiero di Rawls, ma tentano di colorarlo in senso realista. In un articolo apparso recentemente
sul Journal of Political Philosophy e intitolato “Justice and the priority of politics to morality” (la
giustizia e la priorità della politica sulla moralità), Andrea Sangiovanni, docente di filosofia al
King’s College di Londra, si fa promotore di quello che definisce un approccio alla giustizia
dipendente dalla pratica (a practice-dependent approach)[vi]. L’articolo non è citato nel contributo
introduttivo di Galston, ma figura a buon diritto in questo filone analitico del revival realista nella
filosofia politica anglosassone. Sangiovanni propone di mantenere il concetto di giustizia ma
sostiene che le istituzioni e le pratiche storiche e istituzionali di ogni società ne condizionano la
giustificazione e l’applicazione (questo in contrasto a un approccio rawlsiano puro che limiterebbe
la rilevanza di pratiche e istituzioni della società soltanto all’applicazione dei principi di giustizia e
non anche alla loro alla giustificazione).
La seconda tendenza del new-realism anglosassone incoraggia il ritorno sotto i riflettori del
pensiero di alcuni filosofi continentali nell’ottica di una critica strutturata del pensiero rawlsiano e
liberale. È il caso, ad esempio, della filosofa belga Chantal Mouffe che usa la figura e il pensiero di
Schmitt per criticare il concetto di democrazia deliberativa difeso da Rawls o da Habermas (spesso
sovrapposti nel pensiero della filosofa)[vii]. O del filosofo americano Raymond Geuss che utilizza
la Scuola di Francoforte, le analisi anti-kantiane di Nietzsche o dei teorici critici come punti di
contrasto con il costruttivismo kantiano che è alla base del liberalismo rawlsiano (forse
identificando in maniera troppo netta il Kant filosofo morale con il Rawls “filosofo morale
applicato”)[viii]. O infine, in ambito americano, di filosofi nicciani di sinistra come Judith Shklar o
Bonnie Honig, la prima fautrice del liberalism of fear (“il liberalismo della paura”) e la seconda
famosa per le sue critiche “agonistiche” al consensualismo della teoria democratica
contemporanea[ix]. All’interno di questa seconda tendenza c’è anche un ramo più “storico” che
utilizza la storia del pensiero politico come strumento di interpretazione e codificazione della
riflessione politica sul contemporaneo sempre nell’ottica una critica metodologica all’approccio
rawlsiano (reo di essere troppo poco attento alla specificità storica e culturale di ogni forma di
società). Appartenente a questo secondo filone è ad esempio il filosofo politico oxoniense Mark
Philp, che partendo dallo studio del carattere della riflessione politica in Machiavelli e nei classici,
propone un approccio empirico alla condotta pubblica fondato sul giudizio politico e scevro da
interventi normativi precedenti all’azione politica stessa[x]. Ma ci sono anche esponenti importanti
della famosa scuola di Cambridge (allievi di Quentin Skinner e John Pocock) che fanno del lavoro
sulla storia del repubblicanesimo il punto di partenza delle proprie riflessioni sulle democrazie
contemporanee in contrasto con la nozione liberale di libertà.
La critica new-realist alla filosofia politica rawlsiana
In sintesi , il new realism in filosofia politica rappresenta un insieme di posizioni tra loro molto
diverse che hanno come grande comun denominatore l’opposizione alla filosofia liberale americana
di John Rawls o Ronald Dworkin. Occorre dunque accennare brevemente al contenuto di questa
critica e cercare di capire in che senso possa essere qualificata come realista. L’articolo citato di
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Galston ci spiega in maniera molto chiara quali sono i caratteri fondamentali della contestazione
new-realista al pensiero di Rawls. Secondo Galston (ma questa convinzione è ribadita nella parte
introduttiva di quasi tutti i contributi al citato numero speciale dello European Journal of Political
Theory), l’accusa di molti new realisti al sistema rawlsiano è che tiene ad emarginare, negare o
considerare irrilevanti le forze reali del politico eliminando dal nucleo della riflessione politica
concetti chiave come potere, conflitto, resistenza, lotta, di fatto riducendo lo studio della politica a
quello di un ramo della teoria morale. In realtà, Rawls nega che la sua filosofia politica sia filosofia
morale applicata spiegando che la teoria della giustizia come equità non è una dottrina filosofica,
morale o culturale onnicomprensiva o applicabile a qualsiasi soggetto ma funziona se applicata al
caso speciale della società democratica moderna. In questo senso, nella misura in cui la teoria della
giustizia ralwsiana include principi morali, questi ultimi sono ricavati dall’ethos pubblico di una
società democratica. Tuttavia, il fatto che le concezioni morali di Rawls non siano meramente
applicate al funzionamento di una società democratica ma, nell’ottica del filosofo americano,
derivino dalla sua cultura pubblica non salva il suo sistema dall’accusa di moralismo politico
lanciata dai new-realisti. Galston menziona la già citata critica di Bernard Williams al sistema
rawlsiano che può essere presa come paradigmatica dell’accusa più generale di moralismo politico
lanciata dai realisti al sistema di Rawls[xi]. Nell’ottica di Williams, è il rapporto tra giustizia e
politica a costituire il nodo problematico del liberalismo rawlsiano. Infatti, la giustizia non è la
prima virtù delle istituzioni sociali perché concetti come ordine e legittimità hanno un primato
epistemologico e filosofico che rappresenta la condizione stessa dell’idea di giustizia. Il primo
problema politico per Williams, che in questo caso si richiama a Hobbes, è quello di assicurare
l’ordine nella società e non, come fa Rawls, quello di chiedersi se esista un criterio normativo extrapolitico sulla base del quale possiamo valutare il senso e il contenuto dell’azione politica giusta. La
risoluzione del problema dell’ordine richiede innanzitutto una riflessione sul concetto di legittimità
politica, ciò che distingue potere legittimo e forza bruta[xii]. Tuttavia, quest’ultimo non può essere
definito in condizioni normative ideali e per così dire extra-politiche, come avviene per l’ideale di
giustizia in Rawls, ma emerge all’interno delle forze stesse del politico tenendo conto di circostanze
storiche e culturali che sono in continua evoluzione. Questo è ciò che più propriamente distingue in
filosofia politica, secondo Bernard Williams, una prospettiva moralista e una realista ed è anche ciò
che genera l’equivoco per cui la filosofia di Rawls finisce per difendere un’idea di normatività
extra-politica che sovrappone la filosofia politica a quella morale. Due caratteristiche qualificano
dunque il new-realismo rispetto alla filosofia di Rawls: il ritorno dell’autonomia del politico e una
ridefinizione del concetto di teoria normativa, concetto tanto caro a quella filosofia politica
anglofona che è il target principale del new-realismo.
L’autonomia della politica e la nuova teoria normativa
In linea generale, il ritorno all’autonomia del politico significa una riscoperta delle forze reali che
costituiscono l’azione politica e la differenziano da qualsiasi altra forma di azione. Le definizioni
date dai new-realisti delle forze reali dell’autonomia del politico sono le più diverse. Si va da una
riscoperta del valore agonistico e antagonistico della politica di Mouffe all’esclusività del giudizio
dell’azione politica presente nell’analisi machiavelliana di un Mark Philp. Ma l’autonomia della
politica è anche quella che guida l’analisi delle circostanze della politica (ciò che costituisce
l’esclusivo dominio dell’agire politico in contrapposizione a qualsiasi altra forma di azione) di un
filosofo come Jeremy Waldron o che si evidenzia nel ruolo costruttivo che concetti come paura e
timore rivestono nell’affermazione e la difesa dei principi dell’individualismo liberale in una
filosofa come Judith Shklar. Tuttavia l’elemento costruttivo (e non semplicemente critico delle
filosofie liberali anti-politiche rawlsiane) che accomuna tutti i new-realisti nella loro affermazione
dell’autonomia politica è la riscoperta del concetto di potere. Non un potere post-moderno o simile
a quello analizzato nella biopolitica foucaultiana e nelle filosofie di Deleuze, Guattari o Tony Negri,
ma un potere che potremmo definire più legato a circostanze fattuali o a realtà tangibili nella vita
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
quotidiana delle persone. Per i new-realists il potere ha delle manifestazioni concrete, per esempio,
nelle conseguenze imprevedibili che vengono dalla creazione delle istituzioni politiche o nel
conflitto. Come spiegato da Galston, la creazione, la preservazione e la distruzione delle istituzioni
politiche giocano un ruolo fondamentale nel veicolare il potere tra gli individui di qualsivoglia
regime politico[xiii]. La partecipazione degli individui alle istituzioni politiche talvolta ne modifica
l’identità o i valori, ne condiziona le scelte future e i comportamenti sociali ed è un veicolo
fondamentale delle forme del potere. Altro aspetto fondamentale della manifestazione del potere è
nel conflitto e nel ruolo che le emozioni possono avere nella definizione dell’interazione politica. Il
conflitto è un aspetto intrinseco della politica, ne definisce le dinamiche essenziali e pensare di
poterlo sradicare ricorrendo a teorie normative di gestione del conflitto rischia di misconoscere le
forze essenziali della politica. Partendo da posizioni radicalmente diverse, sia Mouffe che Williams
si trovano d’accordo nel considerare il conflitto e il disaccordo la linfa essenziale dell’agire politico,
in qualche modo irrisolvibile, ma sempre tendente a creare equilibri precari e contingenti nell’agone
politico di cui bisogna analizzare pazientemente e di volta in volta le specifiche dinamiche[xiv].
Questo ruolo essenziale del potere veicolato tramite le istituzioni e il conflitto porta i realisti a
riformulare il concetto stesso di teoria normativa in uso tra i filosofi politici anglosasoni.
La teoria normativa cui sono interessati i new-realisti rompe l’associazione tra dimensione
prescrittiva della riflessione politica e teorie morali dell’agire stabilito dalla filosofia politica
rawlsiana. Mentre per Rawls la teoria normativa diventa un generatore di modelli prescrittivi e un
criterio di giudizio morale dell’azione politica giusta, per i new-realisti la normatività non emerge
da condizioni extra-politiche ma è parte integrante dell’azione politica stessa stabilendo un rapporto
complesso con quest’ultima. Come ricordato da Enzo Rossi in un articolo della stessa edizione dello
European Journal of Political Theory, l’articolazione di qualsiasi teoria normativa è di per se stessa
sempre una forma di attività sociale e come tale deve essere considerata e valutata nel rapporto tra
riflessione politica e political reale[xv]. Per il new-realismo, la teoria normativa può diventare una
forma di trasformazione radicale della società che aspira a cambiare l’esistente e, se necessario, a
rovesciarne alcuni aspetti fondamentali. In questo senso e in certe sue articolazioni, il new-realismo
anglosassone può essere anche interpretato come un rottura con il liberalismo e un’apertura di una
parte del mondo filosofico anglofono ai nuovi movimenti di contestazione dell’ordine globale
(Occupy Wall Street o gli indignados).
I due new-realism e lo spirito dei tempi
C’è un rapporto tra il new-realism di Ferraris e quello emergente dal mondo anglofono? La
questione è complessa e richiederebbe un’analisi lunga e articolata. Tuttavia, una risposta
immediata alla domanda sarebbe ispirata da uno spontaneo scetticismo. Le due svolte new-realiste
si sono sviluppate in maniera totalmente indipendente l’una dall’altra, parlano lingue molto diverse
e si riferiscono a modelli culturali e filosofici differenti che hanno come target di critica tradizioni
completamente divergenti. In più, mentre il new-realism di Ferraris assume i contorni di una
tradizione omogenea riferibile a pensatori precisi, quello anglofono è un movimento eterogeneo
senza un manifesto e unicamente delimitato da una certa opposizione alla filosofia politica liberale
rawlsiana. Dobbiamo allora concludere che l’utilizzo di quest’etichetta comune, “new realism”, sia
soltanto una curiosa coincidenza linguistica? Credo che la povertà concettuale di questa risposta la
squalificherebbe in partenza e ci impedirebbe di porre il problema all’interno di una riflessione più
generale sull’interazione tra idee e accadimenti storici e culturali. I due new-realism sono
accomunati da un fattore fondamentale che ritorna nelle loro rispettive critiche alle tradizioni
filosofiche da cui si dipartono: il valore dei fatti nudi e crudi come criterio-guida per la riflessione
filosofica (quello che Ferraris chiama l’inemendabilità o il carattere saliente del reale mentre i newrealisti ne parlerebbero più genericamente come delle forze reali della politica). Inoltre, entrambi
contrastano approcci metolodogici e epistemologici fondati su modelli di interpretazione della realtà
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
troppo centrati sul pensiero o sulla teoria normativa e promuovono una lettura complessa ma
concreta degli accadimenti politici e sociali. Questo ritorno ai fatti nudi e crudi o alle forze della
politica de-ideologizzate e de-mistificate può essere criticabile sotto tanti punti di vista. Tuttavia,
nell’epoca di Internet e del dominio incontrastato della realtà virtuale, ha un che di certamente
paradossale.
NOTE
[i] European Journal of Political Theory, Special Issue on Political Realism, 9:4.
[ii] William Galston (2011): Realism in Political Theory, European Journal of Political Theory, 9:4,
385-411.
[iii] Questa la descrizione di un panel sul realismo all’ultimo convegno di political theory per
giovani studiosi tenutosi alla conferenza annuale dell’università di Manchester Mancept 2012: “The
mid to late twentieth century saw a number of British moral, political and legal philosophers make
significant contributions to the study of political thought, but which frequently differed from the
predominantly abstract and moralistic output of their American counterparts”. (Traduzione mia: Il
periodo tra l’inizio e la metà del ventesimo secolo ha visto un numero di filosofi morali, politici e
legali dare un contributo significativo allo studio del pensiero politico, distinguendosi dalla
produzione astratta e moralistica che caratterizzava le loro controparti americane).
[iv] New York Review of Books, 10/04/2013.
[v] Bernard Williams (2005), In the Beginning was the Deed: Realism and Moralism in Political
Argument, Princeton, Princeton University Press.
[vi] Andrea Sangiovanni (2007) , “Justice and the Priority of Politics to Morality’, (2008) Journal
of Political Philosophy 36/2: 137-64.
[vii] Si veda ad esempio Chantal Mouffe (2000), The Democratic Paradox, Verso books.
[viii] Cfr. Raymond Geuss (2009), Philosophy and Real Politics, Princeton: Princeton University
Press.
[ix] Judith Shklar (1998), Political Thought and Political Thinkers, ed. by Stanley Hoffmann e
Bonnie Honig (2003), Political Theory and the Displacement of Politics, Ithaka, NY: Cornell
University Press.
[x] Mark Philp (2007), Political Conduct, Cambridge, MA: Harvard University Press.
[xi] William Galston, cit. p. 387.
[xii] Bernard Williams, cit., p. 92.
[xiii] William Galston, cit, p. 393.
[xiv] Bernard Williams, cit., e Chantal Mouffe (2005), On the Political, London: Routledge.
[xv] Rossi E. (2010), ‘Reality and Imagination in Political Theory and Practice: On Raymond
Geuss’s Realism, in European Journal of Political Theory 9(4): 504-512, p. 510.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Alessandro Mulieri è dottorando in filosofia politica presso il Centre for Global Governance
Studies e l’Istituto di filosofia politica dell’Università di Lovanio in Belgio. In passato ha
studiato filosofia all’Università “La Sapienza” e Relazioni internazionali presso la London
School of Economics.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
La filosofia delle donne: uguaglianza, differenza, in-differenza
di PAOLO ERCOLANI
Nel secolare percorso della vicenda umana non c’è dubbio che quella della donna sia una storia a
sé. Le lunghe ed estenuanti lotte condotte dall’«altra metà del cielo», prima alla ricerca
dell’uguaglianza, quindi, in epoca a noi più vicina, per rimarcare la differenza dall’essere
maschile, derivano innanzitutto da alcuni fondamenti della cultura occidentale, e da politiche
sociali concrete, che hanno impostato il rapporto con la donna all’insegna della discriminazione e
della maledizione.
1. Un antico pregiudizio
Che si tratti di un essere fisiologicamente connaturato al male, capace di accoglierlo e di produrlo (e
riprodurlo?) in maniera perfino inimmaginabile da parte dell’uomo, è convinzione radicata e
agevolmente riscontrabile nel panorama culturale dell’Occidente.
Se è la prima donna Eva a convincere il primo uomo Adamo a disobbedire al volere divino,
introducendo così nel mondo il peccato e soprattutto la morte, secondo la chiosa di S. Paolo (Biblia
sacra: Rom 5,12), morte che Dio non aveva previsto originariamente per la sua creatura prediletta
(Biblia sacra: Sp 2,24); è sempre una donna, stavolta la moglie, a tentare il buon Giobbe, descritto
di per sé come «integro e retto, timorato di Dio ed estraneo al male», esortandolo a maledire Dio per
tutti i colpi gratuiti ricevuti (Biblia sacra: Gb 1,1 e 2,9).
Né le cose andavano meglio nella cultura della Grecia antica, dove la donna era vista come un
essere irrazionale e ferino, sostanzialmente portatore di discordie, guerre e, infine, morte. Nel
poema esiodeo de Le opere e i giorni è Pandora, una donna, colei che recita il ruolo di portatrice dei
doni che gli dèi fanno agli uomini (fra i quali proprio le donne), dando in questo modo inizio alle
interminabili sciagure che da quel momento li avrebbero colpiti (Esiodo, Opere e giorni: vv. 80-82).
Paradigmatico il caso della Medea raccontata da Euripide, che in seguito al tradimento del marito
rivela quella che significativamente il tragediografo descrive come un’«indole odiosa e feroce che
tutta la riempie» (Medea, vv. 103-104), fino al punto di uccidere i figli e negargli persino la
sepoltura, pur di vendicare il proprio sentimento offeso e infliggere dolore al coniuge fedifrago.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Alla furia animale, la Medea di Euripide aggiunge anche l’immancabile nota irrazionale, per
esempio quando al marito Giasone che piangeva la morte dei due cari («Figli miei diletti») ella, che
pur li aveva uccisi con crudeltà, riesce a rispondere «[diletti] alla madre, non certo a te» (Medea, v.
1397). Una visione, quella di Medea, al tempo stesso olistica e totalitaria (il nucleo famigliare come
entità unica e indistinta, per cui il male che colpisce un singolo elemento coinvolge, deve
inevitabilmente coinvolgere anche tutti gli altri), ma anche figlia di una deresponsabilizzazione
ritenuta del tutto tipica della donna (non sono io a uccidere i figli, è stato mio marito con il suo
gesto fedifrago e distruttivo. Io anzi li amo, lui no).
Questa connotazione originaria con cui viene definita l’essenza della donna fin dai testi più antichi e
fondanti della tradizione occidentale, è certamente alla base di tutto il portato di discriminazioni
intellettuali e sociali che ne sono seguite, e che trovano in san Paolo, ideologo del cristianesimo, il
suggello più autorevole.
E’ lui, infatti, che pur in altre opere aveva pronunciato delle parole inaudite per quei tempi, ispirate
alla perfetta uguaglianza fra tutte le creature di Dio, comprese il maschio e la femmina (Biblia
sacra: Gal 3,26-28), ad esprimersi in maniera inequivocabile attraverso delle vere e proprie
sentenze che sarebbero rimaste indelebili sulla parete della coscienza cristiana e occcidentale:
Voglio tuttavia che sappiate che capo di ogni uomo è Cristo, capo della donna è l’uomo e capo di
Cristo è Dio […] Le mogli siano obbedienti al proprio marito come al Signore […] Le donne
tacciano nelle assemblee, perché non è permesso loro di parlare: siano sottomesse, piuttosto, come
recita la legge (Biblia sacra: 1Cor 11,3; Ef 5,22; 1Cor 11,8).
Una vera e propria paura della donna, mista a una sottovalutazione a dir poco sospetta, visti i toni
estremi, che certamente, come scriveva Jean Delumeau nel suo illuminante La peur en Occident
(1978: 309), non costituisce una prerogativa esclusiva dell’ascetismo cristiano, visto che a Roma si
considerava la «debolezza» o «pusillanimità» mentale della donna (imbecillitas mentis) come un
dato perfettamente naturale, e anche nella tradizione greca, malgrado l’ampio lasso di tempo che
separò le opere di Esiodo e Omero dall’Atene democratica, le cose non cambiarono molto, visto che
un campione della democrazia come Pericle poteva affermare (anticipando S. Paolo) che «la virtù
più grande di una donna è saper tacere» (cfr. Fossier 1991: 360).
2. Fra tradizione pagana e cristiana
L’analisi incrociata della tradizione cristiana e di quella pagana conduce sostanzialmente allo stesso
assunto di fondo: quello di una creatura, la femmina, viziata fin dall’origine, difettosa e quindi
portatrice insana di un virus malefico ben capace di distruggere l’armonia terrena, e anzi, a pensarci
bene, perfettamente in grado di identificarsi con quel «male» che è caratteristica della vita mondana
segnata dall’assenza di Dio e quindi del Bene (privatio boni).
Per la tradizione pagana Aristotele si impegna a descrivere con analisi minuziose l’inferiorità e la
difettosità dell’anatomia femminile rispetto a quella maschile, concludendo che le femmine «sono
per natura più deboli e più fredde, e si deve supporre che la natura femminile sia come una
menomazione» (Aristotele, De gen. anim.: 775a, 15-16), ma anche lo stesso Platone, pur alieno dal
maschilismo viscerale degli altri filosofi antichi, nel Timeo (90e – 91a) immagina che la donna sia
stata prodotta da un processo di corruzione dell’uomo.
Per la tradizione cristiana, si può ricordare S. Ambrogio, che nella fisiologica diversità fra l’uomo
che è spirito (mens) e la donna che è sensazione (sensus), riteneva di scorgere la risposta al quesito
teologico del tempo, cioè se fosse più colpevole Adamo oppure Eva nell’aver ceduto alla tentazione
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
del maligno: sicuramente Adamo, perché lei non era particolarmente furba, e aveva dalla sua la
scusante della stupidità» (S. Ambrogio, De inst. Virg.: PL 16, col. 325).
Ma anche S. Tommaso, che nella Summa theologiae riprende proprio Aristotele e la definizione che
questi dava della donna in quanto «maschio mancato» (mas occasionatus), per arrivare a
confermare la sua sottomissione e inferiorità rispetto all’uomo (subiectio et minoratio), nei
confronti del quale ella svolge un ruolo di aiuto, ma soltanto finalizzato a «cooperare alla
generazione» (in adiutorium generationis), perché per tutto il resto altri maschi potevano essere ben
più efficaci.
E del resto, che di solo aiuto si tratta, lo evinciamo dal fatto che anche nella procreazione è
comunque l’uomo, con il suo seme, a svolgere un ruolo attivo (virtus activa), mentre a quell’essere
«difettoso e mancato» (deficiens et occasionatus) che è la donna resta una mera funzione passiva di
instrumentum procreationis (Tommaso d’Aquino, Summa Theol.: I, q. 92, arg. 1,2, co. e ad. 1).
Insomma, irrazionalità, debolezza (fisica ed emotiva), pusillanimità, difettosità generalizzata della
sua natura, ma ancora, aspetto imperdonabile e irrecuperabile per la cultura cristiana, «porta del
Diavolo» (diaboli janua), «prima ad abbandonare la legge divina» (legis prima desertrix), di fatto
vera e propria incarnazione del male (Tertulliano, De cultu foem.: PL 1, col. 1419).
Siamo di fronte a un marchio indelebile, destinato a caratterizzare per secoli la reputazione e la
condizione della donna, nonché a giustificare ampiamente l’oppressione maschile e le
discriminazioni attuate nei suoi confronti lungo i secoli.
Marchio tanto indelebile quanto influente: indelebile perché non risolvibile neppure con
l’educazione e l’istruzione, influente perché capace di convincere di ciò persino una personalità
illuminata come quella di J.J. Rousseau (non certo l’unico), che nell’Émile ou de l’éducation scrive:
Tutta l’educazione delle donne deve essere relativa agli uomini. Piacere loro, essergli utili, farsi
amare e onorare da loro, allevarli da giovani e prendersi cura di loro da adulti, consigliarli,
consolarli, rendere la loro vita piacevole e dolce: ecco i doveri delle donne in tutti i tempi e ciò che
bisogna insegnargli fin dalla loro infanzia (Rousseau, O.C.: II, 637).
Il timore che la fragilità innata impedisse alle donne di impegnarsi negli studi più alti è stato
condiviso anche al di là dell’Oceano, e per di più quando già eravamo da poco entrati nel XX
secolo. Negli Stati Uniti, infatti, alcune commissioni mediche vennero incaricate di analizzare le
prime studentesse con lo scopo di prevenire il sovraffaticamento del cervello e verificare il timore
diffuso che lo studio troppo impegnativo potesse implicare la sterilità delle loro ovaie (Matthaei
1985: 5).
Un pregiudizio imponente e sedimentato nel sentire comune degli individui dalla matrice culturale
più varia e diversa. Un vero e proprio muro all’apparenza insormontabile, destinato a separare la
donna dal raggiungimento di una consapevolezza e di una riconoscibilità culturale e sociale in grado
di parificarla all’uomo.
3. Uguaglianza e differenza
La ricerca di una parità, infatti, o se si preferisce dell’uguaglianza, è stato il leit-motiv costante delle
prime battaglie culturali condotte in difesa delle donne, quasi un programma minimo di reazione, si
potrebbe dire col senno di poi, volto a tentare di scalfire quel grande muro costruito con le pietre
della maledizione e del pregiudizio.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Prendiamo il caso di Mary Wollstonecraft, per esempio, che esattamente trent’anni dopo l’Emilio di
Rousseau compone un’opera, forse la prima sistematicamente compiuta nel panorama della
letteratura femminista, che sembra una risposta diretta al filosofo francese.
Per esempio là dove scrive che «per rendere il contratto sociale veramente giusto, con lo scopo di
diffondere quei principi illuminanti che soli possono migliorare il destino dell’uomo, alle donne
deve essere concesso di fondare la propria virtù sulla conoscenza, cosa scarsamente possibile se non
vengono educate con gli stessi criteri e obiettivi degli uomini» (Wollstonecraft 1792 (1891): 250).
La scrittrice inglese riconosce il livello inferiore delle donne dell’epoca, per lo più interessate
all’aspetto estetico, alle storie d’amore e alla sola, piccola e misera, dimensione privata. Ma imputa
tale condizione non a un’inferiorità congenita, bensì alla società governata dai maschi, che esclude
la maggior parte di loro dalla possibilità di ricevere un’educazione culturale e mentale adeguata.
Si tratta di un’esplicita richiesta di uguaglianza delle opportunità, con delle finalità neppure troppo
sconvolgenti (per l’ordine valoriale della tradizione occidentale). Infatti Wollstonecraft sottolinea sì
la «massima importanza» che deve essere riconosciuta all’educazione nazionale delle donne, con lo
scopo ultimo di renderle «creature razionali» e «libere cittadine» affinché possano diventare «buone
moglie buone madri» (Wollstonecraft 1792: 255 e 257).
Certo, si era saliti di livello. In quel «libere cittadine» era comunque insita un’istanza sociale che ha
caratterizzato per oltre un secolo la fase cosiddetta «liberal-democratica» della lotta femminista, e
che si poneva come scopo quello di far raggiungere alle donne un trattamento paritario all’interno
delle società liberali che si erano affacciate alla rivoluzione industriale.
Fatto sta che i protagonisti della tradizione liberale si guardarono bene dall’accogliere tale istanza,
tanto che anche lo stesso pregiudizio negativo nei confronti delle donne fece riscontrare un salto di
qualità. Non più confinato alla sola sfera dell’indole e della conformazione fisica più debole (e
quindi inferiore), ora si tentava di bollare la donna come costituzionalmente incapace di coltivare
delle virtù pubbliche e civili, insomma di interessarsi al bene della collettività e della società. Ed è
in nome di questo ulteriore pregiudizio che i pensatori liberali, ma anche gli stati che si
richiamavano a tale nobile tradizione, esclusero per secoli le donne dal godimento di quei diritti
politici e sociali che pur essi teorizzavano con tanta enfasi.
Basti pensare al padre del liberalismo economico, Adam Smith. Questi, ritenendo che il possesso
della generosità e dello spirito pubblico fosse fondato sullo stesso principio della giustizia, distingue
la generosità dall’umanità e conclude che quest’ultima è una virtù della donna, mentre la prima
appartiene all’uomo. Il «sesso debole» è sì fornito di umanità e maggiore sensibilità rispetto al
maschio, ma si tratta di una dote che si estrinseca nella sfera privata, quella della cerchia ristretta
degli affetti. Nel più ampio ambito sociale la donna è meno generosa e meno disposta a impiegare i
beni propri o della propria famiglia per il bene della collettività (Smith 1759: 190).
Allo stesso modo la pensava Tocqueville, compiaciuto nel notare come nella democrazia americana
ci si guardava bene dall’impegnare le donne negli affari politici e sociali, che esulassero da
quell’ambito famigliare in cui lei è sì la regina, ma comunque sottoposta all’uomo che ne è il «capo
naturale» (chef naturel) (Tocqueville 1951 sgg., t. I, v. II: 219-220).
Non c’era niente da fare, insomma, perché il pregiudizio naturalistico si estendeva con grande
facilità anche all’ambito sociale, portato avanti da quegli stessi autori liberali da cui era lecito
attendersi una ricerca dell’uguaglianza delle opportunità.
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
È a partire da questi presupposti che il movimento femminista decise di compiere un salto di
qualità, concentrandosi sul principio della «differenza sessuale» e non più su quello
dell’emancipazione e della ricerca della parità fra uomo e donna.
Gli scritti di autrici come Luce Irigaray e Julia Kristeva ebbero un’influenza enorme soprattutto sul
movimento femminista italiano, artefice di una dura requisitoria contro il concetto di uguaglianza
inteso come momento incapace di valorizzare le differenze di un essere, quello femminile, che
doveva uscire dall’ordine costituito maschile e liberarsi dai rischi dell’omologazione. Insomma, se
«lo sfruttamento delle donne è fondato sulla differenza sessuale, non può risolversi che attraverso la
differenza sessuale», secondo le parole della stessa Irigaray (Boccia 2002: 155-8).
La donna, insomma, almeno quella immaginata dalle femministe, prende le distanze da quel cosmo
maschile che l’ha culturalmente bollata e relegata ai margini più bassi del consorzio sociale, e nel
fare questo, in maniera coerente, si trova a rimettere in discussione ogni aspetto della storia del
pensiero, della storia e della prassi politica, persino del linguaggio, poiché questi sono tutti rami di
una pianta malata all’origine: la pianta di un mondo pensato dagli uomini e per gli uomini, in cui la
donna è destinata a recitare un ruolo marginale, quando non subordinato o del tutto strumentale
(servile).
4. Per un nuovo femminismo tra Freud e Hegel
Non è compito di questo saggio tentare di trarre un bilancio della deviazione estremistica posta in
essere dal movimento femminista negli ultimi decenni del XX secolo, né certamente di tentare un
bilancio esaustivo della vicenda femminile nel suo complesso, quanto piuttosto evidenziare quello
che mi sembra un ulteriore salto di qualità nel rapporto tra filosofia e pensiero femminista.
Questo ulteriore salto di qualità è composto certamente da slanci in avanti significativi, ma anche da
ripensamenti tanto inaspettati quanto prolifici sul piano della speculazione scientifica e su quello di
una nuova percezione che le donne posso avere della propria identità di genere.
L’occasione è fornita dall’uscita, per i tipi di Mimesis, del Manifesto per un nuovo femminismo, a
cura di Maria Grazia Turri (pp. 236), filosofa ed economista dell’Università di Torino, che si avvale
dei contributi di studiose e studiosi di estrazione culturale e ambiti disciplinari diversi.
Dalla lettura di questo testo, veniamo a scoprire un cambiamento radicale di atteggiamento che si
manifesta fin dalla premessa contenuta nel saggio intitolato «Specchio», della psicologa e
ricercatrice dell’Università di Bologna Sara Giovagnoli. La cui lettura mi ha ispirato una parafrasi
del celebre incipit del Manifesto di Marx ed Engels: un fantasma si aggira dentro l’animo di ogni
donna! Tremendamente capace di condizionarla, di fornirla di senso come anche di annichilirla.
Si tratta dello sguardo dell’uomo, una sorta di vero e proprio specchio interiore attraverso cui la
donna cerca quell’approvazione in cui reperire finalmente una propria identità pacificata.
In questa strettissima dipendenza dall’approvazione dello «sguardo» maschile risiedevano l’errore
fatale e la debolezza congenita della donna fin dai tempi di Simone de Beauvoir, che nel suo celebre
Il secondo sesso (1949) scriveva già di una «fanciulla che ha sognato se stessa attraverso gli occhi
di uomo: negli occhi di un uomo la donna crede finalmente di ritrovarsi» (de Beauvoir 1949: 627).
Lo scopo supremo dell’amore umano è il medesimo dell’amore mistico, ossia l’identificazione con
l’amato, la ricerca della sua approvazione, il bisogno di servirlo, di trovare in esso l’identità e il
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
senso della vita, che altrimenti sfuggono tragicamente relegando l’individuo in una dimensione
chiusa e soffocante. Senza speranza alcuna di un possibile salvezza.
L’essere che ama per antonomasia è la donna, come scriveva il Nietzsche de La gaia scienza,
capace del «dono totale dell’anima e del corpo», con una dedizione incondizionata che fa del suo
amore «una fede, la sola che abbia» (cit. in de Beauvoir 1949: 623).
La forza dell’uomo consisterebbe proprio in questo disequilibrio, perché esso non si concede mai
del tutto, non abdica mai per farsi servitore della donna amata, mentre a lei è concesso di amarsi
soltanto attraverso l’amore che ispira, secondo le parole di de Beauvoir riportate in apertura del suo
saggio da Giovagnoli (p. 195).
Questo aspetto, possiamo dire consustanziale all’animo femminile, è quanto forse è stato più
trascurato dall’ala estremista del movimento femminista, che nel rimarcare la «differenza» delle
donne ha spesso dimenticato di «pensare» (e quindi concettualizzare) quelli che sono gli elementi
anche di debolezza insiti in quella differenza:
Così come Freud vedeva nelle donne della sua epoca il motivo portante del disagio della civiltà e il
simbolo evidente della repressione sociale – scrive Giovagnoli con perspicacia profonda e
suggestiva – così oggi, nell’illusiva parvenza di parità, nella corsa alla conquista del negato,
possiamo vedere nella donna moderna una persona altrettanto frustrata, non più vittima della
repressione sociale, ma della sua stessa repressione. È lei stessa che si vincola, che si impone delle
rinunce, che castra il suo essere donna e si getta tra le braccia della nevrosi. Forse è meglio cadere
vittima per propria mano che per quella altrui? Meglio una castrazione autoinflitta di una subìta?
Ma poi, a prezzo di tutto ciò, le donne di oggi hanno realmente maggior potere? Abbiamo parlato
dell’attrazione, sfruttata come oggetto, un mezzo per arrivare alla mèta finale (affermazione
dell’intelletto). Ma, a parere di chi scrive, più che una proprietà della donna, sembra una
concessione dell’uomo. Nell’illusione del pieno controllo del mezzo, ci troviamo ancora una volta a
subire una decisione altrui. Il credere di sfruttare questo potere è un misero ripiego per nascondere
un’ulteriore imposizione. È in realtà l’uomo che ci concede il potere illusorio dell’attrazione, che
non è mai appartenuto fino in fondo alla donna. Scarso o nullo è, in verità, il potere che ella ha sulla
razionalità maschile (p. 206).
Ora, tralasciando il fatto, peraltro non marginale, su quanto converrebbe all’economia globale della
società che la donna riuscisse effettivamente a «scalfire» l’impianto razionale dell’uomo (materia di
discussione pressoché infinita), bisogna prendere atto di un dato filosofico sostanziale che sembra
uscire da questo Manifesto: la proposta di riappacificazione del pensiero femminista con Freud (o
quantomeno un tornare a leggerlo con obiettività e profitto), il cui contenuto obiettivamente
maschilista di alcuni scritti è stato fin troppo volgarmente esasperato, ma anche con Hegel, il
pensatore su cui le femministe storiche proponevano di «sputare».
E non tanto lo Hegel che riproduceva gli schemi reazionari già visti, per esempio nella
Fenomenologia dello spirito, in cui definisce il «feminino» come l’«eterna ironia della comunità»,
l’elemento limitato e limitante pronto a sminuire il fine universale del governo riconducendolo a
fine privato, a «possesso e orpello della famiglia», oppure nella Filosofia del diritto, dove
attribuisce all’uomo una vita sostanziale e reale che si realizza nello stato e nella scienza, a
differenza della donna, per cui ciò avviene esclusivamente nell’ambito della famiglia (Hegel 1807,
v. 2: 34; 1821: § 166).
Quanto piuttosto, potremmo dire, con il metodo dialettico hegeliano, nella misura in cui esso
permette di superare la contrapposizione duale maschio/femmina, per rimettere al centro il concetto
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
di individuo, non più sospeso nella dicotomia differenza/uguaglianza, ma riconosciuto e sintetizzato
nel concetto di libertà (che le contiene, o le dovrebbe contenere, entrambe).
Un aspetto quanto mai centrale per l’epoca odierna, in cui occorre andare oltre, e qui risiede una tesi
dirompente del volume, per superare quel femminismo anacronistico che, rimanendo comunque
ancorato alla rigida distinzione di genere (o «differenza»), dimentica «tutto il resto del mondo»,
come scrive la curatrice Maria Grazia Turri nel suo lungo saggio introduttivo. Come per esempio i
gay uomini, a cui una femminista storica del calibro di Luisa Muraro voleva negare il diritto di
adozione dei bambini, ma anche i transgender, gli ermafroditi etc..
Mai come oggi, insomma, un pensiero femminile e femminista che voglia superare le rigide
dicotomie dell’ordine maschile, nonché la logica del dominio e dell’esclusione che lo sottende, deve
innalzarsi alla considerazione dell’individuo nella sua irriducibilità generica e sessuale, compiendo
un salto di qualità che comprenda le persone non nella loro «differenza», quanto piuttosto nell’indifferenza che le caratterizza come esseri umani (a prescindere dal sesso, dalla razza, dal censo
etc.). Cosa che del resto era stata intuita già da Judith Butler nel suo Gender Trouble del 1990 (ora
rieditato in italiano attraverso una pregevole edizione per i tipi di Laterza: J. Butler, Questioni di
genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, pp. 221), là dove scriveva che «la categoria del
sesso e l’istituzione naturalizzata dell’eterosessualità sono costrutti, fantasie o feticci, categorie
politiche e non naturali» (Butler 1999: 126).
Il superamento dell’antico pregiudizio di cui è stata vittima la donna, in nome del quale si è
esercitato su di essa un dominio secolare, non può essere superato, almeno non da un pensiero
femminista che opera in un’epoca e in una civiltà evolute e libere, attraverso la riproduzione di
schemi dicotomici che possono generare nuove forme di dominio e di esclusione. Attraverso questo
snodo fondamentale può essere ancora attuale il grande contributo, e la nobile lotta, che il pensiero
femminile e femminista hanno condotto, conducono e condurranno contro quella volontà di potenza
che alberga irrimediabilmente nell’essere umano. Uomo, donna, gay o transgender che sia.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Aristotele: il testo greco delle singole opere è citato dall’edizione Aristotelis Opera, 11 vv., E
Tipographeo Academico, Oxonii 1837
Biblia sacra: vulgatae editionis, Sumptibus P. Lethielleux, Parisiis 1891 (i passi biblici vengono
citati direttamente nel testo secondo la vulgata canonica)
Boccia M.L. (2002): La differerenza politica. Donne e cittadinanza, Il Saggiatore, Milano
Butler J. (1999): Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York –
London 1990
De Beauvoir S. (1949): Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 2008
Delumeau J (1983).: La Péché et la Péur. La culpabilisation en Occident, XIII-XVIII siècles,
Fayard, Paris
Esiodo: Opere e giorni, in Opere, testo greco a fronte, Utet, Torino 1977
Euripide: Medea, in Le tragedie, 2 vv., Mondadori, Milano 2007
IL RASOIO DI OCCAM – Numero 1 – marzo 2013
Fossier R. (1991): La société médiéval, A. Colin, Paris
Hegel G.W.F. (1807): Fenomenologia dello spirito, 2 vv., La Nuova Italia, Firenze 1973
Id. (1821): Lineamenti di filosofia del diritto, Bompiani, Milano 2006
Matthaei J. A. (1985): Histoire économique des femmes aux États-Units, L’Age d’homme, Paris
PL: Migne patrologia latina, 217 vv., in Patrologiae cursus completus, Paris 1845-1866
Platone: il testo greco delle singole opere è citato dall’edizione Platonis Opera – The Works of
Plato, 5 vv., Clarendon Press, Oxford 1901-1907
Rousseau J.J.: Oeuvres complete, 4 vv., A. Houssiaux Libraire, Paris 1852
Smith A.(1759): The Theory of Moral Sentiments, Liberty Fund, Indianapolis 1984
Tocqueville A. (1951 sgg.): Oeuvres complètes, Gallimard, Paris
Tommaso d’Aquino: Summa theologica, diligenter emendata, De Rubeis, Billuart et aliorum notis
selectis ornata (1266-1273), 6 vv., Marietti, Torino 1932
Turri M.G., a cura di, (2013): Manifesto per un nuovo femminismo, Mimesis, Milano
Wollstonecraft M. (1792): A Vindication of the Rights of Woman, Scott, London 1891
Paolo Ercolani insegna storia della filosofia e teoria e tecnica dei nuovi media all’Università di
Urbino. Collabora all’inserto culturale del Corriere della sera («La Lettura»), è redattore
della rivista Critica liberale, oltre che fondatore e membro del comitato scientifico
dell’Osservatorio filosofico (www.filosofiainmovimento.it). Fra i suoi libri, che più volte hanno
suscitato un dibattito acceso sui media nazionali: Il novecento negato. Hayek filosofo politico
(Perugia 2006); Tocqueville: un ateo liberale (Bari 2008); La storia infinita. Marx, il liberalismo
e la maledizione di Nietzsche (Napoli 2011) e L’ultimo Dio. Internet, il mercato e la religione
stanno costruendo una società post-umana (Bari 2012).