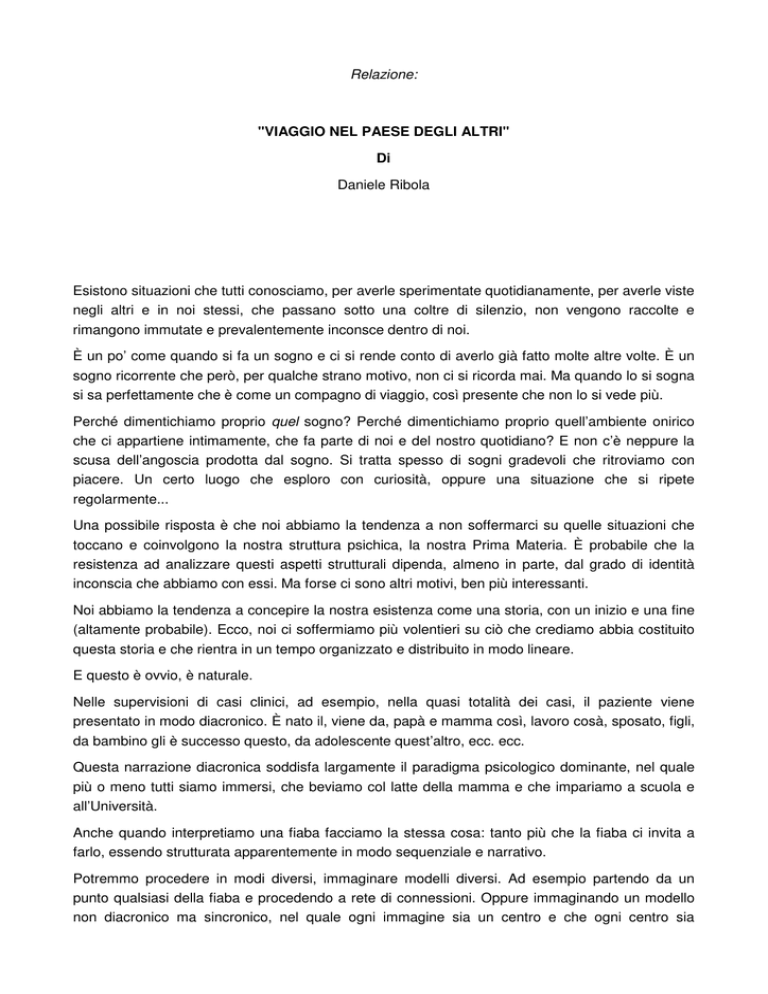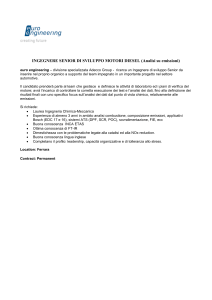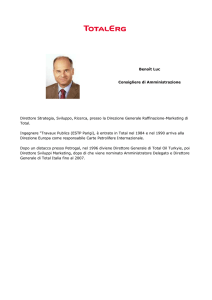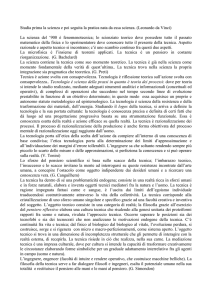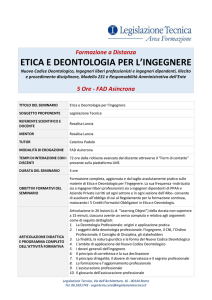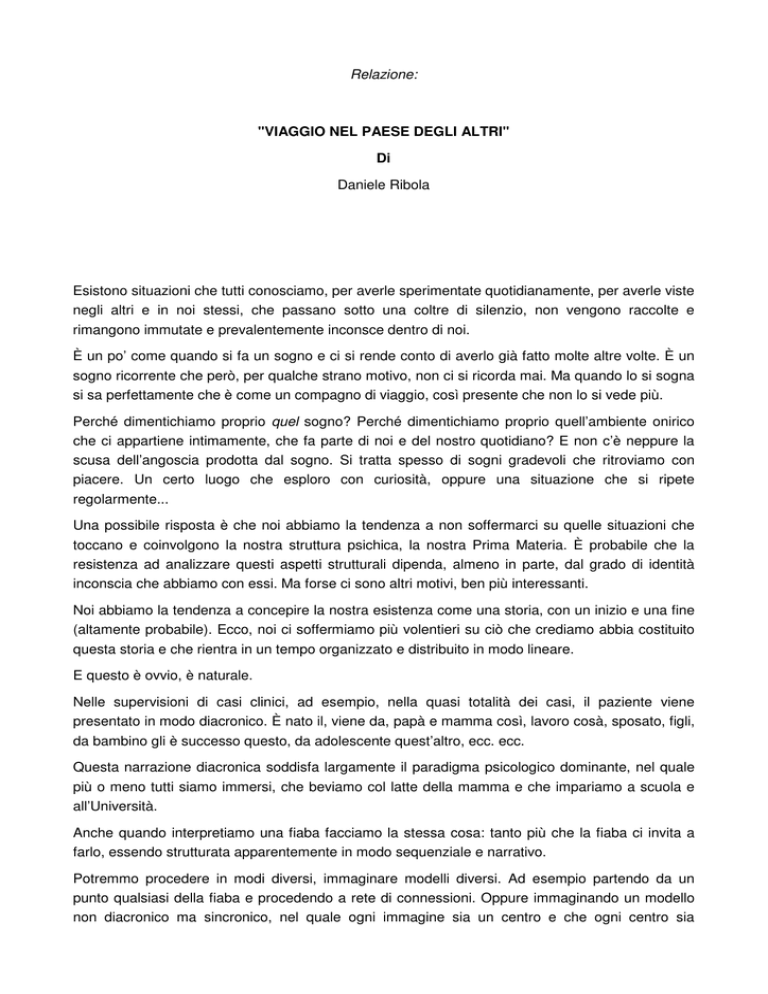
Relazione:
"VIAGGIO NEL PAESE DEGLI ALTRI"
Di
Daniele Ribola
Esistono situazioni che tutti conosciamo, per averle sperimentate quotidianamente, per averle viste
negli altri e in noi stessi, che passano sotto una coltre di silenzio, non vengono raccolte e
rimangono immutate e prevalentemente inconsce dentro di noi.
È un po’ come quando si fa un sogno e ci si rende conto di averlo già fatto molte altre volte. È un
sogno ricorrente che però, per qualche strano motivo, non ci si ricorda mai. Ma quando lo si sogna
si sa perfettamente che è come un compagno di viaggio, così presente che non lo si vede più.
Perché dimentichiamo proprio quel sogno? Perché dimentichiamo proprio quell’ambiente onirico
che ci appartiene intimamente, che fa parte di noi e del nostro quotidiano? E non c’è neppure la
scusa dell’angoscia prodotta dal sogno. Si tratta spesso di sogni gradevoli che ritroviamo con
piacere. Un certo luogo che esploro con curiosità, oppure una situazione che si ripete
regolarmente...
Una possibile risposta è che noi abbiamo la tendenza a non soffermarci su quelle situazioni che
toccano e coinvolgono la nostra struttura psichica, la nostra Prima Materia. È probabile che la
resistenza ad analizzare questi aspetti strutturali dipenda, almeno in parte, dal grado di identità
inconscia che abbiamo con essi. Ma forse ci sono altri motivi, ben più interessanti.
Noi abbiamo la tendenza a concepire la nostra esistenza come una storia, con un inizio e una fine
(altamente probabile). Ecco, noi ci soffermiamo più volentieri su ciò che crediamo abbia costituito
questa storia e che rientra in un tempo organizzato e distribuito in modo lineare.
E questo è ovvio, è naturale.
Nelle supervisioni di casi clinici, ad esempio, nella quasi totalità dei casi, il paziente viene
presentato in modo diacronico. È nato il, viene da, papà e mamma così, lavoro cosà, sposato, figli,
da bambino gli è successo questo, da adolescente quest’altro, ecc. ecc.
Questa narrazione diacronica soddisfa largamente il paradigma psicologico dominante, nel quale
più o meno tutti siamo immersi, che beviamo col latte della mamma e che impariamo a scuola e
all’Università.
Anche quando interpretiamo una fiaba facciamo la stessa cosa: tanto più che la fiaba ci invita a
farlo, essendo strutturata apparentemente in modo sequenziale e narrativo.
Potremmo procedere in modi diversi, immaginare modelli diversi. Ad esempio partendo da un
punto qualsiasi della fiaba e procedendo a rete di connessioni. Oppure immaginando un modello
non diacronico ma sincronico, nel quale ogni immagine sia un centro e che ogni centro sia
interattivo con tutto il resto della storia. In questo modo noi metteremmo in luce l’aspetto
strutturante e “di campo” generato da una certa immagine archetipica e vedremmo meglio in che
modo un certo archetipo tende a prendere forma, quale direzione evolutiva ci invita a seguire, con
quali altre immagini si rinforza.
Come diceva la von Franz, allo stato inconscio esiste uno stato di contaminazione profonda fra le
immagini archetipiche, tutto è legato a tutto. E lo sa bene chi si occupa di simboli. Appena si entra
in un’immagine simbolica si è immediatamente rimbalzati su altre immagini simboliche che sono in
qualche modo intimamente connesse e essenziali per la comprensione generale del simbolo.
Per usare un concetto della fisica quantistica tutto è entangled.
Sempre secondo la von Franz, d’accordo con il fisico David Bohm, è in questo stato che potremmo
eventualmente individuare un ordine diverso, che rimane di solito implicito e nascosto alla vista.
Ma torniamo alla proposizione iniziale: dicevamo che abbiamo la tendenza a non occuparci delle
questioni psicologiche che toccano problemi strutturali.
Una di queste mi pare sia la questione tipologica. Il problema è che, essendo la tipologia junghiana
di tipo strutturale ed essendo così raramente presa in considerazione, essa finisce per stare alla
base di molteplici fraintendimenti e conflitti interpersonali che rimangono invisibili.
Sappiamo troppo bene che queste conflittualità, in cui a nessuno viene minimamente in mente di
mettere in dubbio il proprio modello di realtà, portano, attraverso una catena di effetti perversi, a
conflitti ben più generali e collettivi che sfuggono al controllo e acquistano una autonomia
preoccupante.
Jung pensava che introversione e estroversione costituissero due opposti atteggiamenti generali
che rispondono a due forme di adattamento essenziali alla sopravvivenza della specie. Quindi con
base anche biologica.
La tigre si riproduce poco, ha molti strumenti di difesa e necessita di un enorme territorio. Il
coniglio ha pochissimi strumenti di difesa, si riproduce molto e ha poco bisogno di spazio.
Rimanendo nel modello tipologico è probabile che ogni processo conoscitivo, inteso nella sua
accezione più ampia e esperienziale, si realizzi e si sviluppi attraverso interazioni continue e
dinamiche fra un soggetto e un oggetto. Metto queste due parole fra virgolette perché non so bene
cosa significhino e uso questi concetti in modo del tutto provvisorio. Credo che soggetto e oggetto
siano due fenomeni altamente paradossali. Infatti sono ciò di cui quotidianamente facciamo
esperienza, ma sono inconoscibili nella loro essenza. Oltretutto possiedono una considerevole
variabilità e fluttuazione dovuta probabilmente alla loro reciproca permeabilità.
In altre parole, non sappiamo esattamente dove finisca il soggetto e dove inizi l’oggetto e
viceversa. Analoga considerazione possiamo fare per i concetti topologici di dentro e fuori, interno
e esterno, così fondamentali nella psicologia.
A causa del nostro modello culturale, prevalentemente estrovertito, noi sappiamo più o meno cos’è
l’oggetto esterno. L’oggetto interno è più vago e indicibile, ma dotato anch’egli di incontrovertibile
realtà. Può essere un’emozione, una fantasia, un’immagine psichica, o, ancora, un complesso.
Poiché di complessi ne abbiamo molti, e poiché i complessi possiedono una notevole autonomia e
poiché si comportano spesso come seconde o terze personalità, possiamo azzardare che il
-2-
fenomeno della conoscenza è dato dall’interazione, non fra un soggetto e un oggetto, ma fra molti
soggetti e molti oggetti. Tutti questi personaggi interagiscono fra di loro con modalità
profondamente intricate, producendo di volta in volta sinergie entropiche o neghentropiche.
Tutte queste interazioni sono, inoltre, altamente dinamiche, fluttuanti e poco stabili, un po’ come
delle onde che interferiscono l’una con l’altra.
Come faccia la psiche a trarre da questa enorme complessità un discorso congruo e
un’esperienza unitaria e relativamente continua nel tempo, è uno dei misteri che trovo più
appassionanti.
Credo che uno dei fattori che rende possibile questa relativa unità di esperienza è quello che Jung
chiama EINSTELLUNG, che viene tradotto in italiano con la parola ATTEGGIAMENTO.
L’atteggiamento è una disposizione naturale del soggetto a selezionare ciò che fa al suo caso (in
relazione alla sua struttura conscia e inconscia) e esclude ciò che non è funzionale o compatibile.
Sicuramente uno dei punti di ancoraggio nella formazione dell’atteggiamento è la disposizione
tipologica.
Sebbene il costituirsi della realtà sia il risultato di una continua interazione, noi, con una ingenuità
davvero sorprendente, continuiamo a credere nell’oggettività e incontrovertibilità del reale.
Dovremmo invece cominciare seriamente a renderci conto che questa interazione costituisce
qualcosa di provvisorio, instabile e continuamente discutibile.
L’oggetto informa il soggetto così come il soggetto informa l’oggetto.
L’orientamento introverso e quello estroverso (e non entro qui nel merito delle quattro funzioni)
sono quindi indispensabili alla formazione di questa bipolarità del vivente che sta alla base della
conoscenza.
La base neurologica di questi due atteggiamenti attualmente ipotizzata va nel senso di
un’intuizione già avuta dallo stesso Jung, pur non possedendo le conoscenze di cui disponiamo
oggi.
Sembra che ognuno possieda un set point, ovvero un punto di aggiustamento, personale del
sistema di attivazione reticolare. In sostanza ognuno possiede un certo numero e una certa
intensità di informazioni che partono dal tronco encefalico e arrivano alla corteccia. Chi possiede
un set point alto ha molte informazioni. Chi lo possiede basso ha poche informazioni.
Chi ha molte informazioni è molto attivato, molto sollecitato, e deve quindi produrre molte
elaborazioni. Ha quindi bisogno di più tempo e di più spazio. Possederà quindi un atteggiamento
prevalentemente introverso.
Chi è invece strutturalmente poco sollecitato ha bisogno di maggiori stimoli e possiede quindi un
atteggiamento di disponibilità e apertura verso la fonte stessa degli stimoli, assumendo un
atteggiamento estroverso.
Una cosa interessante però è che questi due atteggiamenti sono così strutturali, così costitutivi del
modo in cui viene elaborata l’esperienza, da produrre due diverse forme di realtà, due mondi, anzi,
due sistemi planetari, che continuamente entrano in conflitto e tendono ad escludersi
reciprocamente, proprio perché si pongono l’uno contro l’altro in modo assoluto ed esclusivo.
-3-
Il mio amico buddista è convinto che, meditando, contribuisce al miglioramento climatico.
L’altro mio amico, un ingegnere che si occupa di problemi energetici, dice che è vero, perché
l’amico buddista, meditando, consuma poca energia.
L’amico buddista si offende a questa battuta e, simulando un’apparente superiorità, si ritira in un
altezzoso silenzio. L’ingegnere lo guarda con affetto e comprensione.
È evidente che, pur essendo il buddista e l’ingegnere in assoluta buona fede, non si sono capiti e
sono entrambi convinti della bontà del loro punto di vista e dello scarso valore del punto di vista
dell’altro.
Ma non sono pari, perché l’ingegnere sta dalla parte del pensiero forte, il buddista del pensiero
debole. Il fatto che l’ingegnere stia dalla parte del pensiero forte, che corrisponde a quello della
maggioranza e del conscio collettivo, lo rende benevolente e un poco arrogante nei confronti del
buddista.
Il buddista, pur essendo un convinto non-violento, cova sentimenti di vendetta e fantasie di potere
nei confronti dell’ingegnere.
E tutto potrebbe finire qui.
Ma l’ingegnere una notte fa questo sogno.
È ingegnere, come nella realtà, ma è un bambino di sei sette anni. Il conoscente buddista lo tiene
per mano e lo guida per dei complicati sentieri dentro una foresta, per lui un po’ inquietante.
L’ingegnere bambino si sente pieno di gratitudine e ammirazione nei confronti del buddista. Sente
di potersi e di doversi affidare a lui.
L’ingegnere sii sveglia molto a disagio e rimane di cattivo umore per tutta la giornata.
Come spesso accade, l’Io è guidato da chi credeva di poter guidare. O meglio: la funzione
compensatrice del sogno mette in scena una situazione in cui colui che crede di guidare viene
guidato.
L’Io estroverso è messo in scacco proprio da colui che, nella sua modalità di introverso spinto,
appare come uno fuori di testa o, nel migliore dei casi, un ingenuo idealista. L’ingegnere è davvero
convinto che il conoscente buddista abbia un atteggiamento magico, arcaico e immerso in una
profonda dimensione grande materna.
Nell’uomo di fede buddista avviene, nei confronti dell’ingegnere, la stessa cosa in senso inverso.
Egli vede l’ingegnere come un uomo superficiale, limitato nella sua percezione del reale, uno che
non sa andare oltre la banale evidenza delle cose. Ma l’inconscio del buddista compensa la sua
debolezza nel mondo con sogni di potere del tutto particolari.
Mi viene in mente il film Ricomincio da tre dove Massimo Troisi, che fa la parte di un napoletano
problematico e introverso, cerca di ipnotizzare un vaso e di convincerlo a muoversi verso di lui. La
sorella, appena uscita dal letto, in camicia da notte, con la tazza di caffè in mano, lo guarda allibita
e si prende gioco di lui, che, irritato per l’interruzione di un momento così drammaticamente
importante, le spiega che se riuscisse a convincere gli oggetti ad andare verso di lui, avrebbe
risolto la sua vita. Questi sono i sogni di potere di un introverso.
-4-
Secondo Jung ognuno possiede un atteggiamento conscio che viene compensato dall’inconscio
con un atteggiamento opposto e complementare. L’atteggiamento inconscio si configura spesso in
modo arcaico, infantile e ombroso e la sua profonda inconsapevolezza lo rende notevolmente
autonomo e quindi altamente proiettabile, producendo così un complicato processo psicologico
prevalentemente inconscio nel quale gli uni e gli altri diventano ad un tempo persecutori e
perseguitati.
Notiamo qui per inciso come il fenomeno proiettivo si situi in quella vaga terra di confine che sta fra
soggetto e oggetto.
Come possiamo vedere nessuno dei due atteggiamenti, estroverso e introverso, è in se stesso
soddisfacente per la psiche nel suo bisogno di completezza e complessità. È necessario che l’Io si
confronti con ciò che costituisce la parte più lontana ed inferiore, più arcaica e indifferenziata. Ma il
confronto con queste parti inevitabilmente diminuisce la luminosità della coscienza.
Il modello di una coscienza omogeneamente sviluppata e altamente differenziata, modello caro
alla psicanalisi, che in modo un po’ paradossale ha evacuato la dimensione inconscia, è molto
lontano da ciò che sembra volere il nostro Sé.
È il figlio grullo del re che nelle fiabe porta la soluzione. Tipologicamente parlando è la quarta
funzione quella più vicina al tesoro dell’individuazione.
Per essere più precisi, ad essere decisiva non è né la quarta funzione né il figlio grullo, ma
l’atteggiamento che essi mettono in atto. Il Grullo infatti non è che faccia un granché, è piuttosto
passivo, ma è talmente aperto e ingenuo che le cose possono capitare. Un Io differenziato
sarebbe, nelle stesse circostanze, così difeso e chiuso da non riuscire neppure a scorgere ciò che
il Grullo riconosce perfettamente. Una rana che parla non è cosa da tutti i giorni. La qualità del
Grullo è quella di essere completamente nel qui e ora e quindi di attivare fenomeni di sincronicità.
D’altra parte il Grullo non sa fare progetti, non sa immaginare il futuro.
E infatti, come ci dicono le fiabe, non basta il Grullo; ci vogliono entrambi: i figli astuti e il figlio
scemo. È la presenza dei due a mettere in atto il processo.
Un figlio scaltro, abile, veloce e sottile; un figlio ingenuo, lento, impotente, forse deforme.
Il rapporto fra i due deve essere affettivo. Bisogna proprio volergli bene a quel bambino deficiente
e rompicoglioni. Solo allora, dopo molti dolorosi aggiustamenti, scatta qualcosa che conduce ad
un’altra dimensione, quella del “sia fuori sia dentro”, o del “né fuori né dentro”, in una parola, della
dimensione simbolica. Allora il viaggio nel paese degli altri diventa l’espressione visibile e
sperimentabile del viaggio nella propria complessità.
Bibliografia:
Jung C.G., Tipologia psicologica,(1921), Edizioni Bollati Boringhieri, Torino, 1970
-5-