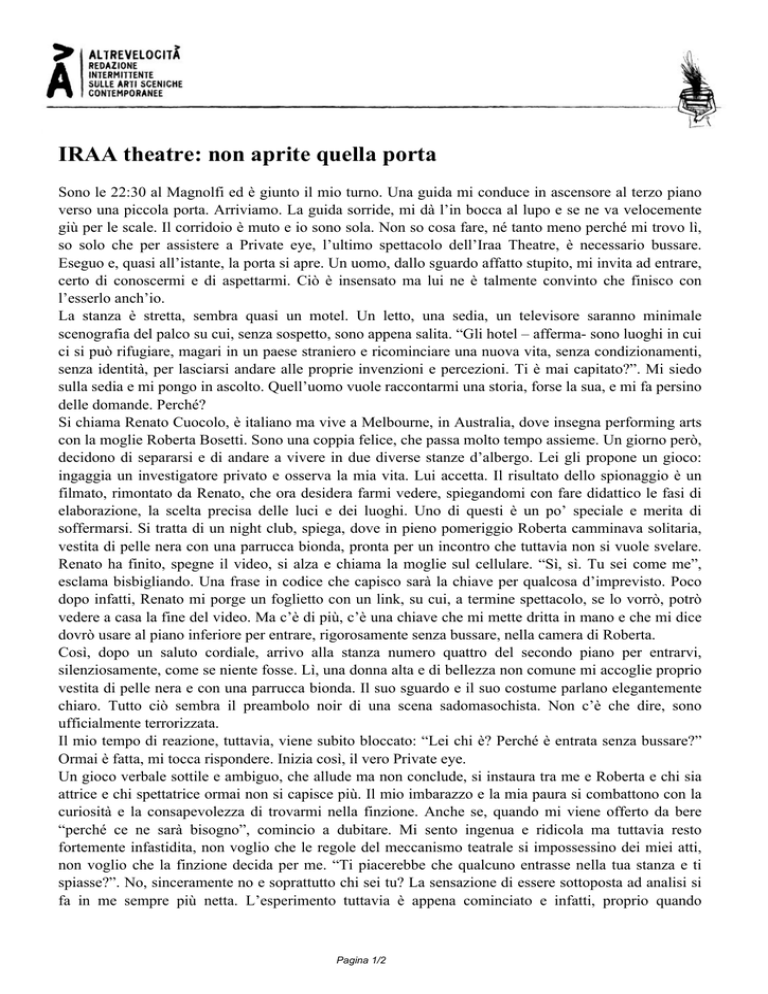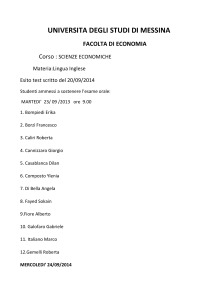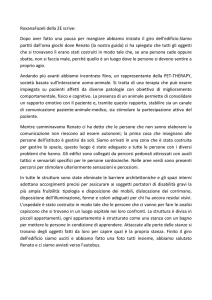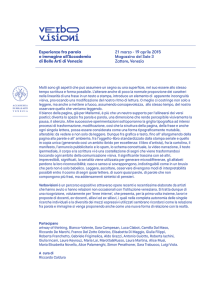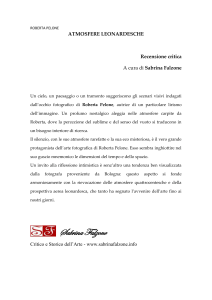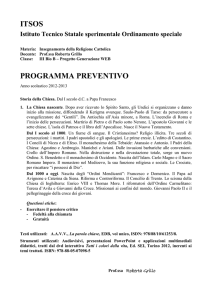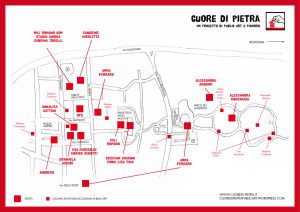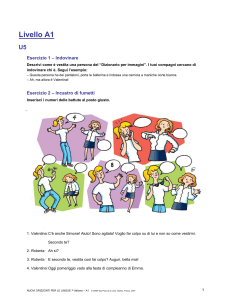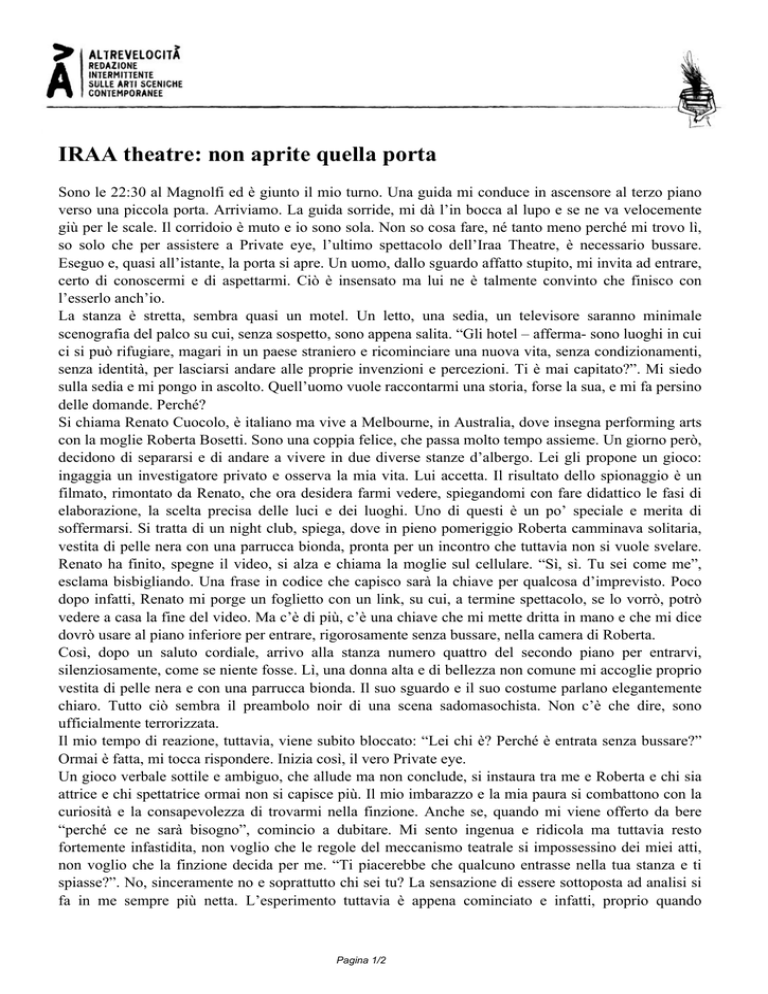
IRAA theatre: non aprite quella porta
Sono le 22:30 al Magnolfi ed è giunto il mio turno. Una guida mi conduce in ascensore al terzo piano
verso una piccola porta. Arriviamo. La guida sorride, mi dà l’in bocca al lupo e se ne va velocemente
giù per le scale. Il corridoio è muto e io sono sola. Non so cosa fare, né tanto meno perché mi trovo lì,
so solo che per assistere a Private eye, l’ultimo spettacolo dell’Iraa Theatre, è necessario bussare.
Eseguo e, quasi all’istante, la porta si apre. Un uomo, dallo sguardo affatto stupito, mi invita ad entrare,
certo di conoscermi e di aspettarmi. Ciò è insensato ma lui ne è talmente convinto che finisco con
l’esserlo anch’io.
La stanza è stretta, sembra quasi un motel. Un letto, una sedia, un televisore saranno minimale
scenografia del palco su cui, senza sospetto, sono appena salita. “Gli hotel – afferma- sono luoghi in cui
ci si può rifugiare, magari in un paese straniero e ricominciare una nuova vita, senza condizionamenti,
senza identità, per lasciarsi andare alle proprie invenzioni e percezioni. Ti è mai capitato?”. Mi siedo
sulla sedia e mi pongo in ascolto. Quell’uomo vuole raccontarmi una storia, forse la sua, e mi fa persino
delle domande. Perché?
Si chiama Renato Cuocolo, è italiano ma vive a Melbourne, in Australia, dove insegna performing arts
con la moglie Roberta Bosetti. Sono una coppia felice, che passa molto tempo assieme. Un giorno però,
decidono di separarsi e di andare a vivere in due diverse stanze d’albergo. Lei gli propone un gioco:
ingaggia un investigatore privato e osserva la mia vita. Lui accetta. Il risultato dello spionaggio è un
filmato, rimontato da Renato, che ora desidera farmi vedere, spiegandomi con fare didattico le fasi di
elaborazione, la scelta precisa delle luci e dei luoghi. Uno di questi è un po’ speciale e merita di
soffermarsi. Si tratta di un night club, spiega, dove in pieno pomeriggio Roberta camminava solitaria,
vestita di pelle nera con una parrucca bionda, pronta per un incontro che tuttavia non si vuole svelare.
Renato ha finito, spegne il video, si alza e chiama la moglie sul cellulare. “Sì, sì. Tu sei come me”,
esclama bisbigliando. Una frase in codice che capisco sarà la chiave per qualcosa d’imprevisto. Poco
dopo infatti, Renato mi porge un foglietto con un link, su cui, a termine spettacolo, se lo vorrò, potrò
vedere a casa la fine del video. Ma c’è di più, c’è una chiave che mi mette dritta in mano e che mi dice
dovrò usare al piano inferiore per entrare, rigorosamente senza bussare, nella camera di Roberta.
Così, dopo un saluto cordiale, arrivo alla stanza numero quattro del secondo piano per entrarvi,
silenziosamente, come se niente fosse. Lì, una donna alta e di bellezza non comune mi accoglie proprio
vestita di pelle nera e con una parrucca bionda. Il suo sguardo e il suo costume parlano elegantemente
chiaro. Tutto ciò sembra il preambolo noir di una scena sadomasochista. Non c’è che dire, sono
ufficialmente terrorizzata.
Il mio tempo di reazione, tuttavia, viene subito bloccato: “Lei chi è? Perché è entrata senza bussare?”
Ormai è fatta, mi tocca rispondere. Inizia così, il vero Private eye.
Un gioco verbale sottile e ambiguo, che allude ma non conclude, si instaura tra me e Roberta e chi sia
attrice e chi spettatrice ormai non si capisce più. Il mio imbarazzo e la mia paura si combattono con la
curiosità e la consapevolezza di trovarmi nella finzione. Anche se, quando mi viene offerto da bere
“perché ce ne sarà bisogno”, comincio a dubitare. Mi sento ingenua e ridicola ma tuttavia resto
fortemente infastidita, non voglio che le regole del meccanismo teatrale si impossessino dei miei atti,
non voglio che la finzione decida per me. “Ti piacerebbe che qualcuno entrasse nella tua stanza e ti
spiasse?”. No, sinceramente no e soprattutto chi sei tu? La sensazione di essere sottoposta ad analisi si
fa in me sempre più netta. L’esperimento tuttavia è appena cominciato e infatti, proprio quando
Pagina 1/2
comincio a capire come agire la mia difesa, bussano alla porta e io vengo improvvisamente catapultata
in una cabina, nient’altro che l’armadio su cui si specchiava Roberta e lì resto a guardare. Un ragazzo
esce da una porta alla mia sinistra. Qualcuno mi ha vista. Mi viene da ridere, ripensando alla mia
reazione goffa, è paradossale ma la finzione è ripristinata. Sono al chiuso, non partecipo indi sono al
sicuro. Sembra quasi un’equazione. Ma dunque è forse questo il teatro? Guardarsi per restare al sicuro?
Roberta nel frattempo si è cambiata, ora è vestita di rosa e di bianco, ha un fare dolce e
sorprendentemente delicata accoglie nella stanza una nuova attrice-spettatrice. Il copione si ripete in
prospettiva opposta, le affermazioni sono le stesse rivoltemi eppure appaiono diverse, l’acqua che ora
viene offerta ha fatto scivolare via tutto l’alcool.
Terminata la scenetta il ciclo si ripete e io vengo fatta uscire. Roberta mi saluta cordialmente sulla porta
e ripiombo nel silenzio.
Mi guardo intorno. Che cosa diavolo sia successo quasi non lo ricordo più. Come dal sonno alla veglia,
cerco di recuperare possesso del mio spazio reale, scendo le scale e tiro un sospiro, si ricomincia, la
vita.
Private eye, lo si comprende in seguito, è un gioco di resistenza che pone in campo nel rapporto
apparenza e realtà anche un forte problema di equilibri di potere come di identità. Identità, prima di
tutto del teatro stesso, che qui diventa meccanismo in costruzione e ci pone la questione, in fondo, sul
come mai sia necessario fingere per capire sé stessi.
Pagina 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)