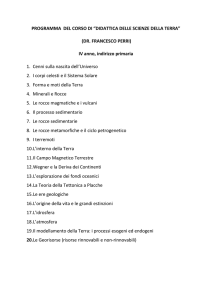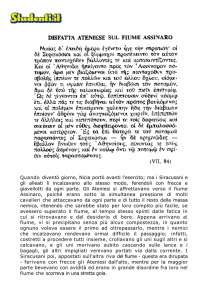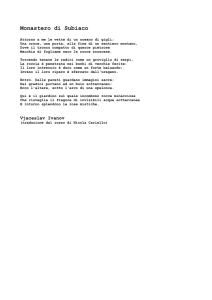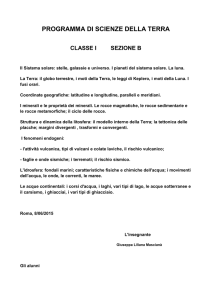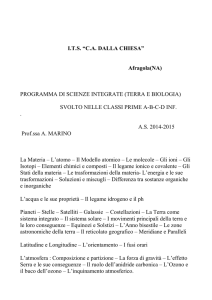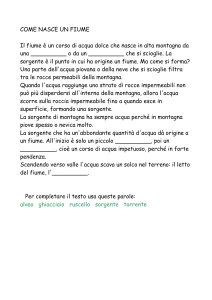Escursione in Barigadu dal Taloro al Tirso
14-10-2012
di Valentina Valentini
La giornata, al suo avvio e all’inizio del nostro viaggio, non sembrava molto luminosa: il cielo appariva infatti
ingombro di gonfie nuvole grigie, che andavano accalcandosi a mo’ di pecorelle di un gregge celeste, ma col
passare delle ore e proseguendo nell’itinerario, esse hanno cominciato a diradarsi, divenendo solo sottili
strisce, illuminate dai raggi mattutini del sole: lo scenario naturale, sotto questa ancora timida luce,
mostrava, in parte, i segni e i colori inconfondibili della assolata estate appena trascorsa.
La strada, per molti chilometri rettilinea, si è fatta di colpo più sinuosa, e seguendo le sue volute, siamo
gradatamente scesi verso il paese di Ghilarza e fra gli alberi e la vegetazione ai bordi della strada, è
comparsa l’amena vallata del lago Omodeo e le alture attorno ad esso, sulla cima delle quali, era allineato, a
formare una sorta di corona di punti bianchi, il paese di Sedilo.
Radunatici tutti sotto una quercia frondosa, dai rami disposti a raggiera, e approfittando per qualche attimo
della sua ombra, che non ci dispiaceva affatto visto il sole ancora caldo, stagliato su di un bel cielo ormai
terso, e dopo aver seguito l’interessante inquadramento storico-archeologico del luogo, tracciato con grande
professionalità da Luciana, ci siamo diretti verso una strada in graduale salita, circondati da arbusti di
macchia bassa e lentischi, alternati a grandi spiazzi color paglia e numerose piante di perastro, cariche di
perine in miniatura verdi e gialle, “anticipati” dalla simpatica bassottina di Raimondo, Giuditta, che col suo
fare tracotante e il suo brio, ha movimentato la nostra spensierata giornata all’aria aperta. Man mano che
salivamo, il placido specchio d’acqua del lago Omodeo andava allargandosi e denotando contorni sempre
più nitidi e definiti, circondato di macchie verdi e zone dorate e sormontato di “catene” di rare nuvolette, che
si riflettevano nelle sue acque.
Dopo un’ulteriore sosta, parte di noi, all’ombra di un albero di lentisco e in parte, sotto le fronde di un robusto
leccio di lunga vita, ci siamo avvicinati, alla spicciolata, a un’altra zona, un po’ stopposa, di muretti a secco,
per poter seguire una descrizione geologica dettagliata del sito ad opera di una delle guide, Marco, e in
seguito, per ascoltare un’altra gradita lezione estemporanea botanico-geologica di un altro amico della
comitiva, Roberto, il quale, ci ha affascinato non poco con le sue conoscenze in materia; entrambi, ci hanno
fatto osservare, con occhi meno distratti e “inesperti”, l’ambiente naturale che ci stava attorno, e noi, con
questa nuova consapevolezza, grazie a loro, lo abbiamo apprezzato di più.
Poco distante da lì, invece, proseguendo per la strada, scanalata dalle acque piovane, siamo pervenuti in un
altro suggestivo luogo, ombreggiato da lentischi e lecci, costituito da un complesso rotondeggiante di rocce
bianche e grigie, scavate abilmente per ricavarne dei “ricoveri per defunti” da esseri umani ancestrali….
Eravamo davanti alle cosiddette “domus de janas”, antichissime tombe, così diffusamente rappresentate,
come i nuraghi, nella nostra isola. Che emozione pensare che questi piccoli antri siano stati usati dall’uomo
e che stupore vedere le aperture realizzate, squadrate con precisione geometrica, alcune concentriche,
alcune più arrotondate, sapendo che gli uomini dell’epoca non avevano idonei strumenti metallici, ma solo la
pietra, per scolpire lo stesso
materiale (l’insediamento risale
infatti a prima dell’età del ferro,
come ci ha precisato l’archeologo
Alessandro)!!
Mario, per la curiosità, si è voluto
introdurre
all’interno
e
ha
“contagiato” altri amici, che l’hanno
seguito nell’esplorazione: all’interno,
l’ambiente, scavato nella nuda
roccia, era largo, ma la volta non
era molto alta e costringeva a stare
seduti; le voci, producevano uno
squillante e rimbombante effetto
sonoro, che regalava ulteriore
suggestione.
Dopo essere arrivati più in vista del
lago Omodeo, dalle alte sponde
color ocra, e aver individuato, all’orizzonte, anche il cratere spento del Monti Santu Padre, svettante tra le
altre cime vicine, abbiamo proseguito la nostra strada, per poi lasciarla per un momento, per una breve visita
a un altro complesso archeologico, per raggiungere il quale, si doveva percorrere un vialetto lastricato e
passare sopra a un lastrone di pietra grezzo, che fungeva da ponte su un corso d’acqua in secca. A quel
punto, ai nostri occhi, tra la vegetazione intricata e affusolata, che sembrava voler cercare la luce, si è aperto
un altro scenario, difficile da
scordare: su una grande roccia
bianco-rosata con una curiosa forma
di maroso crestato che sta per
frangersi, erano ricavate delle
aperture rotonde concentriche, che le
facevano assomigliare tanto a dei
grandi occhi “ipnotici”, i quali
scrutavano il visitatore che si
apprestava al loro cospetto. A fianco
alla roccia occhiuta, un’altra “domus”,
strutturata ad aperture concentriche e
successive:
la
più
interna,
perfettamente rettangolare, era molto
più piccola e bassa delle due
precedenti più ampie, soprattutto in
larghezza, e per entrarci, bisognava
procedere carponi. Anche qui, come
nelle domus de janas precedenti, la
voce aveva un effetto sonoro assai singolare. Sulla sommità di questo antico sepolcro, la cui edificazione si
perde nella notte dei tempi, era appoggiato, solo per uno spigolo, anche un grande masso squadrato,
arancione di licheni, quasi in bilico, com’ è prerogativa frequente di molte rocce del paesaggio tipicamente
locale: anch’esso, accresceva l’aria “incantata” e suggestiva del luogo.
Il nostro amico Mario, ne subiva decisamente il fascino e l’effetto emotivo, tant’è vero che aveva qualche
indugio ad abbandonarlo per riunirsi al gruppo (e non lui solo!).
Il percorso si è ristretto, (ma la cosa non preoccupava affatto Giuditta, che continuava la sua “spola” tra i
primi del gruppo e quelli in coda, alquanto galvanizzata), e siamo penetrati nel folto della vegetazione, dove
la luce si è smorzata; i nostri passi fruscianti sulle foglie morte, circondati da filliree, fitti e giovani lecci, dai
tronchi grigi, chiazzati di bianco e dai lunghi rami laterali intrecciati con quelli dei lentischi a formare una
sorta di galleria e le cui sommità affioranti dalla semioscurità venivano illuminate dai raggi del sole, le liane di
rovi, il profumo dell’humus e dei muschi adornati di ciuffi di felci: gli “elementi” del bosco delle favole c’erano
proprio tutti!
La continuità del colore grigio-verde dominante veniva
interrotta, di quando in quando, solo dai grappolini rosso
vivace della salsapariglia, arrampicata e pendente dai
lentischi, e accomunata, per tonalità cromatica, ai fruttini
piriformi di rari biancospini. Talvolta, anche il forte aroma
mediterraneo di rade piante di mirto (dalle foglie
insolitamente grandi) si intrometteva, e donava una
piacevole nota olfattiva aggiuntiva al tutto.
Una volta usciti allo scoperto, ci siamo trovati a percorrere
un grande spiazzo formato di rocce candide e quasi
piatto, che altro non era che una delle sponde del fiume
Taloro, divenuto ora più lento e limaccioso nel suo corso
e scorrente fra boscaglie di canne in fiore e alberi dalla chioma piumosa; attraverso uno stretto passaggio tra
grandi massi scuri, posti a formare quasi i pilastri di un “cancello naturale”, che avevano impigliati, nelle loro
spaccature, “fascine” di tronchi e rami, trascinati dalla furia delle acque alluvionali, siamo giunti in un ulteriore
spazio aperto, costituito da una grande estensione di pietre e rocce bianchissime e rosa-trachite, contornate
di vegetazione abbastanza folta e “guardate a vista”, dall’alto, da torrioni rocciosi rossicci. Fra queste rocce
chiare, scorreva stavolta una sottile lingua d’acqua. Il tempo di scattare qualche foto su un piancito grigioardesia di sicura matrice vulcanica, che “staccava” dal resto, che abbiamo ripreso la marcia, rincontrando,
sul nostro cammino, ancora piante di perastro, e di biancospino punteggiate di rosso, e siamo arrivati in un
altro punto largo, dove il fiume
Taloro si espande in ampiezza,
formando una conca, la cui
superficie acquea scintillava,
baciata dal sole della tarda
mattinata. Le sue sponde
sabbiose, degradavano verso
l’acqua, solcate da cerchi
concentrici
e
da
essa
affioravano dei particolarissimi
alberi bianchi scheletriti, dai
rami contorti, immersi per metà
fusto,
che
lasciavano
intravvedere, sull’altro lato del
fiume, delle possenti torri di un
“castello” roccioso, separate da
larghi
canali
verticalmente
irregolari e segnate da diversi “livelli”, diversamente colorati, stanti ad indicare le diverse altezze dell’acqua
nel corso del tempo. Sulla ripa, anche un pescatore con le sue canne da pesca, intento a godersi la sua
giornata di relax al sole.
Il cielo in breve si è tornato a riempire di nuvole, sfumate un po’ a vortici, e il sole ha preso a comparire a
sprazzi; dopo un’altra breve sosta poco più avanti, sui massi tondi posti a lato del fiume, siamo rientrati
dentro il bosco ombroso, arrampicandoci in un sentierino pietroso e scosceso, quasi in “cordata”, cercando
di evitare le piante di rovo, che si agganciavano sovente ai nostri abiti; qualcuno di noi, ha anche scorto un
bel cespuglio spinoso di prugnolo, dalle piccole drupe bluastre che assomigliano a mirtilli (“prunixeddas”) e
s’è soffermato a raccoglierle e ad assaggiarle velocemente. Siamo dunque usciti dal “tunnel boschivo”, per
raccoglierci, in ordine sparso, su un altro grande campo dorato di stoppie, dove pascolavano dei cavalli che
ci guardavano curiosi, e dalla quale sommità, tornava visibile il lago Omodeo, dalle acque azzurre e calme,
e un’altra volta, in lontananza, il tronco di cono vulcanico del Monti Santu Padre. Qualche istantanea scattata
al paesaggio dalla serena “ruralità”, che aveva già i colori morbidi e caldi del pomeriggio, e alla mantide
verde-foglia, che ha vissuto il suo momento di notorietà da vera diva, intenta a consumare il suo “fiero”pasto,
che siamo ridiscesi, procedendo paralleli al corso del fiume, con un’andatura più rallentata, anche per
vedere i begli scorci, che si aprivano al nostro sguardo, al nostro passaggio, e che si affacciavano sul corso
d’acqua dai colori verdastri. In particolare, ce n’era uno che faceva presagire, dato il “salto” notevole, che in
periodo di grandi piogge, doveva dar spazio a una cascata dalla grande portata e caduta d’acqua, anche a
giudicare dall’aspetto dei massi, arrotondati e plasmati dalla stessa, posti a formare una sorta di gradinata
ripida, lungo il suo tragitto fino allo sbocco nel corso principale.
Abbiamo attraversato l’ennesimo campo, dorato di sole, percorso da un piccolo gregge frettoloso di pecore
al pascolo, sempre sovrastati, lateralmente, dai bastioni torreggianti della sponda opposta del fiume, ora
“picchiati” dal sole solo
sull’estremità cespugliosa:
voltandoci indietro, molti di
essi, erano già in ombra,
stava infatti lentamente
“calando il sipario” sullo
scenario roccioso e delle
acque
lievemente
increspate dalla corrente,
poco prima sotto la luce, e
si stava preparando alla
prima sera. Non troppo
lontano, si poteva scorgere
il doppio arco metallico del
ponte sul Taloro e le
andavamo
pian
piano
incontro. Giuditta, al termine
dell’ escursione, appariva
sempre vivace, ma forse un
po’ meno in vena di “spole”
avanti e indietro: solo la sua
codina manteneva l’aspetto
guizzante dell’esordio-gita.
Dai vetri dell’autobus in corsa verso Cagliari, l’ultimo regalo di un arcobaleno multicolore, insolitamente
verticale, appena velato, e di un sole al tramonto dalla luce incandescente, appena interrotta da sottili strisce
di nuvole.