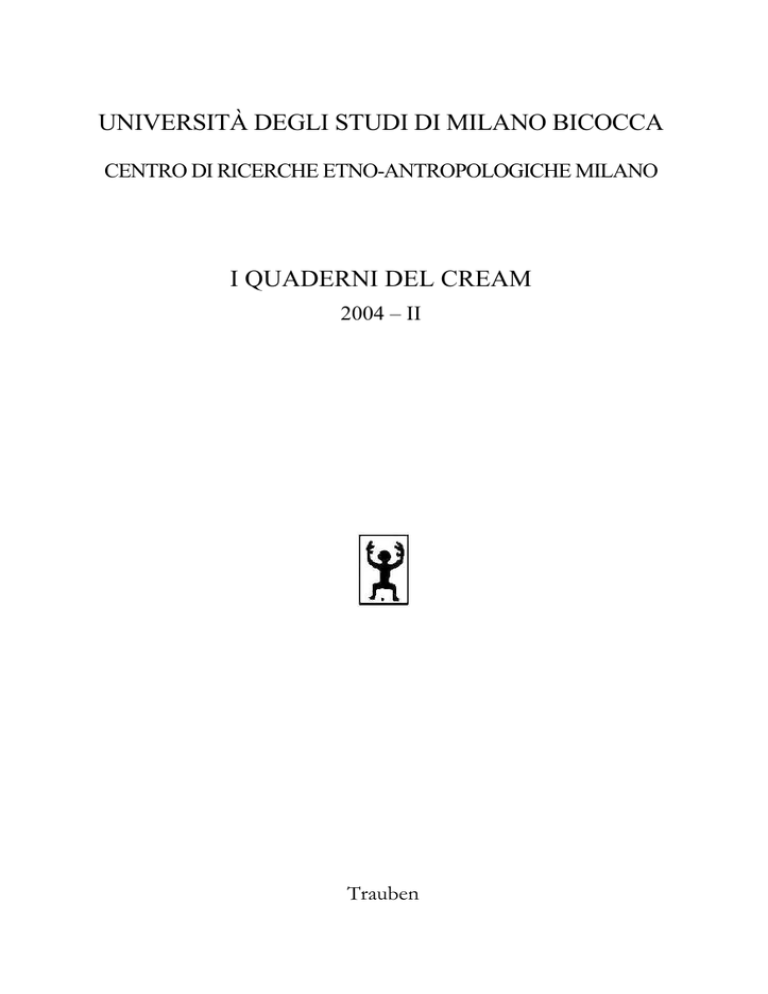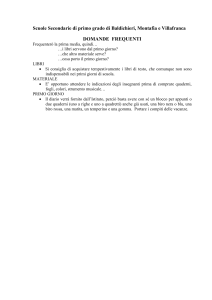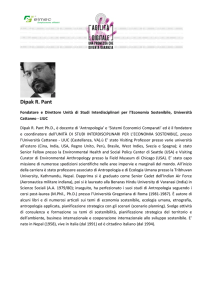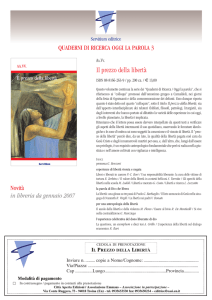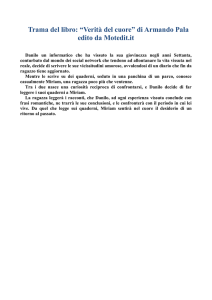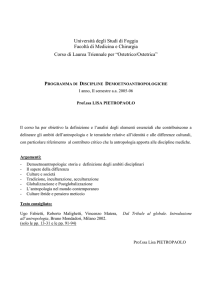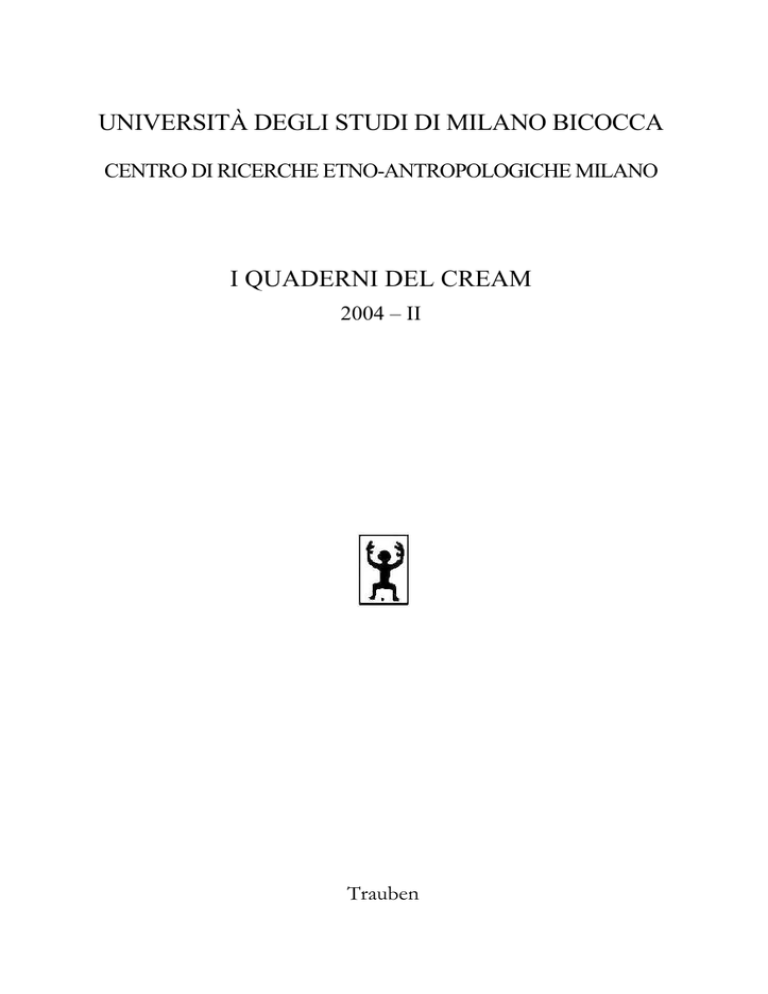
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
CENTRO DI RICERCHE ETNO-ANTROPOLOGICHE MILANO
I QUADERNI DEL CREAM
2004 – II
Trauben
I quaderni del CREAM sono una pubblicazione a cura del Centro di Ricerche Etno-Antropologiche dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Raccolgono articoli, note, recensioni e testi di conferenze e seminari tenuti nell’ambito delle attività del Centro e delle iniziative ad
esso collegate: Corso di Laurea Specialistica in Scienze Antropologiche
ed Etnologiche, Dottorato in Antropologia della Contemporaneità
(DAC), Corso di Perfezionamento in Antropologia Culturale (COPAC),
Laboratorio di Antropologia Visiva (LAV), Seminario di Antropologia
del Medio Oriente e del Mondo Musulmano (SAMOMU), Seminario di
Antropologia Teorica (SAT).
© 2004 Trauben editrice s.a.s
via Plana 1 – 10123 Torino
ISBN 8888398732
I quaderni del CREAM, 2004 - II
2
Indice
5
Tullio Seppilli, La funzione critica dell’antropologia medica:
temi, problemi, prospettive
29
Romano Mastromattei, Il governo ombra del Nepal
69
Ildàsio Tavares, La liturgia della sopravvivenza negra
85
Roberto Malighetti, Emergenza come fine dello sviluppo.
Le alternative dei favelados di Rio de Janeiro
119
Manuela Tassan, La cultura dell’ambiente nelle politiche di sviluppo
della FAO
I quaderni del CREAM, 2004 - II
3
I quaderni del CREAM, 2004 - II
4
TULLIO SEPPILLI
•
LA FUNZIONE CRITICA
DELL’ANTROPOLOGIA MEDICA:
TEMI, PROBLEMI, PROSPETTIVE
♦
Le due culture
Questa sera vorrei presentare l’ambito dell’antropologia medica, i
problemi principali, il suo percorso e le questioni aperte a cui la disciplina può dare un contributo. Visto che si tratta di una lezione introduttiva, cercherò di essere molto telegrafico.
Innanzitutto vorrei segnalare una situazione di stallo riguardante
l’antropologia in genere e l’antropologia medica in particolare. Deriva
dalla condizione in cui, specialmente in Italia, si trovano le scienze che
si occupano dell’uomo, le cosiddette scienze umane. In Italia abbiamo
ancora due culture, intese non in senso antropologico, ma in senso più
generale. Ovvero abbiamo, da un lato, un certo numero di Facoltà che
analizzano l’uomo nella sua realtà biologica, (medicina, scienze, farmacia). Dall’altro abbiamo un certo numero di Facoltà, (lettere, sociologia,
•
Presidente della Società Italiana di Antropologia Medica. Presidente della Fondazione
Angelo Celli per una Cultura della Salute.
♦
Il presente articolo consiste nella trascrizione della Lezione Inaugurale tenuta dal Professor Tullio Seppilli al Corso di Perfezionamento in Antropologia Medica dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, martedì 27 gennaio 2004. Il testo registrato è stato trascritto da Arianna Cecconi e organizzato da Roberto Malighetti, responsabile per
l’elaborazione dei titoli interni e per alcuni interventi editoriali. Non vi è stata alcuna
revisione da parte del Prof. Seppilli che si ringrazia per aver concesso il permesso alla
pubblicazione.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
5
giurisprudenza, economia, scienze della formazione) in cui l’uomo è
analizzato nelle sue componenti storico-sociali.
Fin qui non ci sarebbe niente di male. Il problema è che non c’è dialogo fra le due. Voglio dire che un medico si può laureare tranquillamente senza avere la più pallida idea dei processi sociali che stanno
intorno al complesso groviglio di questioni che riguardano la salute e la
malattia. D’altra parte ci si può laureare in lettere senza sapere che cosa
è una cellula, cos’è un microrganismo, come sta in piedi l’uomo e cose
del genere. Siamo cioè di fronte alla legittimazione di due culture che
sono già di per sé negativamente distinte e che a fronte dello studio
dell’uomo, lo spaccano in due.
In Italia non c’è ancora una seria formazione che ricomponga l’uomo nelle sue componenti biologiche e storico-sociali. Non dappertutto è
così. Malighetti nella sua introduzione ricordava la mia formazione in
Brasile. Qui, molto tempo fa, ho frequentato una Facoltà che allora si
chiamava “sociologia”, dove si studiava biologia umana e genetica, insieme a tutte le discipline sociali, come la sociologia, l’antropologia
ecc… Sembrava normale. In Italia non ci siamo ancora. Possiamo
quindi prendere le mosse da questo punto, un punto molto importante
perché la realtà dell’uomo è costituita da un’integrazione delle componenti biologiche e delle componenti storico-sociali per una serie di ragioni ben precise.
Possiamo, sempre molto telegraficamente, ricordare il fatto che il
processo di formazione progressiva dell’uomo e della specie umana,
come si è venuto configurando fino a oggi, è un processo complesso,
attraverso il quale un animale, uno dei primati che esistevano sulla terra, intorno a quattro, quattro milioni e mezzo di anni fa, si è sviluppato
in termini evolutivo-biologici, ma con una caratteristica ben precisa.
Tutta l’evoluzione biologica dell’uomo è avvenuta dentro contesti sociali. In altre parole, non possiamo distinguere nello sviluppo evolutivo
dell’uomo il suo cambiamento biologico dal fatto che questo cambiamento sia avvenuto all’interno di contesti in cui gli uomini erano integrati tra loro in piccole o grandi comunità. Questo ha indirizzato non
soltanto tutta la storia dell’umanità, ma la stessa sua evoluzione biologica.
Per esempio, l’evoluzione biologica dell’uomo è stata prevalentemente un’evoluzione della capacità di intelligenza e si è tradotta in una
I quaderni del CREAM, 2004 - II
6
profonda trasformazione del sistema nervoso, quindi del cervello. Dal
punto di vista della forza fisica il processo di evoluzione è invece stato
un progressivo indebolimento, perché la questione della sopravvivenza
fisica e della difesa dalle sfide naturali è stata assunta dai gruppi sociali.
Non era tanto il singolo individuo che stava al centro della risposta alla
sfida ambientale, quanto le comunità. La questione è allora diventata
quella della capacità di organizzare al meglio le risorse di una comunità. Questo ha comportato il fatto che, nel corso dell’evoluzione, l’uomo
si sia indebolito fisicamente e nel contempo sia divenuto sempre più
intelligente.
Si tratta di un esempio molto banale, che andrebbe precisato meglio,
ma serve per capirci. Cosa significa? Significa che in parallelo alla
condizione biologica che si stava evolvendo, si è venuta organizzando
nell’uomo l’esistenza di una rete di rapporti sociali più o meno ampia,
che possiamo chiamare molto genericamente società. Possiamo parlare
di comunità, possiamo parlare di gruppi maggiori, ma il problema di
fondo è che l’uomo non è mai vissuto da solo, è sempre vissuto in comunità, e queste comunità hanno costituito una realtà sovra-individuale.
Kroeber1 l’ha chiamata “super-organica”. Non so quanto sia utile questo termine, ma serve per indicare il fatto che la realtà umana non è fatta soltanto di individui biologici, ma di strutture, di rapporti tra individui. Queste strutture, che costituiscono la società, sono un elemento
nuovo, direi che segnano la specificità della condizione umana […].
L’esistenza del gruppo sociale ha una vita e un funzionamento in qualche modo relativamente autonomo rispetto al funzionamento biologico
del singolo individuo.
Se vogliamo porlo in termini più teorici, dobbiamo introdurre il
concetto di sistema, che oggi va tanto di moda. Ovvero l’insieme di individui che costituiscono una società è un sistema e non una sommatoria di individui. La società non riproduce le caratteristiche dei singoli
individui che la costituiscono in termini di sommatoria. È un tutto unico. Se desideriamo usare un linguaggio filosofico, possiamo riferirci al
concetto di salto di qualità, secondo il quale il sistema non funziona come i singoli individui, ma funziona in modo autonomo. Potrei farvi un
esempio metaforico ma abbastanza esplicativo: anche se avete fatto del1
Kroeber, A.L. 1952: The Nature of Culture, Chicago, University of Chicago Press.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
7
le facoltà umanistiche, tutti voi sapete che una molecola d’acqua è fatta
da un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno. L’ossigeno ha una valenza maggiore, per cui sono i due atomi di idrogeno che si attaccano
all’atomo di ossigeno. Benissimo. Il salto di qualità, il passaggio cioè
dal livello atomico al livello molecolare, consiste nel fatto che l’ossigeno e l’idrogeno unendosi in un sistema producono una realtà qualitativamente superiore che funziona come complesso, come sistema e come
tale va analizzato. Lo stesso vale per le società umane. Le società umane, contrariamente a quanto pensavano gli antropologi positivisti dell’Ottocento, non possono essere interpretate solo come una sommatoria
di organismi biologici. Quello che succede nelle società non è un estensione collettiva delle caratteristiche dei singoli individui. La società è
un sistema che funziona con proprie leggi e va studiata ad un livello diverso dallo studio della costituzione biologica dei singoli individui che
pur la compongono.
Questo rapidissimo excursus ci spiega perché le scienze umane hanno la caratteristica epistemologica di doversi collocare a due livelli. Le
scienze umane sono ad un tempo scienze che analizzano le caratteristiche biologiche dell’uomo e allo stesso tempo devono considerare le
modalità di funzionamento dei sistemi sociali che non possono essere
ricavati analizzando le caratteristiche biologiche degli esseri umani. In
questo possiamo cogliere la caratteristica di fondo delle scienze umane,
il fatto di essere scienze che si collocano a due livelli di organizzazione
della materia, quello biologico e quello sociale.
Tutte le volte che nel lungo dibattito su questi problemi inaugurati
alla fine dell’Ottocento, si è dato troppo peso alle componenti e ai fattori biologici, cadendo nel ‘biologismo’, o tutte le volte che invece si è
negato il peso dei fattori biologici, cadendo nel ‘sociologismo’, si è male interpretata la condizione umana. Proprio perché l’unico modo corretto di interpretare la condizione umana è di riuscire a soppesare l’integrazione tra questi due elementi. Detto così sembra tutto molto semplice, ma nella pratica, come potete naturalmente immaginare, le cose
sono più complesse.
Il problema è ulteriormente complicato dal fatto che la componente
minimale, cioè il singolo individuo nella sua realtà biologica, entrando
in un sistema sociale non soltanto dà forma, insieme a tanti altri individui, a questo livello superiore di organizzazione, ma ne viene a sua volI quaderni del CREAM, 2004 - II
8
ta condizionato. Sarebbe troppo comodo studiare l’individuo con la biologia e la società con le scienze sociali. In realtà il complesso sistema
sociale entro cui il singolo individuo si viene a trovare fin dalla nascita
e forse anche da prima, viene a costituire un condizionamento tale per
cui non si può più separare nell’individuo ciò che gli deriva dal suo patrimonio genetico individuale, dalle sue caratteristiche biologiche e
quello che invece gli viene dalla sua esperienza nel contesto sociale.
Questi due livelli si intersecano in modo indistricabile, per cui gli individui che ci troviamo di fronte sono degli individui che hanno una natura biologica (con tutta una serie di esigenze, di problemi, di necessità e
potenzialità), dentro un condizionamento che cambia da società a società, proprio perché le società sono diverse.
Questo è il problema centrale per la fondazione delle scienze umane,
per la fondazione della stessa antropologia e per la fondazione dell’antropologia medica dove, come vedremo, l’integrazione tra il biologico e il sociale diventa particolarmente evidente.
A questo punto si possono fare tante variazioni sul tema. Per esempio se volessimo sapere come sarebbe l’individuo senza il condizionamento del sistema sociale […] potremmo consultare un repertorio di
circa una ventina di casi di bambini che si sono persi fin da piccolissimi
e sono stati poi ritrovati adolescenti o adulti, studiati, analizzati, esaminati a partire dal 1700. Questo è un tema interessante che non possiamo
sviluppare in questa sede. Diciamo solamente, per esempio, che questi
bambini diventati adulti non riescono ad emettere suoni proprio perché
l’apparato della fonazione, che è un apparato biologico, è condizionato
dal processo di apprendimento del linguaggio. Se non impariamo a emettere i suoni funzionali ad una lingua in età infantile non ci riusciamo
più. Questo, fra l’altro, spiega il perché chi impara una lingua da adulto
mantiene l’accento della lingua originale. L’ho sperimentato personalmente perché stando in Brasile e avendo fatto tutte le scuole in Brasile,
parlavo il portoghese come i brasiliani, mentre i miei genitori, che pur
parlavano il portoghese benissimo, avevano mantenuto l’accento italiano proprio perché avevano appreso la nuova lingua da adulti.
Voglio sottolineare che questa interazione tra condizionamento biologico e condizionamento sociale in alcuni campi è particolarmente forte […]. Ci sono alcuni ambiti di ricerca delle scienze umane in cui il
I quaderni del CREAM, 2004 - II
9
nodo del rapporto tra il biologico e il sociale è molto stretto. Ne possiamo elencare sostanzialmente quattro.
Il primo è quello dell’alimentazione. Non è possibile studiare l’alimentazione senza partire dal principio che è un bisogno biologico comune a tutti gli uomini e che in nessun caso nella storia dell’uomo questo bisogno biologico ha trovato una risposta biologicamente fondata.
La risposta al bisogno biologico di alimentazione è sempre stata una
risposta di stampo sociale. Ovvero è sempre dipesa dai modi in cui
l’uomo ha saputo trasformare la natura in beni utili, cioè dal suo modo
di produzione, per cui l’alimentazione di una società agricola, l’alimentazione di una società pastorale o di una società industriale sono profondamente diverse. Anche il clima e una serie di fattori esterni influiscono, ma è la società che, a seconda di come stabilisce il rapporto con
il mondo naturale, crea quella che noi possiamo chiamare una tradizione gastronomica, una tradizione culinaria. L’antropologia dell’alimentazione è ormai così sviluppata da doversi quasi chiedere se si mangi
anche per nutrirsi. Sul fattore alimentare intervengono, infatti, una tale
quantità di fattori simbolici e di ogni altro genere (come gli effetti somatici dei problemi psichici), per cui l’intreccio tra quello che è un bisogno biologico comune a tutti gli animali e a tutte le piante, si intreccia fortemente al fattore sociale. Non si può comprendere l’alimentazione della specie umana senza comprendere in quali contesti sociali
si articola la risposta: bisogno biologico con risposta di stampo sociale.
Lo stesso lo possiamo dire per la sessualità. Non esiste infatti, a nostra conoscenza, nessuna società nella storia dell’uomo che non abbia
reagito a una pulsione che è biologica, la pulsione sessuale, senza costruire regole, canali, inibizioni, proibizioni, tabù. La sessualità di tutte
le società umane conosciute non si risolve mai esclusivamente nella sua
componente pulsionale biologica perché le società sono sempre intervenute su di essa. Ci troviamo di nuovo in un campo in cui uno studio
esclusivamente storico-sociale o solo biologico non avrebbe senso.
L’intervento storico-sociale non ci sarebbe se non ci fosse la pulsione
biologica, che è legata al problema della riproduzione. Da un lato siamo
quindi nell’ambito della biologia, ma questa biologia della specie umana è intercettata continuamente dall’etica, dalla regolarizzazione sociale, dalle strutture parentali, e da una serie di altri elementi che sono
produzioni storico-sociali.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
10
Il terzo esempio, più raffinato se volete, è quello introdotto da Marcel Mauss a proposito delle tecniche del corpo.2 Le tecniche del corpo
sono il modo in cui il corpo viene utilizzato nei diversi contesti sociali.
Marcel Mauss, per primo, ha dimostrato come ogni società selezioni
alcune potenzialità biologiche del corpo umano in funzione dello stile
di vita tipico di una determinata società. Queste potenzialità vengono
selezionate, addestrate, diventano potenzialità che si trasformano in capacità reali. Nel contempo vengono abbandonate altre potenzialità che
in quel contesto sociale non trovano un immediato utilizzo. In occidente
abbiamo perso una serie di tecniche corporee che sono invece state coltivate in oriente: pensiamo ad alcune forme di addestramento indiane,
alla capacità di invertire il movimento peristaltico o di abbassare il ritmo cardiaco. Il fachiro, trasformato in fenomeno da baraccone, sopravvive dopo essere stato rinchiuso in una cassa per dieci giorni, perché
pratica un’auto-ibernazione, fenomeno che in molti animali avviene
spontaneamente e che invece per l’uomo è un processo appreso. L’autoibernazione comporta una diminuzione del bisogno energetico di ossigeno e di alimentazione, abbassa il metabolismo ma non lo elimina. Un
individuo potrà resistere a simili condizioni solamente per un certo periodo: se riaprissimo dopo un anno la cassa dove il fachiro è stato rinchiuso lo ritroveremmo morto. Tuttavia egli ha una potenzialità corporea che la società occidentale ha sostanzialmente eliminato. Ogni società addestra il corpo secondo certe linee. È stato detto, per esempio, che
basta guardare un individuo camminare per capire la sua provenienza o
che è sufficiente osservare la sua gestualità per dedurre se viene dal
nord anglosassone o da Napoli. Esistono quindi usi e atteggiamenti verso il corpo che cambiano […].
Il quarto nodo che ci interessa è quello del rapporto tra salute e malattia. Noi abbiamo la possibilità di esaminare nell’uomo la dinamica
salute-malattia in termini esclusivamente biologici. Tuttavia è emerso
sempre più chiaramente che nel decorso e nella cura delle malattie intervengono una serie di componenti psico-culturali e socio-culturali.
Oggi siamo sempre più coscienti che anche la patologia non è una que-
2
Mauss, M. 1950: Sociologie et antropologie, Paris, Puf (trad. it. Teoria generale della
magia e altri saggi, Torino, Einaudi, 1965).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
11
stione esclusivamente biologica, ma si pone al centro del rapporto immediato fra biologico e sociale.
Ecco allora che ci stiamo avvicinando alla definizione dell’antropologia medica perché essa è, se volete, lo studio del versante socioculturale dei processi di salute e malattia. A fronte dei processi di salute
e malattia che sono stati esaminati e interpretati in termini prevalentemente biologici da parte di quella medicina occidentale che noi antropologi chiamiamo bio-medicina, cioè quella medicina fondata su una
ricerca scientifica prevalentemente concentrata sui fenomeni biologici,
si affiancano una serie di altri processi che non sono analizzabili in
termini biologici proprio per quello scarto tra livello biologico e livello
sociale di cui parlavo prima. Il livello sociale non può essere esaminato
con le categorie biologiche. Bisogna esaminarlo con le categorie delle
scienze sociali, cioè della sociologia, dell’antropologia, della psicologia, e via discorrendo.
La funzione integrativa dell’antropologia medica
In una prima definizione di massima l’antropologia medica può dunque essere definita come lo studio del versante sociale dei processi di
salute-malattia a integrazione dello studio biologico che di quegli stessi
processi viene fatto dalla biomedicina.
Come non possiamo studiare l’individuo soltanto da un punto di vista biologico, perché lo stesso decorso degli aspetti biologici dei processi di salute e malattia è socialmente condizionato, così non possiamo
analizzarlo solamente da un punto di vista sociale. E allora emerge una
questione, che sarà la conclusione a cui voglio arrivare: non è possibile
una semplice divisione di campi. Non basta che i medici studino i processi biologici di salute e malattia e che gli antropologi e i sociologi
studino i processi storico-sociali, perché in questo modo è come se noi
studiassimo da un lato l’uomo biologico e dall’altro l’uomo sociale.
Queste due astrazioni non esistono nella realtà, perché i fenomeni si intersecano a vicenda. Quindi quello a cui si dovrà arrivare è una riconsiderazione dei processi di salute e malattia come fenomeni integrati, biologici e storico-sociali. L’affermarsi di un’antropologia medica non
comporta semplicemente un’aggiunta del versante sociale dei processi
I quaderni del CREAM, 2004 - II
12
di salute-malattia ma una ristrutturazione del discorso, proprio perché
non si tratta di aggiungere ma di integrare, visto che lo stesso decorso
biologico dei processi di salute malattia è socio-culturalmente condizionato, così come, a sua volta, l’andamento sociale che incide su questi è biologicamente condizionato.
Una seconda osservazione che vorrei fare riguarda la nascita di quella che noi chiamiamo antropologia medica, perché la conoscenza dei
percorsi storici delle discipline è sempre un momento critico e interessante. Se i medici oggi studiassero di più la storia della medicina avremmo una medicina più ricca, come peraltro accadeva quando i medici si occupavano di una serie di questioni teoriche che si concentravano in una disciplina chiamata ‘patologia generale’, disciplina che
esiste ancora, ma che un tempo era concepita proprio come riflessione
teorica generale sul concetto di malattia che spalancava le porte ad una
serie di ragionamenti.
Per l’antropologia medica si potrebbe, tutto sommato, ripetere un discorso che si fa per l’antropologia in generale. Tutte le volte che si legge una storia dell’antropologia si devono sorbire quattro o cinque pagine del tipo: “Fin dall’antichità l’uomo è stato studiato… la riflessione
sull’uomo c’è sempre stata, è molto importante… poi nell’Ottocento è
cominciato lo studio scientifico”. Per chi legge non è mai ben chiaro se
questo pezzo di circa tremila anni di storia, minimizzato in maniera un
po’ occidentocentrica in quattro o cinque pagine, faccia parte della storia dell’antropologia, o di qualche altra disciplina […]. È però nell’Ottocento, con il positivismo, che si dice nasca la vera scienza dell’uomo,
la vera antropologia. Lo stesso si potrebbe dire per l’antropologia medica perché una riflessione sulla varietà dei costumi medici c’era già in
epoca romana. Per esempio Celso, grande medico romano, affermava
che non c’è popolo che non avesse elaborato una risposta alle malattie e
alle ferite. Potremmo allora dire che sebbene la disciplina sia nata
nell’antichità dobbiamo arrivare alla seconda metà dell’Ottocento,
quando cominciano i grandi studi sulle medicine.
In quest’epoca si costituiscono tutte le ricerche sulle medicine popolari europee. In Italia ci sono grandi indagini e importanti autori, Giuseppe Pitré per la medicina popolare siciliana, Zeno Zanetti per la medicina popolare umbra, una serie di altri che hanno studiato la medicina
popolare abruzzese, altri ancora quella modenese, e la medicina delI quaderni del CREAM, 2004 - II
13
l’Appennino marchigiano. Una serie di autori cominciano quindi a raccogliere informazioni su cosa pensavano quei popoli delle malattie, su
come reagivano ad esse. Vengono formulate quelle che potremmo
chiamare teorie della medicina popolare e allo stesso tempo prendono
le mosse i primi studi sulle cosiddette medicine esotiche. Gli antropologi cominciarono ad analizzare le idee che i popoli “selvaggi” avevano
sulle malattie, sulle ferite e sulla morte.
Dalla seconda metà dell’Ottocento iniziano quindi a venire studiate
le medicine dei ‘selvaggi’. Tuttavia non vengono ancora compiuti studi
sulla medicina occidentale. Essa viene usata come pietra di paragone:
tutte le altre medicine vengono giudicate in base a quanto siano più o
meno lontane dall’atteggiamento e dai dati scientifici della medicina
occidentale. Se analizziamo le ricerche sulla medicina popolare, che sono molto ricche e che rappresentano, fra l’altro, l’unica seria base che
abbiamo oggi per sapere com’era la medicina popolare, possiamo notare come queste medicine popolari venissero giudicate in base a quanto
fossero lontane dalla medicina ufficiale. Venivano quindi giudicate superstiziose, carenti di basi scientifiche e per ciò stesso inefficaci. Lo
studio di queste medicine doveva servire a documentare quanto indietro
fossero alcuni settori della stessa società europea (oltre a tutti i popoli
extra-europei) rispetto alla grande civiltà bianca, occidentale, scientifica. Dovevano inoltre servire a documentare quali superstizioni si dovessero eliminare per arrivare ad un atteggiamento scientifico. Non dimentichiamo che quella è l’epoca in cui la medicina ufficiale ha i più
giganteschi sviluppi, si scoprono le origini di molte malattie, si individuano i microbi, in rapporto ad essi si individuano i sistemi terapeutici,
si sviluppano le vaccinazioni. Assistiamo ad una stagione di progressive
vittorie della medicina ufficiale sulle malattie infettive, come mai era avvenuto negli ultimi 2000 anni. A fronte di questo tutte le altre medicine
apparivano come pratiche residue e superstiziose di gente ignorante.
Se dovessimo fare una valutazione sulla storia dell’antropologia medica, potremmo dire, anche se questo può sembrare paradossale, che
l’antropologia medica diventa una scienza solo quando non si limita più
a studiare le medicine degli altri, ma inizia a studiare anche quella occidentale. L’antropologia medica diventa una scienza solo quando, inventandosi il concetto di sistema medico, individua in tutte le società
l’esistenza di sistemi di interpretazione e di risposta alla malattia come
I quaderni del CREAM, 2004 - II
14
sistemi radicati nello sviluppo storico delle singole società, sistemi coerenti con le ideologie e con le concezioni del mondo, con le cosmovisioni, se vogliamo usare questo termine, delle singole civiltà. Ed è così
che anche la medicina occidentale diventa uno dei sistemi analizzabili
come tutti gli altri. Questo ha scatenato naturalmente l’ira di gran parte
dei medici. Io stesso sono stato coperto di insulti in certi congressi di
storia della medicina, perché secondo i medici la storia della medicina,
l’unica vera, quella occidentale, è una storia di progressivi trionfi, mentre tutte le altre sono solo delle superstizioni sopravvissute.
Il problema è complesso perché in effetti la medicina occidentale, la
biomedicina che deriva dal pensiero scientifico nasce anch’essa da una
certa concezione del mondo. Tuttavia per noi occidentali, come per gli
antropologi, la concezione scientifica del mondo non è uguale a tutte le
altre. Ovvero, senza un atteggiamento legato a una concezione scientifica dell’uomo non esisterebbero né la medicina, né l’antropologia, dal
momento che l’antropologia nasce proprio dall’idea che sia possibile
studiare scientificamente la condizione umana. Quindi ci troviamo di
fronte ad un paradosso. Da un lato, constatiamo che la biomedicina è un
sistema come gli altri, perché ha una sua concezione del mondo, ha una
sua struttura sociale, è un’istituzione, è legata ai poteri anche economici
(pensiamo al rapporto tra case farmaceutiche e sviluppo della ricerca
biomedica). Dall’altro, dobbiamo osservare che la biomedicina partecipa ad una concezione scientifica del mondo, a cui partecipa in fondo
anche l’antropologia. Ecco perché il problema è complesso. Bisogna
sottoporre la biomedicina ad un esame scientifico e storico-sociale come gli altri sistemi medici, e al tempo stesso non si può non riconoscere
che la legittimità epistemologica della medicina si fonda su criteri di
esame scientifico del mondo, che sono gli stessi su cui si basa anche
l’antropologia.
Questo è un grande problema. Se non si analizzasse la biomedicina
come un sistema insieme a tutti gli altri, l’antropologia medica cesserebbe di essere un’antropologia scientifica. Assumendo infatti come paradigma unico la produzione di una medicina in Occidente e in Europa,
tutte le altre medicine diventerebbero semplicemente confronti rispetto
a quel paradigma, il che non è scientificamente accettabile. Anche il
problema dell’efficacia delle terapie non può essere soltanto risolto
nell’ambito della medicina biologica.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
15
Ci avviciniamo quindi ad una prima conclusione. Nel tentare di definire cos’è l’antropologia medica abbiamo detto in generale che si interessa del versante sociale dello studio delle dinamiche di salute-malattia. Ora possiamo essere più precisi, e possiamo dire che l’antropologia
medica individua due campi specifici dell’analisi di questo versante sociale: il primo ambito riguarda i fattori sociali che incidono sulla salute
e sulla malattia; il secondo tratta le modalità con cui nelle varie società
si interpretano le malattie.
I fattori sociali della salute e della malattia
Il primo ambito è molto semplice da definire e riguarda i fattori sociali che incidono su salute-malattia, perché se ci sono fattori sociali
che incidono sulle condizioni di salute-malattia, questi fattori, in quanto
socialmente prodotti e storicamente determinati, sono tipici di alcune
società e non di altre, e non possono essere spiegati in termini biologici
bensì in termini storici. Se alcune popolazioni o classi sociali vivono in
un certo modo, questo è dovuto alle forme organizzative delle singole
società che non sono un fatto biologico, ma un fattore storico-sociale.
Ad esempio, nell’esaminare le condizioni di vita dei lavoratori inglesi
alla fine del secolo scorso, Engels analizza l’effetto della lavorazione
industriale, dell’urbanizzazione e di una serie di elementi che costituiscono la prima fase di sviluppo del capitalismo inglese. Allo stesso modo quando noi analizziamo perché c’è ancora tanto colera in America
del Sud e ce n’è poco in Italia, siamo di fronte non solo ad un fatto biologico, ma a una serie di elementi quali il sistema di vita o il sistema di
approvvigionamento idrico, che sono fatti storico-sociali e non biologici. Quindi è evidente che c’è un grosso versante di condizionamenti degli stati di salute e malattia che sono prodotti storico-sociali.
Se dovessimo articolare questo discorso si potrebbero individuare
tre livelli. Il primo livello, che è quello di cui parlavo adesso, riguarda
le condizioni di vita, di lavoro, di alimentazione, il tempo libero, fattori
che tutto sommato sono parzialmente studiati nelle facoltà di medicina.
Ad esempio l’alimentazione, non soltanto come insieme di regole, ma
come sistema, viene studiata sempre di più. La medicina del lavoro è lo
studio delle condizioni tecniche della lavorazione di un certo numero di
I quaderni del CREAM, 2004 - II
16
prodotti che incidono sullo stato di salute e malattia. Oppure numerosi
sono gli studi sull’aumento dei tumori in rapporto all’aumentare dell’inquinamento atmosferico legato all’industria e allo scarico delle automobili, e né l’industria né le automobili sono certo fatti biologici ma
prodotti sociali.
Ci sono poi altri due approcci possibili. Uno riguarda certi eventi
storici che hanno avuto una profonda incidenza sullo stato di salute e
malattia. Qui si possono fare esempi molto semplici. Il primo caso notissimo riguarda la grande peste del Trecento, epidemia che complessivamente ha ucciso circa la metà della popolazione europea. Descrizioni sulle condizioni delle città italiane alla fine del Trecento ci parlano di città ormai inesistenti, la cui popolazione era quasi tutta defunta
dopo pochi anni di epidemia. Una serie di storici datano nella peste del
Trecento l’inizio di una serie di dinamiche che devono essere analizzate
per capire la storia dell’Europa. La peste del Trecento è un dato biologico, nel senso che è stata causata da un microrganismo che abita nelle
pulci che a loro volta si insediano nei topi. Siamo quindi in un terreno
tipicamente biologico. Tuttavia l’analisi che è stata fatta da alcuni storici ci dimostra che sono stati i grandi traffici con il Medio Oriente, le
navi che andavano e venivano, a portare in Europa i topi infetti. Topi
sbarcati in genere dopo le grandi crociate, soprattutto in Sicilia e a Marsiglia, città da cui è partita la grande epidemia. Non si può dire che se
non ci fossero state le crociate non ci sarebbe stata la peste. Comunque
è certo che un dato storico come le crociate, in quanto grande movimento di gente, ha portato alle grandi epidemie di peste […].
Facendo un esempio ancora più noto, su cui c’è una documentazione
molto ampia, potrei ricordare come la scoperta dell’America introdusse
la tubercolosi tra gli indiani, che non l’avevano mai avuta, e la sifilide
in Europa, dove non esisteva […].
Il terzo caso che volevo sottolineare è quello che è stato meno studiato in medicina, sebbene oggi sia diventato sempre più evidente. Le
esperienze che gli individui hanno nella vita sociale si traducono in certi stati psichici, e il fatto di essere pessimista, ottimista, felice, scontento, depresso, ecc… incide sugli stati di salute-malattia. In altre parole
siamo di fronte ad un fenomeno che possiamo definire condizionamento da parte della psiche dei sistemi di difesa dalle malattie. Quindi
un sistema biologico di difesa dalle malattie, che è il sistema immunitaI quaderni del CREAM, 2004 - II
17
rio, viene condizionato dagli stati emozionali e psichici conseguenti alle
esperienze nel sociale.
Ora voi capite che qui si apre un gigantesco problema, perché quello
che era ovvio nella cultura popolare europea, e che non era invece riconosciuto dagli scienziati, deve venire ripreso in considerazione. Nella
cultura popolare europea era diffusa l’idea che il pessimista guariva più
difficilmente dell’ottimista; perfino i medici condotti lo sapevano, e
quando si diceva “è morto di crepacuore”, “è morto di dolore”, si intendeva proprio dire che un individuo in uno stato di profonda prostrazione
può lasciarsi morire o può comunque ammalarsi. Tuttavia quest’idea
non era accettata dagli studi accademici.
L’esperienza nel sociale si traduce in stati psichici che a loro volta
condizionano le strutture di difesa immunitaria. Quest’analisi è un punto fondamentale nello sviluppo dell’antropologia medica, che oggi non
abbiamo il tempo di discutere. Chi volesse analizzarlo potrà osservare
che dalla fine dell’Ottocento fino a tutto il Novecento, si va progressivamente affermando in modo convergente da tre settori della ricerca
scientifica, quello psicologico, quello antropologico e quello biomedico, la dimostrazione che effettivamente gli stati psichici incidono sugli
stati di salute-malattia.
I primi che se ne occupano sono gli psicologi. Freud già nel 1890
sottolinea il fatto che accanto ai farmaci, l’atteggiamento del paziente
verso il suo medico è un potente fattore di guarigione.3 Due anni dopo
Charcot, importante psichiatra francese, interviene nel furibondo dibattito di allora riguardo ai miracoli di Lourdes, rompendo l’antagonismo
delle due posizioni a favore o contro l’intervento del sovrannaturale, sostenendo che qualsiasi religione può, in certe condizioni collettive, creare una tale attesa di guarigione che può talvolta produrre una reale
guarigione.4
In questa sede non possiamo approfondire il discorso che si è sviluppato in antropologia con gli studi sui guaritori francesi di verruche.
Pierre Saintyves, un grande antropologo francese, scrive nel 1913 un
3
Freud S., Trattamento psichico (trattamento dell’anima) in Id., Opere, a cura di Musatti, C., vol. I. 1886-1895, Boringhieri, Torino, 1967, pp. 93-111.
4
Charcot, J. M., La foi que guérit, in “La Revue Hebdomadaire”, 7 (dicembre 1892),
pp. 112-132 (tr. it. La fede che guarisce, Capaccini, Roma, 1897).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
18
libro in cui dimostra che effettivamente i guaritori francesi curavano le
verruche con le formule magiche: le verruche andavano via.5 Sostenendo che non si trattava di un fatto magico, cercava di dimostrare che
era l’attesa di guarigione a creare una situazione di mobilitazione psichica che, badate bene, non cura una malattia psichica, cura le verruche,
che sono una malattia virale cioè tipicamente organica. Da lì si sviluppano tutta una serie di altre ricerche che cominciano nel settore delle
scienze psichiche, nel settore dell’antropologia, e poi si espandono anche nel settore della biomedicina. Negli anni Trenta un neuro-fisiologo
sovietico, Aleskej Speransky, allievo di Ivan Pavlov, scrive un trattato
sui fondamenti della medicina e dedica un capitolo al tema riguardante
lo stato psichico. Il sistema nervoso influenza il fatto che ci si ammali o
meno di malattie infettive di tipo microbico.6
In seguito soprattutto negli Stati Uniti, si sviluppano una serie di ricerche, che hanno premesse anche altrove, sul fatto che certe strutture
psichiche favoriscano lo sviluppo di certe malattie, che l’attesa di morte
produce morte. Queste riflessioni si collocano su una linea di continuità
con il noto saggio del 1926 di Marcel Mauss sull’effetto somatico prodotto dall’idea della morte suggerita dalla collettività.7
Viene indagato il rapporto tra emozioni e patologia, rapporto che riproduce l’idea indigena degli indiani d’America e del resto anche dei
contadini italiani, che una grande emozione, un grande spavento possa
produrre malattia: in tutta l’America Latina si chiama susto, ma una simile patologia è diffusa in Sicilia con il nome scantu, così come da altre parti. Si arriva poi alla nascita di un’intera nuova scienza biologica e
biomedica, che è la Psiconeuroendocrinoimmunologia, la quale sancisce nei termini dello studio molecolare, come il sistema nervoso centrale incida sul sistema immunitario.
5
Saintyves P. La guérison des verrues. De la magie médicale a la psychotérapie, Librairie Critique Emile Nourry, Paris, 1913.
6
Speransky, A. D. Elementy postronija teorii mediciny, VIEM, Moskva, 1935 (tr. it.
Fondamenti per una storia della medicina, Einaudi, Torino, 1956).
7
Mauss M., Effet physique chez l’individu d l’idée de la mort suggerée par la collectivité (Australie. Nouvelle Zelande) «Journal de Psicologie Normale et Pathologique» 22, 1926 (tr. it. Effetto fisico nell’individuo dell’idea di morte suggerita dalla
collettività (Australia e Nuova Zelanda), in ID, Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino, 1965, pp.327-347.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
19
Quindi abbiamo tre filoni, psicologico, antropologico e biomedico,
che alla fine del Novecento arrivano a queste conclusioni, aprendo
un’area problematica immensa sui fattori sociali della malattia. Per capire l’andamento delle malattie devono essere prese in considerazione
le condizioni ambientali, i fatti storici e il rapporto tra psiche e difese
organiche.
Le modalità con cui le società interpretano le malattie
Il secondo campo dell’antropologia medica è quello più classico:
studia i sistemi con cui nelle varie società si interpretano le malattie e si
risponde ad esse. La bio-medicina è uno di questi sistemi. Tuttavia tutte
le società hanno un sistema medico e ogni civiltà possiede una differente interpretazione del perché vengono le malattie e un’insieme di
pratiche, di saperi, di organizzazioni, di tecniche di apprendimento professionale per dare risposta ai problemi della malattia in termini sia preventivi che terapeutici.
A seconda che ammettiamo l’interpretazione della malattia fondata
scientificamente sul modello microbico-virale, o accettiamo invece l’idea che siano le divinità a produrre le malattie, per castigare gli uomini
in seguito a colpe o alla violazione di tabù, a seconda del caso verranno
utilizzati nella risposta differenti operatori. Alla concezione scientifica
corrispondono i medici; alla concezione che sia stato uno stregone che
ha rubato l’anima corrispondono gli sciamani; alla concezione che sia
una divinità che castiga una persona corrispondono i sacerdoti. Quindi
voi capite che in rapporto all’eziologia nascono diversi tipi di professionalità e questo vale in generale.
Questi aspetti si intersecano. Anche da noi non esiste solo una visione scientifica. Significativo è il fatto che nei grandi ospedali ci siano
delle chiese. Il parente del malato, che va dal medico a informarsi sulle
condizioni della malattia, ritiene infatti di poter aggiungere al responso
medico, che corrisponde ad una concezione scientifica della realtà, un
aiuto che può invece venire, diciamo, dal Padre Eterno o da un Santo,
come avviene in tante culture, a dimostrazione che la nostra non è poi
tanto diversa dalle altre.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
20
Un aneddoto divertente che corrisponde all’esperienza di molti operatori sanitari nei paesi cosiddetti tradizionali, racconta che dopo aver
tenuto dei corsi per insegnare che i microbi portano le malattie, si trattava di verificare se l’insegnamento fosse stato realmente recepito. Alla
domanda “chi porta le malattie?” tutti risposero correttamente “i microbi”. Tuttavia qualcuno si alzò subito dopo a chiedere: “Ma chi manda i
microbi?”. Anche in questo caso ci troviamo davanti ad una commistione di interpretazioni.
Quindi l’antropologia medica si interessa da un lato ai fattori sociali
delle malattie e dall’altro a come le persone e le culture interpretano le
malattie e rispondono ad esse. Ne deriva, e qui ci avviciniamo alla conclusione, un dato che è importante quando gli antropologi dialogano
con i medici. L’antropologia medica ha introdotto una concezione potremmo dire multi-concettuale della malattia.
Visto che questo discorso è cominciato soprattutto con l’antropologia nord-americana, vengono utilizzati dei termini inglesi, che in seguito sono stati utilizzati dagli antropologi in tutto il mondo. Tre sono le
parole che indicano la malattia in inglese, e la indicano in maniera non
così precisa come in antropologia dove hanno assunto un significato
ben preciso e differenziato. Il decorso biologico della malattia viene definito in inglese disease, che vuol dire malattia. Si tratta del livello della
concezione biomedica: un’aggressione microbica, un’eziologia, una patogenesi sviluppa la malattia, che viene o non viene curata, e produce il
decorso biologico della malattia.
Gli antropologi hanno poi aggiunto nel discorso altri due livelli che
sono i vissuti psichici della malattia da parte del paziente o dei suoi
congiunti, e come lui reagisce, cosa pensa della sua malattia, come la
vive. Si tratta non solo di fattori psichici, perché ogni cultura, entrando
nella testa degli individui, li orienta a vivere la malattia in un modo o
nell’altro. Per esempio, basta che in una cultura ci sia la consapevolezza
che la malattia è curabile, che il vissuto psichico cambia; è sufficiente
che una cultura consideri vergognosa una malattia che nel vissuto psichico della malattia si introduce il bisogno di nasconderla perché è una
cosa sporca. Pensiamo per esempio a quanta gente ha nascosto la propria sifilide perché si vergognava di riconoscerla. Questo secondo livello viene chiamato illness.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
21
Nell’antropologia si riconosce un terzo livello di analisi della malattia che è chiamato sickness: attiene al cambiamento di statuto sociale
che in una certa società il malato attraversa. In altre parole una volta
che uno si ammala cosa succede socialmente? Possiamo dire per esempio che nella società italiana, dove per fortuna abbiamo ancora un sistema nazionale sanitario, ogni cittadino malato ha diritto di essere curato. Non è così negli Stati Uniti come in altri paesi. Non era così nel
Medioevo dove il malato poteva divenire oggetto di beneficenza in alcuni conventi, ma per il resto era lasciato morire di fame, perché, fra
l’altro, si associava il fatto di essere colpito da una malattia alla dimostrazione di aver commesso peccato. Quindi essere malato è, se vogliamo, un dato biologico, ma il cambiamento di statuto sociale del malato è un dato storico-sociale. Questo è stato individuato per la prima
volta da uno dei maggiori sociologi contemporanei, Talcott Parsons, il
quale ha spiegato che essere malato è una condizione, mentre essere
paziente è un ruolo che cambia a seconda dell’organizzazione sociale.
Anche per questo Talcott Parsons può essere considerato uno dei fondatori di una moderna socio-antropologia.
Gli usi sociali dell’antropologia medica
Cercando di concludere questo discorso, vi parlerò di alcuni campi
applicativi dell’antropologia medica. Premetto che non tendo quasi mai
ad usare il termine ‘antropologia applicata’. Preferisco il termine ‘uso
sociale dell’antropologia’.
Tutti gli antropologi sanno bene che per alcune ricerche si trovano i
quattrini, mentre per altri argomenti non ci sono finanziamenti, per non
citare, poi, i casi in cui uno trova i quattrini se anticipa che il risultato
della ricerca sarà di un certo tipo: pensiamo ad esempio all’immenso
sviluppo della psicologia del condizionamento pubblicitario che ha avuto negli Stati Uniti finanziamenti giganteschi. Oggi noi sappiamo come
si aprono le pupille del consumatore nel supermercato di fronte agli oggetti esposti e invece ci sono interi problemi lasciati perdere perché non
hanno immediati risvolti di interesse.
Dal punto di vista delle questioni applicative, per un’antropologia
seria che non si faccia troppo condizionare, un primo settore deriva da
I quaderni del CREAM, 2004 - II
22
quello che ho detto prima, e riguarda cioè una maggiore attenzione al
rapporto medico-paziente. Su questo tema si sta sviluppando un vasto
utilizzo dell’antropologia medica, perché nel momento in cui siamo
consapevoli del fatto che il vissuto del paziente è un elemento costitutivo della sua possibilità di guarire o di peggiorare, non si tratta più da
parte del medico di essere buono o cattivo, ma diventa una necessità
professionale tenere conto dei suoi rapporti con il paziente e considerare lo psichismo del paziente come un elemento centrale, aspetto che
Sigmund Freud aveva già individuato nel 1890.
Questo è un grosso campo che oggi si sta sviluppando e che ha una
serie di correlati. Abbiamo oggi una legislazione che ci viene soprattutto dall’America, molto avanzata e progressista, almeno in apparenza.
Dichiara, per esempio, che il malato ha il diritto di sapere la verità sul
suo stato, per cui se gli restano tre mesi di vita il medico glielo deve dire. Si tratta, tuttavia, di una problematica complessa. Nel caso italiano
nelle facoltà di medicina non viene affrontato questo grosso tema della
comunicazione con il paziente, per cui i medici si trovano impreparati,
producendo casi di malati fermati nel corridoio dell’ospedale a cui viene comunicato che stanno per morire. Questa tendenza alla comunicazione con il paziente, come tutti gli orientamenti etici, è ulteriormente
condizionata e viene giustificata soprattutto nei paesi anglosassoni dove
è nata, come diritto di informazione, per cui se devo fare testamento ho
il diritto di sapere che sto per morire. In Italia invece c’è una certa resistenza, perché tanti medici che, nei casi molto gravi, hanno sempre dato
le informazioni ai parenti, non se la sentono di informare direttamente il
paziente.
Io non so cosa sia meglio. In un contesto ideale sarebbe forse meglio
la consapevolezza. Tuttavia se il medico non sa come dirlo e il suo discorso si tramuta in una forma di terrorismo nei confronti del malato, e
questo può provocare, come abbiamo visto, un abbassamento delle difese immunitarie del paziente stesso, ecco allora che il discorso si complica […].
Un altro grande tema, su cui non posso soffermarmi, è l’immigrazione, fenomeno che rappresenta la manna per gli antropologi medici
italiani, e che ha fatto sì che i servizi sanitari italiani si siano dovuti
confrontare con culture mediche diverse. Noi anche come Fondazione
I quaderni del CREAM, 2004 - II
23
Celli8 facciamo una serie di corsi alle ASL e alle aziende ospedaliere
sulle concezioni della malattia presso popolazioni diverse, e su quale
sia l’atteggiamento che bisognerebbe assumere di fronte a queste differenti concezioni. Le complicazioni sono molteplici, la più eclatante fra
le quali, che esce sempre su tutti i giornali, riguarda le mutilazioni sessuali femminili […].
Resta evidente la difficoltà di come calibrare i servizi sanitari alle
diverse concezioni di salute e malattia, di come favorire l’accesso di
persone con culture diverse ai servizi sanitari occidentali e di come modificare questi stessi servizi a fronte di immigrati che vengono da ogni
parte del mondo. Questo è uno dei problemi centrali su cui l’antropologia medica applicata oggi deve lavorare, e da cui nasce tutta una serie
di problematiche. Come fare in modo che i nostri servizi sanitari comprendano le concezioni della malattia, le richieste e i bisogni di salute,
per esempio dei magrebini? I servizi sanitari dovrebbero essere istruiti.
Non essendo possibile istruire tutti i servizi italiani, come soluzione si
potrebbe predisporre un certo ospedale in modo da renderlo più adeguato nel rispondere a queste richieste. Ecco che però, in questo modo, si
crea un ghetto, perché se c’è un servizio specialistico per gli immigrati,
esso verrà considerato un servizio di minor valore. Ci troviamo quindi
davanti al problema della calibrazione, dell’uguaglianza e dell’equità.
D’altra parte gli antropologi hanno visto anche un risultato negativo
del loro lavoro. Noi abbiamo convinto un certo numero di medici ad
accettare le concezioni mediche delle altre culture e a dialogare con esse. Abbiamo prodotto medici bravissimi, studiosi di antropologia, che
entrano in rapporto con cittadini di paesi dell’America Latina, dell’Africa, delle Filippine, dell’India, ecc… Capita così che quando gli immigrati da questi paesi vengono a chiedere la bio-medicina, questi medici vogliono riproporre loro le medicine tradizionali. Questo è un caso
tipico fra i peruviani, che provenendo soprattutto dalle città dove c’è
8
La Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute, con sede in Perugia, è stata
fondata nel 1987 da Alessandro Seppilli e intitolata ad Angelo Celli, insigne igienista
dell’Ottocento, noto per la sua attività universitaria e di ricerca e per il suo impegno per
una rapida e capillare traduzione sociale delle conquiste della medicina scientifica. La
Fondazione ha per scopo la costruzione e l’espansione la più larga possibile di forme di
cultura funzionali alla promozione della salute individuale e collettiva, intesa come diritto egualitario e bene indivisibile (vd. http://www.antropologiamedica.it).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
24
già la medicina occidentale, in Italia chiedono soltanto servizi più efficienti di quelli del loro paese. Succede che questi si trovino di fronte al
bravo medico che ha lavorato con gli antropologi e conosce la medicina
andina, le pratiche sciamaniche e il susto, e ritiene quindi che la sua apertura consista nel consigliare di lasciar perdere la medicina occidentale e di rivolgersi a quella tradizionale. Adesso sto rendendo la cosa paradossale, ma è stato chiamato ‘complesso di Salgari’. Un medico che
respinge la richiesta di medicina occidentale è abbastanza frequente,
così com’è frequente il medico che dichiara di essere totalmente aperto
alle altre medicine, ma nel trovarsi di fronte ad un caso concreto di un
paziente che si comporta in base alle concezioni di altre medicine, si
arrabbia terribilmente e lo caccia via.
Concludo con il terzo elemento dell’antropologia, diciamo, “applicata”. Si tratta cioè del famoso problema delle medicine internazionali.
Fin dagli anni Ottanta l’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolineava che in Europa almeno un terzo degli utenti dei servizi medici sociali, o comunque dei servizi medici di tipo occidentale, frequentava
anche medici e operatori di medicine non convenzionali. Spesso vengono definite ‘medicine alternative’, ma badate che questo termine è
molto fuorviante, perché di solito non sono vissute affatto come medicine alternative, bensì come altre specialità: come c’è l’oculistica o la
gastrointerologia, così c’è quello che cura quella certa malattia con le
tecniche cinesi, l’agopuntura, ad esempio. Quindi queste medicine non
vengono vissute come alternative, ma piuttosto come alternanti: un po’
da questo medico e un po’ da quello. Inoltre questo termine racchiude
elementi eterogenei: ci sono parti di grandi sistemi medici come quello
cinese o ayurvedico indiano; ci sono pezzetti di risposte magico-religiose di altre culture o grandi sistemi medici come quello tibetano; ci
sono anche medicine non convenzionali di origine europea come
l’omeopatia, che si è molto sviluppata ultimamente; oppure ci sono medicine non convenzionali di origine europea che non hanno la tradizione biologica dell’omeopatica, i fiori di Bach per fare un esempio.
Quando parliamo di medicine non convenzionali intendiamo quindi
un insieme di cose diverse su cui è necessario fare chiarezza. La chiarezza comporterebbe innanzitutto affrontare i problemi riguardanti l’efficacia, ed è quello su cui la ricerca è oggi ancora molto indietro. Io ho
fatto a Perugia un seminario sullo stato della ricerca, soprattutto in AI quaderni del CREAM, 2004 - II
25
merica, sull’efficacia dell’agopuntura. Sono venute fuori cose molto interessanti. È stata dimostrata l’efficacia in un certo numero di casi, ma
solo per l’agopuntura, solo per alcune casistiche e solo negli Stati Uniti.
Il problema andrebbe invece approfondito perché bisognerebbe innanzitutto definire cosa si intende per ‘efficacia’, concetto che viene inteso in
modo diverso nelle varie culture. Poi bisognerebbe definire come si
prova l’efficacia. Un problema paradossale è che quando noi parliamo
di efficacia delle medicine sacrali ci imbattiamo in una questione paradossale, che è la questione dell’effetto placebo. Voi sapete che l’effetto
placebo è l’effetto terapeutico prodotto da un farmaco che non ha in sé
poteri terapeutici. L’esperienza occidentale dimostra che molte volte si
arriva a un 20% di efficacia del placebo, il che significa che per autorizzare la creazione di nuovi farmaci bisogna che la dimostrazione della
loro efficacia sia superiore a quella dei possibili placebo, altrimenti non
occorrerebbe inventare un farmaco nuovo, basterebbe l’acqua distillata,
o una pillola in cui non c’è nulla ma che venisse investita da un’attesa
di guarigione. Mi sembra tuttavia paradossale che la medicina occidentale utilizzi l’effetto placebo solo per testare l’efficacia di nuovi farmaci
e non abbia mai utilizzato l’effetto placebo per fare terapia. Se è vero
che l’effetto placebo in condizioni di pura sperimentazione, può arrivare fino al 20% di efficacia, se venisse studiato a fondo, forse consentirebbe di introdurre una componente psichica di terapia che si affianchi
a quella farmacologia, chirurgica o di altro genere.
E questo ci porta ad un’osservazione finale. Siamo di fronte alla necessità di costruire una nuova medicina, che deve essere una medicina
organica e unitaria, che tenga conto di tutti questi aspetti, di tutte le
componenti psico-sociali e degli effetti del placebo. Un medicina che
consideri l’uomo non soltanto come un essere biologico in cui la malattia è una vicenda biologica, ma l’uomo nella sua integrazione sociale,
nella sua cultura, nel suo modo di vivere e negli effetti che questo modo
di vivere ha sulla salute. Questo significa una nuova medicina, più ampia, più organica.
La critica antropologica alla bio-medicina non è quella di essere
troppo scientifica, ma, al contrario, di esserlo troppo poco. Cioè la critica che noi facciamo non è per quel tanto di scientifico, cioè biologico,
negli studi di medicina. La critica alla bio-medicina è che lo studio dei
fenomeni è fatto solo in base alla biologia e non all’insieme delle scienI quaderni del CREAM, 2004 - II
26
ze dell’uomo. Accanto alla biologia si devono quindi considerare i condizionamenti storico-sociali e quindi la sociologia, l’antropologia, la
psicologia ecc… Per questo noi diciamo che la biomedicina non è abbastanza scientifica, perché taglia l’uomo a metà. Non è troppo scientifica ma lo è troppo poco: e da questo punto di vista la critica antropologica ha una propria identità precisa.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
27
I quaderni del CREAM, 2004 - II
28
ROMANO MASTROMATTEI
•
♦
IL GOVERNO OMBRA DEL NEPAL
La stampa internazionale – e soprattutto quella occidentale – non ha
mai dedicato molta attenzione alle vicende nepalesi: i lettori dei quotidiani spesso ignorano che nel Regno del Nepal, dal febbraio 1996, è incorso una guerra civile e che le truppe e la polizia dell’attuale re Gyanendra controllano di fatto solo una piccola parte del territorio del Regno:
la capitale, la valle che la circonda e una serie di città minori.1
In Nepal e in India è possibile acquistare libri, giornali e riviste che
trattano ampiamente della situazione politica, economica e militare di
un Paese che ha sempre avuto una grande importanza strategica e che
potrebbe acquisirne una molto maggiore nel corso dell’attuale conflitto
islamico-statunitense, nonché in un futuro confronto tra USA e Repubblica Popolare Cinese.
È un peccato che chi scrive queste righe non sia uno storico, un politologo o un economista: si tratta di un antropologo, che può invocare a
proprio credito soltanto un’annosa dimestichezza con quelle campagne,
•
Professore Ordinario di Antropologia Culturale Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
♦
Vorrei ringraziare dell’aiuto e della collaborazione il professor Prem Khatry, il Generale Chatra Bikram Shah, il N.H. Arjun Jung Shah (USAID), il professor Hamid Ansari
e il professor A.Prakash Raj. Ringrazio per il gentile contributo telematico l’ingegner
Antonio Della Rocca.
1
Una notevole eccezione è costituita dall’ottimo saggio di Garzilli E., 2003, “Strage a
Palazzo, movimento dei Maoisti e crisi di governabilità in Nepal”, in Asia Major, a cura
di M. Torri, Bologna, Il Mulino.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
29
che tanta parte hanno nell’ideologia e nella prassi dei maoisti insorti
contro il Governo di Sua Maestà.
Nel corso degli ultimi tre o quattro anni, peraltro, è diventato sempre
più difficile e rischioso avventurarsi fuori della Valle di Kathmandu,
specie se – per motivi professionali – si portano con sé costose attrezzature audio-visive e il denaro liquido necessario per pagare guide e portatori, nonché per acquistare cibo e combustibile.
È tuttora possibile seguire le piste classiche del trekking, che vanno
da sud a nord, verso le cime sempre meno immacolate dello Himalaya:
il forte calo del numero dei turisti – ridotto del 70% secondo stime governative – indica però che anche i trekker temono giustamente possibili incontri spiacevoli lungo il loro cammino, nonostante gli accordi intercorsi tra le agenzie turistiche e i dirigenti degli insorti. Questa situazione generale ha costretto anche gli antropologi meno interessati alla
realtà urbana, a lunghe e pensose soste nella capitale, con molto tempo
a disposizione e la possibilità di scambiare idee con la gente del posto –
dai politici agli accademici, dagli albergatori (preziosa fonte!) ai negozianti, senza escludere i lavoratori di casta o fuori casta. Un mondo – va
detto subito – molto, molto diverso da quello delle campagne.
Il cibo, il combustibile e altri generi di prima necessità sono tuttora
disponibili all’interno della Valle di Kathmandu: negli alberghi e nei
ristoranti di lusso, la guerra ha avuto conseguenze quasi impercettibili
per i visitatori stranieri – beninteso, per quelli provvisti di valute forti.
Del tutto diversa è la situazione dei sudditi nepalesi, usi a nutrirsi essenzialmente di riso, mais, legumi e verdure: la zona agricola più produttiva si trova nel Tarai, la grande pianura lungo il confine con l’India.
Attualmente, le vie di comunicazione tra la capitale e il sud sono insidiate dagli insorti e dai banditi, detti dacoit (propriamente: grassatori),
che erano già una piaga in tempi più tranquilli. La produzione della
Valle, di per sé piuttosto ricca, non può bastare alla popolazione, grandemente aumentata a causa dell’afflusso crescente di profughi provenienti dalle zone controllate dai seguaci dell’ideologia attribuita a Mao
tze tung e che si definiscono come “Maobadi”. Di fatto, la popolazione
delle campagne, sia nella pianura del Tarai, sia nella fascia mediana
collinosa del Paese, è vessata e ferocemente sfruttata non solo dai Maobadi e dai banditi, ma anche dall’esercito e dalla polizia che – come ve-
I quaderni del CREAM, 2004 - II
30
dremo più avanti – non esitano a saccheggiare le magre derrate dei contadini.
Per comprendere l’attuale stato delle cose, è necessario fare qualche
cenno alle origini della guerriglia maoista, che ha dato luogo ad una vera guerra civile – un termine che per lungo tempo non è stato usato dalla pubblicistica nepalese.
L’atto di nascita ufficiale dell’attuale ribellione armata porta la data
del 13 febbraio 1996, allorché gruppi di guerriglieri attaccarono simultaneamente diversi obiettivi in vari distretti del Regno: nel Distretto di
Gorkha (Nepal centrale), i guerriglieri irruppero in una banca statale
che finanziava un programma di sviluppo agricolo a vantaggio – reale o
presunto – dei piccoli proprietari e distrussero tutti i documenti relativi
ai prestiti concessi, per parecchi milioni di rupie, ai piccoli coltivatori,
risparmiando invece i titoli di proprietà. Durante questa azione, alcuni
guerriglieri arringavano la folla, illustrando le motivazioni politiche e
sociali del colpo di mano: a quanto risulta, questa è una prassi che caratterizza molte imprese Maobadi. Lo stesso giorno, i Maobadi attaccavano tre stazioni di polizia, rispettivamente nei Distretti di Rolpa e di
Rukun nel Nepal occidentale e nel Distretto di Sindhuli, nel Nepal orientale. I guerriglieri, che a quanto si disse erano abbastanza ben armati, s’impadronirono di nuovi armi ed esplosivi, strappati ai poliziotti,
che da parte loro non dovettero opporre una fiera resistenza, poiché non
vi furono caduti tra i loro ranghi.2
Anche in queste tre distinte occasioni, i Maobadi non mancarono di
indottrinare i poliziotti prigionieri e le loro famiglie con lunghi discorsi
sulla “Nuova Rivoluzione Democratica”. Questo atteggiamento didattico e bonario non è affatto tipico delle successive azioni dei Maobadi,
che sono state e sono tuttora caratterizzate da un’estrema crudeltà, non
molto dissimile dalle rappresaglie dei loro nemici.
Sempre lo stesso giorno, altri obiettivi esemplari venivano colpiti: un
impianto della Pepsi Cola a Kathmandu, una fabbrica di liquori apparte2
Nell’agiografia rivoluzionaria, figura anche il topos degli insorti che a mani quasi nude strappavano le armi al nemico: ma chi ha osservato, come lo scrivente, il comportamento della polizia nepalese durante la rivoluzione della primavera del 1990, non può
che dubitare di tale versione e semmai è incline a pensare che gli insorti avessero segretamente comprato le armi dai poliziotti stessi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
31
nente ad un “comprador borghese” (ancora nel Distretto di Gorkha3) e
una casa di un noto “feudatario-usuraio” nel Distretto di Kavre nel Nepal orientale. La stessa notte, migliaia di volantini e di manifesti comparivano in ben 60 dei 75 Distretti del Regno: il Partito “si appellava
alle masse, affinché marciassero lungo il sentiero della Guerra di Popolo, per schiacciare lo stato reazionario e fondare un Nuovo Stato Democratico”. Questa prova generale rivela una lunga e meticolosa preparazione: fra l’altro, le comunicazioni in Nepal (specie quelle telefoniche)
sono state sempre carenti e difficili e nulla può essere improvvisato,
tanto meno su scala nazionale.
L’annuncio ufficiale dell’imminente nascita della guerriglia risale a
tredici giorni prima: consiste in una lettera, datata 4 febbraio 1996, fatta
pervenire al Primo Ministro Sher Bahadur Deuba dal Dr. Baburam
Bhattarai, per conto del Fronte Unito del Popolo del Nepal. Questa lettera equivale ad una dichiarazione di ostilità, perché è impensabile che
il Primo Ministro potesse dare una risposta positiva alle richieste formulate da Bhattarai, nella sua qualità di Segretario del suddetto Fronte
Unito.
La lettera presenta quaranta istanze ed è pertanto molto secca e laconica, per standard maoisti: lo spazio, tuttavia, c’impedisce di riprodurla integralmente, come sarebbe auspicabile. In ogni caso, l’analisi
preliminare della situazione generale del Nepal formulata in apertura è
purtroppo molto realistica e ne riporteremo le tesi essenziali. Bhattarai
rilevava che sei anni erano trascorsi dalla rivoluzione dell’aprile 1990 o
– come altri preferiscono definirla – dal “Movimento Popolare” che aveva posto fine al sistema monarchico autocratico, senza partiti, detto
Panchayat. Dal 1990 al momento in cui Bhattarai scriveva, si erano avvicendati al potere quattro governi, sulla base di “un sistema costituzionale, monarchico, multipartitico, parlamentare”. Questa è la definizione
dello stesso Bhattarai: inaspettata, perché in Nepal non è mai stata eletta un’assemblea costituente, né è stata nominata dall’alto.4 In ogni caso,
3
A questo episodio non venne data pubblicità, perché –una nota comica in un contesto
che diventerà sempre più drammatico –i poliziotti accorsi alla fabbrica non mancarono
di servirsi abbondantemente dei prodotti della borghesia compradora.
4
Tutte le costituzioni del Regno del Nepal, passate e presenti, sono state concesse, modificate o revocate dai vari re.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
32
i risultati raggiunti da questi governi – fossero monopartitici o di coalizione – erano stati disastrosi: “Il Nepal è scivolato al secondo posto fra
le nazioni più povere del mondo (dopo l’Etiopia, R.M.); la gente che
vive al di sotto del livello di povertà assoluta ha raggiunto il 71%; il
numero dei disoccupati ha superato il 10%, mentre il numero delle persone semi-occupate o con occupazioni al nero ha superato il 60%; il
Paese è sull’orlo della bancarotta a causa dei sempre più esosi prestiti
stranieri e del deficit commerciale; l’infiltrazione economica e culturale
del Paese da parte degli espansionisti stranieri, specie Indiani, cresce di
giorno in giorno; la forbice tra ricchi e poveri e tra città e villaggi si allarga sempre più”. – Se è lecito aggiungere alcune postille alle parole
del Dr. Bhattarai, si può osservare che della rivoluzione da alcuni detta
borghese del 1990 hanno beneficiato sopra tutto le caste e sottocaste di
mercanti e professionisti di stirpe newar residenti nella Valle di Kathmandu – che peraltro si erano dimostrati coraggiosi e intraprendenti
nell’effettiva conduzione del “Movimento”. La città di Kathmandu subì
dei vertiginosi mutamenti urbanistici ed economici: l’afflusso di denaro
e di merci provenienti dall’estero era vistoso. Il risultato più diretto e
immediato fu una forte inflazione ed una continua fuga di capitali, esportati soprattutto a Hong Kong, non ancora annessa alla Cina Popolare. L’arricchimento era – o piuttosto sarebbe dovuto essere – legato
in gran parte al turismo: giganteschi alberghi furono costruiti dentro e
fuori la città, deturpando senza il minimo scrupolo il paesaggio. Il risultato fu un forte calo del turismo, che precede – si badi bene – di anni
l’insurrezione maoista. La Lufthansa cessò il collegamento diretto con
Kathmandu, dichiarando ufficialmente che i turisti tedeschi non erano
interessati affatto nella nuova realtà nepalese: le immondizie soffocavano la città, l’inquinamento causato dai gas di scarico degli automezzi
e da industrie dannose (cemento e lavaggio dei tappeti nelle acque fluviali della Valle) copriva la capitale di una nube tossica e puzzolente;
dai rubinetti usciva acqua variamente colorata. Gli abitanti delle campagne, usi a venire in città per vendere al minuto i loro prodotti – essenzialmente verdure e animali da macello – erano schiacciati dalla concorrenza dei nuovi supermercati, dove possono approvvigionarsi soltanto i ristoranti, gli alberghi e gli stranieri provvisti di valute forti. Inoltre,
i mercati tradizionali venivano e vengono respinti ai margini della città.
L’occupazione al nero, di cui parla Bhattarai, è bene esemplificata dal
I quaderni del CREAM, 2004 - II
33
caso dei lavoratori degli alberghi, che ricevono salari assurdamente
bassi: l’unico modo di sopravvivere, per questi uomini e queste donne,
è di passare le loro notti negli ambienti più inospitali degli alberghi su
giacigli improvvisati e di cucinarsi qualcosa su fornellini di fortuna; e
tutto ciò, per tutta la vita.
Del lavoro al nero nelle fabbriche di tappeti, non è possibile parlare
qui: basti dire che i bambini e le bambine ivi impiegati non hanno alcun
modo di difendersi dal più spietato sfruttamento e da ogni sorta di maltrattamenti. Queste attività, tipiche della capitale, costituiscono di fatto
una vera forma di schiavitù.
Il divario tra città e campagne di cui parla Bhattarai si presterebbe
ad ulteriori considerazioni: la prima è che per quanto riguarda la possibilità di procurarsi del cibo, la fertile fascia pianeggiante del terai (o
Tarai) era la più favorita: la zona mediana collinare, assai meno; e la
zona settentrionale montuosa può a malapena offrire dei pascoli stagionali. Prima della guerra civile in corso, riempirsi lo stomaco era senza
dubbio più facile per un abitante del terai che non per un cittadino povero: attualmente, a causa dei continui saccheggi – ovvero: “requisizioni” – e dei pericoli connessi con il trasporto su strada delle derrate, è
più facile sopravvivere per un abitante della città, sia pure a costo di esercitare attività precarie e umilianti – compreso l’accattonaggio e la
prostituzione. Anche nei lunghi anni precedenti la rivoluzione – o come
la si voglia chiamare – del 1990, chi voleva svolgere delle indagini antropologiche nell’interno del Paese, lontano dai percorsi clientelari del
trekking, doveva acquistare in città cibo sufficiente per sé e per i portatori, perché accadeva spesso di non trovare assolutamente nulla da
mangiare nei villaggi della fascia collinare; e la stessa dieta degli agricoltori era di una povertà estrema.5
5
Il pasto-tipo consisteva in una sorta di polenta di mais, con erbe selvatiche e peperoncino –e non certo in quantità sufficiente da sfamare un adulto. Per obiettività, si deve
dire che nelle campagne si è creato un circolo vizioso, per cui l’agricoltore denutrito
non riesce a lavorare a sufficienza ed è denutrito perché non produce abbastanza. Ciò è
particolarmente evidente per chi ha visto lavorare, ad esempio, i contadini della Cina,
quale che sia la loro origine etnica. Un altro grave problema in Nepal è costituito
dall’assenza del concetto di manutenzione, che ha come conseguenza danni irreparabili
agli strumenti di lavoro – inclusi i più semplici – e danni alle abitazioni. L’efficienza
dei maschi è molto inferiore a quella delle donne, che si sobbarcano fatiche onerosissime. Un quadro documentato e realistico della situazione generale della donna in Nepal
I quaderni del CREAM, 2004 - II
34
La lettera-proclama di Bhattarai prosegue con una denuncia dei partiti parlamentari, che hanno partecipato ai recenti governi e che “hanno
dimostrato in vari modi di essere più interessati nel restare al potere con
la benedizione dei padroni stranieri imperialisti ed espansionisti, che
non nel benessere del Paese e del popolo”.
Il testo fa poi riferimento alla cessione, da parte del governo nepalese, dei diritti sulle risorse idriche nazionali agli “espansionisti indiani”.
È da notare che nel linguaggio dei Maobadi, gli Occidentali – in particolare, gli Americani – sono detti “imperialisti” e gli Indiani, “espansionisti”. Non v’ha dubbio che questo termine non si riferisca soltanto a
una posizione geografica, ma che insegua altresì una qualche lambiccata distinzione. Bhattarai si riconosce esplicitamente nella linea politica
e nelle sollevazioni armate dello United People’s Front, denunciando la
repressione del governo del re Birendra, che peraltro non è esplicitamente nominato. Il testo in esame si riferisce in modo preciso e specifico all’operazione di polizia (in codice: ROMEO), condotta nel dicembre 1995 nel Distretto di Rolpa (Nepal centro-occidentale) contro i militanti del citato UPF e i “Maoisti”, che – a quanto risulta – non sembravano ancora costituire un movimento organizzato, ma piuttosto un raggruppamento composto da diverse correnti e tendenze. Com’è ovvio, la
storia reale e non strettamente documentale di questo movimento non è
un libro aperto, ma l’attacco contro i posti di polizia e le banche che si
verificò, come s’è detto, il 13 febbraio 1996, dimostra che all’interno
del movimento genericamente maoista, doveva esistere una solida infrastruttura organizzativa o – se si preferisce – un “nucleo d’acciaio”.
L’operazione ROMEO fu brutale e sanguinosa, messa in atto non solo
dalla polizia, ma anche da militanti civili di partiti di centro-destra, diretta di fatto contro la maggioranza della popolazione dei Distretti di
Rolpa e di Rukum e caratterizzata da saccheggi e violenze indiscriminate. Le vittime furono centinaia: ciò è confermato dal rapporto di una
commissione parlamentare nominata ad hoc per indagare sui fatti. Ma
questa indagine non impedì che ROMEO diventasse il modello delle
si può trovare in Gautam S., Banskota A. e Marchanda R., “Women in the Maoist Movement in Nepal”, in Tapa D. (a cura di), 2003, Understanding the Maoist Movement of
Nepal, Chautari Books Series, Kathmandu, 2° edizione, p. 11. Secondo le autrici citate,
il carico di lavoro di una donna è quattro volte superiore a quello di un uomo.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
35
successive operazioni antiguerriglia: e come vedremo, fu un pessimo
modello. Lo Human Rights Yearbook del 1995 riferì che “il Governo
diede corso ad una serie di operazioni a livello di terrore di stato. In
particolare, i lavoratori appartenenti all’UFPN furono brutalmente perseguitati. Seguendo le istruzioni di membri dei partiti dominanti della
zona, la polizia, in undici villaggi del Distretto, ricercò, arrestò e torturò
senza alcun mandato. Quasi seicento persone del luogo avevano lasciato i loro villaggi a causa delle operazioni di polizia. Centotrentadue persone furono arrestate senza alcuna garanzia legale: in questo numero,
figuravano vecchi di oltre settantacinque anni”. Tutti i detenuti – conclude il documento – subirono torture. Secondo alcuni osservatori, la
malaugurata Operazione ROMEO ebbe un peso determinante nella decisione dei Maoisti di lanciare la “Guerra di Popolo”.
Quanto è stato sommariamente esposto può dare un’idea dell’avvio
del processo meccanico della guerra in corso: per una ricostruzione più
approfondita degli eventi, si deve indagare sulla realtà specificamente
nepalese, che non può essere ridotta al quadro offerto dalla stampa – sia
governativa, sia ispirata dall’opposizione parlamentare – e neanche dalla pur copiosa produzione di documenti e proclami diffusi dai Maobadi.
Tutte queste fonti, pur nella loro eterogeneità, hanno in comune la tendenza a prospettare un quadro fortemente snazionalizzato, urbano e partitico di un Paese asiatico, rurale e castale. In Nepal, la tendenza ad adottare formule organizzative di tipo occidentale non trae direttamente
origine – né lo potrebbe – dall’Occidente europeo o americano, bensì
dall’India post-coloniale. Il re Tribhuvan, che nel 1951 pose fine al dominio dei Rana – un clan aristocratico che nel suo ruolo ricorda gli
Shogun del Giappone – mise in atto il suo colpo di stato col pieno appoggio del governo di Nehru; e l’organizzazione partitica del Nepal in
parte ricalca, in parte si connette saldamente a partiti e movimenti indiani. Ciò è evidente soprattutto nel caso del Partito del Congresso e dei
movimenti che ufficialmente si richiamano all’ideologia ed alla prassi
maoiste, ma non certo alla Cina del dopo Mao.6
6
Una buona ricostruzione della storia delle varie correnti all’interno del movimento
genericamente maoista nepalese, si trova in Whelpton J., 1994, “The General Elections
of May 1991”, in Nepal in the Nineties (SOAS Studies on South Asia), a cura di Hutt
M., Delhi, pp. 48-81. Lo scritto di Whelpton ha il pregio di analizzare la storia delle
varie correnti maoiste in Nepal anche alla luce degli eventi che precedono la presa del
I quaderni del CREAM, 2004 - II
36
Il programma di Bhattarai, che esprime l’orientamento del Comitato
Centrale dell’UPF del Nepal, è una singolare mescolanza di progetti utopistici e di richieste sconcertanti per la loro banalità e irrilevanza. Si
parla di abrogazione di trattati che sanciscono l’egemonia politica ed
economica del potente vicino indiano (Punti 1, 2, 3); si auspica la fine
del dominio del capitale straniero nell’industria, nel commercio e nelle
finanze del Paese; si parla di una nuova Costituzione, che dovrebbe essere elaborata da rappresentanti eletti dal popolo – se intendiamo bene
ciò che non è esplicitamente detto. – “Tutti gli speciali privilegi del re e
della famiglia reale dovrebbero essere aboliti”: si allude qui – a nostro
parere – all’impunibilità dei membri della famiglia reale rispetto alle
leggi nepalesi e all’impossibilità di sottoporli a processo, anche nel caso
di reati comuni. Non si parla affatto di abolizione della monarchia: ma
il “Nepal dovrebbe essere dichiarato nazione laica” (Punto 18). Quindi,
l’induismo non dovrebbe essere più religione di stato e il re non dovrebbe essere più oggetto di un culto divino.7 Quanto al sistema castale
– sinora, asse portante della società nepalese nel pubblico e nel privato
– leggiamo un riferimento parziale e indiretto: “Il sistema dell’intoccabilità dovrebbe essere eliminato” (Punto 21). Tale espressione in realtà
ha ben poco senso, perché l’intoccabilità – si allude ai paria, detti dalit
in Nepal – non costituisce affatto un sistema, bensì il corollario di un
sistema. Nel primo paragrafo del programma, accanto alla già citata richiesta di abrogazione dei più importanti trattati con l’India, figura
quella di vietare “la circolazione di tutti i veicoli a targa indiana” (Punto 3); e al Punto 8 si auspica la messa fuori legge di tutti i “volgari film,
video e riviste hindi”.
Ci siamo soffermati su questa lettera-proclama – che naturalmente
non ebbe risposta – perché segna l’inizio di una guerra civile disastrosa,
di cui non si può prevedere la fine.
potere da parte di Mao-tsetung in Cina. La tattica e i compromessi del PCC funsero da
modello alla condotta e ai programmi dei partiti d’ispirazione maoista del Nepal.
7
Delle valenze e funzioni divine della figura del re del Nepal si è occupata Letizia C.,
2003, La dea bambina – Il culto della Kumari e la regalità in Nepal, Franco Angeli,
Milano, con ampia e adeguata bibliografía.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
37
Rammentato e ricostruito il singolo evento che – otto anni fa – ha
innescato il processo di disgregazione di un Paese, vediamo ora di rintracciarne, almeno in parte, le cause e le origini.
Per avvicinarsi alla comprensione della realtà nepalese, si deve considerare anzitutto la sua tradizionale struttura induista e monarchica,
con una forte presenza buddhista ed uno spesso sostrato etnico tibetobirmano, fondamentalmente estraneo alla cultura castale dominante, ma
da questa non solo dominato, ma modellato.8
A nostro parere, non è sufficiente tracciare una storia tutta interna
dei movimenti e dei partiti di ispirazione marxista per avere un quadro
chiaro della situazione verificatasi negli ultimi venti o trent’anni nel
Nepal: questa storia, peraltro, ci viene proposta con serietà e competenza da un gruppo di politologi nepalesi e occidentali e può essere ben usata come complemento di un quadro ideologico complessivo di là da
venire.
Ci si deve anzitutto confrontare con il fatto che la stessa idea di partito è profondamente estranea alla cultura del Nepal, anche se numerosi
partiti sono stati presenti – alla luce del sole, in clandestinità o in semiclandestinità – nella Valle di Kathmandu negli ultimi cinquant’anni: ma
la capitale e le città satelliti non rappresentano certo il Paese nella sua
realtà profonda e totale. Ci permetteremo, pertanto, di offrire una ricostruzione trasversale degli eventi che hanno condotto all’attuale guerra;
un’indagine puntuale, che tenesse conto di tutti i conflitti interni e le
innumerevoli scissioni verificatesi all’interno di partiti spesso minuscoli
sarebbe – noi crediamo – di scarso interesse per il lettore italiano e devierebbe la sua attenzione verso fattori obiettivamente secondari.
Una delle opere più documentate e meno inviscate in micropolemiche interne è A Kingdom Under Siege – Nepal’s Maoist Insurgency,
1996-2003 di Deepak Thapa e Bandita Sijapati.9 Il 1996 – anno dell’inizio ufficiale della guerra civile – si colloca in una fase storica di vio8
La letteratura scientifica sul sistema castale induista in lingue occidentali è molto vasta:
l’opera fondamentale, immediatamente accessibile al lettore italiano, è: Homo hierarchicus – Il sistema delle caste e le sue implicazioni, Adelphi, Milano 1991, traduzione italiana del testo di Dumont L., 1966, Homo hierarchicus – Le système des castes et ses implications, Editions Gallimard, Paris. I marxisti nepalesi – a qualsiasi partito o gruppo appartengano – rifiutano e condannano il sistema castale, almeno in teoria.
9
Pubblicato da The Printhouse, Kathmandu, 2003; con ampia bibliografía.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
38
lenza endemica, caratterizzata dalla prepotenza delle caste più alte, dei
ceti più abbienti e delle forze di polizia, che hanno costantemente sfruttato e angariato le caste più basse, i fuori casta e i gruppi etnici più deboli, quale che fosse la loro consistenza numerica. L’esercito – che ha
sempre avuto grande peso nella politica interna del Nepal – era fedele
al re in carica ed è rimasto tale fino al giugno 2001, allorché ha indiscutibilmente appoggiato il nuovo re Gyanendra nella sua sanguinosa presa
del potere.
Poiché l’attuale movimento di guerriglia ha le sue radici in una peculiare varietà di marxismo asiatico, dedicheremo particolare attenzione
a questa linea politica: ma ciò non deve indurre il lettore a credere che
questa e solo questa linea mirasse al rovesciamento dell’ordine esistente
da secoli in Nepal.
Thapa e Sijapati scelgono come paradigma delle violenze che seguiranno il caso del villaggio di Mirul, nel Distretto di Rolpa, Nepal centro-occidentale, abitato dal gruppo etnico Kham Magar.10 Nel 1996, nel
villaggio non si vedevano uomini: a quanto sembra, erano quasi tutti
simpatizzanti dell’UPF (United People’s Front), che si poteva definire
allora come l’ala militante del CPN (Maoist), ovvero del Communist
Party of Nepal – Maoist. Questo partito, nonostante la sua etichetta, non
sembrava rivelare velleità rivoluzionarie. Gli uomini erano fuggiti per
non essere uccisi dai loro nemici locali, appoggiati da un membro del
Nepali Congress (evidentemente, un signorotto della zona) e dalle forze
di polizia distrettuali. Antiche rivalità tribali sfociarono in una serie di
arresti arbitrari e di massacri particolarmente crudeli, che – per obiettività – non possono essere ascritti alla linea del Nepali Congress in
quanto partito:11 ma alla linea di comportamento della polizia nepalese,
senz’altro sì.
Le atrocità commesse da forze che agli occhi degli abitanti del Distretto rappresentavano il potere centrale e la conservazione, spinsero
uomini e donne ad aderire al nascente movimento maoista armato. Que10
Vedi de Sales A., “The Kham Magar Country, Nepal: Between Ethnic Claims and
Maoism”, in European Bulletin of Himalayan Research, n° 19, Autumn 2000.
11
Di diverso avviso sono i commentatori e gli analisti appartenenti a gruppi e partiti a
sinistra del Partito del Congresso: vedi, in particolare, Karki A., Seddon D., “The
People’s War in Historical Context”, in Karki A. e Seddon D. (a cura di), 2003, The
People’s War in Nepal –Left Perspectives, Delhi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
39
sto, da parte sua, non ha mai esitato – eccetto forse il giorno dell’apertura delle ostilità, a commettere atti di estrema crudeltà all’interno di un
nuovo quadro ideologico, oltre che nella linea di una tradizione di ostilità castali e tribali. Da una lettura complessiva dei documenti disponibili e di testimonianze, si può affermare che la violenza della polizia era
diretta verso persone e comunità prive di potere, escluse – per definizione e non certo per scelta – dal sistema castale e sociale vigente; la
violenza dei guerriglieri era sin dall’inizio diretta contro chiunque appartenesse a quel sistema, anche ai livelli più umili o economicamente
svantaggiati. Le due forze opposte – per somma disgrazia del Paese –
avevano ed hanno tuttora in comune un comportamento, una condotta
altamente distruttiva: lo sfruttamento spietato dei civili. La sopravvivenza sia dei guerriglieri, sia delle forze anti-guerriglia, è legata al saccheggio sistematico delle derrate alimentari prodotte dagli agricoltori: il
denaro – anche se fosse disponibile – non servirebbe assolutamente a
nulla nelle aree rurali, in massima parte montagnose, del Nepal: là dove
si combatte la guerra civile, la guerra reale di ogni giorno. Da parte dei
guerriglieri, viene praticata un’altra forma di taglieggiamento, di cui ci
occuperemo specificamente più avanti: l’estorsione di denaro ai danni
di persone abbienti o considerate tali sullo sfondo dell’estrema povertà
nazionale. Questo denaro può senz’altro servire a comprare armi e forse
medicine: certo, non a comprare cibo là dove non esiste o basta appena
alle esigenze dei civili.
Precedenti dell’episodio del 13 febbraio 1996 non mancano: ma i loro èsiti furono ben diversi.
Se si risale il corso della storia del Nepal degli ultimi cinquant’anni,
si possono fissare alcune date importanti: la prima – il 1951 – segna la
fine del regime dei Rana, un clan di aristocratici che avevano di fatto
esautorato la dinastia Shah nel 1846 e che governavano il Nepal in loro
nome.12 Nel ‘51, il re Tribhuvan, rompendo la tradizione dei rois fainéants, fuggiva a Delhi e con l’aiuto del Pandit Nehru, si reimpadroniva
del suo legittimo potere, apriva le frontiere, allacciava rapporti diplomatici con Paesi stranieri e faceva del suo meglio per portare il Nepal
nel XX secolo. Nelle sue parole, “È nostro desiderio e nostra decisione
che il governo del nostro popolo sia d’ora innanzi esercitato secondo
12
Il fondatore di questa dinastia parallela fu Jung Bahadur Rana, scomparso nel 1877.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
40
una costituzione democratica, presentata da un’assemblea costituente
eletta da esso [popolo]”. Questo progetto è restato lettera morta, non
ostante che tre re siano succeduti al re Tribhuvan negli ultimi 50 anni:
una circostanza che fa riflettere, allorché si sente parlare di diritti costituzionali, di monarchia costituzionale et similia da parte di singoli politici, di partiti e dalla stessa stampa. Il re Tribhuvan, nell’aprile 1951,
promulgò una Costituzione ad interim, che sembrava garantire l’esistenza di alcuni diritti civili e creava un potere giudiziario indipendente:
il re si riservò, però, il diritto di nominare il Primo Ministro e scelse un
rappresentante del Partito del Congresso, che ormai poteva agire
ufficialmente, dopo un secolo di potere autocratico dei Rana. Il re, che
– giova ricordarlo – era profondamente amato e rispettato dal suo
popolo – scelse una figura poco significativa, Matrika Prasad Koirala,
che diede le dimissioni dopo neanche un anno. Questa fu la prima
manifestazione di una tendenza costante fra i moderni monarchi del
Nepal, i quali, pur profondamente diversi tra loro, non hanno mai
rinunciato ad esercitare il proprio potere secondo una tradizione
tipicamente asiatica. Ciò è ben comprensibile: ma si deve altresì
considerare attentamente la corrispondente tendenza dell’opposizione –
pur nella varietà di situazioni degli ultimi 50 anni – a mantenere di fatto
un canale diretto, un rapporto privilegiato con la Corte – con il Palazzo,
per usare l’espressione corrente in Nepal. Questo rapporto può essere
inconfessato o anche sconfessato: ma non per questo ci sembra meno
reale – anche nelle circostanze attuali – e meno vincolante.
Durante il breve regno di Tribhuvan, si verificò la prima rivolta armata che si possa, sia pure tentativamente, mettere in rapporto genetico
con l’attuale movimento dei Maobadi: il 20-21 gennaio 1952, un gruppo militarmente organizzato, guidato da K.I. Singh, un politico con
qualche esperienza di guerriglia, si ribellò al Governo del re e diede inizio alle ostilità. L’esercito schiacciò subito la rivolta e K.I. Singh fuggì.
Il fatto assai singolare fu che il Partito Comunista del Nepal, fondato
nel 1949, cercò di assumersi la responsabilità (ed il futuro merito) della
rivolta stessa, benché, secondo ogni evidenza, non vi fosse in alcun
modo implicato. Ad ogni buon conto, il Governo mise fuori legge il
giovane partito, che restò in clandestinità fino all’aprile 1956.
Nel marzo 1955, il re Tribhuvan morì e gli succedette il figlio Mahendra, che aveva una concezione molto più autocratica della regalità di
I quaderni del CREAM, 2004 - II
41
quanto ne avesse avuta suo padre. Il nuovo sovrano era intimamente
convinto che il sistema partitico non fosse adatto al suo Paese: dotato di
una forte personalità e di un carattere energico, cercò costantemente di
avocare a sé tutti poteri, combattendo sia la nascente democrazia di tipo
occidentale e borghese, sia il clan dei Rana, esperti di intrighi e sempre
pronti a colpi di stato. Nel 1959, il re Mahendra accettò che fossero indette le elezioni, ma non al fine di nominare un’assemblea costituente,
bensì con lo scopo di creare un parlamento, nel quadro di una costituzione che doveva essere concessa dal re, in quanto detentore della sovranità del Paese. Questa costituzione fu promulgata appena una settimana prima delle elezioni e confermava appieno il ruolo assolutamente
centrale e decisivo del monarca. Questo ruolo è ben interpretato e descritto da Anne de Sales nel suo saggio The Kham Magar Country.13
Nel quadro di una descrizione della politica interna del re Mahendra, si
legge come il re progettasse di “costruire l’unità della nazione e sviluppare il sentimento nazionale. Simultaneamente, nasceva un certo concetto di identità. In uno dei suoi discorsi, il Re Mahendra traduceva la
nozione occidentale dell’eguaglianza di tutti i cittadini in termini essenzialmente religiosi (visnuiti). In questa forma di identità, ‘tutti i devoti
di Vishnu [hanno] un’identica sostanza sottile che li unisce all’interno
del corpo sottile di Vishnu nella forma di Parbrahma’. Pertanto, tutti i
Nepalesi sono concepiti come un tutt’uno nella loro devozione verso lo
stato-nazione”.14
Il Partito Nepalese del Congresso, il Partito Comunista del Nepal
(CPN), decisero di partecipare alle elezioni. Questo atteggiamento del
CPN – a nostro giudizio – va interpretato come il primo sintomo della
vocazione non necessariamente repubblicana e tantomeno giacobina dei
vari partiti e movimenti comunisti del Nepal. Il Partito del Congresso
ottenne ben 2/3 dei seggi del neonato Parlamento (74 su 109) e cominciò a promuovere un cauto programma di riforme, relative, ad esempio,
13
In Tapa D. (a cura di), 2003, Understanding the Maoist Movement of Nepal, Chautari
Books Series, Kathmandu, 2ª edizione (1a ediz., ibid. 2003), pp. 59-88.
14
A pagina 61 del suo saggio, Anne de Sales riprende queste parole da un contributo di
Richard Burghart, “The formation of the concept of Nation-state in Nepal”, in Fuller
C.J. e Spenser J. (a cura di), 1966, The condition of listening: Essays on religion, history and politics in South Asia, Delhi: OUP, p. 257. Il re del Nepal è venerato quale incarnazione (propriamente, avatar) del dio Vishnu.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
42
all’istruzione pubblica e all’assistenza sanitaria.15 Ma il nuovo governo
– o per meglio dire, quella componente parlamentare del governo, che
doveva fare i conti col Palazzo – incontrò la tenace ostilità dei proprietari terrieri, allorché cercò di promuovere una timida riforma agraria,
che mirava a sopprimere l’esenzione dalle tasse sulla proprietà fondiaria, di cui godevano, in particolare, i grandi e i piccoli feudatari.16 Re
Mahendra, nel frattempo, continuava ad accogliere suppliche, ad amministrare giustizia e a distribuire fondi dello stato da vero autocrate, in
nessun modo soggetto alle regole di un governo di tipo parlamentare. Si
deve ricordare che aveva pieno controllo dell’esercito e di una temibile
polizia segreta, ereditata dal figlio e attiva almeno fino al 1990.17
Nel maggio 1959, fu formato il primo governo democraticamente
eletto nella storia del Nepal. Il Primo Ministro era B. P. Koirala, da non
confondersi con il più remissivo Matrika Prasad Koirala, suo fratello
maggiore. I rapporti fra il re ed il Primo Ministro furono tesi fin dall’inizio: il 15 dicembre 1960, il re sciolse il parlamento, arrestò Koirala
e alcuni membri del suo gabinetto. Questa mossa inaugurò una fase di
governo autoritario, per non dire autocratico, che durò ben trent’anni
(1960-1990). Il Partito del Congresso nepalese cercò di organizzare una
qualche resistenza armata al regime, con l’appoggio segreto del Primo
Ministro indiano Jawaharlal Nehru, ma senza successo: nell’ottobre
1962, la Cina maoista tentò di invadere il Sikkim, e il Governo indiano
– o i suoi servizi segreti – persero interesse a finanziare una rivolta all’interno di un prezioso stato-cuscinetto come il Nepal.
Nel dicembre 1962, il re Mahendra promulgò una nuova costituzione, che aveva a suo fondamento il sistema detto “Panchayat”, definito
come “una democrazia senza partiti”. Già nel nome, questo sistema ri15
Sotto il regime dei Rana, l’istruzione era riservata ai membri del clan e ai loro satelliti: ciò non impedì la costruzione di scuole monumentali nella capitale. Quanto
all’assistenza sanitaria, essa è tuttora limitata a chi può pagare cure e ricoveri in ospedale: i costi sono proibitivi per un’altissima percentuale della popolazione.
16
Questa esenzione, detta birta, si riferiva originariamente alle proprietà templari e non
a quelle private.
17
Questa polizia – ovviamente in borghese – era composta da elementi difficilmente
identificabili e da una bassa forza di tipo squadristico, riconoscibile per l’atteggiamento
aggressivo e prepotente, tutt’altro che tipico dei civili nepalesi. Parecchi di questi individui – detti “Mandalay” – furono scoperti e linciati dalla folla nell’aprile 1990.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
43
vela le sue radici castali: si tratta in origine di un comitato di cinque
membri (pancaiti) riunito allo scopo di discutere questioni relative alle
caste. Data la varietà di etnie, lingue e culture del Nepal, lo stesso concetto di casta era soggetto a variazioni interpretative locali. Nel 1854, il
Primo Ministro Jang Bahadur Rana, fondatore della potenza del suo
clan, promulgò una legge in cui i sistemi castali dei diversi territori del
regno, furono regolati e unificati, con l’esplicito intento di imporre una
concezione unitaria del Nepal: in termini occidentali, di fare del Nepal
un solo stato-nazione. Nei decenni successivi, il processo di unificazione del sistema castale procedette parallelamente – se non proprio di pari
passo – con il processo di unificazione linguistica: il nepali, lingua indoeuropea, era destinato ad imporsi come lingua nazionale sulle altre
98 lingue del Paese.18
Lo spazio e l’occasione ci impediscono di seguire validissimi studiosi nelle loro analisi dettagliate del periodo della Panchayat: proponendo una non facile sintesi, si potrebbe dire che questa forma di governo cercava di conciliare la tradizione culturale, religiosa ed amministrativa del Paese con le spinte endogene ed esogene che aprivano crepe
sempre più larghe in un’antica costruzione. Era anche evidente che il
monarca si considerava l’unico conservatore legittimo di tale edificio e
che cercava di rafforzare e consolidare con tutti i mezzi a sua disposizione la ristretta cerchia dei suoi parenti, dei suoi collaboratori più fidati e dei cortigiani che gravitavano attorno al Palazzo. Un sistema siffatto poteva avere una sua funzionalità se controllato e dominato da un
monarca energico e vigile: ma aveva in sé i germi di una corruzione
senza fine.
Un’analisi dell’esperimento Panchayat andrebbe divisa in due capitoli, corrispondenti a due fasi: durante il regno di Mahendra e dopo la
sua morte (31-1-1972). Ma poiché il tema di questo scritto riguarda
l’origine e lo sviluppo dell’attuale movimento dei Maobadi, non potremo soffermarci sulla questione dell’effettivo carattere dell’esperimento
Panchayat, che è descritto dai suoi più sagaci critici come un sistema
che di fatto – non di diritto – ammetteva l’esistenza umbratile e sotter18
I proclami e i documenti dei Maobadi contengono costantemente un riferimento negativo all’uso del nepali come unica lingua nazionale: per quanto ci risulta, tali documenti vengono diffusi esclusivamente in nepali.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
44
ranea di partiti politici che sulla carta sarebbero stati assolutamente inaccettabili per il monarca.19 Nel corso di quella che abbiamo chiamato
“prima fase” della Panchayat, si verificò un evento indiscutibilmente
connesso – sia pure assai alla lontana – con il tipo di insurrezione tuttora in corso: la sollevazione armata di Jhapa. Il distretto di Jhapa si trova
all’estremità sud-orientale del regno del Nepal ed è separato dall’India
solo dal fiume Mechi. Sollevazioni di contadini organizzate da elementi
del Partito Comunista dell’India (Marxista), cioè ispirato da Pechino, si
erano già verificate nel 1967 nell’area di Naxalbari (Bengala occidentale). Attivisti indiani filocinesi, nel maggio 1971, collaborarono con elementi nepalesi ai fini di una sollevazione armata contro il governo del
re Mahendra: riuscirono a uccidere otto “nemici di classe”, prima di essere schiacciati dalle truppe del re. Sette leader del “Comitato di Coordinamento” furono messi a morte e parecchi furono imprigionati. I dirigenti sopravvissuti fondarono, in questa occasione, quella che sarebbe
diventata la maggiore organizzazione comunista del Paese: il Partito
Comunista del Nepal (Marxista-Leninista Unificato). Nel giugno 1975,
rappresentanti del Distretto di Jhapa e di altri Distretti, formarono un
Comitato di Coordinamento Comunista pan-nepalese; nel dicembre
1978, fu ufficialmente fondato il CPN-ML. Il tutto, beninteso, in quella
elastica condizione di clandestinità che ha caratterizzato per lunghi anni
in Nepal le iniziative politiche che non ci sentiamo di definire di sinistra, di centro o di destra: forse, la definizione più realistica sarebbe:
“extra-Palazzo”. Il nuovo re Birendra, figlio di Mahendra, per giudizio
assolutamente unanime, era ben lungi dall’avere la tempra del padre: ed
è anche utile ricordare – prima di immergerci nella cronaca delle gesta
dei partiti di orientamento borghese e/o marxista, che i Rana, non più
tenuti a bada da Mahendra, avevano nuovamente gettato una solida testa di ponte a Corte, facendo sposare al giovane re e a uno dei suoi fratelli due principesse Rana, scelte con grande oculatezza. In particolare,
la giovane regina, Aiswarya Rajya Lakshmi Devi Rana, figlia di un generale, aveva preso molto sul serio il suo ruolo di sposa di un autocrate
e si identificava chiaramente col suo clan di origine, rappresentato in
19
Sul regime della Panchayat esiste un’ampia bibliografia: ci riferiamo qui soprattutto
all’acuta analisi di Burghart R., “The Political Culture of Panchayat Democracy”, in
Hutt M. (a cura di), 1994, Nepal in the Nineties, , SOAS Studies on SouthAsia, Delhi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
45
special modo nell’Esercito e nell’alta finanza. Sotto il debole scettro di
re Birendra, il sistema della Panchayat era più che mai messo a repentaglio dalle rivalità fra gruppi di potere, con interessi diversi e concorrenti. La situazione spinse – o costrinse, è difficile dirlo – il re a indire
un referendum nazionale, che permettesse ai votanti di scegliere tra una
Panchayat “riformata” e un sistema multipartitico, che avrebbe inevitabilmente portato all’elezione di un parlamento di tipo occidentale. Com’era da aspettarsi, i partiti, formalmente banditi, vennero allo scoperto
e fecero una loro campagna elettorale; ma persero il referendum e la
Panchayat fu mantenuta. Si parlò di massicci brogli: certo, l’isolamento
e l’inaccessibilità della maggior parte dei piccoli centri abitati del Paese
si prestavano all’uso di violenze, soprusi e raggiri ai danni di una popolazione in gran parte analfabeta e direttamente soggetta ai grandi e piccoli signori feudali. Ciò premesso, ci sentiamo di affermare che il sincero attaccamento al sistema della Panchayat era molto diffuso, nei villaggi e nelle città, allora e in epoca assai più recente. Nel 1985, il Partito del Congresso e alcuni gruppi difficilmente identificabili di orientamento comunista, cominciarono a collaborare ai danni della Panchayat:
fu un periodo oscuro, punteggiato da una serie di attentati, messi in atto
con bombe a tempo, disposte nella capitale: attentati che è ragionevole
far risalire ai servizi segreti del Palazzo, piuttosto che ai movimenti partitici. Nonostante che il rapporto tra causa ed effetto sia tutt’altro che
chiaro, questo stratagemma terroristico funzionò – come, a suo tempo,
in altri Paesi, lontani dal Nepal – e la collaborazione fra un partito di
tipo borghese e gruppi di aspiranti rivoluzionari, cessò.
La Panchayat potrebbe essere definita come un partito – o almeno
un fronte di tipo feudale – anche se questo anacronismo formale può
lasciare interdetto uno storico o un politologo occidentali: in ogni caso,
all’interno della Panchayat, come suoi qualificati rappresentanti, figuravano uomini politici notoriamente legati ai partiti, messi fuori legge o
privi di un vero status legale.
Poiché le radici, sia pure lontane, dell’attuale movimento dei Maobadi affondano nell’humus del Partito Comunista del Nepal, è necessario ricordare che questo partito fu fondato ufficialmente il 15 settembre
1949 da Pushpa Lal Shrestha, che tradusse e pubblicò il “Manifesto” di
Marx & Engels in lingua nepali, gettando il seme di un messianismo,
che produrrà frutti alquanto sorprendenti su una terra induista. Esisteva,
I quaderni del CREAM, 2004 - II
46
tuttavia, un importante precedente: nel 1947, Man Mohan Adhikari,
membro del Partito Comunista dell’India, aveva capeggiato uno sciopero di lavoratori del settore tessile nel Nepal sud orientale. A M. M. Adhikari toccò, molti anni più tardi, il singolare destino di diventare il
primo e sinora unico Primo Ministro comunista del Regno del Nepal,
nel 1994-95, sotto lo scettro di re Birendra. Molti osservatori occidentali (tra i quali, sia detto per incidens, anche chi scrive questa nota) credettero che la nomina a premier di un vecchio dirigente comunista avrebbe provocato un colpo di stato, magari guidato da alti ufficiali
dell’esercito: ma non fu così e in capo a un anno, il governo di M.M.
Adhikari cadde per debolezza intrinseca, fra i compiaciuti lazzi della
stampa indiana.
Se – come abbiamo visto – il ceppo originario da cui derivano i numerosi partiti nepalesi che si definiscono comunisti è costituito dal vecchio Partito Comunista del Nepal del 1949, si deve considerare che di lì
a non molti anni sarebbe esplosa la latente rivalità fra l’URSS – sempre
vicina all’India per ragioni geopolitiche – e la Cina Popolare: una
rivalità che non poteva non riflettersi sulla politica interna del Nepal. Si
può affermare che la politica estera della RPC sia sempre stata
favorevole alla casa regnante del Nepal, prima e dopo la morte di Mao:
non soltanto perché la monarchia rappresenta un sia pur debole baluardo contro l’espansionismo indiano, ma anche perché negli ultimi 50
anni è nato il problema della resistenza tibetana all’occupazione cinese:
qualunque eventuale cambiamento della situazione nepalese, non può
non preoccupare gli strateghi di Pechino, che non hanno mai dimostrato
alcuna simpatia per i seguaci nepalesi del Mao-tzetung-pensiero.
Sempre seguendo il filo rosso – o nero? – delle origini dell’attuale
insurrezione armata, possiamo brevemente enumerare le scissioni che
hanno portato alla formazione di due schieramenti o almeno di due tendenze principali: una di tipo parlamentare, l’altra, antiparlamentare. Se
abbiamo ben compreso lo spirito dei documenti prodotti, entrambe le
tendenze non rifiutavano la possibilità di una insurrezione armata – che
è ben altra cosa rispetto ad una lunga lotta armata: la discriminante,
dunque, non è l’uso delle armi, bensì la sua qualità, la sua durata e l’eventuale coinvolgimento di gruppi numerosi e militarmente organizzati.
Ben più difficile è distinguere obiettivi propriamente politici: persino
l’opposizione monarchia-repubblica è alquanto sfumata e rivela ciò che
I quaderni del CREAM, 2004 - II
47
anche in altri climi e altre latitudini, non può definirsi se non come
bronzeo opportunismo. Allorché, nel 1960, il re Mahendra soppresse i
partiti, la fazione filomoscovita del CPN, col suo segretario K.J. Rayamajhi, decise di accettare le decisioni del Palazzo; la fazione filocinese
si divise in piccoli gruppi e passò alla clandestinità – almeno, in certa
misura, “alla nepalese” – e cominciò a operare per proprio conto. A
questi gruppi possono essere fatti risalire gli attuali Maobadi, emersi
dopo ben 36 anni. Due dirigenti particolarmente radicali, Mohan Bikram Singh – vivente e durissimo critico dei Maobadi – e Nirmal Lama
(scomparso nel 2000) indissero un congresso, detto dai partecipanti “IV
Congresso” (donde, il nome “Partito Comunista del Nepal-IV Congresso”). Questo nuovo partito esigeva l’elezione diretta di un’assemblea
costituente e al tempo stesso auspicava una “lotta di popolo armata”,
seppure non con questa precisa etichetta. Non sappiamo come pensassero i militanti di conciliare le operazioni di voto e le operazioni di
guerra: resta un problema delicato e tuttora insoluto. Quale che fosse la
sua strategia, la dirigenza del IV congresso non si commosse affatto per
la sorte dei ribelli di Jhapa, che giudicò: “terroristi semi-anarchici”. Nel
1983, Mohan Bikran Singh formò un nuovo Partito Comunista del Nepal (Masal), che in capo a due anni si scisse in CPN Masal e CPN Mashal. L’attuale “Supremo” dei Maobadi, Pushpa Kamal Dahal, noto anche sotto l’appellativo di Prachanda, ovvero “Il Terribile”, proviene dal
Mashal; l’altro dirigente dei Maobadi, il Dr. Baburam Bhattarai, estensore della lettera-documento già citata, restò nel Masal.20
Si deve realisticamente ammettere che nel vuoto e nell’impotenza
spesso tipici della clandestinità, le scissioni sono facili e che non disponiamo di documenti attendibili sulla consistenza numerica delle varie
formazioni: nessuno poteva impedire a due o tre individui di considerarsi un partito.
Nel corso dell’inverno e della primavera 1990, si formò una coalizione segreta fra il Partito del Congresso e sette altri partiti, incluso il
c.d. “IV Congresso”, per rovesciare il regime della Panchayat: il Palazzo, tramite la sua polizia segreta e i suoi squadristi, fece assassinare un
gran numero di oppositori, reali o presunti, scegliendoli fra le classi più
20
Sia Masal che Mashal significano: torcia. Tra l’altro, la grande maggioranza dei Nepalesi ha difficoltà a distinguere tra il suono s e il suono sh.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
48
povere e indifese; e arrestò e vessò in ogni modo professionisti, quali
avvocati, giornalisti e sopra tutto medici, che raccoglievano un’ampia
documentazione, anche fotografica, sui corpi delle vittime.21 A quanto
riferisce la nostra fonte preferita – Deepak Thapa22 – il Masal e il Mashal si unirono a quella che abbiamo chiamato “coalizione segreta”, soltanto quando le manifestazioni di massa, organizzate da quest’ultima,
divennero incontrollabili e incontenibili da parte della polizia. La causa
scatenante della sollevazione fu la chiusura – quanto mai tempestiva –
della frontiera da parte dell’India, con conseguente scomparsa di ogni
combustibile: le donne nepalesi, impossibilitate a cucinare anche un
pugno di riso, costituivano una buona metà dei manifestanti. Il 6 aprile
1990, le truppe, in assetto di combattimento, aprirono il fuoco contro la
folla che si dirigeva verso il Palazzo e in pochi minuti uccisero dozzine
di persone, i cui corpi furono in massima parte raccolti e frettolosamente bruciati nel crematorio comunale, senza nessuna di quelle cerimonie
e di quei riti che tanta parte hanno nella vita degli Indù. Il 9 aprile – dopo tre giorni di coprifuoco, che causò altre vittime – il re Birendra annunciò per radio la legalizzazione dei partiti, che avevano pronti numerosi camion, insegne e bandiere: la presenza di gran lunga più forte era
costituita dal Partito del Congresso e dallo United Left Front.23
A nostro giudizio, questa rivoluzione – pur incompiuta e imperfetta
– aprì le porte a forze nuove e innovatrici, con dei programmi realistici,
anche se ben presto snaturati da un’ineradicabile corruzione: il tipo di
governo che s’impose allora, dura formalmente da quattordici anni e la
rivolta maoista scoppiò nel suo sesto anno di vita, sotto il regno di Birendra.
Nel novembre 1990, fu promulgata una nuova Costituzione, risultato
della convergenza programmatica di rappresentanti del Partito del Congresso, della sinistra, della Panchayat, più alcuni indipendenti. Nessuna
convocazione di un’assemblea costituente. Quattro partiti, contrapponendosi di fatto a questo raggruppamento – e precisamente il c.d. IV
21
Parte della documentazione è disponibile in un volume pubblicato a Kathmandu dal
Forum for Protection of Human Rights nel giugno 1990: Dawn of Democracy –
People’s Power in Nepal.
22
Tapa D., “The Maobadi of Nepal”, in Dixit K.M., Ramachandaran S. (a cura di),
2000, State of Nepal, Himal Books, Kathmandu.
23
Osservazione personale dello scrivente.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
49
Congresso, il Masal ed un gruppo scissionista del Mashal, capeggiato
dal Dr. Baburam Bhattarai, si fusero in un Partito Comunista del Nepal,
detto anche “Unity Centre”, con Prachanda come Segretario Generale.
Bhattarai e il Terribile formano attualmente il duumvirato che è alla testa dei Maobadi. I fatti che sono seguiti dimostrano che questo raggruppamento può operare ora all’interno, ora all’esterno del sistema politico-parlamentare del Nepal.
Indette le elezioni generali, uno United People’s Front (UPF) fu
presentato come il braccio politico dello Unity Centre, con il Dr. Bhattarai come segretario. Nel primo Parlamento eletto sotto il nuovo regime, l’UPF ottenne 9 seggi, il Partito del Congresso 110 e il Partito Comunista Unificato del Nepal Marxista-Leninista (CPN-UML) ben 69.
Nonostante la sua etichetta scarlatta, questo partito è tutt’altro che rivoluzionario: ci sembra che attualmente rappresenti piuttosto gli interessi
della prospera e attiva borghesia della capitale, un agglomerato sociale
e castale che riesce ancora a galleggiare, pur nella drammatica situazione economica del Paese.
Un anno dopo, nel dicembre 1991, lo Unity Centre tenne il suo primo congresso, dichiarando di “voler adottare il Marxismo-LeninismoMaoismo come guida ideologica del Partito e il sentiero della guerra di
popolo di lunga durata, implicante la strategia dell’accerchiamento della città da parte delle campagne”.24 Con ciò, il sentiero esplicitamente
maoista e potenzialmente guerrigliero cominciò a seguire un tracciato
diverso da quello parlamentare del CPN-UML.
Cinque anni dopo questa risoluzione, ebbe inizio l’attuale guerra civile: dapprima, definita dalla stampa ufficiale come un fenomeno di
banditismo, poi di terrorismo, poi come un’insurrezione via via più estesa. Attualmente, si parla di un conflitto fra l’esercito e la polizia da
una parte e i Maobadi dall’altra: il termine è accettato dagli insorti e i
giornalisti che lo usano non sono esposti a rappresaglie.
La lettura di saggi storici, politici ed economici scritti sopra tutto da
autori nepalesi e i contatti con gente di ogni condizione, che non scrive
24
La citazione, arricchita da un notevole commento, si trova alla p. 16 del contributo di
Karki A. e Seddon D., “The People’s War in Historical Context”, in Karki A. e Seddon
D. (a cura di), 2003, The People’s War in Nepal – Left Perspectives, Adroit Publishers,
Delhi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
50
affatto, ma che è abbastanza incline a parlare liberamente con gli stranieri, ci permette di ricostruire la genesi di questa guerra: guerra civile
o “guerra di popolo”, come la si voglia definire a seconda del proprio
orientamento: va da sé che nessun interlocutore, nella zona controllata
dal governo, userebbe la seconda definizione.
La guerra sembra avere una triplice origine: l’estremo malcontento,
antico ed endemico, dei Distretti poveri e montagnosi di Rolpa e di Rukum, abitati da gruppi etnici fortemente discriminati e sfruttati;25 la dinamica azione politica e la formazione di nuovi quadri da parte dei dirigenti e dei militanti dello Unity Centre, collegati – almeno come ispirazione teorica – al Movimento Internazionale Rivoluzionario (RIM),
con diramazioni in America Latina e in Europa;26 il malcontento e la
frustrazione di strati castali e sociali urbani, delusi dagli èsiti della rivoluzione dell’aprile 1990. Per quanto se ne può sapere, da un punto di
vista sociale – non però ideologico – i dirigenti dei Maobadi provengono proprio da quella matrice.
Si può aggiungere – con tutta obiettività – che è impossibile non
pensare ad un coinvolgimento dei servizi segreti indiani, almeno nella
prima fase della guerriglia: con altrettanta obiettività, è difficile pensare
che detti servizi si possano unanimemente compiacere degli attuali, macroscopici sviluppi della guerriglia stessa, che rischia di diventare il
modello vincente dei forti movimenti maoisti dell’India. I Maobadi,
ormai militarmente organizzati e strutturati, hanno bisogno sopra tutto
di un regolare afflusso di munizioni, dello stesso tipo e dello stesso calibro: càpita di leggere, nella stampa locale – e non solo in quella – del
grande “bazar di armi indiano”, appena al di là del porosissimo confine
indo-nepalese; ma chiunque abbia una pur vaga idea della guerra, sa
25
Il malcontento non era certo minore nelle zone pianeggianti del Terai sud-orientale:
ma questa è un’area, dove – grazie ad una delle poche strade rotabili del Nepal – è possibile inviare truppe entro ventiquattr’ore. Di grande utilità, per chi voglia approfondire
la questione delle radici locali della guerra civile, è l’indagine, disponibile in internet, di
Gersony R. Western Nepal Conflict Assessment, pp. 1-101. Questo studio è stato commissionato dall’Autore dal Mercy Corps di Portland, Oregon e rappresenta un vero modello di ricerca applicata.
26
La disamina più completa a noi nota delle reali o presunte radici internazionali del
movimento dei Maobadi si trova nell’opera dello studioso e diplomatico indiano Muni
S.D., 2003, Maoist Insurgency in Nepal – The Challenge and the Response, Rupa &
Co., Delhi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
51
che armi disparate, comeprate al bazar, vanno bene per svaligiare una
banca o per un colpo di mano, ma non certo per alimentare un annoso
conflitto con un esercito regolare.
Dopo la dichiarazione delle ostilità, la guerra – agli occhi degli abitanti della capitale – fu per lungo tempo una realtà lontana: i Maobadi
controllavano dei Distretti di scarsa importanza economica e politica e
si scontravano con poliziotti mal pagati e male armati, condizionando in
misura apparentemente accettabile la vita di ogni giorno di Kathmandu.
Per la verità, i visitatori stranieri meno distratti si rendevano conto, sin
dai primi anni della guerriglia, che i proprietari dei grandi alberghi erano molto tesi e che troppe imprese cambiavano improvvisamente padrone: ma nessuno, ai livelli superiori della società, ammetteva di ricever pressioni da parte dei Maobadi. I piccoli proprietari e i commercianti con un modesto volume d’affari, invece, erano abbastanza inclini
a sfogarsi con gli stranieri: non avevano un’immagine sociale da proteggere e spesso erano semplicemente terrorizzati. Nessuno – a nostra
conoscenza – pensava di rivolgersi alla polizia, per tema di ritorsioni e
per evitare ulteriori richieste di denaro. È difficile dire in quale misura
queste richieste provenissero dai Maobadi, ovvero dalla malavita locale, sempre pronta a stampare una falce e martello sulle proprie missive.
In ogni caso, come vedremo meglio in séguito, è dubbio che i Maobadi
in massa siano degli idealisti che usano il denaro estorto soltanto per la
causa.
Un buon barometro della situazione politica ed economica, nonché
della importantissima vita di tutti i giorni in Nepal, è sempre stato costituito dalla stampa quotidiana e periodica in lingua inglese, destinata agli stranieri – in gran parte asiatici – ed alle élites sociali della capitale:
ma, come ricordano i politologi e gli storici da noi citati, la lingua utilizzata dai politici nepalesi è il nepali e tutti i documenti e le dichiarazioni di principio di cui disponiamo sono passati attraverso il filtro della
traduzione. Tutti i quotidiani, i settimanali e i periodici in lingua inglese
stampati nella capitale – con l’eccezione del Rising Nepal, da sempre
emanazione diretta del Palazzo – forniscono notizie precise e fattuali,
come può costatare chiunque viva abbastanza a lungo in quel Paese; il
riferimento a queste fonti è d’obbligo per chi voglia documentarsi sulla
situazione di sempre più grave emergenza che si è verificata negli ultimi otto anni.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
52
Altra fonte di informazione sul reale svolgimento della guerra, è
rappresentata da tempo dalle agenzie di viaggio e di trekking, che sopprimendo o modificando i percorsi turistici, hanno costantemente offerto un quadro attendibile, nelle sue linee generali, dello sviluppo e dell’estensione della guerriglia: con qualche spiacevole sorpresa, però,
poiché la tattica dei guerriglieri funziona grazie alla sua imprevedibilità. Le grandi agenzie, collegate alle catene dei grandi alberghi, possono
garantire percorsi relativamente sicuri soltanto pagando i dirigenti dei
Maobadi, ciò che le piccole agenzie non sono in condizione di fare. Inoltre, nei primi anni della guerra, i Maobadi si muovevano dalle loro
basi nel Nepal centro-occidentale – zona tutt’altro che turistica – e non
interferivano necessariamente col movimento turistico-alpinistico, che
parte dalla capitale e si dirige verso nord. Con l’estendersi della sfera
d’azione della guerriglia, la situazione si è modificata: non solo le poche strade rotabili possono essere bloccate, ma anche le comunicazioni
per via aerea – il Nepal è pieno di piccoli aeroporti – sono state messe
in crisi dagli attacchi dei Maobadi alle sedi locali delle compagnie, dove esiste la certezza di trovare denaro liquido. Per un Paese che – come
si dice correntemente – vive in gran parte di aiuti internazionali e di turismo, la guerra causa un danno finanziario difficilmente calcolabile.
Tracciare una cronistoria del conflitto, dalla guerriglia a una drôle
de guerre, può essere lungo e tedioso: nella linea dell’esposizione sinora seguita, cercheremo di proporre al lettore un taglio tendenzialmente
politico. Il fatto che più colpisce l’osservatore, sia straniero, sia nepalese, è il rifiuto da parte del Governo di S.M. di usare l’esercito per combattere i Maobadi: questi per ben cinque anni (1996-2001) si trovarono
di fronte soltanto forze di polizia male armate e male equipaggiate, cui
inflissero a più riprese gravi e umilianti sconfitte. Nel 2001, le forze di
polizia minacciarono di ammutinarsi, perché chiamate a combattere con
dei vecchi fucili Enfield le truppe maoiste dotate di un buon numero di
armi automatiche.27 Ufficialmente, la riluttanza di re Birendra ad impiegare l’esercito era motivata dalla volontà di non dichiarare la guerra
civile; come compromesso esisteva il progetto di militarizzare, specie
dal punto di vista dell’armamento, le esistenti forze di polizia. In realtà,
la politica dei vari governi succedutisi fra il 1996 e il 2001 oscillò co27
Da interviste personali dello scrivente.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
53
stantemente fra la ricerca di una soluzione radicale del “problema Maobadi” – cioè lo sterminio dei guerriglieri, etichettati come “terroristi”
anche a livello internazionale – e un progetto di addomesticamento dei
medesimi, ovvero la loro riconversione in un piccolo partito, con almeno un piede nel Parlamento. Diversa – e non soltanto secondo noi28 – la
politica del Palazzo. Il re Birendra e la sua cerchia, secondo ogni ragionevole evidenza, miravano a strumentalizzare indefinitamente il movimento maoista contro il sistema partitico e parlamentare: la democrazia
di tipo borghese è fragile nelle situazioni di estrema emergenza e restava in ogni caso da giocare la carta dell’esercito. Quest’ultimo, si sarebbe dimostrato un calcolo tragicamente sbagliato. Il Palazzo appariva del
tutto indifferente al destino della popolazione rurale, dissanguata dalla
guerra civile.
I Maobadi inflissero, tra il ‘96 e il ‘98, una lunga serie di sconfitte
alle forze di polizia e cercarono al contempo di istituzionalizzare il proprio potere nei Distretti-base di Rolpa e di Rukum. Riferendosi al recente passato, Prachanda, nel 1999 scrisse quanto segue nel suo saggio
“Il terzo turbolento anno della Guerra di Popolo: una valutazione generale”:
“…Cooperative popolari, prestazioni di manodopera e attività agricole collettive, costruzione di vie d’accesso rurali, ponti, monumenti ai martiri, registrazione, acquisto e vendita di terre, protezione del popolo, cultura popolare,
tribunali del popolo, amministrazione di scuole e altro, divennero l’esercizio
preliminare quotidiano del nuovo potere del popolo. La gente di quelle aree
[occidentali] si sentì per la prima volta padrona del proprio destino (…) Con
qualche differenza quantitativa, anche molte aree nelle zone collinari (del Nepal) centrale e orientale misero in atto le prime forme di autogoverno”.29
L’espansione della guerriglia e la conseguente repressione generarono una pratica tanto diffusa, quanto insensata e crudele: poliziotti travestiti da Maobadi si presentavano nei villaggi e reclutavano a forza gli
uomini, quindi li liquidavano come ribelli, facendoli figurare come ne28
La denuncia più energica e documentata degli intrighi fra il Palazzo e i Maobadi proviene dal comunista della prima ora Mohan Bikram Singh: “The Royal Palace Massacre
and the Maoist’Pro-King Political Line”, in The People’s War in Nepal – Left Perspectives, cit., pp. 315-374.
29
The Worker, n° 5, 1999.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
54
mici uccisi; i Maobadi, dal canto loro, facevano morire fra le torture più
atroci quei “possidenti” – spesso padroni di pochi acri di terra – che non
pagavano prontamente le cifre richieste. Fra le categorie più perseguitate dai Maobadi figuravano e tuttora figurano i maestri di scuola, colpevoli di trasmettere la cultura tradizionale (e quale altra cultura, nel Regno del Nepal?) e in particolare, nozioni di sanscrito.30
Imbaldanziti dai loro successi militari, i Maobadi pensarono di scatenare un attacco generale in occasione del secondo anniversario della
“guerra di popolo” (13 febbraio 1998), ma il Primo Ministro Girija Prasad Koirala, dirigente del Partito del Congresso, decise di mettere in atto un vasto e feroce piano repressivo, detto “Operation ‘Kilo Sierra’
Two”. La polizia nepalese ha a lungo negato che tale piano fosse mai
esistito, con quella o con altra etichetta, ma lo stesso capo della polizia
dei territori occidentali, dichiarò: “Se i Maoisti non rispettano la Costituzione, neanche noi dobbiamo rispettarla, conducendoli dinanzi ad un
tribunale”, dando così il suo placet alle esecuzioni sommarie.31 L’operazione “Kilo Sierra Two” fu estesa a tutte le zone rurali del Nepal dove
la guerriglia fosse presente e provocò circa 500 vittime, in gran parte
civili accusati di aiutare i Maobadi, quasi che fosse possibile rifiutare
cibo e occasionale alloggio ai guerriglieri. Impossibile calcolare il numero di stupri di cui furono vittime le donne nei villaggi coinvolti; persino un Ispettore Generale di Polizia, Pradap SJB Rana, dichiarò che il
progetto “Kilo Sierra Two” – chiamato questa volta con il suo nome –
“aveva iniettato nuove energie nel movimento maoista”.32
La consistenza numerica dei Maobadi e dei loro collaboratori – volontari e non – non può essere facilmente calcolata. Secondo quanto affermato dallo stesso Prachanda, le forze complessive dei Maobadi sono
divise in tre formazioni: 1) le forze armate pienamente equipaggiate e
addestrate, impiegate nell’attacco; 2) la riserva, per l’appoggio e la di30
La descrizione più esauriente e precisa delle tecniche di tortura usate dai Maobadi si
trova a pp. 71 sgg. del saggio di Robert Gersony, cit. a pag. 25. L’Autore pone in relazione storica e critica queste tecniche con quelle impiegate dai Khmer Rossi. Le torture
– di norma inflitte in pubblico – servono non solo un fine terroristico, ma altresì politico
e pedagogico. Notizia di queste atrocità viene data correntemente dalla stampa quotidiana della capitale.
31
Intervista al Kathmandu Post, 8 luglio 1998.
32
Intervista al Kathmandu Post, 20 maggio 2001.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
55
fesa; 3) i volontari, ovvero la “milizia del popolo”, reclutata fra gli abitanti dei villaggi disposti a collaborare coi Maobadi. Le unità combattenti, secondo calcoli piuttosto congetturali, sarebbero composte dai
cinque agli ottomila fra uomini e donne. I dirigenti maoisti insistono
sull’armonia che regna e deve regnare tra quadri politici e quadri militari. Secondo noi, traspare invece dalle loro parole la preoccupazione circa il futuro, nel caso che i politici accettassero delle situazioni di compromesso con il Governo e i Maobadi inquadrati nella formazione militare si rifiutassero di deporre le armi.
Nelle parole di Prachanda, “non è un segreto che – per quanto riguarda le armi – il maggior rifornimento proviene dal nemico. Come
disse Mao, anche le potenze straniere possono rifornirci attraverso il
nostro stesso nemico”.33 Ciò che Mao non ci ha detto, è come i suoi nipoti più o meno legittimi si procurassero armi moderne strappandole
alla polizia nepalese, che si lamentava di esserne sprovvista.
Il corso politico della guerra ebbe una brusca svolta il 1 giugno del
2001, quando il re Birendra, la regina, il principe ereditario Dipendra e
tutti i consanguinei legati alla linea diretta di successione al trono –
quindici persone – furono massacrati nel corso di una sparatoria notturna a Palazzo. Ufficialmente, l’unico responsabile della strage, eseguita
con diverse armi automatiche, sarebbe stato Dipendra, perché ostacolato da sua madre nel suo sogno di convolare a nozze, giudicate morganatiche, con Devyani Rana – una ragazza di tutt’altro che umili natali. Un
solo fatto è assolutamente certo: le numerose guardie del corpo, appartenenti all’esercito, non intervennero in alcun modo per difendere la sacra persona del monarca e i suoi: i corpi furono immediatamente cremati e i militari di ogni ordine e grado, senza batter ciglio, passarono al
servizio del fratello del re, Gyanendra. Questa è la circostanza politica
di cui si deve tener conto, al di là di ogni congettura criminologica.34
33
Intervista al Washington Times, 14 dicembre 2002.
Vedi Misra N., 2001, End of the Line – The Story of the Killing of the Royals in Nepal, Penguin Books, New Delhi. Questo libro, sotto le ingannevoli apparenze di un pessimo romanzetto giallo-rosa, mette in luce le contraddizioni, le incoerenze e le menzogne della versione ufficiale del massacro. Ai fini di una cronaca e di un’analisi obiettive
della situazione, si deve aggiungere che Nepalesi colti e tutt’altro che ingenui, credono
nella versione dell’improvvisa follia, scatenata anche dall’abuso di alcol e di droghe,
manifestatasi in Dipendra; e credono altresì in una sorta di stupor delle guardie del cor34
I quaderni del CREAM, 2004 - II
56
Non mancarono manifestazioni di piazza, che esprimevano rimpianto
per il re assassinato: ma furono represse con la consueta brutalità. Birendra era stato – non ostante tutto – un re molto popolare: la responsabilità delle stragi dell’inverno-primavera 1990 erano state addossate alla regina di stirpe Rana; della condotta, tutt’altro che lineare e brillante,
della guerra contro i Maobadi, si faceva colpa ai Primi Ministri e ai vari
partiti. Tutto ciò, nella coscienza del popolo, fortemente condizionata –
con buona pace dei politologi che pubblicano in lingua inglese – dalla
valenza sacrale del monarca. Sorprendente, ma non troppo, la posizione
ufficiale delle alte gerarchie dei Maobadi.
Il Dr. Baburam Bhattarai rilasciò un’intervista al quotidiano in lingua nepali “Kantipur”, che fu pubblicata il 6 giugno 2001, appena cinque giorni dopo la strage:
“Perché (…) il Re Birendra e la sua intera famiglia sono stati assassinati
proprio adesso? Qual’era il suo principale ‘crimine’ agli occhi degli imperialisti e degli espansionisti? Qualsiasi ideologia abbraccino, tutti i Nepalesi onesti
e [di sentimenti] patriottici debbono certamente ammettere che la maggior ‘debolezza’, o il maggior ‘crimine’ di Re Birendra fosse che egli, benché prodotto
dalla classe feudale, aveva uno spirito relativamente patriottico e un carattere
politicamente aperto. Benché perfino alcuni ‘sacerdoti’ del marxismo ci abbiano chiamati ‘realisti’ (royalists), noi possiamo dire adesso senza esitare che su
certe questioni nazionali noi e Re Birendra avevamo vedute simili e che esisteva una non dichiarata unità pragmatica tra Re Birendra e noi su alcuni punti”
(corsivo nostro).35
Prachanda, intervistato dal giornalista indiano Neelesh Misra, rivelò
che re Birendra aveva inviato un segnale preciso ai Maobadi, un mese
prima di essere assassinato. Un fratello minore del re, il principe Dhirendra, aveva incontrato la dirigenza dei Maobadi, in previsione di un
futuro contatto diretto con il monarca.
“Qualche volta, abbiamo pensato che con lo sviluppo progressivo del movimento maoista, gli si sarebbe potuto chiedere di giocare in Nepal un ruolo
po, che ritenevano inconcepibile entrare in un’area del Palazzo, aperta solo ai parenti
stretti del re e ai più alti dignitari.
35
L’intervista è ripresa e polemicamente commentata da Mohan Bikran Sing nel suo
contributo al volume The People’s War in Nepal, cit. alla n. 28.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
57
simile a quello del Principe cambogiano (Norodom) Sihanouk. Noi crediamo
fermamente che questo atteggiamento morbido e aperto verso di noi e la sua
inclinazione per la Cina, piuttosto che per l’India, abbia portato al massacro
della sua intera famiglia”.36
Per qualche tempo, i dirigenti dei Maobadi professarono affettuoso
rispetto verso il re ucciso e assoluta esecrazione per il nuovo re Gyanendra e per il suo Primo Ministro Girija Prasad Koirala. Come regalo
per l’augusto compleanno (7 luglio 2001), non mancarono di ammazzare quarantun poliziotti. Nello stesso mese, nel Distretto di Rolpa, presero altri 69 poliziotti in ostaggio. A questo punto, Koirala mobilitò finalmente l’esercito, ma senza successo. Il fallimento della campagna
indusse Koirala a dare le dimissioni. Fu prontamente sostituito da Sher
Bahadur Deuba, che dichiarò che il primo problema da risolvere era
quello dei Maobadi e come prova di buona volontà, il 22 luglio 2001,
ordinò un ‘cessate il fuoco’.
Il gesto fu ricambiato dai Maobadi ed ebbe inizio un periodo, in cui
sembrò che si potesse passare dalla clandestinità, la guerriglia e le sanguinose imboscate ad una fase di trattative, tavole rotonde e persino di
manifestazioni di piazza maoiste autorizzate.
Ma una forte tensione soggiaceva a questo strano e inaspettato accordo: i Maobadi, messo un piede nella capitale, avevano cominciato ad
estorcere apertamente beni e denaro agli abitanti, che prima avevano
conosciuto soltanto le lettere minatorie. Si era passati, insomma, dall’estorsione selettiva all’estorsione di massa. Una politica miope, questa, perché un intero movimento parassitario avrebbe avuto interesse a
mantenere in discrete condizioni di salute il suo ospite. Inoltre i Maobadi si erano scoperti una tardiva vocazione repubblicana, ciò che avrebbe escluso dalle trattative il Palazzo stesso. Corse anche voce che il
capo dell’ala militare, il “compagno Badal” (al secolo: Ram Bahadur
Thapa)37 premesse per la rottura delle trattative in corso. Gli avvenimenti che seguirono sembrerebbero confermare la fondatezza di questa
voce.
36
L’intervista, concessa a Neelesh Misra, è riportata alle pp. 191-195 del volume End
of the Line, cit. alla n. 34.
37
La fonte è Muni S. D., Maoist Insurgency in Nepal, cit. alla n. 28. Muni si riferisce
all’Indian Express del 2 dicembre 2002.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
58
Le trattative furono rotte il 21 novembre 2001 e immediatamente iniziò una nuova fase particolarmente acuta e sanguinosa della guerra,
che durò per ben quattordici mesi, con vere e proprie battaglie e ingenti
distruzioni di beni, attrezzature, installazioni e linee di comunicazione.
Prima di presentare la cronaca delle operazioni di guerra, è opportuno riflettere sul senso di una campagna così distruttiva ed esiziale per il
Paese. Come la storia ci insegna, le guerre si fanno o per vincerle o per
perderle – in questo caso, se possibile, salvando l’onore e sperando di
trarsi d’impaccio da situazioni politiche ed economiche insostenibili.
Nel caso della guerra in Nepal, è comprensibile che il Governo di S.M.
volesse sterminare i Maobadi oppure mantenerne in vita una parte per
strumentalizzarli a fini di politica interna. Ciò che non si può ragionevolmente credere è che i Maobadi intendessero impadronirsi del potere:
per quanto saturi della lettura di testi inneggianti ai trionfi della ‘guerra
di popolo’, debbono esser sempre stati coscienti del fatto che una repubblichetta neo-maoista non sarebbe mai stata riconosciuta da nessuno
e che – sopra tutto – sarebbe stata strangolata in pochi giorni dalla chiusura della frontiera da parte dell’India.
Ciò non ostante, la dirigenza dei Maobadi, o per disegno parapolitico o per forti pressioni interne, decise di attaccare su tutti i fronti,
infliggendo gravi perdite alle truppe del re ed enormi danni e sofferenze
alla popolazione.
L’offensiva dei Maobadi iniziò il 23 novembre 2001 nel Distretto di
Dangdeukhuri, nella zona sud-occidentale del Nepal e precisamente
nella città di Ghorahi: due dozzine fra soldati e poliziotti furono uccisi e
i Maobadi saccheggiarono banche e arsenali, procurandosi, questa volta
senz’alcun dubbio, armi e munizioni moderne di chiara origine governativa. Dopo due giorni attaccarono Salleri, capoluogo distrettuale del
Solukhmbu, nel Nepal centro-orientale, dimostrando di avere un forte
contingente di truppe in una zona ben lontana dalle loro basi principali.
Altro eccidio, altro saccheggio e distruzione del locale aeroporto. In
questo frangente, le truppe del re combatterono con coraggio e decisione ed evitarono il disastro totale.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
59
Il 26 novembre 2001, il Primo Ministro Sher Bahadur Deuba, dichiarò lo stato di emergenza – il primo del sec. XXI 38 – sospendendo
tutti i diritti civili. Il CPN (Maoist) fu etichettato come “organizzazione
terrorista”, nella linea suggerita dal governo di George Bush junior. Dure pene erano previste per chiunque, in qualsiasi modo, assistesse i terroristi nelle loro attività: una forma di ingiusta e feroce persecuzione
verso tutti coloro che – specie nei villaggi – erano prima o poi visitati
dai Maobadi.
Il 3 dicembre 2001, i duumviri Prachanda e Bhattarai rilasciavano
una dichiarazione, in cui indicavano nel rifiuto da parte del governo di
indire l’eternamente auspicata assemblea costituente, il motivo della
rottura delle trattative:
“La gente avrebbe potuto scegliere tra monarchia e repubblica (…) Questa
proposta è stata rifiutata e la banda fascista al potere ha mobilitato le forze armate in tutto il Paese”.39
Tra il 23 novembre 2001 e il 29 gennaio 2003, si verificarono ben
ventisette fra scontri e attentati, con la perdita di 500 uomini da parte
governativa. Per dare un’idea del livello degli scontri, si può ricordare
che il 17 febbraio a Magalsen, Distretto di Acham (Nepal centro-occidentale), i Maobadi uccisero 107 guardie e il responsabile del Distretto.
Impossibile – a nostro giudizio – fare un calcolo attendibile del numero
di vittime civili.40 Difficile anche calcolare il danno umano, diretto e
indiretto, causato dal reclutamento forzato da parte dei Maobadi, che
costringeva, allora come adesso, migliaia di giovani a fuggire dai loro
villaggi, trasferirsi nelle città o emigrare in India o nei Paesi del Golfo.
In questa situazione, secondo gli autori nepalesi da noi utilizzati, il contributo delle donne all’economia del Paese – noi diremmo, più realisti38
Nel sec. XX, lo stato di emergenza fu dichiarato due volte: nel 1952, in occasione di
una rivolta promossa da un gruppo assai poco omogeneo di forze politiche, capitanata
da Singh K. I. e ben presto schiacciata dalle truppe di Re Tribhuvan, la seconda volta,
fu dichiarata nel 1960 da Re Mahendra.
39
Questo messaggio era inopinatamente diretto ai capi delle missioni diplomatiche, che
non ci risulta abbiano avuto mai rapporti diretti e ufficiali con i Maobadi.
40
Ricordiamo un solo episodio: il 22 febbraio 2002, i Maobadi appiccarono il fuoco
con una molotov ad un autobus di linea che non aveva rispettato lo sciopero da loro indetto. Cinque persone furono bruciate vive, tra le quali, una bambina di otto anni.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
60
camente, alla mera sopravvivenza della popolazione rurale – acquisì
un’importanza vitale. Purtroppo, questo ruolo – peraltro non nuovo –
non garantiva e non garantisce affatto le donne dalle violenze e dalle
ruberie praticate dai soldati e dai Maobadi, così come non garantisce
dallo sfruttamento i minori, da sempre costretti a un duro lavoro ed ora
spesso privati dei genitori e dei parenti dalle vicende della guerra. Le
donne, almeno a partire dal periodo dell’emergenza, furono arruolate in
gran numero nelle fila dei Maobadi, in parte a séguito di una libera
scelta, in parte a viva forza. Questa conseguenza della guerra ha attratto,
com’è naturale, il forte interesse di sociologhe di varia ispirazione e di
militanti di sinistra e di centro. Poiché in questo contesto dobbiamo limitarci alla questione Maobadi, ci riferiremo soltanto a indagini e dichiarazioni connesse con la guerra in corso: ma il movimento delle donne ha in
Nepal origini più antiche, nella stessa società tradizionale e si è manifestato in situazioni storiche e sociali molto diverse dalle attuali.41
Nei documenti ufficiali promulgati dalle alte gerarchie dei Maobadi,
la questione della donna è naturalmente appiattita in un pericoloso e ingannevole messianismo, con radici europee ottocentesche: ma i documenti direttamente presentati da donne nepalesi rivelano, al contrario,
un drammatico realismo. La legislazione militare del Nepal vietava
l’arruolamento di donne nell’esercito42: ma già nei primi anni ‘80, un
gran numero di donne faceva parte della polizia ed erano ben presenti e
attive, equipaggiate con elmetto, corazza e bastone, nella repressione
dei moti della primavera del 1990. Si trattava essenzialmente di donne
provenienti dai gruppi etnici più svantaggiati, ansiose di essere alloggiate, nutrite e di ricevere una sia pur modesta paga. Sull’altro fronte,
secondo quanto riferisce una qualificata fonte Maobadi, detta “Compagna Parvati”,43 le donne che hanno liberamente aderito alla guerriglia,
sono state determinate nella loro scelta da due fattori: primo, la discri41
Una bibliografia adeguata ed un’analisi critica si possono trovare in Napoleoni L.,
Donne e rivoluzione in Nepal: dal sistema castale indù alla guerriglia maoista, tesi di
laurea non pubblicata, Università di Roma II Tor Vergata, anno acc. 2003-2004.
42
Vedi Sezione 10 dell’Army Act del 1960. Questa disposizione sembra essere ora contraddetta da una campagna di reclutamento indetta dall’Esercito e indirizzata alle donne: vedi The Kathmandu Post, 28 novembre 2003.
43
Vedi “Women’s Participation in the People’s War”, in The People’s War in Nepal –
Left Perspectives, cit. alla n. 12, pp. 165-182.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
61
minazione insita de jure nella società nepalese, specie per ciò che concerne le leggi sull’ereditarietà; secondo, “lo scatenato stupro di massa
delle donne delle campagne perpetrato dallo stato”. A questi due fattori,
noi possiamo senz’altro aggiungerne un terzo: l’atteggiamento ufficiale
e dichiarato di condanna da parte dei Maobadi dell’uso di prodotti alcolici, quasi sempre distillati in casa e contenenti di regola sostanze altamente tossiche. In tutti i gruppi etnici da noi osservati, le donne hanno
costantemente dovuto supplire col loro lavoro alla ridotta produttività
maschile, determinata – fra l’altro – dall’abuso di liquori.
Com’è prevedibile, la “Compagna Parvati”, che vive in clandestinità, non formula nessuna critica al movimento in cui milita: ma la sua
documentazione delle malefatte del governo del re è preziosa.
Molto diverso è l’atteggiamento di Subita Shakya,44 dirigente della
All Nepal Women’s Assn., affiliata al CPN (UML). Sempre riferendoci
esclusivamente alle conseguenze dirette della guerra e non – come sarebbe auspicabile – al quadro generale della situazione, si può citare la
dura e documentata denuncia presentata dalla Shakya dell’effettiva
condotta dei Maobadi verso le donne e i minori.
I Maobadi reclutano a forza ragazzi sotto i 14 anni e li impiegano
come combattenti e come portatori di bombe artigianali, mine e munizioni. La percentuale di donne uccise in combattimento è molto alta rispetto alla loro presenza negli effettivi: “Possiamo dire che i Maoisti
impiegano con la forza nelle operazioni di guerra donne non addestrate”. Lo sfruttamento di donne e bambini come portatori e come scudi
umani è praticato abitualmente sia dai Maobadi, sia dai corpi antiguerriglia. – “All’interno del partito Maoista, casi di stupro e di sfruttamento sessuale sono – a quanto risulta – comuni e si è sentito parlare di casi
in cui le donne sono state stuprate perché professavano una diversa opinione all’interno del partito”. Lo stesso partito dovette riconoscere che
un Vice-Presidente del Governo del Popolo – tale Kaile Giri – aveva
violentato una bambina. – “Quasi tutte le donne guerrigliere che hanno
lasciato il Partito Maoista si sono lamentate di esservi state costrette a
séguito di violenza sessuale”. Tutto ciò è drammatico, ma non sorpren-
44
Vedi “The Maoist Movement in Nepal: An Analysis from the Women’s Perspective”,
in The People’s War in Nepal, cit., pp. 375-404.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
62
dente in una cultura che non protegge in alcun modo i deboli, a tutti i
suoi livelli, in tempo di guerra e in tempo di pace.45
Durante questa lunga fase di guerra ad oltranza, i Maobadi inflissero
un colpo particolarmente pesante al prestigio del Governo di S.M.: il 26
gennaio 2003, uccisero a colpi d’arma da fuoco, nella capitale, l’Ispettore Generale delle Forze Armate di Polizia, Krishna Mohan Shrestha,
sua moglie e una guardia del corpo, dimostrando di volere e potere agire in una zona considerata sotto controllo governativo.
Per l’osservatore esterno, non è facile mettere a fuoco un qualche disegno politico o strategico dietro una guerra condotta a livello tattico
con ottusa e ripetitiva crudeltà: una possibile spiegazione è che esistano
fratture orizzontali tra le forze degli stessi Maobadi e che chi vive alla
macchia da anni, con un’arma in mano, non s’identifichi con la politica
dei dirigenti, siano questi politici o anche militari. Ufficialmente, i
duumviri continuavano a tuonare contro “la cricca Gyanendra-Paras” –
re e principe ereditario, detestato da tutti per la sua pessima condotta
privata46 – e a suo tempo, dopo il massacro del 1 giugno 2001, avevano
persino esortato l’esercito a non obbedire agli ordini del nuovo monarca: senza alcun successo, come s’è visto. Ma, al tempo stesso, i dirigenti dei Maobadi sapevano benissimo che non solo al tavolo delle trattative avrebbero trovato in ogni caso un rappresentante del Palazzo, ma
che sarebbe stato più facile trovare un accordo con l’emissario del re,
che non con i politici di qualsiasi gruppo parlamentare.
45
Lo Himalayan Times del 5 agosto 2004, pubblicò un articolo che documentava
10.247 casi di maltrattamenti di minori nell’arco di sei mesi. I dati erano stati raccolti
dal Child Workers in Nepal – Concerned Centre (CWIN), un benemerito ente assistenziale privato, diretto da Gauri Pradhan. Il Ministro per le Donne, i Bambini e
l’Assistenza Sociale, Ashta Laxmi Shakya, fece suo il rapporto del CWIN, se ne assunse la responsabilità e lo pubblicò. I casi convenzionalmente detti di abuso o maltrattamento comprendevano assassinii, sparizioni, violenze sessuali, compravendita di bambini, prostituzione forzosa. La guerra civile come tale, nello stesso periodo, condizionò
brutalmente l’esistenza di 6.919 bambini: 42 ragazzi e 12 ragazze perirono a causa di esplosioni di bombe e di coinvolgimento accidentale in conflitti a fuoco; due si suicidarono
a causa di eventi legati al conflitto, 99 furono feriti, 77 furono arrestati dalle truppe governative e ben 6.986 furono rapiti dai Maobadi per essere coinvolti nelle loro attività.
46
Paras investì e uccise con la sua jeep un noto cantante nepalese, che aveva criticato la
condotta del principe in un locale pubblico: soltanto l’immunità di cui godono i membri
della famiglia reale lo protesse dalla normale procedura penale. Era poi presente alla
strage del 1 giugno 2001, da cui emerse senza una scalfittura.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
63
Tre giorni dopo l’assassinio dell’Ispettore generale Krishna Mohan
Shrestha, il nuovo Primo Ministro Lokendra Bahadur Chand, nominato
motu proprio dal re, dopo l’improvviso licenziamento di Sher Bahadur
Deuda, i Maobadi e – se così lo si può chiamare – il nuovo governo dichiararono un secondo ‘cessate il fuoco’. Questa decisione, quale che
fosse il ruolo e il più che dubbio status dei membri del parlamento, fu
presa dal re e dai Maobadi. Se i duumviri, il 6 ottobre 2002, bollavano
il monarca quale autore di “un colpo di stato regressivo”, il 24 ottobre
lo salutavano come auspicabile partecipante a un dialogo tra le diverse
forze politiche, necessario per uscire dall’impasse. I rappresentanti dei
partiti, come si può immaginare, non si compiacquero affatto di questa
rinnovata, cordiale intesa fra il Palazzo e i dirigenti dei Maobadi e nel
maggio 2003 cominciarono, piuttosto tardivamente, ad agitarsi, invocando la ricostituzione del Parlamento – quindi la fine della nuova autocrazia del re Gyanendra. Il 30 maggio 2003, Lokendra Bahadur Chand,
uomo dell’ancien régime, diede le dimissioni e fu sostituito da Surya
Bahadur Thapa, anch’egli uomo della Panchayat.
Il documento a firma di Baburam Bhattarai presentato in data 27 aprile 200347 in occasione del secondo ‘cessate il fuoco’ (29 gennaio
2003), è pressoché identico nella sostanza – e spesso anche nella forma
– al documento presentato nel 1996 e da noi ampiamente citato all’inizio di questo scritto. I sette anni di guerra civile non sembrano aver
modificato, né tantomeno arricchito l’apparato ideologico dei dirigenti
Maobadi; da un punto di vista pragmatico, si propone la formazione di
un governo ad interim – con l’immancabile riferimento alla convocazione a suffragio universale di un’assemblea costituente – e si propone
altresì la soluzione della democrazia parlamentare, esattamente del tipo
che, nello stesso documento, è chiamata sprezzantemente “la democrazia formale britannica”. Nessun cenno alla possibilità di un governo del
genere detto “democrazia popolare”.
Nel Punto IV del par. b della Sez. E (Agenda della discussione), si
propone che “appropriati mutamenti strutturali vengano messi in atto
affinché sia creato un esercito nazionale unito, che comprenda il Regio
47
Vedi “Annex V, Summary of the CPN (Maoist) proposal presented for consideration
during 2003 ceasefire”, in Thapa D. e Sijapati B., A Kingdom Under Siege, cit., pp.
197-205.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
64
Esercito e l’Esercito di Liberazione Popolare e che tale esercito nazionale sia posto sotto il controllo dei rappresentanti eletti dal popolo”.
Nessuna menzione dei danni e delle sofferenze provocate dai Maobadi
alla popolazione civile in sette anni di guerra: ogni responsabilità è addossata alle truppe del re.
Com’era prevedibile, le trattative non ebbero esito soddisfacente e
nell’agosto 2003 furono riprese le ostilità, secondo un modulo ormai
scontato.
Il 14 novembre, i Maobadi misero a segno un altro brutto colpo ai
danni del Governo di S.M.: nel Distretto – sino a quel momento, relativamente tranquillo – di Makawanpur, a circa 50 Km a SE della Valle di
Kathmandu, il Generale di Brigata Sahar Bahadur Pandey fu ucciso con
una mina fatta esplodere al passaggio del suo automezzo. Il generale
Pandey, che viaggiava con la moglie e con la scorta (tutti periti nell’attentato), è stato sinora l’ufficiale di più alto grado caduto vittima di un
attentato organizzato dai Maobadi. L’evento provocò un forte choc alla
popolazione della capitale, ormai assuefatta allo stillicidio quotidiano di
morti violente di semplici soldati, sottufficiali e civili di modesta condizione.48 Lo choc, però fu presto riassorbito – come era già avvenuto in
precedenza – dalla consistenza molle e vischiosa della guerra, che soffoca la popolazione, ma che è ben tollerata dal Palazzo, dai partiti nella
loro roccaforte urbana e dalla dirigenza dei Maobadi.
Il 17 novembre 2003, il Kathmandu Post pubblicò un’intervista – a
cura di Ghanashyam Ojha – al vecchio leader comunista Mohan Bokram
Singh, Segretario dello United Front (Masal), dalle cui fila provengono
– o direttamente o per clonazione – gli attuali duumviri Maobadi. M.B.
Singh – non sappiamo se per scelta o per necessità – vive da clandestino in Nepal, benché non sia indiziato di alcun reato politico. Il suo giudizio sul movimento Maobadi non potrebbe essere più duro:
“I Maoisti hanno deviato dalla loro missione di introdurre cambiamenti
fondamentali in Nepal. Sono più influenzati da Trotsky che non da Mao, Marx
48
Per la cronaca, quello stesso giorno altri tre poliziotti furono uccisi dai Maobadi a
Nepalgunj (Nepal sud-occidentale) e 27 poliziotti feriti – alcuni gravemente – con mine
a circuito elettrico. Babita Mandal, di venti anni, Segretaria Distrettuale della Nepal
Women Organization (Revolutionary) fu uccisa in uno scontro con le truppe governative (The Himalayan Times, 16 novembre 2003).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
65
e Lenin. Sono più opportunisti e carrieristi. Esiste un gruppo di ‘proletarivagabondi’ [sic] che ha influenza all’interno del Partito Maoista. La loro ideologia è sbagliata. A differenza di Mao, che non ha mai estorto, i Maoisti in Nepal continuano a estorcere dalla gente e a macellarla, ciò che ha allontanato i
ribelli dalla società.
The Kathmandu Post:
– “Che cosa ne dice del cosiddetto rapporto dei Maoisti con l’India”
Singh:
–“L’India ha sempre voluto l’instabilità in Nepal: si augura che il Nepal
non riesca mai a trovare una soluzione per l’insurrezione Maoista e che sia costretto a invitare qui l’esercito indiano per contenere la violenza. I Maoisti,
come altri partiti nel passato, sono diventati la migliore arma a disposizione
dell’India ai fini del suo piano. Sono pronti a qualsiasi compromesso, con
chiunque, sia l’India, sia la monarchia, pur di arrivare al potere (…)”.
The Kathmandu Post:
–“Come vede lei il rapporto fra il Palazzo e i Maoisti?”
Singh:
–“I Maoisti e il Re hanno fatto un compromesso – dichiarato o non dichiarato – per eliminare le conquiste del Movimento Popolare del 1990. Essi hanno
ammesso in varie occasioni in passato il loro rapporto con il Palazzo.
The Kathmandu Post:
–“Lei crede che Prachanda voglia instaurare uno stato repubblicano?
Singh:
–“Il Naya Satta (Nuovo Regime), di cui i Maoisti sono andati cianciando,
non è possibile. Imporranno invece un socialfascismo, con cui tutti più tardi
dovremo combattere”.49
A distanza di un anno dagli avvenimenti che abbiamo descritti, non
possiamo offrire un quadro che riveli una situazione nuova e promettente: Sher Bahadur Deuba, dirigente del Partito del Congresso e licenziato dal re Gyanendra per incapacità nell’ottobre 2002, viene nominato
dallo stesso re nel gennaio 2004 Primo Ministro al posto di Surya Bahadur Thapa, uomo da sempre legato al Palazzo. Questo passaggio dei
poteri ottiene il placet – per quello che conta – dei partiti.
La guerra civile continua, senza azioni spettacolari, ma con un costante stillicidio di vite umane, di piccole vittorie e di piccole sconfitte.
49
The Kathmandu Post, 17 novembre 2003. Il testo è tradotto alla lettera dall’inglese:
l’intervista si è certamente svolta in nepali e ciò ha influito sul lessico e sulla sintassi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
66
Ancora una volta si tenta di giocare la carta delle trattative con i Maobadi50: ma ciò non impedisce al P.M. Deuba di recarsi, nel Settembre
2004 in visita ufficiale a Delhi, dove chiede e ottiene un modesto appoggio militare, più l’impegno, da parte del Governo indiano, di addestrare truppe scelte nepalesi ai fini dell’anti-guerriglia. La visita di
Deuba è presentata dalla stampa come il prologo di una prossima visita
ufficiale del re a Delhi: ciò sembrerebbe indicare – fra l’altro – l’intenzione di garantire un ulteriore afflusso di armi in Nepal.51
La questione delle armi non ha attirato a sufficienza l’attenzione dei
politologi nepalesi, non ostante le evidenti implicazioni economiche:
non ci risulta che in Nepal si producano armi moderne ed esplosivi e
pertanto chiunque acquisti queste merci se le deve procurare attraverso
fornitori stranieri: il volume d’affari legato a nove anni di guerra non
può non essere rilevante e non può non influire sulla conduzione generale della guerra stessa, sulla sua durata e forse sulle sue cause e motivazioni attuali.52
50
Il 22 settembre 2004, il Kathmandu Post e tutti i principali organi di stampa della capitale, riportano le dichiarazioni del P.M. S.B. Deuba, che da un lato si dice disposto ad
avviare – per la terza volta! – trattative con i ribelli, dall’altro, si dichiara alquanto scettico sulla serietà e la coerenza delle loro intenzioni.
51
La partita di armi e sistemi d’arma promessa dal Governo di Delhi comprende tre
elicotteri leggeri da combattimento, 35.000 fucili automatici, 5.000 mitragliatrici di vario calibro, 800 fra camion e jeep, più una quantità imprecisata di mine –supponiamo
del tipo anti-uomo. (dallo Himalayan Times dell’11 settembre 2004).
52
Molto tardivamente, la stampa nepalese ha cominciato a prestare attenzione a questo
specifico problema: vedi “Four-Party Leaders Come Down Heavily on King”, The Himalayan Times, 29 settembre 2004. L’autore anonimo dell’articolo sottolinea come
l’importazione di armi vada di pari passo con la militarizzazione – in senso anche giuridico – del Paese e come a tale importazione sia legato un lucroso giro d’affari.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
67
I quaderni del CREAM, 2004 - II
68
ILDÀSIO TAVARES
•
LA LITURGIA DELLA SOPRAVVIVENZA NEGRA
♦
Introduzione
Le procedure liturgiche e la strutturazione dei precetti nel candomblé1 si orientano verso una strategia di sopravvivenza del culto nella diaspora. Le varianti liturgiche (che furono possibili senza condizionare i fondamenti della religiosità) fanno parte di un processo di adattamento della religione africana a una realtà brasiliana che a seconda
del tempo e del luogo, sarà più o meno recettiva e, in alcuni casi e in
alcuni periodi estremamente avversa.
La dislocazione dei terreiros2, veri e propri quilombos3, lontano dai
centri urbani, in zone disboscate nel mezzo della foresta, dislocazione
funzionale a una società globale disboscatrice e poco industrializzata,
•
Poeta e scrittore, Professore di Letteratura presso l’Università di Bahia, ministro di
Oxum e uno dei dodici ministri di Xangô.
♦
Titolo originale Oriki Oyê Orukó in Martins, C. e Lody, R. Faraimará – o caçador
traz alegria. Pallas Editora, Rio de Janeiro, 2000, pp. 209-220. Tradotto da Andrea
Malpeli e Roberto Malighetti. Tutte le note sono a cura dei traduttori.
1
Religione afro-brasiliana che combina le tradizioni africane (jeje, nagô, angola, congo), indigene e cristiane. Jej e nagô, sono termini che indicano rispettivamente le lingue
e le tradizioni dei popoli del Dahomei e Yoruba.
2
Insieme di terreni e di case ove hanno luogo le cerimonie religiose nei culti afrobrasliani (Candomblé, Umbanda, Tambor de Mina).
3
Si riferisce ai luogi di fuga degli schiavi (Malighetti, 2004). Anticamente sembra che
designasse anche i luoghi delle danze religiose degli schiavi.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
69
ha permesso una vita autonoma e perfino isolata di alcune delle forme
più tradizionali di candomblé, finché il progresso della civiltà non andò
integrando poco a poco, le comunità-terreiros nello spazio urbano. La
città andò lentamente divorando le zone disboscate al punto da ridurre
alcuni terreiros spaziosi e importanti dentro i limiti di una casa. L’inesorabile avanzamento del progresso e il conseguente aumento di complessità delle relazioni sociali vennero a negare alle comunità dei terreiros il tempo per assolvere gli obblighi liturgici compresi nell’esercizio religioso, principalmente i tempi lunghi necessari a compiere i riti
di iniziazione.4 Il candomblé dovette adattare i suoi riti alle imposizioni
della società globale, compresa la necessità di adattarsi alla legislazione
lavorativa.
Il calendario delle festività nei terreiros riflette questo processo di
integrazione dei culti nella struttura sociale. Nel Ilê Axé Opô Afonjá5
quasi tutte le festività cadevano in giorni consacrati ai santi o di domenica, quando gli schiavi erano a riposo per le feste della religione ufficiale che proibiva il lavoro in quei giorni.
Gli schiavi approfittavano di questa tregua liturgica per praticare i
loro culti, e i padroni, accorgendosi che i negri erano più contenti se potevano mettere in pratica quello che consideravano come attività festiva, e che lavoravano meglio il giorno successivo, decisero di autorizzare tutto ciò, incentivando il candomblé per propri fini, senza pensare
che così li aiutavano a rafforzare le loro identità. Nel Ilê Axé Opô Afonjá di Rio de Janeiro le feste hanno luogo solo di sabato e domenica approfittando della pausa del fine del settimana. Le feste che normalmente
cadrebbero nel giorno consacrato a un determinato orixá sono trasferite,
a causa degli impegni di lavoro, al sabato o alla domenica. Fare riti di
iniziazione a Rio de Janeiro richiede ferie lavorative.
L’osservazione rigorosa dei fondamenti del Candomblé in qualsiasi
parte del Brasile, a Cuba, ad Haiti e nella stessa Africa condurrà alla
conclusione che si tratta della stessa religione.
4
Riti preparatori per incorporare e ricevere le orixás (divinità iourubane, nagô, intermediarie fra Olórun, l’Essere Supremo o il suo rappresentante e figlio, Oxalá, e gli uomini) o altre entità.
5
Ilê Axé Opô Afonjá: nome nagô (iorubà) di una delle case di Candomblé più antiche
di Bahia. Ha una specie di filiale a Rio de Janeiro.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
70
Conobbi un filho do santo6 di Obatalá7, persona di elevata posizione
sociale in Messico, la cui iniziazione era stata fatta da un babalorixá8
cubano ma che non era mai entrato in trance sotto l’effetto degli atabaques9. Il suo rituale era fatto con dischi e registrazioni dei canti della
santeria10 di Cuba. Portai questo messicano al terreiro Ilê Axé Opô Afonjá e quando entrò nella stanza dell’altare di Xangô, esclamò: “Sono
in Vaticano”. Era la prima volta che vedeva la stanza di una divinità
con gli accessori liturgici canonici. Tuttavia la religione che lui praticava era fondamentalmente uguale alla nostra. Lui era un iniziato – della
santeria come si dice a Cuba – ma non aveva mai partecipato a una Xiré11 (festa) con sequenza di canti dal vivo, danze, atabaques, agogô12,
xequerè13. Praticava la sua religione, riceveva la sua eledá14 in condizioni adeguate alla realtà messicana nella quale la musica registrata sostituiva la vivacità della festa. Ma il suo Orixá arrivava ugualmente.
Questo è ciò che importa.
Alcuni puristi vivono tentando di avviare un processo di ri-africanizzazione del candomblé, prendendo l’Africa attuale come parametro.
Questo procedimento è rischioso perché gli aspetti esteriori del culto in
Brasile intendevano proteggere i fondamenti segreti della religione e
non deformarli. Bisognava prendere in considerazione il pericolo che
con il tempo la forza del significante avrebbe potuto distorcere il significato. Ma si dovette correre questo rischio affinché il candomblé sopravvivesse in Brasile, nella diaspora.
6
Iniziato nei culti afro-brasiliani.
Obatalá: nome africano di Oxalá, figlio di Olorun, il Dio Supremo. È l’orixá (divinità
iorubana) della creazione.
8
Sacerdote responsabile del terriero.
9
Tamburi alti e stretti utilizzati nel candomblé e in generale nei culti afro-brasiliani.
10
Denominazione dei culti afro-brasiliani a Cuba.
11
Ordine in cui sono cantate e danzate le invocazioni alle orixás all’inizio delle cerimonie.
12
Strumento ritmico costituito da due campane in metallo a forma di cilindro percosse
da una bacchetta metallo. Fa parte dell’orchestra del candomblé.
13
Zucca lunga cinta da grani di una collana o di un rosario.
14
Divinità che veglia sulla persona, sua protettrice e guida spirituale.
7
I quaderni del CREAM, 2004 - II
71
Il mimetismo attraverso il quale un orixá si camuffava in una divinità cattolica non corruppe l’orixá. Oxóssi15 non sparì a favore di San
Giorgio, ma continuò a esistere come Oxóssi. E nemmeno sorse un sincretismo secondo il quale si dice erroneamente che esisterebbe una cosa
come Ox-orge o Jor-xossi forse una specie di entità nuova che nondimeno mantenga le caratteristiche delle entità generatrici. Questo mimetismo non deforma la religione come nel caso del sincretismo dell’umbanda16 che creò un’entità nuova che non esisteva nell’Africa, la pomba-gira17 che non può essere interpretata come una femminilizzazione
brasiliana di Exu18, entità maschile, fallica, presente in tutta l’Africa.
Nella realtà, ci sono una serie di processi sincretistici nel vestiario e
negli accessori, i cosiddetti attrezzi degli orixás, senza tuttavia che si
abbia una deformazione dell’orixá nella sua essenza intima. In fondo
sono adattamenti, riduzioni sociologiche e antropologiche nelle quali si
cerca lo stesso significato con significanti differenti. Nella festa di Oxalá in Africa, i negri si coprono di polvere per imbiancarsi. In Brasile,
semplicemente ci si veste completamente di bianco. Oxóssi usa un cappello di cuoio e una borsa di cacciatore, e potrà perfino usare un fucile.
Ma questi accessori fanno solo riferimento, in una forma brasiliana, alla
strumentazione archetipica del cacciatore. Nella danza, nella trance, nei
canti, nei tocchi di atabaques, il rituale è puramente africano. Non c’è
confusione sull’identità legittima dell’orixá e sulla sua espressione liturgica. La traduzione culturale enfatizza solo la teatralità, costruisce il
phisique du role.
Al di sotto di qualsiasi apparenza che modifica l’esteriorità del culto, l’essenza liturgica del candomblé rimane la stessa, sia esso Ketu, Je-
15
Divinità iorubana della caccia, protettrice dei cacciatori. Chiamata anche odé, cacciatore.
16
Religione formatasi in Brasile selezionando elementi dai culti africani, indigeni, cattolici e dello spiritismo e dell’occultismo.
17
Divinità femminile nell’umbanda.
18
È una delle figure più controverse del panteon afro-brasiliano. Nel candomblé tradizionale è un messaggero fra divinità e uomini. Elemento dinamico di tutto ciò che esiste
è il principio della vita individuale e della comunicazione. Nell’umbanda e nelle tradizioni bantu è identificato con il diavolo dei cristiani.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
72
je, Angola, o Caboclo19. Può essere identificata e sarà rispettata dai suoi
cultori senza nessun purismo. Iemanjà20 di un terreiro tradizionale non
è superiore a Iemanjà di un terreiro nuovo. È la stessa orixá alla quale
si dedicano procedimenti liturgici equivalenti. Iemanjà è Iemanjà a Bahia a Cuba e nel più sincretistico terreiro di umbanda. Edison Carneiro
intravide molto bene questo substrato comune al candomblé in tutto il
Brasile, definendo quelli che considerò i lineamenti di base comuni – la
possessione, l’individuazione della possessione e la presenza di Exu. Ci
sono altre caratteristiche comuni che possono essere identificate dai fedeli, ma quelle citate sono realmente le basilari.
Una pluralità di fattori compone il culto del candomblé, al punto da
poter difficilmente trovare due case che abbiano calendari uguali, canti
uguali, paramenti sacri uguali. Tutte le case antiche hanno attraversato
un processo secolare di adattamento. Si modificarono per sopravvivere.
Tuttavia, torno ad insistere, le modificazioni sono di facciata, sono risorse e strategie di camuffamento che non rientrano nel dominio degli
iniziati di primo livello. Ci vuole tempo perché possano cominciare a
capire meglio le cose.
Nel candomblé, come in tutte le religioni iniziatiche, si apprende
prima per poter capire poi. E all’interno di questa pluralità ci sarà sempre una unità esplicita, principalmente per i cultori che sapranno identificare gli atteggiamenti, i procedimenti e le contestualizzazioni che andranno a comporre il quadro generale della liturgia. Gli affiliati si riconoscono e si identificano. E sanno molto bene chi ne rimane fuori, inutilmente nascosto dietro i suoi gesti plateali con cui pretende legittimarsi.
Qualsiasi tentativo di ripurificazione, di recupero di ortodossia, di
riafricanizzazione pecca alla radice, principalmente perché una norma
fondamentale dell’antropologia dice che l’area più lontana è la più conservatrice, e l’area centrale è la più innovatrice. La lingua ioruba del
nostro candomblé è arcaica. Le procedure liturgiche si preservano qui.
L’Africa soffrì un bombardamento alienante e non può oggi esser presa
come parametro. Ha preso un’altra via: non si tratta pertanto di stabilire
gradazioni di qualità. Peggio ancora, se qualcuno si impadronisce di un
19
Si tratta delle tre principali tradizioni di candomblé legate alle provenienze. Il candomblé de caboclo originò a Bahia, utilizzando elementi di origine africana e indigena.
20
Divinità femminile di acqua dolce e salata, orixá dei pesci.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
73
fondamentalismo africanamente manicheista, secondo cui tutto ciò che
si fa in Africa è giusto e ciò si fa in Brasile è sbagliato. No. Insisto. Nei
suoi fondamenti e principi, il candomblé è lo stesso in qualsiasi parte
del Brasile, dell’America o dell’Africa. I suoi aspetti esteriori variano,
conducendo tuttavia sempre allo stesso contenuto. Anche nel candomblé de caboclo nel quale persino la lingua liturgica africana è sostituita
da quella portoghese, l’essenza dei rituali è la stessa ed è di origine africana, jejé-nago21 per essere più precisi. Candomblé in Africa, candomblé in America sono due cammini differenti dello stesso modo di
vedere il mondo, maniere diverse di amministrare una stessa visione del
mondo, non-cartesiana, olistica, integrata, nella quale le frontiere tra il
sacro e il profano non possono essere delimitate a partire dalle circostanze o dalle esteriorità.
Oriki Oyê Orukó. 22 Traduzione/interpretazione nel contesto
di una lingua polisintetica
Poste queste questioni introduttive, possiamo passare al tentativo di
considerare l’oriki23 nell’universo semantico afro-brasiliano nel quale le
diverse distorsioni potranno essere meglio comprese nel momento in
cui si metta da parte qualsiasi purismo di ordine regressivo. Così, il
concetto di oriki si può estendere da un canto di lode a un orixá (narrativo, invocatorio, e presentificatore) fino a un semplice nome, un orukó
nel quale per un processo di agglutinazione comune alle lingue polisintetiche, la caratteristica di base di epiteto dell’oriki può essere fuso al
punto da essere irriconoscibile e da eliminare la distinzione fra i due. È
necessario indagare, se ridotto l’oriki al suo minimo che sarebbe l’epiteto, nell’essenza della filosofia onomastica ioruba, non sia incisa
l’intenzione laudativa – perfino la contiguità fonica oriki/orukó, desta il
21
Designazione data alla cultura e ai rituali religiosi formatisi a Bahia dall’unione delle
tradizioni Jeje e Nago.
22
Oriki, Oyê e Orukó, indicano rispettivamente un saluto alle orixá, un titolo onorifico,
e il nome di battesimo nel candomblé.
23
Cantico di lode che racconta le qualità e le gesta di un orixá.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
74
sospetto di una comprensione di un nome come un mini-epiteto, una
lode.
Oriki e orukó sarebbero allora, secondo questa ipotesi, due facce di
una stessa medaglia onomastica nella quale le intenzioni di individuare
si estendono a identificare e, perché no, a fare poesia. Solamente per
decomposizione metaforica o metonimica si può arrivare a una approssimazione semiotica dei nomi della divinità, gli orukós. Accostarsi agli
orikis più lunghi è un rischio, una temerarietà, una trappola che, nonostante ciò, non inibisce i voraci e incauti traduttori che senza una minima iniziazione linguistica invadono una lingua polisintetica per trasportarla alla più esigua polisemia delle lingue analitiche, senza riuscire ad
immaginare che fra queste esiste l’ostacolo delle lingue sintetiche. Nessuno può essere traduttore in portoghese senza conoscere il latino. Tuttavia viviamo il tempo delle mistificazioni architettate al computer con
ignoranza e mancanza di pudore. Persone che non sanno la lingua ioruba e dominano poco la lingua portoghese vivono traducendo da una all’altra lingua baldanzosamente e pubblicando svergognatamente le loro
mostruosità pseudoletterarie nelle quali nemmeno si avvicinano al senso letterale.
Già ebbi la curiosa esperienza di convivere con uno ioruba bilingue
che parlava inglese come molti della sua etnia, e per di più, medico,
laureato in Inghilterra e sposato a una inglese, dotato pertanto di un eccellente padronanza della lingua di Shakespeare. Varie volte mi sono
divertito nel vedere lo sforzo di questa persona nel tentare di tradurre
frasi, espressioni, orikis dallo ioruba all’inglese. Con la mia discreta
conoscenza di questa lingua e il mio artigianato di poeta e traduttore ho
potuto aiutarlo varie volte e in due, con un po’ di lavoro, siamo arrivati
ad un accordo su tutte le espressioni. Si noti che questo signore per
quanto dominasse bene non solo entrambe le lingue ma anche entrambe
le culture, aveva difficoltà a trasportare concetti da una all’altra frontiera culturale. Io mi divertivo molto a vederlo rimacinare un concetto in
ioruba, a volte tautologicamente, esprimendo qualcosa che sapeva molto bene che cos’era ma che non riusciva a verbalizzare in inglese. Immaginate qualcuno che non conosca non solo i meccanismi più sofisticati dello ioruba, ma anche gli artifici della lingua portoghese. Questa
persona sarebbe perduta e si trasformerebbe in un grande architetto di
equivoci e sciocchezze. Ma gli arditi traduttori sono lì per perpetuare le
I quaderni del CREAM, 2004 - II
75
loro imprudenze, pretese e equivoci, a confondere piuttosto che a chiarire, come un certo presentatore televisivo.
Consiglio qualsiasi persona che voglia approfondire l’universo della
semiotica verbale di avviare uno studio verticale della linguistica. La
linguistica moderna si afferma, giustamente a partire dal fallimento degli strumenti epistemologici tradizionali quando fu necessario studiare
certe lingue indigene polisintetiche dell’America. Questo produsse il
libro Language, di Edward Sapir, un classico della linguistica moderna
che diede impulso alla enfasi descrittiva e alla creazione delle grammatiche strutturali. Chomsky tentò senza successo di invertire questo processo, restando circoscritto a uno sforzo teorico che non aggiunse nulla
alla comprensione particolare dei sistemi linguistici differenti o sconosciuti. Tutti questi obbiettivi facevano parte del tentativo riduzionista di
Chomsky di creare una grammatica universale che spiegasse tutte le lingue, dell’assurdo sforzo di tornare a prima della Torre di Babele molto al
di là delle follie filologiche del metodo storico-comparativo che condussero i grammatici a scrivere romanzi in indoeuropeo. Ipotetici.
I processi semantici delle lingue polisintetiche, così come la loro
struttura sintattica e morfologica non hanno niente a che vedere con le
lingue occidentali, e ancora di meno con le lingue analitiche. L’unico
territorio dove lo ioruba si incontra con il portoghese è quello fonetico.
Foneticamente le lingue si assomigliano e questo permise confusioni ed
equivoci, alcuni comici. In un oriki di Oxum24, lo ioruba dice: “Osun
odolá ayabá imulédei”. Alcuni cantano: “Osun odolá ayabá”, “la donna
con cui fare l’amore”.
Si aggiunge che questo processo di africanizzazione della lingua
portoghese a Bahia, spiegata tanto bene da Yeda Pessoa de Castro confonde ancora di più le cose perché ir si trasforma in i in una evidente
eresia erotica con Oxum.
È necessaria, inoltre una conoscenza linguistica e una intimità con i
processi metaforici e metonimici delle lingue polisintetiche perché si
possa compiere un accostamento rispettoso degli orikis e orukós, al fine
di interpretarli alla luce delle componenti antropologiche relative a un
universo simbolico che non è il nostro, e detto di passaggio, che ci può
24
Orixá femminile dei fiumi e delle fonti di acqua dolce, divinità della ricchezza, della
maternitá, della bellezza, della sensualità, dell’erotismo.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
76
condurre a risultati riduttivi o errati. Come si fa a tradurre sostantivi,
verbi, aggettivi e avverbi, preposizioni e congiunzioni in una lingua che
non ha queste categorie grammaticali? Che non ha categorie grammaticali fisse? Che ha parole-frasi? Forse studiando alcune lingue indoeuropee più remote possiamo trovare prove dell’esistenza di una grommaticalizzazione universale, a partire da parole-frasi o conglomerati verbali
significativi come esistono in ioruba. Ignifer in latino significa torciera,
letteralmente portatore di fuoco, formata da ignis, fuoco, e fer dal verbo
ferre, trasportare, portare; gudafaúhrhts in gotico vuol dire devoto, credente, ma letteralmente che ha paura di Dio, timoroso di Dio, guda della stessa radice da cui deriva Gott in tedesco e God in inglese, faurhts
dalla stessa radice da cui deriva paura in italiano, führt in tedesco e fear
in inglese. Wairaleiks in gotico vuol dire virile, ma letteralmente che ha
corpo di uomo. Si noti che questo processo di metonimizzazione e metaforismo per agglutinazione o congiunzione di parole è presente anche
oggi come eredità indoeuropea nella nostra lingua. Opposta rispetto alla
espressione gotica ma basata sulla stessa metonimia (ma al contrario) è
la perifrasi nel portoghese di Bahia “falso ao corpo” per definire un
omosessuale.
È nel trattare con questi meccanismi linguistici che possiamo comprendere meglio i concetti ioruba. Si rende tuttavia necessario un maggior approfondimento culturale e religioso per giungere vicino a una
comprensione più legittima. Ed è necessario, prima di tutto, stabilire
come obiettivo un’interpretazione aperta piuttosto che una traduzione
chiusa. Le lingue polisintetiche sono estremamente pertinenti nei culti
iniziatici per la loro complessità sonora che può, se mal realizzata, vanificare la presentificazione liturgica e il potere ontofanico della parola. E
sotto questo aspetto, il tono svolge un ruolo fonetico fondamentale, che
non ha equivalente in portoghese, come invece ancora rimane in alcune
lingue slave.
È tanto grande la ricchezza sonora della lingua ioruba, e soprattutto
nella sua realizzazione nel culto, che i ricercatori seri riducono sensibilmente il corpus per poter capire meglio i processi espressivi della
lingua. Conosco un musicologo americano che sta svolgendo una ricerca estensiva soltanto sui canti di Xangô, per studiare le relazioni della
scala tonale della lingua con quelle delle canzoni. Non sempre c’è una
stretta corrispondenza. La parola più vicina alla nostra alegria è aiò con
I quaderni del CREAM, 2004 - II
77
una discesa del tono sulla seconda sillaba, una allegria che scende verso
il basso, provando, una volta di più, la visione sussuriana che il segno
linguistico è arbitrario. In un canto che si è abituati a intonare nel Ilê
Axé Opô Afonjá la melodia ha una curva tonale ascendente che va nella
direzione contraria di quella della parola.
Tutte queste interazioni, accresciute dall’intricata dialettica del senso occulto, formano un affascinante campo di lavoro. Arrivai ad osservare, negli anni dell’esperienza più diretta del candomblé, questo ricchissimo universo poetico costituito da una onomastica simbolica e /o
metaforica-metonimica e una toponimica nella quale le categorie del
reale e dell’irreale si fondono come tutte le antinomie. Molti ricercatori
nel porsi di fronte al candomblé incorrono in confusioni ed equivoci per
non saper distinguere le frontiere tra le varie denominazioni di obblighi,
titoli, epiteti, o il semplice nome del santo, nome religioso con il quale
l’iniziato fu ribattezzato, l’orukó, segno di individuazione personale e
dell’orixá della persona. È comune confondere il tipo di orixá, la qualità, come si dice nel linguaggio del santo, con l’orukó, il nome individuale di quella persona. Quella che sembra una cosa tanto semplice
(anche perché c’è un numero limitato e fisso di orixás), frequentemente
è distorta al punto che alcuni ricercatori hanno inflazionato il numero
dei tipi di orixá confondendoli con gli orukós.
Un altro concetto che è anch’esso confuso con orukó è il concetto di
oyê, in verità un titolo fisso con il quale l’iniziato si cataloga. In questa
condizione si trovano gli obàs25 di Xangô del Ilé Axé Opò Afonjá, per
esempio. Essi sono dodici e, quando per la morte di qualcuno renda vacante un posto, colui che arriva riceverà una qualifica, un oyê che erediterà da colui che l’ha preceduto. Ci sono altri oyês nel candomblé che
definiscono determinate funzioni, come yabassê, il capo della cucina, o
yamorô responsabile dello padê26, cerimonia per Exu precedente alla
festa del barracão27. Tutti hanno un oyê relativo al compito, alla funzione che esercitano. L’orukó è individuale e attribuito dal proprio ori25
Termine usato per designare i dodici ministri di Xangô nella tradizione del Axé Opò
Afonjá.
26
Rituale propiziatorio, con offerte a Exu, svolto prima dell’inizio di tutte le cerimonie
delle religioni afro-basiliane.
27
Sala in cui si realizzano le cerimonie delle religioni afro-basiliane.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
78
xá al suo affiliato e al suo ogã.28 Oggi sono Otun Obà Aré nel terreiro
Ilê Axé Opô Afonjá, pertanto questo è il mio oyê nella casa di Xangô.
Prima di essere Obà, io ero ogã di Oxum, ricevetti un orukó che mi fu
conferito dalla stessa Oxum, l’Oxum della Mãe Georgette la iakekerê29
della casa. Mi chiamo pertanto Omilarè, questo è il mio nome-de-santo,
il mio orukó. Nel pormi e prostrarmi davanti a Xangô, prima di salutarlo, dico chi sono, declino il mio orukó, dichiaro le mie funzioni nella
casa, a quale santo appartengo, e altri dettagli della mia personalità.
Questo è il mio oriki, che è anch’esso individuale, nella misura in cui
definisce chi sono e mi individualizza con precisione di fronte all’orixá,
affinché mi riconosca e mi distingua tra tutti gli altri figli della casa.
Oriki, oyê e orukó sono aspetti differenti di identificazione e individuazione nel candomblé. Oloyês sono tutti i detentori di qualifiche, che in
alcuni casi corrispondono a una qualche funzione e in altri sono soltanto onorifici.
Alcune relazioni oriki/orukó
Chiariti questi punti, mi piacerebbe riflettere un po’ sulla realtà concreta di alcuni orukós e sulla loro forma sintetica nell’oriki, di epiteti o
di saluti agglutinati che in alcuni casi hanno bisogno di una perifrasi
perché siano compresi nella loro interezza semantica. Ebbi l’opportunità nel mio libro, Xangô30, di mostrare come il nome degli orixás incorpora una aspetto laudativo, a volte una agglutinazione di parole in una
frase descrittiva o narrativa. Così, il nome Onirá, attribuito a una quali-
28
Titolo onorifico dato a uomini di buona condizione economica e di prestigio sociale,
scelti dal capo del candomblé o da una divinità incorporata. Hanno la funzione di sostenere e proteggere il terriero.
29
Mãe-de-santo oppure pai-de-santo. Nomi generici per indicare le sacerdotesse o i
sacerdoti, responsabili di un terriero. Mãe Georgette è la iakekerê del terriero, sostituta
naturale della ialorixá quando quest’ultima non sta presente. Kekerê in yorubá vuole
dire piccolo. Iakekerê è la piccola mamma, la Mãe Pequena. Per estensione, la Ialorixá
è la mamma maggiore, quella principale.
30
Grande e potente orixá iorubano (nagô), dio del fulmine e del tuono.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
79
tà di Iansã31, sarebbe una contrazione di Oya wale n’ilu irá e il nome
proprio dell’orixá, Yansan, sarebbe una contrazione di Ya mesan orun,
in entrambi i casi una riduzione di un oriki in un orukó di lode, di apologia, in un onomastico, nel quale tuttavia resta inciso il carattere apologetico. Alla fine dei conti, un nome deve essere qualcosa di cui una
persona possa andare orgogliosa e un nome di un orixá dovrà essere un
segno di gloria, un marchio di potere. I più anziani del culto affermarono sempre che i nomi degli orixás sono in realtà orikis. Solamente pochi e in circostanze molto specifiche possono pronunciare i veri nomi
degli encantados32 che immediatamente li rendono presenti.
Ogni orukó identifica l’orixá del figlio del santo. Chi è di Xangô, sarà Obá; chi è di Omolú33, Iji; di Oxalufan34, Iwin o Olufan e di Oxaguian35, Ajagun; chi è di Oxum sarà Oxum o Omi; se è di Iemanjá, Yá;
di Ewa, Ewa; di Obá36, Obá (ma posposto); chi è di Nanã37, Nã; di Yansan, Oyá; di Ogum, Ogum; di Logunedé, Logun; di Iroko38, Loko, di
Oxumará39, Dan. Gli orixás nella tradizione Ketu che vengono dallo
jeje hanno la loro origine segnata. Dan è la designazione del serpentevodum nello jeje. Loko è il nome di Vodum40. Nanã, si indica con Nã.
Nonostante ciò, l’uso dell’orukó varia da casa a casa. Nella casa Ilê
Axé Opô Afonjá le persone si rivolgono le une alle altre attraverso gli
31
Divinità femminile, una delle mogli di Xangô, divinità guerriera, del vento, dei fulmini e della tempesta.
32
Designazione delle orixás, spiriti ancestrali, esseri di varia natura, animati o forze
sovrannaturali con forma umana.
33
Divinità del vaiolo e delle malattie epidermiche in generale, chiamato anche “medico
dei poveri”.
34
Forma vecchia di Oxalá, figlio do Olórun. È il Dio della creazione, patrono della fecondità, della procreazione.
35
Forma giovane e guerriera di Oxalá.
36
Divinità del fiume Obá (Nigeria), guerriera, moglie di Xangô.
37
Divinità il cui culto sembra esser sorto in Brasile. Una delle mogli di Oxalá. Rappresenta la terra fecondata, il fango. Divide con Yemanjá la maternitá degli orixás. Madre
di Omolu, Exu, Oxossi, Ewa, Oxumarê e Iroko.
38
Divinità fitomorfa.
39
Divinità dell’arcobaleno che presiede al bel tempo. È rappresentata da un serpente.
40
Nome generico delle divinità jeje,corrisponde alle orixás della tradizione nagô. Loko
è il nome di Iroko nella tradizione jeje.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
80
orukó, e conoscono quelli di tutti, anche quelli della ialorixá41. Nel terreiro Ilê Iaomi Axé Iamassê (Gantois) l’orukó è mantenuto segreto, il
che si può essere originato nell’epoca della persecuzione del culto
quando era un nome in codice. Ho scoperto l’orukó della Mãe Menininha, che nessuno sapeva, per deduzione, perché al momento di presentarmi a lei nella fila dei Figli di Ghandi42 per i suoi 90 anni, declinai
il mio oriki e lei mi disse – “allora tu sei mio padre. Che tu sia benedetto padre mio”. Al momento rimasi gradevolmente sorpreso, ma dopo
ragionai e percepii che al di là del fatto che lei era figlia di Oxum, il suo
orukó coincideva con quello di mia figlia, la Mãe Georgette, che era
composto dal mio oriki.
Il mio orukó è Omilarê. Omi indica l’affiliazione a Oxum ed è più
pertinente a Ogã. Nel mio caso, sono l’Ogã dell’Oxum più vecchio della casa Ilê Axé Opô Afonjá. Arê può significare disputa conflitto guerra,
questione, pendenza giudiziaria, partecipazione alla disputa legale, giudizio. Cercai di conoscere il significato del mio nome e una persona anziana mi disse “l’acqua della felicità”; un’altra, “l’acqua della giustizia”
Entrambi gratificanti, qualificando omi, acqua, metafora di Oxum, pacificazione, refrigerio, calma, omi tutu fondamentale per tracciare lo iwa
pelé, il cammino di dolcezza, di soavità, di illuminazione.
Più tardi conobbi un famoso babalawô43 africano, Wande Abimbollah, che determinò anche il mio odu44 e confermò che il mio orixá fosse
Orumilá45. Lo interrogai sul significato del mio nome, essendo uno che
aveva per lingua madre lo ioruba. Egli rispose, “l’acqua vince in caso di
guerra”. Risvegliando la polisemia dell’acqua nel mio orukó, gli chiesi
se non potesse essere “in caso di guerra la calma vince”? Egli scosse la
testa. “È questo, ma non è solo questo. È molto di più”. Così finivo per
apprendere la mia lezione del battesimo: “Stai calmo che tutto si risolve”. Chi mi conosce e sa come mi agito per tutto, percepirà alla svelta
come questo orukó serve bene alla mia crescita. “Stai calmo e lascia
41
Sacerdotessa dirigente di un candomblé.
Organizzazione religioso-carnevalesca che svolge i suoi rituali per le strade in occasione de carnevale.
43
Sacerdote di Ifà, dio della divinazione.
44
Responso della divinazione.
45
Nome del Dio Supremo, creatore.
42
I quaderni del CREAM, 2004 - II
81
tutto il resto a Oxum” direbbe un altro saggio, Prof. Agenor, in un’altra
epoca.
La Mãe Maior di tutti noi e del Brasile, Mãe Stella, a cui rendiamo
omaggio, ha come traduzione possibile del suo orukó la frase: il cacciatore porta (o portò) allegria. Che dire se proponessi una tradizione più
sintetica: “il nutritore”? L’allegria che il cacciatore porta potrebbe essere interpretata come una caccia che riempie la pancia. Nessun è allegro
con la pancia vuota. Il cacciatore porta allegria perché è colui che porta
il nutrimento, la sazietà. Questa è la funzione fondamentale del cacciatore in una società primitiva: fornire il nutrimento.
Da un altro lato, il cacciatore nel significato più profondo della religione ioruba, non deve soltanto trovare la preda, ma come colui che segue le orme, deve altresì indicare il cammino dell’illuminazione, che è
senza dubbio, il cammino dell’allegria che sopravviene dopo uno stato
di disorientamento, agonia, tristezza, oscurità – la negazione della tristezza. L’allegria e il cacciatore – nella sua funzione di cercatore di orme – devono essere assunte nel loro senso allegorico – colui che trova il
nostro cammino ci porta allegria.
La funzione di orientare è, pertanto una funzione archetipica del
cacciatore, fondamentale all’inizio di tutte le civilizzazioni. Queste dipesero sempre dai cacciatori per sopravvivere, non solo per il loro arco
infallibile, ma per la loro capacità di essere guide, di conoscere i sentieri, le scorciatoie e i ripari che potevano salvare i loro popoli dalle intemperie, dagli attacchi delle belve feroci o dei nemici. Bisogna ricordare che Oxóssi è Oxotankanxoxó, il cacciatore con una sola freccia infallibile e che per questo, come tutti i cacciatori, è un grande guerriero.
Il cacciatore sta alla base della piramide della sopravvivenza di qualsiasi popolo scolpito nella memoria degli ioruba. Oxóssi è un orixá
primordiale della terra, un eborá46 che marcia davanti a tutti, perché fu
Tobi Odé, il primo Oxóssi, Odekomorodé, il cacciatore che non è figlio
di cacciatore che forgiò il ferro per la prima volta in questo pianeta e
aprì la strada a Irunmalé con il suo coltello nel Igbo, nella selva quando
la molle scimitarra d’argento di Obtalá47 si piegò davanti alla durezza
46
Nome degli orixás figli in opposizione ai irunmalés, orixás superiori, orixás padre e
madre.
47
Altro nome di Oxalá.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
82
degli alberi. Per questo, Obtalá e Irunmalés diedero a Tobi Odé l’oyê, il
titolo di Olo Irin, Signore del ferro, e gli diedero il privilegio di marciare davanti a tutti gli orixás perché potesse sempre trovare il cammino e
rimuovere gli ostacoli.
A questo punto, dal cacciatore emerge il fabbro e dal fabbro il guardiano. La metamorfosi de Oxóssi in Ogum simbolizza il passaggio dalla
caccia a dalla raccolta verso una maggiore evoluzione sociale attraverso
la guerra e l’agricoltura. Odé Kaiode si rimette alle azioni di Tobi Odé,
di questo Proto-Oxóssi che portò a Irunmalés la felicità di trovare il loro cammino in mezzo alla foresta. Odé Kayode è un orukó che, di conseguenza, riafferma questa capacità del cacciatore di guidare, di orientare, di liberarsi dalle liane, dai rami, dai cespugli, per trasformare una
foresta di inganni, la nostra esistenza, in un cammino che porti l’illuminazione attraverso la luce bianca di Oxalufan, fino alla luce assoluta
di Olórum Axé48.
48
Forza dinamica delle divinità, potere di realizzazione, vitalità che si individua in determinati oggetti (piante, pietre, simboli metallici ecc.). Il termine genericamente usato
come forma di saluto.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
83
I quaderni del CREAM, 2004 - II
84
ROBERTO MALIGHETTI
E MERGENZA
•
COME FINE DELLO SVILUPPO .
LE ALTERNATIVE DEI FAVELADOS DI RIO DE JANEIRO
Antropologia della modernità
L’affermazione di una specificità antropologica nell’ambito delle ricerche sullo “sviluppo”, si è costituita intorno all’analisi etnografica dei
processi di pianificazione e della costruzione della macchina organizzativa nel contesto della quale si affermano i cambiamenti nelle società
del cosiddetto Terzo Mondo. 1
Raccogliendo l’eredità dei teorici della dipendenza e dell’antropologia dinamista,2 gli approcci antropologici analizzano la cause del sottosviluppo e i fallimenti dello sviluppo come il risultato delle relazioni di
dipendenza con le società occidentali.3 In particolare mostrano come la
configurazione dello sviluppo faccia inesorabilmente parte del processo
di espansione del sistema capitalistico mondiale e analizzano la società
civile della cooperazione, un’arena eterogenea composta da 10 milioni
di organizzazioni no profit locali, 40.000 associazioni internazionali, 30
•
Professore Associato di Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
1
Benedict, 1967; Augé, 1972; Grillo, Rew, 1985; Fergusson, 1990; Colajanni, 1994;
Crewe, Harrison, 1998.
2
Frank, 1969; Balandier, 1971; Bastide 1971; Stavenhagen, 1971; Malighetti, 2001.
3
L’ultimo rapporto della Conferenza dell’Onu sul Commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 2004 mostra che i paesi poveri meno influenzati dalla globalizzazione sono
progrediti maggiormente in termini di reddito procapite.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
85
milioni di lavoratori e un fatturato di 1.110 miliardi di dollari a rappresentare l’ottava economia mondiale (davanti a Spagna, Russia e Canada).4
Da queste prospettive, lo studio delle teorie e delle pratiche dello
sviluppo è considerato un capitolo fondamentale di un’antropologia
della modernità,5 tradizione che ha definito l’apparato scientifico disciplinare in modo univoco e totalizzante, sottraendolo all’analisi, così
come l’occhio si sottrae allo sguardo. Opponendosi alle limitazioni della disciplina allo studio delle società “premoderne”, l’antropologia ha
trasformato la stessa modernità in oggetto di scienza, studiandone la
forma di razionalità e la tecnologia come anche le strategie di occultamento della propria culturalità.6 Partendo dal presupposto foucaultiano
secondo cui esiste una “struttura antropologica” che sostiene l’ordine
moderno e le scienze umane, analizza in quale misura abbia dato origine al regime della modernizzazione e dello sviluppo. Esamina il sapere
scientifico e tecnologico, mettendo in luce le modalità fenomenotecniche con cui ha costruito la realtà e mostra altresì come i domini considerati come universali (l’epistemologia, la tecnica e l’economia) siano
invece storicamente determinate, legati a specifiche pratiche sociali e
politiche.
Questa antropologia del rapporto fra “Noi” e gli “Altri” può tracciare una linea di continuità tra l’analisi delle pratiche «occidentalizzanti»
di cambiamento pianificato del periodo coloniale e le attuali iniziative
per lo sviluppo dei paesi ex-coloniali7. Non esaurisce il passato della
disciplina nello sterile meccanismo del disvelamento e con la condanna
di un’attività che la successiva evoluzione politica e teorica avrebbe
4
Marcon, 2002:7. Per quanto riguarda la realtà italiana, secondo i dati dell’Istat del
2001, fra più di 200 mila organizzazioni no profit solo 44.000 (circa 20%) impiegavano
lavoratori retribuiti e avevano bilanci superiori ai 100 milioni di lire annui. Di queste, il
10% più ricco poteva contare su bilanci annuali da più di 2 milardi di lire (Marcon,
2002:11).
5
Remotti, 1993.
6
Feyerabend, 1975; Ardener 1985; Manganaro, 1990; Latour, 1990; Remotti, 1990;
Dumont, 1993.
7
Augé 1972; Cochrane, 1979; Nieuwenhujze, 1983; Latouche, 1984, 1989; Said 1990;
Verhelst, 1990; Colajanni, 1994; Malighetti, 2001, 2002.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
86
“inverato”. Come nota Colajanni,8 sostenere che l’antropologia dell’età
coloniale non fu così “perversa” vuole dire aprire uno spazio di riflessione sul fatto che l’antropologia post-coloniale non è così “buona”. Significa garantirsi la possibilità di un’analisi critica che recuperi la storia
della disciplina nelle sue potenzialità di suggestione e stimolo.
Da un lato Malinowski stesso già nel 1930 diresse l’attenzione non
solo sulla realtà locale, ma anche sul “sistema dei bianchi”, analizzando
“il progetto mondiale di penetrazione economica europea e l’economia
coloniale” e “il caos di una cattiva amministrazione e di una politica
predatoria”9. Anche il padre della cosiddetta antropologia coloniale ebbe modo di riflettere sui concetti di sviluppo e di progresso che gli amministratori acriticamente accettavano. Considerando l’elemento tragico del cambiamento indotto dalla presenza europea descrisse molto
negativamente il colonialismo come «un sistema che produce inevitabilmente impoverimento, malnutrizione, disorganizzazione, demoralizzazione e graduale decadimento demografico” nonché “spedizioni punitive”, “massacri di massa dei nativi” e “strane rappresaglie” “nel nome
della giustizia, del prestigio e dell’onore dell’uomo bianco”10. Nel testo
pubblicato postumo, The Dynamics of Cultural Change, si spinse a sostenere l’impegno politico dello scienziato sociale nella difesa dei nativi,
ridotti in schiavitù, sterminati e spogliati del loro patrimonio.
Sicuramente la critica di Malinowski si limitò a mettere in discussione le modalità con cui il processo di “occidentalizzazione” fu realizzato, non considerando gli elementi strutturali del dominio coloniale, né
analizzando i meccanismi di sfruttamento economico, discriminazione
razziale e oppressione militare e politica. Lo scopo era di stabilire un
“controllo scientifico” della politica coloniale che potesse evitare gli
aspetti negativi o quelli che anche oggi, nel linguaggio della cooperazione e in quello politico-diplomatico, vengono chiamati “effetti collaterali”. Il colonialismo è considerato sotto il suo aspetto tecnico-amministrativo, escludendo dall’analisi i processi sociali, economici, politici
e storici. Come molti dei suoi allievi Malinowski accettò di fatto la
“modernizzazione” del mondo, intesa sostanzialmente come un proces8
Colajanni, 1993:184.
Malinowski, [1930] 2001b:84-5.
10
Malinowski [1930] 2001b:411.
9
I quaderni del CREAM, 2004 - II
87
so positivo di civilizzazione che avrebbe consentito il superamento delle
forme arcaiche di organizzazione e l’assimilazione a un modo di vita sicuramente superiore. In tal senso operò sostanzialmente all’interno di una
prospettiva evoluzionistica, attento ai problemi di adattamento dei cambiamenti imposti dall’Occidente alle istituzioni locali.
D’altro canto anche gli antropologi contemporanei impegnati nella
cooperazione internazionale, come i loro predecessori coloniali, raramente criticano il sistema. Cercando di vivere “professionalmente in
pace”11, convivono, seppur in maniera “riluttante”12 con una politica
economica responsabile della drammatica condizione in cui vive gran
parte dell’umanità. Nella transizione dall’“incontro coloniale” a quello
che Escobar chiama, rifacendosi ad Asad, “l’incontro dello sviluppo”,
l’antropologia ha continuato a dare acriticamente per scontato il significato e i contesti delle politiche di cooperazione e di “aiuto umanitario”,
rifiutando di considerare seriamente la struttura di potere all’interno
della quale sia queste pratiche, sia la stessa disciplina prendono forma.13
Il numero sempre maggiore di antropologi coinvolto nei progetti di
cambiamento pianificato lavora all’interno di strutture neo-liberiste,
sottratte all’analisi critica, nella convinzione di poter contribuire a migliorare il sistema e renderlo più efficiente. In genere hanno assunto un
compito simile a quello che aveva l’antropologia applicata in epoca coloniale, quello cioè di aiutare i tecnici e i pianificatori a rendere più efficaci quegli interventi che non partecipano a definire. Spesso si trovano a studiare, in termini sostanzialmente funzionalistici, gli effetti dei
cambiamenti sull’insieme complesso e interrelato del sistema socioculturale delle popolazioni “bersaglio” o le pratiche di quelli che nel
linguaggio evocativo delle politiche di cooptazione dell’Indirect Rule
11
Asad 1973:18.
James 1973.
13
Escobar, [1995] 2001:298. Citando Said, Escobar sottolinea come la recente letteratura antropologica abbia generalmente evitato di riferirsi all’intervento imperiale statunitense nelle sue articolazioni economiche, militari, politiche, culturali e umanitarie (Escobar, 1995:214). Edward Said (1990:32) esplicitamente considera le strutture di potere globale contemporaneo come un prolungamento dei residui culturali e ideologici del
colonialismo, sostenendo che le tattiche e le strategie dei grandi imperi, smantellate dopo la prima guerra mondiale, furono utilizzate dagli Stati Uniti. Cfr. Ulin 1991.
12
I quaderni del CREAM, 2004 - II
88
vengono chiamati “omologhi”.14 Il development encounter riproduce
così il dilemma etico dell’antropologia coloniale fondato sulla difficile
scelta fra la sterile critica degli impatti negativi dei progetti, che non
incide sulla loro realizzazione e la partecipazione diretta alle attività
che mette a rischio l’integrità morale della disciplina15.
Nonostante il differente modo in cui le società sono incorporate nel
sistema economico mondiale, attraverso un’indipendenza politica che si
è rivelata solo formale, anche nella contemporaneità si può cogliere ciò
che Asad16 considera la “precondizione strutturale per l’antropologia”,
e cioè le relazioni di potere fra dominanti e dominati. Anche oggi
l’antropologia è parte di un sistema globale di relazioni economiche,
politiche e sociali fortemente asimmetriche. Le importanti analogie fra
il contesto strutturale dell’odierna antropologia dello sviluppo e quello
dell’antropologia coloniale consistono, fondamentalmente, nel fatto che
è sempre l’interesse del committente a dominare il campo degli interventi, modello di riferimento unilaterale assoluto e principio di “occidentalizzazione del mondo”.17
La professionalizzazione e l’istituzionalizzazione dello “sviluppo”,
ha prodotto un insieme di conoscenze e di forme di dominio congruenti
con gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti occidentali o
delle elites negli stati ex-coloniali.18 I principali attori della cooperazio14
Rossetti, 1979; Burton, 1992; Malighetti 2002.
Gulliver 1985:50; Scudder 1988:373, Bennet, Bowen 1988:21; Grillo, Rew, 1985:24;
Pigg 1992.
16
Asad 1973.17
17
Grillo, 1985:20; Latouche, 1989; Burton, 1992:185.
18
Se consideriamo la provenienza delle INGO (International Non Governmental Organizations) l’Europa conta il 50% del numero di sedi, della densità dei militanti e della
nazionalità dei responsabili esecutivi contro il 10% degli USA, che destinano la parte
più consistente delle donazioni private alle charities locali (solo 1,2% spettano a ONG
che sostengono cause internazionali). Tra le prime 19 nazioni nella classifica delle INGO nel 2000 c’erano solo due paesi in via di sviluppo (India 12° posto e Nigeria 18°)
(Anheier, Glasius, Kaldor, 2001:283; Pech, Padis 2004:42). Sebbene i locali stessi diventino protagonisti della creazione e funzionamento di Ong, tuttavia lo fanno all’interno di meccanismi di cooptazione generalmente controllati da istituzioni esogene. I
loro intermediari, formati nei paesi del Nord (i Chicago boys in America Latina, la Berkeley mafia in Indonesia) spesso occupano posizioni importanti all’interno dei ministeri
delle finanze locali e delle banche centrali. Spesso sono coloro che si spartiscono i divi15
I quaderni del CREAM, 2004 - II
89
ne internazionale sono pesantemente condizionati dalle priorità dei finanziatori che decidono della destinazione dei fondi in vista dei propri
orientamenti, ideologici, economici e politici.19 Spesso i programmi di
aiuto sono vincolati all’obbligo da parte dei paesi che li ricevono di usare tecnologie o aziende dei cosiddetti donors, ostacolando le capacità
di sviluppo locali compromesse dall’immissione sul mercato di merci
drogate dall’assistenza esterna.20
Questo ha portato differenti autori21 a considerare le pratiche dello
sviluppo come forme di neo-colonialismo e imperialismo, definite altresì come un triplo processo di “decivilization”, “depolitization” e “depossession”22 a causa del loro carattere verticistico ed ignorante delle
conoscenze e della pratiche locali (“they-have-the-problem-we-havethe-solution-approach”).23 Espandendo il potere burocratico statale, costituiscono una “macchina anti-politica” che alimenta il fatalismo, il
clientelarismio e l’assitenzialismo.24 Imprigionano i progetti alternativi
e neutralizzano le potenzialità di resistenza e innovazione native, considerando le questioni politiche della terra, delle risorse, dell’occupazione
o dei salari come problemi esclusivamente “tecnici”.25
L’antropologia, specie nella sua articolazione applicativa, può dunque continuare a definire il proprio ambito come lo studio del cambiamento e delle trasformazioni che si accompagnano con i tentativi di instaurare un sistema economico mondiale globale, trattando problemi di
dendi della subordinazione, degli investimenti nelle infrastrutture, degli aggiustamenti
strutturali voluti da FMI e Banca Mondiale (Traoré, 2002).
19
Minear, Smillie 2003; Duffield 2001; Pech, Padis 2004.
20
L’analisi dell’Ocse (Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) della politica di cooperazione italiana stima che circa il 92% degli aiuti
italiani siano vincolati all’obbligo per i paesi che li ricevono di usare tecnologie o ditte
italiane per realizzare i progetti (La Repubblica, 4 ottobre 2004).
21
Leach, 1982:50; Escobar 1995:5; Sachs 2000:5-12.
22
Fairhead 2000.
23
Arnfred, 1998:77.
24
Fergusson, 1990.
25
I progetti raramente vengono finanziati quando cercano di smarcarsi dal sistema produttivo globalizzato per trovare alternative conformi alle aspirazioni dei beneficiari
(Rahnema 2003:268).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
90
integrazione e di rifiuto, le spinte centripete e centrifughe, gli scarti e le
necessità di mediazioni fra sistemi socio-culturali.
Il/la fine dello “sviluppo”
I fallimenti delle iniziative, la resistenza imprevista di popoli e dei
sistemi culturali alla pressione sviluppista, hanno prodotto un generale
ripensamento del concetto di “sviluppo” e una serie di studi critici che
hanno unito al giudizio storico-politico sulle responsabilità occidentali,
un’analisi antropologica sulle caratteristiche dell’ideologia e della pratica dei cambiamenti pianificati.26
Differenti lavori hanno decostruito, il “discorso dello sviluppo”, presentandolo come una “narrativa” dell’egemonia occidentale27 relativizzandone la presunta portata universale e riportando in luce la sua natura
di prodotto culturale storicamente determinato.28 Lo sviluppo è stato
così considerato come un’impresa etnocentrica, verticistica e tecnocratica, ancorata ad una prospettiva evoluzionistica unilineare e alla categoria illuministica di progresso. Identificato con la crescita, intende teleologicamente il cambiamento come graduale e necessaria trasformazione
verso forme più perfette, identificate con lo sviluppo tecnico-scientifico
ed economico occidentale o, meglio, dei suoi gruppi egemonici e dominanti.
Le prospettive post-moderne e foucaultiane hanno chiarito come il
discorso sullo sviluppo, costituitosi all’indomani del secondo conflitto
mondiale nel momento in cui il potere statunitense è subentrato al colonialismo Britanico e Francese, sia rimasto il principale strumento di legittimazione dell’interventismo “civilizzatore”. In piena Guerra Fredda
funzionò per prevenire l’adesione al campo sovietico, privando nel contempo i popoli dell’opportunità di definire autonomamente le proprie
26
Asad, 1973; Bonfil Batalla, 1982; Apthorpe, Krahl, 1986; Rist, Sabelli, 1986; Mathur, 1990; Whyte, 1991; Sachs, 1992.
27
Escobar 1991, 1994; Nieuwenhujze, 1983; Ferguson, 1990; Verhelst, 1990; Roe,
1991; Hobart, 1993; Fairhead, 2000.
28
Horowitz, 1980; Latouche, 1989; Sachs, 1992; Escobar, 1995:10; Gardner e Lewis,
1996; Rist, 1996.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
91
forme di vita economica politica e sociale.29 Successivamente si è coniugato con nuove categorie come quella di “globalizzazione” e di “emergenza”, continuando a sostenere la struttura delle relazioni di dominio fra i cosiddetti Primo e Terzo Mondo, sempre ridotte a due modelli
asimmetrici semplici (sviluppati-sottosviluppati, semplici e complessi,
Noi e Loro, Occidente e Terzo mondo, tradizionali e moderni).
Le dinamiche “evolutive” sarebbero innescate sulla base dell’ipotesi
che il trasferimento di beni, la fornitura di servizi e di assistenza tecnica
e la costruzione di infrastrutture determinerebbero automaticamente lo
“sviluppo”, indipendentemente dalla considerazione del contesto globale e della realtà socio-culturale dell’area di progetto, sottovalutata fino
al momento in cui diventa inevitabilmente attuale e si presenta con tutta
la sua potenzialità destrutturante.30
Lo iato incolmabile, ma efficacemente rimosso, fra i programmi delle varie agenzie per lo “sviluppo” e l’attualità delle pratiche sociali “reali”, concepito nel gergo della cooperazione come “conseguenze non
previste”, ha comunque prodotto un efficiente strumento di potere. Si
manifesta in termini sia “egemonici”, nei confronti delle popolazioni
“bersaglio”, sia “prestigiosi”, capitalizzando riconoscimenti e risorse finanziarie, da spendere politicamente e economicamente all’interno dei
paesi “sviluppatori”.
L’evidenza scientifica ha chiarito come nel corso delle decadi dello
“sviluppo”, inaugurate negli anni Sessanta dalle Nazioni Unite, gli unici
paesi a svilupparsi siano stati quelli dei “benefattori”. Gli altri, al contrario, sono stati “sottosviluppati”, in conseguenza alle specifiche relazioni politico-economiche fra nazioni industrializzati e nazioni del Terzo Mondo. Analizzando le prove empiriche, in effetti, si può facilmente
notare che gli approcci al cambiamento pianificato non solo si sono dimostrati empiricamente insostenibili, teoricamente insufficienti e incapaci di stimolare un reale processo di “sviluppo” nel Terzo Mondo. Soprattutto hanno partecipato all’ampliamento del gap tra i paesi dell’Occidente industrializzato e paesi del Terzo Mondo, producendo sempre
più gravi contraddizioni interne (fame, violenza, povertà) e dipendenza
esterna.
29
30
Esteva, 2000:352.
Malighetti, 2000.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
92
Diverse prospettive, comprese quelle di Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia, capo della Banca Mondiale, o dell’analista finanziario George Soros, concordano nel sostenere che sono i poveri ad aiutare
i ricchi. La maggior parte delle somme date o prestate sono spese nei
paesi donatori o vi fanno ritorno: rimborso del debito, fuoriuscita di capitali, trasferimenti illeciti di profitti, fuga di cervelli, acquisti di beni e
materiali.31 Già il Primo Rapporto Mondiale sullo Sviluppo Umano
pubblicato dal United Nation Development Program nel 1990,32 aveva
eloquentemente rilevato come nella situazione iniqua che domina le relazioni internazionali, il trasferimento netto di 49 miliardi di dollari dai
Paesi ricchi verso i Paesi poveri, attuato nel 1980-82 avesse prodotto,
negli anni 1983-89 un corrispondente indebitamento da parte dei secondi di 242 miliardi di dollari. Nel 2001 ai 29 miliardi di dollari di
sovvenzioni accordati ai paesi in via di sviluppo, fanno riscontro i 138
miliardi di dollari ripartiti verso i paesi creditori come rimborso del debito.33 Negli ultimi anni, malgrado la crescita considerevole della ricchezza prodotta nel mondo, le ineguaglianze sono esplose: lo scarto fra
il 20% dei più poveri e i 20% dei più ricchi era da 1 a 30 nel 1960 mentre oggi è da 1 a 80. Recentemente la Banca mondiale ha ammesso che
l’obiettivo di dimezzare il numero di persone che vivono nella povertà
assoluta entro il 2015 non potrà essere raggiunto.
Queste cifre continuano a dilatarsi, come eloquentemente mostrano i
dati che eccezionalmente riempiono le pagine dei giornali in occasione
degli inadempienti vertici mondiali, come quello di Cancun, fallito a
causa dell’arroganza delle grandi potenze USA e UE, risolute nel mantenere – nonostante gli impegni presi a Dohan due anni prima e a discapito delle narrazioni “neo-liberiste” – forme di protezionismo e di assistenzialismo su cui fondano le loro politiche agricole. Per favorire una
lobby che rappresenta il 2% della popolazione la UE ha negato l’accesso ai mercati europei dei prodotti dei contadini poveri, ribadendo la
sua volontà di continuare a invadere, nel contempo, quelli dei cosiddetti
PSV (Paesi in Via di Sviluppo) attraverso la svendita delle eccedenze,
tenute sottocosto (grano UE e cereali USA) grazie alle sovvenzioni sta31
Millet, Toussaint, 2002; Sogge, 2004.
UNDP, 1990:51.
33
Sogge, 2004.
32
I quaderni del CREAM, 2004 - II
93
tali. Gli agricoltori dei paesi ricchi (circa il 2% della popolazione) ricevono 300 miliardi di euro di sussidi all’anno. Ogni agricoltore europeo
riceve annualmente 17.000 Euro di sovvenzioni per far fronte a un mercato che non può essere affrontato con la semplice “tecnologia” progredita. A fronte di una popolazione di circa 3 miliari di persone che vive
con meno di 2 dollari al giorno, i giornalisti ogni tanto si ricordano di
farci sapere che una mucca Europea è sovvenzionata con 2,5 dollari al
giorno e una mucca giapponese con 7 dollari. Da Cancun è diventato di
dominio pubblico il caso emblematico del cotone, risorsa vitale per 4
dei paesi più poveri del pianeta (Benin, Burkina Faso, Ciad e Mali) che
ricavano da esso circa il 60% delle esportazione e il 10% del Pil. Gli
USA si sono rifiutati di abbassare i sussidi ai propri produttori (circa
20% del cotone mondiale), superiori all’intero prodotto interno del Burkina Faso. L’eliminazione dei sussidi produrrebbe un aumento del
prezzo del cotone del 26%, costituendo uno straordinario aiuto ai 10
milioni di contadini che vivono di questa risorsa. In generale il dumping
praticato dall’Occidente a vantaggio dei propri prodotti (dai cereali alla
carne, all’industria tessile), ha annullato, il sostegno offerto alle produzioni locali nel quadro dei programmi di aiuto:34 la Banca Mondiale ha
calcolato che la fine del protezionismo UE e USA salverebbe 144 milioni di persone dalla povertà.
La crisi delle teorie dello sviluppo, annunciata negli anni ’80 da diversi autori che ne propongono l’abolizione o l’utilizzo solamente per
le realtà socio-economiche dominanti,35 si è ormai diffusa anche negli
ambienti internazionali come il Fondo monetario internazionale (Fmi),
la Banca mondiale, l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc).
All’ultimo forum di Davos, la cosa non è stata neanche menzionata, rivendicata solamente dalle organizzazioni non governative che di essa
vivono.36
Come sostiene Latouche, lo sviluppo è vittima più del suo successo
nei paesi del Nord che del suo fallimento nei paesi del Sud a dimostra34
Sogge, 2004.
Fergusson, 1990; Escobar, 1994.
36
Cabedoche, 1990; Latouche, 2001. Emblematica è l’affermazione di un contadino
guatemalteco raccolta da Gras (2003:249): “Lasciate in pace i poveri e non parlate più
di sviluppo”.
35
I quaderni del CREAM, 2004 - II
94
zione della sua non universalizzabilità. 37 La finitezza del pianeta renderebbe la diffusione generalizzata dello sviluppo impossibile ed esplosiva, aumentando la competizione su risorse sempre più scarse, il degrado ambientale, le guerre economiche (soprattutto per il petrolio e per
l’acqua), l’emarginazione e la miseria. 38 Tenendo conto dei limiti del
pianeta, lo sviluppo dei più poveri implicherebbe la rinuncia allo sviluppo illimitato dei ricchi in opposizione al processo di accumulazione
capitalistica e ai suoi obiettivi imperialisti e finanziari.39
Se lo sviluppo è la continuazione della colonizzazione con altri
mezzi, la globalizzazione è, a sua volta, il tentativo di prosecuzione dello sviluppo, fondato sulla dittatura dei mercati organizzata da quegli
stessi stati-nazione del Nord, che si erano già fatti più discreti con il
passaggio dalla colonizzazione all’indipendenza, e ora si nascondono
dietro al mercato e ai piani di aggiustamento strutturale imposti dal loro
strumento di gestione, il Fmi.40 Come ebbe modo di rilevare Joseph
Stiglitz, « aujourd’hui, la mondialisation, ça ne marche pas pour les
pauvres du monde. Ça ne marche pas pour l’environnement. Ça ne
marche pas pour la stabilité de l’économie mondiale».41
Emergenza come inveramento dello “sviluppo”
Nonostante i tentativi di riformulazione (alternative development;
self-reliance development; grass rooted development; participatory development; human development; sustainable development)42 e a discapito degli esiti fallimentari, le pratiche di cooperazione internazionale
continuano a fondarsi su una visione unilineare dell’evoluzione del tut37
Latouche, 2001; Harribey 2002.
Latouche, 2001.
39
Secondo Latouche (2001, 2003) è necessario pensare a una società della “decrescita”,
rimettendo in discussione il dominio dell’economia su tutti gli altri ambiti della vita,
nella teoria come nella pratica.
40
Latouche, 2001
41
Le Monde Diplomatique, Septembre 2002; Stiglitz, 2002.
42
La proliferazione di sviluppi “particolari” è notevole: “autocentranti”, “endogeni”,
“comunitari”, “integrati”, “autentici”, “autonomi e popolari”, “equi”, “locali”, “micro”,
“endo” e “etno” (Poncelet, 1994; Latouche, 2001).
38
I quaderni del CREAM, 2004 - II
95
to analoga a quella che in passato aveva legittimato le pratiche coloniali. L’ultima formulazione divenuta dottrina ufficiale delle Nazioni
Unite, lo sviluppo sostenibile, insiste nel sostenere che la ricerca di
un’improbabile crescita economica infinita sia compatibile con il mantenimento degli equilibri naturali e la soluzione dei problemi sociali.43
Nella difficile ricerca di determinarsi, le politiche dello “sviluppo”
tentano di resistere all’usura di un significato che si sfalda a contatto
con la realtà coniugandosi ad aggettivi che convincano della nobiltà
della causa e promettano rinnovati impegni e nuovi obiettivi. Tuttavia
tali aggettivi non rimettono in discussione le cause strutturali del sottosviluppo, aggiungendo, al più, inefficaci e contraddittorie preoccupazioni di carattere sociale o componenti ecologiche alla crescita economica, allo stesso modo in cui si era aggiunta in passato una dimensione
culturale.44 In tal senso lo sviluppo si articola in veri e propri ossimori,45 come nel caso del sintagma “ingerenza umanitaria” un’ingegnosa
alleanza di parole contraddittorie a giustificazione di paradossali unioni
fra la violazione del diritto internazionale, la violenza e il conflitto, con
la compassione; la legge del più forte con l’assistenza ai più deboli; la
pace con la guerra; la scorta armata con il carattere neutro delle azioni;
la crescita con l’ambiente; lo sviluppo con la riduzione delle disuguaglianze; la partecipazione con il controllo.46
L’apparato dello sviluppo si inscrive così in un sistema caratteristico
della modernità occidentale che permette di legittimare azioni ingiu43
Georgescu-Roden, 1995; Latouche, 1997. Lo sviluppo sostenibile, così com’è definito dal rapporto Brundtland, non si accontenta di continuare con il ritmo di crescita attuale, ma intende promuoverne l’accelerazione. Per questo è diventato uno slogan caro
anche alle multinazionali ed agli ambienti dell’alta finanza e ha spianato la strada alla
progressiva apertura del movimento ambientalista al cosiddetto “realismo d’impresa”
(Khan, 2002).
44
Latouche, 2001.
45
Secondo Rist (1994) e Latouche (2003) il concetto di sviluppo costituisce un caso
particolare di ossimoro in sé perché rinvia a pratiche e promesse che raramente sono
confermate.
46
Rist 1993, Perrot, Sabelli, Rist, 1994:55. La risoluzione 46/182 dell’ONU stabilisce
che l’aiuto umanitario deve essere fornito conformemente ai principi di umanità di neutralità e di imparzialità, rispettando la sovranità, l’integrità territoriale, e l’unità nazionale in conformità alla Carta delle Nazioni Unite. L’aiuto umanitario deve essere fornito con il consenso del paese in oggetto e, in principio, su richiesta di quel paese.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
96
stificabili richiamandosi a valori universali indiscutibili (in realtà etnocentrici nella concezione e soprattutto nell’applicazione molto selettiva)
generalmente legati a presunti diritti giusnaturalistici di individui astratti. Attraverso il principio di ingerenza umanitaria, supera il fondamento
del diritto internazionale, perseguendo strategie politico-diplomatiche
miranti all’eliminazione di tutti gli ostacoli, innanzitutto gli Stati, che
impediscano al potere economico di realizzare il suo programma neoliberista di globalizzazione.47
Negli ultimi venticinque anni, i meccanismi dell’aiuto internazionale
hanno contribuito a indebolire la sovranità statali e a delegittimare i poteri pubblici e la nozione stessa di politica pubblica.48 Da un lato i donatori preferiscono rivolgersi a società private, organizzazioni non governative o strutture costruite ad hoc. Dall’altro le autorità nazionali rispondono ai donatori più che ai cittadini. Uno degli esiti dell’aiuto internazionale è un profondo deficit democratico che sostiene il potere
economico e politico di vere e proprie caste locali di oligarchi mafiosi,
come è avvenuto nell’ex Unione sovietica.
Recentemente la categoria “emergenza” ha modificato, o, meglio
hegelianamente “inverato”, la mitologia e la pratica “sviluppista”, risolvendo le contraddizioni e i paradossi. Le azioni emergenziali, che stanno assorbendo gran parte delle già scarsissime risorse destinate alla cooperazione internazionale49, sottraggono tout court gli interventi di
47
Bettati, Kouchner, 1987, Bettati 1991, Sabelli 1994, Piguet 1994, Rist 1994, Perrot
1994. Eppure, l’aiuto internazionale storicamente si è costruito su altre basi. Emblematica è la riuscita del piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale in ragione della
sua ispirazione keynesiana fondata sulla regolamentazione pubblica e sugli investimenti
sociali. Promosso dagli Stati uniti fu gestito direttamente dagli europei senza nessuna
richiesta da parte di Washington di rinunciare a proteggere le industrie, di deregolamentare i propri mercati finanziari, né di saldare immediatamente i debiti (Sogge, 2004).
48
In molti dei paesi che hanno ottenuto aiuti si è assistito al deteriorarsi dei servizi di base
(scuola, sanità ecc.). È una realtà che viene riconosciuta, ad esempio, da un rapporto del
2000 dell’Ocse sulle politiche di aggiustamento strutturale e di privatizzazione a vantaggio una classe di nuovi ricchi legati agli interessi occidentali in Mali.
49
L’aiuto di emergenza coinvolge cifre superiori a quelle degli aiuti regolari o a lungo
termine. Si è moltiplicato per 6 negli ultimi 10 anni fino a raggiungere una media di
quasi 10 miliardi di $ all’inizio degli anni 2000 (Puligny, 2000). Per quanto riguarda il
governo italiano, bisogna aggiungere che sempre secondo l’analisi dell’OCSE la percentuale di aiuti allo sviluppo nel 2003 è scesa allo 0,17% del PIL, rispetto allo 0,20 del
2002. Per il 2005 la percentuale dovrebbe ulteriormente scendere allo 0,15%, tenendo
I quaderni del CREAM, 2004 - II
97
cambiamento pianificato alla sostenibilità e alla partecipazione e in generale all’analisi e al confronto con i risultati del medio e lungo termine, generalmente fallimentari, quasi sempre rimossi e comunque poco
tele-visibili.
Gli interventi di emergenza si caratterizzano per il fatto di entrare in
azione dopo l’avvenimento che li legittima, spesso nella fase più acuta
della crisi, mettendo in gioco un enorme dispositivo umanitario gestito
sempre più direttamente dall’apparato militare e da meccanismi garanti
l’ordine, la stabilità e la sicurezza. In una sorta di «pronto soccorso
mondiale»,50 le organizzazioni non governative e umanitarie si trovano
a doversi appoggiare operativamente a quelle stesse forze armate che
hanno invaso un territorio straniero a volte contro la volontà dello Stato
in questione. Spesso sono costrette a svolgere un ruolo ausiliario alle
azioni militari di occupazione, dovendo ripulire le macerie e avviare i
programmi di ricostruzione.51
La filosofia e le pratiche di tali interventi di emergenza rappresentano la definitiva standardizazione delle procedure trasferibili immediatamente dove le strategie politiche lo richiedano. La configurazione che
ne risulta articola modelli organizzativi fondati sulla performatività e
sull’efficacia in maniera totalizzante, eliminando tutte le altre possibili
modalità di intervento. L’intensa attività, sotto la pressione dell’urgenza, si fissa come non negoziabile, escludendo ogni forma di riflessione
conto dei tagli del governo di 250 milioni di euro ai fondi della cooperazione, pari a una
riduzione del 70% delle risorse destinate alle ONG (50 milioni di euro) e della cancellazione di 55 milioni di euro promessi agli organismi Onu. L’Italia si distingue anche
per essere l’unico paese a non aver versato il suo contributo di 100 miloni di euro per il
2004 al Global Fund contro Aids, malaria e tbc. Ha congelato i 10 milioni di euro destinati all’emergenza Darfur insieme alle iniziative per l’Africa sub-sahariana (La Repubblica, 4 ottobre 2004).
50
Hours, 1998.
51
Nell’ottobre 2001, Colin Powell così sottolineava l’importanza delle ONG, durante
una sessione delle Ong statunitensi in occasione dell’operazione Enduring Freedom:
“un vero moltiplicatore delle forze… una parte importante delle nostre forze di combattimento” (Citato da Brauman, Salignon 2003:275). Le posizioni delle ONG (alcune delle quali nate proprio sui campi di battaglia: la Croce Rossa a Solferino nel 1859, Greenpeace durante la Guerra in Vietnam, Medici senza Frontiere nella Guerra del Biafra del
1968. Vd. Pech, Padis, 2004:13; Boli, Thomas 1999) di fronte alle guerre più recenti
sono molto articolate e in contrasto fra loro (Kaldor 2001:132; Blanchet 2003; Brauman, Salignon 2003; Pech, Padis 2004:32).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
98
critica sulle cause dei problemi come anche l’attenzione contestuale alle
particolarità, alle differenze socio-culturali e ai risultati nel medio e
lungo termine. Pensa al sottosviluppo e alle tragedie della fame e della
guerra in termini apolitici, meccanici e naturali, come semplice risultato
di esplosioni sporadiche legate a stati endemici di warfare tribalistica o
ad una storia ritenuta, questa volta, rigidamente locale e mai globale.
Trascura l’interazione evidente fra attività umane e catastrofi naturali
come anche fra catastrofi naturali e problemi politici e rimuove gli effetti determinati dai cosiddetti “equilibri internazionali”e le competizioni su risorse in continua diminuzione. La fine dell’emergenza produce la sospensione dell’attenzione dei media, l’immediata interruzione
dell’intervento, il trasferimento della macchina organizzativa in altri
scenari emergenti dello scacchiere geo-politico.52
L’apparato dell’emergenza apre un campo politico che si legittima
attraverso la semiotica dell’immagine e la retorica della compassione e
della necessità dell’azione. Viene alimentata da un’ostentata e fortemente censurata visibilità, accecante nella sua vacuità, secondo un registro molto più sensibile alla drammatizzazione dell’evento umanitario e
molto meno alla miseria ordinaria.53
Queste dinamiche costringono le ONG a rincorrere affannosamente
le emergenze per sopravvivere e a mettere in campo un imponente apparato in grado di affrontare la competizione per la raccolta dei fondi
pubblici o privati.54 Le mutazioni del capitalismo determinate dalla crisi
del welfare state keynesiano e dall’apertura dei mercati al neo-liberismo, hanno portato le ONG ad entrare a far parte di un sistema di relazioni con le istituzioni politiche, economiche e gli attori privati. Dal
52
Boltanski, 2000; Pandolfi, 2002.
Piguet 1994:77; Sabelli 1994:135; Dalton 2003; Darcy 2003; Dauvin, Siméan 2003;
Forster, Messica 1989; Minear, Smillie 2003.
54
In Europa nelle seconda metà anni Novanta i fondi pubblici coprivano il 42% delle
risorse (a cui bisogna aggiungere gli aiuti indiretti soprattutto fiscali) a disposizione
delle ONG contro un 42% dei fondi privati e un 16% di autofinanziamento. Il Comitato
per lo sviluppo dell’Ocse calcola che i finanziamenti alle ONG sono passati da 2,9 milioni di $ nel 1970 a 1 miliardo nel 1996 (Commissione europea 2002, p.13). La Banca
Mondiale include un numero sempre crescente di ONG all’interno dei suoi programmi:
fra il 1987 e il 1995 il 33% dei suoi programmi era gestito da ONG. (Pech, Padis 2004:
25; Pinter 2001: 203). Nel 1997 il 50% dei progetti della Banca erano gestiti da ONG
(Pech, Padis 2004:25; Banca Mondiale, 1997).
53
I quaderni del CREAM, 2004 - II
99
crollo del sistema westfaliano delle relazioni internazionali fondato sulla sovranità degli Stati e dal definitivo affossamento dell’ONU dopo
l’11 settembre, hanno assunto un ruolo crescente di rappresentanza,
partecipando a importanti processi decisionali, grazie allo statuto consultivo conferito loro da varie istituzioni internazionali. Molte organizzazioni intervengono direttamente nei mercati, intrecciando rapporti
con le multinazionali, con fondi di investimento, agendo come organismi bancari di microcredito alle imprese familiari e con operazioni
commerciali di vasta portata sul modello del commercio equo.55
Il clima di concorrenza non va solo a discapito delle popolazioni
colpite ma può produrre gravi danni etici per le stesse organizzazioni.
La diffusione dell’informazione, determinata dalle regole di mercato,
costringe a manipolare, a fini di lucro, le azioni umanitarie e a produrre
eventi mediatici a colpi di dichiarazioni e di immagini dal forte carattere emotivo per evocare l’indignazione, la compassione e la “necessità
morale” dell’azione. In alcuni casi servono a sollevare le reticenze del
pubblico alle azioni intraprese in palese violazione delle elementari
norme del diritto.
Gli organismi internazionali e transnazionali agiscono sul territorio
come ciò che Agamben,56 utilizzando un concetto di Appadurai,57 chiama “sovranità mobili”, realtà che si spostano nel mondo imponendo regole e imperativi, legittimati, sotto la bandiera di valori proclamati etnocentricamente come universali. Coniugano l’ideologia del sansfron55
Nel 2001 quasi 14 milioni di persone hanno beneficiato di prestiti di microcredito
(Pech, Padis 2004:72; Yunus,1998). In America Latina su 85 istituzioni di microfinanza
8 sono costituite da banche classiche, 12 da cooperative di credito e 65 ONG (Santino,
2003). Fra le realtà che si occupano di commercio equo Max Havelaar rappresenta la
principale azienda. Distribuisce prodotti pilota (caffé, cioccolato, tè ecc.) per una cifra
d’affari di 112 milioni di franchi svizzeri nel 2003 (+ 33% rispetto a 2002). Occupa una
posizione centrale nel Fairtrade Labelling Organizations, un’entità che definisce i criteri
del commercio equo. Ha altresì stipulato contratti con McDonald’s (140 ristoranti svizzeri si impegnano a servire solamente il caffè Max Havelaar) e con Coop, Migros, Carrefour (Roozen 2003). Fra le organizzazioni che collaborano con multinazionali, Pech e
Padis (2004) riportano i casi di Secours Populaire che collabora con Coca Cola; Fidh
con Carrefour; Wwf con Lafarge, Canon, Mitsubishi, Altria, Unilever, Du Pont de Nemours; Care con Havas.
56
Agamben, 1997; Pandolfi, 2002.
57
Appadurai, 1996b.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
100
tierismo degli anni Ottanta e Novanta con il neoliberismo e l’antipolitica, appoggiandosi al potere mediatico, a quello dei mercati e alle
guerre “giuste”. Comunità di esperti e di poteri coercitivi si mobilizzano così per disaggregare le reti di influenza, concependo nuove alleanze
e confondendo le strategie d’autorità dei poteri locali. Promuovono forme di dominazione che Pandolfi designa come “sovra-coloniali” in
quanto cercano di sovrapporsi ai poteri già esistenti, esercitando strategie globali di controllo del territorio che violano la sovranità degli stati.58 Tali organismi designano competenze, distribuiscono ruoli e integrano gruppi ed elites locali nel circuito internazionale, promuovendoli
al ruolo di negoziatori di forme di governance deteritorializzate e delocalizzate, spesso senza riuscire a sostituirsi efficacemente alle sovranità
pre-esistenti.
Agamben mostra come le “sovranità mobili” si fondino su un concetto di sovranità simile a quello che Carl Schmidt definisce come il
potere di proclamare lo stato di eccezione, di sospendere legalmente la
validità della legge esercitando una sovranità arbitraria senza alcuna
mediazione.59 Determinano una situazione paradossale al di là dei confini dell’ordine giuridico, una forma di esclusione che si materializza
spazialmente anche nei paesi occidentali nei campi dei rifugiati, degli
immigrati, dei clandestini, delle vittime, dei prigionieri di guerra, degli
uomini e delle donne trafficati, traumatizzati. Questi luoghi sono popolati da esseri umani che diventano entità astratte pronte a essere censite,
contate e quantificate, catalogate, etnicizzate e in ogni caso identificate
da poteri alieni.
Mentre la legge classica pensa in termini di individui e di società,
cittadini e stato, questo potere, che Agamben definisce foucaultianamente come biopotere, ragiona in termini di corpi indistinti e delocalizzati, da nutrire, sfamare, vestire, curare, secondo le strategie e le
categorie diagnostiche dell’amministrazione umanitaria esportabili in
tutti i contesti.60
58
Pandolfi, 2002.
Agamben, 1997; Pandolfi, 2002.
60
Agamben, 1997; Pandolfi, 2002.
59
I quaderni del CREAM, 2004 - II
101
Le voci degli esclusi: il lavoro del CCAP di Rio de Janeiro
In un panorama che la cultura egemonica cerca di imporre, con
qualche evidente difficoltà, in termini omologanti e totalizzanti, le voci
degli esclusi riescono tuttavia a farsi sentire. Contraddicono i poteri dominanti e i tentativi di promuovere un’ideologia felice e “rappacificata”
della globalizzazione e dello sviluppo come qualcosa di inevitabile e
soprattutto di già compiuto.
Incalzati dal bisogno di trovare alternative, per paura di essere eliminati dalla violenza neo-liberista e dalle “nuove” forme di aiuto umanitario, la scommessa politica dei gruppi “subalterni”, consiste nella capacità di contrapporsi agli assiomi del capitalismo e della modernità
nella loro forma egemonica.61 Si fonda sulla difesa del locale come prerequisito per impegnarsi nel globale e la valorizzazione dei bisogni e
delle opportunità economiche in termini diversi da quelli del profitto e
dello sviluppo modernizzante.
Superando le dicotomie del discorso modernista (globalità-localismo, modernità-tradizione, centro-periferia ecc.) sostituiscono all’idea
di processi che dovrebbero rimpiazzare il moderno al tradizionale,
l’idea di una modernità ibrida, intesa come un insieme di realtà negoziali prodotte essenzialmente dalla “coappartenenza” della modernità e
della tradizione, del globale e del locale.62 Le “articolazioni”63 e “traffici di culture”64 impongono di ripensare le “culture tradizionali” nel con61
Significativo è il fatto che sia stato il delegato del Botswana ad abbandonare per primo il tavolo delle trattative a Cancun, seguito dalla delegazione del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico. La novità Cancun è il nuovo fronte dei paesi più poveri del Sud (che
rappresenta il 90% della popolazione contadina del pianeta) unitamente alla nascita di
una coalizione di paesi guidato da Cina, India e Brasile. Questo gruppo non solo ha saputo tenere testa a Europa e USA, ma è riuscito a collocare la questione dello sviluppo
sull’agenda politica e non su quella semplicemente tecnica.
62
Già dal punto di vista triadico di Malinowski 1940 (2001:110), il sistema mondiale
non era considerato portatore di un’omogenità culturale globale quanto piuttosto di una
total contact situation, precipitato di “un nuovo tipo di civilizzazione umana”. Questo
“tertium quid”, nato dall’inedita situazione, non era pensata come una “mescolanza”,
bensì un nuovo fenomeno di contatto” in cui “l’insieme differisce in sé dalla somma dei
singoli elementi che lo compongono”.
63
Clifford, 1997.
64
Fabietti, 2000.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
102
testo del loro coinvolgimento trasformativo con la modernità, non in
termini omologanti, ma come società vernacolari65 nate dall’interrelazione fra antico e nuovo. Le “sozzure” sarebbero, cioè, fertilizzanti
per nuove sintesi ed “emersioni” culturali e sociali.66
Nei panorami contemporanei il cosiddetto Terzo Mondo ha contributi unici da apportare alle configurazioni e agli sforzi politici e
intellettuali. La risurrezione e la ricostituzione delle soggettività segnate
da tradizioni molteplici offrono reali possibilità di organizzare nuovi
spazi al di là delle strategie convenzionali di sviluppo che rifiutano di
perire. Come sostiene Escobar, la dispersione delle forme sociali causata dall’economica informatica deterritorializzata consegna opportunità inaspettate ai gruppi marginali per costruire visioni e pratiche
alternative allo sviluppo. Le culture ibride o i “sé rifiutati” si trovano a
poter elaborare un differente senso della direzione rispetto alle tendenze
della ciber-cultura dominante del Primo Mondo.67
In questo contesto si può collocare l’esperienza del Centro de Cooperação e Atividades Populares (CCAP) di Rio de Janeiro, un’organizzazione composta elusivamente da favelados che opera dall’inizio degli
anni Ottanta nella realtà dimenticata e incredibilmente violenta delle
favelas.68 Svolge la maggior parte della sua attività nell’insieme delle
13 favelas che compongono la favela di Manguinhos (55.000 abitanti)
una delle più povere di Rio.69
65
Latouche 1997:112.
Clifford 1993:28; Agier, 2001.
67
Escobar, 1994.
68
Su una popolazione di 5.851.914 abitanti Rio de Janeiro ha 620 favelas con una popolazione di circa 1.092.958 abitanti, pari al 19% popolazione (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, IBGE 2000).
69
Ho avuto modo di fare ricerca sul campo, abitando nella favela di Manguinhos nei
mesi di febbraio e marzo 2003. Secondo i dati IDH (Indice Sviluppo Umano) del 2001
Manguinhos registra il 155° posto fra i 161 quartieri della città. Fra i dati elaborati dalla
Secreteria Municipal da Saude i seguenti sono piuttosto significativi: il tasso disoccupazione supera il 30% fra i giovani dai 18 ai 24 anni; il mercato informale occupa circa
il 45% della popolazione; il reddito pro capite è intorno a R$148,00 (pari a poco più di
40 Euro). Circa il 30% delle abitazioni sono considerate irregolari, provvisorie e a rischio: circa il 20% non è rifornito di energia elettrica; circa 20% non possiede una rete
fognaria e acqua potabile. Secondo i dati della scuola nazionale di Salute Pubblica della
Fondazione Oswaldo Cruz del Ministero della Salute Federale, 80% dei decessi di gio66
I quaderni del CREAM, 2004 - II
103
La situazione è caratterizzata dai conflitti con armi da guerra fra
gruppi di narcotrafficanti che controllano il territorio e fra trafficanti e
forze di polizia. Queste ultime, particolarmente corrotte, adottano pratiche di esecuzioni sommarie e aggressioni alla popolazione civile, promuovendo un clima di terrore congruente con le proprie strategie di
concussione. Unica forma della presenta statale in favela, le forze
dell’ordine accreditano presso la popolazione la concezione delle istituzioni come poteri arbitrari, corrotti e violenti.
In generale, i numeri delle vittime della violenza in favela sono
comparabili con quelli dei conflitti più conclamati e televisti che hanno
mobilitato l’apparato dell’emergenza.
Comparazione fra numeri di morti in combattimento in conflitti moderni e morti per arma da fuoco a Rio de Janeiro 1997-2000.70
1997
1998
1999
2000
Comparazione fra numeri di morti in combattimento in conflitti recenti
e morti per arma da fuoco a Rio de Janeiro 71
Colombia Angola
Sierra
Ex Jugo- Afghani- Uganda
Israel
Rio de
Leone
slavia
stan
Janeiro
500-1.000
------>2.000
--85-250
2.241
1.000.1.500 >1.000
<1.500 1.000-2.000 >2.000
>800
150
2.399
>1.000
>10.000
>6.000 1.000-3.000 >2.000
--100
2.410
>1.000
>1.000
---->3.000
--325
2.646
1964-2000 1998-2000 1991-1999 1998-2000 1991-1999 1994-1998 1948-1963
>39.000
>11.000
>11.000 2.000-5.000 >12.000
>3.000
>13.000
1978-2000 1998-2000 1991-1999 1998-2000 1991-1999 1994-1998 1979-2000
Rio de
Jameiro
49.913
7.465
23.480
7.465
23.480
12.404
48.813
All’interno di questa drammatica situazione il CCAP dall’inizio degli anni Ottanta cerca di stimolare un processo endogeno di cambiamento, sforzandosi di far interagire la popolazione della favela con dif-
vani fra i 15 e i 18 anni sarebbero dovuti a armi da fuoco (Relatório de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro, 2001).
70
Dowdney, 2003.
71
Tratto da Dowdney, 2003, pp. 80-119.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
104
ferenti istituzioni della società civile nazionale e internazionale e a mobilitare gli organismi politici.
Si adopera per articolare le proposte della società civile locale, ritagliandosi il ruolo di coordinazione delle strutture di base autonome e
autogestite, in contrapposizione alle Associazioni degli Abitanti, controllate dal narcotraffico. Articola sinergicamente in un sistema a rete,
attività autonome e indipendenti in differenti aree strategiche: economia, educazione, comunicazione, diritto, risparmio e credito.
Le attività sono iniziate nel 1983 con la costituzione di un sistema di
commercializzazione di prodotti di base che ha integrato i consumatori
delle favelas con i produttori rurali. I risultati mostrano il potenziale
delle attività popolari alternative al mercato, riducendo la precarietà alimentare, migliorando la qualità dei prodotti, generando posti di lavoro
(per circa 81 persone) e funzionando come regolatore dei prezzi
all’interno della comunità.72 Le attività economiche si coniugano con
attività educative finalizzate alla realizzazione di un mercato locale solidale, indirizzate sia ai consumatori (educazione alimentare, diritti del
lavoro, diritti dei consumatori, formazione amministrativo-contabile e
organizzativa del personale, produzione di documenti e materiale informativi e divulgativi) sia ai piccoli agricoltori (amministrazione,
commercializzazione, vendita). In generale partecipano al sostegno
delle iniziative degli altri settori, in particolare l’educazione e la formazione. Queste ultime, in un contesto segnato dall’analfabetismo,73 sono
intese dal CCAP come elementi strategici per processi di cambiamento
“dal basso”. Sono finalizzate a contribuire al superamento dell’emarginazione sociale che si manifesta, prioritariamente, nell’esclusione dal
sistema educativo. A fronte del ridotto numero di quadri e della loro
scarsa formazione, CCAP cerca di rendere gli attori sociali soggetti attivi e promotori autorevoli di processi di cambiamento.
72
Il programma ha rifornito di circa 200 prodotti biologici di qualità, circa 3.000 famiglie, offrendo un risparmio di circa il 20% del prezzo del mercato tradizionale e incrementando del 25% il guadagno dell’agricoltore.
73
La media degli anni di scolarità da parte della popolazione delle favelas di Rio è di
circa 4 anni. L’analfabetismo tocca circa un terzo della popolazione adulta. Circa il
15% dei ragazzi fra 7 e i 14 anni è fuori dal sistema scolastico. In Manguinhos (55.000
abitanti) ci sono solamente 4 scuole elementari (fino alla quarta elementare) e nessuna
scuola media (Relatório de Desenvolvimento Humano do Rio de Janeiro, 2001).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
105
Le azioni in questo senso sono formative in senso generale, inglobando la scuola materna e il sostegno scolastico,74 l’insegnamento superiore,75 e differenti attività culturali, specialmente a sostegno del riscatto dell’identità afro-discendente.
A partire dal 1990 CCAP ha integrato tali attività con la realizzazione ed esibizione di film e documentari, a cui si è successivamente
affiancata la creazione di una televisione comunitaria via cavo e di un
sistema semiclandestino che sfrutta abusivamente un segnale dal satellite per trasmettere un telegionale comunitario. Tali operazioni si collocano nel contesto delle attività informative, divulgative e educative
miranti a stimolare la coscienza critica della comunità, sensibilizzare la
società sulla realtà delle favelas, facilitare il dialogo della popolazione
con i poteri pubblici. Gli obiettivi ambiziosi intendono realizzare un esperimento di democratizzazione dei mezzi di informazione in opposizione al monopolio delle grandi reti televisive e di controinformazione per divulgare le rivendicazioni sociali e la realtà della vita della
favela. I documentari di denuncia, esibiti anche in Europa, hanno avuto
modo di sensibilizzare i poteri pubblici locali (in particolare il Governo
dello Stato di Rio de Janeiro, il Gabinetto per la Sicurezza Istituzionale
74
Il Centro de Educação Tia Zilda, fondato nel 1993 dal CCAP, è un’associazione senza fini di lucro che offre insegnamento infantile a circa 105 alunni fra i 3 e 6 anni e attività di sostegno scolastico (approvata dal governo municipale) per 80 studenti iscritti
alle scuole municipali. Le attività del Tia Zilda sono finanziate autonomamente per circa il 70% (di questi circa il 50% proviene da rette pagate dalle famiglie; 20 R$ mensili
contro i R$ 35 delle altre scuole; circa il 15% è prodotto da attività serali di recupero
scolastico; circa il 5 % dal Ccap). Il restante 30% viene dalle donazioni (nazionali e
internazionali). Il successo del Centro de Educação Tia Zilda, divenuto un punto di riferimento per le entità che lavorano con l’educazione infantile in altre favelas è deducibile da una serie di fattori come l’aumento delle richieste di iscrizione, la pressoché assenza di abbandoni, i buoni risultati degli alunni nelle scuole della rete pubblica elementare, il riconoscimento da parte degli abitanti della comunità e del Potere Pubblico.
75
Il CEPSEM (Corso preparatorio agli esami di scuola media) funziona dal 2001 in
cooperazione con l’Universidade do Estado di Rio e la SUAM (Sociedade Universitária
Augusto Mota) che forniscono i docenti. Nell’anno scolastico 2001-2 tutti i 41 alunni
sono stati promossi e il Cepsem è stato Premiato con una borsa di 980R$ dalla Fundaçao Roberto Marino. Il finanziamento delle attività è a carico del CCAP.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
106
della Presidenza della Repubblica) promuovendo diversi interventi in
favela.76
In collaborazione con varie organizzazione giuridiche di Rio de
Janeiro che raggruppano avvocati e istituzioni per la difesa dei diritti
umani, CCAP ha elaborato una Banca dati sugli omicidi dolosi a Rio de
Janeiro e istituito un Servizio di Assistenza Giuridica gratuita coordinato da avvocati e giovani tecnici giuridici e tirocinanti dell’Università
Statale di Rio. Tale servizio, operativo dal 1996, è diretto ptrincipalmente alle donne e ai bambini e in generale alle persone che non riescono ad accedere al potere giudiziario per cultura (il diritto consuetudinario è determinato dal narcotraffico) e per mancanza di danaro
(l’impossibilità di affrontare anche solo i costi dei trasporti pubblici).
L’obiettivo è di educare i favelados alla cultura del diritto e della cittadinanza, sottraendone il monopolio al narcotraffico e agli abusi della
Polizia, e di costringere i poteri pubblici al rispetto dei diritti costituzionali. Mostrando che il potere giudiziario può essere promotore di diritti,
intende costruire organizzazioni della società civile in grado di promuovere nuove relazioni con gli organismi istituzionali e di realizzare azioni di responsabilità civile contro lo Stato per obbligarlo a rispettare le
norme costituzionali.
Compimento di tutte le attività economiche ed educative è stata
l’istituzione di un fondo di solidarietà che articola, dal 2000, attività di
microcredito e di auto-aiuto finanziario con una carta di credito popolare. L’iniziativa rappresenta un’esperienza di economia popolare che
verte sulla solidarietà. Fornendo piccoli crediti a microimprenditori esclusi dal mercato formale, insieme alla formazione in campo economico, finanziario e culturale, intende favorire la cultura del risparmio e
la concentrazione dei consumi all’interno delle favelas. Incentivando
l’associativismo e fornendo strumenti formativi sia tecnici (economia,
76
Un indicatore dell’importanza della attività viene dalle richieste di produrre pubblicità per eventi, commercianti, gruppi sportivi della comunità che costituiscono la principale fonte di sostentamento. La produzione è stata oggetto di interesse da parte di diverse istituzioni. I documentari sono stati esibiti in differenti circostanze, fra cui il Festival “Favela no Cinema” del Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro e São
Paulo); il Congresso Internazionale di Promozione della Salute (Paris): il Centro
Cultural de Ciências e Tecnologia Universidade do Federal do Rio de Janeiro; il festival
di video Hybrid Vídeo Track, a Zurigo (Svizzera).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
107
finanza) sia culturali (identità, autostima, riflessione sulla realtà), mostra le possibilità endogene di miglioramento.77
Questa esperienza rappresenta un modello molto interessante che si
colloca in realtà che non si possono semplicemente considerare marginali, ordinabili e circoscrivibili in ghetti dai confini ben definiti e
conchiusi. Al contrario le favelas di Rio mostrano tutta la loro “centralità” urbana, collocandosi a ridosso delle zone più ricche, come Copacabana, Ipanema, la Barra di Tijuca. Determinano la quotidianità di
tutti i cittadini della metropoli non solo dal punto di vista dell’ordine
pubblico ma anche e soprattutto da quello ecologico, economico, sociale, culturale e politico, sollecitando l’interesse di trovare una soluzione
ai problemi creati dall’esclusione e dalla povertà. Avvertono che l’alto
tenore di vita di cui crede di beneficiare la maggioranza degli abitanti
dei paesi del Nord è strutturalmente legato al malessere delle popolazioni del Sud e da questo minacciato. L’incremento delle spese per acquistare beni e servizi mercantili, va di pari passo con l’aumento degli
“effetti collaterali” dello sviluppo legati al degrado della qualità della
vita in termini di sicurezza, ambiente e salute.78
Laboratori di forme di umanità e di produzione culturale come il
CCAP fanno riflettere sulle possibilità aperte ai “punti di vista dei nativi”, “degli esclusi”, dei “marginalizzati” per costruire visioni e pratiche
innovative per pensare e realizzare le economie, per trattare i bisogni
fondamentali, per formare gruppi sociali. Portano avanti pratiche di
cambiamento sociale, culturale, economico e politico, che si sottraggono ai meccanismi della dipendenza e del dominio.79 Riannodano il filo
di una storia interrotta dalla modernizzazione, dall’industrializzazione e
dall’urbanizzazione selvaggia, riappropriandosi di un’identità culturale
propria e recuperando le tecniche e i saperi tradizionali insieme all’onore perduto. Superano i fallimentari approcci assistenzialistici, i
77
Dopo un anno di attività con 19 cellule, non si era registrato nessun caso di inadempienza nella restituzione del prestiti.
78
Latouche, 2003. Herman Daly ha compilato un indice sintetico, il “Genuine Progress
Indicator” (Gpi) che rettifica il Prodotto interno lordo tenendo conto dei costi dovuti
all’inquinamento e al degrado ambientale. A partire dal 1970, per gli Stati uniti l’indice
del “progresso genuino” è stagnante, o addirittura in regresso, mentre quello del Prodotto interno lordo continua registrare aumenti (Cobb, Halstead, Rowe, 1995a, 1995b).
79
Houtart 2001; Pech, Padis 2004.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
108
frammentari interventi emergenziali e le compassionevoli e contraddittorie azioni umanitarie, a favore di iniziative integrate e multisettoriali
fondate sul protagonismo e le potenzialità alternative delle risorse umane locali. Liberati dai vincoli economicistici e sviluppisti cercano modi
di crescita collettiva che non privilegino un benessere materiale devastante per i legami sociali e per l’ambiente, rompendo con quell’impresa di distruzione che si perpetua in nome dello sviluppo e della globalizzazione. Come sostiene Latouche, sono queste creazioni originali, di
cui possiamo scorgere qua e là qualche fremito iniziale, ad aprire le
porte alla speranza di un dopo-sviluppo.80
80
Latouche, 2001.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
109
Bibliografia
Afwerki I., “Somalia: Outlines of a Succesful Mission”, International Herald Tribune, October
12, 1993.
Agamben G., 1997, Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil.
Agier M, 2001, Aux bords du monde, le réfugiés, Paris, Flammarion.
Amselle J.L., 2001, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion; trad. it. Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
Anheier H., Glasius M., Kaldor M., 2001, (a cura di), Global Civil Society, Oxford University
Press.
Appadurai A., 1996a, Sovereignty without Territoriality. Notes for a Post national Geography,
in Yager P., Geography of Identity, Ann Arbor, University of Michigan Press.
Appadurai A., 1996b, Modernity at large: cultural dimensions of globalization, Minneapolis,
University of Minnesota Press; trad. it. Modernità in polvere, Roma, Meltemi,2001.
Apthorpe R., Krahl A. (edts.), Development studies: a critique and renewal, Leiden, Brill.
Arce, A. e Long, N., 2000, (a cura di), Anthropology, development and modernity, London, Routledge.
Ardener E.,1985, Social anthropology and the decline of modernism in Overing J., Reason and
Morality, London, Tavistock.
Arnfred S., 1998, From quest for civilization to war against poverty. Observations regarding development discourse, in Arnfred, Marcussen 1998.
Arnfred S., Marcussen H.S., 1998, (a cura di), Concepts and Metaphors: Ideologies,
Narratives and Myths in Development Discourse, Occasional Paper no 19, IDS
Roskilde
Asad T., 1973, Anthropology and the colonial encounter, London, Ithaca Press.
Augé M., 1972, “Sous-dévelopment et dévelopment: terrain d’étude et objets d’action en Afrique francophone”, in Africa, 52, pp. 208-215.
Bakhtin M., 1937, Forms of Time and the Chronotype in the Novel, in M. Holquist ((a cura di)),
The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Austin, 1981, pp. 84-258.
Balandier G., 1971, Sens e puissance. Les dynamiques sociales, Paris, PUF (tr. it. Le società
comunicanti. Introduzione all’antropologia dinamista, Bari, Laterza, 1973).
Banaji J., 1970, The Crisis of British Anthropology, in “New Left Review”, 64.
Banca Mondiale, Annual Report, 1997.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
110
Bastide R, 1971, Anthropologie appliquée, Paris, Payot (tr. it. Antropologia applicata, Torino,
Boringhieri, 1975).
Benedict B., 1967, The significance of applied anthropology for anthropological theory,
in Man, 2, pp. 584-592.
Bennet J., Bowen, J., 1988, (a cura di), Production and Autonomy, Lanham, University Press of
America.
Bettati M., 1991, “Un droit d’ingérence?”, Revue générale de droit international public, vol.
95, n°3, pp. 639-669.
Bettati M., Kouchner B., 1987, Le devoir d’ingérence: peut-on les mourir?, Paris, Denoel.
Bhabha H., 1994, The location of culture, London Routledge (trad. it. I luoghi della cultura,
Roma, Meltemi, 2001).
Blanchet K., Les Humanitaires, cibles politiques en Irak, Le Monde 2-3 novembre 2003.
Boli J., Thomas G.M., Constructing World Culture: International Non-governamental Organizations since 1875, Standford, Standford University Press, 1999, p. 28.
Boltanski L., 2000, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media, e politica, Milano,
Cortina Editore.
Bonfil Batalla G. et al., 1982, America Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio, San José, Flacso.
Brauman R., Salignon P., Irak: la posture du missionarie, in Weissmann F. (a cura di), A
l’ombre des guerres justes. L’ordre international cannibale et l’action humanitaire, Paris,
Flammarion, 2003, p. 275
Burton J.W., 1992, Representing Africa: Colonial Anthropology Revisited, Journal of African
and Asian Studies, XXVII, 3-4, pp.181-201.
Cabedoche B., Les Chrétiens et le Tiers-Monde, Paris, Karthala, 1990.
Canclini N.G., 1998, Culture ibride. Strategie per entrare e uscire dalla modernità, Milano,
Guerini e Associati.
Clifford J., 1993, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel XX secolo, Torino, Bollati Boringhieri.
Clifford J., 1997, Routes, Harvard, Harvard University Press (trad. it. Strade, Torino, Bollati
Boringhieri, 2001).
Cobb C., Halstead T., Rowe J., 1995a, “The Genuine Progress Indicator: Summary of Data and
Metodology, Redefining Progress”, in “Atlantic Monthly”, 276, San Francisco, ottobre 1995.
Cobb C., Halstead T., Rowe J., 1995b, “If the Gdp is Up, Why is America Down?”, in “Atlantic Monthly”, 276, San Francisco, ottobre 1995.
Cochrane G., 1979, Development Anthropology, New York, Oxford University Press.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
111
Coertze A., 1978, “Volkekunde, South African, Journal of Ethnology, 1.
Colajanni A., 1994, Problemi di antropologia dei processi di sviluppo, Varese, Editrice
I.S.S.C.O..
Commissione europea, Solidarieté européenne envers les victimes de crises humanitaires, Lussemburgo,Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali della Comunità europea, 2002, p.13.
Crewe E., Harrison E., Whose development? An Ethnography of Aid, London e New
York, Zed Books.
Dalton M., “Changes in Humanitarian Financing: Implications for the United Nations”, ottobre
2003.
Darcy J., “Measuring humanitarian need: A critical review of needs assessment practice and its
influence on resource allocations”, Overseas Development Institute, Humanitarian Policy
Group, febbraio 2003.
Dauvin P., Siméant J. (a cura di), Le travail humanitaire. Les acteurs des ONG, du siège au
terrain, Paris, Presses de Science-Po, 2002, p. 281.
Dauvin P., Siméant J., 2003, Development Iniziatives, Global Humanitarian Assistance Flows,
maggio 2003.
Delavignette R., 1961, Afrique noire française et son destin, Paris.
Dowdney D., 2003, A criança do trafico, Rio de Janeiro, 7 Letra.
Duffield M., Global Governance and the New Wars, London, Zed Books, 2001.
Dumont L., 1993, Saggi sull’individualismo, Milano, Adelphi (ed. orig. 1983).
Escobar A., 1991, “Anthropology and the Development Encounter: The Making and Marketing of Development Anthropology”, American Ethnologist, 18 (4), pp. 16-40.
Escobar A., 1994, “Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture”, Current
Anthropology .
Escobar A., 1995, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World,
Princeton, Princeton University Press (trad. it. parziale in Malighetti R., 2001, pp. 293-308).
Esteva G., 2000, Sviluppo, in Sachs, 2000, pp.347-377.
Fabietti U., 2000, “Il traffico delle culture”, in Fabietti U., Malighetti R., Matera V., 2000, Dal
tribale al globale, Milano, Bruno Mondadori.
Fabietti U., Malighetti R., Matera V., 2000, Dal tribale al globale, Milano, Bruno Mondadori.
Fairhead J., 2000, Development discourse and its subversion: decivilisation, depoliticisation
and dispossession in West Africa, in Arce e Long, 2000.
Faris J., 1973, Pax Britannica in Sudan: S.F. Nadel, in Asad ., 1973, pp.153-172.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
112
Fergusson J., 1990, The Anti-Politics Machine: “Development”, Depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho, Minneapolis, University of Minnesota Press (trad. it. parziale in Malighetti R., 2001, pp.265-274).
Feyerabend P., 1979, Contro il metodo, Feltrinelli (ed. orig. 1975).
Frank A.G., 1969, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New York, Monthly
Review Press (trad.it. Capitalismo e sottosviluppo in America Latina, Torino, Einaudi, 1974).
Gardner K., Lewis D., 1996, Anthropology. Development and the Post-Modern Challenge,
London, Pluto Press.
Georgescu-Roden N., 1995, La décroissance: Entropie-Ecologie-Economie, Sang de la terre,
Paris.
Goddard D., 1969, Limits of British Antrhopology, “New Left Review”, 58.
Gough K., 1968, Anthropology: child of imperialism, in “Monthly Review”, vol. 19, n°11,
April 1968, pp.12-7.
Gras A., 2003, Fragilité de la puissance, Paris, Fayard.
Grillo R., Rew A., 1985, (a cura di), Social Anthropology and Development Policy, London,
Tavistock.
Guidieri R., 1990, Voci da babele, Guida, Napoli.
Gulliver P.H., 1985, An Applied Anthropologist in East Africa during the Colonial Era, in
Grillo R., 1985, pp. 37-57.
Hannerz U., 1992, Cultural Complexity, New York, Columbia University Press (trad.it. La
complessità culturale, Bologna, Il Mulino, 1998).
Harribey J-M., 2002, Una contraddizione irrisolvibile, Le Monde Diplomatique/Il Manifesto,
dicembre 2002.
Hobart M., 1993, (a cura di), Introduction: the growth of ignorance?, in An Anthropological
Critique of Development, London, Routledge, pp.1-30 (trad. it. parziale in Malighetti R., 2001,
pp. 283-292).
Horowitz L., 1980, Taking lives: genocide and State power, New Brunswick.
Hours B., 1998, L’idéologie humanitaire ou le spectacle de l’altérité perdue, Paris, L’Harmattan.
Houtart F., 2001, “Vers une societé civile mondiale: celle d’en haut ou celle d’en bas”, ContreTemps, n°2, settembre 2001, Paris, Edition textuel.
Huizer G., Mannheim B., 1979, The Politics of Anthropology, The Hague, Mouton.
Hymes D., 1969, (a cura di), Reinventing Anthropology, New York, Pantheon.
James W., 1973, The Anthropologist as reluctant Imperialist, in Asad, 1985, pp. 41-70.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
113
Kaldor M., A Decade of Humanitarian Intervention: The Role of Global Civil Society in Anheier,
Glasius, Kaldor.
Khan A.S., Sviluppo sostenibile, un’idea snaturata, Le Monde Diplomatique/Il Manifesto, dicembre 2002.
Kouchner B., 1991, Les malheur des autre, Paris, Odile Jacob.
Latouche S., 1984, Le développement en question, in Tiers Monde, XXV, pp. 25-100.
Latouche S., 1989, L’occidentalisation du monde, Paris, La Découverte (trad. it. L’occidentalizzazione del mondo, Torino, Bollati Boringhieri, 1992).
Latouche S., 1997, L’altra Africa. Tra dono e mercato, Torino, Bollati Borignhieri.
Latouche S., 2001, Sviluppo, una parola da cancellare, Le Monde Diplomatique/Il Manifesto,
maggio 2001.
Latouche S., 2003, Le défi de l’éthique dans une économie mondialisée, Paris, Fayard.
Latouche S., 2003, Per una società della decrescita, Le Monde Diplomatique/Il Manifesto,
maggio 2003.
Latour B., 1990, Somme-nous postmodernes? Non, amodernes! Etapes vers une anthropologie
de la science, in I. U. E. D., La pensée métisse, Paris, Puf.
Leach E.R., 1982, Social Anthropology, London, Fontana.
Leclerc G., 1972, Anthropologie et colonialisme, Paris, Librairie Arthéme Fayard (trad. it. Antropologia e colonialismo, Milano, Jaca Book, 1973).
Lewis D., 1973, “Anthropology and Colonialism”, Current Anthropology, 14 (5), pp. 581-91.
Lobrera J.R., 1975, Some provisional theses on the nature of anthropology, in “Critique of anthropology”, 1, pp. 3-25.
Malighetti R., 2000, Contro il trattore. La necessità di cooperare, in “C&D”, vol. 72, pp.15-23.
Malighetti R., 2001, Antropologia applicata, Milano, Unicopli.
Malighetti R., 2002, Post-colonialismo e post-sviluppo: l’attualità dell’antropologia coloniale,
in Antropologia, pp. 91-114, Roma, Meltemi.
Malinowski B., 1929, Practical Anthropology, in “Africa”, vol. 11, n. 1, pp. 22-38 (trad. it. parziale in Malighetti, R., 2001, pp.59-77).
Malinowski B., 1930, The Rationalization of Anthropology and Administration, in “Africa”,
vol. 3, n. 4, pp.405-430 (trad. it. parziale in Malighetti, R., 2001, pp.78-92).
Malinowski B., 1940, Modern Anthropology and European Rule in Africa, in “Reale Accademia d’Italia”, vol. 18, pp. 880-901 (trad. it. parziale in Malighetti, R., 2001, pp. 93-121).
Malinowski B., 1945, The Dynamics of Culture Change, New Haven, Yale University Press.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
114
Malinowski B., 1938, Methods of study of culture contact in Africa, London, International African Institute (Memorandum XV).
Manganaro M., 1990, Modernist Anthropology, Princeton, Princeton University Press.
Marcon G., 2002, Le ambiguità degli aiuti umanitari, Milano, Feltrinelli.
Mathur H.M., 1990, (a cura di), The Human Dimension of Development. Perspectives from
Anthropology, New Dheli, Concept Pub. Company.
Messica F., Le bonnes affaires de la charité, Paris, Plon, 1989, p.13 (in Piguet 1994, p.77).
Millet D., Toussaint E., 2002, 50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde, Bruxelles-Paris, Syllepse.
Minear L., Smillie I., The Quality of Money, Humanitarianism and War Project, Tufts University, aprile 2003.
Nieuwenhujze, van C.A.O., 1983, Culture and Development. The prospects of an afterthought,
The Hague, Institute of Social Studies.
Okot P’Bitek, 1970, African Religions in Western Scolarship, Nairobi, East African Literaure
Bureau.
Onoge O.F., 1979, “The Counter-Revolutionary Tradition in African States”, in Huizer, Mannheim,1979.
Pandolfi M., 2002, “Moral entrepreneurs”, souverainetés mouvantes et barbelés. La biopolitique dans le Balkans postcommunistes, in Anthropologie et Sociétés, vol. 26, n.1: 29-51.
Pech T., Padis M. O., 2004, Le multinazionali del cuore, Milano, Feltrinelli.
Perrot M.D., Sabelli F., Rist G., 1994, Dérives humanitaires. Etats d’urgence et droit
d’ingérence, Paris, Presses Universitaires de France.
Pigg S.L., 1992, Constructing Social Categories through Place: Social Representations and
Development in Nepal, Comparative Studies in Society and History 34 (3), pp. 491-513.
Piguet F., 1994, Ingérence utile et manipulée, in Perrot, 1994.
Pinter F., Funding Civil Global Society Organizations in Anheier, Glasius, Kaldor, 2001.
Poncelet M., 1994, Une utopie post-tiers-mondiste, Paris, L’Harmattan.
Puligny B., “L’Humanitaire non governemental face a la guerre”, Politique étrangére, 2/200, p.
367.
Rahnema M., Quand la misére chasse la pauvreté, Paris-Arles, Fayand/Ates Sud, 2003.
Remotti F., 1990, Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Torino, Bollati-Boringhieri.
Remotti F., 1993, A ritroso, verso la modernità, Etnoantropologia, 1, 1, 13-34.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
115
Rist G., “Des sphinx, des licornes et autres chimères… Trois approches des relations entre
culture et ‘development’ face aux practiques sociales” in La culture, otage du dévelopment? (a
cura di), Colection de l’Homme et la Société, Paris, L’Harmattan, 1993, pp. 46-98.
Rist G., 1994, Origine de l’idéologie humanitaire et légitimité de l’ingérence, in Perrot,
1994.
Rist G., 1996, Le Développement. Histoire d’une croyance occidentale, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, Paris (trad. it. Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Bollati Boringhieri, Torino, 1997).
Rist G., Sabelli F., 1986, Il était une fois le dévelopment, Lausanne, Editions d’en bas.
Rodney W., 1972, How Europe Underdeveloped Africa, London, Tanzania Publishing House.
Roe E., 1991, Development Narratives of Making the Best of Blueprint Development, “World
development”, 19, n.4, pp.287-300.
Roozen N., der Hoff F., 2003, Max Havelaar. L’avventura del commercio equo e solidale, Milano, Feltrinelli.
Rossetti C.G., 1979, Antropologia del dominio coloniale e sviluppo democratico, Napoli, Liguori Editore.
Sabelli F., 1994, L’ingérence humanitaire entre religion e politique, in Perrot, 1994.
Sachs W., 1992, (a cura di), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge and
Power, London, Zed Books (trad. it. Dizionario dello sviluppo, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2000).
Said E., 1990, Arabesque, “New Statesman and Society”, n.7.
Santino J., Les marchés de la vertu, working paper, Questions on Researches, n. 8 ceri/Sciences-Po, febbraio 2003.
Scholte J.A., Global Civil Society : Changing the World?, Centre for Study of Globalization
and Regionalization, “Working Paper” n. 31/99, Warwick University, maggio 1999.
Scudder T., 1988, The Institute for Development Anthropology, in Bennet e Bowen , 1988, pp.
365-386.
Sinai A., 2002, Povertà e grandi affari, a partire dal Sudafrica, Le Monde Diplomatique/Il Manifesto, dicembre 2002.
Slim H., 1997, “Doing the Right Thing”, in Studies on Emergencies and Disaster Relief, n° 6,
Nordiska Afrikaninsitute.
Sogge D., 2004, Aiuti internazionali: tutto da rifare, Le Monde Diplomatique/Il Manifesto, settembre 2004.
Stavenhagen R., 1968, Las Classes Sociales En Las Sociedades Agrarias, Mexico City, Siglo
XXI (trad. it. Le classi sociali nelle società agrarie, Milano, Feltrinelli, 1971).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
116
Stiglitz J.E., 2002, La Grande Désillusion, Paris, Fayard.
Tommasoli M., 2001, Lo sviluppo partecipativo, Roma, Carrocci.
Traoré A.D., L’oppression du développement, Le Monde diplomatique, settembre 2002.
UNCTAD, Rapporto sui paesi meno avanzati, 2004.
UNDP, 1990, Lo sviluppo umano, Torino, Rosenberg e Sellier.
Ulin R., 1991, “Critical Anthropology Twenty Years Later: Modernism and Post-Modernism
in Anthropology”, Critique of Anthropology, 11 (1), pp. 63-89.
Verhelst T.G., 1990, No life without roots. Culture and development, London, Zed Books.
Whyte W.F., 1991, (ed.), Participatory Action Research, London, Sage.
Yunus M., Il banchiere dei poveri, Milano, Feltrinelli, 1998.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
117
I quaderni del CREAM, 2004 - II
118
MANUELA TASSAN
•
LA CULTURA DELL’AMBIENTE
NELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLA FAO
Fino alla fine degli anni ’70, il concetto di sviluppo non venne mai
messo seriamente in discussione, rappresentando, ormai da tempo, una
certezza nell’immaginario sociale (Escobar, 1995). Gli stessi dependentistas latino-americani si limitarono a proporre un modello alternativo
alla teoria della modernizzazione, senza contestare la validità dello sviluppo in quanto tale (Rist, 1997). Entrambe le prospettive si basavano,
infatti, su una concezione della storia ascensionale e progressiva, di natura teleologica (Colajanni, 1994, p. 33). Opponendosi a questa tradizione, gli studi di Foucault sulle dinamiche del discorso e del potere
nella rappresentazione della realtà sociale hanno, invece, permesso di
relativizzare la presunta portata universale dello sviluppo, riportando in
luce la sua natura di prodotto culturale storicamente determinato (Escobar, 1995, p. 10).
Lo sviluppo , però, non può essere semplicemente considerato come
una forma astratta di ideologia, poiché esiste tangibilmente e può essere
concretamente studiato, nel momento in cui si traduce in un insieme articolato di pratiche promosse da varie istituzioni, fondate su norme e
valori specifici, noto come apparato o configurazione dello sviluppo
(Tommasoli, 2001, p. 23). Le attività che distinguono l’operato di queste istituzioni, tra cui possiamo annoverare la stessa FAO (Food and
Agriculture Organization), non vanno solo a modificare le condizioni
materiali del vivere sociale, ma contribuiscono a veicolare una rap•
Dottoranda in Antropologia culturale presso l’Università degli studi di Milano Bicocca.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
119
presentazione della realtà coerente con le aspettative e i valori del modello culturale dominante. Tale produzione socioculturale (Escobar,
1995, p. 107) può divenire oggetto di indagine antropologica non solo
attraverso la comprensione delle concrete interazioni che avvengono
“sul campo” durante un intervento di mutamento pianificato, ma anche
attraverso un’analisi etnografica dei documenti prodotti dalle istituzioni
stesse. Questa metodologia di ricerca può essere considerata come un
ulteriore strumento per antropologizzare l’Occidente (Rabinow, 1986,
p. 241), mostrando quanto sia peculiare la sua costruzione della realtà.
Secondo gli etnometodologi, infatti, i documenti prodotti dalle organizzazioni vanno interpretati in relazione agli obiettivi e agli usi dell’istituzione, nonché al loro contesto di produzione (Garfinkel, 1967).
Piuttosto che un sistema di azione razionale, la base documentaria rappresenterebbe un modo per oggettivare la conoscenza, rendendo “ovvie” e universali alcune particolari interpretazioni della realtà. Il processo di “iscrizione” degli eventi in una forma testuale non può essere
considerato neutrale, poiché la percezione stessa dei fatti, nonché il
modo di ordinarli significativamente, sono condizionati dallo schema
discorsivo che struttura l’operato dell’istituzione (Escobar, 1995, pp.
108-109).
Dalla prospettiva dell’institutional ethnography (Escobar, 1995),
dunque, più che il contesto dell’azione locale, diventa importante comprendere i “discorsi” veicolati attraverso la produzione di documenti
costruiti in un processo di continua “negoziazione dei significati” (Fabietti, Malighetti, Matera, 2002). Tali testi sono sostanzialmente autoreferenziali, tanto che non sembrano scritti per illuminare un problema
dato, ma per assicurare il loro inserimento in un flusso incessante di testi organizzativi (Escobar, 1995, p. 112). Come osserva giustamente
Escobar, le procedure documentarie rappresentano una dimensione significativa, ma trascurata, nelle analisi critiche di quelle pratiche attraverso le quali il potere viene esercitato nella vita quotidiana (Escobar,
1995, p. 109).
Per l’antropologia, il concetto di cultura rimanda ad un insieme relativamente sistematico ed integrato di istituzioni, valori, credenze, tecniche e costumi posseduto da una società e trasmesso alle generazioni
successive attraverso canali formali o informali. La cultura di un gruppo rappresenta, dunque, un patrimonio collettivo e non individuale e
I quaderni del CREAM, 2004 - II
120
nessuno, in questo senso, può essere definito privo di “cultura” (Fabietti, Malighetti, Matera, 2002; Colajanni, 1994, pp. 20-22). In particolare,
il modo di concepire la natura e di rapportarsi ad essa è parte integrante
di questo patrimonio ed è definito dalle relazioni sociali e dalle strutture
di potere e dominazione. Lo sviluppo, d’altro canto, è il prodotto delle
relazioni di potere tra stati, i quali usando capitale, tecnologia e conoscenza, alterano la cultura e la società di particolari gruppi di persone
(Adams, 1990, p. 83-84). Può essere, quindi, legittimo ipotizzare che
gli interventi attivati da un’istituzione preposta al perseguimento dello
sviluppo interagiscano anche con questo peculiare aspetto della cultura
che è il rapporto con la natura, modificandolo profondamente. Tale
cambiamento non va, però, considerato come un “effetto perverso” delle politiche di sviluppo, ma rappresenta una trasformazione necessaria e
funzionale alla diffusione dello sviluppo stesso, soprattutto quando tali
politiche focalizzano la propria attenzione su un settore come l’agricoltura, attività primaria della FAO, così strettamente connesso con il
mondo naturale. In genere, nelle agenzie di cooperazione, lo sviluppo
viene considerato separatamente dalla cultura, come se fossero due diversi ordini di realtà (Tommasoli, 2001), ma, soprattutto, non viene riconosciuto il significato culturale e simbolico della natura.
Il concetto stesso di “ambiente”, al pari di qualsiasi altra categoria che
permette di ordinare significativamente la realtà, deve essere riconsiderato proprio a partire dall’idea che esprima qualcosa di ovvio, di autoevidente. In particolare, secondo Sachs, la natura si trasforma in “ambiente” quando diventa oggetto di politiche e pianificazione (Sachs,
1998, p. 55) e viene quindi ridotta a premessa non problematica dell’azione. Sotto lo sguardo occidentale, la natura è trasformata in risorsa, in un senso molto diverso da quello che si intravede nell’etimologia
latina della parola, che risale al verbo surgere. In questa accezione originaria la risorsa era intrinsecamente sinonimo di abbondanza, intesa
come qualcosa che “ri-sorge” con continuità (Shiva, 1998). Tale vitalità
e creatività attribuite alla natura si sintetizzano nella definizione, comune a molte culture, di “Terra Madre”, fertile e generosa, fonte di timore e rispetto per l’abbondanza che accorda agli uomini che sottostanno alle sue leggi (Shiva, 2002). Finché venne considerata come un
unico organismo vivente, ogni atto distruttivo contro di essa poté essere
I quaderni del CREAM, 2004 - II
121
condannato come una violazione delle norme etiche di comportamento
(Merchant, 1988, p. 40).
Una netta cesura nel modello organicista si ebbe, nel contesto occidentale, con l’affermazione del dualismo tra spirito e materia (Barbour,
1998; Shiva, 2002), da cui deriva anche la scissione tra cultura e natura.
La metafisica di Cartesio pone le basi della scienza proprio nella distinzione tra sostanza estesa (res extensa) e sostanza pensante (res cogitans): l’ideale scientifico cartesiano scinde, quindi, una concezione meccanicistica del mondo corporeo da una concezione spiritualistica dell’uomo. Questa demarcazione netta tra corpo e anima, se, da una parte,
legittima la costruzione della natura come oggetto della conoscenza
scientifica, dall’altra, la trasforma in “ambiente”, inteso come puro contorno materiale alla centralità dell’uomo “spirituale”, e, quindi, come
qualcosa di totalmente separato dall’uomo stesso (Shiva, 2002).
Il metodo sperimentale di Bacone ha fornito un’ulteriore legittimazione all’interpretazione meccanicistica della natura. Questa, divenuta
materia morta e manipolabile, non viene più percepita olisticamente
come un tutt’uno, ma si frammenta in componenti, comprensibili secondo modelli matematici (Barbour, 1998, p. 87). Si può, dunque, affermare che la storia del concetto di natura è segnata dalla progressiva
divaricazione tra significato scientifico e significato morale: «la natura
reificata, ridotta a mera res extensa, esaurita dalla sola dimensione
quantitativa, resta priva di legami di origine e significato con la soggettività, la res cogitans» (Tallacchini, 1998, p. 11).
L’economia capitalista ha contribuito a legittimare un’immagine
mercificata della natura, trascurando di considerare come importante
ciò che non costituisse una fonte di immediata utilità per l’uomo: le “risorse naturali” sono percepite unicamente come input per la produzione
industriale (Shiva, 1998, p. 261). Un approccio puramente riduzionista
porta a scomporre l’ambiente in una serie di settori liberamente manovrabili, valutati e sfruttati a prescindere dalle interrelazioni che le parti
intrattengono tra loro. Questo tipo di “ambientalismo” rappresenta una
concezione meccanicistica e strumentale che tende a ridurre la natura a
un «deposito di risorse» (Bookchin, 1986, p. 49), dove l’interesse alla
conservazione è subordinato al «valore d’uso» (Pearce, Turner, 1991)
che riveste per le attività umane. La riconcettualizzazione della realtà
come macchina, anziché come organismo vivente, ha decretato la “morI quaderni del CREAM, 2004 - II
122
te della natura” e sancito il dominio incondizionato dell’uomo (Merchant, 1988, p. 42). Le origini filosofiche di questa scissione tra uomo e
natura non bastano però a spiegare la peculiarità che caratterizza la nostra epoca. Le relazioni che l’uomo intrattiene con l’ambiente sono state, infatti, sempre più prepotentemente strutturate dai nuovi ritrovati
della tecnologia occidentale, che, nell’immaginario collettivo, si è costituita come la prova tangibile della superiorità umana sulla natura.
L’ottimismo positivista ha coniato il termine “pianificazione”, ritenendo implicitamente di poter definire a tavolino le modalità del mutamento sociale, legittimando al tempo stesso l’ingerenza del mondo occidentale nei cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo. La pianificazione ridefinisce la vita sociale secondo i criteri e il bagaglio culturale dei pianificatori, nonché la loro idea di razionalità ed efficienza (Escobar, 1998).
Il mutamento storico che si innesca con un intervento di questo genere
non può che essere anche, e necessariamente, un mutamento ecologico.
Dicotomizzare natura e cultura non rende giustizia all’interazione dinamica tra ecosistemi naturali e culturali (Merchant, 1988).
La gestione delle risorse non è certo una novità nella storia dell’uomo. Quello che è nuovo, e che caratterizza l’apparato dello sviluppo, è
l’idea di “gestione scientifica”, attraverso la definizione di modelli, validi ovunque e stabiliti a tavolino dagli esperti occidentali, per mezzo
dei quali si impone implicitamente la propria idea di “ambiente”, definito come oggetto da sfruttare e di cui aumentare la produttività, trascurando il significato culturale che la natura assume presso le popolazioni su cui si desidera attivare un progetto. Ogni intervento sull’ambiente viene considerato come un gesto puramente tecnico, privo di implicazioni ideologiche, mentre, in realtà, le visioni ecologiche introdotte
dalle agenzie di sviluppo interagiscono fortemente con le forme di costruzione dell’identità connesse alle modalità di socializzazione della
natura (Van Aken, 2001, p. 138). Alla base di questi meccanismi di
professionalizzazione e di istituzionalizzazione caratteristici delle grandi agenzie per lo sviluppo vi è una “logica problematizzante”, per cui le
realtà sociali vengono definite unicamente come problemi, ad esempio
la povertà o lo stesso ambiente, e, in quanto tali, richiedono quasi necessariamente una gestione esperta attraverso il ricorso ad un sapere
tecnico in grado di fornire soluzioni specialistiche (Tommasoli, 2001,
p. 83).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
123
Se qualsiasi processo di etichettamento è un atto di valutazione che
coinvolge pregiudizi e stereotipi (Wood, 1985, p. 348), allora l’ambiente può essere considerato come una particolare etichetta tra le molte che
contribuiscono a definire il discorso “sviluppista”, poiché rappresenta
una nozione «costruita per sottrazione di caratteri individuanti» (Tallacchini, 1998, p. 2), che veicola un’immagine della natura funzionale
agli aziendalistici criteri del profitto.
“Ambiente” nasce quindi come nozione avalutativa, vocabolo tecnico che
deve indicare un sapere rigoroso e neutrale sulle tematiche ecologiche, in modo da isolare e definire i contorni di ogni singola questione – inquinamento,
conservazione delle risorse, crescita demografica – evitando le complicazioni
di un approccio globalistico. (Tallacchini, 1998, p. 14)
In una prospettiva utilitaristica, le uniche forme di relazione con
l’ambiente sono l’uso e la gestione: la natura, in un mondo industrializzato, non contribuisce alla rappresentazione identitaria degli attori sociali. Questo assunto, esteso acriticamente a qualsiasi gruppo sociale,
finisce però per trascurare che, a volte, una risorsa naturale può rappresentare un importante connotato sociale che demarca un confine di identità (Van Aken, 2001, p. 137).
La prospettiva gestionale è, dunque, sicuramente, la chiave di lettura
con la quale i sostenitori dello sviluppo hanno interpretato il problematico rapporto tra ambiente e sviluppo. Il managerialismo ambientale
rappresenta, infatti, un approccio costruito sull’idea che una risposta
tecnica, basata su una metodologia quantitativa, sia la risposta più efficace ai problemi ambientali (Zappacosta, 1995, pp. 57-58). Questo tipo
di modalità gestionale, definita «ingegneristica» da Sachs (1998, p. 57)
e Pellizzoni (2001, p. 17), presuppone l’idea che esista un livello ottimale nell’uso delle risorse, per cui il problema diventa il raggiungimento di tale punto di equilibrio attraverso la migliore combinazione di tecnologie disponibili in un dato momento storico (Zappacosta, 1995). Secondo una prospettiva neomalthusiana, infatti, ogni ecosistema può sostenere un numero massimo di individui di una data specie. Superato
tale limite assoluto, espresso dal concetto di carrying capacity, si può
generare, in breve tempo, il collasso dell’intero sistema (Zappacosta,
1995, p. 34). Questa impostazione del problema non sembra tenere, però, adeguatamente conto del fatto che la definizione stessa di tale ipoteI quaderni del CREAM, 2004 - II
124
tico punto di equilibrio rappresenta una scelta arbitraria, fondata su valutazioni caratterizzate da una forte componente soggettiva.
Per cercare di capire se, e come, la FAO abbia contribuito a diffondere tale cultura dell’ambiente e se questa si sia modificata nel tempo, è
stato necessario analizzare come questa istituzione si sia rapportata al
cosiddetto processo di greening dello sviluppo, che ha segnato la progressiva acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza circa il
ruolo dell’ambiente nel cambiamento economico e sociale, fino ad affermare la necessità di integrare questo fattore nella definizione delle
politiche per lo sviluppo (Adams, 1990). Questa graduale trasformazione è cominciata ufficialmente con la Conferenza di Stoccolma del 1972,
primo appuntamento nella storia dell’ecodiplomazia (Ziparo, 1996, p.
62), ed è culminata con il Vertice della Terra di Rio de Janeiro del
1992. In questa occasione, in particolare, si è cercato di dare una definizione operativa del concetto di “sviluppo sostenibile”, attraverso i programmi promossi da Agenda 21, documento programmatico elaborato
con l’intento di fornire un’esaustiva panoramica dei problemi, e delle
relative possibili soluzioni, che si sarebbero dovuti affrontare nel ventunesimo secolo. Rispetto ad eventi di tale portata, la FAO ha dovuto
necessariamente prendere posizione e per questo risultano particolarmente rilevanti ai fini del tipo di analisi proposta.
In queste occasioni di confronto internazionale la risposta trovata ai
problemi della Terra è, comunque, assolutamente “tradizionale”. Secondo Sachs il dibattito si basa sempre su una fondamentale distorsione, poiché si orienta verso un ampliamento gestionale, senza prendere
in considerazione un’intelligente autolimitazione (Sachs, 1998a, p. 56).
Il vero obiettivo non sembra tanto essere proteggere l’ambiente, quanto,
piuttosto, perseguire lo sviluppo, definito come «ciò a cui tutti miriamo
nel tentativo di migliorare la nostra sorte in questa dimora» (Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, 1987, p. 18). In tale accezione del termine “sviluppo” si sottolinea una tensione verso generici
cambiamenti qualitativi, che permette di applicare il concetto tanto ai
paesi considerati più avanzati tanto a quelli definiti “arretrati” (Bresso,
1996, p. 76).
Tale approccio, secondo Ziparo, fa parte di un vero e proprio filone,
da lui definito “Sustainable Growth Management”, che si caratterizza,
dunque, per la sostanziale adesione al modello socio-politico che ha
I quaderni del CREAM, 2004 - II
125
prodotto gli attuali disastri sociali ed ecologici, nonostante l’introduzione di alcuni correttivi. In questa prospettiva, il problema della sostenibilità viene ridotto a questioni di regolazione, che nella sostanza non vanno ad inficiare il presupposto che l’Occidente, con i suoi sistemi politici
democratici e un’economia prevalentemente capitalistica, rappresenti,
oggi, l’unica area geografica caratterizzata da condizioni socioeconomiche “vivibili”. Secondo i sostenitori di questo modello, la risposta al
“problema” della mancanza di sviluppo va affrontata estendendo su
scala planetaria la forma di assetto sociale prevalente (Ziparo, 1996, pp.
60-61).
La fortuna dello “sviluppo sostenibile” è derivata anche da una certa
ambiguità nel suo significato, che ha prodotto diverse interpretazioni.
Sono, comunque, prevalsi due orientamenti fondamentali. Da una parte,
un’accezione “debole” del concetto di “sostenibilità”, secondo la quale
l’elemento rilevante è il solo benessere della specie umana, il cui perseguimento legittima la sostituibilità tra capitale naturale e capitale prodotto. Dall’altra, l’idea di una sostenibilità “forte”, che si basa sulla necessità di lasciare alle generazioni future lo stesso stock di capitale naturale, ritenendolo non rimpiazzabile dal capitale costruito (Bresso, 1996,
p. 79). Per gli ecologisti, tale interpretazione ha sancito l’impegno a rispettare un volume di produzione economica sopportabile per l’ecosistema: quello che va preservato non è tanto lo sviluppo, ma il mantenimento della vita sul pianeta, in tutte le sue forme (Rist, 1997, p. 195).
In un’accezione strettamente economica la sostenibilità viene intesa
come una strategia di massimizzazione della crescita vincolata alla non
diminuzione del capitale produttivo complessivo (Zappacosta, 1995, p.
73). A questo proposito risulta particolarmente significativo un commento pubblicato nel Technical Background Document che ha accompagnato il Report finale del World Food Summit del 1996 in cui si afferma:
There has been considerable progress since 1992 in defining sustainable
development in operational terms. A particularly useful notion is the division
of total capital to be maintained (or enhanced) within and between generations
into four separate components: capital from nature, human capital, institutional
capital and social capital. This concept… accepts that the components may
change in size, so that it is legitimate to allow (in a wise way) capital from nature to be spent in order to build, for example, human or institutional capital…
I quaderni del CREAM, 2004 - II
126
Sustainable agricultural development therefore assumes that actions taken
must enhance the total sum of capital components, even though their relative
proportions may change. (FAO, 1996)
Questa interpretazione rischia, però, di trascurare il fatto che la natura, non è solo fonte di risorse ma, per il solo fatto di esistere, produce
anche una serie di rappresentazioni e di significati, vere e proprie “esternalità culturali”, che possono contribuire a definire, più o meno
consapevolmente, l’identità e la cultura di un gruppo sociale. La natura
possiede, dunque, un “valore aggiunto” difficilmente quantificabile secondo i rigidi canoni economici del mercato. Scialabba (2000), che nella FAO si occupa di agricoltura biologica (organic agriculture nella definizione inglese adottata dall’organizzazione), sottolinea come le varie
risorse non possano essere considerate totalmente sostituibili tra loro.
Vanno più correttamente considerate complementari, poiché la perdita,
anche parziale, di una risorsa naturale non verrà mai pienamente compensata dalla risorsa prodotta dall’uomo. La valutazione della sostenibilità può avvenire facendo riferimento alla somma complessiva delle risorse del sistema solo quando il grado di uso, scambio e commercializzazione delle risorse stesse risulterà commisurato al valore attribuito a
ciascuna, poiché il loro grado di sostituibilità dipende, in ultima istanza,
dall’accettabilità sociale del nuovo equilibrio che si viene a creare.
La FAO, accettando completamente il principio della sostituibilità
tra le risorse, in particolare rispetto allo sviluppo agricolo, conferma,
invece, l’adesione ad un’idea di sostenibilità “debole”, che aveva già
trovato una definizione compiuta e articolata nel concetto di SARD, acronimo di Sustainable Agriculture and Rural Development, nato ufficialmente in occasione della Conferenza su Agricoltura e Ambiente
(Conference on Agriculture and Environment) organizzata dalla stessa
FAO nel 1991 (FAO, 1991) e definito in maniera più precisa nel quattordicesimo capitolo di Agenda 21 (UN, 1992).
Il problema chiave delineato da questo concetto non sembra essere
tanto rendere l’agricoltura compatibile con l’ambiente, quanto piuttosto
creare le condizioni perché quest’ultimo sia in grado di sostenere un
aumento del volume produttivo del comparto agricolo. In quest’ottica,
la protezione dell’ambiente non ha un valore intrinseco ma è funzionale
al mantenimento, e al potenziamento, della base fisica necessaria a rispondere alle esigenze alimentari di una popolazione costantemente in
I quaderni del CREAM, 2004 - II
127
aumento. È la FAO stessa a precisare che le risorse naturali «are used
and managed by people to safeguard their well-being, not simply for the
sake of conservation» (FAO, 1992, corsivo nostro).
Una delle prime critiche a questo tipo di impostazione del problema
risale al lontano 1949, quando Aldo Leopold, naturalista americano,
propose il concetto di land ethic, proprio per affermare la necessità di
tutelare qualsiasi membro della “comunità biotica”, a prescindere dal
suo potenziale valore economico, poiché solo in questo modo è possibile garantire l’integrità, e quindi la stabilità, della Terra (Leopold, 1998,
p. 135). La posizione di Leopold finisce per avere, comunque, ricadute
positive anche sull’uomo, che di questa “comunità biotica” fa evidentemente parte e del cui equilibrio non può che giovarsi. A queste considerazioni di ordine prettamente ecologico si affianca, oggi, anche il riconoscimento di altri valori, che «esistono nella natura stessa dell’oggetto e che non sono associati al loro uso attuale o a quello potenziale»
e che per questo sono detti “intrinseci” o “di esistenza”: il diritto ad esistere di una specie minacciata così come di un intero ecosistema, in
quest’ottica, prescinde dal beneficio che ne può trarre l’essere umano
(Pearce, Turner, 1991, p. 136).
La sostenibilità, nozione contraddittoria e al tempo stesso pregnante,
diventa, comunque, un frame da cui è impossibile prescindere per
chiunque intenda affrontare le problematiche connesse al conflittuale
rapporto tra ambiente e sviluppo. Tutte le grandi agenzie internazionali,
come la FAO, sono state costrette a rivedere i propri obiettivi e le proprie pratiche alla luce di questa nuova parola-chiave. L’adozione diffusa del concetto di “sviluppo sostenibile” sembrava garantire l’effettiva
realizzazione di un processo di greening delle istituzioni di assistenza
allo sviluppo. Rimane da chiedersi, però, quanto tale processo di internalizzazione delle problematiche ambientali sia sintomo di reale cambiamento o rappresenti solo una sottile modifica del linguaggio (Zappacosta, 1995, pp. 71-72). Lo sviluppo non può, infatti, svincolarsi dai
concetti fondamentali che lo definiscono, cioè “crescita” “evoluzione”,
“maturazione” (Esteva, 1998) e, quindi, per quanto “aggettivato”, qualificandolo come “sostenibile”, in modo da indicare la compatibilità tra
attività economiche e ambiente naturale (Bresso, 1996), la sua portata
innovativa non potrà mai essere radicale. Per Esteva, “l’invenzione”
dello “sviluppo sostenibile” è solo un modo per sostenere lo “sviluppo”
I quaderni del CREAM, 2004 - II
128
stesso, cooptando all’interno di questo regime discorsivo ogni forma di
dissenso (Esteva, 1998). La logica del “produttivismo” competitivo rimane indiscussa, mentre ci si muove verso nuovi livelli di controllo e
monitoraggio amministrativo (Sachs, 1998), comportandosi «come se»
(Rist, 1997, p. 232) fosse davvero possibile per il pianeta sopportare nel
Sud del mondo lo stesso consumismo, e gli stessi rifiuti, del Nord
(Sachs, 1998).
A questo proposito, la posizione della FAO non lascia dubbi:
sustainable development in developing countries should therefore be
sought within an overall framework of growth so that the development measures adopted can maintain a momentum towards the goal of a more effective,
stable and productive agricultural sector. (FAO, 1992, corsivo nostro)
Il primato della crescita economica e la soluzione gestionale proposti dalla Commissione Bruntland erano elementi già consolidati da quarant’anni di impegno nel campo dello sviluppo. Adottato ufficialmente
dalla FAO nel 1989, il concetto di “sviluppo sostenibile” ricalca quasi
testualmente la definizione proposta in Our Common Future:
…the management and conservation of the natural resource base, and the
orientation of technological and institutional change, in such a manner as to
ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present
and future generations… (FAO, 1992, corsivo nostro)
L’analisi della documentazione prodotta in occasione dei vari incontri promossi dall’ecodiplomazia internazionale ha evidenziato come, in
realtà, non sia corretto chiedersi quanto la FAO abbia modificato la sua
cultura dell’ambiente in rapporto agli stimoli provenienti dal dibattito
internazionale, poiché è proprio in queste occasioni di confronto che
continua ad essere promosso un approccio puramente gestionale alle
problematiche inerenti il complesso rapporto tra ambiente e sviluppo.
Il managerialismo ambientale, funzionale alle esigenze produttive e
basato su un’ottica fortemente antropocentrica, ha contribuito a ridefinire profondamente le caratteristiche del comparto agricolo. La grande
espansione demografica che si verificò nel secondo dopoguerra venne
malthusianamente interpretata come un importante fattore di rischio per
l’equilibrio tra uomo e risorse: la natura sembrava non essere più in
grado di provvedere al sostentamento di tutti gli abitanti del pianeta. La
I quaderni del CREAM, 2004 - II
129
sua “inefficienza” divenne un concetto quasi assiomatico così come la
necessità di migliorarla, ottimizzandone la produttività attraverso una
serie di pratiche innovative, come l’impiego di fertilizzanti e pesticidi
abbinato a sementi selezionate in laboratorio. L’impatto di questi cambiamenti sulla produzione agricola, in particolare in India, fu straordinario ed ebbe grande risonanza sia nell’opinione pubblica, sia tra gli
addetti ai lavori, tanto che nel 1968 un amministratore della U.S. Agency for International Development (USAID) scrisse nel suo rapporto
annuale che sembrava di assistere ad una “Green Revolution” (Borlaug, 2002), termine con il quale si è soliti designare ancora oggi il processo di modernizzazione dell’agricoltura.
Non si vuole certo affermare che l’uomo, da essere “innocente”, si
sia improvvisamente macchiato di una “colpa” fino ad allora sconosciuta: ogni singola selezione vegetale attuata dai coltivatori attraverso gli
innesti delle piante o la ricerca di nuove razze animali, effettuata grazie
a progressivi incroci, sono tutti elementi che testimoniano come, specialmente nel settore agricolo, la manipolazione della natura sia sempre
stata una componente essenziale della vita umana. Tali usi progettati di
fenomeni biologici (Cerroni, Borrelli, 2003, p. 148) hanno permesso
all’uomo di tentare di trarre dalle componenti naturali il maggior beneficio possibile.
Non c’è, dunque, davvero nessuna differenza tra l’agricoltura “non
sviluppata” e il moderno “agro-business” o più in generale tra i due modi di rapportarsi alla natura che presuppongono? La risposta ovviamente non è né univoca, né universale, ma merita una certa attenzione.
Si potrebbe, forse, affermare che l’agricoltura “tradizionale”, i cui
saperi sono fortemente contestualizzati, mirava a migliorare la resa delle potenzialità offerte dalla natura, manipolandola, sì, ma ex post, in un
processo di progressivo adattamento alle esigenze imposte dall’esterno.
Non bisogna dimenticare, poi, i molteplici significati culturali associati
a particolari varietà vegetali, la cui importanza può essere solo relativamente, o per nulla, legata alla produttività (Van Aken, 2001).
Quando la genetica, sapere che si propone come oggettivo e universalmente applicabile, fa la sua comparsa nel mondo agricolo, questo
schema pare ribaltarsi: la manipolazione della natura avviene ex ante,
dentro le mura di un laboratorio, senza che l’esperimento abbia l’effettiva possibilità di rapportarsi al contesto naturale in cui verrà inserito
I quaderni del CREAM, 2004 - II
130
(Carson, 1963). La natura non viene semplicemente manipolata, ma
piuttosto ricreata secondo parametri umani, primo fra tutti l’efficienza,
termine economico che, applicato al settore agricolo, determina una
certa ambiguità, richiamando più le esigenze del profitto che quelle della sussistenza.
La FAO (1996), abbastanza recentemente, ha definito la Rivoluzione Verde come «a technology package», sottolineando la necessità di
fornire, insieme alle varietà di semi selezionate geneticamente, un complesso di input quali concimi, antiparassitari, erbicidi, acqua d’irrigazione, macchinari tecnologicamente avanzati. Tali input, se utilizzati
singolarmente, hanno effetti trascurabili se non addirittura negativi,
mentre se impiegati contemporaneamente manifestano effettivamente
una forte sinergia, garantendo una superiorità produttiva. D’altro canto,
il venir meno, di anche uno solo di essi rende frequentemente le varietà
selezionate molto meno produttive di quelle tradizionali (Zappacosta,
1995, p. 120), poiché gli alti rendimenti non sono intrinseci ai semi
modificati, ma sono subordinati alla disponibilità degli input necessari
(Shiva, 2001, p. 45), per cui è evidente che l’esclusione dalla Rivoluzione Verde di regioni meno dotate di risorse e particolarmente povere
non è stata una tendenza tacita o non voluta, ma ha rappresentato piuttosto una selezione necessaria (Shiva, 2002; Zappacosta, 1995).
La Rivoluzione Verde ha, dunque, cercato di risolvere l’inefficienza
della natura promuovendo delle pratiche agricole che fossero in grado
di garantire più raccolto su un’estensione minore di terra, aumentando
la produttività dell’agricoltura. Si è verificata, però, una situazione quasi paradossale, per cui queste innovazioni, presentate come chiave per
sconfiggere la fame nelle aree più svantaggiate del pianeta, hanno finito
per avvantaggiare, invece, quelle regioni la cui situazione di partenza
già presentava delle caratteristiche più favorevoli sia sotto il profilo
ambientale che economico, aspetto fondamentale dato il notevole costo
degli input. Le nuove tecnologie agricole non hanno rimesso in discussione la distribuzione, altamente concentrata, del potere economico,
specialmente rispetto all’accesso alla terra. L’aumento nel volume complessivo di cibo prodotto non sembra corrispondere ad un affettivo e
proporzionale miglioramento nella sicurezza alimentare (Rosset, Collins, Moore Lappé, 2000).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
131
La riflessione intorno al concetto di sostenibilità, pur con tutti i suoi
limiti, ha, comunque, permesso di evidenziare molte problematiche a
lungo trascurate. Come sottolineato in un articolo apparso nel 1993 su
Ceres, una pubblicazione bimestrale della FAO, i delegati che nel 1992
parteciparono alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo
were forced to admit that crop yields are stagnating or even declining in many
countries, rural poverty is increasing and the natural resource base in far too
much of the world is being seriously degraded. (Haverkort B. et al., Ceres 144,
1993)
Il pacchetto tecnologico della Rivoluzione Verde aveva condotto ad
una situazione difficilmente conciliabile con l’agricoltura sostenibile e
lo sviluppo rurale promossi a Rio de Janeiro. È proprio in questa sede
che venne, infatti, affermata ufficialmente la necessità di attuare aggiustamenti in campo agricolo, ambientale e macroeconomico in vista di
questi nuovi obiettivi (Haverkort B. et al., Ceres 144, 1993).
L’utilizzo della biotecnologia in agricoltura, punto focale
dell’auspicata Seconda Rivoluzione Verde, sostenuta dalla FAO, oggi
rappresenta il naturale proseguimento di questo percorso, senza che vi
sia discontinuità alcuna rispetto al sistema di pensiero che aveva legittimato i metodi della Prima Rivoluzione Verde, portandolo piuttosto alle
estreme conseguenze: inizialmente si dipendeva dal materiale ereditario
per ottenere vantaggi genetici, con la Nuova Rivoluzione Verde si utilizzano, invece, nuove fonti di materiale ereditario per aumentare la
produttività attraverso la manipolazione genetica.
Secondo Donna Haraway (1991) siamo in presenza di una forma di
Reinvenzione Postmoderna della Natura, cioè un nuovo regime discorsivo in cui viene legittimata la costruzione della natura attraverso le più
diverse biopratiche, possibili grazie alle nuove forme di scienza e
tecnologia. Rifkin (1998) si serve di un neologismo, la parola algenia,
per indicare la biotecnologia, pensata come una sorta di nuova alchimia
in grado di cambiare l’essenza della natura. L’algenia rappresenterebbe
il tentativo di realizzare la perfezione della natura attraverso una
seconda genesi artificiale della natura stessa, delle cui conseguenze non
siamo pienamente consapevoli (Cerroni, 2003).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
132
La tutela della natura è spesso posta dal il paradigma dominante in
contrasto con il soddisfacimento dei più elementari diritti umani, tra
cui, ovviamente, quello ad un’alimentazione adeguata. Proponendo un
tale conflitto tra le esigenze dell’uomo e quelle della natura è evidente
che gli squilibri ecologici causati dalla Rivoluzione Verde diventano
giustificabili in nome di un più alto obiettivo, quale è la sconfitta della
fame nel mondo. Tale prospettiva, però, non può essere considerata oggettiva e ovvia, perché pratiche troppo “aggressive” vanno a minare la
produttività complessiva della natura, ripercuotendosi, in ultima istanza, sull’uomo stesso. Le grandi potenzialità offerte dalle nuove specializzazioni del sapere scientifico hanno creato l’illusione di un controllo
totale sui processi naturali, sottovalutando, spesso, le conseguenze a
medio e lungo termine di alcune scelte dettate dall’entusiasmo suscitato
da nuove scoperte. Come osserva giustamente Shiva, «sulla base dell’assunto che la natura è inefficiente, ne stiamo rapidamente minando la
produttività» (Shiva, 2002, p. 155).
Agenda 21 ha avuto il pregio di definire un framework di riferimento che, pur non essendo vincolante, ha stabilito nel dibattito su ambiente
e sviluppo delle priorità non più trascurabili. Aumentare le capacità
produttive di un territorio non è un elemento sufficiente per stabilire la
riuscita di un intervento: ciò che diventa importante è mantenere le
condizioni della riproducibilità nel tempo del sistema considerato, sia
sotto il profilo ambientale che sociale. Osservando il problema dalla
prospettiva della più recente economia dell’ambiente, l’utilizzo di tali
tecniche agricole di tipo capital-intensive crea anche un’evidente distorsione nel mercato, perché la produzione si basa su un’esternalizzazione di costi sociali e ambientali che non vengono contabilizzati,
gonfiando artificialmente anche l’effettiva portata dei profitti.
Il dibattito sulla questione è divenuto prioritario, anche all’interno
della FAO, proprio all’indomani del Vertice della Terra di Rio de Janeiro. Nel 1995, su Ceres n.154 vengono raccolte tutte le posizioni più autorevoli e rappresentative in materia, il che sottolinea l’importante ruolo
di questa organizzazione come forum di confronto, anche mediatico, su
questioni di grande rilevanza. Nonostante il quadro sia piuttosto complesso e vi siano molte sfaccettature diverse nelle argomentazioni, si
possono comunque individuare due posizioni fondamentali: da un lato,
coloro che ritengono sia solo necessario riformare dall’interno le carenI quaderni del CREAM, 2004 - II
133
ze dimostrate da un paradigma sostanzialmente valido, che anzi, pur
con le dovute modifiche, merita di essere riproposto come “New Green
Revolution”; dall’altro, coloro che ne criticano radicalmente le premesse teoriche e culturali, auspicando un vero e proprio “cambio di paradigma” che possa aprire la strada ad una “Real Green Revolution”, basata non solo su un globale ripensamento del rapporto uomo-natura, ma
anche su una revisione nella gerarchia dei saperi, ridiscutendo la centralità della scienza occidentale.
Il cauto riformismo proposto dai sostenitori della Rivoluzione Verde
è sicuramente più consono alla linea tenuta dalla FAO in merito a questo fenomeno, essendo stata fin dall’inizio tra i più decisi promotori di
questa tipologia di rinnovamento in agricoltura. Non bisogna dimenticare che la Rivoluzione Verde discende direttamente dal paradigma
“sviluppista” e ne condivide gli aspetti fondamentali, come la centralità
accordata alla crescita economica, il tecnicismo, la superiorità della
scienza occidentale e dei suoi esperti: tutte caratteristiche che hanno segnato anche l’esperienza della FAO.
Il World Food Summit del 1996 è stato un momento fondamentale
per definire alcuni elementi chiave nel dibattito su agricoltura, ambiente
e sviluppo, ma anche per rielaborare in maniera propositiva, ma sostanzialmente coerente con il passato, le istanze critiche formulate in occasione del Vertice di Rio, che rischiavano di mettere in discussione in
maniera troppo radicale l’operato dell’organizzazione. In questa occasione la FAO auspica apertamente un’evoluzione del paradigma originario che sappia raccogliere le sfide lanciate dall’ecologia e dalle scienze sociali, mobilitate nella critica all’approccio settoriale e tecnocratico
della Prima Rivoluzione Verde (FAO, 1996). Al centro del dibattito rimane la necessità di avviare «the rapid transfer of appropriate and new
technology», tra le quali le più rilevanti e innovative sono proprio le
tanto controverse biotecnologie (FAO, 1996, Punto 5,7).
Nadia Scialabba, osserva, invece, che «sustainable agriculture development needs a paradigm shift from segregation to integration, that is
a move from focusing on single, isolated parts of agricultural systems
(disciplinary reductionism) to perceiving all parts in their full context
(interdisciplinary holism)» (Scialabba, 2000, corsivo nostro). In linea
con queste posizioni, Miguel Altieri ritiene che il concetto di agricoltura sostenibile potrebbe rivelarsi utile solo se prima l’agricoltura stessa
I quaderni del CREAM, 2004 - II
134
venisse correttamente interpretata come risultato della “co-evoluzione”
del sistema socioeconomico e dei sistemi naturali. Una più vasta comprensione del contesto agricolo richiede uno studio più approfondito
delle relazioni che intercorrono tra le pratiche agricole, l’ambiente e i
sistemi sociali, mentre si tende sempre a privilegiare la valutazione delle componenti tecnologiche. Perché venga soddisfatta l’esigenza di garantire la sicurezza alimentare, conservando al tempo stesso la base di
risorse naturali, è necessario non solo attuare profondi cambiamenti
nelle strategie d’azione, ma rivoluzionare completamente il tradizionale
approccio allo sviluppo rurale (Altieri, 1995, Ceres 154).
A questo proposito, sia Scialabba che Altieri, seppur in forme diverse, sostengono le potenzialità dell’agricoltura biologica non solo come
possibilità di coprire una marginale nicchia di mercato, ma anche di attuare un vero e proprio cambio di paradigma che permetterà “the Real
Green Revolution” (Parrott, Marsden, 2002). La peculiarità di questo
approccio vuole essere, prima di tutto, culturale, poiché si propone un
più globale ripensamento proprio del modo di rapportarsi alla natura e,
di conseguenza, all’agricoltura.
La natura deve essere considerata, al tempo stesso, instrument and
aim (Scialabba, Hattam, 2002, Capitolo 2) e al coltivatore è, quindi, richiesta una strategia preventiva, ex-ante (Zappacosta, 1995), volta a
massimizzare la stabilità complessiva dell’agroecosistema, molto diversa da una strategia sintomatica di correzione, ex-post, caratteristica della prospettiva manageriale (Zappacosta, 1995). La sola eliminazione
degli inputs sintetici non consente di definire “organico” un modello
agricolo, essendo necessario avviare anche una serie di attività sinergicamente connesse tra loro, secondo un approccio olistico e sistemico, in
assenza del quale si può incorrere in un’effettiva diminuzione dei livelli
di produttività ed accelerare una degradazione complessiva dell’ambiente (Scialabba, Hattam, 2002). I metodi organici non vogliono semplicemente offrire garanzie sulla qualità di una merce, ma proporre
piuttosto una revisione dell’intero ciclo produttivo, come riconosciuto
dalla stessa FAO, che afferma: «organic is a process claim rather than a
product claim» (FAO, 1999a, corsivo nell’originale). L’ecosistema rappresenta il principale “input” produttivo, per questo è necessario «to
work with nature to protect crops, rather than to submit to or subdue it»
(Scialabba, Hattam, 2002, Capitolo 1, corsivo nostro).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
135
Allevamento degli animali e coltivazione di diverse tipologie di
piante sono considerati ugualmente importanti perché parte di un ciclo
virtuoso che arricchisce la biodiversità e diversifica la produzione, in
netto contrasto con le monoculture della Rivoluzione Verde che avevano portato a separare nettamente queste due attività. Secondo l’IFOAM,
International Federation of Organic Agriculture Movements, il principale obiettivo dell’agricoltura biologica è gestire, secondo un approccio”bio-intensive” piuttosto che “chemio-intensive”, un’azienda agricola diversificata, ma considerata come fosse un organismo vivente,
un’entità individuale, all’interno di un sistema chiuso (FAO/IFOAM,
1998, p. 6,7). Hervé La Prairie, che dell’IFOAM era presidente, evidenziò come l’agricoltura biologica «cannot be considered only as a technique, but as a whole way of living and a means to increase food and
quality of life» (IFOAM/FAO, 1998, p. 4). Risulta, dunque, particolarmente felice la scelta di Scialabba e Hattam, che l’hanno definita «new
agrarian ethic» (Scialabba, Hattam, 2002, Abstract, corsivo nostro).
Fino agli anni ‘90 la FAO non si era mai pronunciata ufficialmente
in materia, sostanzialmente disinteressandosi del fenomeno. Le critiche
espresse nel corso del Summit di Rio de Janeiro avevano rischiato, però, di incrinare l’immagine di questa istituzione, che, nelle sue attività
aveva sempre dato pieno sostegno ai metodi, ora sotto accusa, della Rivoluzione Verde. Il tentativo di avvicinamento dell’IFOAM, avvenuto
proprio in questa occasione, venne accolto, quindi, favorevolmente, sia
pure con una certa cautela. I sostenitori dell’agricoltura biologica speravano, infatti, che il coinvolgimento diretto da parte di importanti agenzie internazionali, prima fra tutte la FAO, portasse al riconoscimento del grande potenziale di questo approccio alternativo nel risolvere
una serie di problemi fortemente interrelati tra loro, in modo che, a lungo termine, anche gli stati nazionali si sentissero incentivati a promuoverne la diffusione (Parrott, Marsden, 2002, p. 99). La FAO, da parte
sua, attraverso questa collaborazione, ebbe l’occasione per estendere la
sua funzione normativa anche su questo settore, inizialmente trascurato,
aumentando il proprio prestigio e migliorando la sua immagine internazionale.
In generale, la centralità assunta dai risvolti economici dell’agricoltura biologica ha portato a trascurare completamente le più profonde
motivazioni etiche e sociali di questo approccio. Molti sostenitori del
I quaderni del CREAM, 2004 - II
136
biologico, infatti, rifiutano non solo un sistema agricolo, ma un intero
modello culturale, quello stesso modello, basato sulla centralità della
produttività e del profitto, che ha legittimato i metodi della Rivoluzione
Verde (Shiva, 1998, 2001, 2002). La FAO, ovviamente, non raccoglie
queste istanze più critiche, limitandosi a considerarla come «one of the
alternatives for sustainable agriculture» (FAO/IFOAM, 1998, p. 4).
Non un cambio di paradigma, dunque, ma solo una delle possibilità per
ottemperare alle nuove esigenze ambientali espresse a Rio de Janeiro.
Questo nuovo approccio, infatti, non viene proposto tanto come strumento veramente innovativo, in grado di garantire direttamente il sostentamento della popolazione tramite una produzione alimentare sostenibile e di qualità, ma come un’opportunità che solo indirettamente
garantisce la sicurezza alimentare, poiché permette ai produttori di avere a disposizione un surplus di reddito, derivante dai prezzi maggiorati
dei prodotti biologici, che può essere speso nell’acquisto di cibo. La sicurezza alimentare, infatti, non è necessariamente equiparata ad una
forma di autosufficienza, ma può essere garantita anche attraverso delle
entrate adeguate che permettano l’acquisto di beni primari.
Il processo di istituzionalizzazione dell’agricoltura biologica può essere, dunque, interpretato come una forma di cooptazione del dissenso
entro strategie d’azione consolidate, basate su standards restrittivi, funzionali alle esigenze del mercato. La burocratica definizione di regole e
procedure diventa l’aspetto prioritario, contribuendo a legittimare, in
questo modo, l’esistenza stessa di una grande istituzione internazionale
come la FAO, preposta al ruolo di garante imparziale, nonostante il suo
operato sia evidentemente coerente rispetto al dominante paradigma
“sviluppista”, di stampo occidentale. L’agricoltura biologica si riduce a
mero problema tecnico, senza che venga colta la radicale alterità di
questa prospettiva olistica, basata sulla stretta interconnessione tra uomo e natura. La FAO, quindi, sembra concepire questo approccio come
un insieme di strategie gestionali, che, utilizzate contemporaneamente,
garantiscono i benefici di un marchio distintivo sul mercato, ma che, in
alternativa, possono essere anche combinate con i metodi convenzionali.
La certificazione dei prodotti rappresenta, dunque, un momento
molto delicato e importante, perché è solo attraverso questo strumento
che si può garantire un incremento nel valore del prodotto organico,
premiato dal prezzo di vendita, ma può anche costituire una barriera inI quaderni del CREAM, 2004 - II
137
sormontabile all’ingresso nel mercato di molti produttori. Secondo la
FAO, il riconoscimento internazionale del suo Codex Alimentarius
Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of
Biologically Produced Foods, approvato nel giugno 1999, poi aggiornato nel 2002, permetterebbe di stabilire un’equivalenza tra gli standards
delle diverse nazioni, armonizzando la situazione internazionale (FAO,
2000).
Una maggiore omogeneità nelle regole ha, certo, risvolti positivi,
ma, in generale, equiparare la risoluzione delle problematiche ambientali alla sola definizione di limiti e standards comuni non è sufficiente,
né auspicabile. L’ambiente, secondo questo approccio, continuerebbe
ad essere riproposto solo come problema tecnico di competenza degli
esperti, privo di implicazioni sociali e culturali più profonde. Secondo
Bresso il mondo occidentale è vittima di un’assuefazione perversa alla
dominanza assoluta del prodotto interno lordo, di cui occorre liberarsi
prima di tutto sul piano culturale. La sfida della sostenibilità non si gioca, quindi, solo sul piano economico-produttivo, ma implica, soprattutto, una modifica profonda della cultura e degli stili di vita, cioè delle
relazioni che si stabiliscono tra gli uomini e tra questi e il resto del
mondo vivente. L’obiettivo deve essere, dunque, costruire un sapere
condiviso, meno funzionale alla produzione di beni e più attento ad assicurare il consolidamento di relazioni simmetriche tra tutti le componenti dell’ecosistema (Bresso, 1996, p. 82). In questo modo si realizza
quella “sostenibilità forte” che non significa solo garantire ai posteri un
livello di benessere materiale pari a quello sperimentato nel momento
attuale, come afferma chi sostiene un’idea “debole” di sostenibilità, ma
significa, soprattutto, allargare il concetto di “responsabilità” alle altre
specie viventi, riconoscendone anche il solo valore di esistenza (Bresso,
1996, p. 79). Non si vuole negare l’importanza di attuare opportuni approfondimenti su aspetti particolari di questa complessa problematica,
ma la divisione dell’ambiente in singoli settori di intervento, focalizzando l’attenzione separatamente su acqua, suolo o foreste, legittima
un’immagine frammentaria di ciò che, invece, è intrinsecamente un
tutt’uno, comprendente anche l’uomo stesso.
L’artificiosa separazione tra uomo e natura non permette di cogliere
allo sguardo “disincantato” (Latouche, 1999) dell’esperto occidentale
l’importanza che talune categorie ecologiche assumono nella cultura di
I quaderni del CREAM, 2004 - II
138
molti gruppi sociali (Van Aken, 2001). A questo proposito il sapere antropologico potrebbe offrire un contributo interessante per capire i significati attribuiti dalle persone al mondo naturale di cui hanno esperienza, analizzando anche come tali categorie ecologiche, nel contatto
forzato che avviene durante un progetto di sviluppo, si trasformino in
seguito all’influenza esercitata dalle categorie della scienza occidentale,
che trasforma la “natura” nel neutro e funzionale concetto di “ambiente”. L’obiettivo pare essere, dunque, la ricerca di un equilibrio parziale,
in continua ridefinizione, tra le regole imposte dall’ecomanagement
globale e la considerazione delle peculiarità culturali e ambientali dei
singoli contesti locali. Non bisogna, infatti, dimenticare che la definizione di limiti e standards si basa su valutazioni che hanno un’ineliminabile componente soggettiva, in quanto ogni esperto è in grado di
vedere solo quello che il suo paradigma teorico gli permette di considerare rilevante. I problemi, anche se definibili in termini scientifici, non
possono essere risolti esclusivamente entro tale ambito. Le questioni ambientali, infatti, sono il prodotto di un’intricata e complessa rete di relazioni tra fenomeni fisici e azioni antropiche (De Marchi, 2001, p. 68).
Bibliografia
Adams W.M., 1990, Green development. Environment and sustainability in the Third World,
London, New York, Routledge.
Altieri M., 1995, Escaping the treadmill, in Ceres 154, The green revolution revisited: new
needs, new strategies, vol.27, n. 4.
http://www.fao.org/docrep/v6640e/v6640e00.htm
Barbour I. G., 1998, Ambiente e Uomo, in Tallacchini M. (a cura di), Etiche della terra, Milano, Vita e Pensiero (ed. or. 1978, Environment and Man, in Warren T, Reich (ed. in chief)
The Encyclopedia of Bioethics, New York-London, The Free Press, Collier Mac Nillan, pp.
366-74).
Borlaug N., 1970, Nobel Lecture, “The Green Revolution: Peace and Humanity”
http://www.nobel.se/peace/laureates/1970/borlaug-lecture.html
I quaderni del CREAM, 2004 - II
139
Bookchin M., 1986, L’ecologia della libertà, Milano, Elèuthera (ed. or. Palo Alto, 1982).
Bresso M., 1996, Per un’economia ecologica, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
Carson R., 1963, Primavera silenziosa, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1962, Silent Spring, Boston,
Houghton Mifflin Company).
Cerroni A., Borrelli E., 2003, Il codice del futuro. Per una sociologia del vivente dopo la rivoluzione biotecnologia, Bologna, FrancoAngeli.
Colajanni A., 1994, Problemi di antropologia dei processi di sviluppo, Varese, I.S.S.CO.
Collinson M.,1995, Green Evolution, da Ceres 154, The green revolution revisited: new needs,
new strategies, vol. 27, n. 4.
http://www.fao.org/docrep/v6640e/v6640e00.htm
Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, 1988, Il futuro di noi tutti. Rapporto
della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, Milano, Bompiani. (ed. or. 1987,
World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford, Oxford
University Press).
Escobar A., 1995, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World,
Princeton, Princeton University Press.
Escobar A., 1998, Pianificazione, in Sachs W. (a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino,
Edizioni Gruppo Abele (ed. or. 1992, The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as
Power, London, Zed Books)
Esteva A., 1998, Sviluppo in Sachs W. (a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino, Edizioni
Gruppo Abele (ed. or. 1992, The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as Power,
London, Zed Books).
Fabietti U., Malighetti R., Matera V., 2002, Dal tribale al globale. Introduzione all’Antropologia, Milano, Bruno Mondadori.
FAO, 1991a, FAO/Netherlands Conference on Agriculture and the Environment.
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/EPdirect/EPre0023.htm
FAO, 1991b, The Den Bosch Declaration on Sustainable Agriculture and Rural Development.
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/EPdirect/epre0024.htm
FAO, 1992, Sustainable development and the environment. FAO policies and actions Stockholm 1972-Rio 1992.
http://www.fao.org/docrep/U7260E/U7260E00
FAO, 1996, World Food Summit, Technical background document, Lessons from the green
revolution: Towards a new green revolution.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
140
http://www.fao.org/docrep/003/w2612e/w2612e6a.htm
http://www.fao.org/docrep/003/w2612e/w2612e06a.htm#2
FAO,1999, Committee on Agriculture, Fifteenth Session, Organic Agriculture.
http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/X0075E.htm
FAO, 2000, FAO Perspectives on Future Challenges for the Organic Agriculture Movement.
13th IFOAM Scientific Conference: The World Grows Organic, Basel, 28-31 August 2000.
http://www.fao.org/biologicag/doc/ifoam2000.htm
FAO/IFOAM, 1998, FAO/IFOAM Meeting on Organic Agriculture-Report.
http://www.fao.org/biologicag/doc/Ifoammtg.doc
Garfinkel H., 1967, Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
Haraway D., 1991, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York,
Routledge.
Haverkort B.; Reijntjes C.; Waters-Bayer A., 1993, Inspecting the toolbox. A look the means
for achieving sustainable agriculture, in Ceres 144, Low input farming: merits and limits, vol.
25, n. 6.
http://www.fao.org/docrep/v2865e/v2865e00.htm#Contents
Leopolod A., 1998, L’etica della terra, in Tallacchini M. (a cura di), Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Milano, Vita e Pensiero (ed. or. 1949, A Sand County Almanac
and Sketches Here and There, Oxford, Oxford University Press).
Latouche S., 1999, L’occidentalizzazione del mondo, Torino, Bollati Boringhieri (ed. or. 1989,
L’occidentalisation du monde. Essai sur le signification, la portée et le limites de
l’uniformisation planétaire, Paris, Editions La Découverte).
Merchant C., 1988, La morte della natura, Garzanti, Milano (ed. or. 1980, The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution, New York, Harper & Row).
Parrot N., Marsden T., 2002, The Real Green Revolution. Organic and agroecological farming
in the South, Department of City and Regional Planning, Cardiff University, pubblicato da
Greenpeace Environmental Trust, London, United Kingdom.
www.greenpeace.org.uk/MultimediaFiles/ Live/FullReport/4526.pdf
Pellizzoni L., 2001, Il rischio ambientale nella società contemporanea, in De Marchi B., Pellizzoni L., Ungaro D., Il rischio ambientale, Bologna, il Mulino, Universale Paperbacks.
Pearce D.W.; Turner R.K., 1991, Economia delle risorse naturali e dell’ambiente, Bologna, il
Mulino (ed. or. 1989, Economics of Natural Resources and the Environment, Hemel Hempstead, Harvest and Whatsheaf).
I quaderni del CREAM, 2004 - II
141
Rabinow P., 1986, Representations Are Social Facts: Modernity and Postmodernity in Anthropology, in Clifford J., Marcus G. (a cura di), Writing Cultures: The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press.
Redclift M., 1987, Sustainable development: exploring the contradictions, New York, Methuen.
Rifkin J.,1998, Il secolo biotech: il commercio genetico e l’inizio di una nuova era, Milano,
Baldini & Castoldi.
Rist G., 1997, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Toprino, Bollati Boringhieri.
(ed.or. 1996, Le Développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques).
Rosset P., Collins J., Moore Lappè F., 2000, Lessons from the Green Revolution, March/April
Tikkun Magazine.
http://www.foodfirst.org/media/printformat.php?id=148
Sachs W., 1998, Ambiente in Sachs W. (a cura di) Dizionario dello sviluppo, Edizioni Gruppo
Abele. (ed. or. 1992, The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as Power, London,
Zed Books).
Scialabba N., 2000, Opportunities and constraints of organic agriculture. A socio-ecological
analysis.
http://www.fao.org/biologicag/doc/SOCRATES1999.htm
Scialabba N., Hattam C. (a cura di), 2002, Organic agriculture, environment and food security.
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4137E/Y4137E00.htm
Shiva V., 1998, Risorse in Sachs W. (a cura di), Dizionario dello sviluppo, Torino, Edizioni
Gruppo Abele (ed. or. 1992, The Development Dictionary: a Guide to Knowledge as Power,
London, Zed Books)
Shiva V., 2001, Monoculture della mente. Biodiversità, biotecnologia e agricoltura “scientifica”, Torino, Bollati Boringhieri (ed. or. 1993, Monocultures of the Mind. Perspectives on Biodiversity and Biotechnology, London, Zed Books Ltd.,)
Shiva V., 2002, Terra Madre. Sopravvivere allo sviluppo, UTET. (ed. or. Staying alive.
Women, Ecology and Survival in India, London, Zed Books, , 1989)
Tallacchini M., (a cura di), 1998, Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Milano, Vita e Pensiero.
Tommasoli M., 2001, Lo sviluppo partecipativo. Analisi sociale e logiche di pianificazione,
Roma, Carocci.
Van Aken M., 2001, Alberi tra identità e alterità. Negoziazione di categorie ecologiche nel Pakistan settentrionale, in Fabietti U. (a cura di), Etnografia e culture. Antropologi, informatori e
politiche dell’identità, Roma, Carocci.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
142
Wood G., 1985, The Politics of Development Policy Labelling, in Development and Change,
v.16, n. 3.
Zappacosta M., 1995, Agricoltura, ambiente e sviluppo economico nel Terzo Mondo: un’analisi teorica, Roma, La Città del Sole.
Ziparo A., 1996, La pianificazione sostenibile per le aree del sud del mondo, in Paloscia R.,
Anceschi D. (a cura di), Territorio, ambiente, e progetto nei Paesi in Via di Sviluppo, Bologna,
Franco Angeli.
I quaderni del CREAM, 2004 - II
143
Stampato presso Maya – Torino
I quaderni del CREAM, 2004 - II
144