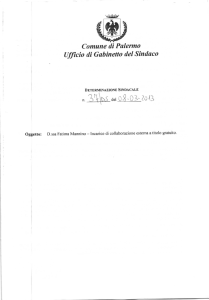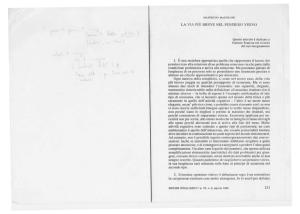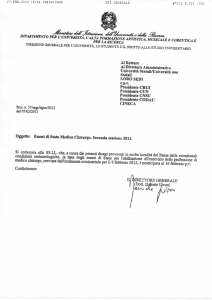Elaborato di
Isabella Spanò
‘COMPARED TO WHAT?
THE UCLA COMPARATIVE LABOR LAW PROJECT
AND THE FUTURE OF COMPARATIVE LABOR LAW’
DI HARRY W. ARTHURS
L’interessante breve saggio di Arthurs si propone di definire l’ambito e le finalità proprie
del diritto comparato del lavoro (d’ora innanzi, “DCL”). Di seguito è una sintesi dello
scritto.
Le prime ricerche di DCL risalgono al secondo dopoguerra e si devono agli studiosi
partecipanti all’”UCLA [University of California - Los Angeles] Comparative Labor Law
Project” 1965-1978. In realtà, si rammentano analisi di DCL già alla fine del 19° secolo;
ed in proposito, meritevole di memoria per il diritto del lavoro è l’insigne comparatista
statunitense John R. Commons (1862–1945), che influenzò in misura notevole gli studi
successivi.
Ma la vera sistematizzazione del DCL si ebbe appunto con l’UCLA Project, il cui
ideatore fu Benjamin Aaron, a sua volta ispirato dall’opera dello studioso britannico Otto
Kahn Freund. Il Project prevedeva lo scambio d’informazioni, mediante appositi rapporti
sulla situazione del proprio paese, tra giuristi del lavoro di sei diversi stati – Francia,
Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia. In realtà, già nella fase iniziale del
Project, nonostante la buona volontà espressa in tre mesi di continuo dialogo, ci si rese
conto che le differenze culturali e ideologiche erano tali da impedire il consolidarsi di una
piattaforma comune e da compromettere sostanzialmente il futuro buon esito del
Project.
Una delle conclusioni da trarre da quell’esperienza è che i comparatisti hanno la
responsabilità di contestualizzare le informazioni che ricevono, e di farlo in modo
comprensibile ai lettori dei loro scritti, che si trovano per la prima volta ad affrontare
quei dati contesti.
Aaron fu profeta nel sottolineare la necessità di un’apertura del diritto alle scienze sociali,
nell’ottica di una rifondazione del diritto comparato, sebbene sia poi rimasto in un
approccio troppo condizionato da pregiudizi teoretici. Egli infatti presupponeva che vi
fossero fattori sociali unici determinanti per il diritto interno di un paese. Tale
presupposto, peraltro, non comportò che gli studi condotti durante il Project non
rimanessero descrittivi e pragmatici piuttosto che analitici, tralasciando di approfondire
gli aspetti sociologici. Inoltre, per rispetto delle diverse posizioni politico-ideologiche dei
sei membri del gruppo di ricerca, gli studi dovettero essere portati avanti secondo uno
spirito di neutralità: fatto che forse limitò la portata dell’analisi sociale.
I componenti del gruppo avevano comunque in comune una visione del diritto del
lavoro come atto a promuovere la giustizia nei luoghi di lavoro: “missione” che sarebbe
stata facilitata dalla conoscenza della dimensione comparata ed internazionale. Ma le crisi
dell’economia politica, delle istituzioni e della teoria giiuridica, causando troppa variabilità
e diversità tra i sistemi, minarono alla base la possibilità di un confronto produttivo e
causarono in seguito la cessazione del Project.
Gli studiosi del Project esaminarono un periodo che, sconfinando dagli anni
dell’immediato secondo dopoguerra, aveva visto importanti sconvolgimenti nel mondo
del lavoro (cambiamenti tecnologici, ristrutturazioni industriali, ampliamento del
terziario, espansione del lavoro altamente qualificato, incremento della presenza
femminile): il paradigma sottostante a molta della legislazione del lavoro in essere
cominciava perciò ad apparire superato, ed anche la consolidata visione della giustizia
sociale entrava in crisi. Si può affermare, guardando ai fenomeni crescenti di recessione,
disoccupazione, inflazione, che a metà degli anni Settanta finì l’”epoca d’oro” delle
relazioni industriali. Gli accennati cambiamenti epocali misero in discussione il ruolo
degli stati nazionali nelle relazioni industriali. L’internazionalizzazione dei mercati e le
nuove strategie di produzione, distribuzione e management, supportate dai nuovi mezzi
di comunicazione a tutti i livelli, fecero sì che il potere passasse dagli stati e dai lavoratori
ai datori di lavoro; nello stesso tempo, la capacità di contrasto di questi fenomeni da
parte dei lavoratori andò scemando, a causa del venir meno della solidarietà tra loro, a
sua volta dovuta al distacco dalla coscienza di classe e alle crescenti differenze in termini
generazionali, razziali, etnici, d’istruzione, e via dicendo. La differenza di ricchezza e
potere si manifestava non solo tra lavoratori e datori, ma anche tra i lavoratori medesimi,
secondo le differenze di paese, di settore economico d’appartenenza, di classe anagrafica.
La stessa categoria unitaria “lavoro” assume un quid d’anacronistico di fronte a tali e
tante disparità di vario ordine. C’è quindi da chiedersi se sia possibile un più equo sistema
di diritto del lavoro in presenza di simili sfavorevoli condizioni. Sarebbero necessari
organismi transnazionali capaci di porre regole effettive, giustificazioni
ideologiche/filosofiche alla protezione sociale dei lavoratori da parte dei governi, un
potente movimento di lavoratori; e gravi crisi politiche o economiche come “una guerra
o una depressione” – che nessuno si augura - atte ad operare forti cambiamenti “nelle
percezioni e nei valori”. Ma niente di ciò sussiste.
Come procedere a una comparazione se i sistemi da mettere a confronto risultano ormai
erosi e al loro posto sono sorte nuove realtà e si svolgono nuovi processi? La risposta è
che il DCL deve trovare nuovi oggetti di studio, al di fuori degli ambiti tradizionali.
È vero che fondamentali elementi del diritto del lavoro sono sempre esistiti all’esterno
del sistema giuridico statale; ma ora, a differenza che in passato, questi prevalgono su
quelli interni, e sembra che tale proporzione resterà immutata nel tempo. Gli stati non
hanno più la capacità di regolare i propri mercati interni del lavoro, poiché questa è stata
compromessa dal progetto neo-liberistico di “restringimento” dello stato, progetto che
ha avuto spesso successo grazie a manovre subdole di nomina di giudici che non
condividono le scelte legislative in materia di lavoro, o di riduzione del numero, della
retribuzione, della motivazione e della presenza degli incaricati “sul campo” alla ricerca
ed al contenimento delle violazioni. Inoltre, anche le legislazioni del lavoro nazionali
sono predisposte sempre più non all’interno dei ministeri del lavoro, ma in altri ministeri
ed agenzie. Il diritto del lavoro non-statuale è dunque in crescita, e di questo dovrebbero
interessarsi i giuristi - tra i quali quelli che si occupano di DCL. Ad esempio, gli studiosi
di DCL potrebbero chiedersi come si sono trasformati gli antichi sistemi giuridici dopo
l’impatto con questi mutamenti epocali.
I comparatisti dovranno allora confrontare i codici di condotta elaborati dalle
multinazionali come facevano con i diritti interni degli stati? In realtà, questi codici
corrispondono all’interesse dell’impresa e mirano a favorire la condiscendenza verso
l’impresa stessa, rafforzandone il potere “con le buone maniere”, e perciò sembrerebbe
senza senso che il DCL se ne occupasse. Ma volendo studiare ciò che accade in realtà e
non ciò che è tradizionalmente legale o favorevole ai lavoratori, la cosa non appare più
inutile o peregrina.
Il Global Compact lanciato nel 2000 dall’ONU si propone di suscitare l’impegno delle
multinazionali a rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori. Allo stesso modo, il
progetto Ratcheting Labor Standards (RLS) mira ad incrementare le buone prassi dei
datori di lavoro anche mediante “sanzioni da parte del mercato”. Altri progetti
prefigurano forme di controllo della produzione per mezzo di informazioni dettagliate
sui luoghi di provenienza delle merci e sulle condizioni di lavoro, o dell’”etichettatura
sociale” dei prodotti, o, ancora, dell’esclusione dalle commesse pubbliche dei produttori
di beni risultati al di sotto di determinati standard sotto il profilo del lavoro. Tutti questi
piani e progetti dovrebbero migliorare le condizioni di lavoro, e sicuramente aiuteranno i
giuristi nell’assunzione della nuova prospettiva di considerare il “diritto senza stato”.
Compito, dunque, di chi si occuperà d’ora in poi di DCL sarà la ricerca e l’analisi delle
differenze tra vecchi e nuovi regimi e tra sistemi di diritto del lavoro statali e non statali a
scopo operativo-pragmatico – il che dovrebbe far nascere anche una nuova sintassi, una
nuova grammatica e un nuovo vocabolario del comparativismo.
Al di là dei fattori esogeni, ve ne sono anche di endogeni, afferenti la teoria legale e sociolegale, atti a modificare la prospettiva degli studisoi di DCL. Si tratta delle norme interne
non statali, proprie di altre discipline, che alcuni studiosi hanno cominciato a mappare
opportunamente: usi e consuetudini commerciali, procedure arbitrali e di conciliazione,
accordi e contratti collettivi, manuali operativi, sanzioni informali, e così via. D’altronde,
il diritto “ufficiale” non ha portato – spesso – ai risultati sperati, come nel caso delle
legislazioni antidiscriminatorie e di quelle sugli standard di lavoro, delle convenzioni
internazionali sui diritti fondamentali, delle dichiarazioni sull’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge.
La comparazione giuridica, così come anche l’approccio interdisciplinare, costituisce un
esercizio di umiltà, in quanto porta a superare il “legocentrismo”; superamento, peraltro,
non fine a se stesso, ma con un preciso obiettivo: quello di delineare le forze che
modellano in concreto il diritto del lavoro.
Tali forze non sono tanto le tradizioni giuridiche o la storia e la sociologia delle imprese e
dei sindacati, quanto tutte quelle che, al contrario, destabilizzano le tradizioni, gli
ordinamenti giuridici, le società stesse.
E l’effetto da prendere in considerazione non è solo quello sul diritto del lavoro
nazionale, perché quest’ultimo è inestricabilmente unito a, ed interdipendente da, ulteriori
campi ed oggetti di studio.
Il DCL ha ora davanti, in sostanza, una complessa sfida “a due facce”: considerare regimi
giuridici sia statali che non statali, i primi plasmati dai secondi piuttosto che il contrario:
ciò potrà comportare che l’analisi di DCL prenda le mosse da considerazioni politicoculturali-antropologiche prima che giuridiche. L’ottica “legocentrica”, invece, fa sì che si
consideri il diritto come un qualunque bene pubblico, con una sua autonomia e
predominanza su altri settori e discipline.
Il nuovo approccio risentirà di una certa vischiosità applicativa, poichè il distacco
dall’ottica precedente non sarà facile.
Ma, a conferma della necessità di tale nuovo approccio, va aggiunto che sul piano delle
regolamentazioni internazionali, appare ancora meno produttiva che in ambito nazionale
la comparazione tra norme analoghe, in quanto a quel livello i testi, quando esistenti,
sono spesso frammentari, vaghi e privi di forza cogente.
In sostanza, il DCL va concepito come parte di un’analisi più generale sull’impatto sui
vari sistemi dell’economia politica e della “governance” globale e regionale, attuata da
enti come WTO, NAFTA, Unione Europea, e da movimenti di opinione pubblica, come,
ad esempio, quelli che promuovono boicottaggi a favore dei lavoratori del Sud del
mondo.
Inoltre, il DCL dovrà occuparsi anche della comparazione interaziendale e intraziendale,
stante la presenza di molti pseudo-ordinamenti giuridici interni alle imprese stesse, a
carattere sia paralegislativo che paragiurisdizionale: si dovrà quindi indagare in modo
approfondito il rapporto di tali “ordinamenti” con il contesto sociale e culturale esterno
ed interno.
Il DCL da porre in essere si prospetta quindi come parte dell’analisi di innumerevoli
implicazioni politiche, economiche, sociali, culturali e psicologiche delle relazioni di
lavoro. Nessun dubbio che tale nuovo DCL sia in ogni caso vero e proprio “diritto”, in
quanto concerne la legalità; che riguardi senz’altro il “lavoro”, perchè tratta delle relazioni
tra chi lavora e chi del lavoro si avvale; che infine sia “comparato”, dal momento che si
basa sul porsi domande in merito alle alternative statali e non statali in termini di valori,
percezioni, azioni e intese.
Tutto ciò premesso, risulta impossibile essere giuristi del lavoro senza essere
comparatisti; ed anzi bisognerebbe diventare “giuristi del lavoro senza frontiere” alla
maniera dei “medici senza frontiere”: abili quindi a fornire soluzioni in situazioni di
sconvolgimento e di conflitto, affrontando – come ogni buon giurista fa - il diritto nel
suo proprio contesto...che però al presente è il contesto globale. Senza frontiere tutto
diviene “contesto”, e in questo quadro il diritto scompare come tale: Aaron mostrava
perciò, in fondo, di avere delle buone ragioni nella scelta di affrontare primariamente
norme e istituzioni del diritto del lavoro nazionale piuttosto che il contesto, perchè per
lui e per gli studiosi suoi colleghi il concetto di “contesto” era troppo vago, complesso e
intrinsecamente legato alla storia, alla cultura e alla politica.
Il destino del DCL sarà dunque determinato dalla capacità o meno, sul piano intellettuale,
d’individuare un nuovo quadro di riferimento, di convogliare risorse, di reclutare talenti,
onde svilupparlo, come sopra esposto, in tutta la necessaria ampiezza, profondità e
complessità.
A commento del saggio testé riassunto, voglio osservare che la migliore comprensione
dei fenomeni esterni ai singoli diritti del lavoro nazionali - ottenuta mediante la corretta
applicazione del DCL come dall’autore auspicata -, e soprettutto dei fenomeni
strettamente connessi alla globalizzazione, può aiutare gli stati a trovare gli strumenti per
recuperare in parte la sovranità perduta. A parere di chi scrive, infatti, è quantomeno
preoccupante lasciare ambiti come quello del lavoro – ma non solo – in balia di forze
esogene sulle quali sia minima la possibilità d’esercizio di un controllo. Troverei
necessario che si pervenisse ad un nuovo equilibrio che comunque contemplasse i
governi nazionali come interlocutori autorevoli sullo scenario mondiale – il che non
appare così scontato, considerando gli attuali trend.

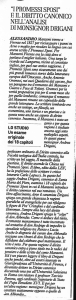
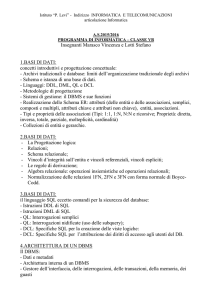

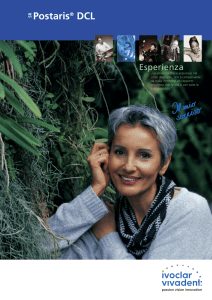

![Contratto con Sanisystem [pdf - 530,26 KB]](http://s1.studylibit.com/store/data/006230647_1-fc81501d02636e5972321f7b03c486fe-300x300.png)