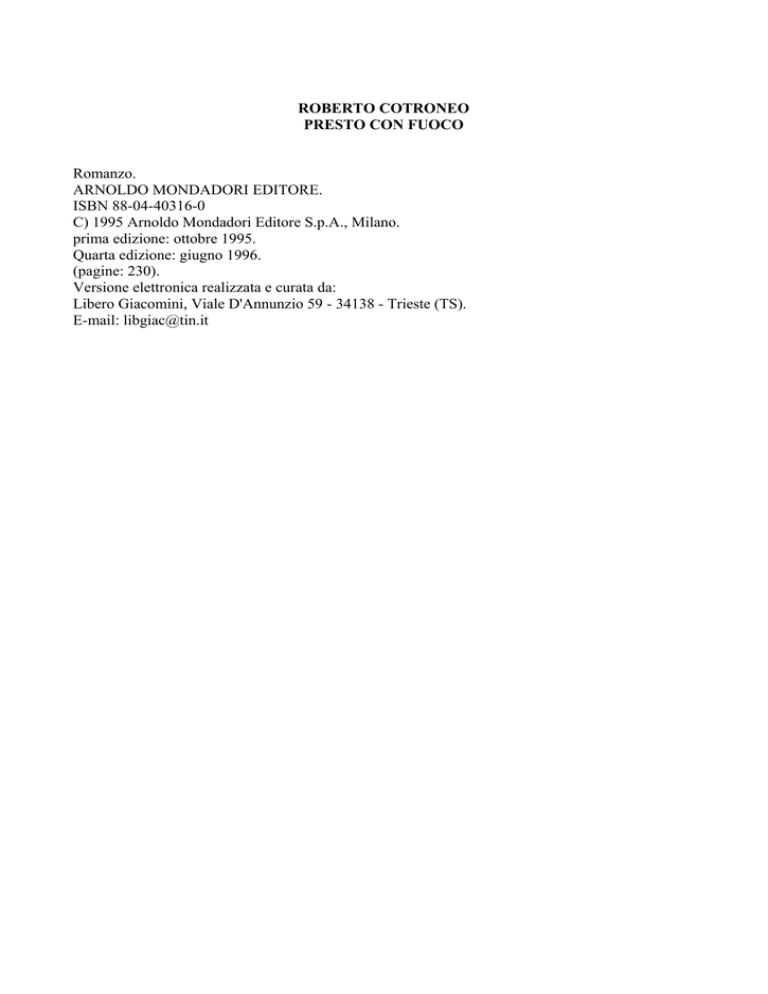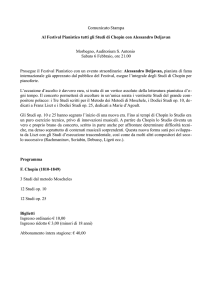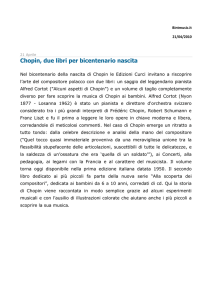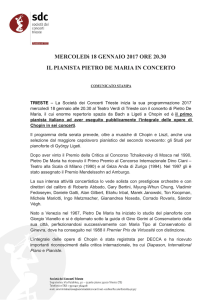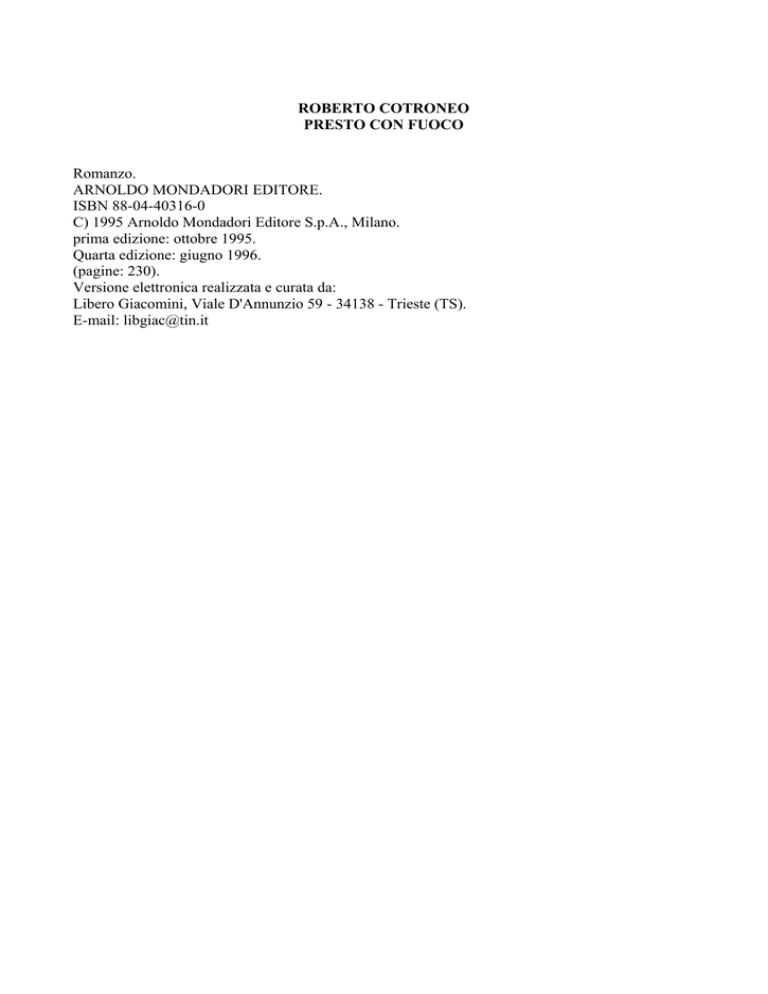
ROBERTO COTRONEO
PRESTO CON FUOCO
Romanzo.
ARNOLDO MONDADORI EDITORE.
ISBN 88-04-40316-0
C) 1995 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano.
prima edizione: ottobre 1995.
Quarta edizione: giugno 1996.
(pagine: 230).
Versione elettronica realizzata e curata da:
Libero Giacomini, Viale D'Annunzio 59 - 34138 - Trieste (TS).
E-mail: [email protected]
Dedica.
PRESTO CON FUOCO.
A Federica e Francesco,
per la pazienza.
E ora anche ad Andrea.
Giunse a conoscere l'innocenza attraverso il peccato.
JAMES JOYCE, Alphabetical Notebook.
FRÉDÉRIC CHOPIN, Ballata op. 52, batt. 211-212.
Capitolo primo.
Eppure deve esistere una calligrafia delle passioni.
Un segno più morbido, una coda della croma che
scende di troppo, uno svolazzo di pausa, quella che
vale un quarto, una pressione più forte del pennino,
quasi un graffio, un oltraggio a quella carta spessa,
lanosa, che un tempo si usava per scrivere musica. Si
deve pur trovare un barlume di esitazione, la follia di
un Presto con fuoco; il restringersi dell'inchiostro in
quel breve spazio della pagina, come volesse comprimere
il tempo, farlo stare tutto tra quelle righe esitanti
e quegli spazi irregolari: cascate di note, le chiamano;
gocce d'acqua, qualche volta. C'è persino un suo
Preludio, di Frédéric Chopin intendo, che ha questo
nome. I nomi che vennero dati dopo: emozionali,
descrittivi, talvolta deleteri. A significar la musica come
qualcosa d'altro. Grande sbandamento di chi venne
dopo i romantici e volle che la natura, l'analogia,
entrasse tra quei segni, e li guidasse, quasi fossero i cristalli
d'argento d'un dagherrotipo. Neppure il ricordo
di quell'albero di fronte alla sua finestra nella casa
di campagna di Nohant deve esser servito a cambiare
quei segni incerti, malati, stanchi, che ho di fronte a
me. Certo sublimi, geniali, minati però dalla fatica,
dalla sensazione di non farcela. Altro son le gocce
d'acqua, altro le pianure polacche, altro ancora i versi
del poeta Mickiewicz che guidarono le Ballate. Si
diceva che scrisse le quattro Ballate ispirato da quei
versi. Eppure, di quei versi nulla rimane, cancellati;
rimane la musica, e sarebbe un'offesa accomunarla a
qualunque cosa, vorrei che fosse lasciata in pace. No,
leggende di vecchi insegnanti, abituati alla vita, alla
similitudine, piuttosto che alla musica; a paragonare
l'accordo di do maggiore, piuttosto che ascoltarlo per
davvero.
Qui di fronte a me vedo solo un pianoforte, un
sistema di leve sofisticato, con i tasti bianchi e neri che
si riflettono sull'interno del coperchio, dove in caratteri
oro c'è scritto Steinway & Sons. Di fronte a me
non ci sono gocce d'acqua ma tutto quanto sono stato
costretto (sì, costretto) a imparare in anni di studio.
Imparare a conoscere la meccanica di uno strumento.
Perché son quelle leve a garantirmi che ogni cosa
funzionerà, che le mie dita assolveranno al loro onesto
lavoro. E' lì che parte la suggestione, lì dentro, tra
feltri e piccole cinghie in cuoio, tra smorzatori e corde
avvitate attorno a perni d'acciaio. Li chiamo così, e
non si chiamano così. Con il mio accordatore si parla
in un altro modo, e oggi, sul finire di questo secolo,
non ci capirebbero che in pochi, pochissimi forse. Da
qualche giorno sono convinto che sul terzo fa qualcosa
non funziona, forse è la leva del doppio scappamento,
ma l'accordatore mi ha detto che si tratta del
rullino, il punto di contatto tra montante e martelletto.
Siamo rimasti in una posizione di stallo. Forse ha
ragione il mio accordatore. Intanto il mio pianoforte
ha un fa che non suona come dovrebbe. Si sente un
fruscìo impercettibile, come un retrogusto acidognolo
di un rosso d'annata, di un barbaresco che vuol
darsi importanza. E così quel fa della tastiera mi
lascia nell'orecchio lo strofinìo del feltro, del panno, o
forse di un tassellino di legno dolce. A pensarci bene,
credo che dipenda un po' dal mio orecchio: più
ossessivo del solito in questo periodo, e persino incerto.
Sento tutto, ogni possibile imperfezione del mio
pianoforte (ormai ne suono solo uno, il modello CD 318,
uno Steinway naturalmente, costruito nel 1938, gli altri
sei sono chiusi), eppure non so decidere quali riesco
a tollerare e quali invece no, anche se per tanti anni
ho creduto di saperlo.
Ora che incido poco, direi pochissimo, vivo qui
chiuso, in una villa che nulla ha di arioso, che se potesse
non guarderebbe neppure questo prato all'inglese
che il giardiniere si ostina a tenere in perfetto ordine;
questa villa in cemento grigio, a un solo piano, circondata
da mura alte e poco attraenti, che mi son fatto
costruire in ostilità al Leon Battista Alberti e alle divine
proporzioni di tutti gli architetti, perché mi portasse a
dimenticare quelle che si voglion giuste e ammirate,
diversa da ogni casetta di montagna che si può vedere
da queste parti, lontana da qualunque città e vicina
sola a un bosco di abeti, fitto, umido e disordinato,
senza panorami, a meno di non cercarli. Qui si parla
tedesco e si vive isolati, anche se si è quasi al centro
dell'Europa; qui si respira un odore di clinica, asettico
e beneducato. Pochi mi conoscono, ancor meno han
voglia di chiamarmi maestro, anche perché io non
rispondo, sfioro la maleducazione: lascio correre e
cancello dalla memoria i sorrisi che mi porge la gente di
qui, tutt'altro che semplice, tutt'altro che povera. Da
queste parti ogni cosa funziona come dovrebbe: non è
un esilio, non è un eremo, non è una fuga. La natura
da queste parti non separa, non isola: integra, vanta
cavi sotterranei che portano informazioni in ogni parte
del mondo, strade perfette che conducono ovunque.
Anche a Parigi, dove ho vissuto inutilmente per
troppi anni, convinto che la vicinanza ispiri, mentre
l'unica fonte di ispirazione è l'ossessione, la paura del
distacco, la lontananza, il non poter capire. E' da qui
che comincio a comprendere, da un luogo altro,
distante nello spazio, ma prima ancora nello spirito. Da
queste parti il Romanticismo è arrivato in una forma
frusta, come una malattia subdola e un po' fastidiosa
da cui si guarisce senza tanti clamori. E poi qui, di
pianisti non ce ne sono e pochi si può dire ne siano nati. A
parte Alfred Cortot, naturalmente: veloce e ginnico.
Imperfetto ma entusiasmante. Come Rubinstein,
d'altronde. Arthur, s'intende. Capace di suonare la Ballata
in fa minore in quel modo che i volgari definirebbero
frizzante, e a me fa sorridere, perché ogni volta che si
sedeva al pianoforte sembrava lui l'autore, lui l'unico,
quasi potesse ripetere il prodigio di suonarla di fronte
a Madame la Baronne Nathaniel de Rothschild. Soltanto
che Rubinstein era massiccio, forte, potente. E
Chopin esile e tisico. Per non dir di Cortot, che
sembrava un bon vivant dalle dita fuggevoli: un po' Proust
e un po' Debussy.
Eppure deve esistere una calligrafia delle passioni.
Ma se c'è, questa volta pensavo, anch'io ne sono
responsabile. Colpa di una storia oscura e segreta, che
mi ha messo nelle mani un manoscritto che credevo
non esistesse. Se non nelle prime pagine, che son poi
quelle che meno mi interessano. Perché il problema
non è in quell'Andante con moto. Quello si sa come va
suonato. Anche se Rubinstein lo fa quasi con la fretta
di chi ripone in un cassetto un pacchettino, qualcosa
che cerca di nascondere. No, non ce l'ho con Rubinstein,
non più oggi. Ma quando ero ragazzo, tutti si
chiedevano se sarei diventato come lui. E io a far
dispetto al mondo, al mio di mondo, e a sfiorar tasti come
fossi Maurice Ravel, l'orologiaio. A calcare su
quegli accordi che sembravano impossibili, almeno
sulla carta; aggrovigliati al pentagramma come piante
tropicali rampicanti, che però creavano un effetto
musicale decisamente opposto: freddo, vago, esitante,
indisponente. E poi la notte, in fondo alla casa,
nella parte vicino al bigliardo, correvo al pianoforte
verticale, quello che usava mamma per gli esercizi
dello Czerny, dai tasti irregolari, macchiati di caffè,
che mescolato con l'avorio prendeva tonalità e colori
che saprei riconoscere ma non descrivere, e senza farmi
sentire, usando il pedale della sordina, suonavo la
Fantasia-Improvviso, sublime pasticcio romantico
senza capo né coda pubblicato postumo, e per questo
rimasto forse senza vita. E lì la mia mano destra,
ancora incerta per l'età e la febbre di notti insonni a
pensare alle donne che frequentavano la mia casa,
giovani e adulte, e che mi sfioravano con le scuse più
diverse, rallentava fino a diventare imprecisa e
annebbiata, come le gambe muscolose ma stanche di un
corridore.
Dovevo essere davvero bambino, allora. Oggi i miei
baffi sono quasi bianchi, i capelli pettinati indietro
diventano sempre più radi e le febbri hanno lasciato il
posto a una parvenza di spirito meditativo. Perché
nulla hai più da fare, e assai poco da suonare. Mi sono
guardato allo specchio in questi ultimi anni pochissime
volte, per non accorgermi che mi infiacchivo (non
invecchiavo, è troppo poco; e sarebbe esagerato dir
che mi ammalavo). Specchio. Si fa per dire. Qui di
specchi quasi non ce ne sono, eccetto quelli dei bagni:
spartani, e un po' scomodi come si conviene a un uomo
che era destinato alla carriera militare. Il più delle
volte mi sono specchiato sul coperchio del pianoforte,
dividendo il mio volto con la scritta d'oro della Steinway,
che cancellava - sovrapponendosi - il bianco dei
miei baffi. L'ho fatto quasi con civetteria come se quel
legno soltanto, opportunamente lucidato, potesse
restituirmi la mia immagine vera, l'unica possibile. Mi
piace questa idea. Ho pensato di riportarla in qualche
modo nella mia autobiografia che forse non scriverò
mai, anche se il mio editore svizzero mi ha già versato
una parte di anticipo e si impegna a venderla all'intero
mondo. Tutti pronti a tradurre le memorie di uno
che ha passato buona parte della vita a suonare il
pianoforte, e quel che rimaneva a pensare perché non
avrebbe potuto farlo meglio, a meditare sulle note da
migliorare. Come potrei mai scrivere una cosa del
genere?
Nel 1935 mi sono diplomato, avevo quindici anni:
ero come quelle ragazzine che fanno l'amore troppo
presto, quando ancora non sono donne, e per tutta la
vita guardano gli uomini con espressione lasciva, perché
il sesso le ha imprigionate per sempre e impedisce
loro di pensare ad altro. E spesso ti seducono: e quando
lo fanno, ti legano in una passione soffocata,
guardandoti fino alla fine con le iridi spalancate come se
volessero dai tuoi occhi una risposta per la loro ossessione.
Come se da te sperassero inutilmente di esser
liberate da una prigionia che le attrae. Bene: io sono così.
Il pianoforte mi ha cambiato la vita perché mi ha
sorpreso giovane, quando i miei muscoli erano quelli
di un bambino, le mani sottili, fragili, perse in una
tastiera che il mio sguardo quasi non riusciva ad abbracciare
per intero. Il pianoforte ha svelato come un crudele
maieuta quella parte di me che gli altri chiamano
talento straordinario, o persino genio. E di cui io non
avevo coscienza ma solo emozione nell'ascoltare me
stesso, al punto di sentire i brividi salire dalle braccia
fino alle tempie e alla nuca, quasi fosse una sapiente
carezza; emozione e compiacimento nel vedere che
progredivo per una forza interna che mi impauriva, e
che doveva impaurire mia madre, mio primo maestro
di pianoforte. E il crudele maieuta, quello Steinway &
Sons tedesco dei primi anni del secolo, ha mostrato a
tutti il mio innegabile talento quando ancora io non
ero nelle condizioni di farlo, e me ne vergognavo. E mi
ha turbato sentire me stesso quattordicenne studiare il
quarto concerto in sol minore di Rachmaninov senza
alcuno sforzo, come se il mondo, non solo la tastiera,
obbedisse ai miei capricci adolescenziali. Oggi i miei
capricci sono oggetto di biografie, di trattati: non lo
sopporto, e cerco di isolarmi per quanto posso.
Eppure non sono un eccentrico. I critici musicali
amano alimentare leggende: e raccontano che ho un
pessimo carattere. Non è vero. Amo stare per conto
mio e non torno indietro sulle mie decisioni. Basta
tutto questo per far parlare di sé come di un bizzarro
signore? Non so. Certo no. Ma non importa, perché i
giornali preferisco non leggerli. E dunque non mi
occupo di quelli che vorrebbero occuparsi di me. Diceva
Proust: «Quel che io rimprovero ai giornali è di
farci prestare attenzione ogni giorno a cose insignificanti,
mentre non leggiamo che tre o quattro volte in
tutta la vita i libri dove ci sono cose essenziali». Tra
questi libri io potrei mettere anche un paio di partiture.
Come fossero dei testi da leggersi.
L'altro giorno ho incontrato poco distante da qui
Vladimir Aschkenazy. Non lo conosco, solo dopo mi
hanno detto chi era. Passeggiavo tra gli abeti, cercando
di non guardare il panorama. Lui mi è venuto
incontro, quasi correndo, felice. Sembrava un ragazzino
sereno nel suo essere scoordinato, con le braccia
che si muovevano per conto proprio. Era vestito di
nero: un paio di pantaloni sportivi e una dolce vita
che rendeva ancora più evidente il pallore del volto e
il bianco dei capelli. Pare mi abbia detto qualcosa del
tipo: maestro, sono un suo grande ammiratore. Non
lo so: è che un uomo che sorride con i capelli lunghi
bianchi e mi corre incontro mi fa paura, e così mi sono
ritratto, come un riccio. Non l'ho sentito e non gli
ho risposto. Alcuni amici mi dicono: peccato, avreste
avuto molto da dirvi. Può essere, ma non frequento
più le sale da concerto e non posseggo riproduttori
di suono molto sofisticati. Talvolta fingo persino di
non sapere cosa sia un compact disc, anche se alcuni
miei vecchi dischi sono stati stampati in quel materiale.
Mi sembrano tutti fanatici, dunque ridicoli. Io
che passo le mie giornate a leggerla la musica, senza
strumento, come fosse un romanzo di Tolstoj,
sentendomi addosso le note, che mi rimbalzano sullo
sterno come se fossero biglie d'acciaio. Avrei
comprato tutti i manoscritti del mondo per non dover
leggere sempre note a stampa, belle, uguali e perfette.
E invece niente, quelle vere sono da sempre nei
musei, per non essere lette da nessuno, né tanto meno
da me, che ormai so riconoscere ogni misterioso
tremolìo, ogni esitazione, e la immagino, e trasformo
in suono tutto questo.
Altro che Cortot, con quello sguardo obliquo e la
palpebra socchiusa; altro che Rubinstein, forte come
un contadino polacco, capace di bere e poi suonare
magnificamente. Per non dire di Claudio Arrau. Lo
incontrai tre sole volte. La prima nel 1949, a Berlino.
L'ultima poco prima che morisse, a Monaco di Baviera,
una città che comincio ad amare e a preferire ad
Amburgo. Doveva essere dicembre, perché si portavano
guanti imbottiti. Era freddo, molto. Quando entrò
in sala e si sedette al pianoforte, capii che non
avrei resistito a lungo, e infatti dopo poco me ne andai:
non sopportavo quel suo modo immobile di
gestire la tastiera, quel virtuosismo che veniva dal cervello
senza il bisogno della forza delle braccia, quelle
mani placide e veloci che non scattavano. Mi sembrava
tutto contronatura: il meraviglioso suono che usciva
dal suo gran coda mal si addiceva a quel viso
elegante di possidente terriero latino-americano. Anche
se con Arrau si parlava tedesco e conosceva meglio
Berlino di Santiago del Cile. Devo ammetterlo: in lui
c'era il talento totale, assoluto. Non suonava soltanto
bene, percepivi che tutto capiva, tutto interpretava.
Ti guardava senza metterti in difficoltà, con cortesia;
e con cortesia ti contraddiceva mostrando sicurezza.
No, non aveva niente di affettato il suo modo di suonare,
era più che altro un mistero: un pianista dell'interno,
del cervelletto, dell'ipofisi. Ti aspettavi che prima
o poi le mani sarebbero scomparse e lui con il
pensiero avrebbe continuato a suonare; e che il
pianoforte rivelasse un'anima, scacciando via ogni
trionfo meccanico, liberando le corde da quella tensione
impossibile. Dieci tonnellate deve reggere il telaio
dello strumento.
Ricordo una sera, lontana, la seconda volta che ci
incontrammo, nel 1966 a Ginevra. Io tenevo un
concerto: solo Mozart e Brahms. Lui venne e ne fu turbato;
si aspettava un programma di sala con Chopin,
con Debussy, non Mozart. Mi disse che suonavo il
Rondò in la minore in un modo curioso, di più:
misterioso. Poi, non so come, si cominciò a parlare dei
Preludi di Chopin. Mi chiedeva perché non li avessi
ancora incisi e perché figurassero così raramente nei
miei programmi, nei miei concerti: «Un pianista della
sua profondità potrebbe raccontare molto di
quest'opera», disse, «credo che sia il momento più alto,
il più drammatico di Chopin. Andrebbero suonati
tutti insieme, uno di seguito all'altro, senza interruzioni.
Forse non mi darà ragione, ma con i Preludi si
può dire molto della personalità di un pianista».
Risposi che preferivo le Ballate, e lui mi fissò compiaciuto,
poi dopo aver sorseggiato un bicchiere d'acqua
minerale mi sorprese con una domanda: «Lei, le
Ballate. Io invece amo alcuni Notturni. Sa quale?
Forse non se lo aspetterebbe mai, quello dell'opera
37, in sol. Ma non le dirò il perché. Preferirei che lo
scoprisse da solo, ascoltandolo». E subito dopo
aggiunse: «Credo che la sua Ballata preferita sia la
quarta, in fa minore. E questa volta le dirò il perché:
per ora è quella che suona peggio». Lo guardai smarrito.
Forse fu la prima e ultima volta che mi smarrii
nelle parole di un pianista. Credevo di essere un
pianista diverso: che suonava note come fossero biglie,
biglie d'acciaio che rimbalzano sullo sterno. Probabilmente
mi sbagliavo. Oggi tutto mi è molto più
chiaro perché ho di fronte il manoscritto dai bordi
smangiati, polveroso e sbiadito come si vuole di
ogni vecchia carta ritrovata.
Ci vuole pazienza con Chopin, troppa pazienza:
c'è chi diventa pazzo e chi, come me, finge soltanto.
Perché in questo mondo, cinque anni dal duemila, i
pianisti o sono folli o non sono; e io non posso
raccontare al mondo che non sono. A meno che non
riveli ciò che ho qui davanti, quelle due pagine diverse
che nessuno poteva immaginare. Mi viene in mente
quando suonai l'ultima volta in concerto la quarta
Ballata. Si era a Salisburgo, nel 1975. Un concerto che
fu trasmesso in diretta alla radio; la solita folla, il solito
evento, ma avevo male alla gola e mi sentivo stanco.
Studiai il programma fin nei dettagli: Liszt,
Debussy, Mozart, una Toccata di Bach. Alla fine Chopin:
avrei dovuto suonarlo come bis, per chiudere il
concerto. Invece incominciai da lì: quasi a temere di non
farcela fino alla fine. La mia musica iniziò come un
girotondo ostinato. Suonavo su di un Bosendorfer
imperiale: un pianoforte senza le morbidezze degli
Steinway. Perfetto per Mozart e Bach, eccitante per
Liszt, ma controindicato per Debussy e naturalmente
Frédéric Chopin. Era uno strumento che, come dire,
faceva sentire l'acciaio delle corde: alcune lunghe
quasi tre metri. E allora, già alle prime due battute,
sentivo che c'era un errore, che stavo sbagliando
qualcosa. Lo sentivo io, s'intende, nessuno del pubblico
avrebbe potuto immaginare che quell'inizio in
do maggiore portava con sé una sensazione di perdita;
meglio, di inadeguatezza. Sentivo il suono svilupparsi
per tutta la lunghezza della corda, e da lì arrivare
in sala; e capivo che non avevo scelta, che avrei
suonato con una meravigliosa precisione, e al tempo
stesso che non sapevo che farmene di quella precisione.
Lo ricordo: fu Isaac Stern, che suona il violino come
fosse uno strumento inventato dai romantici e
potrebbe far vibrare di vita persino il deserto del Negev,
a farmi capire veramente quanto sia diverso impugnare
un archetto, e maneggiare le corde con la forza
delle mani, delle dita, delle braccia. Noi pianisti siamo
separati dal suono, non abbiamo ance che vibrano,
corde che segnano i polpastrelli, ma leve e tasti
rigidi, piacevoli al tatto, spesso in avorio. Solo noi
siamo separati dalla musica, non aderiamo con il corpo;
e ogni sol, ogni do, re, fa diesis avrà sempre lo
stesso suono, più forte, più leggero, impercettibile,
aumentato dal pedale di risonanza, reso diverso da
quello tonale; ma sempre quel timbro verrà fuori, e
nulla di più.
Sembrerà strano, ma quel giorno a Salisburgo ho
pensato a tutto questo in pochi attimi e ho avuto
voglia di aggredire il pianoforte, di togliergli quel privilegio;
ho avuto il desiderio di chiedere ad alta voce
che le note aderissero alle mie emozioni con maggior
forza. In una parola, ho sentito la musica lontana da
me come se la comandassi a distanza: come se avessi
tra le mani solo il filo di un mirabile aquilone, e non
l'aquilone stesso. La musica deve viaggiare da sola,
come i romanzi: eppure quell'inizio in do maggiore
crea il primo equivoco vero della Ballata. Lo so che è
un do maggiore presago di altro, e inganna l'ascoltatore
facendogli credere che tutta la Ballata sia in questa
tonalità: dunque lineare, affatto ambigua,
sorprendente per uno Chopin che nel periodo in cui
scrisse queste pagine era davvero tormentato. Note
aperte, legate, eppure libere; come dire, panorami
senza scorci, visti al grandangolo. La musica è matematica:
e la matematica è un'opinione, solo gli sciocchi
credono che sia indiscutibile, come fosse aritmetica.
Sette battute sette. Le sentivo quella sera non
tanto come fossero note di passaggio, semmai come
note divaganti, come a raccogliere le idee: volevo
sfrangiarle, quasi interromperle in modo impercettibile.
E invece la musica colta, che altri chiamano ridicolmente
«classica», è oggi un museo dell'interpretazione,
monumento di regole e canoni, fredde rigidità
che ti obbligano a suonare quelle note e in quel modo.
E più la partitura si fa precisa, più sembra che il
compositore, a voler fissare ogni cosa sulla carta, possa
dare un'impronta netta e decisa alla sua opera. Ormai
si sa: gli abbozzi contano meno, sono il risultato
di pensieri minori, incompleti, dell'artista. Solo ciò
che è segnato, e fin nei minimi dettagli, vale e conta:
in qualche modo, è. L'incompletezza non si addice ai
compositori. Per questo il Novecento si dissolve in
mille rivoli di note libere, disegnate, da inventare e
percorrere partendo da punti sempre diversi, fatto di
pentagrammi circolari e non so che altre diavolerie
ancora. Il Novecento è stato l'esplosione liberatoria:
uccidere la partitura scolpita nella sua perfezione
formale; un deicidio, per intenderci.
Ma devo tornare alla Ballata. Dopo le prime sette
battute comincia il tema: in fa minore, tonalità vera
della Ballata; e si chiarisce l'equivoco tonale. Ora Chopin
comincia a raccontare, senza divagare; un'annotazione
dice: a mezza voce. In italiano, la mia lingua: anche
se mi accade sempre più raramente di parlare e
pensare in italiano. Persino nei sogni prediligo il francese,
e quelli che faccio in italiano sono quasi sempre
sogni antichi, lontani nel tempo, dove non suono mai
il pianoforte, come se il mio strumento e il francese
fossero uniti da un legame misterioso.
Eppure, quando mi soffermo sulle annotazioni in
italiano delle partiture ho quasi un moto di rabbia e
malinconia, sembra un italiano ingessato in frasi di
maniera, qualche volta con errori. Leggiero, si scriveva
nell'Ottocento, con quella «i» di troppo che nessuno ha
mai tolto: inesorabile rigidità della musica, neppure
gli errori di ortografia si osa correggere. E diviene un
vezzo lasciare tutto com'è, nel delirio di una mirabile e
rigida precisione. Quel a mezza voce arriva dopo un
diminuendo ritenuto. Ora, ritenuto è espressione enigmatica
che ogni pianista crede di poter interpretare come
gli pare. Molti pensano sia sinonimo di rallentare, ma
non è così. Niccolò Tommaseo fu più preciso, scrisse:
«Tiene luogo di rallentato, se non che ha qualche affinità
con stentato».
Non sapevo di questa definizione del Tommaseo.
Me ne parlò una sera Cortot, in un ristorante di Siena.
Non so dire che anno fosse, è come se avessi consegnato
alla storia della musica i miei ricordi, ma con
un po' di perfidia li avessi privati di un ordine cronologico;
e che sia la storia della musica a ordinarseli da
sé! Esagero? No, non esagero affatto. Però Cortot mi
aveva detto, con quel francese perfetto di chi forse
non si è mai dimenticato di essere svizzero: «Un vostro
dizionario ottocentesco mi ha regalato l'immagine
più nitida della parola ritenuto: "Che ha qualche
affinità con stentato". Certo, bisogna stentare, stentare
senza dare la sensazione che lo si riesca a stento».
Ma non è affare da poco trasferire tutto questo sulle
dieci dita. Appesantirle quanto basta per dare una
sensazione di stentatezza, che non sia però troppo
vicino all'imperizia, e dunque apparire sgradevole e
deludente. Ma l'esitante ritenuto rischia, tra i pianisti
che credono troppo alle leggende romantiche, di
trasformarsi in un'arma impropria, in un rallentìo del
pensiero, quasi a voler tener sospeso l'ascoltatore.
Certo, a Salisburgo quel giorno non pensai affatto a
tutte queste cose. Non immaginavo neppure che la
quarta Ballata op. 52 in fa minore di Frédéric Chopin
sarebbe diventata per me una vera ossessione, una
lingua sconosciuta che mi ha rivelato un mondo che
prima non decifravo. E neppure potevo immaginare
che esistevano due finali diversi; e in questo spazio,
tra queste pagine diverse, io potessi rileggere la mia
vita, forse quella di Chopin, e forse - ancor di più che avrei potuto intravedere, scorgere a fatica, la fine
di un'epoca, di cui io posso essere un'ultima propaggine,
un'appendice sbiadita che non continuerà. Quel
giorno a Salisburgo mi domandavo, incurante di un
pubblico in visibilio, se fosse possibile suonare un a
mezza voce in una sala da duemila persone, e se quei
signori che seguivano il mio concerto per radio
avrebbero mai potuto immaginare di quanto i miei
tendini, i muscoli di ogni singolo dito si contraessero
in uno spasmo misurato proprio in quel cambio di
tonalità; in quel passaggio al fa minore, esitante, suonato
a mezza voce; ma su un Bosendorfer imperiale, di
una potenza di suono impressionante, anche se un
po' troppo freddo per i miei gusti.
Nodi della vita, curiose coincidenze. Di quel
concerto ricordo questa angoscia, come se da quel do
maggiore, a voler troppo esitare, non sarei stato capace
di cambiar di tonalità, di passare al fa minore con
il timbro che si conviene. E non sarei stato capace
perché lì ha inizio il primo grande tema della Ballata.
E ancora sapevo che tutte quelle mie preoccupazioni
non le avrei mai potute trasmettere a nessuno: a nessuno
tra il pubblico in platea, a nessuno tra i critici
musicali, che impazziscono per ogni mio concerto, e
fanno chilometri per entusiasmarsi di quanto suono,
scrivendo poi cose generiche, e mostrando di avere
più dimestichezza con gli aggettivi e un po' meno
con le note musicali. Cosa avrebbero capito? Possono
sapere quanto pesa, emotivamente, il passaggio da
una tonalità di do maggiore a un fa minore? Potrebbe
sembrare esagerato, forse è giusto che tutto questo
non debba importare a nessuno. Ma allora perché mi
seguono, perché dicono che sono il più grande pianista
vivente? Perché cercano di intervistarmi quando
sanno che preferisco suonare e tacere? E perché i miei
dischi vendono centinaia di migliaia di copie, e la
mia casa discografica mi manda, almeno una volta al
mese, un signore discreto, colto, competente, cortese,
educato, che parlando di rose e ortensie (quelle che
tiene in ordine la signora Ursula) ed elogiando i miei
quadri di Francis Bacon fa poi cadere il discorso su
quei Preludi che avrei dovuto incidere da almeno
cinque anni? Su cui mi ostino a fare annotazioni a
margine della partitura senza mai suonarli. Anche
perché continuo a guardare questo autografo, ad
odiarlo. Ho comprato lenti di ingrandimento di ogni
tipo. Per vedere se in quella calligrafia avrei potuto
scorgere un segno, qualcosa che mi avrebbe portato
non so dove. Non parlatemi di Frédéric Chopin, e se
lo fate sappiate che di lui so tutto. E quel che è peggio
ora so anche tutto di me stesso. E guardo con disperazione
un pianoforte, mirabile congegno di leve e
avorio, di corde e legno stagionato, feltri e chiavi
d'acciaio. Un pianoforte così diverso dal suo, così
lontano da quelli che si usavano nella prima metà
dell'Ottocento.
Com'è diversa questa mia villa grigia dalla sua
stanza in place Vendome, dove forse avrà pensato alla
sua ultima Mazurca. L'ultima cosa che ha scritto:
più che una musica, una musica di idee che si allontana;
incurante del mondo, della vita.
Ma qui divago. L'ho incisa, quella Mazurca. Assieme
ad altre, e allo Scherzo in si bemolle minore, e alla
Ballata in sol minore, la prima, la più famosa. C'è così
poca consapevolezza nella prima Ballata, da lasciare
disarmati; la paragono a quell'età della vita in cui
si prende coscienza del proprio fascino e si gode del
fatto che si è quasi irresistibili. Quando avevo
vent'anni non lo sapevo. A trenta mi rendevo conto di
cosa sarei stato capace di suscitare negli altri, uomini
e donne: e ritenevo che quello fosse l'unico modo per
conquistare il mondo. Non lo conquistai, e difatti sto
qui, in una valle alpina. In Svizzera, chiuso a tenaglia
tra la Francia e l'Italia, a ricordare di quel concerto a
Salisburgo. Non so perché ma lì capii che un'annotazione
come a mezza voce poteva aprirmi il mondo.
Bastava che io facessi più attenzione, che non respingessi
quel frammento di follia che piccolo, insignificante,
è capace di fermare ogni tuo pensiero. Chiude
tutte le strade, te ne lascia una sola come un incubo
da cui non puoi che uscire, una strada obbligata in fa
minore. Sapevo che l'andamento di questa Ballata
era quello di un'improvvisazione. Credo che Chopin
sia partito proprio da un'improvvisazione, una delle
tante che faceva per la delizia di amici e commensali
nelle case di Parigi dove si poteva trovare un
pianoforte. Forse il nucleo originario stava in un luogo
remoto, in qualche nota solo accennata. Le stesse note
che suonavo quella sera, che tornano continuamente,
con piccole variazioni, sul tema. E mi rendevo
conto per la prima volta, questo sì, che in quel brano,
in quelle pagine, c'era tutto lo Chopin che avevo suonato
nella mia vita. C'erano passaggi che sembravan
richiamare un Rondò, e l'Improvviso, persino gli Studi,
e la Barcarola, e le Variazioni e il Notturno. Una
vera e propria summa musicale. Io che al conservatorio
turbavo i miei professori suonando Liszt in prima
lettura senza apparenti difficoltà, che in gioventù sono
stato un virtuoso da applauso infinito (ne ricordo
uno a Mosca di venticinque minuti, dopo aver
eseguito la Sonata per pianoforte in si bemolle maggiore
di Sergej Prokofiev), di fronte all'apparente linearità
di questa Ballata mostravo la sfrontatezza del giovane
pianista di genio. La incisi per la prima volta in un
78 giri, doveva essere il 1946, o il 1947, il disco conteneva
anche la Ballata in sol minore opera 23 e tre
brevi Mazurche. Il disco doveva intitolarsi: Recital
romantico. Proprio ieri, il mio solerte impiegato della
casa discografica, che mostra una conoscenza musicale
enciclopedica, e per questo asfittica, mi ha
annunciato trionfante di aver ritrovato il nastro, il
master originale. «Si credeva perduto», mi diceva con
un misurato affetto che a volte ha la gente che vive
dalle parti di Amburgo. Voleva farne un compact:
«Storico». Anzi, se avesse trovato altri nastri dello
stesso periodo, se ne poteva fare un cofanetto. Non
gli ho risposto subito: con il pensiero sono tornato
all'esecuzione di quella quarta Ballata. Ricordo che la
incisi tre volte: e decisi per la seconda. La terza forse
la suonai meglio, ma un improvviso temporale aveva
leggermente cambiato il suono del pianoforte. Almeno,
a me così sembrava; i tecnici, che sono abituati ad
ascoltare attraverso lucine, levette e cifre non erano
della stessa opinione, dicevano che non si coglieva
alcuna differenza. Mi guardavano con disapprovazione,
allora ero giovane e per nulla famoso. Oggi
quegli stessi tecnici troverebbero sublimi le mie bizze,
e racconterebbero con orgoglio di aver dovuto
incidere una volta ancora perché il maestro non era
convinto del suono, perché il maestro sentiva lo
Steinway leggermente impastato, come se le note
non fossero sufficientemente pulite. Ma quel giorno,
in ogni caso, vinsi io: suonai la Ballata in fa minore
come fosse Brahms, con incertezza e un'ombra di
fredda melanconia. Per poi terminarla con un vero e
proprio Presto con fuoco, tecnicamente perfetto, emotivamente
nullo. Non ero ancora pronto, forse. Gli
strumenti musicali sono di una perfidia senza limiti:
quando sei giovane e possiedi la tecnica pianistica
per suonare tutto ciò che vuoi, non hai la maturità
per interpretare; quando hai la maturità per farlo,
senti le dita che non rispondono più come quando eri
giovane. E solo i critici possono credere che un uomo
di ottant'anni possa suonare con l'elasticità e la
padronanza della giovinezza.
Ricordo Vladimir Horowitz. Ebbe un sussulto di
popolarità nell'ultimo periodo della sua vita. Merito
anche di un concerto a Mosca trasmesso in mondovisione.
Fu uno dei rari casi in cui stetti per più di cinque
minuti di fronte a un televisore: suonava brani
un po' mondani, spiritosi. Niente di introspettivo.
Horowitz è sempre stato così, il suo pianoforte rifuggiva
da ogni pensiero. Il suo Liszt preferito era quello
delle Soirées de Vienne. Il suo Chopin, quello delle
mazurche. E si trovava a proprio agio con gli Studi di
Aleksandr Skrjabin. Tutte cose che non ho mai inciso.
Suonava come fosse tornato ragazzino, ma senza
esserlo. Mi ricordava un mio nonno materno, che ultranovantenne
corteggiava con grazia tutte le ragazze
che non avessero più di vent'anni. E lo faceva davvero,
non per vezzo. Mostrava meno anni di quelli che
aveva, ma in casa era diventato un argomento divertente.
E ricordo che mi chiedeva sempre di fargli
ascoltare la TrÄumerei di Schumann. Un brano che
non suono più da allora, forse, e che ho sentito sotto
le dita di Horowitz proprio in quel concerto di Mosca.
Con i russi che piangevano dalla commozione e
io che avrei voluto capire perché il vecchio Horowitz
non mi faceva ascoltare Debussy. Per saper come si
potrebbe suonare a quell'età autorevole. Macché. La
TrÄumerei la senti da ragazzini imberbi, assai spocchiosi,
e ti perdi tutto. Dovevo essere un po' così,
allora, quando incisi il Recital. Era la prima volta che
visitavo Amburgo. E mi parve una città fantastica,
Gli studi di incisione erano tecnicamente perfetti, anche
se in Germania si respirava un'aria post-bellica
assai pesante, e al tempo stesso molto concreta: capivi
che c'era la voglia di buttarsi alle spalle la tragedia
nazista. Più che una voglia era un imperativo kantiano:
non lasciava esitazioni di sorta, né via di uscita.
Alla fine tutto questo venne definito con una parola
presa in prestito dalla psicoanalisi: «rimozione». Ma
in quel momento c'era la voglia di poter ricominciare
a viaggiare per l'Europa, e l'euforia copriva la cenere
su cui avremmo camminato ancora per anni.
L'euforia deve aver contagiato anche la mia mente
e le mie mani, perché incisi quel brano in un modo
che molti anni dopo mi avrebbe turbato. Accadde nel
1970. Ero di passaggio a New York, città dove capitavo
spesso in quel periodo. Vladimir Horowitz mi fece
avere un bigliettino dove mi invitava a un suo
concerto alla Metropolitan Opera House che avrebbe
tenuto un paio di giorni dopo. Mi fermai a malincuore:
detesto New York. Quella sera andai subito a salutare
Horowitz in camerino. Lui mi guardò e mi disse,
ammiccante: «Suonerò per lei la quarta Ballata.
Ricordo la sua prima incisione. E' la migliore interpretazione
che io conosca di quel brano. Accesa, potente,
si sentono tutte le pause. Oltre che le note. E' un
omaggio a lei». La suonò proprio nello stesso modo.
Si appropriò della mia protervia giovanile. Ed ebbi
un tonfo al cuore, perché capii che Horowitz non la
suonava bene: troppo veloce. Suonata con un virtuosismo
che mi irritava, persino poco preciso in alcuni
passaggi. E finiva come se mancasse tempo. Come se
al termine dell'esecuzione lo attendesse il responso
di un cronometro fermato al momento giusto.
Quel giorno a Salisburgo, cinque anni dopo, volevo
suonarla in un modo diverso. Volevo che fosse
lenta, dubbiosa del proprio procedere. Sarebbe stato
bello se qualcuno del pubblico si fosse chiesto:
cos'ha? non si sente bene? Era quello che volevo:
fingere insicurezza per far dell'insicurezza un cardine
dell'interpretazione. Mi devo consolare: nessuno,
posso giurarlo, lo ha pensato. Nessuno ha creduto
che fossi insicuro. Questo è un mondo dove le opinioni
procedono in fila, e tutte uguali, come gli
impulsi elettrici. Quella sera a Salisburgo, quando
cominciai il primo tema e tenni un istante di più il terzo
dito su quel do che fa da cerniera nel passaggio da do
maggiore a fa minore, bene, in quel momento tutto il
pubblico avrà pensato che stavo esprimendomi al
meglio, che avevo di fronte a me tutta la Ballata e la
dominavo con il pensiero, prima che con le mani.
Niente di più falso. Forse fu una grande interpretazione,
ma il pubblico (e questo accade spesso) pensa
delle cose giuste, ma per ragioni sbagliate. Si può
cioè arrivare a un risultato esatto attraverso calcoli
errati. E' sconcertante, passare una vita a studiare
dettagli che nessuno può cogliere.
Il mondo della musica non è misurabile con nulla, è
incommensurabile, un'altra dimensione. Vai a spiegare
che un compositore è passionale e un altro è freddo,
che la musica di Bach si riconosce da quella di Scarlatti,
e quella di Beethoven è diversa da quella di Wagner!
Ma se dobbiamo raccontare la musica di Bach a
chi non l'ha mai sentita, non possiamo che rifarci a termini
generici: geometrico, preciso, rilassante, orditore
di trame armoniche simili ad arazzi pregiati. Oppure
entrare nei tecnicismi musicali, viaggiare dentro l'arte
della fuga, distinguere le singole voci del Clavicembalo
ben temperato, e rifarci al Barocco, e al Seicento; svelando
parallelismi, usando come sfondo la filosofia,
scomodando la matematica del tempo. O ancora regalandosi,
e penso questa volta a Wagner, una lettura di
Nietzsche pronta a mettere in crisi tutti i luoghi comuni
sul Tristano o sul Parsifal.
La storia della musica (ma che dico, ma quale storia!)
è un continuo accumularsi di riferimenti e citazioni
che cercano di supplire a quel vuoto descrittivo,
a quell'impossibilità di narrare una partitura. La storia
della musica è un continuo stratificarsi di citazioni
dotte, una sopra l'altra, utili a dire quello che per
molti sembra indicibile. Perché un accordo in tonalità
minore è più triste dello stesso accordo in tonalità
maggiore? Chi può spiegarlo? Forse quelli che ti
raccontano che la diminuzione di un semitono sulla terza
di un accordo di quinta porta a una diminuzione
del proprio stato d'animo, e dunque intristisce?
Sciocchezze. Nessuno riesce a dare una spiegazione
accettabile. Eppure è vero, la tonalità minore è più
triste di quella maggiore. Ma ora sto divagando. Non
è di Johann Sebastian Bach che qui devo raccontare, e
neppure di Parsifal, Nietzsche e Wagner, né tanto meno
della tonalità minore o di quella maggiore. Ma devo
raccontare, se mi riuscirà, di come il ritrovamento
di un manoscritto che si credeva perduto ha cambiato
la mia vita. Se solo sapessi narrare con un po' d'ordine
questa storia, che comincia in un giorno di giugno,
meno di vent'anni fa. Un giorno di sole talmente
afoso che persino la Senna, esausta, sembrava volesse
smettere di scorrere, o almeno così pareva dalle
finestre della mia casa sul Quai d'Orléans.
Capitolo secondo.
Le finestre che davano sulla Senna erano tre: ampie e
altissime. Non entrava solamente la luce da quei vetri.
Molto di più, era come se il cielo avesse un'anima;
meglio, un motore che guidava nuvole, che accendeva
colori, e subito dopo li sfumava, facendo del blu
prima un azzurro, poi un grigio tendente al cerùleo,
per virare sempre di più e divenire perlaceo, intenso
e luminoso. E poi nero, senza bagliori, di uno scuro
che trasformava il fiume quasi in un Acheronte e rendeva
ancora più bianche e perturbanti l'abside e le
due torri di Notre-Dame. E, a volerlo, anche la Tour
Saint-Jacques. Lo spettacolo di questo cielo del nord
mi ha sempre accompagnato nelle ore che stavo
seduto al pianoforte. E quando suonavo a memoria mi
capitava spesso di perdermi a guardare quello scorcio
che cambiava come fosse guidato dalla mia musica,
e devo ammettere che alle volte ero proprio io a
scegliere le pagine più simili al mio stato d'animo e al
colore del cielo.
La mia casa era a due numeri civici di distanza dal
museo Adam Mickiewicz e dalla biblioteca polacca.
Lì si conservano cimeli, autografi di Chopin e persino
la sua maschera funeraria, ma, ironia, non ci sono
mai stato. Quegli autografi non mi interessano, e
Mickiewicz, poeta polacco amico di Chopin, ebbe
troppa grazia dalla storia e dal destino. Curioso
personaggio, Mickiewicz: visse in Russia e fu amico di
Puskin. Passò quasi l'intera vita in esilio. E con Chopin
arrivò a Parigi nel 1831. Il suo antizarismo divenne
fastidioso persino per Luigi Filippo. Fu espulso
anche da Parigi e passò i suoi ultimi anni a Roma, in
una sorta di misticismo poetico e nazionalista: credeva
che alla Polonia, «Cristo delle Nazioni», toccasse il
compito storico del sacrificio in nome del trionfo dello
spirito nazionale. Naturalmente fu un cantore
mediocre, le sue opere fuori dalla Polonia sono quasi
dimenticate, le sue idee oggi suonerebbero a dir poco
ridondanti, ma la fortuna volle che Chopin dichiarasse
di essersi ispirato ai suoi versi per scrivere le quattro
Ballate. Forse è vero solo per la prima, quella in
sol minore, dell'opera 23. Riguardo alle altre, penso
che fu più un complimento di Chopin. Dal museo
Mickiewicz non si vedevano uscire troppi visitatori,
si doveva chiedere un appuntamento, e una guida
accompagnava il pubblico tra cimeli e autografi
polacchi. Ma certamente la musica del mio pianoforte
arrivava fino lì, e poteva colpire più di un visitatore,
specie quando finivo per suonare proprio Chopin, e
magari qualche Ballata. In quel periodo, ricordo che
si era alla fine degli anni Settanta, avrei dovuto incidere
proprio la Ballata in sol minore e alcuni Notturni,
in particolare il Notturno op. 48 n. 1, che Chopin
pensò, elaborò nella chiesa di Saint-Germain-desPrés, dove aveva trovato riparo durante un violento
temporale. Almeno questa è la leggenda. Una
leggenda datata 1841: Chopin ha trentun anni, è nel
periodo più fertile; in quell'anno scrive anche la sua terza
Ballata, in la bemolle maggiore, la Polacca in fa
diesis minore, il Preludio in do diesis minore. I suoi
rapporti con George Sand sono ancora tollerabili, la
sua salute, tra alti e bassi, gli permette di lavorare e
dare concerti affollatissimi, e l'estate a Nohant lo
aiuterà ad attraversare con maggior vigore i faticosi
inverni, anche se di lì a pochi anni la malattia lo debiliterà
sempre più e lo condurrà alla morte.
Ho pensato spesso a questa leggenda di Saint-Germain:
come molte storie che si riferiscono a Chopin è
quasi priva di ogni fondamento. Ricordo la fatica che
feci in quel periodo per trovare un modo di raccontare
quel Notturno, e di come poi decisi di non inciderlo. Se
ci penso, sono davvero troppi i brani che ho rinunciato
a incidere. Questo Notturno poi mi irritava: difficilissimo
da interpretare, e tecnicamente poco appariscente,
nascondeva una parte centrale adatta a mani grandi e
grande forza. Un inizio lento e cantabile lascia il posto
a un crescendo di doppie ottave, assolutamente
imprevedibile, corale, con grandi accordi come se il brano
fosse scritto per organo. Forse è per questo che si
racconta di Chopin in chiesa, del temporale, del rifugio
che diventa fonte di ispirazione. E con un finale
agitato, inquieto, che si conclude con tre accordi, gravi
e pianissimi di do minore.
Come dire: era il Notturno meno Notturno di
Chopin, ma rispecchiava meglio di ogni altro il mio
stato d'animo di quel periodo, fuggito dall'Italia perché
l'aria era torbida, perché temevo che accadesse
qualcosa di irreparabile. Ero disgustato, da tutto. Ebbi
il colpo di grazia, capii di essere arrivato al massimo
dell'irritazione quando fui fermato da quattro
agenti di non so quale servizio d'informazione. Aldo
Moro era nelle mani delle Brigate Rosse, una formazione
terroristica italiana di quegli anni. Era d'aprile,
nel 1978. Milano era presidiata. Io tornavo a casa,
quando in via Manzoni venni fermato dagli agenti.
Mi fu puntato il mitra all'altezza del mento. E dovetti
consegnare la borsa che avevo con me. Non avrebbero
potuto, erano documenti personali, ci voleva un
mandato di perquisizione. Le mie proteste non servirono
a nulla, non bastò nemmeno che dicessi chi ero,
che garantissi amicizie importanti. Sogghignavano.
Aprirono la borsa, trovarono fogli in tedesco. Erano
contratti e lettere del mio editore discografico: Deutsche
Grammophon. Fu scambiato per materiale propagandistico,
che proveniva, per di più, da un paese straniero.
Tre dei quattro agenti erano giovani e arroganti,
un po' rudi, mi dissero di allargare le gambe, e
di appoggiare le mani sul tetto della loro auto. Chiamavano
attraverso una radio ed era tutto un gracchiare
con un sottofondo di voci confuse. Il quarto
agente mi guardava, mi fumava sul viso, e voleva
dimostrare di saperne più di tutti. Strappò di mano i
miei documenti all'agente più giovane, e disse con
fare sprezzante: «Questi li prendo io». Pensai che
leggesse il tedesco e mi sentii rincuorato. Avrebbero
capito, tutto si sarebbe spiegato di lì a poco. Invece
no, le cose andarono peggiorando. Fu deciso che mi
avrebbero portato via, per radio continuavano a dire
il mio nome e ad aggiungere: «Un tipo sospetto». Ero
spaventato, ma ancor di più scandalizzato. Perché
mi rendevo conto che volevano terrorizzarmi, che
non pensavano affatto potessi essere un pericoloso
terrorista. Forse non avevano capito che ero un
pianista, certo non conoscevano il contenuto dei miei
documenti e la mia etichetta discografica, ma sapevano
che quel modo arrogante di parlarmi, di puntarmi
le armi, di rivoltarmi le tasche non doveva
portare a nulla, solo alla glorificazione del loro misero
potere. Ripetevo il mio nome, avvertendoli che
ero un famosissimo pianista, e ricordo lo scherno, il
ghigno supponente di tutti loro. Così subii anche
l'oltraggio di passare una notte in carcere. Di dover
togliere la cintura (non porto mai cravatte), di imprimere,
debitamente inchiostrati, i miei polpastrelli
sulla carta per lasciare le impronte digitali (e di tanto
in tanto mi chiedo: diventeranno una rarità per
collezionisti?). Il giorno dopo fui liberato, con le scuse del
prefetto e del capo della polizia. Non esitai oltre. Il
tempo di sistemare le cose, di avvertire le pochissime
persone a me più vicine: e avrei lasciato, forse per
sempre, l'Italia.
Scelsi l'esilio di Parigi. E non rimpiansi Milano, città
frivola, modaiola e opportunista, che mi definiva un
reazionario, un elitario. In tutta fretta mi fu trovato
quel meraviglioso appartamento sul Quai d'Orléans,
uno dei luoghi più amabili di Parigi, e naturalmente
uno Steinway, modello CD 318, costruito nel 1938.
Quando lo suonai la prima volta ebbi un sussulto,
volevo che fosse abbassato il punto di appoggio del
tasto, in modo che il pianoforte reagisse a un tocco più
pesante, e Dio sa quanto ne avevo bisogno in quel
periodo. I tecnici mi risposero che era un pianoforte
perfetto. Io non lo suonai per venti giorni, tanto bastò a
convincerli, e il mio suggerimento poté esser preso
per buono. Il CD 318 è tuttora il mio pianoforte preferito.
Ed è l'unico che continuo a suonare, qui, in questo
esilio noioso. Per il tempo che non toccai lo strumento,
in uno di quei bracci di ferro insensati a cui
sovente non so resistere, passeggiai molto: la sera per
Saint-Germain, a guardare le donne sedute nei caffè.
Poi ripresi a suonare con un'intensità nuova, che
mi sorprese. Per la verità un pianista come me non
studia mai in modo tradizionale. Quasi non studia,
ma ascolta sé stesso, guarda le sue mani muoversi,
decide una diteggiatura diversa da quella scritta, per
capire se il suono che poi ne deriva può dirsi più efficace.
Un concertista non studia, ma interroga il pianoforte;
chiede suoni più limpidi, calibra le dita perché
esca quel timbro che a lui sembra il più giusto, il
migliore. E poi magari sbaglia, si rende conto che
ancora qualcosa non funziona, che il pedale è troppo
duro, non risponde come si dovrebbe, e ricomincia
daccapo, e daccapo ancora, se crede sia necessario.
Quel Notturno di Chopin, che i visitatori del vicino
museo dovevano ascoltare con stupore, mi teneva
lontano dalla Ballata in sol minore che continuavo a
rimandare; e naturalmente (ma ancora non lo sapevo)
dalla quarta, quella in fa minore.
Una notte conobbi una ragazza, in uno di quei soliti
caffè parigini che finiscono per esser tutti uguali; è
curioso quanto gli scrittori amino descriverli, distinguerli,
dare loro un nome. Quella sera non ero da Flore,
o ai Deux Magots, o in un anonimo locale del
boulevard Saint-Michel, ma in un caffè a rue de Rennes,
un po' dopo l'incrocio con boulevard Raspail. Mi
spingevo spesso fin verso Montparnasse, un quartiere
dove non vedi gente che guarda per aria mentre
cammina. E i visi degli uomini e delle donne sono
quelli di chi sta vivendo la propria routine. Mi fermavo
la sera tardi, a leggere in quel locale che aveva, come
accade spesso, i tavolini appoggiati ai grandi
vetri finestra che danno sulla strada.
Quella sera, forse era quasi notte, vagavo con ancor
meno decisione del solito. Incrociavo sguardi
complici e curiosi. Mi è sempre accaduto; ho sempre
pensato che la gente mi riconoscesse, quella che
incontravo per strada, all'aeroporto, persino all'edicola.
E non perché avesse tenuto a mente la copertina di
qualche mio disco, dove spesso il mio viso appare in
primo piano, ma perché mi si legge negli occhi che
vivo in un mondo sospeso, in un mondo non verbale,
dove le parole non riescono a entrare, girano attorno,
assediano la musica, cercano di trovare un varco, ma
poi devono desistere. Quella notte sembrava che i
miei pensieri si leggessero attraverso i miei occhi, e
tutti, in quel locale dove mi ero seduto, ne stessero
discutendo. Proprio tutti, dalla cameriera alla vecchia
signora che stava poco distante da me. Non ebbi il
solito moto di fastidio, tutt'altro: cominciai a pensare
che non mi sarebbe dispiaciuto se, per paradosso,
tutto il caffè si fosse impegnato in una pubblica
discussione sul mio talento pianistico. Accendevo una
sigaretta dopo l'altra, una passione che ancora oggi
mantengo, e mi resi conto che qualcuno mi fissava.
Fu come un presentimento, lei non sedeva esattamente
di fronte a me, ma di lato, e io non stavo neppure
guardando in quella direzione, ma un sesto senso
mi disse che due occhi mi osservavano. Mi voltai,
lentamente, e non abbassò lo sguardo. I capelli biondi
e gli occhi di un colore indefinibile davano al suo
viso una strana luce. Il libro aperto sul tavolino e la
tazza di tè sembravano disposti come se avessi dovuto
cogliere un equilibrio delle forme. E per di più il
suo volto mi ricordava quello di una ragazza che
portava un grande cappello in un quadro di Eugène
Delacroix, un piccolo olio su tela che avevo visto a casa
di un collezionista.
Era un'ossessione, ancora una delle mie ossessioni,
il pensare a Delacroix proprio in quel momento?
C'era un legame con il fatto che il grande pittore fosse
tra gli amici più assidui e sinceri di Frédéric Chopin?
C'è sempre un legame. Mentre pensavo a questo
la ragazza con il cappello (ma sono io a chiamarla così,
come il quadro, non portava cappelli, naturalmente,
e l'abbigliamento era quello di una giovane qualunque)
mi sorrise e la invitai a sedere al mio tavolo.
Portò con sé il libro, guardai la copertina. Era il Voyage
au Congo di André Gide. Gide? Un caso, un destino,
che significato poteva avere, e che rapporto aveva
con me una ragazza che assomigliava a quella di un
quadro di Delacroix e leggeva un libro di André Gide?
Avevo letto il Voyage. Ma forse il libro di Gide che
conoscevo meglio era un'esile plaquette intitolata
Notes sur Chopin. Mi guardò, vaga, e sorrise: non sapeva
che Gide era anche un modesto pianista, che
aveva scritto una serie di considerazioni sull'arte di
Chopin. E di certo ben poco doveva sapere di me,
anche se il mio nome doveva dirle qualcosa. Molto più
delle considerazioni di Gide dedicate a Chopin. Però
una di queste si addiceva alla bizzarra situazione che
si era creata quella notte: «E' ovvio», scriveva Gide,
«che numerose composizioni di Chopin comportano
andature di fantastica rapidità, ma, in generale, ogni
virtuoso suona indifferentemente quasi tutte le
composizioni di Chopin il più presto possibile, ed è ciò che
mi sembra mostruoso». Aveva ragione Gide. E'
mostruoso il pianismo circense: l'eccessiva rapidità turba
gli animi, impedisce di vedere i contorni.
Ho sempre avuto orrore della velocità. E persino
quella notte, di fronte alla ragazza con il cappello, temevo
la rapidità della seduzione, quel modo di saltare i
passaggi, quel linguaggio sensuale che talvolta attraversa
le volontà e impedisce di darsi regole, comportamenti,
un'etica insomma. Ma come poteva sottrarsi
a tutto questo un uomo abituato alla sensualità della
musica, romantica e post-romantica; uno come me,
capace di eseguire un Preludio di Debussy decine e decine
di volte finché i suoni non diventavano una variante
stessa del proprio sistema nervoso. Non ricordo, e
forse qui non lo voglio neppure ricordare, se mi chiese
a ora tarda di portarla a casa mia. E, certo, non interessa
riferire di ciò che accadde. Però la mia mente era
occupata a bilanciare i sensi della musica con l'erotismo
di un uomo che, d'un tratto, aveva cambiato gli scenari
quotidiani, e forse anche quelli mentali. Neanche a
dirlo, il mattino dopo le parlai di quel Notturno: la
mia punizione, il mio girare in tondo, il mio inferno
dantesco. Non sapevo cosa sarebbe accaduto di lì a
qualche giorno, ma sentivo che dovevo soffrire per
qualcosa; e non certo della ragazza che mi aveva chiesto
di passare la notte nel mio letto. Capiva esattamente
di cosa stessi parlando. Chissà, forse aveva studiato
musica, forse anche pianoforte. Io volevo liberarmi
del Notturno a tutti i costi. Chiamai persino Amburgo.
Volevo inciderlo. Mi chiesero: maestro, verrebbe
fin qui solo per lasciare sul master quattro minuti scarsi
di musica? Dovevo averli sconvolti, sapevano che
ero eccentrico, ma ogni buona volta si ostinavano a
dimenticarlo. E facevano assai bene; in realtà non capivo
neppure io cosa mi stesse accadendo.
Quella mattina continuavo a parlare, le raccontavo
che il tema della prima parte è malinconico ed esitante,
quasi Chopin volesse rimproverare a sé stesso tutte
le sicurezze giovanili di un uomo consapevole del
proprio fascino e del proprio successo. Tutto è
capovolto, gli abbellimenti della composizione diventano
struttura portante, mentre le note portanti vanno
suonate quasi fossero abbellimenti. Il fascino del
Notturno è nei colori del buio, nelle note blu, come le
chiamava Delacroix. E per tutte le prime ventiquattro
battute si ascolta un tema dove sembra dominare
l'indecisione, quasi che la nota successiva debba
rinnegare quella precedente, ma, come in un perfido
gioco tra amanti, alla fine questo non avvenga mai.
Parlavo senza quasi prendere fiato. Io poi, che detesto
proferire parola sulla musica e odio tutti i musicisti
che scrivono libri sul perché hanno suonato quel
tal brano o quell'altro.
E allora perché? Forse un perché c'era, c'era
un'analogia tra quel brano di Chopin e il mio modo di sfiorare
e spogliare quella donna. In qualche modo avevo
scelto lo stesso ritmo, la stessa indecisione, persino la
stessa tonalità. O magari non è così, magari la musica
è davvero un mistero che nessun parallelismo, nessuna
ripetizione, e nessuna analogia potrà mai sfiorare.
Per tutta la vita la musica mi è parsa chiara, spiegabile
e luminosa; ma anche l'opposto: ambigua, misteriosa,
talvolta demoniaca. Non raccontavo alla ragazza
con il cappello, citazione vivente di Delacroix, dei
miei dubbi sulla musica, e neppure che il mio piacere
quella notte assomigliava a degli accordi potenti e
corali. E che ero affascinato da lei almeno quanto dal tema
del Notturno che tornava, in do minore, dopo tutta
quella parte in do maggiore, persino violenta per
forza e determinazione come fosse una grande Sonata
di Beethoven eseguita da Liszt. E tornava con la forza
di un pianissimo agitato. Facendo riaffiorare il tema
iniziale ma in modo diverso: la malinconia lasciava
spazio alla consapevolezza, l'indecisione si trasformava
in qualcosa di molto simile a una timidezza
sfrontata. Non mi chiese di suonare quelle note. Fui
grato di quella delicatezza. Credevo che non l'avrei
più rivista, ma il destino a volte gioca scherzi curiosi.
Da quel giorno non pensai più al Notturno: come
se avessi risolto un nodo interpretativo senza dover
sfiorare il pianoforte. Mi confortava che la musica, la
mia musica, avesse qualche rapporto con la vita, ma
era un conforto apparente, forse. Quella sera stessa
mi sarebbe accaduto qualcosa che ai musicisti càpita
assai raramente. Forse mai. E dovevo anche ringraziare
la ragazza che leggeva Gide, e conosceva quello
che Gide aveva scritto su Chopin, e la vicinanza con
il museo Mickiewicz. Anche se spesso eventi come
questi accadono per caso, e non per un destino, una
necessità, o una volontà superiore. Ma cercherò di
procedere con un qualche ordine, per quanto mi sia
possibile e, debbo ammetterlo, sopportabile. Anche
perché Parigi è una città che mi ha sempre dato
l'inquietudine dei Preludi, come se non fosse risolta, come
se mi lasciasse incompiuto: è una città che non
riempie la tua vita, che non ti assorbe completamente,
come potrebbe essere New York o Berlino. E' una
città che vive attraverso grandi vetrate: un po' come
quando stai seduto in quei caffè, e guardi la città
attraverso i vetri, e ne senti i rumori leggermente attutiti
e gli odori smorzati, e le luci restituiscono riflessi
inaspettati; e dopo un po' non sai più quanto sia tu a
esser dietro un vetro oppure se invece sia la città dentro
un tuo acquario immaginario. Non pensavo di
certo a queste cose in quei giorni, lo faccio ora, che vivo
in una casa con pochi vetri, pochi specchi, e troppe
protezioni, vittima di una nevrosi che allora non si
era ancora del tutto rivelata, ma correva sul fondo,
come un ostinato, o un basso continuo, o la mano
sinistra del terzo movimento dell'Appassionata di
Beethoven, presago e incessante, persino fascinoso
nel suo ripetersi oltre misura.
Quando ero ragazzino lo abbreviai, quel terzo
movimento dell'Appassionata. Avevo la sensazione che
Beethoven lo avesse scritto per farla durare più a lungo,
ripetendosi. E feci di peggio: a un saggio mi rifiutai
di suonare la parte finale com'era scritta, bensì la
rallentai, in modo esasperato e provocatorio. Perché
l'originale mi pareva un'inutile esibizione di velocità
pianistica; buona per gli applausi degli incompetenti,
che vedendo volare le mani sulla tastiera credono di
trovarsi dinnanzi a un pianista virtuoso ed entusiasmante.
E dire che poi magari sentono suonare la
quarta Ballata, e non si impressionano allo stesso modo.
Sembra un giochetto la quarta Ballata (almeno
all'inizio) e invece tu studi, tremi per la tensione, per
la paura che non si senta tutto come dovrebbe. Ai
saggi di pianoforte, dovevo avere nove anni, dieci
forse, ma con le idee ben chiare, c'è sempre un
pubblico di insegnanti e genitori, amici degli studenti.
Quel che si dice un pubblico di esperti. L'Appassionata
non è Sonata che io abbia mai amato. Ma fui
quasi costretto a eseguirla. Quando nel finale tutti si
accorsero che non acceleravo, sentii prima l'incomprensione,
poi il gelo della sala. Applaudirono, applaudirono
comunque, quasi con calore, ma non capivano.
E provai il disagio della superficialità, del
giudizio inconsistente: ma anche una sorta di onnipotenza,
per la prima volta ero padrone dei miei
compositori, li giudicavo; per la prima volta seppi
che con la musica si poteva osare.
Da allora ho lottato con il mio perfezionismo, e più
ero rigoroso nel mettere a punto le mie note, i miei
toni e semitoni, e dunque le mie convinzioni e la mia
visione del mondo e della vita, più facevo attenzione
che la cassa armonica restituisse un suono che io ritenevo
perfetto, più sapevo che quella era una strada
che mi avrebbe lasciato solo, sempre più solo. La
perfezione voluta, l'ossessione del più piccolo dettaglio,
portano alla solitudine; di certe cose parlo ancora con
il mio accordatore: dei risvolti tecnici, intendo. Ma
della musica, delle differenze che io sento non trovo
più interlocutori disposti non tanto a seguirmi (molti
lo farebbero, se non altro per moda), piuttosto a
capirmi, a comprendere, a vedere con il mio stesso
occhio, con la mia stessa acutezza.
Ma non c'era bisogno di una vista acuta per capirlo:
quel signore che stette per più di cinque ore sotto la
mia finestra, a guardare in alto, ascoltando la mia
musica e sperando di vedermi affacciare, aveva un morboso
bisogno di parlarmi e - in più - sapeva assai bene
chi fossi. Di certo non poteva chiamarmi da giù, anche
se sull'île-Saint-Louis è possibile, non sembra Parigi
ma un borgo di campagna della Loira, ma poi basta
che passi il ponte e sei sulla rive Gauche, tra odori greci,
frotte di turisti e studenti svogliàti; e cambia tutto.
Non mi chiamò, dunque, ma avrebbe voluto farlo. Io
incrociai il suo sguardo un paio di volte. La prima con
distrazione, senza capire. Molti si fermano ad ascoltare
il pianoforte, passando dal Quai, e ci ho fatto
l'abitudine. Trovano che suono bene, ma certo non possono
immaginare che molti fanno file di ore per avere un
biglietto che dia la possibilità di ascoltarmi in una sala
da concerto. Non avevo nulla di che stupirmi se un
signore con i baffi, e l'aspetto un po' sciatto, certo modesto,
guardava in direzione di una finestra da cui
proveniva una musica assai bella: stavo rivedendo la Suite
bergamasque di Debussy. Ma ebbi come un'intuizione:
quel signore sembrava ansioso, di più, angosciato,
persino impaurito. Non godeva della mia musica, ma
fremeva, come fosse in una posizione di stallo da cui
avrebbe voluto uscire. Aspettai ancora. Gli ascoltatori
casuali, quei tanti che passano sotto la mia finestra, se
il pianoforte tace si allontanano in fretta. Lui no. Pensai
che attendesse nuova musica, ma dopo un'ora era
ancora fermo, lì sotto, come aggrappato a una speranza:
forse aveva bisogno di soldi. Fu allora che decisi di
affacciarmi, di appoggiare i gomiti sul davanzale,
sporgermi e dal mio primo piano, tre metri di altezza
o poco più, guardarlo a lungo negli occhi per capire se
cercasse qualcosa da me. Ma stavo per scoprire che in
verità ero io a cercare qualcosa da lui.
«Eppure lei, maestro, l'aveva detto. Eppure lei aveva
fatto balenare che quella partitura poteva essere un
lavoro non definitivo. Come se Chopin volesse ancora
ripensare il finale del brano, come se non lo convincesse.
Accadeva spesso. La seconda Ballata, ad esempio,
pare finisse in la minore, non in fa maggiore.
Ricordo una sua intervista di molti anni fa. Lei diceva:
"Non mi stupirei di trovare una versione della quarta
ancora diversa da quella che conosciamo".»
Non lo ricordavo, per la verità: i tuoi ammiratori
tengono a mente ogni parola, ogni nota incisa, come
qualcosa di memorabile. Pensano alla tua vita come
fosse sotto teca: tutta illuminata da luci così risplendenti
da far sembrare scintillanti anche pietre preziose
false, diamanti sintetici. No, non ricordavo, devo
ammetterlo, di aver parlato a un giornalista russo
venticinque anni prima, né tantomeno di aver messo
in dubbio la partitura della Ballata in fa minore. Però
lo trovavo plausibile, era convincente. Il mio interlocutore
non aveva perso la sua agitazione: anzi, mi pareva
ancora più sudato di prima; come se in quel
caffè all'angolo tra rue Dante e rue Domat avesse la
sensazione di esser seguito, braccato da qualcuno che
non voleva parlasse con me. D'un tratto glielo chiesi,
sorrise, e mi spiegò che un russo, con pochi denari,
fuggito da Mosca, ha sempre la sensazione di esser
braccato, sente sul collo il fiato freddo della storia.
Parlava un francese con un accento tedesco, diceva di
conoscere il polacco ma di conoscere ancor meglio
me, e di avermi ascoltato suonare tre volte nella sua
vita: una a Leningrado e due a Mosca. Gli chiesi le
date, e devo dire che non le ricordavo neppure io. Volevo
capire se diceva il vero. Me le disse di seguito,
come un ragazzo che si è preparato agli esami e vuole
dimostrarlo rispondendo con prontezza: «16
dicembre 1958, 6 giugno 1962, 19 aprile 1971». Mi
guardò, come a cercare conferma, io abbassai lo
sguardo. Lui poteva ricordare. Io per nulla. Era vero:
nel 1958 suonai a Leningrado, e doveva esser dicembre.
Nei primi anni Sessanta tornai più volte a Mosca,
e tenni molti concerti. La data del 1971, la più vicina,
curiosamente mi appariva come la più estranea. Era
vero che nel 1971, e di aprile, ero a Mosca? Chissà,
probabilmente aveva ragione il mio interlocutore. Mi
disse che era un violinista fuggito a Parigi. Il suo
sguardo, gli occhi chiari, le mani nervose me lo rendevano
sospetto. E non mi era mai accaduto che un
uomo mi dicesse, come fosse una parola d'ordine, un
tacito patto tra me e lui: «Maestro, sa cosa vuol dire
in polacco zaginiony? Le sto parlando dell'autografo
della quarta Ballata». Sapevo bene che zaginiony voleva
dire «disperso». E dunque sapevo che quell'autografo
della quarta Ballata non esiste, che nessuno lo
ha mai visto. Come sapevo d'altronde che della quarta
Ballata non esiste un manoscritto integrale; solo
due, e parziali: uno alla Bodleian Library di Oxford e
uno alla collezione R.F. Kallir di New York. Sapevo
anche, e non era certo un segreto, che il manoscritto
della Bodleian ha 136 misure soltanto, mentre quello
di New York, sebbene in 6/4 e non in 6/8, ne aveva
79. Poco. Alfred Cortot mi raccontò molti anni prima
che le pagine della quarta Ballata conservate a New
York gli sfuggirono di mano per poco. Fu nel 1933 a
Lucerna, e destarono sconcerto perché Chopin le
scrisse in 6/4, solo dopo le cambiò in 6/8. Il russo mi
guardò: «Lo sa da dove veniva quel manoscritto? Da
Berlino. Berlino era un luogo tragico e misterioso,
specie dopo il 1935. Circolavano fogli preziosissimi.
Spesso erano suonati in appartamenti privati e non
venivano mai pubblicati. Si racconta di manoscritti di
Beethoven sconosciuti, ma anche di Mozart. Leggende,
maestro, nessuno ci credeva. Quando però i russi
entrarono a Berlino, portarono via molte casse da una
stanza della Deutsche Staatsbibliothek, e anche intere
collezioni private di alti ufficiali del Reich. Lei conoscerà
la Deutsche Staatsbibliothek? Son sempre circolate
leggende sui suoi manoscritti musicali. Sono
sessantamila: c'è tutta la storia della musica, quella
conosciuta e quella sconosciuta. Perché non tutto era
schedato, non tutto si poteva vedere. Se ne parlava a
Mosca, subito dopo la guerra. Mio padre che morì
qualche anno dopo la fine della guerra, nel 1952, in
qualche lager staliniano, insegnava violino all'Istituto
Gnesin e raccontava di questo tesoro arrivato in
Unione Sovietica che veniva passato di mano in mano
e mai pubblicato. Massimo privilegio del potere.
Così tra noi studenti, io ero allora al quinto anno di
violino, cominciò a circolare la voce di una decima
Sinfonia di Beethoven. Questo era davvero uno
scherzo, una burla di ragazzi. Ma il Kgb si preoccupò,
e ricevemmo delle minacce. In ogni scherzo c'è
sempre un fondo di verità, lei capisce vero, maestro:
la decima Sinfonia no, proprio non poteva esistere.
Ma chissà, era possibile ci fosse altro. Smettemmo
subito di inventarci storie che sembravano fatte apposta
per rovinare la nostra vita. E accaddero cose che
avrebbero sconvolto la mia esistenza e quella di amici
molto cari che qui non posso raccontarle. Anche se
dalla scomparsa di mio padre io ebbi una sola idea
fissa. Fuggire dall'Unione Sovietica. E ci riuscii».
Chi era questo signore che si era presentato con un
nome qualsiasi? Un fuoriuscito, un dissidente, magari
una spia. Come sapeva dove abitavo? Solo la mia
casa discografica conosceva il mio indirizzo. Ma in
quel momento era inutile tentare di fare chiarezza su
questi aspetti. Personaggi così possono raccontarti
tutto, e il suo contrario. Disse che più volte andò alla
Biblioteca polacca per vedere certi autografi di Chopin.
E che lì era stato quasi avvolto da una musica,
dal suono di un pianoforte abbastanza vicino. Prima
non ci fece troppo caso. Poi riconobbe la Ballata in sol
minore, e intuì che non poteva essere uno studente
qualsiasi. Così tornò per alcuni giorni cercando di
capire da dove potesse provenire quel suono. E fu colto
da un'emozione fortissima; l'interpretazione, lui dice,
era di una sapienza non comune. Non gli ci vollero
molti giorni per vedermi uscire di casa e riconoscere
(«ma solo un po' invecchiato») quel pianista
che aveva applaudito a Mosca e a Leningrado.
Reggeva il racconto? Reggeva. Ma poteva anche
essere falso, e non mi importava. Quel che importava
era altro. Capire cosa volesse da me. Certo del
denaro; bastava guardarlo per accorgersi che aveva
bisogno di denaro, e anche molto. Ma in cambio di
cosa? «Ricorda la battuta 211 della Ballata in fa minore?
Certo che la ricorda.» No, non l'avevo presente. I
cultori di musica credono che i pianisti, i violinisti,
abbiano in mente i brani per numero di battuta. Una
cosa folle. Certo, avevo capito che si trattava della fine
della quarta Ballata. Ma non potevo stabilire il
punto esatto a cui si riferiva. I pochi tavolini accanto
a noi erano occupati da avventori casuali, che
cominciarono a guardarci. Dovevamo rappresentare un
bizzarro spettacolo. Io in maniche di camicia, lui
vestito con una giacca di cattivo taglio, verde petrolio,
senza un bottone ma con il filo che ancora pendeva,
e con dei pantaloni di lino grezzo stropicciati e
consunti. Nonché vecchi mocassini senza calze e le mani
bianche bianche. Si guardò attorno, più di una volta,
poi mi disse: «Usciamo, stiamo dando nell'occhio,
non vorrei ci avessero seguito». Non credevo a una
parola di quanto mi diceva. E potevo sospettare che
fosse un impostore. Però sapeva la musica, parlava il
mio stesso linguaggio, mi guardava ansioso, cercando
da me conferme, comunicazione, solidarietà. Come
potevo non comprenderlo? Pagai la sua insalata
e uscimmo. Pochi passi a piedi e subito mi voltai
indietro: nessuno sembrava seguirci. Non riuscivo a
vedere personaggi ambigui con occhiali scuri. Tutto
sembrava normale, una bella giornata d'estate a
Parigi. Il mio interlocutore appariva più tranquillo. Io
diventavo via via più nervoso. Entrammo alla libreria
Shakespeare and Company. Sfogliai un'edizione
dei Collected Poems di T.S. Eliot. Lui sorrise. E mi disse
che certo era un onore passeggiare con me, che
sarebbe stato emozionante per lui potermi vedere
suonare (si espresse proprio così, «vedermi suonare»),
ma che era lì, con me, per ben altro. Lo guardai, i
suoi baffi chiari erano poco folti e irregolari, una lieve
cicatrice gli attraversava il sopracciglio sinistro, i
capelli non cercavano di nascondere l'incipiente
calvizie, ma la esaltavano, dritti sulla testa. I suoi occhi
ammiccavano. Io posai il libro di Eliot, con calma, e
lo fissai con indignazione: «Signore», ricordo di
avergli detto, «vogliamo scoprire le carte una volta
per tutte? E' troppo tempo che la sto ascoltando».
Sorrise, in modo esagerato: «Se lei solo sapesse cosa
possiedo, non si preoccuperebbe del tempo perso a
parlare con me. Sarebbe felice di avermi incontrato».
Ho passato la mia vita a suonare il pianoforte e non
ho mai trattato alcunché con nessuno; ho passato
un'infanzia ricca tra precettori e il parco della villa di
casa. Giovanissimo sono diventato una celebrità, un
ragazzo protetto dal mondo, affinché il mondo
godesse e gioisse delle mie doti e del mio talento. Non
saprei comprare il prosciutto, affittare una casa,
risolvere un problema pratico. Sono nato molto ricco,
e negli anni sono diventato ricchissimo. E ho usato la
mia ricchezza per non farmi distrarre dal mondo, come
fosse un dono del destino: così potevo pensare a
Beethoven ogni giorno, e a nient'altro. Un bel privilegio.
Ora, per la prima volta nella mia vita dovevo
sopportare un russo volgare e mellifluo e un po'
untuoso che cercava di vendermi il genio di qualcuno
in valuta pregiata. E lo faceva coi tempi che lui stesso
aveva stabilito. Come fosse un adagio un po' estenuante.
Poche note, sempre le stesse, e una facile melodia.
Facile facile. Volevo il colpo di scena, volevo
l'accordo risolutivo, quello che mi introduceva al tema
vero. Ma non doveva essere ancora il momento,
mi disse che no, che non si era spiegato bene. Sì, le
pagine le possedeva ma non era certo il tipo da
portarsele dietro. «Lei non ha idea di quanta brutta gente
giri per Parigi. Magari non sanno leggere la musica,
però hanno un fiuto per gli affari che non si può
neppure immaginare.» Dunque il russo aveva orchestrato
la sua trappola con una sapienza che mi irritava,
ma di cui comprendevo tutti i passaggi. Parlavamo
la stessa lingua.
Lo sapevo che non potevo sottrarmi, e misi a fuoco
la battuta 211. Certo, lì inizia la coda della Ballata. E'
uno dei momenti più intensi tra tutte le composizioni
di Chopin. Preceduto da un pianissimo di cinque accordi:
do maggiore il primo, do maggiore l'ultimo.
Aggiunge persino una settima all'accordo maggiore, il
grande Chopin: rivoluzionario. Ho sempre pensato
che lì, quella Ballata potesse finire. In do maggiore come
era iniziata. Con un pianissimo che mette a tacere
l'inquietudine di quel tema in fa minore, che assomiglia
a una fuga di impostazione romantica. E invece,
colpo a sorpresa, quando sembra che la composizione
sia finita - e quante volte accade ai pianisti di sentire
qualche sprovveduto che accenna all'applauso,
convinto di ascoltare le note finali del brano -, in quell'accordo
di do maggiore che si perde verso il silenzio inizia
un concitato gioco di specchi, una corsa attraverso
un labirinto musicale, affannosa e lucida, una fiammata
di romanticismo, una rabbia risolutiva che termina
un'opera, trattenuta e controllata per pagine e pagine,
in una sorta di esplosione di passione, come un temporale
atteso da tempo, e per questo ancora più violento
di quanto si potesse immaginare. Eppure non riesco a
trovare parole per descrivere quello che accade in
quelle pagine finali. La forza della similitudine si
stempera se messa di fronte alla grandezza di quella
musica e anche alla sua difficoltà. Come gettare
dell'alcool sulla brace ardente, una brace che ha scaldato
l'ascoltatore per nove, dieci minuti; e che sembra rassicurante,
non pericolosa. Oppure, meglio, come fosse
un amore trattenuto, contenuto, volutamente controllato,
un gioco mentale intelligente che alla fine non riesce
a trattenersi ed esplode in un fuoco d'artificio dei
sensi tale da stupire e quasi spaventare. Si dice che
Cortot abbia portato all'esame di diploma proprio
questo brano, con un'esecuzione indimenticabile:
suonando queste ultime battute con una velocità strabiliante
e una grande potenza di suono. Non saprei dire
se questo fosse giusto, però devo ammetterlo: quel
russo che mi stava di fronte aveva la stessa agitazione
della battuta numero 211 e della 212, e di tutte le altre,
le successive. Anche quando si congedò da me, quasi
correndo, e dicendomi un attimo prima: «Maestro,
non me ne voglia, non posso più restare. Mi farò vivo
ancora. E tornerò con qualcosa che lei sta cercando
da tempo, e non se n'è mai reso conto. Con qualcosa
che oggi solo lei potrà suonare, e saprà farlo, questo sì,
in modo perfetto. Non le costerà troppo, mi creda;
intendo dire che il suo prezzo è irrisorio se si tiene conto
del valore - come direbbe lei? estetico? - di ciò che le
farò vedere. Addio, maestro. A proposito, era bella la
ragazza che ha accompagnato oltre il pont de
l'Archeveché questa mattina. . . ». E così dicendo, con un ultimo
sguardo d'intesa, mi lasciò a Saint-Étienne-duMont, correndo impacciato verso rue Descartes.
Capitolo terzo.
C'è un modo della curiosità che vuole attesa. Così
tentai di mantenere un distacco verso le mie stesse
passioni: mi volevo sospeso, privato del giudizio. Mi
ritrovai come se fossi all'inizio di una strada che non
credevo di poter prendere. Temevo di dover continuare
a suonare musica di cui sapevo tutto, per averla
ascoltata da altri, per averla prima studiata e poi
suonata io stesso, per poi magari lasciarla da parte, e
meditarci sopra, leggere libri che mi potessero, per
analogia, far suonare meglio, cambiare quella che i
profani chiamano «interpretazione» (e io sapevo che
la parola interpretare significa nulla). Mi vedevo vicino
ai sessant'anni, a far impazzire tutti i miei collaboratori
per due Preludi di Debussy, che a loro sembravan
sempre perfetti, e a me quasi banali: la loro
miopia contro il mio cannocchiale. Io non vedo le note;
di più, riconosco ogni frequenza come se fossi una
di quelle macchine, gli oscilloscopi, che vibrano in
onde meravigliose a ogni rumore che produci. Loro, i
miei ingegneri del suono, le note le sentono a grappoli,
almeno tre alla volta. Quelli che vengono ai miei
concerti, è già tanto se riconoscono il brano intero. E
quelli che stanno fuori, quelli che non vanno ai
concerti, non fanno testo.
Ero a Parigi anche per finire di preparare Debussy:
il secondo libro dei Preludi. Non ci potevo impiegare
meno di dieci anni. Dieci anni per 38 minuti di musica
e dodici brani. Ci sono pianisti, come Rubinstein, che
ci mettono due giorni a incidere tutti i 24 Preludi di
Debussy. Io no. In questo, con Gould mi sono sempre
trovato bene. Un giorno a Toronto mi diceva divertito
che ero persino più lento di lui; anche se per le Invenzioni
di Bach Gould impiegò un po' meno di vent'anni.
Perché era un uomo insopportabile, lavorava sui
frammenti: pezzettino per pezzettino. Gould in sala di
in cisione ha costruito sempre dei Frankenstein di sé
stesso. Il brano viene ripetuto, risuonato decine di volte,
poi i passaggi migliori vengono montati assieme fino
a completare l'incisione. L'ascoltatore, anche il più
smaliziato, non si accorge di nulla: è tutto perfetto.
Non l'ho mai fatto. Mi sono sempre rifiutato. Io sono il
mio pianoforte, io sono in quel momento, nel momento
in cui interpreto quel brano, quel giorno, a
quell'ora, e non voglio spezzoni. So che il futuro non è questo.
Ma in quel momento il mio futuro assomigliava
già a un passato da ricostruire.
E dunque cosa fare? Immaginare di essere al centro
di un complotto mondiale: con spie russe, servizi
francesi, pianisti americani avidi e pronti a tutto per
una semicroma scritta con troppa solerzia? Sapevo
bene che non poteva essere; e non mi sentivo neppure
seguito: da chi, poi? Da un russo con l'alito cattivo
che, cercando di far soldi con la mia celebrità, tentava
di vendermi qualcosa di cui poco sapevo, ma che
sarebbe costato comunque moltissimo? Se poi, mentre
rimuginava sul mio virtuosismo, e lo faceva sotto i
miei balconi, abbia visto una ragazza uscire dal
portone, be', aveva solamente visto ciò che era e non
poteva non essere. Già, ma perché ha detto: quella
ragazza con il cappello? O non l'ha detto? Qui sta il dubbio,
non può averlo detto perché la ragazza, il
cappello non l'aveva; ero soltanto io ad accostarla al
personaggio di quel dipinto minore; e solo perché
Delacroix era il miglior amico di Chopin. Ma l'aveva
detto, o l'avevo sognato? Deliravo: pensavo persino
di non aver neppure incontrato il russo. Quel giorno
ebbi una sospensione della credulità, un collasso
temporale, e un'allucinazione muscolare. Cominciai
a sentire fastidio alle mani, meglio, alle singole dita:
all'anulare della mano destra, ma anche all'indice e
al mignolo della mano sinistra. E sentivo le dita
colpite da un'improvvisa pigrizia, quasi addormentate,
come un formicolìo, un torpore che non mi avrebbe
mai permesso, io credetti allora e ne son certo oggi,
di accostarmi a una tastiera. In una parola: mi venne
come un'angoscia che sedendomi al piano non sarei
più stato capace di suonare; si ripeteva nella veglia di
un tardo pomeriggio d'estate uno dei miei sogni
ricorrenti, e dei più mostruosi.
Sono bambino, nella mia casa di campagna.
All'inizio sembra un sogno dolce: sono nella mia stanza,
al secondo piano, con le finestre che sfiorano gli alberi
di olmo. Sto leggendo un libro, e di tanto in tanto
guardo fuori per capire se è ora di cena; alle sette i
giardinieri smettono di lavorare. Dalla mia finestra li
vedo dirigersi verso il cancello della villa. Allora so
che sono atteso a tavola. Ma quella sera i giardinieri
sembra che non finiscano mai di sistemare le siepi di
alloro che ornano lo spazio di fronte alla villa. D'un
tratto quella giornata d'estate con la luce che sfuma
lentamente si fa aspra, sembra d'esser passati
dall'estate all'inverno in un attimo: fuori si crea una
nebbiolina, il buio circonda la casa, lascia intravedere solo
la luce lontana che illumina il cancello, in fondo al parco.
Guardo fuori, spaventato, mi sembra che nevichi.
Ma lo spettacolo non è piacevole, m'accorgo che non è
la neve che ho sempre amato, è una neve che sembra
sintetica, che non si scioglie, ma seppellisce la natura
come una cappa bianca soffocante. Mentre faccio questo
pensiero entra mia madre, in silenzio, vestita di
bianco, sto per chiederle qualcosa ma con uno sguardo
mi lascia capire che non è il caso di parlare: ha
un'aria corrucciata, irrigidita, va verso le finestre e
chiude gli scuri per proteggere la camera dal gelo.
L'atmosfera è come soffusa, i rumori attutiti, meglio
rallentati, come dei suoni ritenuti. Tutto è pianissimo,
ppp si scrive in musica. Mia madre, bellissima nel suo
abito lungo, mi indica il pianoforte, un pianoforte che
per la verità non ho mai visto se non in quel sogno, un
vecchio strumento della metà dell'Ottocento, intarsiato
e dalla coda lunga. Un pianoforte fragile e prezioso:
inadatto alle mani forti di un giovane pianista. La
guardo e non oso sedermi alla tastiera, ma dall'espressione
del suo viso capisco che è un ordine. Più che
sedermi mi appoggio, quasi sospeso sullo sgabello, e mi
accorgo che non so leggere quelle note. Mi sembra un
affresco confuso di segni di cui non riconosco nulla,
che mi paiono tutti uguali, se non fosse che son disposti
in altezze diverse rispetto a quelle righe sottili e
orizzontali. Nel sogno appoggio le mani sulla tastiera,
quasi impacciato, come un ragazzino che non sa suonare
e si atteggia a concertista. Mia madre è immobile,
alle mie spalle, sento la sua presenza fisica come qualcosa
che mi opprime. E quelle mani che avevo appoggiato
a caso sulla tastiera rimangono ferme, rigide e
doloranti; comincio a tremare per dover ammettere
che non so più suonare, che non ne sono capace; anzi,
forse non ne sono mai stato capace. Mi alzo umiliato e
offeso. Senza guardare il viso accusatore di mia madre
mi appoggio alla parete, come se avessi fatto uno sforzo
enorme. Lei, indifferente, con un sorriso enigmatico
siede al pianoforte, poi mi guarda, ma di traverso.
E, come un fulmine che si scarica su una casa, percuote
quel fragile strumento con un accordo potente.
Fortissimo. Secco come il vento che sentivo fuori della casa:
perfetto. Lo riconosco, è l'accordo iniziale dello
Studio n. 12 op. 10 in do minore di Chopin. Il cuore mi
batte fortissimo, in modo irregolare, come fossero (oggi
lo so) continue extrasistole. Ma non faccio in tempo
a prendere fiato che subito la mano sinistra di mia
madre scende sulla tastiera verso le note gravi a una velocità
impressionante. Non avevo mai sentito suonare
quello Studio in quel modo. E nel sogno lo ricordo
eseguito a una velocità impossibile, molto più veloce (e
molto più preciso, ed è quasi inverosimile) di come lo
suonava Alfred Cortot. Solo Franz Liszt avrebbe potuto
suonarlo così. C'è una lettera di Chopin che mi ha
sempre colpito. Credo scrivesse a George Sand, o forse
a Delacroix. A un certo punto dice: «Ora devo interrompere,
di là, nell'altra stanza c'è Liszt che sta suonando
i miei Studi, e mi fa uscire di senno».
Nel sogno mia madre suona nello stesso modo, da
farmi uscire di senno: e suona con rabbia, come fosse
allo spasimo, e violentasse, oltre le dita, i tendini e i
muscoli delle braccia, costretta a uno sforzo estremo
che accompagna tutto il suo corpo dalle caviglie fino
alle tempie. Non ho mai osato suonare in vita mia
quello Studio. Provavo dolore alle mani solo al
pensiero di avvicinarmi a quella partitura. E non ho mai
inciso l'opera 10 con le scuse più diverse. (Quanto mi
sono poi innervosito nel leggere i critici che discettavano
sul fatto che avessi inciso così bene gli Studi
dell'opera 25 e non quelli dell'opera 10! E perché mai
non l'opera 10? Nessuno aveva mai inciso metà degli
Studi, soltanto io. E in un saggio si sostiene che la
mia interpretazione degli Studi dell'opera 25 «nega»
quelli dell'opera 10. Che io considererei minori. Dio
mio!)
Quel giorno a Parigi ebbi la stessa sensazione, e
ripensai a quel sogno che nessun analista avrebbe
potuto capire meglio di me. L'angoscia volle il suo tempo,
se lo prese volentieri mentre passeggiavo tra i
bouquinistes, mi guardai bene dal dirigermi verso casa
per non trovarmi di fronte a un pianoforte; l'ansia
mi divorava, temevo di vedere il mio Steinway suonare
da solo, quasi fosse uno strumento a rullo, con
sopra inciso quel maledetto Studio. Temevo che le
mie mani si sarebbero fermate per sempre, e la
memoria non mi avrebbe più consentito di leggere la
musica con la stessa naturalezza di un attore che recita
versi per la prima volta, e lo fa come se li conoscesse
da sempre; e temevo che proprio quella mia dote
prodigiosa sarebbe svanita. Per non pensarci, passando
per i bouquinistes, mi aggrappavo ai primi libri che
mi capitavano tra le mani, leggevo qua e là, morsicavo
frasi di romanzi sconosciuti, di testi famosi, di
poesie dimenticate. Guardavo stampe di poco valore,
e persino incunaboli dalle pagine incollate dall'umidità.
Tutto costava poco, meno di quanto valesse. Anche
la musica che suonavo - credevo - costava meno
di quanto valesse; persino le mie mani erano pagate
meno di quanto fosse opportuno. Ma non ho mai
avuto passione per il denaro, Già nel maneggiarlo
sentivo una sorta di sporcizia, di sciatteria, di volgarità.
Mio padre mi ha insegnato che un gentiluomo
non parla di denaro, e non tratta con nessuno, il denaro
è roba per banchieri: a suo avviso, individui a
cui non si deve concedere troppa confidenza. Mio padre
era un eccentrico: talvolta i banchieri sono uomini
di qualche raffinatezza. Ma in sostanza è vero: credono
che il mondo si possa comprare, che tutto sia in
vendita. Ricordo un'amica di mia madre, voleva
mettere sotto stipendio una medium, una vecchietta di
origine boema che terrorizzava i presenti raccontando
di aver passeggiato con Johann Sebastian Bach e
Claude Debussy, per carpirle i misteri della composizione
musicale. Naturalmente la vecchietta si dileguò
in men che non si dica: aveva pochi segreti da vendere;
però si diceva che nelle sedute spiritiche sapesse
parlare con la voce di un uomo, e si diceva fosse
quella di Bach. Storie di una vecchia Europa bizzarra
che non esiste quasi più, e per nessuno; neppure per
me, che per la verità mai mi son curato di queste cose,
contrariamente a molte altre menti eccelse, e
uomini talentosi, capaci di rovinarsi per un raro trattato
di alchimia, o di spiritismo.
Ma in fondo anch'io ho cercato il mistero: l'ho
scacciato e l'ho inseguito, e ancora l'ho scacciato. E in
questa altalena nevrotica, ho studiato le sue pieghe,
nelle mie mani, nelle mie unghie troppo curate, nello
sfiorare quei tasti, quelli neri, quelli in avorio, nel
comandare la mia gamba destra a ogni sfumatura del
pedale di risonanza. Volevo che la mia interpretazione,
la capacità di far rivivere i secoli, di far risuonare
fogli muti in bianco e nero, coincidesse con il mistero
della vita. E le mie mani si muovevano come obbedendo
a una regola di cui non conoscevo che un principio
flebile, un inizio di spiegazione. Nulla se si pensa
al mistero di un suono che non aveva dimensioni,
e insieme tutte le aveva; e si insinuava in ogni luogo:
persino nelle parti più seducenti di un corpo teso,
pronto a godere di ogni minima modulazione sonora.
E mi tornava in mente la notte prima, e la ragazza
con il cappello, la ragazza del caffè di rue de Rennes.
Pensavo a lei, al modo in cui muoveva il corpo, come
a voler capire in anticipo i miei desideri, attraverso
un codice che ho sempre stentato a riconoscere, perché
ogni volta diverso.
Mi fermai: colto dalla paura di spingermi oltre, di
pensare alla musica ancora una volta come analogia,
non come volontà. Raccontare il sesso attraverso la
musica? Non volevo farlo. La musica è Volontà, non
Rapresentazione. La musica non ha legami con il
mondo, non lo spiega, semmai genera il mondo,
cambia le forme, modifica gli umori. Non dovevo
tornare a cercare brani musicali per dare un senso ai
miei turbamenti e alle mie passioni. E mi chiedevo
(dovevo farlo) se il mondo non fosse l'effetto di una
disarmonia universale; figlio di una quantità di suoni
casuali, sovrapposti, irriconoscibili, di frequenze
musicali ordinate a intervalli irregolari, discontinui, come
fossero gruppi di nuvole che si scontrano e provocano
temporali improvvisi, scatenano fulmini,
danno bagliori, infuocano il cielo per poi lasciare tutto
come se nulla fosse accaduto, a parte un persistente
odore di bagnato. E quel mondo, quella disarmonia,
finivano per essere riordinati dalle mie mani, dal
mio udito, come fossi un abile giardiniere. Sapevo
trovare la tonalità delle cose? O forse era una follia, il
delirio di un uomo malato di sensazioni, abituato a
tal punto a pensare con l'udito, a leggere con l'udito,
che non gli riusciva quasi più di riordinare gli eventi
secondo un ordine, una logica.
In che tonalità era il mio incontro con la ragazza al
caffè di rue de Rennes? Era in mi bemolle, in fa diesis
minore, in do maggiore? Sciocchezze di un pignolo
musicista, si potrebbe dire. Ma non è così, ho rivissuto,
in quel dialogo, in quel modo di parlarsi, l'andamento
del primo Preludio di Chopin, quello in do
maggiore, ho avuto la sensazione che quella fosse la
tonalità e non un'altra. Un incontro in do maggiore è
diverso da un incontro in la bemolle minore; non ha
pieghe ambigue, non lascia aperte possibilità, non
obbedisce a regole sconosciute. Un volto in do maggiore
non ha sguardi sorprendenti, non vuole lasciare
capitoli aperti: è lì, indubitabile, compiuto. Solo che il
primo Preludio, trentaquattro battute in tutto, non è
semplicemente in una tonalità rassicurante, è agitato.
E per di più è in 2/8. Brevissimo come un raggio di
sole che illumina a stento qualcosa che è in movimento,
in rapido movimento. E quel giorno ripensavo
a quanto mi era accaduto, e mi chiedevo se desideravo
ancora quella donna; e sapevo che la risposta
era forse in una manciata di note in tonalità do maggiore,
agitate, e in 2/8.
Non so dire ancora oggi che rapporto ci fosse tra il
mio corpo e un'allucinazione acustica che mi faceva
ascoltare non più il solo Preludio in do maggiore, ma
tutti i 24 Preludi dell'opera 28, uno di seguito all'altro,
mentre i bouquinistes diventavano sempre più rari
per il Lungosenna, e lasciavano il posto a marciapiedi
sgombri. Certe volte sembra impossibile che la
memoria possa sopportare una quantità di dettagli
che si muovono per la mente, ma non si riescono a
comunicare, come fossero un peso troppo grande.
Non avrei potuto cantare il Preludio in fa diesis
minore, in 4/4, Molto agitato, eppure lo risentivo come
in un nastro perfetto, nel mio cervello che sfuggiva
dall'emozione del proprio corpo, dal ricordo che si
mescola al desiderio, e il mio passo accelerava, e mi
portava sempre più lontano dal centro della città.
Avevo superato sulla riva destra il ponte della Tour
Eiffel e mi ricordai della clinica per malattie mentali:
l'Hôtel-Lamballe, a rue d'Ankara, una vecchia strada
di quello che nell'Ottocento fu il villaggio di Passy. Lì
nel 1845 il dottor Sylvestre Esprit Blanche aprì una casa
di cura che divenne subito famosa. Il 12 ottobre
1853 il figlio Émile, che era succeduto al padre, scriveva:
«Oggi Gérard de Nerval è stato condotto qui in
stato di delirio furioso». Rimane per molti mesi in
clinica, e la terapia sembra guarirlo, al punto che decide
di partire per un viaggio di convalescenza in Germania.
Ma, al suo ritorno, Nerval ha avuto una ricaduta e
l'8 agosto 1854 viene nuovamente internato. Quest'ultima
crisi è stata meno lunga delle precedenti e il 19
ottobre dietro sua richiesta viene affidato alla zia.
Gérard de Nerval morirà tre mesi più tardi suicida.
Impiccato a un'inferriata. Lasciò un biglietto: «Ne
m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche».
Portava ancora un dignitoso cilindro, quando lo
trovarono senza vita.
Ho letto Sylvie di Gérard de Nerval più volte, proprio
nell'età del mio sogno, quello dove non riesco a
suonare lo Studio di Chopin. Era una fuga in un
mondo senza tempo dove il passato e il presente si
fondono, e persino il desiderio è qualcosa di indefinito.
Mi deliziavo a pensare che in quel libro fossero
contenuti segni oscuri, messaggi cifrati, figli di una
mente ormai malata in modo irrimediabile, come
quella di Nerval. Per anni molte letture mi erano
proibite: appartengo a una generazione che non poteva
leggere tutto, nella mia casa una parte di biblioteca
mi era interdetta, e amo i libri anche per questo,
perché talvolta li ho desiderati troppo. In quei tempi,
quando ebbi, ormai giovinetto, il permesso di entrare
in quel piccolo studiolo la cui finestra dava sul labirinto
di siepi, scoprii non soltanto Orazio e Marziale.
Ma anche le cose migliori, quelle che accendevano
davvero la mia fantasia: Giordano Bruno e Girolamo
Cardano, Giacomo Casanova e persino Plotino, che
mio padre curiosamente riteneva una lettura pericolosa
per un ragazzo (e ancora oggi, solo in parte mi
spiego il motivo di tale divieto).
Tra i libri certo non vietati, ma neppure troppo
tollerati, c'era Nerval, in varie edizioni. Forse mio padre
non si accorse mai, veramente, che quel libro non stava
più nello scaffale dei romantici francesi, vicino alla
traduzione, sempre di Nerval, del Faust di Goethe.
Quell'edizione di Les filles du feu l'ho ancora qui, nella
piccola libreria accanto alla mia poltrona, proprio
vicino alla finestra che dà sulle montagne bianche della
Jungfrau. Era curioso, mi si permetteva (poiché era
musica) di leggere e suonare senza turbamenti le
sonate per pianoforte di Skrjabin, la decima in special
modo: dichiaratamente demoniaca e perturbante,
capace di privare di ogni stabilità chiunque la ascolti, e
molto, molto di più di certi tormenti mahleriani. Così
Skrjabin, quasi ai limiti della musica, oltre ogni
equilibrio armonico, mi era concesso: perché era musica,
e secondo i profani la musica non parla, non dice,
non conduce al ragionamento.
E pensavo all'impressione che ebbi, io, che ho sempre
ascoltato nella mia vita musica colta, quando mi
ritrovai in America latina e potei sentire la bossa nova.
E un corto circuito mentale mi fece tornare alla
mente mio padre, che mi censurava le letture e non
sapeva quanto può essere sensuale, e persino
indecente, certa musica. La bossa nova turbava il mio corpo,
scopriva i miei nervi, metteva in movimento i
miei muscoli, e non ne ero più padrone; e me ne
vergognavo, sapevo che quella era soltanto sensualità,
che lì non ritrovavo le carte della mia cultura, che
non avevo codici, tutt'altro. Ancora oggi non so se
era la forza di quella musica a trascinarmi oppure ero
io stesso a sentirmi libero da mille condizionamenti,
e lontano da un'Europa di cui avevo assorbito tutto, e
di cui, come già allora si diceva, ero uno dei rappresentanti
più «inquieti e geniali». Ma tutto questo lo
avrei scoperto dopo; a quei tempi, ai tempi delle mie
letture proibite, non dovevo farmi troppo notare se,
nelle pause, rileggevo l'incipit di Sylvie; così tra la
musica che avevo ascoltato fino ad allora e quel modo
vago di scrivere di Nerval finivo per non saper
più dove fossi, e in quale mondo: «Je sortais d'un
théatre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes
en grande tenue de soupirant».
Je sortais, quando, però? In che tempo? Ero affascinato
dalla dimensione temporale di Nerval, debole,
vaga, quasi esoterica nel suo correre incerto e
contraddittorio; almeno quanto mi affascinava quella dei
Preludi di Chopin, che sembra non vogliano mai
iniziare, frammenti di racconto musicale sospesi
proprio come Sylvie. Ho sempre pensato che l'animo
romantico fosse figlio di un equivoco temporale, fatto
di attese, di vuoti, e di accelerazioni improvvise. E' un
tempo elastico, quello dei romantici. E ti sorprende
sempre.
Da ragazzo, come fossi Nerval, finivo per tornare
con il pensiero nel Valois, a ritrovar riti arcaici, canti
sconosciuti, ambigue rappresentazioni, a celebrare la
mia passione che non aveva una sola immagine, ma
vagava in un ideale fatto di più donne, e dunque mi
offendeva, da giovane e puro romantico quale ero
non perdonavo a me stesso di amare più di una donna
alla volta: e quindi mi domandavo se vivevo attraverso
l'amore l'ambiguità del tempo, o attraverso la
vaghezza del tempo l'ambiguità dei miei amori di
ragazzo (ma anche dei miei amori di tutta una vita).
Quanto potevo rubare dell'incanto di un libro che
ancora non sai se è già figlio della follia di Nerval oppure
l'ultimo sprazzo di lucidità, l'ultima visione geniale
di un uomo infelice che non sapeva più opporsi a
un'anima che stava per spegnersi?
Ma perché ero arrivato fino a rue d'Ankara, al
numero 17? Cercavo il luogo dove Gérard de Nerval
soffrì delle sue ultime crisi? O forse sarei dovuto
andare in rue de la Vieille Lanterne, alla cancellata del
numero 4?
Pochi giorni fa è venuto proprio qui, in questa valle
dimenticata, un amico scrittore; che ha con me due cose
in comune, il giorno di nascita e l'amore per Sylvie.
Stava preparando delle lezioni: una dedicata a Nerval.
Il mio amico scrittore si vanta di saper sopportare
i miei visi scuri e i miei sbalzi di umore: credo che ci
riesca bene soltanto perché mi vede assai poco. E' un
uomo famoso, forse ancora più di me. L'altro giorno,
qui in questa valle svizzera depurata dal mondo, il
mio amico era allegro, più del solito, stava partendo
per gli Stati Uniti con le sue lezioni in tasca. Avevo
stappato una bottiglia, Chateau d'Yquem, lui non beve
vini rossi. E sorrideva, caustico e sospettoso di tutti
quelli, turisti e pallidi giovinetti, che vanno a Parigi
per sostare in silenzio dinnanzi all'inferriata dove si
impiccò Nerval, a rue de la Vieille Lanterne. Non gli
dissi che molti anni prima anch'io ebbi la tentazione
di farlo, e con partecipazione, quasi dolore. E mi chiedevo
se Chopin e Nerval si fossero mai incontrati:
Nerval nasce nel 1808 e muore nel 1855. Frédéric Chopin
nasce invece due anni più tardi, nel 1810, e muore
sei anni prima, nel 1849; ed è a Parigi dal 1830. Avrebbero
potuto incontrarsi: avevano diciannove anni di
tempo. E invece pare di no. Si sa che Nerval incontrò
Liszt a Vienna, nel 1839, assieme alla pianista Camille
Pleyel. Ma non Chopin. Probabilmente Nerval sapeva
chi fosse Chopin, ma è più probabile il contrario. Nerval
era una celebrità a Parigi, nel mondo letterario,
mondano e teatrale. Chopin, un giovane polacco in
cerca di qualcosa di stabile.
Però Sylvie era un racconto che avrebbe fatto impazzire
Chopin, perché irrisolto: con le vaghezze che
furono spesso dello Chopin più affascinante, e che
talvolta è anche lo Chopin più semplice, quello dei
Preludi per esempio. Ma cosa c'era in Sylvie che mi
rimandava a Chopin, e in Chopin che mi faceva tornare
a Nerval? Quel sentimento romantico che non si
dovrebbe avere né verso Nerval né tantomeno verso
Chopin. Allora chi stavo cercando quel giorno? Nerval
o i suoi personaggi? Aurelia, strana attrice di cui il
protagonista del racconto si innamora? O Adriana,
biondissima e lontana nella terra del Valois; o ancora
Sylvie, in lacrime quando il narratore fanciullo offre
ad Adriana una corona intrecciata? E quale di queste
tre donne il narratore insegue davvero? No, non
riuscirei a raccontare questa novella oggi, che sono più
vecchio; e non sarei stato capace allora, in quel
momento di totale confusione. Troppo oscuri sono i tempi
narrativi, troppo profondo l'abisso che ci mostra
Nerval. E quel giorno mi chiedevo se la mia passeggiata
fino a rue d'Ankara fosse casuale, lo sfogo di un
uomo ansioso che ha bisogno di stancare i propri
muscoli, o se invece fosse qualcosa di più profondo. Avrei
avuto un passaporto per la terra del Valois, per quel
castello turrito, rosso di fuoco, dove Nerval immagina
che al tramonto le fanciulle danzino e cantino?
Pochi giorni fa il mio amico scrittore mi guardò con
aria diffidente, colto di sorpresa da una mia domanda
diretta. Poi rispose, come parlasse a sé stesso: «Lo sai,
il testo di Sylvie ti chiede di diventare malato come
Nerval e ti vuole incapace di distinguere tra sogno,
memoria e realtà». Lo sapevo allora, in quel giorno di
giugno, a Parigi? Forse no, pensavo semmai alla
combinazione che mi aveva portato fin lì, alla ricerca di un
equilibrio che non potevo trovare. Pensavo che mi ero
spinto a rendere omaggio a uno scrittore di cui mia
madre mi aveva parlato da bambino, e che mi fece
leggere, e ho amato, anche troppo.
Così, mentre tutto questo turbava i miei pensieri, in
un'altra parte della memoria, la più profonda e misteriosa,
correva il cantabile del Preludio in si bemolle
maggiore. E avrei voluto fermare quel nastro mentale
che mi impediva di muovermi, di guardare, persino di
pensare, senza tornare a quelle note. Di chi era l'interpretazione
della musica che ascoltavo dentro me stesso?
Sarebbe stato curioso capire se io suonavo allo stesso
modo quelle note che correvano nella mia testa, o se
invece quei Preludi li ricordavo di Rubinstein, o forse
di Cortot. Solo dopo molti anni, oggi, qui, tra questo
panorama che mi ostino il più possibile a non guardare,
so che la musica di Chopin che ascolto nella mia
mente, e non come una colonna sonora del mio modo
di leggere la vita semmai come un contrappunto dei
miei pensieri, e dunque contrappunto del mondo, è
quella di Claudio Arrau: l'unico pianista che posso dire
di aver davvero invidiato, che ho spiato, verso cui
ho espresso ammirazione; l'allievo dell'ultimo degli
allievi di Franz Liszt, Martin Krause. Arrau è stato il
più misterioso tra i pianisti che abbia mai ascoltato;
più misterioso di me, anche se forse meno celebrato.
Quando lui morì, un amico mi portò un ritaglio di
giornale (io non leggo giornali): c'era uno spazio
pubblicitario comprato dalla Philips, la casa discografica
di Arrau. Con la grande foto di un pianoforte, su un
palcoscenico. Sul seggiolino non sedeva nessuno. Sotto
quest'immagine, due sole righe: «Claudio Arrau,
1903-1991». Nient'altro. Non so dire se fu lui a chiederlo
in punto di morte (e mi piacerebbe fosse così), oppure
fu un'idea di qualche discografico. Certo ebbi un
brivido nel vedere quello strumento, in attesa, in una
sala deserta; un gran coda senza nessuno assieme a
quella data di nascita e morte. Ma quel giorno, tra rue
d'Ankara e il pont de Bir-Hakeim, non potevo capire
che quei Preludi che correvano a spegnere la mia ansia
di vivere, a dissolvere il mio incubo ricorrente di
trovarmi paralizzato di fronte a una tastiera, non erano i
miei (che ho suonato più volte in concerto ma non ho
mai inciso), ma quelli di Claudio Arrau.
Ci volle tempo perché tornassi indietro, era già sera
quando mi apparve l'île-de-la-Cité, e mi sentivo di
una stanchezza profonda, ero esausto. Solo in quel
momento capii che potevo tornare: tornare a casa e
tornare a studiare; aprire l'armadio a vetri dove tenevo
tutte le partiture, ordinate per compositore, e
scegliere, quasi a caso, in libertà, senza pensare ai doveri,
ai dischi che avrei dovuto incidere. Capii che
l'ansia era svanita, l'avevo vinta per stanchezza, senza
esorcizzarla, ma permettendole di mettermi all'angolo,
di minacciarmi. Vincendo su di lei con l'arma
della pazienza, perché sapevo che l'ansia corre sui
tetti, è un male collettivo che passa da uno all'altro,
senza conoscere troppo chi colpisce, chi minaccia. Ma
la stanchezza mi fece pensare a quel russo.
Dove l'avrei ritrovato? Sotto casa? Guardai con
attenzione prima di salire, cercavo di capire se poteva
essersi nascosto da qualche parte, mi sentivo spiato,
come lui si sentiva seguito da fantomatici e strani
individui. Mi sembrò di vedere un uomo sul ponte che
unisce la Cité con l'île-Saint-Louis: mi stava osservando.
Credetti di riconoscerlo: mi avvicinai deciso,
pronto a chiedere se avesse con sé quelle misteriose
pagine che mi aveva promesso. Anzi, mi ero convinto
che era tornato apposta, che tutto fosse più semplice
di quanto credessi. A pochi metri da quell'uomo
capii che il russo doveva essere da ben altra parte.
Quell'uomo mi guardò, con un certo timore. Tornai
sui miei passi, con una delusione che mi bruciava come
un dolore acuto.
Erano molti anni che non provavo un desiderio così
forte verso una musica misteriosa e una donna
altrettanto enigmatica. Se poi quella musica, che non
aveva un nome, e quella donna, che un nome aveva
ma non osavo neppure pronunciarlo (e qui, ancora,
non oso scriverlo, perché troppo si spiegherebbe, anche
a me stesso), fossero legati assieme solo nella mia
mente ormai malata, o invece erano uniti da qualcosa
che mi sfuggiva, da fatti di cui non ero a conoscenza,
non potevo ancora dirlo. E non avrei neppure voluto
saperlo, almeno in quel momento.
Capitolo quarto.
Quando oggi ripenso al modo in cui venni ancora in
relazione con il musicista russo, ho un moto di rabbia;
detesto le lettere, le buste chiuse, non sopporto le
notizie, tollero solo quelle che provengono dal passato.
Il presente è chiacchiericcio: discorsi senza senso,
cose che svaniscono nel nulla e di cui mai si sentirà
ancora parlare in qualche futuro. Anche la musica ha
subìto lo stesso destino; non c'è mai stata epoca così
affollata di musica: senti musica ovunque, per strada,
nei negozi, sugli aerei, persino dal dentista. Musica
di ogni tipo: qualche volta musica classica, spesso ritmi
moderni, canzoni. Da qualche anno ci sono anche
cuffie per ascoltare musica dove si preferisce, anche
sulle cime della Jungfrau. Si può spezzare il silenzio
in qualunque luogo si voglia, eppure mai come in
questa epoca la musica non si ascolta: sono luci di
mille fari, senza che ci sia una sola nave a coglierli, a
farsi indirizzare. Passa tutto attraverso i timpani senza
che ne rimanga memoria.
Dovetti aspettare molti giorni prima che quel
signore si decidesse a farmi sapere qualcosa di sé. E
furono giorni inquieti; di sonni interrotti e di pomeriggi
passati a vagare per casa, e ad affacciarmi, di
tanto in tanto, alla finestra. Una sera, era già molto
tardi, tornai in quel caffè di rue de Rennes per vedere
se avevo la fortuna di rivedere la ragazza con il
cappello. E immaginavo di incontrarla ancora, certo,
ma accompagnata al russo; assieme per strada, quasi
di corsa, come volessero nascondere qualcosa non
soltanto a me, ma anche al mondo. Per quei giorni
non feci altro che pensare a situazioni che puntualmente
non si verificarono; comprai un'edizione
dell'opera di Nerval, e ricominciai a studiare i Preludi
di Debussy. Come inciderli? Gli uomini della mia
casa discografica mi tempestavano di lettere, alcune
formali, altre più accattivanti: volevano sedurmi; ma
soprattutto avrebbero evitato volentieri di far uscire
un disco dei Preludi di Debussy ogni dieci anni.
L'avevo promesso, non mi sarei dedicato altri dieci
anni ai Preludi di Debussy, non volevo: e poi molti
dubbi li avevo già sciolti nel primo disco. Allora ne
ero convinto. Oggi so che non andò così, che impiegai
altri dieci anni per incidere il secondo volume: 39
minuti e 4 secondi di musica divisi in un decennio. Il
mio amico scrittore un giorno mi guardò da dietro le
spesse lenti degli occhiali e mi disse: «Se tu avessi inciso
un secondo, un solo secondo di Debussy al giorno,
in dieci anni ci avresti lasciato almeno un'ora di
musica. Ma hai fatto di meglio, solo 39 minuti, e
qualche spicciolo». Il mio amico scrittore ama i paradossi,
ed è per questo che mi piace frequentarlo. Io,
che non ho il minimo senso dell'umorismo, in
vecchiaia scopro di amare più di quanto prevedessi gli
uomini spiritosi.
Ma qui preferisco non dilungarmi oltre. In un moto
indispettito di precisione posso dire che il mattino
del 24 giugno 1978 mi arrivò una lettera. Per la
verità fu portata a mano. Il mio indirizzo non era noto
a nessuno, e il postino non avrebbe potuto leggere il
mio nome nella cassetta delle lettere: visto che non
c'era. La busta era appoggiata sopra il banco della
portineria di un palazzo che aveva rinunciato al
portiere ormai da molti anni. Ero tornato da una delle
mie consuete passeggiate svogliate. Mi ero spinto fino
a Saint-Germain, per veder passare la gente seduto
in un caffè. La giornata era scura e ventosa, a tratti
faceva quasi freddo per essere estate. Mi accadeva
spesso in quei giorni di trascurare il lavoro e lo studio
passeggiando senza meta, ma in me non c'era
più quell'ansia: quell'angoscia che mi aveva sorpreso
subito dopo l'incontro con quell'uomo. Neppure
cercai altre donne, anzi le evitai. Ma più di tutto
cancellai dalla mia vita ogni contatto mondano; non
aprivo neppure gli inviti che mi arrivavano attraverso
la mia casa discografica. Quando il camino era
acceso finivo per bruciarli, ancora sigillati dentro le
buste.
Quella lettera non era di certo uno di quegli inviti.
La busta gialla, senza francobollo, non aveva indirizzo;
c'era scritto solo il mio nome, con calligrafia
incerta, e il tutto era un po' gonfio, come se dentro la
busta quei fogli fossero stati piegati male e in fretta.
Non l'aprii subito, mi presi il tempo di salire le scale,
e persino di prepararmi un tè. Il mio orrore per ogni
tipo di lettera, specie quelle senza mittente, era
stemperato da una curiosità morbosa: finalmente avevo in
mano la soluzione del caso, avevo trovato le pagine
che mi avrebbero chiarito il mistero. Se c'è stato un
solo momento nella mia vita dove ho avuto una
completa sensazione di euforìa, deve esser stato quello.
Perché tutto mi sembrava perfetto, e non mi venne
neppure in mente che ancora non sapevo cosa cercassi.
E perché mai fossi felice di quanto non sapevo.
Parigi, 23 giugno.
Egregio maestro,
perdonate se non avete avuto mie notizie fino a
oggi. Molti sono i motivi. E credo di avervi annoiato
moltissimo già l'unica volta che avete avuto la grande
generosità di dedicarmi del vostro tempo. Vi posso
soltanto dire, perché voi abbiate un'idea di che
mondo ci è toccato di frequentare e vivere, che sono
seguito. Proprio così. Più di una volta mi sono accorto
che un uomo, e poi una donna, mi stavano quasi
addosso. Io allungavo il passo, cambiavo direzione
improvvisamente, ma già sapevo che non sarebbe
servito a nulla. E devo anche confessare che qualche
giorno fa, mercoledì per l'esattezza, rientrando a tarda
notte nella stanza della mia pensione ho trovato
la camera sottosopra; tutti i miei indumenti (pochi,
per la verità) erano in disordine. La mia unica valigia
aperta e poi sventrata con una lametta, per vedere se
nascondevo qualcosa. Tutto questo mi ha molto
turbato. Anche se posso dire di essere abituato a questo
genere di cose. A Mosca accadeva spesso che agenti
della polizia suonassero nella notte e svegliassero me
e mia madre per controllare se tenevamo documenti
in casa e se facevamo attività sovversiva: ma dovevano
rassegnarsi, nella nostra casa c'erano soltanto
partiture, di ogni genere, e loro non sapevano neppure
leggerle. E spesso mentre quell'umile appartamento
veniva rovistato dappertutto, io e mia madre dovevamo
aspettare sulle scale, dove il freddo era
pungente e intollerabile. Da allora, maestro, la mia salute
non è buona, e quella di mia madre, molto anziana,
ancora peggio. Un fastidio ai polmoni mi costringe
spesso a cure per me troppo costose, e di poca efficacia.
E dire che qualche franco in più potrebbe essermi
utile. Mi hanno parlato di un ospedale non lontano
da qui, nel Valois, dove c'è uno specialista che
potrebbe fare qualcosa... Perdonate il mio francese,
maestro, quando è scritto è anche peggio di quando
è parlato, mi consolo pensando che il grande Chopin
parlava e scriveva un cattivo francese anche dopo 18
anni di vita parigina, e per questo preferiva presentarsi
di persona piuttosto che rispondere per lettera.
Io però non posso presentarmi di persona, come
potrete capire. Voi stesso rischiereste, e di molto. Qui
non ci si può fidare di nessuno. Per cui, permettete
una raccomandazione (e non me ne vogliate): non
parlate a nessuno di questi nostri rapporti. Non
capirebbero, e poi tutto potrebbe andare in fumo. E,
dovete credermi, per me sarebbe un evento luttuoso,
vorrebbe dire perdere l'unica ricchezza che possiedo.
E sapete che vita può fare un uomo povero in una
città come questa. Dovevate vedere la mia pensione
quella notte che fu visitata da ignoti... Ma tant'è. Un
esule russo non ha di che lamentarsi se a Parigi riesce
a campare con qualche lavoretto. Umile, s'intende.
Niente a che fare con voi, maestro; ho visto, per
quel poco che mi era dato di capire, che possedete un
bellissimo appartamento. Ho sentito il suono del
vostro pianoforte, e so che deve essere uno Steinway,
un suono dolce, un'accordatura perfetta. Dal basso,
dalla strada, credetemi maestro, ho ammirato i soffitti
e gli stucchi della vostra casa. Si vedono da giù, lo
sa? E sono proprio belli. Un musicista ha gusto.
Gusto sempre, senso dell'armonia, senso delle proporzioni.
A proposito dell'armonia e delle proporzioni: spero
che i vostri studi procedano come si deve, che
potremo avere presto i secondi dodici Preludi di Debussy.
Che disco meraviglioso il primo! Amici mi dicono
che se ne parla anche a Mosca, e molto. Ebbene, maestro,
vi devo confessare una cosa: l'altro ieri sentivo
parlare di voi in un negozio di musica. Erano due
signori, dall'aria distinta, uno mostrava di saper molto
sulla vostra vita; diceva che voi avevate lasciato da
poco l'Italia, ma che nessuno sapeva bene, per la
verità, dove vi eravate nascosto, che il vostro rifugio era
segreto a tutti, ma che sareste tornato assai presto a
tenere concerti. Io gli credo, e spero sia vero. Ascoltarvi
forse mi aiuterebbe a rendere più sopportabile
un'antica ferita.
Permettetemi, maestro, se oso chiedervi già sin
d'ora un biglietto per quel giorno, sperando che
sceglierete la città di Parigi: uno come me, naturalmente,
non si muove agevolmente. Ma se così fosse, vorrei
tanto sapere cosa suonerete. Posso confessarvi che
un'idea me la sono fatta. So che suonerete Debussy,
sicuramente. Alcuni dei Preludi. Poi suonerete Brahms.
E qualche Mazurca di Chopin. E poi ascolterò Liszt. E
così sarebbe già un grande concerto. Vi prego di
scusare questa inopportuna divagazione. Ma che dico, ho
dimenticato un altro brano che suonerete sicuramente,
penso alla quarta Ballata, in fa minore, che mi avete
mostrato di amare così tanto.
A proposito, maestro, perdonatemi ancora, forse
sto osando troppo, ma anni di privazioni fanno
perdere un po' il senso della misura: la mia promessa di
alcuni giorni fa, quella sul manoscritto della quarta
Ballata, è sempre valida, ma, vedete, mi è molto difficile
muovermi, e poi con quei fogli tra le mani sarebbe
un rischio assai grande. Vi chiedo pazienza, dunque,
la pazienza che ci vuole per le cose che si amano.
D'altronde capirete presto che non è un problema di
denaro. E Dio non voglia che questa lettera finisca
nelle mani di qualche malintenzionato, sapeste quanti
ce ne sono qui a Parigi...
Mi farò vivo, ancora. Con ammirazione.
P.S. Quanto è delizioso ciò che è rimasto del vecchio
villaggio di Passy, non vi pare?
Fui colto da un sentimento di disprezzo, poi di
rabbia, infine di inquietudine. Una lettera miserabile
e leziosa, divagante, come una brutta variazione su
di un tema assai banale. Quella lettera, su carta color
paglierino, era scritta da un uomo furbo ma poco
intelligente. Aveva un andamento allegro e ossequioso,
come un minuetto di maniera, buono per il ballo,
non certo per la storia della musica. Ma l'ossequio
portava con sé una minaccia oscura. Tutta la lettera
era costruita con sapienza; non era scritta di getto,
ma dimostrava che l'autore era abituato alla pratica
del ricatto. A un certo punto, ma solo alla fine, mi
diceva le due cose più importanti: che possedeva un
manoscritto, e per la prima volta lo ammetteva senza
giri di parole e senza ammiccamenti. E che io ero
seguito, e per di più con una certa solerzia. Sapeva che
la ragazza con il cappello era uscita dalla mia casa
quella mattina. Sapeva inoltre che mi ero spinto quel
giorno stesso fino a quello che fu il villaggio di Passy.
Dunque ero seguito. Perché? Per quale motivo un
russo che vuole diventare ricco con i miei soldi decide
di non vendermi ciò che cerco, ma invia sottili
lettere? E perché, ancora, vuole farmi sapere che sono
seguito? E da chi, poi? Da lui stesso o da altri? E se
lui fosse soltanto un uomo mandato da qualcuno, un
semplice emissario?
No, non ho mai creduto alle storie troppo complicate.
In realtà il russo vuole alzare il prezzo. Per farlo
ha bisogno che la mia bramosia di leggere ciò che lui
possiede aumenti, divenga sempre più forte. Non c'è
che l'attesa, dunque: ma anche qualcosa in più. Il russo
è furbo, sa bene che il sentirmi seguito mi procura
angoscia e paura: sa dove abito, non è difficile conoscere
le abitudini di un uomo solo, che fa vita ritirata.
Seguire un uomo come me è fin troppo facile; anche
perché sono molto distratto, e di troppe cose tendo a
non accorgermi. La mia passeggiata fino a Passy, a
rue d'Ankara, non era certo segreta.
Dunque la ragione ha sempre la meglio. Ma solo
per poco. Perché alla logica preferivo il mistero, alla
banalità di una storia che poteva anche essere di
ordinaria miseria anteponevo, proprio così, qualcosa di
molto più intenso, qualcosa che potesse sconvolgere
la vita di un vecchio pianista, certo di straordinario
genio e talento, ma condannato a convivere con la
propria musica in un rapporto che prima o poi diviene
ossessivo, e persino terrorizzante. Avrò suonato
Beethoven con il necessario colore? Di più: il mio
Beethoven, quello che esce dalle mie dita, è un compositore
più vicino al Settecento, oppure già in viaggio
verso il Romanticismo, senza quella strana allegria e
leggerezza che alcuni pianisti riescono a dargli?
Sono domande per pochi, rimangono per pochi, e
mi chiedo che senso possa avere porsi interrogativi
simili, in un mondo di sordi che sentono musica da
mattino a sera. E vai poi a spiegare loro il valore delle
pause, e di come i silenzi possano riempire la musica!
Non son discorsi da farsi, un vecchio pianista deve
saperlo che un mondo è finito, e per sempre. Pochi
giorni fa mi è arrivato per posta, qui, in questa mia
casa di cemento che contrasta con una delle valli più
belle del mondo, un pacchettino. Era un compact disc
di un pianista americano. Non mi è possibile ascoltarlo,
mi dicono però che questi giovani pianisti suonino
tutti nello stesso modo: buona tecnica e nessuna
coscienza degli uomini e delle epoche che stanno
interpretando. Forse non è molto democratico dirlo,
ma la mia musica è elitaria, non conosco, e neppure
capisco, il termine «cultura di massa»: è un ossimoro
ideologico, e niente più. Il cammino verso la
comprensione è complesso, lungo, quasi iniziatico, nulla
può essere dato, ogni cosa va assimilata con calma,
con fatica, con attenzione. E, prima di ogni cosa, con
rigore. Chi suona sa che la fantasia è figlia del rigore;
meglio: è il rigore stesso portato a livello di perfezione,
esagerato fino a raggiungere dettagli impensabili.
Quanto è diversa l'interpretazione se solo si cambia
dito sul pianoforte, o si muove addirittura una falange
in un modo particolare? Quando stavo a Parigi ero
ormai una leggenda vivente. Eppure molte cose le ho
riscoperte in quest'eremo svizzero dove mi sono ritirato.
Ad esempio ho imparato a legare le ottave,
scivolando con il pollice da una nota all'altra. Riuscendo
ad appoggiare la seconda falange sul tasto bianco
mentre la prima scivola sul tasto nero. Sono tecniche
che ho ritrovato dopo tanti anni, figlie di un modo di
suonare che credo sia perduto, ormai.
Ma bando ai tecnicismi, non è di questo, ora, che
mi interessa parlare. La ferita di quella lettera mi brucia
ancora: non riuscivo a tollerare che un uomo
volgare potesse tenermi in scacco, bloccare la mia vena
creativa, mettere in subbuglio un mondo che avevo
voluto perfetto, come fosse uno Studio di Chopin
eseguito come si deve; entrando dunque nella mia vita
privata, spiandomi, minacciandomi, promettendomi,
chiedendomi di sopportare attese che si annunciavano
troppo lunghe per non essere studiate ad
arte. E tutto questo con i metodi spiccioli degli impostori.
Che poi un individuo simile possedesse un
manoscritto così importante era uno di quei controsensi
che la vita ci riserva di tanto in tanto, e che vanno
comunque tollerati.
Il russo doveva saper bene quanto poteva valere
un testo di quel genere. Nessuno possiede il
manoscritto completo di quella Ballata. Se poi era diverso
da quello che conosciamo, da quello stampato, be',
allora la cosa si faceva davvero seria. Ma quanto
diverso? Il russo quel giorno mi parlò della battuta
211, dunque della parte finale: perché lì inizia la coda
della Ballata. C'è qualcosa in quella coda che
lascia perplessi; ho passato la giovinezza a interrogarmi
su singoli frammenti di partiture; speravo che
ingrandendoli in modo esagerato, quasi a cercare
degli atomi musicali, o particelle infinitesimali, si
potesse sentire il mistero, si potesse capire qualcosa
di un mondo di cui facevo parte ma con una certa
ritrosia, e che guardavo da lontano: protetto da mille
filtri, da genitori ricchi e comprensivi, da istitutori
rigidi ma dolci, da tate efficienti e curiose, e poi
giardinieri, e tutto quanto si può immaginare per un
fanciullo di famiglia agiata. Anche quando mi era
concesso di viaggiare (e il più delle volte mi fu
imposto), venivo separato dagli altri a tal punto che il
mondo mi appariva come uno spettacolo teatrale,
dove alla fine della giornata calava il sipario e non si
poteva andare a parlare con gli attori in camerino.
La coda della quarta Ballata era uno di quei frammenti
su cui fantasticavo da giovinetto. Aveva tutte
le caratteristiche per stimolare le fantasie di un giovane
pianista molto dotato. E ricordo che spesso la
suonavo in modi diversi, alcuni non consentiti dalla
partitura, perché così mi sembrava di smontare le note e
vedere dove era il segreto di quel finale drammatico.
Dopo aver passato quasi dieci minuti a suonare la
prima parte della partitura di Chopin, continuando a
variare su due temi diversi che si rincorrono, e spesso
si incrociano, arrivavo al momento dell'attesa, agli
accordi che preludono a quella sorta di tempesta, a
quella forza di colori dati sulla tela quasi casualmente,
con la ferma intenzione di colpire l'occhio,
saturandoli oltre misura, rendendoli spessi, fino a far
diventare la tela qualcosa di simile a una scultura: il
colore diventa denso, assume una dimensione fisica,
si può toccare.
In quella Ballata avviene la stessa cosa: le mani si
agitano, con la foga di qualcuno che cerca di aprire
dei cassetti il più veloce possibile, perché non c'è
tempo, perché il pericolo incombe; ma quei cassetti
cigolano, alcuni sono chiusi da anni, e fanno resistenza,
non scorrono. Poi di scatto invece si aprono, e
bisogna rovistare, guardare più a fondo, spostare indumenti,
lanciarli per aria. E fermarsi un attimo, per
capire se quello che si sta cercando magari è lì,
davanti agli occhi, e non si riesce a vedere; perché è vero:
le cose che si cercano più affannosamente spesso
sono proprio di fronte a noi. E magari senti il
ticchettìo del bastone sulla strada gelata del pirata Pew,
che con gli avanzi della ciurma che fu del vecchio
Flint torna per sgozzarti; o forse no, stai fuggendo da
una casa in cui non puoi più vivere, e devi farlo presto,
perché l'ansia ti chiude la gola, e mentre porti via
le tue cose, d'un tratto ti accorgi che non sai più quali
scegliere, che devi attribuire importanza a oggetti che
non valgono più nulla, o poco o niente. E ti fermi, e
acceleri, e ti fermi ancora, e ti distrai, come fosse una
piccola variazione, magari a guardare un vecchio
orologio di nessun valore, che non sai se merita la tua
scelta (e poi magari non la merita). E chiudi tutto, per
nulla fiero di te stesso, perché ancora una volta non
hai scelto, e ancora una volta stai fuggendo.
Cosa faccio, divago? Ebbene divago. Ma come
dovrei raccontare il mistero di quelle pagine? Come fanno
i musicofili: «Tema III, in fa minore, battute 211239. Impetuose». Cosa avrà pensato Chopin quando
scriveva quella coda? E dov'era? A Nohant, certamente,
un paesino della Francia del sud. Con George
Sand che fumava il sigaro e gridava: «Frédéric, del
fuoco!». In quella casa di campagna Frédéric passava
le estati: un grande edificio senza pretese, adagiato
fra il verde dei prati e i fiori, in mezzo ad alberi e
arboscelli, somigliava a una di quelle case della campagna
inglese, un po' trasandate. Ricordo quando andai
a visitarla, giovane e romantico: tutto era rimasto più
o meno com'era. Mi turbò: non era il tipo di luogo
dove la mia immaginazione avrebbe potuto mettere
Chopin a comporre quella musica. La casa era su due
piani, più una mansarda. Il pianoforte, verticale, stava
nel salone, dove si riunivano tutti: la famiglia
Sand, ma anche gli amici. Come Chopin riuscisse a
lavorare in quel vai e vieni, è davvero incomprensibile.
Le estati passate a Nohant erano un modo per
curare la sua tubercolosi. Ma dovette servire a ben poco:
nel 1842 la salute di Chopin era decisamente
compromessa, i concerti stavano diventando difficili
per lui, non aveva la forza fisica per suonare la musica
che scriveva. Quell'estate del 1842, l'estate in cui
scrisse quella Ballata, passò qualche giorno a Nohant
anche Eugène Delacroix, grande amico di Chopin.
Ho sempre pensato che tra la quarta Ballata e i colori,
i grandi quadri di Delacroix, ci fosse più di una
corrispondenza, un dialogo.
Quando scrisse quella Ballata? In una di quelle
tante estati chiassose passate a Nohant, con George
Sand e un gruppo di individui che Chopin mal
sopportava, e che potevano avere il privilegio di ascoltare
le composizioni più importanti, senza capirle, forse.
«Il mio piccolo Chopin», lo chiamava George
Sand. Donna insopportabile: il mio piccolo Chopin, a
un uomo che aveva rivoluzionato buona parte della
musica dell'Ottocento, scrivendo capolavori come i
Preludi. Quanto ha sofferto la fama di Chopin per
colpa di personaggi come George Sand: mediocre
scrittrice, e incapace di distinguere una nota da un
latrato. Pronta però a prodigarsi in consigli e opinioni
non richiesti. Delacroix no, lui era diverso, lui capiva:
«Abbiamo conversazioni interminabili con Chopin, a
cui voglio molto bene e che è un uomo fuori del
comune: è l'artista più autentico che abbia incontrato
nella mia vita; appartiene a quel piccolo numero di
artisti che si possono ammirare, stimare». Sì, ma poi
quanto? Quanto restituisce Delacroix del genio di
Chopin, con espressioni del tipo «artista autentico»?
Povero Delacroix, lui intuiva, ma non sapeva spiegare
di più. Non poteva immaginare quanto era
importante per la storia della musica quella Ballata, che
lui e gli amici che frequentavano Nohant devono
aver ascoltato a pezzi, a frammenti, poi ripensati,
interrotti, ricostruiti in modo diverso; e poi devono
averlo sentito Chopin quando si decideva a suonarne
dei brani un po' più lunghi, per capire se tutto si
teneva assieme, e magari nell'esecuzione di qualche
battuta si interrompeva per cambiare una nota, una
soltanto forse, un abbellimento, un accordo della mano
sinistra, magari una quinta che diventava settima.
Chopin amava Delacroix, lo considerava un vero
amico, ma non credo che l'uno abbia capito qualcosa
dell'arte dell'altro. Fu soprattutto Chopin a non capire
i quadri di Delacroix, pare che al vederli si
rabbuiasse, che non avesse sensibilità per altre arti. E
fosse capace anche di qualche gaffe: una volta disse
(o almeno così viene riferito) a Delacroix che ai suoi
quadri preferiva quelli di Ingres. Dimenticando che
tra i due pittori c'era un odio profondo, e Delacroix
riteneva Ingres un perfetto imbecille. E forse aveva
ragione: Ingres non mi suscita alcuna emozione,
Delacroix mi accende i pensieri. Mi piace perdermi in
quei colori saturi e in quelle grandi tele, che dico,
immense tele, come La morte di Sardanapalo, venti metri
quadrati a metà tra la retorica e il fumetto, con quei
visi contratti, quegli occhi fissi, quei muscoli tesi
dell'uomo che accoltella una delle donne: e lei, morbida
nel corpo e lasciva nel ricevere il pugnale intarsiato
e prezioso almeno quanto i suoi anelli e il suo
bracciale. I colori di Delacroix sono porpora e marrone
scuro, i corpi muscolosi e plastici, gli indumenti
morbidi e soffici.
Ma oltre le grandi tele, al Louvre c'è anche il quadro
dimezzato di Delacroix, il famoso, piccolo e
continuamente riprodotto ritratto di Chopin. Forse la
sua immagine più nota. Se penso a Chopin, lo penso
come lo ha voluto Delacroix: ben pettinato, pensieroso,
dal naso adunco e lo sguardo intenso. E' un perfetto
ritratto romantico, di tre quarti, vitale, e allo stesso
tempo irrisolto. Ogni muscolo del suo viso sembra
che vibri, tutto è in movimento. Nulla è dato per certo.
Non è veramente un ritratto, semmai è un'espressione.
Quel piccolo quadro ha una storia curiosa, era
parte di un'unica tela che raffigurava anche George
Sand. Forse il tutto doveva entrare a far parte di una
composizione più ampia. Ma quell'unico quadro, con
George Sand e Chopin, non uscì mai dall'atelier di
Delacroix. Solo dopo la sua morte passò alla collezione
Dutilleux, e i due ritratti vennero divisi. La Sand
venne ceduta nel 1887 al prezzo di 500 franchi; poi
nel 1919, per 35 mila corone danesi, finì in un museo
di Copenaghen. La parte di tela che ritrae Chopin, un
po' più piccola, ha avuto meno passaggi. Fu venduta
nel 1874 per 820 franchi e poi nel 1907 arrivò al Louvre
attraverso il lascito Marmontel.
Se conosco e racconto tutta questa storia, è perché
mio nonno, grande collezionista, cercò di aggiudicarsi
questo quadro all'asta del 1874, e perdette per pochi
franchi. Mio padre raccontava che per il nonno questo
fu uno dei dispiaceri più grandi, e che cercò di
comprare ancora quel quadro ma senza successo: si rassegnò
soltanto quando venne esposto al Louvre nel
1907. Mio nonno era pianista dilettante, si vantava di
aver suonato in presenza di Franz Liszt, e fu amico di
Claude Debussy, ma la sua passione era Frédéric Chopin.
Nato nel 1830, fece in tempo ad ascoltare un
concerto di Chopin al salone Pleyel, il 16 febbraio 1848,
l'ultimo che diede a Parigi. Non conobbi mio nonno,
morto vecchissimo nel 1916, quattro anni prima che io
nascessi: mio padre si sentiva ripetere, specie negli
ultimi anni, il racconto di quel concerto, dei dieci biglietti
comprati dal re, del duca di Montpensier, del fatto
che Chopin quella sera non suonò solo musica sua,
ma anche un Trio di Mozart per pianoforte, violino e
violoncello. Quando gli fu mostrato per la prima volta
il ritratto di Chopin fatto da Delacroix, mio nonno
si convinse che con quello sguardo Frédéric lo aveva
fissato per un attimo prima di sedersi al piano. Quello
fu lo Chopin che gli si era impresso nella memoria, e
quel ritratto voleva avere. Non gli riuscì perché, diceva,
l'influsso della Sand era negativo. L'altra metà di
quadro che la raffigurava rendeva giustizia a
quell'unione: lei è cinica, leziosa e prevedibile. Dove Chopin
è elegante e spirituale, la Sand è fredda; le mani, lo
sguardo, la bocca mostrano un carattere autoritario ed
esibizionista. Dal raffronto dei due quadri si capisce
quella tormentata relazione, e quanto Delacroix conoscesse
i suoi due amici: i difetti di George Sand, e la
grandezza e il genio di Chopin.
Eppure Chopin non capiva Delacroix, anche se
amavano passare a discutere interi pomeriggi nella
casa di campagna di Nohant. Proprio lì, in quell'ambiente,
nasce quella straordinaria Ballata. Un giorno, a
Milano, Arturo Toscanini mi disse che l'unico paragone
possibile era con la Gioconda di Leonardo, con il
sorriso della Gioconda, per esser più precisi. La quarta
Ballata è un brano ineffabile, un velo di Maya squarciato
a tratti per far intravedere l'anima, qua e là, una
continua deriva, suonarla è un po' come andare a vela,
vuol dire dosare ogni movimento, mai essere bruschi.
Anche nei passaggi più intensi, più rapidi, di virtuosismo
trascendentale, ci vuole attenzione.
Amo quella Ballata perché è un po' come me, un
insieme di controllo e passione, ragione e follia, e alla
fine mistero. Ma sotto, sotto quel mare di note che
si sovrappongono e viaggiano per correnti oscure di
maree tonali, finisci per scoprire anche la linearità
barocca, il contrappunto, senti il compositore che
portava sempre con sé le partiture di Bach, e ovunque,
anche a Maiorca, al convento di Valldemosa,
dove alcuni anni prima Chopin aveva ultimato i Preludi
dell'opera 28. Per lui fu una delle esperienze più
angosciose. Trascinato da George Sand in un'isola
inospitale, dove gli indigeni non gli volevano affittar
casa, e questo perché Chopin era malato: tossiva,
sputava, aveva la febbre alta, nonostante i 18 gradi
di temperatura, i fichi e gli aranci. Trovarono un
convento abbandonato, un enorme edificio del XV secolo,
tutto di pietre, con finestre gotiche. Oltre molte
celle per novizi, c'era una parte del convento più
recente, un chiostro dove si sistemarono la Sand, con i
figli, e Chopin. Ma il luogo era impervio, il convento
stava a cavallo di due rocce scoscese, c'erano pochi
mobili e il cibo costava tre volte il suo prezzo, perché
gli indigeni si erano accorti che Chopin e la Sand
non andavano a messa. E li minacciavano: se lui fosse
morto a Maiorca, non lo avrebbero seppellito in
terra consacrata. Ma poi arrivò il pianoforte, un piccolo
Pleyel, dal suono argentino, e Maiorca divenne
un incanto.
Il 28 dicembre Chopin scrive al suo amico Fontana
che finalmente il pianoforte è arrivato, lo aveva noleggiato
a Marsiglia ed era guardato dagli abitanti dell'isola
come fosse una sorta di mostro che avrebbe fatto
saltare in aria tutti. Ma subito dopo, e per 28 giorni,
dal monastero si cominciarono ad ascoltare le composizioni
che Chopin doveva ultimare. I Preludi innanzitutto,
e la Ballata n. 2 in fa maggiore, un altro di
quei brani che non sono mai riuscito a suonare come si
dovrebbe. Dove l'impeto, il dramma, va restituito con
una tecnica pianistica che non credo di possedere. Dove
la forza e l'ansia, la fretta e le note ritenute diventano
un tutt'uno: per cui è impetuosa e lucida al tempo
stesso, possente e infuocata, ma a tratti anche esitante,
come un bagliore di indecisione negli occhi di un
coraggioso soldato che sta per correre disperato all'assalto:
cose da pianismo di Arthur Rubinstein. Come fu
suonata quella Ballata da uno Chopin che sputava,
tossiva, e che scriveva agli amici di esser pallido e
stanco?
A giudicare da quello che accadde a Maiorca,
Frédéric Chopin impressionava, e molto. Persino i
contadini dei dintorni con vari pretesti si arrampicavano
per i muri, spiavano attraverso le fenditure, per
ascoltarlo suonare. E mi viene una sorta di malinconia
verso quei pianisti di un tempo capaci di suscitare
impressioni fortissime, mentre oggi tutti noi, malati
della fobia dell'imperfezione, non oseremmo mai
sedere a uno strumento e improvvisare. E a queste
cose non posso pensare, perché mi fanno soffrire: per
la mia inadeguatezza, e l'inadeguatezza di quelli come
me. La nostra lingua, le nostre mani, la nostra
musica non arrivano più da nessuna parte. E' dove è sempre
stata: tra le élite; e in fondo non è cambiato nulla.
Forse i villici di Maiorca, i contadini che si arrampicavano
per i muretti, avranno sognato quella musica.
Oggi la nostra musica non la si sogna più.
Per Frédéric il viaggio a Maiorca fu l'inizio della fine.
Da quel momento, complici un tempo infernale
fatto di pioggia e vento continui e passeggiate per nulla
adatte a un malato di tisi, la malattia non gli avrebbe
lasciato scampo. George Sand diceva di Chopin che
era un «malato detestabile»: era nervoso, impressionabile,
demoralizzato. E soprattutto vedeva fantasmi,
spiriti ovunque. Soffriva di allucinazioni, parlava di
processioni di monaci trapassati, di cortei funebri, si
metteva al pianoforte e improvvisava. Talvolta aveva
anche momenti di esaltazione, e si ritrovava con la
fronte cosparsa di sudore, i capelli irti, lo sguardo
spaventato. Sarà stato vero? O si tratta di una rivisitazione
romantica?
Tutta la vita è lastricata di continui dubbi sulla
verità delle cose; sempre si è di fronte alla paura - di più,
all'angoscia - di non cogliere, di non capire, e finire
per pensare come tutti. Chopin? Il candore romantico,
il poeta del pianoforte. Liszt? Il grande virtuoso, il
diavolo. George Sand? Premurosa e oppressiva; parole
piene di «r». Nerval? Pazzo e grande al tempo stesso.
La prigione romantica ha sbarre forti e spesse, celle
piccole, e poca luce. Molti ne sono usciti, negando il
Romanticismo stesso, ripudiandolo fino all'essenza,
suonando Chopin come fosse Bach, o Richard Strauss,
o Luciano Berio. Hanno sostenuto che il Romanticismo
è un accidente dell'interpretazione, una bella storia
scritta in una tonalità sbagliata. Ho ascoltato, da
certi giovani e promettenti pianisti, gli Studi e mi sono
reso conto che non sembravano nulla di più che degli
studi. Ho sentito dei Preludi freddi, scintillanti di
precisione, ma senza colori; e senza le probabili e assai vere
disperazioni di Chopin, che moriva tossendo ogni
giorno di più. Non si possono suonare i Preludi senza
i fantasmi dei monaci che camminano nella notte. Perché
anche quelli ci sono. E se i Preludi vanno suonati
in quel modo, che allora la tecnica, la grande tecnica
pianistica sia al servizio delle ossessioni, e non viceversa.
E' quello che ho sempre rimproverato a Glenn
Gould: la sua ossessione era al servizio della tecnica, e
non il contrario, come invece dovrebbe essere. Per
questo suonava Bach ma non suonò mai Chopin: a
Toronto non ci sono monaci e dèmoni, soltanto meravigliosi
paesaggi che si addicono di più alle Fughe di
Bach.
Ma il mio pensiero, più che a Toronto, andava a
un'altra città, per me ben più interessante, perché dalle
ossessioni di Glenn Gould tornavo alle mie ossessioni:
a Mosca. I paesaggi russi portano a tutto. Anche
se i russi non hanno mai capito Chopin fino in fondo;
in questo sono stati molto più bravi i francesi e forse
anche gli italiani. Le Ballate si ispiravano ai versi di
Mickiewicz, poeta romantico e nazionalista. I russi
erano invasori, e gli invasori non potevano capire lo
spirito polacco delle Ballate, anzi potevano perfino
esserne infastiditi. La Polonia sotto l'oppressiva
dominazione russa fu motivo di sofferenza per l'acceso
nazionalista Chopin (che però aveva un cognome
francese, e si allontanava da Parigi malvolentieri). Era
quindi bizzarro che proprio un russo potesse conservare
il prezioso manoscritto della quarta Ballata. Ma
perché andò perduto? E quando fu ritrovato?
Se oggi ripenso a come riuscii a ricostruire quella
storia, ho un moto di nostalgia profonda. Ero preso
come da una febbre gioiosa: scoprire, trovare nessi,
collegamenti, mettere i tasselli mancanti di un puzzle
di cui conoscevo soltanto i contorni fu per me una sfida
inedita ed eccitante. Tornai giovane, e tutte le mie
stanchezze, le mie nevrosi, svanirono. Io che evitavo
di compiere qualunque sforzo fisico, che dovevo
riposare moltissimo, non camminare troppo, perché le
mie mani, terminali di un corpo che viveva per loro,
che si muoveva per dare a loro sicurezza, forza ed
elasticità, quelle mani esigevano riposo e freschezza.
Per la prima volta nella mia vita non mi preoccupai
neppure di questo. E coltivai la mia voglia di mistero,
con un entusiasmo che oggi quasi mi imbarazza.
Prima di ogni cosa dovevo parlare ancora con
quell'uomo. Incontrarlo, e chiedere il manoscritto,
vederlo. Ma prima dovevo essere sicuro che fosse
autentico. E per farlo avevo bisogno di incontrare un
vecchio amico, a Londra, che di Chopin sapeva tutto,
ma ancora di più dell'inchiostro che usava, della
consistenza dei suoi pennini, della carta che acquistava,
e di tante altre cose. Non era propriamente un musicista,
ma un collezionista famoso, consulente per i
manoscritti musicali delle più prestigiose case d'asta
del mondo. Ma nonostante lui sia scomparso ormai
da due anni, preferisco ancora tenere riservata la sua
vera identità.
Capitolo quinto.
«No, no, questo era della Bates & Sons. Quasi dell'epoca,
attorno al 1850. Guardi, maestro, una meraviglia,
il pianoforte meccanico con il più prodigioso
congegno a orologeria che ci fosse. Si poteva anche
suonare senza rulli, ma il miracolo stava nel meccanismo,
perfetto. Li facevano non distante da qui, a
Ludgate Hill, al numero 6. Devo dire che l'ho comprato
con poco, troppo grande, pesante e voluminoso.»
Guardavo quel pianoforte immenso, verticale, tutto di
legno di noce. Brutto, per certi versi. Mentre il cameriere
di James (lo chiamerò così, ma non è il suo vero
nome) versava del whisky. In quel salone c'era la più
grande collezione di macchine musicali che avessi
mai visto: alcune prodigiose, altre quasi inquietanti.
Conoscevo James per motivi innanzitutto familiari.
Era un americano, di Boston, trasferitosi con il padre,
ambasciatore, alla fine degli anni Venti a Londra. Non
se ne andò più, e divenne cittadino inglese. Un mio zio
materno era addetto culturale a Londra nello stesso
periodo, e conosceva assai bene suo padre. Era più
vecchio di me di soli quattro anni, ma ne ha sempre
dimostrati di meno: la corporatura forte e muscolosa,
l'abitudine di andare in bicicletta per chilometri, lo
rendevano atletico anche a sessant'anni. La sua casa,
una grande villa dalle parti di "...", sembrava un museo
bizzarro e insieme prezioso. Non c'era solo la collezione
di macchine musicali: pianoforti meccanici,
organetti di Barberìa, pianole a gettone; e poi veri e
propri armadi musicali che si chiamavano Symphonion,
e poi pendole con boîte-à-musique, e suonadischi
di ogni genere, anche per bambini; e ancora orologi da
tavola con carillon, e macchine meravigliose, come
quella appena vista o un Hupfeld-Sinfonie-Jazzorchester, un particolare tipo di Orchestrion destinato al
jazz, dove dentro un mobile c'erano: triangolo,
sassofono, piatti, batteria, banjo, e non so quale altra
diavoleria. Per non dire poi dell'Orchestrion «Ohio», dove
dentro un armadio alto più di tre metri e pesante
una tonnellata c'erano banjo, mandolino, violino,
violoncello, sassofono, batteria, e veniva reclamizzato come
la migliore orchestra jazz meccanica mai costruita.
Quanto aveva speso James per comprare in America,
in Germania, in Italia e in tutto il mondo macchine
che poi andavano finemente restaurate? Moltissimo.
Ma quanto guadagnò come esperto di manoscritti
musicali? Naturalmente molto, molto di più. Lui non
leggeva la musica, guardava oltre, per i suoi occhi un
foglio di partitura era un quadro, un dipinto che andava
analizzato con la competenza di chi sa di grafologia,
ma anche di musica, storia e persino sentimenti.
Come iniziò tutto questo non saprei; so che fu un
giovane e assai promettente pianista, e che incise anche
qualcosa; deve esserne rimasta documentazione negli
studi di Abbey Road. Ma d'un tratto smise di suonare,
come se il pianoforte non gli interessasse più. Mio zio
sosteneva che a poco più di vent'anni doveva averlo
colto un forte esaurimento nervoso, che lo allontanò
dalla musica. Ma non tutti erano di questa opinione: si
dice che fu un tèndine della mano sinistra lacerato dopo
una caduta in montagna a precludergli la carriera
di concertista, e per sempre. Uno di quegli incidenti
che per chiunque non significano nulla, e non lasciano
strascichi, tranne che per un pianista.
Non gli chiesi mai, naturalmente, quale fosse la
verità: James non è tipo da grandi confidenze (e oggi,
che è morto ormai da un paio d'anni, mi rimprovero
di non avergli dato mai del tu, forse in quel modo
avrei avuto accesso a un suo mondo ancora più
segreto, che valeva certo la pena di conoscere). Però ho
sempre creduto che fosse bizzarro, curioso, che una
grande promessa del pianoforte finisse poi per
innamorarsi di tutti i riproduttori di suono, degli
strumenti meccanici, e a deliziarsi nel mostrarmi i rulli di
carta con cui funzionava il Bechstein Welte Mignon
Reproduktions Fliigel. Un vero pianoforte a coda della
Bechstein, che però, attraverso un sofisticato sistema
pneumatico e dei rulli di carta, registrava alla
perfezione anche la più leggera sfumatura dell'esecuzione
pianistica. Era, agli inizi del secolo, lo strumento
più raffinato che si fosse mai ascoltato. Al punto
che anche Richard Strauss, Grieg, Saint-Saens, Skrjabin,
Mahler, Busoni, lo provarono. Lo suonò anche
Claude Debussy, che lasciò su rullo di carta due Preludi.
James possedeva, oltre al pianoforte, anche questo
prezioso supporto tecnico: era in grado di far
suonare il fantasma di Debussy. E io sperai che non gli
venisse la tentazione di farmi ascoltare il compositore
che suona sé stesso: mi impauriva, subivo l'autorità
di chi ha scritto, di chi può stabilire, per tutti, la giusta
lectio.
Mai come in quel momento temevo e sentivo i
limiti di un mestiere, il mio, che alla fine non crea, ma
se vogliamo commenta all'infinito pagine date,
immodificabili e scritte da altri. Il Bechstein era un altro
degli orgogli di James, che è tipo dai grandi entusiasmi;
e quel giorno, solo il fatto che avessi preso un
aereo per raggiungerlo a Londra lo riempiva di gioia, e
si sentiva onorato. E mentre magnificava ancora una
volta il suo ultimo acquisto, il pianoforte meccanico
della Bates & Sons («entrai in quel magazzino a
Ludgate Hill quasi per caso, guardi, c'era di tutto, di tutto:
robaccia arrugginita, da farsi male. Ma sapevo che
quel mobile impolverato non era un semplice e vecchio
pianoforte...»), mi osservava, quasi a prepararsi
a una mia domanda, che di solito con lui era precisa,
dettagliata. Sapevo che potevo fidarmi, e ne avevo
davvero bisogno. Mi sentivo alla deriva, a tal punto
che sfidai la mia proverbiale pigrizia e partii da Parigi
in meno di quanto non si dica, e di quanto io stesso
potessi immaginare. Trovai Londra diversa da quella
dove per qualche mese ero vissuto: depressa, sporca
e consapevole del proprio declino (mi dicono che oggi
è meglio, che sta tornando a essere una città piacevole),
ma quel giorno, se non fosse stato per James
avrei detto al tassista di tornarsene indietro. Tutto mi
dava angoscia, persino quel tempo grigio, caldo e
umidissimo non mi rassicurava, e prevedevo qualche
mal di gola dei miei, capaci in altri tempi di farmi
saltare all'ultimo momento un concerto.
Arrivato da James ritrovai una certa serenità, specie
nel vedere quella strana biblioteca che teneva dietro
una piccola scrivania Impero. Erano un centinaio di
volumi, tutti uguali, rilegati in marocchino. Di formato
grande, in quarto. Lì c'erano tutte le fotografie e i
fac-simili (ma anche originali) dei manoscritti dei
compositori da Bach a Stravinskij. Con quei volumi,
che in realtà erano preziose cartelle porta fotografie e
documenti ma sembravan libri, il mio amico James
lavorava. Oltre a questi, poteva vantare una bibliografia
degna della British Library, che occupava un'altra
ampia parete, l'unica non consacrata all'esposizione degli
strumenti musicali meccanici: le macchine parlanti,
come lui amava chiamarle, con perfetto e ostinato
accento londinese, vezzo di un americano che si sentiva
inglese, e guai a ricordargli che era nato a Boston, e
aveva studiato a Harvard negli stessi anni del futuro
presidente John Fitzgerald Kennedy.
«Maestro, ricorda quella vecchia storia della prima
Ballata? L'opera 23? Aspetti, aspetti, le faccio vedere il
catalogo...» James di fronte a un whisky e a un
manoscritto diventava serio e amabile al tempo stesso, cauto
ma anche curioso. Si alzò, e trovò con sicurezza, come
se lo consultasse di continuo, un piccolo fascicolo,
che stava su uno scaffale alto. Sicuro e stabile sulla
scaletta che gli consentiva di prendere i libri disposti
più in alto, sfogliò rapidamente l'opuscolo. Poi, senza
smettere di leggere, venne verso il salottino in cui
eravamo seduti. Tolse gli occhiali da miope, avvicinò il
foglio e mi fece leggere:
Lettres Autographes et Manuscrits de Musiciens - Marc
Loliée,Paris: Chopin - Pièceautographemusicale.2 portées
sur une page d'album in 12 oblong. Sous passe-partout.
75.000 fr. C'est le début de la magnifique Ballade en sol mineur. (De la collection G. Sand.) Rarissime.
«Era il 1957? Sì certo, il 1957», James cercava tra i
ricordi. Il prezzo era altissimo. Due pagine, solo due
pagine, ma autografe della Ballata in sol minore: «Si
conosceva un manoscritto autografo di quella Ballata. E'
a Los Angeles: quello che servì per l'edizione a stampa
di Schlesinger. Ora spuntavano due pagine, ancora
autografe. Dalla collezione Sand. Davvero curioso.
Un compratore inglese, un vecchio amico che colleziona
manoscritti di ogni tipo, avrebbe speso volentieri
quei 75 mila franchi per quelle due pagine. Chiesi di
vederle: non ero convinto. Da dove potevano uscire?
Vidi la partitura. E solo a guardarla capii che era falsa.
E sa perché?».
Lo guardai con ammirazione. Sapevo che non mi
avrebbe dato una spiegazione tecnica, che pure aveva.
James voleva dirmi che per riconoscere ci vuole una
capacità di interpretare veramente ciò che è scritto.
«Guardi, maestro, guardi questa fotografia.» La
pausa gli era servita per andare dietro la scrivania e
prendere una di quelle cartelle porta documenti che
erano rilegate come fossero libri: «Vede, maestro, ecco
l'incipit: Largo», Poi cominciò a cantarlo: do mi la si do
mi la si do mi... «Ma non faccia caso alla scrittura,
potrebbe anche esser quella di Chopin. Guardi però come
son disposte le note. Perfettamente, larghe, come
provenissero da una partitura stampata. Con gli stessi
equilibri di spazi tra le note. Vede, maestro? Non legga
questa partitura come fosse musica, la guardi come
se si trovasse di fronte a un quadro, a un'opera grafica.
Questa non è la cifra di Chopin. Aspetti, aspetti.» Prese
un altro volume, tirò fuori altre fotografie: «Guardi
qui, è l'autografo della Mazurca op. 59 n. 3. Questo è
autentico. Faccia caso a quanto è impreciso tutto, ai
ripensamenti, all'inchiostro che macchiava troppo il
foglio, perché il pennino usato sul leggìo del pianoforte
sta quasi in posizione orizzontale, scrive male, e si deve
premere con più forza; e il foglio si macchia, con
irregolarità: non come queste due pagine, che
nell'imprecisione sono uniformi. Figlie di qualcuno che ha
letto troppe partiture a stampa, e di musica ne ha scritta
poca».
Così mi piaceva James. Preciso e creativo: «Poi,
comunque, spiegai anche perché storicamente si poteva
considerare un falso. Se lei va a leggere il Rekopisy
Utworow Chopin Katalog, vedrà che la mia analisi ha
fatto scuola: il manoscritto è indicato con il numero
278, e c'è scritto in polacco: "falsyfikat". Ma queste
son storie vecchie. Mi dica, piuttosto: mi sembra di
capire che qualcuno le ha offerto il manoscritto della
quarta Ballata».
Qualcuno. Era difficile esser troppo precisi. Eppure
con James la precisione era necessaria, perché lui
era come un medico: stetoscopio e silenzio. Si accese
un sigaro di pessima qualità, qualche volta anche gli
uomini più raffinati hanno cadute di gusto. Poi mi
guardò con aria ambigua: «Be', la storia dei
manoscritti di Berlino Est è nota. Forse esistono pagine
sconosciute di Handel, di Bach, sono pronto anche a
pensare che qualcosa di Mozart non sia pubblicato, e
forse persino di Beethoven. Ma per Chopin non
saprei: mi sembra un compositore di cui si conosce tutto,
anche le opere disperse, alcune giovanili. Però c'è
qualcosa che mi incuriosisce in questa sua storia, caro
maestro. Può darsi che qualcuno voglia venderle
un banale falso. E per questo non si preoccupi, appena
potrà vedere il manoscritto la raggiungerò a Parigi.
E non ci sbaglieremo, né io e né lei. Ma qui c'è
qualcosa di più, che mi affascina: perché mai il falso
dovrebbe esser diverso dall'edizione a stampa che
conosciamo. Chi potrebbe mai inventarsi un falso
Chopin, chi ne avrebbe la capacità? E poi, c'è un altro
aspetto importante: perché offrire un falso così
rischioso proprio a lei? Diamine, se volessi guadagnare
dei soldi saprei come fare: andrei da qualche collezionista
che non distingue un tetrarigo da un pentagramma
e gli venderei la copia esatta e manoscritta
della quarta Ballata. Ma non verrei da lei, che è un
raffinatissimo interprete, che conosce ogni nota di
Chopin, che ha amici esperti in ogni parte del mondo,
e saprebbe riconoscere un falso Chopin con sicurezza.
E le dirò ancora una cosa, maestro: ci pensi
bene, proprio la quarta Ballata, forse l'opera per
pianoforte più importante mai scritta in tutto l'Ottocento,
la più complessa, proprio quella era il caso di
falsificare? Non potevano offrirle una bella Mazurca?
Breve, semplice, qualche nota struggente, e via.
Magari come ultima composizione scritta, oltre quella
dell'opera 68. No, maestro, qui dobbiamo vederci
chiaro. E' possibile, poi, che un russo disperato conosca
uno degli indirizzi più segreti d'Europa? Neppure
io, caro maestro, sapevo che lei ormai vive a Parigi.
A proposito, è proprio sicuro che i miei sigari non le
piacciono? Guardi che sono molto meglio di quanto
lei possa credere: li provi, li provi».
Lo guardai divertito, era un suo modo abituale di
scherzare. Sapeva benissimo che quei sigari non potevano
piacere a nessuno, tanto meno a me: accanito
fumatore di sigarette, e di nient'altro. Mi alzai dalla
poltrona perplesso, e andai verso i suoi scaffali, a guardar
meglio quei dorsi, ordinati per compositori: c'erano
tutti, anche molti che non ho mai suonato, come
Richard Strauss, o come Kalkbrenner. Lui taceva e continuava
a riempire l'ambiente di fumo puzzolente, poi
mi guardò vago, come parlasse tra sé: «Guardi che la
storia della quarta Ballata è davvero strana: perché
non esiste il manoscritto? Non si sa molto bene. Ma
non è importante. Sono molti i manoscritti di Chopin,
e di tanti altri, che sono andati perduti. Di solito però
ci sono un paio di regole: è più facile che si perdano
quelli giovanili; mentre la Ballata viene scritta nel
1842 a Nohant, Chopin è già una celebrità e pubblica
le sue opere contemporaneamente in Inghilterra da
Wessel, in Germania da Breitkopf & Hartel, e a Parigi
presso Schlesinger. Accanto a lui ci sono amici che gli
fanno da copisti, compresa George Sand. Qualcuno ha
mandato ai suoi tre editori il manoscritto. Ma non c'è
più. E non è tutto. Di questa Ballata esistono due
manoscritti, lei lo sa bene, maestro, uno conservato a
New York e uno qui vicino: alla Bodleian Library.
Entrambi incompleti, fortemente incompleti. Mentre
però quello di New York, comprato a Lucerna da
Rudolf Kallir nel 1933, è curiosamente in 6/4 e proviene
da Dessauer, un amico di Chopin, quello della
Bodleian apparteneva addirittura a Cécile, la moglie di
Mendelssohn. Perché è incompleta? Dove sono le tante
pagine che mancano? Per quale misterioso motivo
un amico di Chopin conserva un manoscritto incompleto
e pure sbagliato? Ed è credibile che un grandissimo
compositore come Mendelssohn riceva uno stralcio
di Ballata e non tutta? E se - ancora - l'avesse
ricevuta per intero, come si può mai pensare che l'abbia
persa? Un'opera così, poi...».
Mentre lo ascoltavo mi fermai a leggere una curiosa
partitura, manoscritta. Poggiata su di un leggìo e
fermata da due graffe. Sotto c'era un rullo che ruotava
sotto una fila di aghi, o di chiodini. James mi raggiunse:
«Non gliel'ho mai mostrata? Curiosa, vero? E' la
macchina tracciatrice per rulli della fabbrica di pianole
di Giovanni Bacigalupo, un cognome italiano,
genovese mi dicono, ma la sua fabbrica era berlinese, è
assai rinomata. E' morto proprio quest'anno, lo sa?,
molto vecchio. E questa macchina tracciatrice me l'ha
regalata proprio lui, con questo spartito. Lo legga, lo
legga, riconoscerà il brano: è l'aria di Mackie Messer.
Nel 1928 Kurt Weill e Bertolt Brecht avevano scritto
apposta quello spartito in occasione di una visita che
avevano fatto alla fabbrica di Bacigalupo, in modo che
la canzone potesse essere riprodotta su rullo. Anche
quello è un manoscritto, maestro. Ma è completo».
«Certo», obiettai, «ma la Ballata comprata da Kallir
ha un senso, così incompleta. Chopin inizia a scriverla
in 6/4, poi decide diversamente, si ferma e
ricomincia a scriverla in 6/8. Quei fogli rimangono da
qualche parte, forse abbandonati. Poi un amico li
prende, e li tiene in qualche cassetto. Un manoscritto
di Chopin è per lui ancora un testo affettivo: ci vuole
tempo perché i manoscritti diventino qualcosa di
veramente prezioso. Ma di quella copia non doveva
esistere una sola pagina di più. Per il manoscritto
conservato alla Bodleian Library la storia è diversa.
Perché lì non si spiega che il testo si fermi alla battuta
numero 136. E il resto non sappiamo dove sia.»
«Se fossi un raffinato truffatore? Intelligente, molto
intelligente, sa cosa avrei fatto?» James parlava con
compiacimento, fiero della sua limpida ragione, un
misto di senso pratico americano e di ironia inglese:
«Be', mi sarei falsificato la parte che manca del manoscritto
della Bodleian, e naturalmente senza varianti.
Tecnicamente era però molto più difficile, si doveva
trovare una carta identica, un inchiostro invecchiato
allo stesso modo. Roba da professionisti. Anche se
qualcuno riesce a fare questi lavori, e molto bene».
Dunque non c'era un solo elemento che potesse
farmi pensare a un gioco grossolano, a una truffa
volgare. E James senza affermare nulla, con molta cautela,
mi confermava che la faccenda era seria, e che
andava approfondita. Ma la sorpresa vera me la riservò
per la seconda parte della serata. Dopo che aveva
esaurito tutte le congetture logiche, cominciò a mettere
in comunicazione, come fosse un investigatore,
tutte le notizie che aveva su quella Ballata: ovvero
tutte quelle che aveva raccolto nel corso degli anni.
D'altronde non era un mistero che persino un collezionista
come Kallir, che acquistò il manoscritto nel 1933,
chiese, un anno dopo, a James di esaminarlo,
per essere definitivamente sicuro della sua autenticità.
E James non espresse dubbi. Devo dire, ripensando
oggi a quel lungo e amabile colloquio, che James
fu molto cauto all'inizio, come se temesse
qualcosa da me. Argomentando e ragionando prendeva
tempo, forse voleva capire se avevo altri scopi,
se possedevo già quel manoscritto.
Poi come un lampo, quando ormai la notte si
avvicinava, e per le abitudini londinesi l'ora era inconsueta,
mi chiese: «Lei ha mai sentito parlare di Franz
Werth? No, credo di no. E' vissuto molti anni a Santiago
del Cile, dopo il 1945 naturalmente. Era un criminale
nazista, un criminale medio, intendiamoci: di
quelli che se potevano stavano defilati, e che neppure
gli israeliani perdevano tempo a cercare. Ma nelle SS
ci stava benissimo. Bene, il maggiore Franz Werth
aveva studiato al conservatorio di Berlino, era un
ottimo pianista: solo un po' matto, eccessivo, pensava
che il demonio e la musica romantica avessero più di
un rapporto. Un giovane brillante che diventa nazista
nel nome della geometria di Bach. Le pare possibile?
No, maestro, non le pare possibile. E invece è
così. Tutto può essere capovolto, anche le Toccate di
Bach. Il maggiore Werth doveva sapere abbastanza
delle misteriose partiture di cui le ha parlato il suo
amico russo. Sembra che fosse molto popolare tra i
gerarchi del Terzo Reich; e che a Berlino fosse amato,
e non solo dalle donne, che lo trovavano bello e fascinoso.
Ma pochi sapevano che in realtà lui si vantava
di non essere affatto nazista, e di avere un debole per
il denaro, il potere e la cultura: quella cultura a cui
aveva accesso solo attraverso certe frequentazioni
privilegiate. Nel maggio del 1945 il maggiore Werth
si imbarcò clandestinamente, assieme a un'amante
polacca, su una nave: destinazione Cile. Norimberga
rinunciò a lui.
«A Santiago si faceva chiamare Bauer, e lì nessuno
sapeva che era stato uno dei tanti lacchè del regime
nazista. Ma cominciò a dar lezioni di pianoforte, e a
tenere concerti senza troppe pretese. Piccole sale. Si
vantava di essere stato un allievo di Claudio Arrau. E
invece, forse, Arrau lo ascoltò a Berlino una volta sola,
quando era ancora studente. Pare che fosse colpito
dalle doti tecniche, ma non lo volle come allievo:
"Troppo rigido, poco espressivo". Ora, maestro, si
chiederà perché io sappia tutto di questo signor
Werth, alias Bauer? Non ci crederà: me ne parlò per la
prima volta Simon Wiesenthal. Girava una strana voce
su questo signore: che, di tanto in tanto, nei concerti
suonasse brani fuori programma, cose mai sentite da
nessuno. Sosteneva l'esistenza di una Partita in sol
diesis di Bach: Johann Sebastian, intendo. Ora lei sa
che non risulta che il grande Bach abbia mai composto
una Partita in sol diesis. Ma lui, il maestro Franz
Bauer, la suonava. Santiago del Cile è assai lontana,
ma certe informazioni girano, e negli anni Cinquanta
c'erano più agenti israeliani a Santiago o a Buenos Aires
che a Tel Aviv. Insomma, si venne a sapere. E allora
cominciarono a tornare alla mente quelle strane storie,
di partiture nascoste, suonate per pochi, sottratte agli
studiosi. Vede, maestro, lei potrebbe ritrovare una
sonata di Beethoven anche in un libro di partiture di
Lehar, rilegata in mezzo, così magari per sbaglio, o
perché la preferita di una nobildonna a cui veniva
dedicata, messa tra i brani del suo album e lì rimasta, per
molti anni. I manoscritti musicali non sono libri, due
fogli di musica si possono perdere in una biblioteca di
manoscritti, passano inosservati a tutti. Lei può
immaginare cosa accadde. Tutti i collezionisti del mondo,
antiquari, gente senza scrupoli, cominciò a
convergere verso il Cile. Tutti in vacanza a Santiago, in
qualunque stagione dell'anno. A cercar cosa? A cercare
mister Bauer, pianista di ottimo livello tecnico, in
grado di suonare con sicurezza anche brani molto
difficili, ma per nulla in cerca di notorietà, perché
comunque a Norimberga assieme a molti altri era stato
condannato a morte in contumacia, e qualche rischio
lo correva a mostrarsi troppo. Ma vede, a quei tempi si
cercava ancora il dottor Mengele, altro che il maggiore
Werth! un gagà che di notte partecipava a riti celtici, il
giorno lo passava nei bordelli di lusso, e la sera si
esprimeva al pianoforte a casa di vari gerarchi, e
incantava le fanciulle per la sua avvenenza».
Ho ancora qui davanti quelle poche pagine, ingiallite
e un po' sgualcite: carta sottile, quasi velina.
Macchina per scrivere imprecisa con le «o» piene di
inchiostro e le «s» un po' più alte. E una scheda dedicata
a Franz Hans Werth, mi arrivò pochi giorni dopo il
mio colloquio con James; fu proprio lui a spedirmi
quei dati che era riuscito a procurarsi: nato il 3 luglio
1915 a Frankfurt an der Oder. Il padre, mai tornato
dalla prima guerra mondiale, era un modesto funzionario
dello Stato; la madre, dopo la morte del marito,
viveva di lezioni di pianoforte. Poi, il trasferimento a
Berlino: si iscrive al conservatorio nel 1927. Si diploma
nel 1933. In tempo per l'ascesa del nazismo. «Intelligenza
vivace e visionaria», leggo sul foglio, «ha forti
interessi rivolti all'esoterismo, allo spiritismo e alla
magia. E da questi trae una filosofia perversa di vita
che lo avvicina, da subito, all'ideologia nazista».
Ma la sua carriera è compromessa: ricattabile, avido
di denaro, millantatore, debole. Passa quasi tutte le
notti in due bordelli di Berlino, è spesso ubriaco. Poi,
nel 1937, la svolta. Werth cambia vita, ritorna a studiare
con solerzia. Abbandona certe amicizie, va sempre
meno frequentemente nelle case di tolleranza («in tutto
l'anno 1938 è segnalato non più di quindici volte»,
recita il mio precisissimo foglio). Che accade?
Nell'informativa si dice che ha finalmente accesso ai
salotti buoni, quelli «più raffinati» e quelli «che contano».
Si dice abbia suonato anche di fronte al FÜhrer, e
un paio di volte almeno. Werth, di fatto, è il pianista di
corte, e stringe amicizia con tutti gli uomini più
importanti del regime nazista: Joseph Goebbels, innanzitutto,
ma anche Baldur von Schirach, con cui passava
molte delle sue serate, prima del trasferimento di
Schirach come Gauleiter di Vienna, e Franz von Papen,
che sembra avesse una certa simpatia per quel giovanotto.
E qui sul foglio c'è una curiosa reticenza. Si parla
troppo vagamente di serate medianiche, dove la
concentrazione di Werth al pianoforte è totale e
inquietante. In realtà, il mio foglio dice che «si trattava
di modeste messe in scena, di un uomo privo di scrupoli».
Parla di trance, di musica che proveniva dal
profondo, e altre diavolerie da baraccone; sembra persino
che Werth fingesse svenimenti alla tastiera, per lo
sforzo mentale e fisico. Cosa accadeva veramente?
Quella sera James fu molto, molto più preciso su questo
punto.
«Le esibizioni di Werth furono dapprima sottovalutate:
se ne parlava a Berlino; lo chiamavano il medium
del pianoforte. E non ci credeva quasi nessuno,
naturalmente. Werth suonava pagine di grandi compositori,
dettate dalle anime trapassate di Bach, di Beethoven,
di Debussy, di Schubert. Lo faceva in un'atmosfera
studiata nel dettaglio: candele accese dappertutto, incenso
che bruciava. Esigeva dei pianoforti a coda neri (allora
non erano così frequenti), e lui appariva vestito in divisa
da SS, perché - sosteneva - gli dava più forza, ma era
opportunismo. Nel 1938 un caro amico in missione
diplomatica a Berlino ebbe la possibilità di ascoltare uno
di questi concerti. Il mio amico londinese amava la
musica, la conosceva e sapeva ascoltarla: ne fu turbato.
Perché le sedute spiritiche al pianoforte stimolavano il
suo humour e lo divertivano. Credette di assistere a
una grottesca buffonata per pochi eletti. Però, man mano
che Werth suonava si accorse che qualcosa non tornava.
Mi disse: "Per essere pagine inesistenti, è un
buon imitatore, in qualche caso davvero eccellente. Se
anziché inventarsi giochetti patetici si dedicasse alla
composizione, forse avrebbe qualche chance".
«Cosa succedeva veramente in quelle serate? Oggi
lo so: Werth aveva avuto accesso a dei manoscritti
segreti. Qualcuno glieli mostrò, forse addirittura Baldur
von Schirach, con molta più probabilità Hans Fritzsche,
commentatore alla radio e uomo ombra di Joseph
Goebbels, e Hugo Fischer, una sorta di consulente
culturale, un uomo basso con lenti spesse che aveva
l'incarico di fare ordine tra quelle carte portate via,
forse, dalla Staatsbibliothek. Nulla di voluminoso,
intendiamoci, pare fosse una semplice scatola di cartone
assai pesante, ma non troppo grande. Con manoscritti
strappati via da album rilegati, spesso proprio album
che contenevano pagine insignificanti di compositori
di cui non ci importa nulla. Sembra ci fossero almeno
dieci pagine di Mozart, Liszt, alcune cose di Mendelssohn
(bandite, e mai suonate, perché era ebreo), e poi:
Johann Sebastian Bach, Handel, molto, mi creda, davvero
molto. Ma poi era tutto vero? Maestro, ancora oggi
non so quanti di quei manoscritti inediti fossero
autentici, e quanto fosse messa in scena, ma le aggiungo
un dettaglio: tra questi manoscritti c'erano anche molte
pagine di Chopin. E forse quelle della quarta Ballata.
Come arrivò tutto questo a Berlino, è difficile dire.
Credo da Vienna. Ma qualcosa anche da Parigi, e dopo
l'occupazione nazista trasferite a Berlino. Naturalmente
i concerti di Werth, sempre meno frequenti,
continuarono anche durante la guerra; e se il manoscritto
della quarta Ballata era veramente arrivato a
Berlino, certo doveva essere dopo il 1940. Ma tant'è,
caro maestro, la verità non si può sapere: perché intanto
quei manoscritti nessuno li ha mai visti. Qualcuno
disse che Werth se li portò con sé a Santiago del Cile. E
lì continuò a dare concerti.»
James sapeva molto, ma non abbastanza. Oggi
conosco la verità. Franz Werth e Krystyna Puszynska
fuggono da Berlino all'alba del 7 aprile 1945. Hanno
documenti falsi. Un passaporto svedese. Arrivano in
Danimarca, a Copenaghen. Poi da lì a Oslo, dunque
a Londra. A Londra si fermano per qualche giorno.
Come si muova Werth per tre giorni nella capitale
inglese, chi vede, chi incontra, non sappiamo (meglio,
non sapevo). Poi arriva a Dublino, e da lì, con
una nave mercantile, varca l'Atlantico il 23 aprile.
Alla fine di maggio, viene già segnalato in un modesto
appartamento di calle Diego de Almagro (al civico
5). Ma lì rimane poco, cambia appartamento una
prima volta, ma non se ne conosce l'indirizzo. Poi si
stabilisce non lontano dal quartiere di Bellavista: tre
stanze senza riscaldamento in calle Blas Canas (sul
civico il mio foglio è ambiguo, sembra un 3, ma può
essere un 8). Dice di chiamarsi Bauer, e di essere un
pianista tedesco. Krystyna fugge dopo sei mesi con
un ricco latifondista argentino, e lui rimane solo. Qui
c'è il nodo: Werth, naturalmente, viene visitato da
ogni tipo di gente, spiritisti nazisti che come lui sono
scappati in Cile, faccendieri di ogni tipo, anche gente
di grande qualità, uomini che potevano ricavare
molti soldi da quel tesoro che Werth voleva far credere
di avere (perché, con la fuga in Cile, la trance
pianistica cessò da subito; non c'erano più fanciulle e
uomini potenti ammaliati dalle sue qualità medianiche,
c'era innanzitutto bisogno di soldi). Ma sostiene
che quei manoscritti non li ha più, che Krystyna, perfida
e traditrice, li portò via con sé, e che dunque sono
andati perduti. In realtà Krystyna Puszynska
muore molto povera nel 1976 a Buenos Aires dopo
varie disgrazie che qui non interessano, e ha sempre
detto di non aver mai visto nessun manoscritto. Ad
alcuni amici argentini confessò che Werth partì da
Berlino con una grande borsa di cuoio, che portava
sempre con sé come fosse preziosissima; e che però
era vuota.
Cosa succede, dunque? Il tesoro della musica
dov'era rimasto? Mentre guardo questo manoscritto, in
cui cerco ancora un senso superiore, il centro, il punto
profondo che tutto spiega e tutto giustifica, mentre
mi compiaccio di queste note, di queste semicrome, e
di questa carta preziosa e perfetta, penso che il mio
amico James quella sera doveva avere il cuore in gola.
Perché lui aveva passato gli ultimi vent'anni della
sua vita a cercare la borsa di Werth, che a suo avviso
era a Londra, o in Inghilterra; a non trovarla, e dunque
forse a consolarsi con gli strumenti parlanti.
Secondo James, ma allora si guardò bene dal dirmelo,
Werth stette a Londra i giorni necessari per vendere
in blocco il suo tesoro. A quante sterline? A poco,
troppo poco, ma in Cile se vuoi vivere bene e sei un
criminale nazista, devi avere molti soldi. Però James
si sbaglia. Werth, ormai lo so bene, non vendette proprio
nulla a Londra, o meglio non vendette certo dei
manoscritti musicali, che non possedeva. Semmai
sedicenti documenti compromettenti sui rapporti tra
alcuni uomini del Terzo Reich e diplomatici inglesi.
Documenti falsi, forse, che gli fruttarono poche sterline
da alcuni gruppi filonazisti inglesi che si ispiravano,
oltre che a Hitler, anche a Lawrence d'Arabia, e
sostenevano che Lawrence non fosse morto per un
banale incidente di motocicletta, bensì assassinato
dai servizi inglesi perché voleva mettersi in contatto
con i nazisti e stringere una segreta alleanza.
In realtà, Werth poteva suonare molte di quelle pagine,
ma solo perché era stato costretto a impararle a
memoria. Non gli fu mai permesso di conservarle, né
tanto meno di copiarle. E' vero che poteva scriversele
ugualmente, ma come avrebbe dimostrato poi la loro
autenticità? Così teneva a memoria, dagli anni berlinesi,
molti autori, e a memoria naturalmente suonò
anche quando fuggì in Cile. Si seppe poi che il suo
carattere poco costante, e i suoi eccessi, gli impedirono
sempre più di ricordare, e negli ultimi anni della
sua vita a quei pochi che ormai lo andavano ancora a
trovare - con la speranza di avere qualcosa che mai
c'era stato - eseguiva dei frammenti mescolati a
musica sua, con effetti immaginabili. Finché il morbo di
Parkinson cominciò ad aggredirgli le mani, e allora
oltre la memoria si perse anche quel poco di tecnica
pianistica che gli rimaneva tra le dita. Franz Werth
morì solo, povero e alcolizzato qualche anno fa,
nessuno si ricordava più di lui. Neppure quelli che
dovevano cercarlo perché fosse fatta giustizia.
Quella sera James mi fece pensare che il manoscritto
della quarta Ballata poteva essere ovunque: a Londra,
a Ginevra, forse in Russia, ma soprattutto che
quell'offerta era sensata, e andava presa in seria
considerazione. I manoscritti c'erano, ma furono portati
via da Berlino e arrivarono a Mosca, dove diventarono
un vero oggetto del desiderio che sfiorava il morboso.
E venivan confidati, nota per nota, come fossero
dei romanzi proibiti, da uno studente a un altro, e
tra i concertisti, fino a creare delle stralunate leggende.
Dunque il russo non mentiva: trafugato il manoscritto
a Parigi, fu portato dai nazisti a Berlino, e da
Berlino l'Armata Rossa lo trasferì a Mosca; il russo
chiudeva il cerchio riportando ancora a Parigi quei
fogli preziosi.
James, quella sera, pensava che io fossi arrivato al
momento giusto, per risolvergli un mistero, e invece
glielo complicavo. Quella sera si fumò più del solito:
io le mie solite sigarette, lui quei sigari insopportabili.
Ci fu un momento in cui mi resi conto, capii, che
non c'era altro da dire, che io ero soddisfatto, e lui
anche. Gli occhi di James non lanciavano più interrogativi,
non completavano in modo perfetto le sue parole,
aggiungendo significato, come fossero un
plusvalore al ragionamento, all'intelligenza. Doveva
essere stanco, e in quell'ora tarda, tardissima, lo colse
una sorta di malinconia inconfessabile. Eravamo
passati dal grande salone dove teneva tutti gli strumenti
parlanti, prodigi tecnici meravigliosi e
senz'anima, a un altro studiolo, pieno di libri, e con un
pianoforte, uno Steinway a mezza coda, americano,
degli anni Venti, probabilmente. Mi guardò appena:
«Di tanto in tanto suono qualcosa, ma è come se un
giorno mi avessero strappato l'anima, lasciandomi
solo la sua ombra. E così inseguo suoni già dati,
impressi su rulli, o altro, e pagine mute che mi illudo
possano rivelarmi misteri che persino ai pianisti
risultano inestricabili, anche ai più bravi». Mi sedetti
al pianoforte, senza dire una parola; cosa che non
facevo quasi mai. Guardai la partitura sul leggìo. Era
Chopin, un'edizione dei Notturni aperta alla pagina
dell'opera 9 numero 1 in si bemolle: il primo dei
Trois Nocturnes dedicati a Camille Pleyel. Mi sorpresi
di un sorriso non voluto. I Notturni di Chopin sono
a un tempo sublimi e intollerabili; dipende dai pianisti,
non dai Notturni. Persino l'opera 9 numero 2 in
mi bemolle, forse il brano in assoluto più famoso di
Chopin, storpiato da generazioni di fanciulline alle
prime armi, ha un suo fascino profondo. Questo
Notturno, aperto sul pianoforte di James, mi imbarazzò,
perché non riuscivo a capire a quale categoria
James potesse appartenere. Se ai sublimi, che sanno
quanto Chopin amava i suoi Notturni, e dunque sanno
come possono diventare misteriose le note più
semplici; o se invece James era un uomo che apparteneva
all'altro lato del mondo, agli intollerabili. E
magari scoprivo che il mio raffinato amico, in grado
di capire tutto dei fogli della musica, ma anche della
pittura olandese del Seicento, si dilettava la sera a
suonare piccoli Notturni giovanili di Chopin. Quello
che teneva aperto sul leggìo, poi, era un Notturno
molto particolare: tecnicamente assai semplice, e
dunque pericoloso, perché tutti i brani che si suonano
con facilità possono esser eseguiti male, nascondeva
passaggi di grande intensità, allitterazioni di
note, scale lievemente imperfette, abbellimenti e
ornamenti da rendere con esitazione, ma senza esser
leziosi. Cominciai a suonarlo, di fatto a memoria,
non avevo bisogno certo di leggere un Notturno così
famoso. Ma lo feci pianissimo, come se temessi il
silenzio fermo che quella notte portava con sé. Lui era
partecipe, rispettoso, qualche passo indietro il mio
seggiolino. Non accese neppure il sigaro che teneva
spento da un po' di tempo tra le labbra. Il pianoforte
era stato suonato molto, i tasti erano davvero morbidi;
il suono marcava lievemente le note gravi e rendeva
particolarmente squillanti quelle acute: si sentiva
che quel pianoforte era uno Steinway costruito in
America, sono leggermente diversi da quelli che
fabbricano ad Amburgo; morbidi nella tastiera ma decisi
nel timbro. Cercavo di suonare quel Notturno nel
modo più cantabile possibile, senza troppe esitazioni,
sottolineando gli ornamenti, perché il pianoforte,
per nulla lezioso, me lo consentiva senza un effetto
eccessivamente dolciastro. Era bellissimo, devo
ammetterlo, e mentre passavo al secondo tema in re
bemolle mi rendevo conto che a volte Chopin riesce a
trovare soluzioni geniali con molto poco; a creare
attese solo con la ripetizione di una nota più del necessario;
a rendere la malinconia con quelle crome ostinate
della mano sinistra, sestine che si muovono
come un ricordo martellante e sommesso. Poi, quando
suonai gli accordi delle battute finali, e lo feci più
forte di quanto avrei dovuto, di come fosse scritto,
mi accorsi che James si era avvicinato, quasi sfiorava
le mie spalle. Si creò un curioso silenzio, che altre
volte mi era accaduto di ascoltare: pianisti come me,
o suonano da soli, oppure in sale da concerto. Quando
finiscono un brano, spesso sentono applausi,
oppure - quando studiano o incidono - l'accordo o la
nota finale è l'inizio di un processo di ripensamento,
è uno scorrere il brano appena suonato, come a
sentirne un'eco impossibile, e in quest'eco trovare la cifra
per giudicare se stessi. Ma quella era una situazione
ancora diversa: l'applauso era decisamente
inopportuno, tra due uomini abituati al mondo i
complimenti non sono richiesti, specie per un
notturno di quella semplicità. E allora si creò un fertile
silenzio, teso, e compiaciuto: da parte mia e da parte
sua. Solo che James, quel silenzio lo spezzò quasi
subito: poggiò il dito sulla carta, facendo persino
rumore. E sottolineò la quindicesima battuta, scorrendo
il dito per tutta la riga.
C'era un forte appassionato e poi crescendo... con forza.
«Sa cosa vuol dire perdere l'anima dalle mani? Non
riuscire a dare la giusta interpretazione di questo forte
appassionato, di questo crescendo con forza. Non riuscire
a entrare in queste quattro battute, in modo che... come
lo chiamerebbe lei? lo spleen, forse? Sì, diciamo così...
in modo che lo spleen ti possa attraversare la
mente e il corpo in un tutt'uno, come un incendio
improvviso. Suonavo i Notturni in modo eccellente, era
come se tra queste note, apparentemente semplici, io
riuscissi a trovare la complessità, vedessi meglio degli
altri. In qualche studio di registrazione, proprio qui a
Londra, ci devono essere ancora le incisioni dei miei
Notturni: non le ho mai risentite. Ogni tanto provo a
suonarli ancora, ma sono come una bellissima donna,
molto bella, con una cicatrice sulla guancia. Una cicatrice
quasi invisibile, niente di impressionante: ma
tutti faranno caso quasi solo alla cicatrice. Ma no, maestro,
non è l'ora giusta per parlar di queste cose, e poi
forse mi esprimo come un dilettante, da domani pensiamo
al nostro manoscritto.»
Fece cenno di accompagnarmi quando notai uno
strano marchingegno che non avevo mai visto: un
oggetto di legno pieno di sofisticati meccanismi, poco
profondo, largo come una tastiera di un pianoforte,
con due pedali del tutto simili a quelli di un
harmonium. Tra i meccanismi c'era tutta una parte fatta
di bacchette di legno allineate come fossero dei tasti
di un pianoforte. James vide che quell'arnese aveva
stimolato la mia curiosità: «E' un pianista meccanico ad
aria aspirata», disse, «vede quelle bacchette di legno?
Sono in realtà delle dita meccaniche. Quell'aggeggio
si accosta a una tastiera, poi si muovono i pedali,
l'aria passa attraverso un cartoncino di Manila come
fosse un'armonica a bocca, e attraverso un complicatissimo
sistema pneumatico muove quelle 88 dita di
legno, che percuotono i tasti del pianoforte, con tutte
le sfumature possibili. Anche per questo strumento
ho molti rulli, forse anche lo Studio op. 10 n. 12 in do
minore di Chopin».
«No, quello proprio no!», mi lasciai sfuggire, ma a
bassa voce: mentre guardavo sconcertato quel
mostro meccanico senz'anima. E pensavo a quelle parole
del mio amico James: «E' come se un giorno mi avessero
strappato l'anima, lasciandomi solo la sua ombra.
E così inseguo suoni già dati, impressi su rulli...».
Non si esprimeva come un dilettante, James, e
lo sapeva.
Capitolo sesto.
Avrei voluto pensare alla musica come fosse un gesto
magnanimo, un regalo del buon Dio nei sette
giorni della Genesi: la musica frutto della creazione,
assieme agli animali, alle piante, al sole, alla luna, alle
stelle. Se c'è un buon motivo per pensare che Dio
non esiste, è in questo universo muto, profondo,
insopportabile. Da bambino guardavo le stelle e non
pensavo solo che erano belle, che riempivano di luccichii
tutta la volta del cielo; pensavo a quelle palle
di fuoco, lontane miliardi di chilometri, mute, senza
suono: perché il vuoto non diffonde musica, solo
l'aria, gli oggetti, le cose che vibrano, hanno un loro
suono. Studiavo i pianeti e immaginavo le loro rivoluzioni,
lente, in quel mare di nulla e di buio, acceso
soltanto da lontani bagliori, e pensavo che nessuna
musica avrebbe potuto interrompere quel dramma
del silenzio che doveva durare da milioni, miliardi
di anni. E allora forse mi poteva consolare l'esistenza
di un Artefice, o magari un Dio, un motore immobile
capace di spezzare questo orrore. Sì, era meglio che
un Dio esistesse, e fosse come una voce, meglio una
nota, magari grave, che interrompeva per qualche
secondo quell'eterno universo muto, quel silenzio
siderale. Oggi comincio a credere a un Dio che sta da
qualche parte, me lo hanno insegnato gli astrofisici,
ultimi sacerdoti di questa fine millennio: mi hanno
fatto sapere che esiste un suono dell'universo, un
rumore di fondo, che si può udire e immaginare
soltanto attraverso sofisticati radiotelescopi (e pensare
che un tempo le stelle si vedevano, oggi pare che si
ascoltino), ma non riesco ad abituarmi: per tanti anni
le mie stelle e i miei pianeti si muovevano in un
mondo senza suono, come la geometria piana si
spiega senza una terza dimensione. Mi sentivo come
un triangolo equilatero sbattuto d'imperio in un
mondo di solidi: poliedri, coni, cilindri, piramidi.
Però ci ho pensato, e assai spesso, a quel suono:
meglio, a quel rumore di fondo.
E mi sono chiesto da quale strumento uscisse: non
da un pianoforte, neppure da un'arpa, e da nessuno
strumento che produce suoni attraverso vibrazioni di
corde. Allora forse un tamburo di pelli tese, un rullìo
incessante? No, nemmeno quello; credo di essermi
fermato a qualcosa di molto simile a un corno, o
magari persino un sassofono basso. Una sola nota, grave
e bassissima, lunga, e persino lenta, come una macchia
d'olio che avvolge densamente l'universo, ma
senza spezzarsi in rivoli o diramazioni, rimanendo
costante, come una valanga vista al rallentatore.
Quello è il mio suono dell'universo, la giustificazione
che un Dio c'è, e non perché ha creato i pianeti, le
stelle e l'uomo; ma perché, geniale e razionale, dopo
essersi compiaciuto di quello che aveva fatto, e di tutte
le sue meraviglie; dopo che la sua mente aveva
concepito l'infinito, ed era riuscito anche a riempirlo,
quell'infinito, aveva sentito il bisogno di dare un suono
a tutto questo, uno solo, indistinguibile, ma
esistente: semplice, primitivo, come un essere vivente
unicellulare, un'ameba sonora, un miracolo e un
sollievo per tutti.
Qual è la nota di Dio? Un do, un re, o forse un mi
bemolle, un fa diesis. E se non fosse una nota sola, e
neppure un rumore, ma qualcosa di più complesso?
Un accordo di quinta, di settima, o persino un passaggio
vero e proprio che si ripete all'infinito, ruotando
anche lui su sé stesso, come se la partitura di quel
passaggio assomigliasse a certe scritture musicali
contemporanee, che hanno talvolta il pentagramma
circolare, che sembra un disco, e non ha un inizio e
una fine, ma può essere suonato partendo da qualunque
punto. E allora l'universo avrebbe una sua tonalità:
eterna, fissa e costante, e scoprire la tonalità
dell'universo vorrebbe dire accordarsi con il mondo,
con la totalità delle cose. Mi deluderebbe un universo
in do maggiore: troppo definito. E non mi piacerebbe
neppure che fosse in una tonalità minore, notturna,
melanconica; sarebbe un universo triste, quello in
minore. Forse preferirei che l'universo suonasse come
un accordo: e allora vorrei un accordo musicale di
quinta eccedente. Un suono formato da queste note,
assai semplici: do, mi, sol diesis. La nota più alta, il
sol diesis, apre l'accordo, lo estende all'infinito, e fa
pensare a un universo sempre più concavo.
Provo a suonare questo accordo sul mio pianoforte,
lo suono sull'ottava centrale della tastiera: do, mi,
sol diesis; poi riprovo, con più leggerezza sulle dita:
tengo il do e il mi premuti e con il quinto dito suono
prima il sol diesis, poi passo al sol naturale. Sento
ancora la differenza tra un do maggiore eccedente e un
do maggiore naturale: è un intervallo di un semitono,
un mezzo spostamento di frequenza, e già cambia
tutto. Il mio universo si apre, si chiude: passo dal
sistema tolemaico a quello copernicano, dal cielo dei
greci e dei romani, al mio cielo, dal loro mondo
compiuto e solare, al mio, impreciso, inquieto, fatto di
mille citazioni, attraversato dalle opere di Spinoza e
di Nietzsche; e mi compiaccio di tanta potenza in un
solo semitono, in un piccolo intervallo, in una differenza
di vibrazione. Il sol naturale sulla tastiera è un
tasto bianco, il sol diesis è un tasto nero: è il giusto
contrasto tra i due mondi, che sto scorrendo nella
mia memoria in questo momento. Ci fu chi arrivò ad
abbinare i suoni e le qualità dei suoni a ogni pianeta;
lessi già adulto il De occulta philosophia di Cornelio
Agrippa, ne trovai una prima edizione del 1533 da
un antiquario viennese, subito dopo la guerra, e mi
sorpresi a scoprire curiose annotazioni sulla musica:
Saturno ha suoni tristi, rauchi e gravi, lenti e come
raggruppati e concentrati; Marte ha suoni rudi, acuti,
minacciosi, risoluti e come improntati d'ira; la Luna
ha suoni misti tra gli indicati. Questi tre pianeti hanno
in comune la caratteristica di possedere voci o
suoni piuttosto che accordi. Gli accordi contraddistinguono
invece Giove, il Sole, Venere e Mercurio.
Giove ha accordi gravi, costanti, intensi, soavi, gai e
piacevoli; il Sole accordi venerabili, forti, puri, dolci e
graziosi; Venere accordi lascivi, lussuriosi, molli,
voluttuosi, dissoluti e dilatati concentricamente; Mercurio
accordi multipli, allegri, piacevoli per una certa
vivacità.
Avevo sempre cercato una consonanza tra pianeti
e musica, tra il mio universo interiore e quello vero,
quello che stava fuori di me. Quel libro prezioso era
arrivato tardi, in un periodo della mia vita successivo,
quando credevo di aver risolto molte delle mie
inquietudini. Mi sono però sempre chiesto, ogni volta
che mi accostavo al pianoforte, dove finissero le
onde musicali che il mio strumento produceva, se la
grande musica aveva il potere di cambiare l'ordine
dell'universo, le architetture che aveva predisposto il
grande Artefice, in una parola: se potevo influire sul
rumore dell'universo. Quali sono gli accordi lussuriosi
e voluttuosi? Forse potrei arrivare a identificare
quelli piacevoli e allegri: un accordo mozartiano di
sol maggiore è certo vivace, mentre il suono di un
accordo di settima di do diesis si può pensare come
venerabile. C'è stato un momento in cui ho creduto
veramente di aggiornare Agrippa, di andare oltre, di
trovare corrispondenze, analogie, di trasferire il
mondo dentro l'essenza della musica. Ma dovetti
soccombere, non potevo che accettare il contrario:
lasciare che la musica fosse incurante del mondo e delle
sue analogie. Come scrive Schopenhauer: «La musica
non si assimila mai alla materia». I miei pianeti
avrebbero dovuto continuare a girare senza i miei
accordi, i miei do diesis e i miei sol maggiore, o meglio,
quelli dei compositori che sceglievo per avere un'idea
plausibile del mondo.
Ma in questi suoni primordiali, in questi accordi
alterati di un semitono e in questo lieve intervallo
capace di suscitare in me deliri teoretici, non avevo
messo in conto tutta quella musica che Cornelio
Agrippa non avrebbe potuto conoscere, e neppure
Bartolomeo Ramis de Pareja, di cui mi ero comprato,
proprio a Parigi nel 1956, un incunabolo del 1482, De
musica practica. Ero condannato (ma poi quale
condanna?) a vivere dentro la musica romantica: perché
era quella che meglio suonavo, e perché era quella
che amavo di più. E non c'era Richard Strauss che
tenesse, per non dire di Schonberg, che suonavo come
fossi un dilettante della tastiera. Persino Ravel, di cui
mi ero immaginato come un possibile interprete in
gioventù, mi sfuggiva dalle dita, come la molla di un
orologio che non riesci a incastrare, e ti fa rabbia,
perché sai che funzionerebbe solo se quelle due
estremità piccolissime andassero nel posto loro assegnato.
Non so se Dio è un accordo di do diesis settima
maggiore; so però che l'armonia del mondo è solo
una pallida imitazione dell'armonia musicale. Lo
giuro, lo posso assicurare: alcune notti ho creduto di
impazzire, esercitandomi a suonare lo stesso accordo
di due sole note in cento modi diversi, e in questi
cento modi immaginarne altri cento, lievemente
differenti, eppure da me distinguibili perfettamente. La
partitura di un Walzer, il più semplice tra quelli di
Chopin, non è fatta di un accordo di due note, ma di
centinaia di combinazioni, che sfociano in altre
combinazioni possibili, come gli occhi di mille uomini e
donne incontrati per strada; e in quegli occhi intravedi
drammi e malinconie di cui non sai distinguere
i contorni: sono languori, talvolta felicità, sguardi
distratti, di attesa, assopìti in pensieri lontani; occhi
che si distinguono dal corpo, occhi profondi in corpi
magri e scattanti, oppure occhi mobili, che sembrano
ancora giovani, in uomini e donne anziani, e affaticati
dal peso degli anni. Spesso la musica è fatta di
contrasti come questi, interruzioni, bagliori, o solo
un passaggio, brevissimo, che ti risuona in testa per
tutta la vita.
Come i contadini che ricordo io, i nostri contadini,
che si toglievano goffamente i cappelli di paglia
quando si passava per i tratturi e fischiettavano per
tutta la vita un solo motivo, e lo facevano sempre
nello stesso modo. E per loro la musica era quel
motivo fischiato, che forse avevano sentito dai loro
padri o dai loro nonni; e spesso non sapevano neppure
il nome di quel motivo, perché si era perso nella
memoria: i figli uccisi dalla spagnola, le sorelle piegate
dalla fatica, o magari finite a lavorare nelle risaie; le
madri rassegnate nei campi, con le schiene ingobbìte
dai dieci figli allevati come si poteva, sperando che
nascessero maschi, e dunque braccia da lavoro. Li
sentivo fischiettare, i nostri contadini, quando tornavano
dai campi, sudati e per nulla felici di una vita
d'inferno, che faceva dei loro occhi vere e proprie
fessure. Li sentivo fischiettare e pensavo che c'era la mia
musica, ma c'era anche quella musica, semplice, acuta,
a volte stonata: l'unica musica che avevano.
Nell'Italia degli anni Venti, l'Italia di quando ero bambino,
gli uomini fischiettavano anche nelle città, dove
non c'erano auto, e le biciclette strofinavano con
discrezione i loro copertoni sulle strade acciottolate: così
fischiando ci si faceva ascoltare, e spesso un motivo
particolare, udito da lontano, annunciava l'arrivo
a casa. Fischiettavo anch'io, e da ragazzino canticchiavo,
specie quando suonavo al pianoforte motivi
molto semplici, li accompagnavo con la voce. Ho perso
l'abitudine. Come si è persa l'abitudine di chiedere
a un amico pianista di suonare un solo passaggio
di un brano musicale, poche battute che possono
risvegliare un ricordo, un'emozione. Un tempo accadeva,
e nessuno se ne vergognava: sentivi che la musica
era ancora viva, maneggiabile.
Ricordo che una cara amica voleva che suonassi
più volte il tema iniziale del Walzer in la minore,
chiedeva che io lo ripetessi. Accettavo volentieri, tutto
si teneva insieme: la grande musica, l'espressione,
l'interpretazione, e poi il ricordo, l'emozione di
riascoltare, e persino di stordirsi con le stesse note che
si ripetono come un tedioso argomento, quasi all'infinito.
Oggi non ci si permette più un lusso del genere,
tutto è monolitico: i brani sono capolavori intoccabili,
perfetti. Variare, suonare prima una parte, poi
un'altra, scherzarci sopra, cambiare il modo di eseguire
un passaggio non interessa più nessuno, perché
nessuno è più capace di capire cose del genere, di
maneggiare gli strumenti. Come dice il mio amico
scrittore: «Nessuno possiede più le grammatiche». E'
un'espressione un po' fredda, ma rende bene l'idea.
Sono poco mondano ormai, anche se può accadere
che accetti un invito; e spesso gli inviti sono
accompagnati da un pianoforte: suono raramente e, quelle
poche volte, mi trattano come una reliquia di cui non
capiscono nulla. Potrei suonare qualunque cosa e loro
mostrerebbero fieri la beatitudine dell'ignoranza:
tutti, senza distinzione di ceto, censo, classe sociale.
Certo, i miei commensali non chiedono il Notturno
op. 9 n. 2 di Chopin (e almeno avessero il coraggio di
farlo), semmai Eric Satie o Beethoven, con cui non ci
si sbaglia mai. E allora sarei tentato di suonare
l'Appassionata, e non la Tempesta, più alla moda. E
cancellerei dal repertorio Johann Sebastian Bach, che
peraltro le mie mani suonano sempre peggio. Ma tutto
quanto non è Romanticismo, non è passione dell'anima,
va molto di moda, come se le passioni dell'anima
fossero un sentimento disdicevole, da tenersi ben
nascosto, come un'inopportuna scenata di gelosia a
un pranzo di gala. E trovo persino qualche signore
che finge di saper tutto di Wagner, e mi chiede, con
tatto e cortesia, come io possa aver trascorso quasi
una vita nel leggere ed eseguire un compositore come
Frédéric Chopin: lezioso, romantico, minore per
non aver mai composto una Sinfonia, un'opera per il
teatro musicale. E tu a fissarli negli occhi, senza
rispondere: a pensare che se Dio esiste, e forse esiste,
non poteva che dare un solo rumore, una sola nota, a
quest'universo di cialtroni, incapaci di distinguere
un suono da uno stridìo.
Allora che sia un rumore! Un solo rumore per tutti:
e che si senta in ogni luogo dell'universo, con la stessa
intensità, e accompagni la nostra vita di poveri sordi:
un rumore che tentiamo inutilmente di scacciare dalla
nostra mente, dalle nostre orecchie che si illudono di
non udirlo più, coprendolo con altri suoni di ogni
genere: sublimi, meravigliosi, insopportabili, lenti, forti,
veloci, acuti e gravi, metallici e morbidi; e poi ancora
cristallini, e drammatici, e strazianti come il trillo di
un violino, o evocativi come un lontano oboe e le note
più basse di un flauto dolce. Forse ci siamo affannati e
ci affanniamo tutti, i miei contadini che fischiettavano,
i miei maestri compositori, i miei amici musicisti:
tutti impegnati ad allontanare da sé quel rumore che
forse sentiamo di notte, quando le difese del nostro io
si abbassano e la nostra psiche si apre al suono
primordiale. E siamo soli, non possiamo suonare, cantare,
accendere la radio, neppure sentire il rombo del
motore di un'automobile, forse l'unico rumore
concesso è quello dello sferragliare dei tram, giù in strada.
E allora era forse meglio quel silenzio che tanto orrore
mi faceva quando ero bambino e guardavo le stelle,
quei pianeti muti, disegnati sul mio libro di astronomia,
come palle perfette, dalle strisce colorate, su un
fondo nero disperante, come fossero attori in scena, e
risplendessero di una luce spot. Come la mia figura ai
concerti, dove tutto è nero: è nero il mio frac, nero il
mio Steinway, nero il seggiolino, neri (ancora
abbastanza neri, debbo dirlo) i miei capelli, ma chiarissima
la pelle del mio volto e delle mie mani. E quando
comincio a suonare si vede solo la tastiera, le mie mani e
il mio volto. Tutto intorno è il buio, che la luce concentrata
su di me non può rischiarare: ed è come aggiungere
significato a una musica che di per sé ha già abbastanza
significati.
Com'erano i concerti di Chopin? Mio nonno diceva
che erano per metà circenses, per l'altra riunioni di
amici. Nulla era al buio, il pianista era vicino al suo
pubblico, spesso lo conosceva. L'emozione c'era, ma
non la scenografia. E allora tutto cambia se la quarta
Ballata la si suona con persone vicine al pianoforte,
se l'equilibrio delle luci non è studiato, ma è quello
della vita quotidiana. Il concerto, in questo secolo
bisognoso di rituali laici, è l'esteriorizzazione del genio,
qualcosa di unico che si ripete sempre uguale,
ma con dettagli diversi; che siano figli di un'intuizione
particolare o invece di un banale mal di denti, poco
importa. Alle volte è il pianoforte a suggerirti un
modo di suonare diverso, acceleri perché la tastiera
risponde meglio alle sollecitazioni, perché i pesi che
regolano l'abbassarsi dei tasti son calibrati in modo
più felice; altre volte è meglio non arrischiarsi in un
virtuosismo che potrebbe risultare imperfetto: e basta
pochissimo, può dipendere da vaghi dettagli, la
notte prima in cui hai dormito male, qualche sigaretta
di troppo, un bicchiere di whisky, e cambi il modo
di leggere il brano, cerchi di far di necessità virtù.
Partendo da un lieve svantaggio, lo trasformi, quando
è possibile, in un punto di forza. Ma questi scherzi
della casualità non sono contemplati in un mondo
che vuole la cultura, il genio e il talento dentro schemi
rigidi. Perché un pianista come me dovrebbe suonare
un poco più lenta la Polacca-Fantasia di Chopin,
per un mal di testa improvviso? Giammai,
perché «la sua lettura di Chopin sta diventando più
saggia, più meditata, anche l'uso del pedale di risonanza
si fa persino timido, incerto, esitante, come a
voler entrare dentro le pieghe di un compositore, di
cui non ha ancora esplorato tutto, che lascia spazi
ambigui...». Non risposi a questo critico illustre che
recensiva un mio concerto berlinese: bastava che
venisse ad ascoltarmi sei giorni dopo a Monaco di
Baviera, per sentire che quella Polacca-Fantasia diventava
veloce come prima, e che entrambi i modi di
suonarla mi erano congeniali.
Mi tornava in mente questa recensione perché
l'avevo trovata casualmente in mezzo a un libro,
mentre facevo ordine tra quei pochi volumi che avevo
deciso di portar con me a Parigi: odio le biblioteche
immense, fatte di migliaia di dorsi che non si
leggeranno mai, buone per riempire scaffali, per non
vedere pareti bianche. Avevo scelto un centinaio di
libri per la casa di Parigi, quasi tutti classici, quasi
sempre letteratura. Nessun libro sulla musica, nessun
discorso intorno a essa: sulla musica parlano le
partiture, e quelle, di certo, non mancavano. Anche
perché leggevo continuamente partiture: quelle che
stavo studiando, e altre ancora, che non avevo mai
suonato, ma che amavo sfogliare, come si legge un
racconto che poco ci interessa, e lo si fa meccanicamente,
perché è pur sempre uno svago, è pur sempre
narrazione, storia, intreccio. Mentre leggevo e
riponevo quel foglietto più volte ripiegato, con
quell'articolo ingiallito scritto in tedesco (credo che
fosse della «Zeit»), mi tornò alla mente la ragazza
con il cappello. Il perché di questa associazione non
so spiegarmelo. Era la Polacca-Fantasia a evocarmela?
Non credo. O forse il fatto che io, quel giorno,
non riuscivo a suonare come avrei voluto? Neppure
questo, credo. Penso che il mio viaggio a Londra di
qualche giorno prima mi aveva lasciato una forte
voglia di andare avanti. Ed era una voglia frustrata.
Il russo non si faceva vivo. Ma la ragazza con il
cappello, invece, potevo cercarla. E tornare in quel caffè:
per sedermi magari allo stesso tavolino, attendendo
con pazienza, un giorno, due giorni, tre giorni, persino
una settimana. Perché mai in quel tempo lontano
avrei dovuto perder dei giorni ad aspettare? Tanto
più che quella ragazza sapeva dove abitavo,
com'era la mia casa, e persino quanto fosse morbido
il mio letto. In quale racconto potevo aver preso
questa fantasia romantica?
Eppure, oggi che il massiccio della Jungfrau ha i
colori rosso fuoco di un sole che illumina la neve, come
fosse davvero un quadro di Delacroix, un colore
della sua tavolozza, so che feci bene ad andare per
quattro giorni di seguito in quel caffè per intere serate
a leggere libri diversi, ma anche con un occhio
attento a tutti quelli che passavano. Fu in quei giorni
che cominciai a elaborare un'ipotesi che prima di
allora non avevo mai fatto. Perché la quarta Ballata è
diversa? Non sapevo, non sapevo ancora voglio dire,
cosa avesse composto Chopin in quella parte finale.
Però credevo di capire il motivo di quel ripensamento.
E dico ripensamento perché non posso negare la
versione ufficiale della quarta Ballata. Quando fu
pubblicata, Chopin era vivo e nel pieno delle sue
facoltà mentali (quelle fisiche peggioravano sempre
più). E se vado a ripensare a quella lettera che manda
all'amico Grzymala sui diritti da riscuotere per quella
Ballata, mi rendo conto sempre più di quanto Chopin
tenesse alla composizione, e si reputasse un autentico
professionista, al punto da pretendere ben 600 franchi
per la pubblicazione:
Ti ho detto che t'avrei pregato di mandare una
lettera ai miei genitori, e un'altra a Lipsia coi manoscritti.
Non ho altri che te di cui fidarmi. I miei manoscritti
non valgon nulla, ma rappresenterebbero un enorme
lavoro per me se andassero perduti.
Mi ripetevo questa frase, continuamente: «I miei
manoscritti non valgon nulla, ma rappresenterebbero
un enorme lavoro per me se andassero perduti». Se
andassero perduti... Non andò perduto quel manoscritto,
arrivò agli editori e fu stampato. Ma forse Chopin
ci ripensò, ne scrisse un altro, e così pensava di
ripubblicare quella Ballata con la variante, ma non fece
in tempo. Già, potrebbe essere andata così. Potrebbe
darsi che Chopin abbia deciso negli ultimi mesi della
sua vita di rivedere il suo capolavoro, e di rivedere
solo la parte finale. Ma ne avrebbe parlato con qualcuno:
Jane Stirling, per esempio, la persona che si
occupò di Chopin negli ultimi anni della sua vita, con
uno zelo e una determinazione che più volte lo avevano
infastidito.
Jane Stirling non era propriamente una donna
piacente, e neppure discreta, ma dopo la rottura con
George Sand fu l'unica che si occupò di un uomo ormai
malato, allo stremo delle forze. Senza la Stirling,
Chopin sarebbe morto prima e sicuramente non sarebbe
riuscito a far ordine in tutte le sue composizioni.
Fu lei quasi a costringerlo a un lavoro che facesse chiarezza
su tutta la sua opera. Lei lo amava di un platonico
amore, e lui scriveva a un amico che era gentile «ma
così noiosa». Dopo gli eccessi con George Sand,
quell'epilogo affettivo, in un momento drammatico,
sembrava paradossale: Chopin in balìa di una zitella
inglese, ancorché solerte e disponibilissima. Nelle carte
di Jane Stirling c' era la sistemazione completa di ogni
sua opera. La quarta Ballata porta il numero 52. Si dice
che la scrittura sia dell'amico Franchomme. Ma secondo
James è invece un incipit autografo di Chopin.
Niente di più che un inizio. Quale Ballata aveva in
mente quando, come fosse un veloce appunto, segnava
in pochi tratti l'incipit dell'opera 52? Quella che
bramavo (ormai sì, bramavo) di possedere, o quella
stampata e pubblicata che tutti abbiamo suonato in
concerto? Qui la scrittura di Chopin, per quel poco
che se ne può dedurre, è assai decisa, non sembra
mostrare esitazioni. Cercavo in quelle due sole misure un
tratto, un'esitazione del pennino che potesse dirmi di
sì, che il mio dubbio era fondato; che l'opera 52 era
stata rivista, e dunque che forse avrebbe dovuto cambiar
di numero, essere datata in un altro modo. O forse
no, per pochissime pagine non si poteva post-datare
l'opera: sarebbe stata una sproporzione. Ma cos'era
tutto questo? Ero pazzo? Certo, era come se avessi una
sorta di collasso mentale, una tensione a cui non sapevo
far fronte; stavo a spiare due sole misure, a immaginare
se l'inchiostro era più denso, o magari no: se il
grande Chopin, ancor giovane, ma probabilmente con
i tremori di un vecchio, avesse fatto qualche fatica nello
scrivere anche solo queste poche note. E pensare
che il rivedere quella Ballata deve essergli costato
molto, anche fisicamente: visto che negli ultimi mesi
della sua vita il comporre gli era diventato difficile, e
aveva bisogno di molto riposo. In quel tempo, in quelle
sere che mi facevano sentire affetto da una febbre
che mi infuocava il corpo e la fronte oltre il tollerabile,
continuavo a frequentare quel caffè di rue de Rennes,
al punto che cominciai a pensare che ci fosse una relazione
tra la mia Ballata op. 52 n. 4 in fa minore e quella
donna, somigliante a un ritratto di Delacroix, che avevo
incontrato, e con cui avevo passato una delle mie
prime notti a Parigi. Di più, nella mia natura nevrotica,
sapevo (senza ammetterlo neppure a me stesso)
che di certo non avrei mai ritrovato quella partitura
senza incontrare ancora quella donna; e non perché io
facessi di quella ragazza una complice oscura del russo,
né tantomeno perché io la volessi legata in qualche
modo a quella strana e contorta vicenda. Semmai per
una magia, per un effetto di senso che mi piaceva:
volevo che quella calligrafia delle passioni che stavo
cercando avesse una relazione con unapassione dei sensi
che mi turbava in un modo che non avrei immaginato.
E non solo: mi piaceva pensare a lei come alla donna
che mi avrebbe aperto la porta di un enigma per me
insolubile. Insomma mi ero convinto che la mia ragazza
con il cappello doveva entrare nella mia vita, anche
solo come puro concetto. Forse soltanto perché mi piaceva,
e mi piaceva al tempo stesso quel manoscritto: e
non volevo scegliere. E le mie poche forze non riuscivano
a tenere sotto controllo entrambe le cose.
Allora ero io a collegare la calligrafia delle passioni
con una passione della mente, a riportare nel mondo,
in un mondo fatto di gesti e carne, di sguardi e movimento,
pagine di musica scritte nel secolo scorso, e
non per ridare vitalità a quelle ceneri del Romanticismo,
ma per accendere di passione una storia che nella
mia mente rischiava di trasformarsi in qualcosa che
troppe volte avevo già visto e già conosciuto. E in questo
il mio Dio musicale non mi aiutava, e non mi aiutava
neppure Schopenhauer; rischiavo di perder la mia
partita: la musica non ha bisogno della materia e io,
per farla uscire da quella cassa armonica di legno, per
far suonare le note come si deve, proprio con la materia
dovevo avere a che fare, bestemmiando sui fruscii
dei miei martelletti, sentendo le dita sudate nelle giornate
troppo umide e calde, accorgendomi che le notti
passate a leggere mi davano minor elasticità alle mani.
Io ero quella materia che doveva poi scomparire, io
che avrei voluto vivere per sempre dietro i suoni che
producevo. Pensavo a Gould che canticchiava mentre
incideva: nei suoi dischi si sente la sua voce sotto le
note di Bach. E tutti credevano fosse una bizzarria,
mentre non capivano che era la paura folle di non
esserci, di lasciare ai posteri soltanto il suono, lui poi,
che da quando aveva poco più di trent'anni si era ritirato
e non teneva più concerti. Lui che voleva concentrarsi
unicamente sulle incisioni e lasciare a quelli che
sarebbero venuti dopo soltanto i nastri della sua
musica. E perché lui, perfezionista più ancora di me,
permetteva che si pubblicassero dischi mirabili nel
missaggio e disturbati poi dalla sua voce? Solo per
un'eccentrica bizzarria?
Proprio no: era un modo per ricordare a chi ascolta
che lui esisteva, che lui c'era, che quella musica veniva
da un signore che si chiamava Glenn Gould, e che
non è solo il signore ritratto sulla copertina del disco: è
nel disco. Ci sono le sue mani, i muscoli stanchi, c'è il
sudore di un uomo che si sforza di elevare la musica
oltre la materia. E chi ascolta i dischi di Gould sa che
lui c'è, per sempre, là dentro. Anch'io fui tentato di
incidere facendo ascoltare di tanto in tanto la mia voce
che accompagnava qualche nota. Ma non ho mai osato:
sono un vecchio pianista educato al suono come
fosse un'emissione sacra. Di tanto in tanto si ascolta
nelle mie incisioni il respiro, lieve, e si sente in particolar
modo quando suono i pianissimi, perché le sale di
incisione trattengono tutto, come fossero spugne.
Ma in quei giorni in cui inutilmente tornai al caffè di
rue de Rennes a cercare ancora una persona che nulla
poteva sapere delle mie trame mentali, dei fili che
legavo assieme, avvertii per la prima volta che la soluzione
del mio enigma doveva essere vicina, molto vicina.
Capii che il tempo era dalla mia parte, e che tutto
sarebbe andato a posto, perfettamente, come fosse
una Fuga del Clavicembalo ben temperato, dove ogni voce
è perfetta, ogni nota insegue l'altra, e si inizia cauti,
in modo abbastanza semplice, per arrivare poi alle
ripetizioni del tema, incrociate, approdando a una
ricchezza tematica che dà stordimento e piacere, per poi
giungere a un finale che tutto risolve e restituisce una
sensazione di benessere e di pace. Mi sarebbe piaciuto
che l'andamento di quella storia fosse simile a quello
di una Fuga di Bach. Avrei voluto fosse così: era la lingua
che meglio conoscevo, non mi avrebbe spaventato.
Ma anche se non fosse stato Bach, anche se avessi
dovuto muovermi per composizioni più infide, meno
geometriche, avrei provato comunque un senso di
comprensibile felicità. Una Sonata di Beethoven, o
ancora lui, Chopin, magari uno Scherzo, imprevedibile,
virtuosistico, eclettico: anche questo mi avrebbe dato
una sensazione di sicurezza, allo stesso modo dell'alpinista
che non ha paura di una parete aspra ma di cui
conosce ormai tutti i segreti, anche quelli che potrebbero
fargli commettere un passo falso, che potrebbero
farlo cadere.
Attraverso quale partitura si poteva leggere la mia
vita di quei giorni? Né Bach, né Beethoven, e per
quanto riguarda Chopin, se lui era il più vicino a me,
doveva esserlo in qualche pagina che ancora non
conoscevo. Al punto che mi accorsi un pomeriggio in
quel caffè, da solo, che cominciavo a fantasticare sulla
storia della quarta Ballata. E se le vicende di cui ero
protagonista non fossero state altro che il contrappunto
di quelle pagine? E se fossi stato io a decidere, come
fossi l'Artefice del suono, come un Dio del rumore
universale, cosa avrei trovato in quella scrittura che
ormai volevo incerta, persino morente, dello stremato
Chopin? Io, la mia vita, le mie passioni, parti integranti,
voci di quella partitura? Era rivelatore pensare che
tutto ciò che mi accadeva nella vita in quel periodo
avesse un corrispettivo in fa minore che ancora non
conoscevo. E allora non c'era più la possibilità di pensare
a un rumore dell'universo, feroce e terribile, come
il Dio dell'Antico Testamento, e neppure a
quell'intuizione di Schopenhauer sul rapporto tra materia
e musica, e dunque tra Rappresentazione e Volontà.
Per non dir poi della musica in Cornelio Agrippa, che
cercava nei suoni una corrispondenza dell'ordine
universale. No, ora capivo che la mia quarta Ballata con
quella variante finale stava aspettando me, e da
centocinquant'anni. Era passata da amici di Chopin troppo
distratti, ad altre persone di cui nulla sapevo, ed era
arrivata a Berlino, suonata da uomini che di questa
musica nulla avrebbero potuto cogliere; per poi giungere
a Mosca, eseguita forse da qualche vile e sublime
pianista, nel segreto di casermoni staliniani. Infine,
tornando ancora a Parigi attendeva me. Come attendeva
me, in un caffè di rue de Rennes, una deliziosa
fanciulla di nome Solange, Rappresentazione di quella
Volontà in forma di musica a cui stavo consegnando
il mio grande virtuosismo, e forse la mia esistenza.
Capitolo settimo.
Solange Dudevant era una ragazza molto capricciosa
che da bimba non ebbe grandi attenzioni dalla
madre, troppo impegnata a scrivere libri e a condurre
una vita romantica e mondana. Così venne cresciuta
da balie e nonne, assieme al fratello Maurice; e quelle
poche volte che la madre andava a trovarla la vestiva
da maschietto. Eppure Solange crebbe con una carica
sensuale e femminile che quei vestiti da maschietto
non riuscirono a cancellare: montava a cavallo con
grande eleganza e possedeva un carattere difficile e
mutevole.
Solange Dudevant era la figlia di George Sand; di
lei la madre diceva: «E' bella, e cattiva». Proprio per
questo prima viene mandata in convento, poi affidata
a un'istitutrice: Marie de Rozières. E Marie ha un
incarico preciso, sottrarre Solange alla compagnia
degli uomini. George Sand le scrive: «Giunge sempre
il momento in cui le ragazzette non sono più tali
e in cui bisogna vegliare sul significato che, nel loro
spirito, possono assumere tutte le parole che esse
sentono. Non una parola, anche indifferente, sul sesso
maschile: ecco tutta la prudenza che vi raccomando».
Le parole della Sand servono a poco. Solange rimane
impertinente e molto interessata agli uomini,
forse troppo.
Nel 1845 Solange ha diciassette anni e il suo rapporto
con Chopin diviene più intenso. Lui scrive: «Mi
sento immerso in un'atmosfera strana quest'anno. Vivo
in spazi immaginari. Non so perché, ma non faccio
nulla che abbia valore e tuttavia lavoro, non vagabondo
da un posto all'altro. Trascorro intere giornate e
serate in camera mia. Devo tuttavia portare a termine
certi manoscritti prima di rientrare, perché durante
l'inverno non posso comporre. Ieri Solange mi ha
interrotto mentre lavoravo chiedendomi di suonarle
qualcosa; oggi ha voluto farmi assistere all'abbattimento
di un albero: torno da una passeggiata con lei,
mi ha voluto portare in carrozza scoperta».
Quel rapporto tra Chopin e Solange non è mai stato
chiarito da nessun biografo: accenni timidi, e troppe
preoccupazioni di lasciar fuori Chopin da storie
poco chiare e un po' morbose. Ma ci fu un momento
in cui a Parigi si diffuse la voce che lui avesse chiesto
la mano di Solange alla madre. E la Sand fu costretta
a smentire quella che venne considerata una notizia
senza fondamento. Certamente, tutti i biografi ci dicono
che furono i figli di George la causa della rottura
tra il compositore e la scrittrice. E' vero che Chopin
mostrava un grande affetto per Solange, ma aveva
anche pessimi rapporti con Maurice, l'altro figlio,
che lo detestava e pretendeva di essere un artista, un
pittore.
Solange si prese cura di Chopin quando a Nohant
George Sand cominciava a stancarsi di lui, a sopportare
sempre meno la sua malattia, e Chopin cercava
di proteggere la fanciulla dai dispetti della madre e
di suo fratello Maurice, Tutto avveniva in un quadro
che doveva essere fertile e creativo, e in realtà era
assai piccolo e meschino. Maurice, un giovane violento
e viziato, iniziò una relazione con Augustine Brault,
una lontana cugina che divenne figlia adottiva della
Sand: vivace come la polvere da sparo, si diceva. La
relazione era dunque scandalosa, e per quanto la si
volesse segreta, cominciava a dare imbarazzo. George
Sand fingeva di non saper nulla, ma in fondo
quella storia non doveva dispiacerle. Chopin invece
disapprovava, e Solange si indignava, anche perché
considerava Augustine una plebea. Si crearono due
fazioni: da una parte, Chopin e Solange; dall'altra,
Maurice e la madre. E non bastava. Di lì a poco Solange
si fidanzò con uno scultore, tal Auguste-Jean
Clésinger, un uomo intelligente e senza scrupoli che
si impose a Solange con grande sfacciataggine. George
Sand acconsentì al matrimonio, ma Chopin non
amava affatto Clésinger, lo considerava un avventuriero.
E la Sand lo sapeva, al punto che in una lettera
al figlio dove annunciava il suo consenso al fidanzamento
di Solange, scriveva: «Non una parola a Chopin:
tutto ciò non lo riguarda, e una volta varcato il
Rubicone i se e i ma fanno solo male».
Cosa accadde davvero in quell'estate del 1846? Oggi
sappiamo che fu l'ultima estate a Nohant, l'anno dopo
Chopin non sarà più invitato. George Sand lo tratta
con freddezza, Maurice gli è apertamente ostile, e
Solange ha ormai il suo Clésinger. Solo che tra Solange e
Chopin rimane un rapporto forte e affettuoso. I biografi
dicono che, dopo il matrimonio con Solange, Chopin
inizierà a stimare Clésinger. Ma nessun biografo mette
in dubbio che l'amicizia affettuosa e protettiva tra
Solange e Chopin possa mai essere stata qualcosa di
diverso. Chopin è uomo ineccepibile, di grandi princìpi,
che prese a considerare i figli della sua compagna come
figli propri. I biografi tendono ad accreditare di continuo
un'immagine di Chopin fortemente filtrata da un
certo moralismo. In realtà, molti lati oscuri rimangono.
In una lettera piuttosto ipocrita di George Sand
all'amico di Chopin Grzymala, si legge:
Per sette anni ho vissuto come una vergine con lui
e con altri, son invecchiata prima del tempo, tanto sono
stanca di passione, e incredula che essa ritorni. Se
una donna al mondo avesse dovuto ispirargli completa
fiducia, quella avrei dovuto essere io, ed egli
non ha mai capito. So che molte persone mi accusano,
le une di averlo esaurito con le violenze della mia
passione, le altre di averlo ridotto alla follia con le
mie pazzie. Credo che voi sappiate come stanno le
cose. Egli si lamenta ch'io l'abbia ucciso rifiutandomi
a lui, mentre io son certa che l'avrei ucciso se avessi
agìto altrimenti... Sono stata una martire; ma il cielo
mi si è mostrato inesorabile, come se avessi dovuto
espiare grandi crimini: perché in mezzo a tanti sforzi
e a tanti sacrifici, colui che io amo di amore assolutamente
casto e materno, muore vittima del suo insensato
affetto per me.
Ho sempre sospettato che il rapporto tra Solange e
Chopin non fosse soltanto amichevole, nonostante fiumi
di inchiostri ipocriti. Al matrimonio di Solange
Chopin non fu invitato, e l'episodio lo irritò fortemente.
Cambiò opinione sul marito quando ormai si era
rassegnato, ed era anche molto stanco. E preferì rivedere
e scrivere a Solange da buon amico piuttosto che
perderla del tutto. Forse è un'illazione, ma Chopin doveva
scrivere a Solange cose davvero inconfessabili. In una
lettera del 9 settembre 1848, quando ormai lei è sposata
con Clésinger, Chopin scrive, piuttosto spaventato:
Mi è capitata una strana avventura mentre stavo
suonando la mia Sonata in si bemolle a degli amici
inglesi. Avevo eseguito pressoché correttamente l'Allegro
e lo Scherzo; stavo attaccando la Marcia, allorché,
improvvisamente, vidi levarsi dal coperchio
semiaperto del pianoforte le creature maledette che, in
una lugubre sera, mi erano apparse alla Certosa.
Dovetti uscire un attimo per riprendermi: poi mi sono
rimesso a suonare senza dir niente.
Questa lettera è rimasta per molto tempo inedita.
Me ne parlò per la prima volta Bernard Gavoty che la
comprò a Londra e stava per pubblicarla in una sua
biografia di Chopin. Non sapevo dove, neppure
quando, ma il manoscritto della quarta Ballata doveva
passare certo dalle mani di Solange Clésinger. Forse
ha l'ordine di bruciarlo, dallo stesso Chopin.
Solange è una delle poche persone davvero amiche che
sono al capezzale di Frédéric in place Vendome.
Qualche mese prima, nel maggio del 1849, quando
con l'esplodere di una primavera calda Chopin ebbe
un periodo di miglioramento del suo stato di salute,
finirono bruciati nel camino moltissimi manoscritti
che voleva distruggere; sapeva che non gli rimaneva
molto tempo e raccolse le forze per non lasciare pagine
inedite che non approvava. Rimase qualcosa,
quelle che oggi conosciamo come opere postume, e
che pubblicò Julian Fontana.
Ma ancora poco prima di morire Chopin si raccomandò
di non far stampare più nulla, di distruggere
ciò che era rimasto. Con ogni probabilità si può datare
la revisione della Ballata attorno ai primi mesi del
1849. Chopin cambia la dedica a Madame Solange
Dudevant. Poi la consegna a Solange. Meglio, la regala.
Pensa di pubblicarla? Probabilmente no: è un gesto
d'amore, di passione; e per questo deve rimanere
discreto. Cosa fa Solange di quel regalo inconsueto? Forse
subito non capisce, vede che la Ballata è stata dedicata
a lei, e le fa piacere, ma non si accorge delle ultime
pagine. Non ci sono lettere che accompagnano il
manoscritto; dunque quello che si son detti Chopin e Solange
non lo sapremo mai. Sappiamo che Solange non
fu una pianista, per quanto avesse avuto come maestro
persino Chopin, in grado di suonare quella partitura.
E allora? Cosa fa di questi preziosi fogli? Mi
sarebbe piaciuto chiederlo alla mia fanciulla, che di
nome faceva Solange, ma di cognome certo non
Dudevant. E che il destino mi aveva mandato la notte prima
di incontrare il russo. Cos'era questo, il gioco del
caso? O un avvertimento del mio Dio musicale, che mi
voleva interprete di un mistero che si svolgeva in fa
minore? Allora non potevo sapere che Solange era
qualcosa di più della figlia di George Sand, e buona
amica di Chopin. E quando la ragazza di rue de Rennes
pronunciò il suo nome ravvisai solo un effetto, un
gioco, una musica di idee. Poi capii che a volte nella
vita accadono cose che hanno attinenza con il romanzesco.
Per sapere che Solange era stata la prima a possedere
il mio gioiello musicale ci volle tempo. E ci volle
un russo che non si chiamava Frédéric, per fortuna,
e che aveva un nome che non avrebbe turbato nessuno.
E sapevo che prima o poi sarebbe riapparso sotto
la mia finestra, e come un dilettante del mistero avrebbe
cercato di imbrogliarmi. Ma sapevo anche un'altra
cosa: lo avrebbe portato con sé, quel manoscritto. Non
poteva abusare della mia pazienza.
Non lo fece. Quattro giorni dopo la mia ultima
sortita al caffè di rue de Rennes, in un pomeriggio
davvero caldo, mi affacciai alla finestra e si alzò il
sipario sulla commedia di quel frammento della mia
vita. Lui stava giù, immobile, appoggiato a un muro,
non guardava verso le mie finestre, e ansiosamente,
come aveva fatto la prima volta. Sembrava sapesse
che sarei stato io il primo a vederlo, che io avrei attirato
la sua attenzione, perché questa era la regola.
Stringeva tra le braccia una vecchia e consumata borsa
di cuoio. Guardai proprio la borsa, e prima di
ogni cosa, come a voler giustificare la mia relazione
con quell'uomo solo attraverso un oggetto o, meglio,
ciò che quell'oggetto doveva contenere. Non cercai
la sua attenzione da subito, mi tirai quasi indietro
dalla finestra, come d'istinto volessi proteggermi da
quanto sarebbe accaduto. Lo temevo, temevo che
non ci fossero manoscritti, che potesse rapinarmi,
obbligarmi a consegnargli del denaro. Ebbi paura
che questa volta fosse armato, e in me tornarono tutti
i timori fisici che avevo da bambino, quando lo
studio eccessivo del pianoforte mi rafforzava le mani,
i polsi, le braccia, ma mi rendeva goffo e meno
forte fisicamente degli altri ragazzi (che peraltro non
frequentavo). Fu solo un lampo, un timore che
venendo da lontano se ne tornava lontano: feci un passo
in avanti, ma non mi piegai coi gomiti sul davanzale,
volevo che la mia figura, che il russo a quell'ora
doveva vedere in controluce, fosse più dritta e più
ieratica possibile; che il mio corpo avesse l'autorevolezza
dell'attimo prima di sedere al pianoforte in un
concerto. Volevo che lui sapesse chi aveva di fronte,
e non solo: che mi temesse, e subisse quell'autorità e
quel carisma che doveva aver sentito nei miei
concerti a Mosca e Leningrado. Chi può dire se ci riuscii?
Mentre pensavo a tutte queste cose, rigido, di fronte
alla finestra, lui mi guardò, alzando di scatto gli
occhi verso di me. E quasi senza volerlo feci un cenno
del capo, che voleva dire: sì, puoi salire. Sapevo che
un manoscritto di Chopin non si consulta in un caffè,
o su di una panchina.
«Maestro, finalmente...», mi disse tendendomi la
mano, quando ancora non aveva salito per intero la
rampa della scala. Mostrava sicurezza, e forse
imbarazzo, di fronte al mio fare gelido e trattenuto. Sapevo
che avrebbe cominciato con infiniti complimenti: sul
mio appartamento, sull'arredamento della casa, e la
posizione, e non so che altro. Però mi sbagliai: entrò
senza dire una parola, quasi senza guardare neppure
l'ingresso, si voltò un attimo prima che chiudessi la
porta, per vedere se qualcuno lo aveva seguito per le
scale. Ma cercò subito di giustificarsi: non temeva nulla,
che stessi tranquillo, era solo un'abitudine antica e
radicata. Guardò soltanto il pianoforte nel salone,
girandogli attorno fino ad arrivare alla tastiera: si piegò
sulla partitura aperta sul leggìo: «Scrive molto sulle
partiture: che bello sarebbe pubblicare questi appunti,
per giovani pianisti; gli studenti del conservatorio di
Mosca fogli come questi se li strapperebbero di
mano». Non badai a quelle parole: gli appunti sulle partiture
erano per me un'antica abitudine. Segnavo ai
margini anche pensieri che non c'entravano nulla con
la musica, come fossero fogli per scrivere aforismi
casuali, impressioni. Non badai a quelle parole, e mi
affrettai a chiamarlo, dopotutto quelle annotazioni erano
molto personali, e mi infastidiva che qualcuno
potesse leggerle: «Si accomodi, signore», dissi indicando
il divano di fronte alla finestra.
Il racconto entrò subito nel vivo: «Dunque la prima
persona che ha in mano questa carta è una donna: la
figlia di George Sand. A lei è dedicata la Ballata. E dire
che la baronessa di Rothschild fu donna assai vicina
a Chopin, fino alle sue ultime ore».
Gli feci notare che mostrava di conoscer bene la vita
di Chopin, e mi rispose che avere in mano un documento
affiorato dall'oblio porta a saper tutto su ciò
che gli sta attorno, a capire il mondo che lo ha generato.
Un po' come il voler conoscere proprio ogni cosa
del passato di una nuova amante: «Così, maestro, ho
cominciato a legger libri e lettere, biografie, diari. Non
doveva sfuggirmi nulla e non solo di Chopin, ma anche
di George Sand, e Delacroix, e Liszt, e Mickiewicz,
e Julian Fontana, e più in generale del gruppo che
ruotò attorno a Chopin per tutta la sua vita». Seppi così
del perché quella Ballata rimase per molto tempo in
un cassetto, nascosta: era la prova di un rapporto che
qualcuno poteva pensare quasi incestuoso. Certo,
Chopin non era il padre di Solange, e di fatto neppure
l'amante della madre. Però era vero che Chopin
conobbe Solange quando era ancora bambina, ed ebbe
all'inizio atteggiamenti paterni; poi, lei cresciuta, si
mostrò più volte geloso e si oppose al matrimonio con
Clésinger; fino a rompere i rapporti con George Sand
proprio a causa della figlia.
«Dunque, nei primi mesi del 1849 Chopin decide
di cambiare la coda della Ballata. Sembra lo faccia
piuttosto rapidamente, e probabilmente è l'ultimo
lavoro importante che porta a termine. Persino lo scrivere
una lettera di sole due pagine lo mette in ginocchio,
gli toglie ogni forza.»
«Come può sapere che furono i primi mesi del
1849 e non ancora prima? E come fa a dire che è
autentico?», chiesi impaziente.
«Un momento, maestro, non abbia fretta. Le pare
che sarei qui se possedessi un manoscritto falso?»
Sorrisi sconfortato: «Niente di più facile. Il mondo
è pieno di manoscritti falsi».
«Non il mio», disse il russo, con l'aria di chi vuole
chiudere un discorso che l'annoia profondamente, che
credeva di non dover più fare. «Maestro, avrei preferito
che lei discutesse con me di altre cose. Non sull'autenticità
di un testo. D'altronde, credo lei sappia bene
che quel manoscritto può esistere, e che qualcuno lo
ha perfino suonato, negli ultimi cinquant'anni, assieme
a molte altre partiture segrete.»
«Franz Werth...», dissi sottovoce.
«Non so chi sia questo signore, so di alcuni pianisti
sovietici che poterono copiare e suonare molta di questa
musica. Ma gente minore, di cui lei certamente non
avrà mai sentito parlare. Ma la Ballata no, quella fu
suonata da una sola persona...»
Il dubbio però era forte: perché queste pagine sono
rimaste nascoste, e nessuno ha mai pensato di
pubblicarle? Tenterò qui di sintetizzare un po' di quanto
il russo mi disse. Secondo lui, ma anche secondo
quanto mi raccontò alcuni anni dopo un antiquario
di Amsterdam specializzato in manoscritti musicali,
fino ai primi anni del Novecento non c'era l'ansia di
pubblicar tutto. E non erano in molti a occuparsi di
dettagli musicali così marginali. Poi arrivò il momento
della gelosia morbosa: l'imperativo era di possedere
qualcosa di unico, che nessuno poteva avere, e
nessuno poteva suonare, se non per la concessione di
un privilegio.
Chi era Werth? Un mero esecutore, una pianola
meccanica come quelle del mio amico James, a servizio
dei suoi amici nazisti, pronto a usare le mani come
fossero un rullo musicale. Chi erano i fantomatici pianisti
di cui mi si parlava? Mestieranti pronti a far udire
qualcosa di raro e prezioso solo perché schiavi di un
regime che dava questo privilegio, e poteva toglierlo
in qualunque momento. Sorta di eunuchi musicali.
Per quanto ne sapevo, nessun pianista di quelli che
potevano leggere correttamente quella variante ne
aveva mai sentito parlare. Ma se questa era storia quasi
recente, quella che la precedeva, e andava da Solange
fino a Franz Werth, come si poteva spiegare? Perché
quella Ballata non arrivò mai a qualcuno che
potesse suonarla? Secondo il mio amico russo il cambio
di dedica poteva creare problemi a Solange, che
conosceva assai bene la baronessa di Rothschild. E
non solo: George Sand, già inferocita verso la figlia,
avrebbe sospettato una relazione tra Solange e Chopin
se solo avesse saputo di quella dedica, di quella partitura,
di quella variante.
Dunque, fino alla morte di Solange, nel 1899, quelle
pagine rimangono certamente in un cassetto. Come
ne escono? Arrivano nel 1906, assieme a libri e ad
alcune lettere che Chopin le scrisse, a un piccolo collezionista
che comprava e vendeva (assai a poco) e che
abitava proprio a rue Pigalle, un centinaio di metri di
distanza da una delle abitazioni di Chopin a Parigi. Lì,
tutto viene smembrato, ma senza capirci più di tanto. I
libri si ritrovano vent'anni dopo in vari cataloghi
antiquari di Parigi. Delle lettere nulla si sa. Tranne forse di
una, quella comprata da Bernard Gavoty a Londra,
dove si racconta degli spiriti maligni che escono dal
coperchio del pianoforte. Il resto è mistero, vero.
«Caro maestro, mi permetta di parlarle con la
confidenza che si conviene: quelle lettere forse dicevano
la verità sul rapporto tra Chopin e Solange. Ma non
ci sono: come non ci sono neppure le lettere di Chopin
a George Sand, tutte bruciate dalla signora. Perché?
I biografi danno una spiegazione troppo semplice:
riconducono tutto alla crudeltà della scrittrice,
ai suoi sbalzi d'umore, al suo egocentrismo. Niente
affatto: George Sand era furiosa, troppo furiosa;
mentre Chopin era distrutto, avvilito, e non solo per
il suo stato fisico...»
Ma cosa c'era in quelle lettere? Solo la prova del
rapporto tra i due? Chopin si rivelava uno spirito ben
diverso da quello che conosciamo: meno puro, meno
romantico, certo più tormentato e contraddittorio?
Quell'unica lettera ritrovata da Gavoty starebbe a
testimoniarlo. Fu l'unica visione, l'unico delirio di
Chopin? O c'era di più? Secondo il russo, che si
permetteva di chiamarmi «Caro maestro», c'era di più.
Ma, per quanto mi affascinassero, si trattava di fantasie
eccessive, buone forse per rendere ancora più
densa la storia del manoscritto.
Eppure, in quel pomeriggio troppo caldo capii che
- e non c'erano più dubbi - il suo manoscritto era
autentico. Da un dettaglio: dal modo in cui teneva la
sua borsa, senza abbandonarla mai, quasi fosse lui a
temere qualcosa. Poteva portargliela via un vecchio
pianista come me? Non era credibile. E allora c'era
qualcosa di irrazionale, un'affezione del cuore che gli
impediva di lasciare sul divano quella borsa, e lo
costringeva a tenerla tra le mani mentre mi parlava.
Mani che osavano toccare la borsa quasi con voluttà,
ma che poi vidi timide, tremanti, esitanti mentre
accompagnavano le sue parole. Un uomo si tradisce
particolarmente con i gesti: le mani parlano, hanno
linguaggi che altri non conoscono, vanno spiate,
osservate, seguite nei loro movimenti, morbidi, violenti,
prepotenti. C'è un linguaggio fatto con le mani,
che vive dietro le parole, e le sorregge. Più di una volta
mi sono sorpreso a immaginare come avrebbe suonato
un mio allievo (ne ho avuto qualcuno, ma per
un breve periodo) osservando come muoveva le mani
durante il colloquio preliminare. E debbo dire di
non essermi sbagliato quasi mai. Le mani del russo a
guardarle bene erano forti, passionali e rispettose.
Sentivano la forza musicale di quel manoscritto, e al
tempo stesso erano legate a esso da una malattia
possessiva. Forse lo aveva tenuto con sé molto tempo. E
chissà, l'avrà magari nascosto in qualche anfratto della
sua casa di Mosca, senza che nessun poliziotto se
ne potesse accorgere (e che ne sanno poi, gli aguzzini
totalitari, di calligrafie delle passioni).
Il mio amico (e qui mi sorprendo a chiamarlo per la
prima volta in questo modo) proteggeva la sua borsa
come fosse una creatura fragile, come un messaggio in
una bottiglia da gettare in un mare in burrasca, al punto
che mi allontanai da lui: mi alzai, e presi a passeggiare
per la stanza, come a rassicurarlo. Anche il mio
era un messaggio, ma lui continuava a parlare:
«Non mi chieda troppi dettagli, maestro, sui
passaggi di questo manoscritto. So da dove partì, e so come
arrivò dalle mie parti. Nel 1946 si sentì parlare di
un pianista del conservatorio di Mosca, uno che scomparve
tre anni dopo, e non se ne seppe più nulla. Non
fuggì in un'isola incontaminata, maestro, dalle mie
parti si andava al freddo per non tornare più. Bene, si
diceva che questo pianista suonava le Ballate di Chopin
in un modo strano. All'inizio si parlò delle Ballate,
in un modo generico. Ma le informazioni in ambienti
come quello si fecero subito morbose. Come suonava
quelle Ballate? In un modo normale, le prime tre. La
quarta, alla fine cambiava. Assomigliava un po' alla
parte finale della seconda, con un Molto agitato, o
meglio, pareva un Presto con fuoco, ed era diversa da quella
che conoscevamo tutti. Lei può capire come queste
notizie circolino in ambienti così ristretti. Perché proprio
lui ebbe il privilegio di leggere quella partitura?»
Dopo la caduta dell'impero sovietico, ho potuto
sapere qualcosa di più di quel fantomatico pianista. Dagli
archivi del Kgb risulta che il suo nome era Andrej
Charitonovic, era nato il 6 marzo 1928 nel paesino di
Zovnin, non lontano da Kiev, in Ucraina. Virtuoso e
promettente concertista, fu arrestato nella notte tra il
16 e il 17 febbraio del 1949 e spedito in un lager
probabilmente perché la sua omosessualità, vissuta in modo
troppo esplicito, infastidiva. Neppure le carte del
Kgb mi hanno saputo dire quale fu il suo destino.
Morì probabilmente in un campo di lavoro siberiano
nell'inverno del 1957. Nel foglio si davano informazioni
anche sulla sua famiglia: tutti deportati, tra il
1950 e il 1952, e tutti morti sul finire degli anni
cinquanta, madre, padre e due fratelli più grandi di lui.
Ma il mio amico russo mi spiegò che tra il 1947 e il
1949 Charitonovic ebbe un ruolo importante al
conservatorio di Mosca, dove fu l'amante di un vecchio
professore di pianoforte. Probabilmente fu lui a fargli
leggere il manoscritto di quella Ballata. E forse il suo
entusiasmo giovanile gli aveva fatto commettere un
errore, non doveva suonare quelle note in presenza di
altri. Chi lo denunciò?
«Non saprei, maestro, è passato troppo tempo. Io
lo conoscevo bene, molto bene e sentii suonare quel
brano per la prima volta proprio da lui una notte in
cui ci eravamo riuniti in molti ad ascoltare e suonare
Chopin, che noi leggevamo come un compositore per
metà polacco e per metà francese, che odiava i russi
invasori. Doveva essere nel gennaio del 1949. Mio
padre era fortemente contrario a quelle mie amicizie,
forse sapeva i rischi che si correvano, e certamente
non gli piaceva che uno di noi potesse suonare anche
solo un frammento di quel materiale che era arrivato
da Berlino, in un baule piombato al seguito dell'Armata
Rossa. Ma non subito, sembra che quel materiale
fosse trasportato a Mosca solo nel novembre del
1946. Prima fu esaminato con attenzione, e rimase
fermo ancora a Berlino.»
Quanti erano a conoscenza di quelle partiture? E di
che cosa si trattava? Oltre a Chopin, cosa c'era? Più o
meno il repertorio di Werth a Berlino e a Santiago, ma
anche qualcosa di più. Nessuna Sonata di Beethoven
sconosciuta però, certo molte pagine di Handel,
Mendelssohn, Clementi, e soprattutto Bach, Liszt, e alcune
pagine oscure di Debussy, pagine che lui non volle
mai pubblicare. Erano partiture arrivate a Berlino per
vie diverse, e provenivano - diciamo così - da collezioni
private di mezza Europa. Alcune da Parigi, altre
da Londra, e altre ancora da Vienna, naturalmente.
Molte furono requisite ai legittimi proprietari, specie
quelle di Parigi e di Vienna. Ma furono anche regolarmente
comprate. Non si può dire che non sarebbero
mai state pubblicate, ma si aspettava: non c'era fretta
di far conoscere quelle pagine a tutti. Nessuna fretta.
«No, nessuna fretta. Questo manoscritto ho deciso
di offrirlo a lei da quando lo possiedo», il mio amico
russo era quasi emozionato, forse si aspettava da me
qualcosa di simile a un sorriso compiaciuto. Ma non
venne, sebbene mi accorgessi che le sue mani e i suoi
modi, che in un primo tempo mi parevano intollerabili,
cominciavano a convincermi. E quel senso di
repulsione si allontanava sempre più: «Ricorda quando
le dissi che solo lei avrebbe potuto suonare in modo
meraviglioso quel finale, frutto di una passione
inconfessabile di Frédéric Chopin? Sono trent'anni che
non lo sento più.»
Qual era la passione che il mio amico riteneva davvero
inconfessabile: quella di Chopin per Solange
Dudevant? O forse la sua per Andrej Charitonovic?
Non potevo che esser io a mettere assieme suoni che
si univano in accordi o procedevano per arpeggi, per
scale, e scale ascendenti e discendenti di terze, di
quinte e seste, io che avevo tra le mani qualcosa che
assomigliava a una storia e nello stesso tempo mi si
chiedeva di completarla in un solo modo. Mi sentivo
un predestinato. Sarei stato il primo pianista (un pianista
che Liszt e Chopin avrebbero di certo apprezzato)
a suonare veramente quelle pagine. Certo anche
Werth e Charitonovic avevano potuto eseguire quel
finale. Ma il primo era un mestierante, e il secondo
era offuscato dai ricordi passionali e confusi del mio
amico russo per lui. E non potevo esser sicuro che
fosse un grande virtuoso come mi era stato detto.
Anni dopo cercai di capire meglio che pianisti fossero
quei due signori, uno russo e uno tedesco, che in
quegli anni di blocchi contrapposti, guerre e dittature
feroci, cercavano attraverso la scrittura di un polacco
esule e nostalgico un sollievo da quel mondo che forse
entrambi detestavano. Ma era come se quella tecnica
fosse rimasta imprigionata nelle loro esistenze bizzarre,
e per certi versi drammatiche. Non potevo sapere
come fossero le mani di Werth e Charitonovic. Di
Werth seppi qualcosa di più; di Charitonovic le notizie
sfuggivano. La famiglia fu distrutta in pochi anni. E
non c'erano altre informazioni. Ucraino, certo, ma
quando iniziò a suonare il pianoforte? Molto giovane,
come tutti. E quando arriva a Mosca? Probabilmente
alla fine del 1945, con la famiglia. E termina gli studi
nel 1947. L'attestato di diploma non è mai stato ritirato.
Poi non si sa cosa accade, come nasce la relazione con il
vecchio professore. E perché quel giovanotto alto,
biondo e spavaldo viene in possesso di una copia (certo
non dell'originale) di quella Ballata: la Ballata dedicata
a Solange. Dove la suona, per la prima volta? E a
chi? A un vecchio amante disprezzato che però gli
permette di accedere a quel tesoro? E' molto probabile. Come
è probabile che fu proprio il vecchio insegnante a
denunciarlo quando capì che l'oggetto del desiderio di
Andrej non era lui, ma ciò che lui possedeva. Doveva
esser stata una rabbia sorda, e tremenda, una rabbia
impetuosa quella che fece arrivare una lettera anonima,
o qualcosa di simile, alla polizia sovietica. Attività
sovversiva, omosessualità, un individuo che cercava
di corrompere e di inquinare il sano ambiente socialista
della scuola. E poi strane partiture, notti passate a
suonare o a fare altro? Ce n'era abbastanza per un
viaggio verso il mare di Bering. Per lui solo, però. Si
dovevano evitare scandali in un luogo per molti aspetti
sacro come il conservatorio di Mosca. Sparì solo
Andrej, o forse - nel tempo - anche qualcun altro. Certo il
mio amico russo, che fu il suo amante, da quel momento
cominciò a pensare di fuggire. E in quel periodo
dovettero iniziare le perquisizioni notturne, fino all'arresto
del padre. E fu proprio Andrej Charitonovic ad
affidargli quelle pagine.
«Andrej mi consegnò una borsa, proprio questa
borsa che lei sta guardando da quando sono entrato
nella sua casa, me la diede tre giorni prima di finire in
un campo di concentramento. Mi disse poche parole:
"Non aprirla, per ora, ma nascondila dove puoi". Il
suo viso era segnato, strappato il colletto della camicia.
Sembrava che avesse avuto una colluttazione, ma
non era spaventato, solo un po' affannato. Pensai che
avesse rubato qualcosa, ma non gli feci domande: presi
la borsa e la nascosi. In vari posti: ogni giorno la spostavo
da un'altra parte. Poi lui scomparve, e non ci
volle molto tempo per capire cosa doveva essere accaduto.
Allora aprii quella borsa e vidi quello che c'era.
Il manoscritto stava in una cartellina color amaranto,
con il dorso e i lacci di cuoio. Maestro, sapevo bene di
cosa si trattava. Fu un'emozione assai forte, non era
solo il valore di quelle pagine scritte da Chopin, e
neppure il fatto che alcune fossero inedite, diverse da
quelle che si conoscevano. C'era un'altra emozione...
sapevo che non sarebbe tornato, ne ero certo. E capii
subito che quel manoscritto era stato portato via a
qualcuno. La persona che si era vista sottrarre quelle
pagine le avrebbe cercate in tutti i modi; e avrebbe
sospettato di me, perché ero la persona più vicina ad
Andrej, e si sapeva. Dunque ero in pericolo.»
Forse non era in pericolo. Certo, Andrej era stato
arrestato, ma per miopia e moralismo. I regimi totalitari
sono stupidi, non sono in grado di costruire
complotti su varianti di una partitura. Non capiscono
quanto possa essere pericolosa una partitura di Bach,
più ancora di un libro che inneggia alla libertà, contro
le dittature del proletariato. Nessuno cercò il mio
amico russo. O almeno così risultò anni dopo. Il suo
nome non compariva tra le persone controllate dal
regime. Solo il padre era considerato un individuo
pericoloso, e fece una brutta fine. Ma lui perse molto
del suo tempo a guardarsi da strani figuri che a suo
avviso lo seguivano, e volevano portargli via quella
partitura, e dunque quel poco di anima che sembrava
essergli rimasta. La partitura rimase salda nelle sue
mani, assieme a quella borsa che stringeva con
voluttà, e ormai sapevo il perché.
«Lei ricorda, maestro, quando ci incontrammo per
la prima volta? Le dissi che la mia idea fissa era quella
di fuggire dall'Unione Sovietica. Mio padre fu
arrestato il 16 marzo 1949. Lo vennero a prendere che si
faceva ancora la barba. Non disse nulla, non finì neppure
di radersi; appoggiò il rasoio nel bacile, pulì alla
meglio il viso dal sapone e prese a vestirsi lentamente.
Mia madre, in silenzio, tentò di riempire una piccola
borsa. Io guardavo la scena dal fondo di un breve
corridoio. Mio padre mi lasciò il suo violino,
quello che ho ancora adesso, ma non gli fu permesso
di salutare, né me né mia madre. Morì nel 1951, o
almeno così ci dissero, di tubercolosi. Ci spiegarono
che fu curato, ma il suo fisico non poté reggere. Io
dovetti aspettare altri venticinque anni per andarmene
da Mosca. Fu nel 1976, suonavo in un modesto quartetto
d'archi. Fummo invitati a Glasgow per un festival:
per la prima volta nella mia vita potevo uscire
dall'Unione Sovietica. A Glasgow non ci arrivai neppure.
Scesi dall'aereo a Londra, arrivai in aeroporto e
cominciai a correre. Salii su di un taxi e mi feci lasciare
all'ambasciata americana. Mi presentai dal poliziotto
all'ingresso e dissi, un po' goffamente: "Chiedo
asilo politico". Un addetto all'ambasciata, un'ora
dopo, mi guardò con aria interrogativa, e persino
divertita: "Ma se lei vuole vivere in Inghilterra, perché
è venuto a chiedere il permesso all'ambasciata
americana?". Non seppi rispondergli.»
Nel 1976, dunque, il mio amico russo ottiene asilo
politico in Inghilterra, ma l'anno dopo è già a Parigi.
Non è mai stato un grande violinista in Unione
Sovietica, e non lo sarà neppure in Occidente. Per di più
ha poche possibilità di entrare a far parte di
un'orchestra. Finisce per vivere di espedienti. E quando lo
conobbi credo si guadagnasse da vivere suonando in
qualche orchestrina. Beveva molto, e la sua salute
non era delle migliori. Probabilmente non lo cercava
più nessuno. E il suo manoscritto fu dimenticato: erano
passati trent'anni. Dunque, quelle del mio amico
dovevano essere le fantasie di chi aveva perso un po'
la ragione.
«Come potrei avere il suo manoscritto?», chiesi a
un certo punto con impazienza.
«Non il manoscritto, maestro: la borsa. Io non le
darò il manoscritto, io le darò la borsa che Andrej
Charitonovic mi consegnò quel giorno. Quella sera
lontana, tanto lontana che persino il suo viso mi
appare come offuscato, e ormai non riesco più a ricordare
l'espressione dei suoi occhi. In questi anni ho
ascoltato molti pianisti. Li ho ascoltati tutti: a parte
Horowitz che non ha più suonato in Unione Sovietica.
Ma nessuno assomigliava a lui. Se Andrej avesse
avuto il tempo per far conoscere il suo grande
virtuosismo, ma anche la sua maturità interpretativa, ci
si sarebbe accorti che suonava un po' come lei,
maestro. Lo capii già nel 1958, quando riuscii ad ascoltarla
a Leningrado. Lei certo non lo ricorderà, ma in
quella occasione suonò proprio la Ballata in fa minore,
la quarta Ballata di Chopin. Iniziò il tema d'esordio
ed ebbi come un tremore, inspiegabile, mi
sembrava di riascoltare Andrej. Quel giorno seppi a chi
avrei dato questa borsa. E provai a fargliela avere le
due volte successive che venni ai suoi concerti. Senza
riuscirci. Non potevo neppure avvicinarmi al suo
camerino. Oggi io so che se per ogni uomo c'è un
destino, il mio è stato quello di consegnarle questa borsa.
Perché è lei che deve possedere queste pagine. Il
prezzo lo faccia lei, fossi ricco non chiederei nulla,
ma ormai vivo a fatica di espedienti. Così mi affido
alla sua generosità.»
Forse mi aveva raccontato una storia completamente
falsa, e ben architettata. Forse mi lasciai convincere,
affascinato dalle simmetrie di quella vicenda, da quei
destini di uomini così diversi, ma in quel momento
contò ancora di più sentirmi il terminale di tutto: molte
persone erano esistite perché quei fogli arrivassero
fino a me. Cominciavo a diventare pazzo? Probabilmente.
Certo che in quel delirio musicale dovevo starci
bene, al punto che decisi di non aprire neppure la
borsa, di farmela dare senza controllare: poteva non
esserci nulla dentro, essere una truffa. Ma io sapevo
che a volte la vita vale un gesto arrischiato. Lo avvertivo
confusamente, ma ero arrivato a 58 anni per vivere
quel momento; e non potevo rovinare ogni cosa
andando a controllare, come un qualunque acquirente di
salumi, se stavo per essere ingannato, o se invece era
tutto vero, come il destino voleva che fosse. Non guardai,
e mi fidai della mia fierezza, e del fatto che la storia
era troppo perfetta per esser stata inventata. Fui
generoso e non chiesi altro. Le sue mani lasciarono
quella borsa, ancora con qualche esitazione, probabilmente
rimase colpito dal fatto che non controllavo il
contenuto. Non so cosa pensò, ma prima di congedarsi
mi disse: «Forse quando la suonerà, io sarò lì sotto,
sotto queste finestre, ad ascoltarla». Non risposi, non
avrei mai fatto per lui un concerto privato, e poi era
giusto che mi spiasse ancora mentre suonavo, lui, che
era entrato in modo così prepotente nella mia vita.
Una sola cosa gli chiesi, prima che scendesse i gradini
delle scale:
«Mi scusi, Evgenij, ma perché lei quel giorno disse
che la ragazza uscita dal mio portone aveva un
cappello?».
Mi guardò perplesso, poi rispose: «No, maestro,
non aveva nessun cappello, forse ricorda male...».
Capitolo ottavo.
C'è un punto in cui l'anima si congiunge alla materia.
E' marginale, piccolissimo, e non sono molti i pianisti
che lo conoscono. In termini tecnici viene denominato,
assai freddamente, «coordinatore fra l'azione del
tasto e quella della meccanica». A vederlo sembra una
normale vite, molto piccola, conficcata nella parte
finale del tasto, quella che non si vede più perché sta
dentro il pianoforte. Il coordinatore sposta in alto il
talloncino del cavalletto e, attraverso un sistema di
montanti, di rullini, di leve e di molle, quella piccola
vite aziona il martelletto che percuote la corda. Ma
«l'azione del tasto» è la mia azione, è il riflesso delle
mie dita, è il mio pensiero della musica: affidato a una
piccola vite che quasi non si vede. Se tocco il tasto con
più morbidezza, quella vite deve trasmetterla alla
meccanica, e la meccanica deve suggerirla al martelletto
che andrà a colpire la corda tesa al punto giusto,
secondo un carico ben preciso. Quando mi dicono che
l'universo è insieme semplice e complesso, penso al
mio pianoforte e capisco esattamente cosa si intende
con questa espressione. Quando inizio a suonare la
quarta Ballata, e suono le prime note sul mio strumento,
accade qualcosa di terribilmente complesso, che
qui accenno, sapendo che queste parole potrebbero
risultare incomprensibili: premendo il tasto il movimento
viene trasmesso tramite il pilota alla leva intermedia;
il montante agisce in seguito sul rullino del
martelletto, il quale si alza in direzione della corda...
Eppure il suono di quell'ottava di sol, l'inizio di
quella Ballata, è qualcosa di straordinariamente aereo,
impalpabile, perfetto. Quei due sol, figli di anni di studi
sulle meccaniche pianistiche, sembrano venire da
un prodigio, non da assicelle di legno ben costruite,
neppure da sistemi di leve complessi e perfetti. Ma è
tutta materia, tutta tecnica costruttiva. Più volte mi sono
chiesto quanto potevo influire su quella vera e propria
tecnologia; quanto potevano fare le mie mani, e
quanto proveniva invece dal mio Steinway. Non so
ancora dirlo oggi, a distanza di anni. E se guardo il
pianoforte di questa casa, il mio, lo vedo perfetto nella
sua tastiera di tasti giallo avorio, che variano lievemente
di sfumatura uno dall'altro, e di tasti neri;
perfetta nell'intreccio delle corde, nel nero brillante degli
smorzatori che sembra vogliano proteggere quelle
corde; e ancora nelle chiavi d'acciaio lucente, infisse
perfettamente nel telaio giallo-oro.
Sembrano forme classiche, antichissime, pensate da
sempre in quel modo. E invece sono figlie di uno studio
incessante, che ha cambiato l'aspetto degli strumenti di
continuo. I pianoforti che suonava Chopin erano molto
diversi: le corde erano fino a cinque volte più sottili di
quelle di un pianoforte costruito oggi, e dunque il suono
più debole e più intimo. Più volte ho pensato di dare
un concerto con uno strumento concepito nella prima
metà dell'Ottocento. Ma non ci sono mai riuscito: sono
nato nel 1920, ho suonato pianoforti sempre diversi, e
via via sempre migliori. Quelli di Pleyel, per esempio,
erano strumenti che richiedevano ancora di esser
perfezionati. E Chopin era costretto a suonare strumenti
che oggi considereremmo non all'altezza della sua
musica. Allora quella grandezza è testimoniata dai segni
che tracciava, che scriveva sui fogli, più che dal suono
dei suoi strumenti.
Solange avrebbe potuto suonare quelle pagine?
Forse. Ma ora dovevo essere io a leggerle con attenzione,
Perché ciò che è scritto non è sufficiente a dare
il carattere di una partitura: va suonata, e suonandola
viene completata, si chiudono le parti lasciate bianche,
risuonano persino le pause e le esitazioni delle
mie mani. E il merito è anche di questa piccola vite,
l'anima del pianoforte, che registra ogni mia rabbia
musicale e ogni mia pacatezza.
Evgenij (ora potevo usare il suo nome, ora che sapevo
non essere quello di un volgare truffatore) lasciò
la casa quasi sollevato, dalla mia finestra lo vidi
dirigersi verso la rive Gauche, verso Saint-Julien-lePauvre. Poi guardai la borsa, ma non la toccai subito.
Andai al pianoforte e suonai per un po': alcuni Preludi
di Debussy, poi due Studi di Skrjabin. Infine
decisi di stancarmi per bene, andai alla libreria, presi il
secondo volume del Clavicembalo ben temperato, e lo
suonai tutto, tutti i Preludi e le Fughe. Era qualche
anno che non tornavo a Bach, e mi sorprese la capacità
di non sbagliare anche di fronte a pagine che
non eseguivo da tempo. Alla fine ero stanco, la
schiena mi doleva quanto bastava. Andai alla finestra,
per controllare che Evgenij non fosse lì, ad
aspettare che io suonassi le note che ben conosceva.
Mi accorsi che da quando era iniziata quella storia
non avevo mai suonato la quarta Ballata, forse attendevo
la versione definitiva, forse non lo feci per
qualche pensiero scaramantico. Non so. Invece so
che presi la borsa consumata e la aprii.
Dentro c'erano due scomparti: uno era vuoto, l'altro
conteneva la cartellina color amaranto, con dentro
dei fogli dai bordi smangiati, non erano molti. Li presi
con delicatezza e li sfilai, poi senza guardarli mi andai
a sedere alla scrivania. Accesi la lampada, ma non
c'era bisogno di altra luce, e guardai la prima pagina.
La carta era di color avorio. I bordi avevano disegni in
rilievo, decorazioni che facevan da cornice al foglio,
fatta di motivi vagamente floreali, ma anche tratti che
evocavano strumenti musicali dell'antichità, come la
cetra o il flauto. Quella cornice in rilievo dava eleganza
ai fogli. L'inchiostro era di color nero (James, poi,
mi corresse: «Grigio nero»), ogni foglio conteneva tre
righe musicali solo sul fronte del foglio, e non sul verso.
Ogni riga, cinque misure. Contai le pagine, ma
evitando di guardarle: erano sedici. L'ultima aveva il
bordo inferiore particolarmente rovinato, e l'angolo
strappato, quasi a lambire l'accordo finale di fa minore
(e, a guardar bene, la nota del fa basso dell'accordo
di ottava della mano sinistra mancava assieme al lembo
tagliato). Tornai alla prima pagina, era di un avorio
più sporco delle altre, e c'era qualche macchia di umidità.
A sinistra, sopra la prima misura, quasi appoggiato
al quinto rigo della partitura c'era scritto: «Ballade»,
sopra ancora, al centro, quasi a intestazione del
foglio: «dédiée à Madame Solange Dudevant». A destra,
a matita, c'era scritto: «op. 52».
Mi fermai, guardai la scrittura di quelle poche parole
della prima pagina, la stessa che continuo a guardare
oggi, a distanza di anni. La «B» di Ballade era
più grande e in basso non si chiudeva; la «e», quasi
accennata, sembrava una «i». Mancava la dizione:
«pour le Piano forte». Mancava anche: Andante con
moto. Prima indicazione del brano. Una dimenticanza?
Forse. Cominciai a sfogliare le pagine, rapidamente,
poi andai a prendere la mia partitura. L'edizione
delle Ballate curata da Ewald Zimmermann
per la Henle Verlag di Monaco, del 1976. Ed ecco le
prime lievi differenze: all'inizio del tema principale,
all'ottava battuta, l'annotazione mezza voce diventava
ppp. Ma erano dettagli. Chopin stesso non era molto
rigoroso in queste cose: per esempio scriveva al suo
copista Julian Fontana di guardar bene se aveva contato
in modo giusto, e «in caso contrario, di correggere».
Era come fossi trattenuto dall'arrivare alla battuta
211, ovvero alle ultime due pagine, la 15 e la 16.
Quasi a temere una delusione. E mi accorgevo che giravo
attorno a quei fogli come se il mio leggerli fosse
un libero contrappunto al contrappunto stesso di
Chopin. Guardavo e confrontavo, leggevo e mi ripetevo
i motivi nella mente, ma poi mi fermavo e tornavo
indietro, di due, tre misure, forse a riprendere
qualcosa che prima mi era sfuggito o, se non mi era
sfuggito, non gli avevo dato importanza.
Che scrittura era quella di Chopin? Mi pareva un
manoscritto piuttosto ordinato. Vergato in bella copia
da Chopin per Solange affinché fosse il più leggibile
possibile. La diteggiatura, nelle parti più complesse,
era segnata in modo molto dettagliato. Se fu scritta nei
primi tre mesi del 1849, le forze di Chopin erano ridotte
a nulla, e per lui deve essere stata una fatica mortale
portare a termine questo regalo per Solange. E si vede
da una scrittura che a volte ha l'orgoglio di chi non
vuole soccombere ed esser schiavo della malattia (le
parti più marcate sul foglio) e subito dopo si perde come
un capogiro, diviene accennata, quasi Chopin,
consapevole dello sforzo, si lasci andare a pochi tratti
leggeri (o, come avrebbe scritto lui, leggieri) quasi a
risparmiar altre forze per il dopo. Ero ammirato da quel
cromatismo intenso e lieve di un inchiostro che qua e
là macchiava il foglio di piccole gocce che ingannerebbero
chi non è musicista, e potrebbero persino esser
scambiate per note, ma non da chi conosceva assai bene
quella partitura come Solange; alla quale era destinata
come fosse una lettera privata, una dichiarazione
d'amore impossibile, perché musicale: e la musica
non è un modo per parlare di passione, non è un
romanzo sentimentale, è essa stessa passione, una relazione
pericolosa a cui non devi cedere mai del tutto,
perché ti acceca, ti impedisce di vedere il mondo, ti
costringe a parlare di cose di cui nessuno sa nulla. Ti
obbliga insomma a inseguire le note con le parole, e per
quanto anche le parole possano avere un suono, un
ritmo, possano essere melodia, non riusciranno mai a
ripetere quelle armonie che cerchi di raccontare, di
descrivere; e non solo in pagine come queste, anche in un
colloquio, semplice e banale, con il tuo accordatore. A
cui cerchi di spiegare perché hai bisogno che il
pianoforte diventi più leggero, meno impetuoso; perché
non suonerai Beethoven, ma Debussy, e Debussy vuole
suoni mescolati e morbidi, e pedali impercettibili.
Solo i falsi romantici pensano che si possa dedicare
musica al posto di parole.
Il rapporto tra Solange e Chopin doveva essere
molto più sfumato e contraddittorio per credere che
quei fogli fossero dettati da una melanconia dello
spirito, o soltanto dalla coscienza di un amore impossibile.
No, per quello poteva bastare una qualche
Bourrée o una Valse Mélancolique, non c'era bisogno
di scomodare quello che è da tutti considerato uno
dei massimi capolavori mai scritti per il pianoforte. E
allora perché esitavo ad andare a quelle due pagine
finali? Perché non le scorrevo subito, per capire almeno
una cosa: se era vero che erano diverse da quelle
che conosciamo? Le mie mani esitavano, quasi a voler
ritardare all'infinito quel momento; ed esitavano
mentre nella mia mente risuonava il mondo in fa minore,
e tutto nella mia stanza era diventato in fa minore:
oggetti, quadri, poltrone, sedie, divani, orologi,
tappeti. Sentivo che tutto era marcato da quattro
Bemolle sulla chiave della mia vita. Ed era come se una
scala di fa minore mi corresse tra una tempia e l'altra
di continuo, come fosse un'onda costante, ed
insopportabile. A mezza voce, che diventa pianissimo. Una
pausa a corona che si sposta di una nota e accentua le
esitazioni. C'è più trasporto romantico in questa versione
o invece, come comincio a sospettare (e con sollievo,
debbo ammetterlo), una lucidità quasi
classicheggiante? La risposta sarà nelle pagine 15 e 16, ma
intanto continuo a guardare quella scrittura volutamente
elegante e precisa. Forse questo manoscritto
non è una copia di lavoro, ma fu scritto in bella da
Chopin successivamente. E in questo caso ci dovrebbe
essere ancora un manoscritto, un altro, precedente,
con le correzioni, le esitazioni, le frequenti cancellature.
Allora forse dovrei cercare ancora altre pagine
che mi svelino quello che ora sto leggendo; e sarebbe
troppo, non riuscirei più a tollerare questo gioco di
rimandi. Ma se il manoscritto è questo, allora debbo
dire che Chopin non ebbe grandi esitazioni. Che la
scrittura appare decisa in molti punti, e sembra decisa
in particolar modo quando invece è la partitura a
sembrare esitante, quando le note vanno interpretate,
quando non basta scrivere a mezza voce oppure
crescendo, dolce, fortissimo, ritenuto, con forza.
Quanto ho discusso con i miei maestri su queste
annotazioni agogiche! Com'era un crescendo per
Paderewski? E per Rubinstein? E per lo stesso Chopin?
I biografi raccontano che spesso lui stupiva, perché in
concerto poteva variare a suo piacimento: decidere
un pianissimo, al posto di un fortissimo. Eppure era
un rigoroso esecutore, anche di sé stesso. Una sera
Franz Liszt suonò alcuni Notturni in sua presenza, e
li fioriva con mille piccole e leziose variazioni. Chopin
si irritò: «Se vuoi eseguire i miei Notturni», disse,
«ti pregherei di suonarli come li ho scritti». Liszt si
offese e lasciò a Chopin l'onore di suonarli lui stesso.
Dunque, niente abbellimenti inutili, niente languori
romantici eseguiti a sproposito. Lo vedo anche da
queste pagine, precise, lineari, eppure così accese in
un tormento lucido, appassionato e rigoroso. Un uomo
che aveva messo assieme quello che viene chiamato
il trasporto romantico con il Cours de Contrepoint
et Fugue di Cherubini. E qui si sente, dalla battuta
58, dopo alcune note tenute inizia il contrappunto
libero del tema. Il grigio nero dell'inchiostro si fa più
saturo, quasi il metodo compositivo prevalesse sulla
malattia e sul senso della perdita; perché Chopin di
certo sapeva, in quei primi mesi del 1849, che quel
male non gli avrebbe lasciato più scampo, e affidava,
lui mondano come pochi, a una partitura destinata a
rimanere segreta il suo testamento musicale. La scrittura
della battuta 58 e delle seguenti è meccanica,
precisa, non lascia dubbi, non apre spazi di interpretazione.
Le gambe delle note di tanto in tanto tremano,
come fosse colto, proprio mentre il pennino era
appoggiato sul foglio, da un colpo di tosse improvviso
e violento, che lo costringeva a smettere, quasi lo
soffocava. Più di una volta in queste pagine la penna
vola altrove, e l'inchiostro traccia segni che assomigliano
a cancellature discrete, come se la tubercolosi
si beffasse non solo del suo corpo, ormai neppure in
grado di salire una sola rampa di scala, ma anche della
sua mente musicale, e delle sue mani e, in una
parola, delle sue composizioni. Si dice che negli ultimi
concerti, l'anno precedente, gli capitasse spesso di
svenire tra un tempo e l'altro per la debolezza. E che
Chopin eseguisse la sua musica con molti pianissimi
non certo per scelta musicale, e neppure perché la
maturità lo avesse indotto a ripensare la sua musica
con maggior levità, ma solo perché le sue forze non
reggevano un pianismo più vigoroso. Forse fu vero
anche questo. Ma non mi basta, ora che questa carta
lanosa non sfugge più ai miei polpastrelli, ma posso
accarezzarla fino a sentire i lievi solchi, le leggère
incisioni del pennino; e se la studiassi al microscopio
vedrei fiumi e gole e alture, e oltre le note scoprirei
un paesaggio invisibile che potrebbe corrispondere
alla musica da cui nasce, una natura di carta che si
trasforma in pura musica. Per merito mio, e delle mie
piccole viti in fondo ai tasti, nascoste come fossero
tante ipofisi dell'armonia, che danno l'ordine meccanico
a quella grande macchina perfetta, il mio Steinway.
Tutto torna come in una perfetta geometria della
volontà e delle emozioni. Persino le lettere tr che
indicano i trilli sembrano vivere sotto la penna di
Chopin, come se nel gesto di scrivere quelle due lettere
vibrasse tutto il corpo. In un punto, sotto la battuta
116, vedo una macchia assai piccola, amaranto,
forse color seppia, mi chiedo se sia sangue, quello
che gli usciva dai polmoni quando tossiva, o se invece
si tratta di una macchia successiva, di non so chi:
Solange forse, o tutti gli altri che avranno maneggiato
quelle pagine. Eppure sembra vecchia, seppellita da
quella leggera polvere di 130 anni, che non si vede
più ma uniforma gli inchiostri, crea uno strato che si
stende impercettibile sulle pagine.
Nessuno ha mai legato assieme questi fogli, li sfoglio
uno per uno, e mi accorgo che le decorazioni sono
diverse, cambiano di pagina in pagina, seppur
leggermente. Alla battuta 164 il tratto è leggermente
più spesso, forse Chopin cambiò pennino; guardo bene:
nel passaggio del cambio di pennino c'è un piccolo
foro, uno strappo della carta che quasi non si vede,
nascosto in parte da una biscroma di sol bemolle.
Sotto quelle note Chopin ha scritto: accelerando. Alzo
il foglio fino a metterlo in controluce, contro la lampada,
e mi accorgo che ormai si è fatta sera, la luce
passa da quello strappetto, riaggiustato per bene, ma
non troppo. La luce illumina il mio foglio, passa
attraverso come uno spillo fastidioso, e in fondo, in
penombra, c'è il mio pianoforte. Mi alzo, e vado a
sedermi alla tastiera: portando con me i fogli, deciso a
suonare tutta la Ballata e - a prima vista - le ultime
pagine. Non voglio essere come il mio amico James,
che degusta i manoscritti come fossero uno dei suoi
whisky raffinati, o una delle sue macchine per riprodurre
musica. Io posso suonare tutto questo, anzi, è
mio dovere. Alzo il leggìo, riordino i fogli dalla prima
pagina e li allineo bene uno con l'altro. Manca la
dicitura Andante con moto, ma non importa, lo suonerò
ugualmente così. La mia mano destra comincia
a far risuonare la stanza di ottave di sol, legate, come
voleva Chopin. E mi accorgo subito che non sto
leggendo le note, che peraltro conosco a memoria, alla
perfezione. Ma quello che nella pagina c'è oltre le note.
Le mani procedono agili, e più lente di quanto si
dovrebbe. Se il taglio di una croma è più incerto, la
mia nota diviene più incerta; se marcato con più forza,
a intingere nell'inchiostro il pennino e macchiare
quasi il foglio, be', allora tendo ad accentuare la forza
delle mie mani sulla tastiera. Anche i manoscritti
hanno un'anima, non solo i pianoforti. Alla nota che
dà inizio al tema della Ballata (uno dei temi della
ballata), al do che qui Chopin indica con ppp, quasi mi
fermo, come a voler calibrare l'attesa delle note
successive sullo spazio bianco che separa quel do dal
successivo re bemolle. Stavo prendendomi delle
libertà inaccettabili. Davo un valore a quelle note
secondo criteri che non esistevano, eppure sapevo che
se esiste una calligrafia delle passioni, quello era il
modo di renderla al meglio. Se volevo capire quella
partitura, dovevo cominciare daccapo, e non con
quella fretta che toglie ogni chiarezza, che non si
compiace dell'attesa, che cede inutilmente alla curiosità.
Suonai le prime pagine come se avessi una lente
di ingrandimento, anzi desiderandola. Avrei ingrandito
quelle note che conoscevo da decenni fino a
trasformare quei tratti di inchiostro in segni misteriosi,
non più note, dèmoni sensuali che ordinavano alle
mie mani di suonare quella musica. Come avrei suonato
quel piccolo strappo sul sol bemolle? No, ora
stavo esagerando, la musica non può essere letta in
questo modo.
Eppure sapevo che dietro quei segni non c'era la
casualità di un uomo che scriveva come poteva, stremato
dalla fatica e dagli attacchi di asma: c'era un
disegno, c'era una volontà. Ed era la volontà di chi
sapeva comunicare oltre le semplici note, la volontà di
un grande compositore a cui non bastava più mandare
alla donna che mai avrebbe confessato di amare
una partitura in dono, ma aveva bisogno di aggiungere
qualcosa, e di certo non a parole. Guardavo quei
fogli, quell'inchiostro indeciso, quei tratti prima sottili
e poi spessi, quei segni che talvolta sembravano
delle cancellature, e capivo che dovevo imparare a
leggere la musica, e in un modo diverso da quello
che avevo sempre conosciuto. Dovevo trasformare
gli stati d'animo in musica, non basarmi soltanto su
un canone, un insieme di regole codificate da molti
secoli; regole che non lasciavano spazi, che soffocavano
tutto. Cominciavo a capire cosa intendesse il
mio amico James quando sosteneva che per lui un
manoscritto musicale era come un quadro di Paul
Klee o di Kandinskij, che c'era un altro modo di leggere
quei fogli, un modo che spesso i musicisti ignoravano.
Ora, io cominciavo a scoprire quel modo, che
mi portava a fare un passo in più rispetto al mio amico
James, che poteva goderne solo con la vista e con il
pensiero: potevo trasformare tutto questo in musica,
in pura musica. E il solo pensarlo mi riempiva di una
gioia che non provavo da tempo, e che mi sorprendeva
allora, come mi sorprende oggi.
Da quest'eremo svizzero, dove ho scoperto che la
noia è fatta anche di numeri, e si può scandire con le
ore della giornata, ho per me stesso un sentimento
simile alla tenerezza se penso al mio entusiasmo di
quei giorni. Oggi so che quando un uomo crede di
possedere l'intuizione del tutto, e si convince che solo
dal particolare si possa risalire a Dio, allora vuol
dire che ha fatto un solo passo, un solo gradino, di
una scala infinita. E l'entusiasmo sta nel sentirsi al
sicuro, superiore alle cose, quando invece non è così,
perché tutto ci sovrasta. Credevo di possedere il
mondo in una nota indecisa, e invece ero entrato in
un mondo che mi ero sempre rifiutato di considerare,
io: protetto dai filtri del mio talento, della mia
ricchezza. E solo allora capivo che le mie mani avrebbero
avuto molto da fare per trasformare quelle note
ambigue in qualcosa che, come in un perfetto
microcosmo, mi restituisse il senso della mia esistenza e,
con quello, il senso di tutto ciò che mi aveva circondato
fino a quel momento. Capivo che ognuno di noi
era chiamato a contribuire all'ordine dell'universo,
ad arricchire quel rumore di fondo di suoni riconoscibili,
di tonalità più sofisticate, per trasformare il
Dio pneumatico, che soffia musica nelle nostre anime,
in qualcosa di comprensibile e definibile. E a me
serviva Chopin: lui, la sua Ballata, per arrivare a questo.
Mi serviva un russo romantico. Un raffinato collezionista
e una donna che portava lo stesso nome di
una passione segreta del mio Chopin, al punto da
dedicare a essa una partitura importante.
Solange fu l'inizio di quella storia: per me, come
per Chopin. Solo che la mia Solange sarebbe riapparsa
dopo, con la forza della casualità che tutto spiega,
e a tutto dà un senso. C'era un progetto divino che mi
faceva unire le due Solange per poi farmi suonare
quella partitura? Il mio Dio che suona una nota, un
accordo di quinta eccedente in fondo all'universo
può mandarmi una Solange al caffè di rue de Rennes?
No che non può. Sono io a dare un senso agli
eventi. Posso cercare mille Solange, e non trovarle,
eppure sentire ugualmente quella frequenza infinita,
quella radiazione fossile, quella nota che viene dai
confini dell'universo nel freddo buio che nessuna
partitura mai scritta potrà squarciare, quasi fosse un
fondale sbagliato, che non ti lascia possibilità.
Ma allora ero salito all'origine dei miei suoni, ero
arrivato al manoscritto, lo stavo suonando, e mi bastava;
meglio, credevo fosse tutto quanto potessi desiderare.
Mi avvicinavo lentamente alle due pagine finali,
di cui ancora non sapevo nulla; e volevo che mi apparissero
come un bagliore, un'emozione fortissima. Volevo
essere come un pellegrino che arriva alla cattedrale
di Tours, o di Nôtre-Dame, e prima cammina per
viuzze tortuose, fiancheggiate da case basse, da vicoli
strettissimi dove il sole penetra come una lama, e per
poco; ma poi, come d'improvviso, esci in una piccola
piazzetta, volgi la testa verso l'alto e trovi, quasi all'altezza
di Dio tanto sembrano alte, le torri campanarie
del gotico francese. Ed è un effetto strabiliante. Perché
vorresti vedere tutto l'insieme con la calma della
prospettiva e invece sei costretto quasi a sfregare la schiena
contro la casa più lontana dalla facciata (che poi è
sempre troppo vicina) senza che tu riesca in nessun
modo a cogliere il tutto di quell'evento visivo.
Volevo insomma che il passaggio dalla pagina 14 alla
pagina 15 fosse così, come la visione improvvisa
della facciata di un capolavoro gotico: folgorante,
paralizzante, da fermare almeno per un attimo quelle
mie mani ormai agilissime, mio malgrado, incapaci di
fare ordine su quelle note, che sapevo già intense, e
probabilmente molto difficili. E man mano che procedevo,
lentamente, sapevo che quelle due pagine mi
sarebbero apparse d'un tratto, perché la battuta
numero 211 era la prima della quindicesima pagina.
Quindi l'effetto emotivo che avevo previsto era facilitato:
avrei girato pagina e avrei visto quelle note, e tutte
assieme. Ma prima dovevo arrivare a quegli accordi
sospesi che fanno pensare a una conclusione della Ballata,
e invece preludono al finale. A quel punto mi fermai:
potevo farlo, non ero a un concerto, neppure in
sala di incisione. Guardai quelle note, quei cerchietti
sovrapposti, come direbbe qualcuno che non ha mai
visto una pagina di musica: così irregolari che taluni
non si chiudevano neppure. Mi sembrava che Chopin
avesse voluto evidenziare le legature che stavano
sopra gli accordi. Come se fossero state rimarcate in un
secondo tempo, con un pennino più spesso e un
inchiostro più granuloso. Ma forse esageravo.
Voltai pagina e mi ritrovai in un mondo che non
conoscevo più. E non riuscivo quasi a leggere, mi venne
come un'angoscia. La stessa del sogno, la stessa che
mi prese quel giorno sul Lungosenna. Ebbi paura. E
mi alzai dal pianoforte per andare alla finestra come a
scacciare un lieve malore. Respirai profondamente,
più di una volta. Ma tutto attorno a me continuava a
girare, e la Senna sembrava una cascata d'acqua, e le
due torri di Nôtre-Dame parevano le pale di un mulino
che pescavano acqua dal fiume. Persino la Tour Eiffel
oscillava come un gigantesco pendolo d'acciaio, e
le stelle correvano come fossero astronavi lontanissime.
Sapevo che tutto questo sarebbe passato, che anche
il mio cuore avrebbe rallentato i battiti, che ogni
cosa sarebbe tornata normale; così mi sarei seduto al
pianoforte per guardar meglio quella pagina. Avevo
visto subito: quella non era una partitura ricopiata,
non c'erano segni più leggeri, più forti, note più intense,
e gambe più tremolanti, crome più o meno svolazzanti;
lì c'erano le note che Chopin doveva scrivere
appoggiato faticosamente sul leggìo del pianoforte,
con entrambi i gomiti, la testa appoggiata al braccio, la
mano alla tastiera a riprovare gli accordi, gli arpeggi,
le note. Prima la sinistra, poi la destra, poi entrambe, e
dunque subito dopo a correggere i passaggi che, provati
a mani unite, potevano non convincerlo. C'erano
battute cancellate quasi con violenza, e sostituite da
altre scritte ai margini del foglio. Sembrava un campo
di battaglia, non una di quelle meravigliose partiture,
una delle tante, che avevo imparato ad amare quando
bambino, piccolissimo, sfogliavo quei fogli stampati,
grandi, dalle note perfette, distanziate una dall'altra
con la regolarità che ci vuole. E solo quello per me era
il mondo: equilibrato, rassicurante, anche quando le
note diventavano tante, troppe; ed erano accordi, ricchi
di alterazioni, di diesis e bemolle, e doppi diesis e
doppi bemolle; e ancora trilli, e notine più piccole,
quelle che noi chiamiamo abbellimenti, e note acciaccate.
Eppure, in questo universo di cinque righe, io
scoprivo un ordine, anche nella passione, un ordine
sensuale. E tutto quell'ordine mi trasmetteva una
sicurezza: la musica, la mia musica, quella che io
sceglievo di suonare era lì, stampata con precisione, con
gli intervalli, le pause e le parole scritte in corsivo. Con
quell'eleganza tipografica un po' antica che ancora oggi
mi affascina. E per di più era in bianco e nero, un'immagine
in bianco e nero che parlava quanto un'incisione
di DÜrer.
Sapevo cos'era un manoscritto. E non solo: conoscevo
anche la differenza tra un manoscritto copiato
e uno di lavoro. Ma per quanto fossi davvero abituato
agli sgorbi di un compositore ottocentesco, quelli
mi coglievano impreparato. Cosa avrà pensato
Solange di quelle note? E non sarà stato poco gentile
inviare a una donna un testo non ricopiato,
inconprensibile per chi non aveva grande consuetudine
con la musica? Ragionavo come uno sciocco pianista
che pensava al passato come alle sue partiture di
bambino. Come se l'ordine, la calligrafia delle passioni,
passasse da regole precise, da convenienze, da
educazioni. Come se il mio universo di note si potesse
estendere a chiunque. Non era così, e lo stavo
imparando: anche a spese della mia testa, che ora girava
un po' di meno. Tornai allo Steinway. Quasi lo
accarezzai andando dalla coda verso la tastiera. Poi
di nuovo seduto davanti al leggìo, guardai quel
foglio, il quindicesimo, e quello successivo, l'ultimo:
trattenendo il fiato. Da dove cominciare?
Intanto l'indicazione diceva: Presto con fuoco, la
stessa indicazione che compariva in un tema della
prima, e poi della seconda Ballata. Presto con fuoco.
Ogni pianista sa come suonare un Presto con fuoco.
Come il pianoforte si deve trasformare in un oggetto
incandescente, di cui però non bisogna aver paura. E
le dita scappando da una parte all'altra della tastiera,
salendo e scendendo, debbono dare l'impressione di
non fermarsi e al tempo stesso di maltrattare i tasti,
di farsi sentire. Come uno spadaccino pronto a saltare
ovunque con agilità in un duello, capace però di
colpire con forza, facendo sentire la lama che risuona
contro quella dell'avversario. Le mani saltano, con
grande agilità: eppure i tendini sono forti, le dita
percuotono i tasti con vigore e si alzano dalla tastiera più
del solito. Gli studenti faticano moltissimo a imparare
una tecnica come questa; richiede forza, precisione
e velocità, molta velocità. Dopo il 1841, Chopin non
suonò più in concerto i passaggi delle sue composizioni
che avevano dei Presto con fuoco. In particolare
la seconda Ballata, di cui eseguiva soltanto la prima
parte, quella più lenta. Le sue condizioni fisiche glielo
impedivano. Queste pagine furono scritte invece
nel 1849, sei o sette mesi prima di morire, e di certo
non poteva suonarle. Dunque le scrisse, e mai le
suonò. Certo dovette ascoltarle da Solange. Perché
nessuno avrebbe dovuto conoscere queste pagine.
Dunque Solange prese lezioni da Chopin sul come
eseguirle, perché non era una pianista di straordinario
livello tecnico, quello che ci vuole per suonare
questo Presto con fuoco. Guardai l'ultima pagina, c'era
una data: 17 febbraio 1849. Esattamente otto mesi
prima della sua morte. Due giorni prima, il 15 febbraio,
Pauline Viardot, amica di Chopin, scriveva a
George Sand:
Mi chiedete notizie di Chopin. La sua salute declina
lentamente con giorni passabili nei quali può uscire in
carrozza e altri nei quali ha sbocchi di sangue e accessi
di tosse che lo soffocano. Non esce più di sera. Tuttavia
egli può ancora dare alcune lezioni e, nei giorni
favorevoli, gli càpita anche di essere allegro. Ecco l'esatta
verità. Del resto è molto tempo che non lo vedo. E'
venuto tre volte a farmi visita senza trovarmi.
Sappiamo che in quei giorni di febbraio Chopin è
stremato. Sa bene cosa gli accadrà: già da qualche mese
ha fatto testamento e dettato «alcune raccomandazioni
circa quel che si dovrà fare della sua vecchia
carcassa quando renderà l'ultimo respiro». Prima di ogni
cosa: distruggere i manoscritti. Quelli non ultimati, e
non sono pochi: lo farà lui stesso quando le forze glielo
concederanno. In una mattina di maggio accenderà
il camino e manderà a fuoco un patrimonio straordinario.
L'umore di Chopin di quel periodo non lo aiutava:
nel foglio in cui dettava le sue ultime disposizioni,
disegna una bara, delle croci, un cimitero e alcune
note musicali. Il medico che lo aveva curato per anni,
l'unico di cui Chopin si fidava, era morto. Quelli chiamati
a sostituirlo capivano ben poco, davano rimedi
approssimativi e avevano onorari alti: «Sono tutti
d'accordo sul clima, la calma, il riposo. Il riposo lo
avrò comunque un giorno e senza di loro. Brancolano
nel buio e non mi danno sollievo». Oltre a questo,
Chopin è anche povero. Metà dell'affitto della sua casa
viene pagato da un gruppo di amici, ma Chopin
non lo sa, le sue condizioni non gli permettono di dare
le necessarie lezioni e i concerti, le uniche sue fonti di
guadagno. E non c'è più Madame Sand a risolvere tutti
i problemi pratici. In questo clima Chopin vede
Solange e le scrive. E di tanto in tanto frequenta Delacroix
con cui mantiene un rapporto di grande affetto.
Lo si capisce dai diari del pittore:
29 gennaio 1849. Questa sera sono andato da Chopin
e sono rimasto con lui fino alle dieci. Caro uomo!
Abbiamo parlato di Madame Sand, di quello strano
destino, di quella mescolanza di qualità e vizi. Parlavamo
a proposito dei suoi Mémoires. Egli mi diceva
che sarebbe per lui impossibile scriverli...
14 aprile. La sera da Chopin. L'ho trovato prostrato,
che non respirava. Dopo qualche tempo, la mia
presenza lo ha risollevato. Mi diceva che la noia era il
suo tormento più crudele. Gli ho chiesto se prima
non avesse mai provato quel senso di vuoto insopportabile
che talvolta provo io. Mi ha detto che sapeva
sempre dedicarsi; per quanto poco importante sia,
un'occupazione riempie certi momenti e dissolve
quei vapori. Altro sono i dolori...
In tutto questo dove nasconde Chopin il suo
segreto? Forse in qualche lettera non ancora ritrovata?
Oppure distrutta? In queste pagine che hanno viaggiato
per un'Europa indifferente? O ancora altrove?
Non è facile capire. Quegli anni restituiscono tutto
come filtrato da una patina romantica talvolta
insopportabile. E in una sorta di continuo e collettivo
ritratto oleografico, fatto da amici, conoscenti, testimoni,
alla fine ti sfugge chi fosse veramente un uomo
come Chopin. Mondano e geniale, ma anche malinconico
e annoiato, e persino capace di odii profondi
e inconfessati. Tutti si sforzano di dire una sola cosa:
chiese di Madame Sand fino alle ultime ore della sua
vita. Che non tornò a trovarlo neppure in punto di
morte. Ed è uno sforzo collettivo che non vuol lasciare
dubbi ai posteri. Ma non solo: Chopin è uomo
sempre perfetto («Che uomo squisito!», scrive Delacroix),
capace di grandi generosità, sofferente,
morente, eppure solare.
Guardo ancora questa calligrafia, oggi, e mi rendo
conto che non è così, che non è solo questo: che la
patina mondana in cui è stato avvolto Chopin ci ha tolto
molto. Perché questa non è la calligrafia di un uomo
che, come un bravo amante respinto, chiede sempre
dell'amata, anche in punto di morte, e con sua
figlia mantiene un rapporto di correttezza. Ma è la
calligrafia della sensualità, la sensualità di Chopin; e
non quella sensualità data dalle ombre, dai colori
tenui, dagli accenni: ma semmai dal suo opposto. Voglio
Chopin perso in una febbre di passione che non
ha nulla a che spartire con quel Romanticismo lezioso
della sua epoca. Guardando queste pagine capisco
ormai bene quale tormento insopportabile doveva
cogliere Chopin in quel gruppo di individui senza
alcun talento. E comincio con il dar ragione a Baudelaire
quando di George Sand scriveva: «Non è mai stata
artista. Essa possiede il famoso stile fluente caro ai
borghesi. E' stupida, pesante, chiacchierona; le sue
concezioni morali hanno la medesima delicatezza di
sentimento di quelle delle portinaie e delle mantenute.
Il fatto che alcuni uomini abbiano potuto
invaghirsi di questo cesso, costituisce la dimostrazione
dell'abbassamento degli uomini di questo secolo».
Tra quegli uomini c'era anche Chopin? Chi può
dirlo. Certo quel giorno avevo intuito che il mio enigma
andava svelato attraverso una donna che viveva
a Parigi e portava lo stesso nome della figlia di George
Sand, e una vecchia storia familiare: più che una
calligrafia, una strategia delle passioni che fino a quel
momento avevo come rimosso e dimenticato.
Anche se non ricordo a cosa pensai quando quella
notte cominciai a suonare quelle due pagine.
Capitolo nono.
Dubito che James avesse mai agìto così rapidamente
in vita sua.
Telefonai di giovedì, prima di cena: alle 23 e 52
minuti era già a casa mia. Un posto sul primo aereo per
Parigi non fu difficile da trovare e il taxi aveva corso
forse più di quanto potesse. Dubito che James di
fronte a un manoscritto abbia mai avuto in vita sua
così poche esitazioni. Le pagine probabilmente erano
autentiche, ma doveva fare dei confronti, controllare
ancora alcuni dettagli per dirmi con piena certezza
che quell'inchiostro grigio nero proveniva dalla penna
di Chopin. Lo trovai calmo e rapido al tempo stesso:
rapido nei ragionamenti, calmo nel modo di
esporli. Volle sapere come ero riuscito finalmente a
venirne in possesso, e io lo raccontai volentieri, omettendo
alcuni particolari che ritenevo ormai privati.
James non era uomo a cui avrei confessato di sentirmi
predestinato a suonare quelle pagine: avrebbe
capito troppo bene, e questo mi metteva in imbarazzo.
La sera prima ero riuscito a suonare quelle due pagine
con una certa fatica: e cercai di risolvere una serie
di scogli tecnici studiando una diteggiatura appropriata,
ma in molte parti la composizione sembrava
inafferrabile persino dalle dita di un virtuoso.
Come poteva Solange suonare questi salti nel vuoto:
fatti di intervalli discendenti di terze, sovrastati
da scale ascendenti di seste rapidissime? Mi ricordava
per molti versi le parti più impetuose della seconda
Ballata, ma anche lo Studio op. 25 n. 11. Tutto forte,
in qualche caso fortissimo, e legatissimo. Sembrava
una parete impossibile, e non avevo né chiodi né corde;
dovevo arrampicarmi a mani nude, sapendo
quanto grande fosse il rischio di cadere. Mi chiedevo
quella notte come avesse fatto Solange, ma anche come
avrebbe potuto lo stesso Chopin suonare note così
faticose.
Domande che era meglio non pormi: non potevo ragionare
come un qualunque virtuoso del pianoforte.
La partitura era quella, molto più impetuosa, della coda
alla Ballata che già si conosceva. Chopin la scrisse
quasi a violentare quei delicati fogli che aveva scelto, e
poi non la ricopiò, così nel manoscritto si genera un
contrasto, tra una scrittura bella e ordinata e le pagine
finali, difficili da leggere e interpretare. Non le ricopiò
perché Solange le voleva così, voleva vedere il congegno
che le aveva create: non poteva ascoltare da lui
quelle note, perché il fisico non avrebbe retto, e non gli
rimaneva altro che leggere in quei segni il tormento
che le aveva generate. Così gli impedì di ricopiarle, e
le volle così, come io le vedo ora.
Ma anche questa lettura non mi basta: troppo
romantica, troppo facile, forse. I detrattori di Chopin
godrebbero di un uomo che scrive, nel tormento, la
coda di una Ballata. Quando invece Chopin era
compositore di grande lucidità, un uomo nato nel cuore
del Romanticismo che amava Bach. E persino quella
coda, ossessiva nel suo ostinato virtuosismo, aveva
un geometrico rigore, era come una brillante soluzione
di un problema matematico; talmente brillante da
emozionare, però talmente matematica da non lasciare
illusioni sulla sua logica sfolgorante. Passai una
notte a trovare un modo di suonare quelle note.
Intorno alle quattro del mattino, accaldato, perché la
musica mi costringeva a tenere le finestre chiuse, seppi
che quella partitura sconosciuta ora aveva una forma,
si poteva cominciare ad ascoltare. E capii quanto
doveva essere straordinaria la tecnica pianistica di
Werth e Charitonovic. Non erano pagine pensabili
per un mestierante del pianoforte; anche perché non
c'era un modo più semplice o più lento di suonarle,
come non può esistere un modo diverso per raggiungere
la cima di una montagna se l'unica strada è una
parete impraticabile. Allora capii che impressione
avrebbe potuto fare al mio amico Evgenij sentire
quelle note suonate con spavalderia. Ma c'era un modo
giusto di suonare quelle note, o forse si trattava
dell'ultima beffa di Chopin? Guardavo quelle pagine
e non riuscivo a scrollarmi di dosso un senso di
frustrazione: doveva essere soltanto tecnica e passione,
fuoco e velocità? Questo era il desiderio di Chopin
verso Solange? E questo era ciò che Solange Dudevant
chiedeva a Chopin? Un labirinto di note disposte
in un modo che solo apparentemente poteva
assomigliare a quello tradizionale delle partiture, ma che
era altro, altro che non capivo. Pensai ad Arrau,
Claudio Arrau, e mi chiesi cosa avrebbe pensato di
quelle pagine; fui persino tentato di chiamarlo, poi
mi convinsi che le proprie ossessioni si risolvono da
soli, senza il parere di nessuno. Oggi mi sono pentito
di non averlo cercato, scioccamente pensavo che non
ci si può perdere in due in una stessa passione.
Con James era diverso, anche se mi turbava quella
calma competente che non lasciava trasparire emozioni:
non era una vera e propria consulenza la sua,
era una confessione tra due uomini innamorati della
stessa donna, a tarda notte. Ma se lui cercava di
mantenere una fredda consapevolezza, io vivevo l'angoscia
di dover trovare un filo, un bandolo, dove non
c'era nulla da scoprire.
Non mi rimaneva che leggere quelle due pagine
come una calligrafia delle passioni: anche se Chopin
fu vittima forse di un compromesso che voleva mettere
assieme, come un tutt'uno, il Clavicembalo ben
temperato e lo spirito romantico. La sua passione non
era solo figlia di un passaggio da una tonalità
maggiore a una minore, come se quel minore in musica
fosse una privazione, una diminuzione della propria
razionalità. E poi cosa dico ora? Perché su queste
pagine devo trovare Cherubini a tutti costi, mentre
quando a Buenos Aires ascoltai i tanghi di Carlos
Gardel ebbi un sentimento che mi sorprese: ero
ammirato da una musica che avevo sempre ritenuto non
adatta alla mia cultura, al mio rigore musicale. Mi
accadde la stessa cosa quando un amico pianista jazz
mi insegnò a suonare alcuni passaggi di Ragtime, e
capii d'un tratto che c'era più Bach in Scott Joplin che
in molti virtuosi di fine Ottocento e Novecento.
E ora, che potevo leggere musica scritta da un uomo
che già con i pensieri non era più nel mondo, mi
spaventavo: dimenticavo la mia indecente bossa nova,
i miei tanghi, e persino il mio Ragtime, e ricominciavo
a pensare come avevo sempre fatto, come uno
cresciuto con il Gradus ad Parnassum di Muzio
Clementi. A giudicare attraverso il principio della
difficoltà, alla lente del virtuosismo, e ricordarmi d'un
tratto, come svegliato da un sogno per entrare in un
incubo, di non esser altro che un sofisticato artigiano,
una macchina musicale pensante, di quelle che colleziona
il mio amico James (che guarda il mio manoscritto
prima con la lente, poi quasi lo allontana, a perdere
i dettagli e vedere il quadro generale dei fogli).
Solo che al posto dei rulli, dei chiodini, dei motorini,
ci sono tendini, ossa e muscoli. Le mie mani sono
macchine programmate, educate per anni a suonare
un certo repertorio: che poi è molto ristretto.
Forse avrò interpretato 500 brani musicali in tutta la
mia vita: solo 500, in 70 anni di pianoforte. E non
odiavo forse il mio destino che mi costringeva a
leggere quelle note così come erano, decise da altri? Il
mio amico scrittore un giorno mi disse divertendosi
di questa mia disperazione: «La verità è brevissima.
Dopo è solo commento. Tu sei destinato come tutti a
commentare all'infinito quelle "verità" che leggi sulle
tue partiture. Tutti facciamo così. Non c'è via di
uscita. Questo è il secolo del commento infinito».
Potevo dire queste cose a James, quella notte in cui
sembrava non dovesse arrivare l'alba? Lui, ossessionato
di non poter interpretare nulla, perché un piccolo
congegno dentro la sua mano (o, secondo altri, dentro
il suo cervello, ma fa lo stesso) per un caso fortuito
aveva smesso di funzionare. E dire che ogni macchina
musicale che comprava per il mondo dopo sapienti
restauri diventava perfetta. Con quelle si poteva sostituire
un pezzo, magari con un altro materiale. Ma un
cattivo memorialista romantico avrebbe detto che non
si può riparare l'anima, e forse non avrebbe avuto torto.
I Preludi di Debussy incisi su rullo erano la sua
vendetta contro tutti. Il suo modo di leggere le partiture,
la sua vendetta contro sé stesso: c'era qualcosa che
superava lo strumento, qualcosa che andava oltre la
musica. E qualcosa che andava oltre l'analogia. Io mi
sforzavo di descrivere quelle pagine come fossero
pareti scoscese, picchi inarrivabili, strapiombi di note,
come un paracadutista in caduta libera. Tentavo di
costruire un mondo di immagini e di movimenti che
assomigliavano a quella musica che non sapevo e non
potevo descrivere (a meno di uniformarmi al linguaggio
tecnico dei musicologi, che è vuoto). E lui leggeva
ciò che non era più musica, era altro: qualcosa a metà
tra la critica d'arte e la grafologia.
«Guardi queste note. E' come se Chopin avesse
voluto disegnare una passione, le guardi bene. Sono
accordi di terza che scendono per tre ottave in modo
furioso. E sembrano al tempo stesso il disegno di chi non
le vuole nitide e precise, ma le scrive con irregolarità,
come se il movimento delle mani, il vento che la forza
di questa musica potrebbe produrre, spostasse anche
le note di questa partitura. Verrebbe voglia di rimetterle
a posto, di chiudere la finestra, perché questa
scrittura sembra alterata da un forte temporale.»
Sognava, e godeva della sua rivincita, James. Sapevo
vedere queste cose, io, abituato a partiture educate
e stampate con cura? No. Ero in grado soltanto di
affermare che una nota che sta sul primo rigo in basso
del pentagramma è un «mi», sul secondo è un
«sol», e via dicendo. Questo mi era stato insegnato.
Un giorno anche i computer sapranno farlo (o forse
sono già in grado di farlo).
«Ah, come non aver pensato a Solange Dudevant»,
ripeteva James tra sé: «E' curioso. I biografi hanno
sempre trattato questa vicenda con una delicatezza
assoluta. Come se Chopin fosse un loro parente, e vivo
ancora oggi. Dopo 130 anni il tabù resiste. Persino
noi non ci avevamo mai pensato. Però vede, maestro,
gli elementi c'erano tutti. Lei era una donna di una
sensualità irresistibile. L'esatto contrario di sua
madre. Era provocante. Era dispettosa, esibizionista.
Allegra e leggera. E questo a Chopin doveva piacere
molto. Gli scrollava di dosso quella noia che ormai lo
imprigionava. Cosa succede tra loro forse non lo
sapremo mai, qualcuno ha fatto sparire ogni documento
possibile. Però da queste pagine capisco che Chopin
è turbato e disperato, forse addirittura sconvolto,
da quanto può essere accaduto».
Quelle due pagine mi confondevano, io quella
passione non riuscivo a leggerla. O forse non volevo. Se
fosse stata solo una costrizione? Se Chopin non fosse
riuscito a scrivere quelle pagine in modo più ordinato?
Se avesse perso, di fronte alla sua malattia che lo
consumava, gli atrofizzava i muscoli e cancellava ogni
passione vincendola con la stanchezza e la consunzione?
Tutto poteva essere più semplice, allora. E io avrei
vissuto con più tranquillità il resto della mia vita.
Ma neppure questa poteva essere una spiegazione.
Avrei potuto fare come Gould: dedicare una vita a
Handel e Bach, rifiutare i romantici, affermare, quasi
sprezzante, che la musica finisce nel Settecento e ricomincia
nel Novecento, e in un sol colpo cancellare
ogni paura, orientare i miei timpani dentro i prodigi
barocchi delle Suites e delle Fughe. Per non dire di
Nerval; meglio Laclos forse, che tutti hanno letto con
il senno di poi: come un romanzo di un amore non
realizzato, e per questo struggente; quando invece era il
romanzo dell'impossibilità dell'amore. E per questo
tutti pèrdono la loro partita: perché i personaggi di
Laclos non hanno scampo. L'amore non c'è, esiste solo
il gioco. Per Laclos, Valmont non è un vero innamorato,
e neppure un uomo nobile: è uno sciocco. Lui e la
sua marchesa di Merteuil.
Per questo è difficile capire Mozart, e intendo tornare
a suonarlo. Perché Mozart sbeffeggia il Settecento,
ci gioca, e guarda i suoi ascoltatori con gli occhi di chi
sa che ormai non c'è via di uscita. Che quella leggerezza,
quei ricami, quei merletti che avevano incantato
gente senz'anima sarebbero stati spazzati via da quel
gigante scontroso che di nome faceva Beethoven. E
lui, Wolfgang Amadé, genio dell'equilibrio, a guardare
con un occhio alla musica che fu di Bach e con l'altro
a ciò che dopo Beethoven sarebbe avvenuto. Unico
a poter sorridere dei suoi antenati e dei suoi posteri:
equilibrista straordinario su di un filo dorato teso
sull'abisso del genio. Leggero e consapevole, solare
eppure esoterico. Pietra nera misteriosa, impossibile
da smontare, monade musicale unica e staccata da tutto.
Dentro Mozart non entri e non esci, in Chopin
puoi, e puoi con Beethoven, e con Bach, e con Wagner
e Schonberg e Berg. Ma non Mozart: Mozart lo
circumnavighi, come un'isola che puoi ammirare in tutta
la sua bellezza, ma senza poter sbarcare, perché non
c'è una via, o è introvabile.
Chopin amava Mozart e amava Delacroix, perché
conosceva alla perfezione tutta la musica che Mozart
aveva scritto. Chopin suonava Mozart, spesso, nei
suoi concerti. Ma erano diversi, in tutto. Anche in
questi segni che vedo qui e che James mi mostra con
aria vittoriosa. Segni che ti entrano fin dentro il cuore,
dice il mio amico James. Segni che scompaginano
la mente, dico invece io, pauroso di usare per
qualunque cosa la parola cuore: insulsa e sminuente; che
il cuore pompi il suo sangue, e non si interessi dei
sentimenti, e lo faccia con precisione, come un orologio
della vita a lunga carica. Sono i neuroni che mi
turbano, i crocevia dei neuroni, non gli orologi, i
procedimenti meccanici. Forse è giusto: James è un uomo
che ha fatto della meccanica, dei carillons un
motivo di esistenza, io invece preferisco muovermi tra
corto circuiti, effetti di senso, logici e musicali, l'unico
verbo della mia esistenza. Lui pensa coi rulli sonori
delle sue macchine musicali, io metto in controluce le
note e, se non combaciano una con l'altra, mi invento
dei disegni nuovi, che forse mi piacciono. James gode
del rullo che gira, della perfezione meccanica, del
movimento, del pensiero perfetto. Io del pensiero
sfalsato, di ciò che non funziona, e non funzionando
produce senso, e mi conduce ad altre storie. James ha
una sensualità in crescendo, come l'inizio della settima
Sinfonia di Mahler, riempie il suo recipiente di
piacere fin quasi a colmarlo, ma è incapace di pensare
al piacere se non in forma di accumulazione continua:
un oggetto dopo l'altro, ad ammassarsi in quella
grande casa, un manoscritto dopo l'altro, per stiparli
tutti in quelle grandi cartelline rigide; io ho una
sensualità interrotta da mille rivoli, come un delta frastagliato
di un fiume, e assomiglio a Chopin che cerca
nell'attesa, nella pausa, negli intervalli e nelle frange
del tempo la possibilità del piacere estetico. Ho una
sensualità incompleta, che gode delle proprie
mancanze, fatta di luci e di ombre, di vuoti e di pieni. Era
così anche per il mio manoscritto: passionale e insieme
rigoroso, fatto di cancellature, di note tremule e
di segni fortissimi, rabbiosi e impotenti.
Preso quasi da un senso di soffocamento cominciai
a copiare in bella la prima delle due pagine inedite.
Mentre James leggeva la seconda con attenzione, presi
un grande quaderno per la musica e una matita, e
segnai la chiave di violino e la chiave di basso. Misi i
quattro bemolle in chiave, sulle note di si, di mi, di la,
di re, e segnai il tempo: 6/8. Ero pronto, scrissi quasi
emozionato: Presto con fuoco. E presi a segnare le note,
gli accordi, tentando di esser più preciso possibile; di
più, costringendo ogni nota, ogni cerchietto annerito,
ogni taglio delle crome e delle semicrome, alla loro
neutralità. Togliendo a quelle pagine ogni significato
ulteriore, qualsiasi cosa potesse andare oltre la musica,
qualsiasi esitazione e forzatura che giungesse a
somigliare in qualche modo a una scrittura delle
passioni. Lo feci con la mia calligrafia perfetta, ordinata,
precisa, come quella di un progettista: se la partitura
di Chopin era un olio alla Delacroix, e un dipinto che
andava interpretato, la mia copia era invece un disegno;
in qualche modo opposto, preciso forse, leonardesco
(per paradosso) nella sua esattezza, nelle sue
linee sottili che si ripetevano simili, e mi davano
sicurezza, tranquillità, pacatezza d'animo.
James mi guardò, e per un po' stette in silenzio.
Attese che la mia matita mostrasse la seppur minima
esitazione, per interrompermi: «Maestro, anche la sua è
una calligrafia, una calligrafia di chi teme - forse - le
passioni; o di chi le vuol vivere in un modo diverso,
ma non creda di cancellare, di ridurre a sola musica, e
solo perché lo sta ricopiando, questo portento. Non è
possibile, ne siamo entrambi prigionieri. Io perché mi
ha gettato di nuovo in un prato verdissimo del Massachusetts,
nei primi anni Trenta. Lei per motivi che ancora
non conosco. Guardi, gliela voglio raccontare la
storia del prato. Forse l'aiuterà a sopportare meglio
tutto questo. Doveva essere il 1930. Ero tornato a
Boston in primavera, fu una delle ultime volte, credo,
che lasciai l'Inghilterra (a parte gli anni di Harvard).
La casa dove aveva sempre abitato la mia famiglia era
una grande villa, costruita intorno al 1865: a due piani,
con molte torrette. Sembrava uno di quei castelli francesi
che si incontrano tra Orléans e Tours. Non so dirle
chi era il progettista, ma spesso si scherzava in casa su
come fu costruita quella strana dimora. Sembrava un
castello leggero, senza torrioni, e muri invalicabili,
senza finestre o saloni imponenti. Non c'era neppure
il ponte levatoio o il fossato, ma un prato, pianeggiante,
immenso. Sarà stato quasi un chilometro, mi creda,
un chilometro di prato: curato da un esercito di giardinieri.
Un mare di verde interrotto da grandi querce e
qualche acero.
«Quella primavera tornai portando con me un
frammento di malinconia. Quel viaggio negli Stati
Uniti mi dava una sorta di agitazione: non avrei
voluto tornare, e insieme desideravo vedere ancora
quella casa, fatta di corridoi interrotti continuamente
da scale, da stanze piccole che si aprivano su camere
più grandi; una casa dalle pareti rivestite in legno,
che cigolava tutta, dove la luce entrava come fossero
serpentine, e illuminava solo dettagli delle stanze,
mai tutto l'insieme. In una stanza c'era il mio
pianoforte: uno strumento a coda di marca inglese della
fine dell'Ottocento, il pianoforte su cui studiavo. E
poiché la stanza aveva grandi finestre che guardavano
quell'immenso prato interrotto dagli alberi, io mi
esercitavo al pianoforte e mi perdevo a guardare fuori,
a vedere come il sole illuminava le cime degli alberi
a spicchi, cambiando di continuo i suoi disegni di
luce. Ormai non ero più un bambino, anzi, cominciavo
a sentirmi grande, e probabilmente il mio sviluppo
fu assai precoce e rapido. Non avevo torto ad
atteggiarmi a giovane intellettuale malinconico.
Sapevo di greco, di latino, parlavo tedesco sin dalla
più tenera età, e - non sorrida, maestro - potevo dirmi
un eccellente giovane pianista. Ma quel giorno,
quel ritorno a Boston, quel ritorno in quella casa, e
in quella stanza, furono per me qualcosa di sconvolgente.
Ricordo che entrai in quell'ambiente che, specie
le estati, consideravo mio; guardai i libri, ricordo
un dorso di Tennyson, un altro di Blake, queste erano
le buone letture di un giovane colto, e c'era un esile
libro dalla copertina decorata e dal dorso color
sabbia: il saggio su Dante di T.S. Eliot. Ma quello che
ricordo ancor meglio è la sensazione che ebbi nello
spostare lievemente quei libri, aprire quasi con delicatezza
il coperchio del pianoforte, senza toccare
neppure i tasti, e guardare d'un tratto fuori della
finestra. D'un tratto, maestro, proprio così: come avessi
avuto la sensazione che in quel momento esatto io
dovevo guardare un punto preciso del prato che avevo
di fronte.
«Passava una ragazza, poco più grande di me, aveva
i capelli biondi, come fossero colorati dal sole.
Camminava abbastanza lontano attraversando tutto
l'arco delle mie finestre. E camminava lentamente,
quasi esitando, la testa bassa, gli occhi a guardar l'erba,
e un vestito a fiori, molto semplice, che si fermava
sopra il ginocchio. Non so dire quanto fosse bella, forse
neppure lo pensai. Ebbi solo un sentimento di perdita.
Fu la prima volta, maestro, che provai qualcosa
di molto simile alla passione, forse all'amore. Ero
ragazzino, non potevo ancora sapere cosa fosse la
sensualità. Cominciai a capirlo da quel giorno: per la prima
volta vidi una donna, una ragazza che già desideravo
come passato. Una donna il cui movimento su
quel prato grandissimo mi generava quasi una nostalgia
verso quel corpo che si muoveva e quel ciuffo di
capelli che si spostava leggermente. Ho conosciuto la
passione attraverso la nostalgia della perdita, come se
vivessi in ogni momento l'angoscia del gesto che si
dissolve anziché il piacere del gesto che si coglie. Non
godevo dei suoi movimenti perfetti, come da manuale
di portamento, soffrivo di quel passo che non potevo
più veder ripetersi. E tutto questo mi sconvolgeva, mi
sorprendeva, e mi agitava.»
Si fermò, mi chiese il permesso, e poi accese uno di
quei sigari che odiavo, e che quel giorno trovai
stranamente sopportabili. Io avevo posato la mia matita,
e mentre lui parlava passeggiavo lentamente per la
stanza. Ora ci eravamo seduti, uno di fronte all'altro.
«No, no, non creda che quello che le ho raccontato
finora sia la cronaca di una struggente storia d'amore,
neppure i turbamenti di un giovane di buona famiglia.
Non è questo: il mondo vive di turbamenti, dei
più diversi, e ogni quindicenne potrebbe raccontare
assai bene il languore dell'innamoramento quando
arriva inaspettato. e non si è imparato ancora a
riconoscerlo. No, maestro, questa è un'altra cosa. Questa
è letteratura, questa è la nostra cultura. Volevo quella
fanciulla, non avevo fatto altro che leggere dei libri
che mi avrebbero preparato a quell'incontro. Non
avevo fatto altro che suonare dei brani musicali che
avevano la stessa armonia di quella caviglia che si
sollevava dall'erba. Non avevo fatto altro che leggere
poesie - poesie che si pubblicavano allora - dove si
parlava di ragazze dei giacinti, dove si raccontava il
desiderio, con mille mediazioni. Volevo la mia epifania,
e l'ho avuta.
«Chi era quella ragazza? Ancora oggi non lo so.
Scomparve dalla vista delle mie finestre e le mie
gambe non reggevano per seguirla, per capire dove
stesse andando. Chiesi poi a mia madre, ma non
ricordava nessuna mia coetanea dai capelli biondi che
vivesse in qualche parte della casa in quel periodo.
Fu un'apparizione, forse un fantasma. Ma doveva
essere la stessa malinconia che dovette provare Chopin
scrivendo con questa calligrafia delle passioni, e forse
lo stesso turbamento che prova lei di fronte a queste
pagine. Per questo non serve ricopiarle, per questo
non le sarà molto utile trasformare queste note in
qualcosa di educato e perfetto. Non potrei cancellare
l'immagine di quel giorno lontano; anzi, da quel
giorno per me fu sempre così. Non può negare questa
musica, e dimenticare la mano che l'ha scritta.
Non tutto può essere riordinato dentro un'architettura
perfetta, e rassicurante. Esistono dei luoghi dove
la natura cresce così rigogliosa e irresistibile che non
si fa in tempo a tracciare un breve tratto di strada in
terra battuta che il giorno dopo si vedono già ciuffi
d'erba, piante e altro ancora. Non abbiamo la forza
per vincere questa battaglia, maestro. Io non l'ho, e
neppure lei. Ma forse sto parlando troppo. A lei che
importa di quella ragazza bionda apparsa ai miei
occhi un pomeriggio di cinquant'anni fa? Forse non ha
senso raccontare la malinconia delle passioni, e della
vita, in un modo così trascurabile, laterale. E dire che
nella mia vita le passioni non sono mancate, e dire
che ho amato molte donne, e veramente. Ma ogni
volta che riflettevo tendevo a perderle. Cosa pensò
Chopin della sua Solange? Che non l'avrebbe mai
avuta? Forse. Ma guardi qua: un ostinato, su una scala
di fa minore nella chiave di basso. Un ostinato
continuo, come un sordo rancore, o meglio come un
rimpianto. Un tema che ricorre e che sposta verso il
basso, come un'àncora, come una pietra pesantissima,
le scale di accordi discendenti di terza sui tasti
acuti della mano destra. Diceva qualcuno che la nota
grave è più pesante di quella acuta. E sbilancia di
molto il suono...»
Analogie, e ancora analogie. Certo che il suono
grave sbilancia quello acuto. Una corda spessa due
centimetri vibra molto di più di una corda sottile
quattro millimetri. E' un fatto fisico, non filosofico.
Però è vero che queste due pagine sono imprigionate
dal destino. Come se neppure dentro la musica Chopin
riuscisse a liberarsi del suo dolore, da un mondo
che lui vedeva allontanarsi, e suo malgrado. Però James
mi turbava: l'avevo visto a Londra e mi aveva
raccontato di quel Notturno, e di quel passaggio che
non riusciva a suonare. Ora mi raccontava una storia
un po' magica, che mi vedevo passare davanti agli
occhi con il ritmo di un Satie. Guardavo il suo viso,
quello di un uomo ormai vecchio, cercavo di spostare
la mia immaginazione su quegli stessi lineamenti, ma
con cinquant'anni di meno. Gli zigomi forse erano
più duri, più squadrati, il naso più sottile, la fronte
liscia e meno aggrottata, ma gli occhi azzurri, che con
il tempo dovevano essere diventati lievemente più
acquosi, erano vividi e mobili come allora. Non era
un uomo curvo nelle spalle, James, tutt'altro, e la sua
corporatura era ancora atletica, ma quel giorno lontano
il suo corpo doveva apparire più incerto, forse
(per quanto James fosse alto quasi un metro e novanta)
persino più fragile. Perché mi raccontava quella
storia? Che rapporto c'era tra Solange Dudevant e la
sua ragazza del prato? E tra il languore della perdita
e la calligrafia delle passioni? Non riuscivo a difendermi
da quei rimandi continui, da quei paesaggi
della mia memoria, o della memoria di altri che
arrivavano fino a me per vie che non conoscevo. Pensai
al suo languore della perdita e alla mia ossessione
per la carne; alla mia Solange, conosciuta in una notte,
e niente di più. Pensai che non c'erano epifanie
per me, neppure apparizioni, ma attraversamenti
dolorosi. Lui impiegava il suo tempo per soffrire del
tempo che passava. E mi sarebbe piaciuto fare altrettanto.
Invece io la ragazza l'avrei seguita, a ogni
costo, non avrei atteso, non le avrei permesso di scomparire
dallo specchio della mia finestra. E oggi saprei
forse il suo nome, e magari cosa fa, dove vive. Ho
un'ansia di possesso: amo possedere le cose e le
persone, soffro dell'abbandono, del distacco e della
separazione, almeno quanto James soffre del passato
più vicino, di quello ancora fresco di presente.
«Dell'immediato passato, maestro, non di quello
più lontano», mi disse, cogliendomi di sorpresa, quasi
che in quel silenzio avessi proceduto assieme a lui
nei pensieri con una sintonia stupefacente: «So elaborare
il passato più lontano. Ma non riesco a controllare
quello vicino a me. E' come un treno che parte: ti dà
più nostalgia vedere l'ultimo vagone che si allontana,
più ancora che il binario deserto con il treno ormai
lontano. Forse anche questo è un modo per sopportare
i vuoti dell'esistenza».
Guardai i vuoti della mia pagina, a spiare le pause,
o le note lunghe nella partitura che avevo ricopiato.
Mi accorgevo che lì non c'erano vuoti. Che quelle
pagine non chiedevano silenzi, ma attimi di brevissima
inquietudine preludevano a una grande musica di
un'intensità senza pari. E più le note correvano, più
sembravano andare in una direzione; così per la prima
volta capii cosa significasse leggere una partitura
con un metodo diverso. Era qualcosa di molto simile
a una tecnica impressionista. Dovevi allontanarti dalle
note per vederle, non c'era narrazione in quelle
due pagine. O meglio: c'era, ma si doveva pensare a
quelle pagine come un tutt'uno. Come a un qualcosa
che cresceva, e finché non raggiungeva un compimento
non avrebbe svelato il suo senso. Era un
monolite a cui girare attorno come molte pagine di
Mozart? Forse. Ne sarebbe stato felîce James, che amava
godere dello stordimento sensuale. Ma anch'io
potevo compiacermi di quei fogli. Per quelle pause
brevissime, letteralmente incastrate tra una semibiscroma
e l'altra, a generare un'interruzione neppure
udibile con l'orecchio esterno, ma forse solo con
l'orecchio interiore. C'era tutto quello che volevamo;
e c'erano quelle note, pennellate in modo
imprevedibile, quasi confuso, eppure, lette tutte assieme,
perfette e necessarie.
«Ricopi, maestro, perché le chiederò di farmi ascoltare
la musica di tutto questo. Ma potrebbe già
bastarmi quello che ho visto e che ho letto finora», disse
James ancora una volta soddisfatto del proprio intùito
e della propria competenza. E io pensai a Evgenij,
e mi chiesi se il caso e il destino lo voleva proprio in
quel momento sotto la mia finestra. Ancora oggi non
so dire se quella mia interpretazione della Ballata,
per intero, con il finale per Solange aveva avuto il
suo spettatore privilegiato. E neppure quanto avesse
capito di quelle pagine Evgenij. Se erano solo figlie di
un ricordo a cui era legato, o se anche lui aveva cercato
un senso del mondo in quelle poche righe. Credo
che per Evgenij fosse diverso, che il suo mondo stesse
da ben altre parti, e non nelle partiture. Qualche
tempo dopo credetti di vederlo mentre scendeva a
una fermata del metrò, a Rambuteau. Fu l'unica volta
che mi spinsi fin nel ventre di questa città, e quasi di
corsa scesi le scale che portavano ai treni. Non sono
sicuro fosse lui. Feci appena in tempo a vedere un
uomo di spalle che saliva su una vettura e correva via
assieme alla luce dei finestrini. E non saprei dire
neppure se fosse lì sotto quando suonai per James la
ballata. Mi affacciai subito dopo alla finestra e guardai
con attenzione dappertutto. Mi sembrò di intravedere
un uomo che camminava svelto oltre il ponte che
collega la Cité con l'île-Saint-Louis. Mi sembrò. Per
quanto avessi desiderato con grande intensità che il
destino lo portasse proprio lì quella notte, non credo
che Evgenij abbia mai potuto ascoltare quelle note.
Di lì a poco avrei lasciato Parigi. E per di più quella
fu una delle ultime volte che suonai quelle due pagine.
Da quel giorno l'ho fatto sempre meno. Anche se
ho continuato a frequentare queste pagine: a leggerle
e a spiarle. A usarle come una lente per la mia anima,
e per le mie ossessioni.
Non diedi a James copia della mia partitura. E lui,
debbo riconoscerlo, non mi chiese nulla. Aveva preso
solo una serie di appunti su molte cose: carta, inchiostro,
scrittura. Mi disse che la conferma dell'autenticità
del manoscritto mi sarebbe arrivata assai presto.
Ma senza trattenere il manoscritto, almeno per
un certo periodo sarebbe stato difficile esserne certi:
«Ma non le chiederò di lasciarmelo, maestro. E
non perché penso che lei sia geloso di queste pagine.
So quanto sappia fidarsi di me. Capisco però che io
non la potrò privare di questa scrittura, appartiene
solo a lei, meglio: è destinata a lei, quasi fosse un
regalo di Chopin. In fondo lei sa meglio di qualunque
esperto quanto questi fogli siano autentici, lo sente,
lo capisce. La mia risposta sarebbe tecnica e inutile.
Pochi minuti fa, mentre la ascoltavo suonare queste
pagine ho avuto un'idea, poi l'ho buttata via. Possiedo
una macchina che incide rulli per uno dei miei
pianoforti meccanici. Avrei voluto chiederle se poteva
incidere per me, naturalmente su rullo, una partitura
che ormai so bene lei non suonerà mai in pubblico.
Ma poi ho capito che non potevo. Come in quel
giorno lontano in cui non seppi fermare la ragazza
bionda che attraversava tutte le mie finestre e spariva
fuori scena. Anche questa Ballata per me è uscita di
scena. A suo modo anche un ascolto musicale può
essere un'apparizione. Va bene così, maestro: non si
può chiedere di più».
E' curioso, ma quando uscì da casa lo vidi per la
prima volta stanco e provato. Lo guardai dalla finestra.
E, chissà perché, ebbi la sensazione che i suoi
passi fossero come trattenuti da qualcosa, come di
chi dovesse fare ogni sforzo per non tornare indietro.
Camminava con una fretta ansiosa, risolutiva: ogni
passo era qualcosa di molto simile a una vittoria sulla
tentazione. Pensai che fosse così, che la sua educazione
e la sua intelligenza gli impedissero di chiedermi
veramente di suonare ancora una volta la Ballata per
il suo rullo meccanico. Ma che per lui fosse uno sforzo
intollerabile. O forse fu semplicemente quella
malinconia dell'attimo appena passato, di cui tanto mi
aveva parlato fino a poco prima. Lo lasciai allontanare,
senza guardare oltre. Di lì a poco sarebbe scomparso
alla mia vista, nascosto dai palazzi parigini e
dalle vie strette del Quartiere Latino. Era ormai l'alba,
e la luce della lampada che illuminava la scrivania
sembrava invecchiata: pallida, fioca, inutile,
persino malata. Andai a spegnerla con un moto di
rabbia. Guardai quel che restava dei suoi sigari. E
quel che rimaneva di una notte senza sonno. Il manoscritto
era ordinato con cura, un foglio sull'altro, i
bordi che combaciavano. Pensai che sarebbe stato bene
in un museo, o forse sotto una di quelle teche della
British Library, assieme a quelli di Beethoven, di
Bach, di Stravinskij. E fui sorpreso di provare rabbia.
Capitolo decimo.
Da tempo non riesco più a suonare Chopin con la frequenza
dei miei giorni migliori. E non c'è alcun motivo
plausibile. Più divento vecchio, meno comprendo
le cose che accadono attorno a me. Così in questa
vecchiaia fatta di solitudini che gli altri chiamano
«splendidi isolamenti» perché non sanno che c'è una
forma di solitudine anche per i privilegiati come me,
inseguo Mozart e mi consolo con Bach: che è come un
problema matematico già risolto e dà la sensazione
che la vita abbia un senso, che l'universo risponda a
congegni barocchi collaudati e garantiti. Il Dio di Bach
è un Dio che crea l'universo, le stelle e i mondi, e poi ti
dà un certificato di garanzia, qualora qualcosa non
funzionasse. Quello di Mozart fa tutto ciò che gli
compete e poi non ti dà le chiavi per entrare. Fatti
tuoi, se non capisci come si apre quella porta. Il Dio
di Chopin non c'è. In questa mitologia musicale è un
parente lontano, ombroso e geniale, ma soprattutto
incompleto. E' un frammento di tempo: straordinario
per la sua incompiutezza, ma pur sempre imperfetto.
C'è una genialità nell'imperfezione, e Chopin fu
genio dell'imperfezione. Oggi la mia stanchezza non mi
permette di tollerare quell'imperfezione che devi
completare di continuo con pezzi della tua vita, intervalli
della tua sensibilità. E' per questo che suono
Bach, e lo suono male, come a voler violentare gli
ingranaggi di quel grande orologiaio, e con rabbia. Tornare
a Bach è una malattia senile di molti pianisti,
esausti da un repertorio che ti toglie l'aria, e ti soffoca,
anche se hai di fronte un panorama grandioso come
questo. Là in fondo nevi eterne, qui invece prati
verdissimi che non osi neppure sfiorare. I giorni
successivi a quell'incontro con James, al ritrovamento
del manoscritto, furono i più difficili della mia vita.
Mi prese una forma di depressione che non avevo
mai conosciuto. Era come una paura: la paura che la
mia vita potesse cambiare, che quelle pagine avessero
scardinato tutte le mie nevrosi, e un fiume di passione
in piena se le portasse a valle come misere reliquie
di un uomo che proprio su quelle nevrosi aveva
fondato la sua esistenza e il suo talento. Temevo di
uscire, e di scoprire che il mondo era muto ed era
arrivato il momento di imparare il linguaggio dei gesti.
Dunque ero un uomo che doveva ricostruire tutto.
Mi sentivo arido come una di quelle macchine sofisticate
di James, null'altro. Altro che i Preludi di Debussy.
A che servivano le mie mani se poi un rullo qualunque
avrebbe potuto annullarle? Cominciai a pensare che
era tutto inutile, che forse l'unica soluzione era fare le
valigie e scappare ancora, andare altrove, dove nessuno
avrebbe potuto raggiungermi. Non pensavo a
Solange Dudevant, e neppure a Chopin: pensavo alla
mia di Solange. E dovevo trovarla, fosse l'ultima cosa
da fare a Parigi. Anche se capivo che non serviva a nulla.
Perché il mondo non funziona come una Partita di
Bach, semmai come un Preludio di Chopin. Non ha
numeri definiti, geometrie comprensibili; ha pause, e
note irrisolte. Come quella notte in cui mi addormentai
accanto a lei. Le palpebre vibravano come sentissero
il movimento rotatorio della terra e le voci dei suoi
guardiani, che mi chiedevano conto del mio talento: di
come ne fossi entrato in possesso, e perché. E di che
uso ne avrei fatto. E quando. Il mio privilegio aveva un
prezzo, forse era arrivato il momento di pagarlo. Ma
nessuno mi spiegava come. Pensai persino che doveva
essere arrivato il momento di abbandonare il mondo,
di chiudere la mia esistenza terrena. E pensai che avevo
avuto tutto dalla vita, ora anche quelle pagine lanose
su cui Chopin aveva scritto il suo testamento passionale.
Ma io non avevo lasciato nulla, a parte qualche
incisione. Io non avevo passioni da regalare ai posteri,
lettere da mandare alle mie amanti, figli con cui
condividere le proprie amarezze.
Pensai che anche il mio Steinway sarebbe finito in
qualche studio discografico, e non certo in un museo.
Provai rabbia per me stesso. Ero un esecutore, un mero
esecutore. Soltanto in musica questa parola ha un
valore positivo, anzi, è indice di talento, genio, raffinatezza.
Altrove si usa per esseri volgari, individui
mediocri. Altrove gli esecutori sono degli incapaci al
servizio di menti pensanti, manovalanza. I killer sono
esecutori, per esempio. Per questo provavo rabbia,
e mi ero inventato che quel manoscritto andava
letto come fosse un codice cifrato. Perché i codici
cifrati possono essere capiti soltanto da menti pensanti,
gli esecutori comprendono soltanto gli ordini chiari,
il pentagramma tradizionale. Poi pensai anche a
un'altra cosa. Quasi volevo convincermi (e per qualche
ora ne fui persuaso veramente) che quelle pagine
erano false, che ero oggetto di un piccolo complotto,
ordito da non so chi. E risi di me stesso, del come fossi
stato capace di cadere in quella trappola, fatta di
note troppo indecise, troppo intense. E non volli
fermarmi neppure a questo, andai oltre: Solange? La
mia Solange? Un'affezione della mia sensibilità. Volli
ricordare quella donna con quel nome, e non con un
altro. Malato di parallelismi, figlio di un mondo che
amava giocare con i nomi, con gli eventi e con le parole.
Dunque, perché cercare al di fuori di me un sogno
che avevo costruito nel mio cervello malato? Perché
soffrire? Non c'era bisogno di tornare in quel
caffè, semmai dovevo chiudere ancora di più le porte
della mia vita, sprangarle dall'interno e passeggiare
per le mie stanze lussuose, sentirmi suonare, e capire
perché fossi vittima di quella follia. Pensavo che nulla
era esistito, e dunque che non avevo altra scelta:
dovevo liberarmi la testa, i pensieri da quella storia
eccessiva e perfetta, troppo perfetta. Durò qualche
giorno, oggi non so dire quanto: due, tre, forse quattro.
E per fortuna tornai in me, e mi imposi di uscire
per cercare Solange. La mia Solange. Non dovevo far
altro che aspettarla ogni giorno al nostro caffè. Dovevo
radermi, tornare alla mia eleganza discreta e
ricominciare a suonare (soprattutto questo), con la
frequenza che mi conoscevo; tornare al mio Debussy,
interrotto per un tempo che cominciavo a reputare
intollerabile. Così scelsi dei libri che mi avrebbero
tenuto compagnia nelle sere da passare al caffè. E scelsi
primo fra tutti Sylvie, sicuro che anche i libri influenzano
gli eventi, fanno accadere le cose.
Fu come in una partitura con Canone e Variazioni.
Ogni sera, puntualmente, attorno alle otto mi presentavo
al caffè: un libro sotto il braccio, il solito tavolino.
Rimanevo fino a mezzanotte, a volte anche più
tempo. Leggevo e guardavo fuori, ma non manifestavo
alcuna ansia: sapevo che se lei fosse entrata mi
avrebbe avvicinato; sapevo di non doverla cercare, e
dunque non era un'attesa spasmodica, ma lenta e
persino compiaciuta. Di tanto in tanto mi incuriosiva
un avventore e mi piaceva guardarlo, e allora la
variazione del mio stato d'animo somigliava a quegli
intrecci di note che solo Bach sapeva restituire: veloci
e fieri della loro precisione, come una collezione di
orologi dotata di coscienza meccanica, e dunque
orgogliosa nel saper procedere con un ritmo preciso.
Ma erano brevi digressioni, poi tornavano le variazioni
più adeguate al mio animo, e dunque lente e
meditate; qualche volta con un passaggio o due più
allegri. In quelle sere bevevo di tutto: caffè per iniziare.
Poi i miei whisky, e persino Pernod. Accadde
talvolta che tornassi indietro con andatura malferma, e
accadde persino che, salito in casa, mi sedessi al
pianoforte per suonare, forse male ma con tecnica più
sciolta, brani che in stato di lucidità non avrei mai
voluto ascoltare, tanto meno da me stesso.
Accaddero molte cose in quelle sere, in quelle notti
cominciai a guardare il mondo con un occhio che non
avevo mai avuto; osservare la gente che entrava e
usciva. Ebbi una sorta di ebbrezza che a volte coglie
gli artisti, quando per un caso fortuito hanno la possibilità
di entrare nel mondo, e ne gioiscono, come fossero
alle giostre: godono delle luci colorate, ridono
delle montagne russe, che sanno per nulla pericolose.
Sembrano bambini felici. Credevo di poter cancellare
per un po' quei tratti aristocratici di cui mi ero fregiato
con orgoglio per tutta la vita. Credevo. E allora una sera
mi accompagnai (ma ormai era notte inoltrata, e
Solange non sarebbe più arrivata) con una piccola pattuglia
di musicisti a suonare in un locale del Marais. E io
che stavo quasi in disparte, perché quella loro musica
che amavo, non sapevo per nulla suonarla. E ascoltavo
loro, invece, il pianista innanzitutto, che faceva alla
tastiera tutto quello che a me non era mai stato
permesso, e suonava benissimo. E ricordo che, era quasi
l'alba, mi misi al pianoforte io stesso, e vidi i loro volti
stupefatti nel sentirmi eseguire con prevedibile
sicurezza lo Scherzo in si bemolle di Chopin, e qualche
Studio di esecuzione trascendentale di Liszt (e forse,
come fossi un giovinetto, mi compiacevo di stupirli
con la mia tecnica). E quando fu mattino, e l'ora della
stanchezza che coglie gli insonni si poteva dir passata,
svanita assieme ai colori violacei che hanno le città
quando arriva l'alba, mi ritrovai proprio in quello
stesso caffè in un gioco di seduzioni con una ragazza
di cui ancora una volta ho rimosso il nome, un gioco
che non sapevo fare, di cui non conoscevo le regole. E
lei a guardar divertita un uomo quasi anziano che le
piaceva e che aveva sentito suonare, ma da cui era
separata da una distanza incolmabile.
Fu forse quella volta, proprio quella, in cui mi
accorsi che non potevo attendere oltre, che non c'era
più niente da aspettare, e non mi rimaneva che
cominciare a vedere anch'io, come Chopin, i dèmoni e
le creature infernali che lo avevano sorpreso in
Inghilterra, e di cui aveva scritto a Solange. No, non
potevo sfuggire a quella Ballata, a qualunque costo.
Pensai persino di inciderla, idea folle che abbandonai
ancora prima di chiarirla a me stesso. Pensai che non
sarei più andato in rue de Rennes, che non mi interessava
più nessuno. L'ultima volta che venne a trovarmi
il mio produttore di Amburgo, non potei fare a
meno di notare il suo sguardo perplesso e il suo
sopracciglio esitante ai miei discorsi. Forse pensò che
fossi impazzito. Non mi chiese quasi nulla, e andò
via più presto del solito. Neppure cercò di convincermi
a ripubblicare alcune mie vecchie incisioni che
non volevo più sentire. Forse era lui a non star bene.
Ma credo che quello, interrotto da momenti di breve
euforia, sia stato uno dei momenti più cupi della mia
vita. Credo anche che il modo di suonare ne abbia
risentito. Poi, quasi d'un tratto, tutto cambiò. E dovevo
aspettarmelo, capire che spesso le cose accadono,
non si attendono come fosse un autobus.
Era un martedì, e non saprei dire di che mese. Credo
fosse già settembre, perché le strade di Parigi a
settembre hanno un altro profumo. Sanno di pioggia e
dello zucchero delle crêpes; lo zucchero bruciato dalle
piastre che si mescola all'uovo, forse alla farina, e
prende un odore caldo. Se posso dirlo: doveva essere
anche un settembre inoltrato, perché il cielo aveva
colori più saturi e il pomeriggio sembrava leggermente
più scuro, lasciando alle vetrine illuminate dal neon il
predominio delle strade. Rue du Cherche-Midi, quasi
all'incrocio con rue du Four. Giravo attorno al mio
caffè di rue de Rennes, senza entrare. Un meccanismo
nevrotico della mia mente diceva che non potevo farlo.
Pena: non avrei mai più trovato la mia Solange. Dunque,
come un vecchio folle giravo per il quartiere, intimorito
dai divieti che io stesso mi imponevo. Il mio viso
doveva essere quanto mai pallido. Una vetrina che
esponeva prodotti di erboristeria mi dava un colorito
giallognolo, lo vedevo nel riflesso. Mi voltai, come
guidato da un istinto, lo stesso di cui mi parlò il mio amico
James quando a Boston prese a guardare fuori della
finestra. Potrà sembrare curioso, ma talvolta nella vita le
cose si possono decidere, se il momento è stato scelto
con cura. Mio padre mi raccontava sempre una favola
che da bambino amavo ascoltare più di tutte le altre:
mi diceva che nella vita sono concessi tre desideri. Per
tre volte si può chiedere una cosa, e averla proprio in
quel momento. Ma bisogna sentire il vento, è il vento
che dice quando arriva il momento giusto. Se no, nulla
accade. E i desideri sono sempre dedicati agli incontri,
alle persone, a ciò che si ama; non compare un portafogli
con molto denaro. Non ci sarà mai un momento per
quello. Può apparire invece una persona che non
vediamo da tempo, e di cui sentiamo il bisogno, e forse
non sappiamo neppure dove cercarla. O magari una
persona che non conosciamo e ci porterà fortuna.
Quel giorno sapevo che un terzo dei miei desideri
doveva avverarsi, che il vento leggero di quel tardo
pomeriggio era quello giusto. Sapevo che potevo
chiedere al caso di voltarmi e di trovare Solange,
immobile e distratta dall'altra parte del marciapiede.
Era sola, guardava nella mia direzione, ma non me.
Mi fece impressione, mi sembrava diversa; le sue
gambe mi parevano ancora più sottili di quanto le
ricordassi: portava dei calzoncini molto corti, e i suoi
capelli biondi, lunghi, mi apparvero un po' infantili.
Era sola, dicevo, immobile, e si accorse subito della
mia presenza e di come io la fissassi. Per molto tempo,
davvero molto, sopportò il mio sguardo e poi con
calma ritrasse gli occhi dai miei quasi assentandosi.
Era lei? O forse quell'attesa spasmodica di incontrarla
aveva trasformato un volto in qualcosa d'altro, in
un oggetto del desiderio. Volevo far diventare la prima
donna che passava da quella via l'immagine delle
mie inquietudini? E quale crudeltà la teneva a distanza
come fosse un'estranea? E quale mia presunzione
mi portava a pensare che una donna conosciuta una
notte non fosse un'estranea, e solo perché vantava un
nome che per la mia fantasia ormai significava tutto?
Un grande scrittore direbbe che quel giorno fui chiamato
ad alta voce dalla vita. Oggi non ricordo quanto
durò quel silenzio, e quanto tempo dovette passare
prima che quella distanza venisse colmata da qualche
parola. Ancora oggi non so organizzare i tempi di
quell'incontro, come obbedissero a regole che non
conosco, e dunque quasi fossero fusi assieme senza un
ordine.
Mi venne incontro? Non mi sembra. L'avvicinai io
stesso? Forse. Non mi riconobbe? Probabilmente,
non subito. E più tardi, quando pronunciai il suo nome,
mi guardò sorpresa e quasi intimidita: ricordavo
il suo nome, come potevo? E dovetti pronunciarlo
con una confidenza eccessiva, che poteva suonare
falsa, ma che era figlia di un delirio musicale, non di
un tentativo di approccio indiscreto. Oggi mentre
scrivo queste righe ho messo sul piatto del mio giradischi
le Partite di Johann Sebastian Bach. Ho bisogno
di musica che possa raffreddare la mia mente.
Non sopporterei di scrivere di quest'incontro con le
note di Chopin in sottofondo. Sarebbe come addensare
nuvole cariche di pioggia a nuvole cariche di
pioggia. Anche se quel giusto vento che mi aveva
permesso di avverare il desiderio preludeva a un
acquazzone tremendo, come solo a Parigi ne ho visti.
Come arrivammo al caffè di rue de Rennes? Prima
che fosse piovuto? Mentre l'acqua scendeva a catinelle?
Posso dire di non ricordarlo. Ricordo bene invece
come spostò la sedia per sedersi, prima ancora che lo
facessi io; e come ebbi un moto di eccitazione nel
vedere quella caviglia sottile che affiorava da sotto il
tavolino. E quell'espressione di stupore alla storia di
Solange Dudevant, di Chopin e del mio amico Evgenij.
Forse mi ero sbagliato, forse nulla sapeva di musica,
e - peggio - poco le importava. Un nome è un
nome è un nome è un nome.
Ma era la mia paura: il terrore e il sollievo che il
mondo potesse essere una mia costruzione mentale;
mia, di James, di Evgenij, e persino del mio scrittore.
Lo temevo ma ci speravo. Volevo che tutto fosse frutto
della mia mente, delle mie mani, del mio talento.
Come un buon artefice che, con il permesso di Dio,
potesse inventare una storia che alla fine facesse
tornare ogni cosa al proprio posto, e in modo perfetto.
Volevo trasformare quella passione in una bella calligrafia,
che mi rassicurasse? Oggi non saprei dire.
Temevo tutto di lei, come se avessi incontrato un sosia
della mia Solange, un sosia che non volevo.
In che direzione la pioggia bagnava i vetri del
caffè? In modo obliquo, con gocce che si fermavano
per un attimo e poi scendevano, con una brusca sterzata,
giù in verticale per i vetri del locale. So che dopo
(ma quanto tempo dopo?) in una casa che ormai
faticavo a tenere in ordine, al pari dei miei pensieri,
capii quanto fosse faticoso vivere in tonalità minore.
E lei mi guardava e domandava del perché mai Chopin
avrebbe dovuto scrivere quelle note così male. Fu
Solange a strappar di mano a Chopin quelle pagine
prima che fossero ricopiate? Quasi a fuggire via da
una passione terribile a cui non sapeva far fronte. Lui
vittima della bellezza di Solange, oppure lei, incapace
di sopportare il declino fisico di Chopin, di guardarlo
morire lentamente.
Le avrei fatto ascoltare quelle pagine? Mi domandavo
in quel caffè, mentre la pioggia, che non accennava
a diminuire, aveva trasformato il cielo in un
quadro a olio denso, quasi vischioso. E non so se fu
allora che mi venne in mente un episodio assai simile
a quello di cui mi parlò James, avvenuto nella casa
di Boston. O se invece quel cielo, ripensato qualche
tempo dopo, mi aveva suggerito di quel giorno in
cui portai una ragazza, Annetta, fino al garage, che
stava un po' isolato ai lati del parco. E che aveva una
doppia entrata: quella che dava verso la strada e
quella che dava verso l'interno. E Annetta disobbediva
spesso e scavalcava il cancello per venire a
giocare con me. Lei doveva avere tredici anni. E mi venne
a cercare per un'estate. E io la vidi cambiare,
quasi di giorno in giorno, e sempre più incapace di
resisterle. Ricordo solo che un pomeriggio che
assomigliava al mio, quello di rue du Cherche-Midi, con
l'acqua che scendeva obliqua e colpiva i vetri come
fosse un proiettile, e ancora esitava per poi proseguire
rapidissima, lei mi chiamò con un sorriso consapevole,
e paziente. Mi fece entrare nel garage, dove
ormai mio padre teneva soltanto due vecchie carrozze,
mi stese a terra, con calma, con lenti movimenti,
abbassò le spalline del vestitino, bagnato dall'acqua,
e sentii che era nuda: e prima che potessi capire, con
una grande agilità mi imprigionò tra le sue gambe,
mentre il bacino si muoveva come se stesse avvitando
la mia vita dentro un desiderio da cui non mi
sarei più liberato.
E quell'acqua che scendeva, quasi con fretta, da
quei vetri del caffè allontanava il mio piacere perché
volevo Solange come fosse allora: dentro un garage.
Andammo verso casa: rue d'Assas, rue de Vaugirard,
rue Cassette, a girare subito per rue de Mezières, per
place e rue Saint-Sulpice, e l'Odéon e poi a destra, come
per gioco, per rue Monsieur-le-Prince e su per rue
Racine, attraversando il boulevard per rue des Écoles,
tagliando rue Saint-Jacques per rue Thénard, su
fino a rue Dante e Saint-Julien-le-Pauvre, passando il
pont de l'Archeveché e il pont Saint-Louis, quando la
pioggia ci sorprese ancora, proprio mentre si cominciava
a intravedere qualche stella. E di stelle quella
sera non ce n'erano troppe.
Ma quel giorno lontano uscii dal garage con una
sensazione di sgomento e di spossatezza, mentre
Annetta non diceva nulla e appoggiata al muro bagnato
dalla pioggia si mordeva i capelli e si abbottonava
con calma, con troppa calma, i tre bottoncini del
vestito che si aprivano sul seno, per poi ripensarci un
attimo dopo e sbottonarne ancora uno, quasi tornando
a provocarmi, proprio nel momento in cui doveva
rincasare, passando per il cancelletto basso e sparendo,
come sempre, oltre la strada.
Una strada certo diversa da questa, che si affaccia
sul Quartiere Latino e talvolta assomiglia a un lungomare
di luci, con ondate di gente che cammina piano
e va su e giù. Io vedevo quella folla anche dalle mie
finestre e pensavo a certi esercizi di Clementi,
meravigliosamente inconcludenti, o anche ad alcuni di
Carl Czerny e persino a certi Preludi di Bach. Dove il
piacere è nella ripetizione, nel continuare a girare
attorno, come fossero gruppi di numeri periodici dove
al quinto o sesto decimale tornano uguali. Non c'erano
code finali risolutive, ma simmetrie che si ripetevano.
Brani circolari, come i movimenti del bacino
della mia Annetta, quasi il suo corpo aspettasse ogni
volta un piacere nuovo, qualcosa che potesse stupirla,
mentre io, raggelato e impaurito, aspettavo quasi
inerte che tutto finisse, per goderne dopo, al buio,
dentro la mia stanza, o fingendo di essere assorto
davanti a una partitura.
Ed è quello che feci con la mia Solange quando lei,
appena sveglia, dopo un'ora di sonno, mi chiese a cosa
pensassi quando fissavo un punto preciso di quel
vecchio foglio manoscritto. Ma Annetta, in quel tempo
lontano, non avrebbe potuto domandarmi perché
quella notte suonai fino a sfinirmi, guidato dall'angoscia
del piacere, tutto il Gradus ad Parnassum, proprio
tutto: dal primo esercizio fino al novantesimo. Una
strada in salita impossibile per chiunque, come
volessi restituire al mio pianoforte una sensazione
vissuta altrove. Avevo quindici anni, e Annetta cambiò
la mia vita per sempre. Ogni volta che toccavo il
pianoforte sapevo che era soltanto un gioco di vasi
comunicanti, che c'era un rovescio nella mia sensualità,
che stavo sfinendo i miei sensi; e sapevo che non avevo
altra scelta, che quello era il mio modo per non
condurre una vita ossessionata dalla sensualità e dalla
passione. Mi accorgo che non uso mai la parola
amore, se non per dire: amore per la musica, per il
pianoforte; mi accorgo con piacere che ancora so
dissimulare, e mantenere un opportuno distacco.
Passione e calligrafia delle passioni. Lo dissi a Solange,
e non so più se a rue de Rennes, a rue ChercheMidi, o a casa mia; e se proprio voglio guardare, non
so neppure se lo dissi a Solange, o ad Annetta, che
era una donna fatta già a tredici anni. E poco importa.
Perché anche Frédéric Chopin dovette scoprire il
sesso in quel modo. E perché c'è un piacere nell'essere
turbati da un coetaneo che non parla, ma che sa, e
ti guarda. Annetta tornò più volte, e io non riuscivo a
capire quanto mi desiderasse. Ed ero pazzo di lei, finché
seppi che per Annetta ero un gioco, perché un
pomeriggio la vidi dietro un muro di un cascinale
abbandonato con un uomo adulto, lei teneva le gambe
incrociate sui suoi fianchi mentre lui la sollevava da
terra con le mani sulle natiche. E lei un attimo prima
di mordergli un orecchio per non gridare mi guardò
con disappunto, quasi rabbia per una curiosità che
non dovevo avere. Non tornò più Annetta, non saltò
più per il cancello, e per me fu un dolore. E ripensai a
quel cancello che un bel giorno fu sostituito con
un'inferriata più alta, e mi ricordai di aver giurato
che alle donne non avrei mai fatto troppe domande.
Con Solange non seppi resistere. In quel caffè le
chiesi perché non tornò più all'appartamento di
Quai d'Orléans. Ma sapevo già cosa mi avrebbe
risposto. Io non le avevo chiesto nulla, dunque non
volevo più cercarla. Perché mai avrebbe dovuto tornare
proprio lei. Le domandai altre cose, che vita
facesse, chi fosse. Dove era nata. Mi accorsi che di me
sapeva tutto, che aveva comprato ogni mio disco:
avrebbe fatto felice il mio produttore, convincendolo
che era nel giusto, che si doveva ripubblicare ogni
mia cosa. Era divertita, mi diceva che aveva capito
«chi fossi veramente» soltanto qualche ora dopo
essere uscita dalla mia casa.
Mentre Annetta no, lei era la figlia di un fattore
che viveva vicino a noi e vantava rapporti con i
nostri cuochi. Mi accorsi di lei per la prima volta un
giorno che passeggiavo sul retro della casa. Qualche
volta scambiammo una parola o due. Poi tutto fu come
un'estate troppo rapida, che brucia ogni giorno
di più, e la confidenza si fece strada ostacolata da
deboli indugi. Ma Annetta sapeva a malapena che io
suonassi il pianoforte. Non so neppure più dove oggi
sia, e cosa faccia. Ma passato qualche anno - non
troppi per la verità - dopo aver letto Sylvie pensai
che la mia Annetta non poteva che essere la Sylvie di
Nerval, e che quei confini del parco della mia casa
potevano essere la mia terra del Valois, e io potevo
essere Nerval pazzo d'amore per lei, ma rassegnato.
E ogni cosa tornava al suo posto.
E tutto tornava anche con la mia Solange, bella e
dalle caviglie sottili. Anche il suo modo di desiderarmi:
diverso da quello che avevo conosciuto la prima
volta. Ora sapeva, sapeva chi fossi, sapeva persino dei
miei deliri paralleli: di lei Solange, e di Solange Dudevant,
e di Chopin, e della quarta Ballata in fa minore. E
aveva visto quel manoscritto, e mi cercava con un misto
di timore e di fascinazione che la rendeva ancora
più sensuale. Mi accorgevo che ora pensava, che ora
sapeva, e voleva sapere ancora altro; non potevo
sbagliarmi: questa volta non sarebbe andata via all'alba
senza troppi rimpianti, ma avrebbe lasciato il mio portone
con nostalgia. Però non mi bastava: non volevo il
suo corpo, lo temevo, perché quel corpo avrebbe
potuto dirmi molto di quella calligrafia delle passioni
che ancora oggi ho qui sul tavolo.
Non ricordo come Solange uscì dalla mia casa, se
con quella nostalgia che allora le avevo previsto, o in
un altro modo. Però ricordo bene come Annetta
scavalcò per l'ultima volta il mio cancello, con una spallina
del vestito che si abbassava e mi faceva intravedere,
per l'ultima volta, quel seno che allora trovavo
indecente, ma solo perché provocava ogni mio senso.
La mia eccitazione scattava come le mie dita a un
passaggio veloce e improvviso. Forse fu allora che pensai
all'Appassionata di Beethoven e per la prima volta mi
accorsi che l'ostinato della mano sinistra, nell'ultimo
movimento, non era il sottofondo della disperazione,
ma il ripetersi del desiderio, del mio desiderio. E del
desiderio della carne, il più profondo, forse il più
incontrollabile. Molti anni dopo, era una tranquilla serata
d'estate, mi confortai nel leggere che Thomas Mann
lo chiamava «il cane rabbioso che ho dentro di me».
Guardavo Solange, intenta a curiosare tra i miei
appunti musicali. Li sfogliava, leggeva, e tornava a
guardare qua e là. Io stavo alla finestra e fumavo una
sigaretta. Pensavo a quel periodo in cui, assai giovane,
cominciai a farmi le sigarette con il tabacco della
pipa di mio padre. Ero bravissimo a modellare le cartine.
E non so dire se fu proprio Annetta la prima
donna che me ne chiese una.
«A cosa pensi?», chiese Solange, quasi sorprendendomi.
Pensavo anche a James, che mi raccontò quella storia,
quella della ragazza sul prato, di lui che la lasciò
passare, e di quella nostalgia della perdita, del senso
del passato, del provar piacere nel poter rimpiangere
il desiderio. E pensavo che la mia debolezza era invece
nel bruciare quel desiderio, come fosse una sigaretta
che quando si fa incandescente diventa cattiva.
Forse solo al pianoforte sapevo aspettare, capivo che
la passione romantica era solo un complicato sistema
di segni, che io sapevo leggere e riconoscere. Forse
solo lì, davanti a pagine scritte, godevo del vantaggio
della riflessione. Perché l'intensità musicale si smonta
come un giocattolo, e diventa all'origine una
sequenza di note a volte semplicissima.
Mi accadde per la prima volta forse con la FantasiaImprovviso di Chopin che, giovinetto, elessi a
bandiera delle mie sofferenze di adolescente. La suonavo
dapprima lentissima, e non riconoscevo nulla,
come fosse uno scioglilingua quasi sillabato. Poi sempre
più velocemente, ma con gradualità, e mi
sembrava di rifare un gioco che mia nonna mi aveva
insegnato da bambino. Ordinando le caselle di un
mosaico apparentemente insensato, affiorava il disegno
che prima era nascosto. E dietro quella facciata
perfetta, dietro quella famiglia ricca e privilegiata in
cui ero cresciuto, c'erano due velocità. A me era riservata
quella più lenta, quella più fredda. Ma se avessi
avuto la coscienza di accelerare, come con la Fantasiaimprovviso, ogni nota della mia quotidianità,
avrei capito molte cose di cui allora non sospettavo.
Di mio padre tormentato da un amore non corrisposto.
Di mia madre che avrebbe voluto sposare mio
zio, ma non era possibile, perché mio zio Arturo non
amava le donne e, in età matura, neppure più gli
uomini. E allora mia madre sposò mio padre, senza
amarlo, perché era l'unico modo per non perdere del
tutto mio zio.
Neppure la morte di zio Arturo, dopo una lunga
malattia, e un mese dopo, d'improvviso, quella di
mia madre, riuscirono a consolare mio padre di non
essere stato amato per una vita intera. E mia nonna
vigilava su quelle affezioni delle passioni come un
medico impotente. Ma tutto era lento, come la mia
Fantasia-Improvviso suonata in modo stentato, o
meglio rallentata e ingrandita come un dipinto d'altare
di cui vedi solo dettagli e mai l'insieme. Mia madre,
asciutta e consumata in un dramma di cui lei stessa
era stata artefice; mio padre, canuto prima del tempo
e sempre nascosto nel suo studio. E io poi, che vivevo
in un mondo rigido e chiuso, costretto a suonare ore
e ore perché zio Arturo era concertista e primo maestro
di pianoforte di mia madre. E quando morì, mia
madre volle che fossi io a suonare al suo funerale i
Preludi in mi minore e in si minore, proprio come
accadde al funerale di Chopin, alla Madeleine.
Solange doveva essere là, seduta nelle prime file.
Erano le undici del mattino del 30 ottobre 1849.
Tremila persone affollavano la chiesa parata con drappi
neri. Il coro e l'orchestra della Società dei concerti del
conservatorio eseguirono il Requiem di Mozart. Poi
l'organista della Madeleine, Lefébure-Wely, suonò le
trascrizioni dei due Preludi di Chopin, e improvvisò
alcune variazioni sul tema di un terzo Preludio. Ma
nessuno specifica quale fosse. Forse, così mi piace
pensare, quello in fa diesis minore. Così mi piacque
pensare anche allora, quando al funerale dello zio
Arturo suonai, fuori programma, anche il Preludio in
fa diesis minore. E seduto all'organo potevo vedere
mia madre, distrutta dal dolore, in prima fila; eppure
con una luce negli occhi che non le avevo mai visto. E
oggi non saprei definire l'espressione del viso di mio
padre, grigia, come fosse disegnata a carboncino, e
quasi cancellata. Avevo diciassette anni. Solange,
l'anno che morì Chopin, ne aveva ventuno. Avrebbe
vissuto per altri cinquant'anni. Avrebbe lasciato suo
marito Clésinger, e condotto - come scrivevano i
biografi del tempo - un'esistenza molto avventurosa. In
realtà condusse una vita slabbrata e priva di ogni freno,
vittima delle sue passioni e della sua natura
sensuale. Cosa pensò Solange mentre i cordoni funebri
sorretti da Franchomme, Delacroix, Pleyel e i principi
Aleksandr e Adam Czartoryski conducevano il feretro
di Chopin fino al Père-Lachaise. Cosa provò alla
Madeleine nel sentire quel Requiem di Mozart, cantato
da Madame Viardot-García e Lablache, Jeanne
Castellan e Alexis Dupont. Pensò alla sua quarta Ballata,
scritta solo per lei? E zio Arturo suonò almeno
una volta per mia madre? E Annetta mi avrà ascoltato
da giù, dal quel tratturo che di là dalle mura non
doveva passare molto distante dalla mia finestra (oggi
non so più ricomporre le distanze)? E pensare che
in quei giorni lontani suonavo quasi solo per lei, e lei
di certo non mi avrà mai ascoltato. Chissà se ha mai
saputo che sono diventato un famoso concertista.
Solange aveva ascoltato tutti i miei dischi. Non
amava Chopin, credeva fosse un compositore «inutilmente
romantico». Non commentai opinioni e giudizi
che non hanno un fondamento, ma si formano per
continui equivoci che nessuno si premura di correggere,
di svelare. Mi piaceva la sua ricerca a posteriori, mi
piaceva che Solange mi avesse cercato in un modo che
non prevedevo, e che non osavo sperare: seguendo le
tracce che in tanti anni dovevo aver lasciato per il
mondo, e che erano ormai altro da me, cose su cui avevo
scarso potere. Non so dire come fece a procurarsi
molti vecchi filmati televisivi, andati in onda in Italia e
anche in Francia, dove suono Debussy e Chopin, ma
anche Beethoven. Mi disse di averli visti. E mi parlò di
una Mazurca di Chopin che interpretai con particolare
efficacia: la numero 4 dell'opera 68. Non sapeva che
si tratta della sua ultima composizione, dettata sul letto
di morte, e non mi ero mai accorto che anche quella
Mazurca è in fa minore, come la quarta Ballata.
Ero turbato dal fatto che mi parlasse di quella
mazurca: un brano che ho sempre suonato con una specie
di timore. Come se non mi sentissi pronto a quella
semplicità profonda, a quella nebulosità incerta. Quasi
lo considerassi un brano da suonare quando si è
adulti. E pensavo a quanta differenza ci fosse tra quella
Mazurca e la coda della quarta Ballata; e di quanto
fossero vicine le date di composizione. Cominciavo a
capire d'un tratto quanto mi diceva James. Come la
coda della quarta Ballata fosse la passione, la rabbia,
l'impossibilità, persino il destino. E certamente i sensi
e lo sgomento. E quella Mazurca, tutto quanto era James,
la perdita, la malinconia, il piacere del non vivere
l'attimo per poi rimpiangerlo, e quasi da subito: come
un lieve asincronismo della sensibilità. Ora capivo anche
Solange, la mia, seduta di fronte alla finestra:
giovane e bella, a riflettere, a modo suo, il mio corpo
magro che era quello di un vecchio, e non me ne ero mai
reso conto. Capivo Solange, di fronte a me, con le
gambe incrociate e la testa appoggiata al muro, e i
capelli biondi mossi leggermente dal vento che la notte
aveva alzato. Capivo che c'è un momento della giovinezza
dove si può essere James e me: dove si può
alternare malinconia e passione. Come due onde che si
sovrappongono e, facendolo, si spezzano confondendo
i loro disegni.
Era proprio vero che quel momento della mia vita
correva in fa minore. Per la prima volta, in quella
serata iniziata con un'apparizione, capivo che tutto
aveva una spiegazione, che nulla era lasciato al caso.
Ma quel tenersi insieme di storie lontanissime era un
privilegio di uomini che sapevano molte cose, che
leggevano il mondo attraverso un codice che conoscevano
assai bene, e inventavano una lingua e una
scrittura anche là dove sembrava non esserci, e forse
non c'era. E nonostante fosse persino ovvio, tornai a
stupirmi, quando presi a pensare ad Annetta, alla sua
sensualità quasi dolorosa, appena sentii ancora una
volta il corpo di Solange che si avvicinava al mio.
Capitolo undicesimo.
Forse fu un caso, ma ha del romanzesco. Non mi ero
mai accorto che il pianista russo Andrej Charitonovic
fu arrestato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 1949.
Esattamente cento anni dopo che Chopin terminò di
scrivere la parte finale della quarta Ballata. I fogli che
ho qui davanti a me dicono: 17 febbraio 1849. Ma chissà,
Charitonovic doveva conoscere quella data, e deve
aver sorriso sprezzante, quando in quella notte fredda,
certo più fredda che a Parigi, ottusi poliziotti
pensavano di agire secondo i tempi dettati dalle pratiche e
dai timbri del loro sordo regime e invece obbedivano
ai tempi di un dramma a cui non avevano accesso,
perché non potevano capire. Con che arroganza quello
straordinario pianista, il giovane Andrej Charitonovic,
può aver guardato negli occhi quegli uomini?
Non saprei, e certo non può saperlo neppure Evgenij,
fuggito con il denaro che gli avevo dato in qualche
luogo più sopportabile. Qualche biografo sostiene che
il 17 febbraio sia la vera data di nascita di Frédéric
Chopin. Ma nell'intreccio delle date ci si può perdere,
si può uscire di senno. Preferisco pensare che non fu
solo un caso, ma una volontà: Charitonovic riuscì a
evitare il suo arresto, non so in quale modo, fino alla
data fatidica: perché una decisione, un ordine che non
aveva un senso, se non quello della cieca repressione,
prendesse un significato, diventasse bello.
E' straordinario come ci siano due mondi distinti.
Entrambi sorretti dal caso. Ma nel mio mondo, in
quello che assieme a me ha attraversato quasi tutto il
Novecento, il caso è un buon materiale d'uso: per fare
trame, costruire edifici, rendere significativo ciò
che non ha forse grande significato. Dove potevo
mettere la mia Solange? Nel caso o nella trama
perfetta che fin qui avevo costruito? Non so dire. Neppure
oggi, a distanza di qualche anno. Quella notte
suonai per lei la quarta Ballata, e l'ultima Mazurca.
Non sembrava impressionata, non era ammirata,
semmai mi pareva eccitata da quella che lei chiamava
la «forza leggera delle mie mani». Per la prima volta
mi trovavo di fronte a qualcuno che non mi ammirava.
Una persona a cui piacevo. Come Annetta, che
non conosceva il mio virtuosismo, ma solo il mio corpo.
E cercava soltanto quello.
Ho passato una vita a sedurre le donne con la mia
fama e la mia celebrità, con il carisma del grande interprete,
e persino con il mio denaro. E quella notte mi
trovavo di fronte una donna che non mi avrebbe mai
chiesto di suonare. Che mi lasciava libero di fare ciò
che volevo, una donna che mi guardò con disappunto
perché nella mia casa non c'era neppure uno specchio,
e non mostrava ammirazione per quella bizzarria di
un vecchio nevrotico. Tutto questo mi confondeva.
Suonai ancora una volta la quarta Ballata, e mi sembrava
che le note fossero confuse. Arrivai a pensare
che la prima versione fosse meglio, che la passione
avesse accecato Chopin, che la bizzosa Solange Dudevant
lo avesse quasi costretto a riscrivere una partitura
che non aveva certo bisogno di revisioni. Mi
sbagliavo: ero io a soffrire di quella partitura, ultima beffa
di un Dio verso cui avevo sempre mostrato rancore.
Domani verranno in molti da Amburgo, fin qui, in
questa valle dove corre il Rodano. Ci mettono tempo,
l'aeroporto è lontano. Si deve parlare del futuro. Vogliono
un'edizione di Chopin, quasi completa. Alcuni
brani non li ho mai incisi: gli Improvvisi, gli Scherzi,
forse non ho mai fatto un'integrale dei Notturni.
Sarebbe un bel lavoro, ma detesto avere dei tempi.
Invece loro sono precisi: pare che in tre anni tutto
possa andare a posto. Qualche volta non li ascolto, e
forse loro capiscono quanto io riesca ad assentarmi
anche con dieci persone sedute di fronte a me. Ma sono
perdonato, e io ne approfitto. Non c'è più Arrau,
non c'è più Magaloff, neppure Gould. Sono l'ultimo,
con Richter, dei grandi pianisti viventi. Loro godono
di quelle che chiamano bizze, e io invece amo definirle
«intervalli di sofferenza»; loro pensano sia il genio,
io so che di queste cose ho sofferto per una vita, e me
ne sono sempre vergognato. Perché ho ricevuto una
rigida educazione, e un uomo educato non fa bizze,
capricci, e si adatta a tutto. Almeno così mi diceva
mio padre, che in tutta la sua vita ha sempre nascosto
le sue grandi debolezze.
Quando morì mia madre, di crepacuore, io credo
per la morte di zio Arturo, mio padre non pianse
neppure una lacrima, eppure l'aveva amata, soffrendo
per una vita intera. E non solo: ma aveva amato
anche lo zio Arturo, più giovane di due anni e di
talento straordinario, un talento che lui non aveva mai
avuto. D'un tratto nella sua vita erano accadute due
tragedie. Eppure lui no, le sue passioni non le aveva
mai manifestate, e dopo quello che era avvenuto in
quel mese funesto si erano definitivamente chiuse,
come dietro una porta massiccia, dalle serrature sicure.
Passai in casa altri due anni, Annetta non c'era
più, e neppure il mio maestro di pianoforte, a cui non
rimase altro che consigliarmi un concorso internazionale
che mi rendesse famoso. Per quei tre anni, mentre
preparavo il mio primo repertorio, vidi mio padre
solo il mattino, e poi mezz'ora la sera. Lo guardai
invecchiare, di giorno in giorno, e più i suoi capelli
imbiancavano e cadevano, più i suoi silenzi si facevano
lunghi e insopportabili. Una sola volta lo scoprii
appoggiato, quasi nascosto, alla porta del salotto. Stavo
suonando, e lui non mi aveva più ascoltato in quegli
anni, quasi non sopportasse la musica che eseguivo.
Ma quel pomeriggio si era fermato, muto e immobile,
richiamato proprio da quella Mazurca in fa minore di
Chopin, che forse mia madre, con crudeltà e sofferenza,
deve avergli suonato. Mi accorsi di lui solo dopo
e, forse emozionato, mi fermai per un attimo. Poi
ripresi, quasi pentito di averlo disturbato. Ma tutto era
già finito, il suo corpo magro e ormai curvo scivolò
oltre la porta, e scomparve.
Non dovevano esser passati più di due mesi da
quel pomeriggio, e io mi avviavo a vincere il primo
premio assoluto al concorso Chopin a Varsavia. Mio
padre uscì un mattino dalla villa, e non tornò più. Di
lui non si seppe più nulla. Continuò a vivere nascosto
da qualche parte, oppure morì lasciandosi trascinare
dalla corrente di un fiume o con una pietra al
collo in qualche lago? Nessuno poté dirlo. Più di una
volta mi mandarono a chiamare per riconoscere
signori che potevano sembrare mio padre. Poi tutto
finì. Solo una lapide nella cappella di famiglia lo
ricorda. Mi piace pensare che non sia morto subito, che
quel giorno, il giorno del mio concerto al concorso
Chopin, lui fosse lì dietro una porta ad ascoltarmi,
pronto a scivolare via alla mia prima esitazione. E
sarà un caso, ma quella volta suonai anche la quarta
Ballata e la Mazurca op. 68 n. 4 in fa minore.
Che giorno era quando mio padre non tornò più a
casa? Di solito queste date rimangono impresse nella
mente, ma io l'ho dimenticata. Ricordo l'agitazione,
l'inquietudine della sera che scuriva il cielo, il
lampione che con il crescere dell'ansia si faceva sempre
più acceso, e più quella luce rischiarava un pezzo di
giardino, più io sapevo che stava accadendo qualcosa,
perché il cielo passava dal blu chiaro a un colore
simile al nero, in una notte senza luna, e il vento calava,
e si smorzavano le voci, i domestici tornavano
con le torce, ma nei loro visi io leggevo una qualche
consapevolezza, discreta, per non offendermi: se lo
aspettavano, anche se mai avrebbero osato farmelo
capire. Non ce n'era bisogno: sapevo e intuivo quanto
era avvenuto. Pochi giorni prima avevo trovato
delle lettere di mia madre a mio padre, erano del
1919, un anno prima che nascessi, e lì c'era tutto: il
dramma di mia madre, la rassegnazione di mio padre,
il compromesso inutile di far vivere mio zio in
un'ala indipendente della casa, vicino a loro, un
compromesso che non lasciava vie di uscita. Erano stati
vent'anni di formale convivenza, eppure terribili, per
tutti e tre; anche per zio Arturo, debole e tormentato,
che mai visse con chiarezza la sua omosessualità, ma
il più delle volte la celava al mondo e persino a sé
stesso. Solo da quel giorno, come avessi trovato il
bandolo della mia infanzia e della mia giovinezza,
avevo compreso cosa era stata la mia vita fino ad
allora. E solo in quel momento ero riuscito a trovare la
giusta velocità perché la lanterna magica facesse
muovere gli attori della mia commedia.
Poi fu tutto come un lampo, un Presto con fuoco.
Meno di un anno dopo quella notte ero già celebre:
primo assoluto al concorso Chopin, un solido contratto
discografico con i tedeschi, un calendario di
concerti che mi avrebbe occupato per due anni, se la
guerra non avesse chiuso ogni possibilità. Lasciai
l'Italia, e per tre anni vissi in Svizzera, a due chilometri
da questa casa; un paesaggio che mi ha insegnato
cosa sia l'attesa, il saper aspettare. Sono tornato in
questo posto trentacinque anni dopo e non riesco a
strappare dalla mia memoria i frammenti di una
giovinezza che non ho mai vissuto. Quegli anni furono
terribili, per molto tempo smisi di studiare il
pianoforte. La guerra mi procurava un dolore profondo,
il privilegio di essere riuscito a evitare la chiamata alle
armi mi lasciava un senso di colpa fortissimo che
riuscii a cancellare solo quando, dopo l'8 settembre,
decisi di tornare in Italia per unirmi ai partigiani di
Dionigi Superti. Passai il Sempione e vissi l'esperienza
della Repubblica dell'òssola, e poi l'angoscia di
veder arrivare 13 mila nazifascisti e occupare una
Domodossola ormai abbandonata, e da tutti. Ma prima
che ogni cosa finisse, con gli altri ragazzi ridevo
di me, dei miei calli alle mani.
Quell'atmosfera durò poco. Una sera capitammo
in una casa dove c'era un pianoforte: uno strumento
verticale, di marca tedesca, senza il pannello di legno
che copriva la meccanica e le corde. Ricordo che
c'erano dei coriandoli ancora attaccati ai feltri dei
martelletti. Maurizio, il più anziano del gruppo, mi
disse: «Dài, adesso facci sentire se sai davvero suonare».
Dovevamo essere dalle parti di Iselle, a pochi
chilometri dal confine, quasi nelle gole di Gondo.
Mentre alzavo il coperchio mi chiesi come erano riusciti
a portare quel pianoforte fin lì. Poi provai un solo
accordo: di do maggiore. Era tutto a posto, la
meccanica a baionetta del pianoforte aveva mantenuto
l'accordatura piuttosto bene. C'erano delle ragazze
che ridevano, un frastuono di pentole e odore di aceto,
molto forte. Suonai senza timidezze il Walzer brillante
di Chopin, qualcuno dietro le mie spalle
accennò qualche passo di danza. Sentivo delle voci che
chiedevano un charleston. Ma non ci badai. Erano
quasi due anni che non vedevo un pianoforte, e fui
quasi scortese nell'ignorare richieste confuse,
accompagnate da fischiettii e da qualche strofa di canzone
un po' stonata. Poi presi a suonare Brahms, una
rapsodia. E mentre lo facevo mi accorgevo che i movimenti
dietro le mie spalle diventavano sempre meno
identificabili, fino ad avere la sensazione che nulla si
muovesse, che mi avessero lasciato solo. Quando terminai
di suonare la Rapsodia, mi alzai dal seggiolino
e li guardai tutti. Erano silenziosi, anche le ragazze,
quasi impauriti, non osavano neppure farmi dei
complimenti, mi sembrava di arrivare da un altro
mondo. Per la prima volta mi guardarono come non
fossi uno dei loro, certo non lo volevano, ma erano
imbarazzati dalla mia diversità.
Cosa avevo fatto? Avevo soltanto suonato Brahms?
O forse c'era un'aria diversa che il mio pianoforte gli
aveva fatto percepire? Non saprei, ma ricordo che era
l'alba, e il freddo cominciava a farsi intenso, l'inverno
era alle porte. Si capiva che tutto stava finendo. Il
14 ottobre saremmo scappati, la Repubblica dell'òssola
finiva la sua storia e io seguii Superti, assieme ad
altri trecento uomini, in val Divedro. Da lì passammo
il confine, e me ne scappai in Svizzera. Solo molti mesi
dopo tornai a Milano, nel giugno del 1945. Ma per
riandare a quella sera, si capiva che in un futuro vicino,
con gli abiti civili, nulla sarebbe più stato uguale.
E quella notte mi dovetti accorgere che non si cambia,
che può anche accadere di viaggiare per strade
parallele, ma poi tutto torna al suo posto. Io nelle mie
ville, tra i miei Steinway, sempre a metà strada tra
New York, Londra e Parigi. Loro tutti un po' diversi,
chi a fare il giornalista, chi a tentare la carriera politica;
molti però tornarono a esistenze dignitose, e con il
piacere di farlo. Cosa aveva scatenato quella musica,
in quella notte? Certo, doveva apparire estranea,
difficile, ma non bastava: c'era qualcosa di più, che divideva;
avevo lasciato un portone aperto, e svelato la
mia anima, il mio spirito, il mio talento. L'avevo fatto
in buona fede, ma bastava, e ancora una volta, ad
alzare quel muro: un muro dietro cui ho vissuto
sempre, e con rimpianto.
Persino mio padre era imbarazzato dal mio talento
quando si nascose dietro quella porta. Solo mia madre
riuscì a sopportarlo, perché nel mio genio vedeva la
sconfitta di zio Arturo, pianista e grande virtuoso, ma
perdente. Io lo avevo annientato: a soli dieci anni suonavo
assai meglio di lui. Quella dovette essere la vendetta
di mia madre su zio Arturo, che l'aveva rifiutata,
e più di una volta. E lo fece con una sorta di dolore, con
una rabbia che rivelava quanto fossero contraddittori
e confusi i suoi sentimenti. Si scrissero delle lettere, un
pacchetto ritrovato pochi giorni dopo che morì mia
madre nel doppio fondo di un cassetto, assieme a un
cofanetto di gioielli che lui forse le regalò. Fu una zia
particolarmente solerte a bruciare quelle lettere, che
avrei voluto leggere, e che arse dal fuoco del caminetto
spargevano un profumo di gelsomino. E io vidi quel
fuoco, e quella carta che stava bruciando, e non potevo
sapere che qualcosa del genere doveva essere avvenuto
molti anni prima, dopo la morte di Chopin.
Siamo nel 1851, Alexandre Dumas figlio scopre a
Myslowitz, in Slesia, le lettere di George Sand a Chopin.
Sono molte. Dumas è entusiasta, sa di aver trovato
qualcosa di prezioso. Come sono finite in Slesia
quelle lettere? Furono affidate da George Sand a Luisa
Chopin, la sorella, perché le portasse via da Parigi.
Luisa prende queste lettere e le porta in Polonia, poi le
affida ad alcuni amici. Perché? Non si riesce a capire.
George Sand vuole liberarsi di qualcosa di scomodo,
ma come è che decide di affidarle alla sorella di Chopin?
Non erano le lettere di Frédéric, bensì le sue. Cosa
contenevano quelle lettere? Forse un segreto che
avrebbe potuto mettere in cattiva luce Chopin. E chi
meglio della sorella, dell'amatissima sorella, poteva
garantire discrezione? Ma c'è di più: Luisa non tiene
con sé quelle lettere, neppure lei. Perché? Non c'è una
risposta. Prende il pacchetto e lo consegna, sigillato,
ad alcuni amici di Myslowitz. Lì arriva Alexandre Dumas
figlio, che non cerca esattamente quelle lettere ma
nel trovarle ha un moto di entusiasmo. Legge quello
che c'è scritto e poi, pensando di far cosa gradita, mette
al corrente la Sand della scoperta. Finalmente quelle
lettere potranno tornare a Parigi.
Il 7 ottobre 1851 George Sand scrive poche gelide
parole a Dumas: «Poiché avete avuto la pazienza di
leggere il pacco di lettere, piuttosto insignificanti a
causa delle ripetizioni e che mi pare abbiano interesse
esclusivamente per il mio cuore, sapete ora quale
materna tenerezza abbia riempito nove anni della mia vita.
Certo in esse non vi sono segreti e dovrei piuttosto
glorificarmi che arrossire per aver curato e consolato,
come un figlio, quel nobile e inguaribile cuore...». E'
vero che non ci sono segreti? Non si direbbe. George
Sand ci ha lasciato nove volumi fitti di epistolario, e
quasi tutte le lettere della sua vita per migliaia di pagine.
Ma quelle che mandò a Chopin le fece bruciare. Un
po' come fece mia zia con quelle che mia madre inviò
allo zio Arturo? Non posso dire se anche quelle di
George Sand profumassero di gelsomino, ma ho sempre
associato i due episodi in modo strettissimo. Al
punto che oggi non so più dire se ho letto di quelle
lettere profumate in qualche biografia di George Sand o
se invece era la carta da lettera di mia madre. Tutto è
sempre stato talmente fuso assieme che il ritrovar la
quarta Ballata, e il conoscere una Solange, doppio e
sosia di Solange Dudevant, ha definitivamente sconvolto
la mia vita, mi ha sorpreso affacciato, per quel
poco che si può tollerare, alla finestra della follia.
Avrà capito la mia Solange tutto questo? Avrà
saputo, intuito dalle mie parole, che quei suoi capelli
che si muovevano leggeri per la stanza erano, persino
loro, tasselli di un mosaico sensuale di cui conoscevo
ogni dettaglio, come fosse un romanzo scritto
da me. Tornava quella sensazione di gelo, quel silenzio
che avrei voluto spezzare, in quel giorno lontano,
quando Maurizio, e Johnny, e Alberto, tutti i nomi di
battaglia dei miei compagni partigiani che erano con
me in quella casa, capirono che non c'erano più strade
da percorrere assieme; che le uscite erano diverse,
e dunque le destinazioni. Mi guardarono, quella notte,
con rispetto e disagio, neppure per i complimenti
si sentivano adeguati, temevano di sbagliare; soltanto
Johnny mi chiese che musica era, e io non osai neppure
dire il nome del compositore. E mentre tornavo
a sedermi, e le ragazze continuavano a ridere e a bere
del vino rosso, una mi guardò, era tutta accaldata:
«Sei bravo», mi disse quasi per togliersi un peso, e
sfiorandomi il ginocchio con la mano.
Solange quella notte non si avvicinò al pianoforte.
Stava un po' distante, e io potevo vederla con la coda
dell'occhio: in piedi, la schiena contro il muro, e una
posizione del corpo che sembrava naturale, morbida.
I suoi occhi fissavano le mie mani, ma senza ammirazione,
nonostante quasi volassero per la tastiera e le
dita sembrassero a tratti dei congegni perfetti capaci
di percuotere i tasti con una precisione che si faceva
eleganza. Quando terminai di suonare, neppure si
avvicinò, rimase distante: in un atteggiamento di
attesa, quasi di rispetto. Ma sapevo che in quel rispetto
c'era già un congedo, in quell'atteggiamento discreto
e sensuale potevo leggere la stessa distanza di quel
giorno lontano, di quel «Sei bravo» della ragazza
scapigliata che aveva bevuto troppo vino rosso. O almeno
temevo che così fosse: il pianoforte aveva finito
per separarmi, per togliere ogni possibilità di comunicare
con il mondo. O meglio, era lui stesso a comunicare.
Così ero vittima del mio strumento; e a tal
punto che più di una volta ho avuto degli scatti
distruttivi. Avrei spazzato via tutto. Un giorno, dopo
un concerto, a Stoccolma, lo dissi a un giornalista che
aveva avuto la pazienza di attendere il mio buon
umore fino a tarda sera: «Si pensa che il pianoforte
sia un tramite tra l'esecutore e il suo pubblico. Il più
delle volte la mia tecnica prodigiosa trasforma il mio
strumento in qualcosa di autonomo, in un mostro che
non controllo, fino a dargli vita propria, a trasformarlo
in un vero protagonista. E io quasi scompaio, piegato
da quella potenza meccanica e sonora».
Mi pareva che Solange sentisse tutto questo, che lo
provasse persino sul suo corpo, come un vento troppo
freddo, e la colpa fu certamente anche di Chopin, che
scrisse quella parte, quelle pagine con un Presto con
fuoco. Lui che era riuscito veramente a trasformare il
suo pianoforte in un semplice strumento della sua
sensibilità, lui che avrebbe potuto scrivere per Solange un
finale struggente e perfetto come quello dell'ultima
Mazurca, aveva invece scelto di impiegare la forza, la
passione, quasi la rabbia, per non dire il mistero.
Sapendo che non avrebbe più potuto suonare quelle
pagine, sapendo che per Solange sarebbero rimaste soltanto
scritte, forse mute, senza suono, senza musica.
Quale beffa delle simmetrie! Io a poter soltanto eseguire
quella partitura difficilissima e impetuosa, ma senza
che dentro di me riuscissi a trasformare quell'impeto,
quella passione, in un sentimento autentico per
quella Solange che il caso mi aveva fatto incontrare in
uno dei tanti caffè di Parigi. Io imprigionato dentro la
mia tecnica pianistica: io che avevo fatto del mio talento
una passione, e lo avevo come chiuso nella cassa
armonica del mio pianoforte, come i dèmoni che Chopin
dovette vedere quella notte in Inghilterra, e che lo
turbarono così tanto.
Ieri ho fatto una lunga passeggiata per i boschi che
dalla mia casa si estendono per tutta la valle. Comincio
ad aver bisogno di muovermi, a non sopportare
più questo esilio che mi ha aiutato per certi versi a
separarmi da me stesso. Negli ultimi anni della mia vita
ho scelto Debussy, perché Debussy non mi sfiora, lo
amo di una passione misurata e dissonante, come i
suoi accordi bizzarri, i suoni che lascia mescolare
nell'aria, come fosse un alchimista musicale che fa esperimenti,
o un pittore che predilige le tempere. Nessuno
potrà capire perché nelle rare interviste che concedo
parlo di Debussy, di Mozart, di Scarlatti, di Clementi,
talvolta di Beethoven, ma non parlo mai di Chopin.
Perché so che Chopin mi aspetta, che alla fine dovrò
tornare a lui, e so che vuole per sé tutta la mia capacità
di stupire il mondo, oggi non credo di essere ancora
pronto, non sono capace di entrare in quella chiesa
immaginaria che forse ho soltanto sognato (ma qualcuno
mi dice che da qualche parte esiste), che immagino
gotica, dal soffitto ligneo in oro e azzurro a cassettoni,
altissima, sorretta da colonne di granito e cipollino che
termina con un presbiterio poligonale illuminato da
grandi finestre, e ascoltare le voci di un coro, e sotto
un organo; e le fiamme libere delle torce a illuminare
la chiesa quasi ti abbagliano e sembrano mosse da un
vento misterioso, che entra dalle vetrate, o dal rosone
centrale. Mi sono immaginato, scaraventato in mezzo
a quel pieno musicale, incapace di leggere il pavimento
della chiesa, costituito interamente da un mosaico
antichissimo, misterioso, come quello della cattedrale
di Otranto.
Ho fatto sogni di grandezza mentre gli scoiattoli
correvano e saltavano da una cima di un albero a
un'altra, e ho cominciato ad avere paura del silenzio,
come solo una volta mi era accaduto, tanti anni prima,
mentre ero sulla cima della pala di Gondo, una parete
di gneiss a strapiombo di almeno cinquecento metri, e
il torrente correva sotto, sempre in ombra, e profondissimo,
e nessuno era mai salito su quelle pareti; si
arrivava da un sentiero pericoloso e ci si affacciava su
quell'abisso che nel fondo era stretto e nero, e le vie
che conducevano lì avevano nomi da brivido, più
freddi del vento che soffiava, come via delle rondini
sanguinarie. E io fantasticavo di una vita passata da
molti alpinisti a superare scogli tecnici quasi impossibili,
e mi chiedevo se non fossero gli stessi miei, quelli
che mi avevano permesso di suonare, forse come nessuno,
i passaggi più difficili della seconda e della
quarta Ballata. Persino Claudio Arrau arrancava, faticoso,
sulle salite di accordi di sesto grado, lo sentivo
che faticava, che le sue dita non gli bastavano. E
Rubinstein invece leggero, come un agile arrampicatore,
capace di sconfiggere ogni difficoltà con levità e un
pizzico di civetteria. E sentire quel brano suonato da
entrambi era come vedere un vecchio alpinista con
esperienza salire una parete, e osservare il suo corpo
mentre finisce quasi per soccombere alla fatica e così
capisci quanto sia difficile. E in quella esibizione della
difficoltà trovi il senso di ciò che sta facendo. Mentre
l'altro alpinista, il doppio, il sosia di Arthur Rubinstein,
è perfetto nei movimenti che la natura gli ha
dato come un privilegio raro, quella stessa natura che
aveva modellato la roccia su cui stava inerpicandosi
gli dava la chiave per vincerla, e guardandolo avresti
pensato fosse un gioco da ragazzi. E io che rappresentavo
la medietà tra quei due miracoli di tecnica e
interpretazione, e forse la mia medietà era un miracolo
ulteriore, perché era una grande sintesi, o almeno così
scrivevano i critici da anni, una sintesi che esigeva
tempo. Una parete a strapiombo di cinquecento metri
mi sarebbe bastata per tutta una vita. L'ironia forse fu
un'altra: quando pensavo di essere arrivato in cima,
mi ero accorto che avevo raggiunto solo il primo gradino,
che con quella quarta Ballata la parete sarebbe
continuata e certo non potevo immaginarlo.
E Chopin? Come avrebbe scalato quella parete?
Come me? Come Rubinstein? Come Arrau? O ancora
qualcun altro, per esempio Cortot? No, Chopin quella
parete l'aveva costruita, modellata, forgiata, creata,
l'aveva lasciata a noi. Lui era un Dio beffardo, che
aveva affidato al caso i nostri successi, e aveva investito
sulle nostre fatiche. E portato in carrozza la sua
Solange ad ammirare quella creatura di roccia
magnifica e impossibile, quel paesaggio che Immanuel
Kant avrebbe definito «sublime», e poi avrebbe
aggiunto: «dinamico». Proprio così, il «sublime dinamico».
Aveva condotto la sua Solange ad ammirare ciò
che lui stesso, per primo, non poteva più vincere. Un
paesaggio grandioso e inaccessibile. Affidato solo alla
scrittura, muto. Una calligrafia delle passioni interrotta
per brevi momenti da tre uomini in un intero
secolo. Tre destini diversi, non legati da nulla, se non
da un dettaglio, ognuno di noi non avrebbe mai
potuto suonare in pubblico quella musica. Franz Werth,
Andrej Charitonovic e io sapevamo da quel primo
accordo di due note che quelle pagine sarebbero
rimaste chiuse dentro il nostro pianoforte, dentro il
nostro orecchio, dentro la nostra memoria. Nessuno le
avrebbe potute pubblicare, era giusto che le generazioni
di pianisti continuassero a suonare la versione
conosciuta della Ballata. E che si continuasse a pensare
che quella partitura era intoccabile e perfetta così
come fu scritta la prima volta, e dunque come tutti
noi l'avevamo incisa negli anni. Forse la più straordinaria
composizione per pianoforte.
Forse. Quel manoscritto che io avevo tra le mani
era un conto aperto: tra me e Chopin, tra me e Solange
Dudevant, tra me e mia madre, mio padre, lo zio
Arturo, magari Annetta, i fantasmi di Werth e
Charitonovic, ed Evgenij e persino James o anche Arrau.
Per non dire poi di Solange, la mia Solange (e ogni
volta che scrivo sono costretto ad attribuirmela, la
mia la mia la mia, ed è bizzarro che, per distinguerla
dall'altra Solange, io chiami mia una delle donne che
meno ho posseduto nella mia vita). Quale miracoloso
collegamento ero riuscito a fare tra una stagione che
ingenuamente credevo di aver dimenticato e quello
che mi era accaduto dal giorno in cui a Parigi il russo
Evgenij mi aveva avvicinato?
Non ero più tornato a quell'episodio, quello della
serata con i partigiani in cui avevo suonato Brahms, e
poi quel pomeriggio con le gambe che ciondolavano
sull'orrido precipizio ad aspettare che un giorno
d'ottobre i fascisti e i tedeschi portassero ancora il
terrore. E quando la guerra finì, molti di quegli uomini
non volevano separarsi dalle loro armi, e forse non
sapevano cosa avrebbero visto tornando alle loro case.
E io stesso dove mai sarei andato? A Milano, forse?
O ancora qui in Svizzera, in questa valle dimenticata?
E come sarebbe stata la mia vita? Per la prima
volta mi sentivo solo, e libero da ogni legame. Quando
tornai a Milano, seppi che mia nonna era morta
nella sua villa sul lago di Como qualche giorno prima
della liberazione. Ero diventato ancora più ricco,
ed entrando nella nostra casa di Milano che nessuno
aveva mai amato, ebbi come un sentimento di felicità.
In pochi giorni arrivò il pianoforte dalla villa in
campagna, e ricominciai a suonare Chopin (un anno
dopo, forse un anno e mezzo, e avrei inciso la quarta
Ballata per la prima volta).
La guerra aveva seppellito quei venticinque anni
della mia vita in un sonno da cui mi ero svegliato poche
volte, e in cui mi sono rifugiato di continuo. Per
molto tempo non ero più tornato a pensare a
quell'antica storia: una passione familiare come molte, di
quelle che non si raccontano perché troppo private, e
che possono interessare solo la curiosità morbosa
degli altri, e nulla di più. Ma ora sapevo che quell'antica
vicenda aveva bisogno di qualcosa che la completasse,
e dovevo essere io, e doveva essere il mio pianoforte
a dare significato a tutto questo. Perché il pianoforte
nella mia famiglia non era uno strumento, era il motore
immobile dei sentimenti. Lo suonava mia madre, e
mio zio, e io, e non lo suonava mio padre, e questa fu
la tragedia della sua vita. Di una vita che si è trascinata
stancamente, e non si è mai compiuta, neppure nella
sua fine. Allora capivo che la passione di Chopin per
Solange doveva essere quella di mia madre per zio
Arturo, della mia per la Solange del caffè di rue de Rennes,
e forse di mia madre per me, figlio amato anche
per questo. Per non dire di Andrej Charitonovic per
Evgenij, e chissà, forse persino del vecchio professore
che amò Andrej e, atroce vendetta, lo volle perduto in
un lager, piuttosto che separato da sé.
Eppure queste affezioni dell'anima prendevano
significato solo quando si potevano legare tutte assieme,
in un intreccio che mi sorprendeva. Lo capii la mattina
che Solange uscì dalla mia casa, in modo meno casuale
della prima volta. Ormai sapevo che poteva tornare, e
che sarebbe tornata. Posai in un cassetto il manoscritto
e mi accorsi che era lo stesso cassetto in cui avevo
conservato una grande busta con poche fotografie. La
aprii, dopo molti anni che la portavo chiusa da una casa
all'altra. C'era una mia foto da bambino, con mia
madre e mio padre. Lui appoggiava le mani sulle spalle
a me e mia madre con un movimento talmente lieve
e timoroso che sembrava non osasse sfiorarci. Poi c'era
una mia immagine al pianoforte, avevo undici anni. E
ancora un'immagine mia e di mia madre: io seduto al
pianoforte, lei in piedi dietro il seggiolino. Anche in
questa foto lei mi appoggia una mano sulla spalla
mentre io fingo di girare una pagina della partitura.
Ma questa è una mano più decisa, forte, persino
autoritaria. E lo sguardo è fermo, quasi ostinato nel guardare
l'obiettivo. Giro la foto e vedo che c'è una riga
scritta: «Da Arturo, il 6 gennaio 1933». Dunque dietro
l'obiettivo stava proprio lo zio Arturo, e quello sguardo
di mia madre doveva essere uno dei modi in cui lei
lo avrà guardato per una vita. Sentii il bisogno di
rimettere tutto nel cassetto, insieme al mio manoscritto
di Chopin. Ma in questo mio intreccio di destini, che
tutti assieme mi potevano persino portare a pensare
che il Dio dell'universo è veramente un accordo di fa
minore, mancava qualcosa: non la mia Solange che
aveva assolto al suo ruolo, ma la sua Solange. Dovevo
trovarla, e sapevo quanto fosse una follia andare alla
ricerca di una donna morta nel 1899. Di cui nell'ultimo
periodo della sua vita non si è saputo quasi più nulla.
Ma come avrei potuto decifrare quella calligrafia delle
passioni senza che riuscissi a trovare un filo, quel filo
che avrebbe potuto mettere assieme tutta la mia storia.
E così quella mattina uscii senza meta. Forse fu follia.
Probabilmente il desiderio di trovare un senso
dove sembrava non esserci. Cosa sapevo di Solange
Dudevant? Che si separò dal marito Clésinger e condusse
una vita «avventurosa» fino alla morte, che il
fratello Maurice morì dieci anni prima. Sapevo ormai
che quel mistero, quel segreto, lo aveva tenuto per sé
assai bene. Ma nulla di più. Forse non c'era da conoscere
altro: la sua vita, ciò che contava della sua vita,
si era chiusa in poco tempo, in quegli anni di Nohant.
Ma per una volta la discrezione aveva avvolto tutto
di una coltre impenetrabile. Ancora nel 1849, nel
periodo in cui Chopin scriveva la quarta Ballata, le sue
lettere a Solange erano prudenti, affettuose ma assai
corrette. E in un biglietto datato 5 aprile 1849 le scriveva
rassegnato: «Sono al mio quarto dottore. Mi
prendono dieci franchi per visita e qualche volta
vengono due volte al giorno. Siate contenta della più
grande delle gioie: la salute». A maggio, quando
Solange darà alla luce una bambina, mostrerà grande
felicità: «Un amico infelice vi benedice, e benedice la
vostra figliola». Sembra che Solange scompaia con la
morte di Chopin, anche se continuerà a vivere per
altri cinquant'anni. E per altri cinquant'anni terrà quelle
pagine con sé. Dove potevo trovare tracce di Solange,
quando Solange di sé non regalò quasi nulla per
molto tempo. E se molto prima la passeggiata fino a
Passy mi aveva riportato a Nerval, ora mentre vagavo
attorno a rue Pigalle sapevo che le mie speranze
di trovare l'ultimo filo, fosse anche un filo qualsiasi,
della mia storia erano quasi nulle. Cercavo le case
che aveva abitato, ma in realtà volevo liberarmi da
un'ossessione che mi pareva eccessiva, e che cercavo
di trattare con distacco, persino ironia.
Tornai, camminando di buon passo, verso place
Vendome. C'è una targa che ricorda che lì morì il
grande compositore Frédéric Chopin. E ripensai alle
parole che Pauline Viardot scrisse a George Sand per
raccontare cosa avveniva nella casa del compositore
morente: «Tutte le grandi dame di Parigi si sono
sentite obbligate a recarsi a svenire nella sua camera
affollata di disegnatori che facevano schizzi in tutta
fretta, e un dagherrotipista voleva far mettere il letto
presso la finestra affinché il morente fosse esposto al
sole. Allora il buon Gutmann, indignato, ha messo
tutti questi mercanti alla porta».
Certo Solange non sveniva. Anzi non si mosse da
quella casa, e fu proprio lei che, la notte in cui lui
morì, si accorse per prima che non respirava più. E il
marito di Solange fu l'autore della maschera mortuaria
di Chopin, e della statua funeraria che si può
vedere sulla sua tomba al Père-Lachaise. Forse c'erano
ancora le lettere che gli mandò Solange in quella casa
di place Vendome. Ma nulla era destinato a rimanere:
da quella casa uscì tutto quello che era appartenuto a
Chopin, destinazione Polonia. La sorella Luisa
raccolse ogni cosa: lettere, carte personali, l'agenda.
Ma neppure un viaggio in Polonia mi avrebbe potuto
aiutare. Fu tutto bruciato dai cosacchi il 19
settembre 1863 durante una rivolta polacca contro la
Russia. Finì in cenere un vero tesoro, fatto di
manoscritti, libri, lettere e persino il pianoforte Bulcholz
sul quale Chopin aveva studiato. Mi è stato detto,
qualche anno dopo, che in mezzo a quei manoscritti,
a quelle carte, dovevano esserci certamente le lettere
che gli mandò Solange, e che lui non ebbe il coraggio
di bruciare. Uno strano destino: che tutto fosse finito
in cenere, tranne quelle pagine che il caso mi aveva
inviato. Si dice che Eugène Delacroix non fosse
soddisfatto del medaglione che Clésinger aveva fatto per
Chopin, anche se era somigliante. L'ironia volle che
fosse proprio sua moglie Solange l'unica che avrebbe
potuto darci il ritratto più veritiero di Chopin.
Quella giornata passò in fretta. Ci volle tempo perché
riprendessi la strada di casa. Ormai sapevo che
avrei lasciato Parigi, e che i miei amici di Amburgo
avrebbero sopportato di buon grado i miei capricci.
Rientrando nel portone ebbi due strane apparizioni,
forse delle allucinazioni. Mi sembrò di scorgere Evgenij,
sotto la mia finestra, pareva vestito con un abito
decente; lo vidi d'improvviso mentre il portone si chiudeva
alle mie spalle, tornai indietro, uscii ancora, ma
non c'era più nessuno. Era scappato, o si trattava degli
ultimi fili per il mio telaio che stavo cercando? Non so
dirlo ancora oggi. Come non posso dire il perché, ma
credetti di impazzire quando rientrando nel portone
vidi una busta sul banco della portineria, una busta
che mi parve profumare di gelsomino. La aprii, subito,
senza aspettare oltre: non c'era nulla, dentro, soltanto
un numero di telefono, di Parigi. Salii le scale di corsa,
presi il telefono, meglio, lo afferrai, e feci il numero. E
qui il ricordo si fa vago, era una voce decisa, di una
donna giovane: parlava francese, ma un francese
desueto e lezioso, come provenisse da un tempo lontano.
Di quella sera non ricordo altro, se non la bottiglia di
whisky vuota. Il giorno dopo riprovai, ma nessuno
rispondeva e dal ricevitore non arrivava alcun segnale.
L'addetto della società dei telefoni mi disse cortese che
quel numero non era mai esistito.
Capitolo dodicesimo.
In cima a uno dei monti che fanno la guardia alla mia
casa hanno messo un'antenna. La vedo lontana, e mi
sembra altissima; così potrò sentire meglio la mia radio
e persino me stesso, quando al canale svizzero e a
quello francese trasmettono brani delle mie incisioni.
Di tanto in tanto li ascolto, e devo ammetterlo: mi piace
la distanza che le onde radio pongono tra me e ciò
che ho suonato negli anni passati. Amo quel tipo di
imperfezione, le piccole scosse, le scariche leggère
pronte a interrompere un concerto di Chopin, o La
terrasse des audiences du clair de lune di Debussy. Ora
l'antenna restituirà me stesso perfetto, specchio della mia
anima, e mi lascerà ascoltare Chopin, suonato da me
come forse non vorrei, e contribuirà a tenere più vicino
il mio passato attraverso la perfezione sonora.
Capisco l'ossessione di molti musicisti sulla tecnica
di registrazione: più il suono è cristallino, perfetto,
fedele, più si pensa di cancellare il tempo, e si crede che
tutto rimanga inalterato. L'alta fedeltà è un modo
dell'eternità. Mi dicono che questi compact disc sono
indistruttibili, che non temono la polvere, che riproducono
il suono sempre allo stesso modo, e per sempre.
E' la nostra sconfitta, di noi musicisti intendo, e
non mi piace. Se potessi, ascolterei il mio primo disco
così come uscì, in 78 giri, con il gracchiare della puntina
e quel rumore, quel continuo fruscìo di fondo, che
dà alla musica la profondità del tempo, della vita, del
passato.
D'altronde, il mio passato l'ho stipato alla meglio
nella mia musica, all'inizio cercando un ordine, poi
sempre meno, alla rinfusa, talvolta lasciando fuori
qualche frammento spezzato nella foga di far star tutto
in una decina d'ore di pianoforte. Tanto dura il mio
repertorio nella sua forma migliore. Una vita cancellata,
sacrificata, quasi annullata in dieci ore di musica,
che non fanno neppure il sottofondo musicale di
un'intera giornata in un negozio di musica. Se ci penso,
quasi mi vengono i brividi. Non sono stato bravo
come Arrau, o come Rubinstein, o Magaloff, che hanno
lasciato una quantità di incisioni sconcertante. Io
tremavo a ogni suono che non rispondeva come avrei
voluto. Ora è troppo tardi per cambiare, e non voglio
diventare come quei vecchi pianisti che si mettono
improvvisamente a girare il mondo per tenere concerti
disperati, e magari perché hanno paura di morire.
Rubinstein aveva novant'anni, era quasi cieco, e sbagliava
anche le note. Arrau no, mio Dio, è stato perfetto fino
all'ultimo. Mi consolo con Richter, che non è più
quello di una volta, e i critici cominciano a storcere il
naso. Riguardo a Gould, poi, tutti sanno come finì,
quasi sotterrato dentro alberghi in cemento a Toronto,
a suonare soltanto la notte, e passare ore al telefono,
ma senza vedere nessuno. Quattro mesi prima che
morisse chiamò anche me, mi parlava in tedesco, era
un suo vezzo: «Maestro, quando incidi i Preludi? Sei
l'unico pianista che potrebbe farmi rimpiangere di
non aver quasi mai suonato Chopin». Scherzava, come
sempre. Arrau non mi disse mai una frase del
genere. I suoi Preludi potevano bastare, per tutti, me e
Gould compresi. Persino Alfred Cortot, colorato, incisivo,
quasi eccessivo, avrebbe avuto qualcosa da
imparare da Claudio Arrau.
I Preludi saranno il mio prossimo lavoro, se riuscirò
a sopportare quella loro incompiutezza strana,
che posso paragonare soltanto alle statue di
Michelangelo nelle Cappelle Medicee di Firenze. Se riuscirò
a suonare, come nessuno ha mai fatto, il Preludio in
re minore, l'ultimo, che Cortot definì con tre parole:
«Sangue, voluttà e morte». E lo suonava come un
rematore su un fiume che cerca di andare controcorrente,
e la mano sinistra raggiunge il sublime in un
continuo affaticarsi, mentre la destra grida disperata e
chiede una via di uscita. Arrau diceva: «E' quasi una
tempesta di mare, la fine definitiva dei Preludi. Dopo,
credo non si può più provare grande entusiasmo per
la vita». Ho scelto i Preludi non solo perché volevo
misurarmi con l'opera di Chopin più inquietante e
angosciosa che ci sia: perché i Preludi stanno esattamente
all'opposto delle Ballate. E l'ultimo Preludio è
forse il suggello di uno stato di sospensione emotiva:
anticipa la coda della quarta Ballata che solo io conosco
e posso suonare. Anche se i due brani sono stati
scritti a molti anni di distanza uno dall'altro. Quando
compose i Preludi, Chopin temeva di non tornare vivo
da Maiorca, era terrorizzato: sputava sangue, il
viaggio di ritorno lo fece in una nave carica di maiali,
ma il suo cammino musicale non si era certo compiuto.
La mia quarta Ballata è un'altra cosa, è l'opera
finale, l'ultimo atto, e per di più la consapevolezza della
passione, una consapevolezza arrivata troppo
tardi. Se il Preludio in re minore è un rematore
controcorrente, la quarta Ballata, la mia quarta Ballata, è
invece un rematore che cerca di moderare, anche se
inutilmente, la forza della corrente, e alla fine affronta
con coraggio le rapide.
Per tutti questi anni ho passeggiato molto, ho suonato
quel poco che mi basta, e ho pensato a lungo.
Ho vissuto per il mio pianoforte, ho parlato per ore
con il mio accordatore, mi sono fatto svelare dettagli
tecnici che ancora non conoscevo, anche se alla mia
età c'è ormai poco da sapere. Ho cercato l'anima del
mio pianoforte e anche quella di Solange, e forse le
ho persino confuse. Sapevo che Solange sarebbe tornata
nella mia casa di Parigi, e per molte altre volte,
se io non fossi scappato via, terrorizzato da una vita
che sfumava in un gioco di incastri, e in quel gioco
perdeva ogni malinconia. Di tanto in tanto Solange
mi manda una cartolina; vive in Irlanda, ma non so
bene dove. Mi scrive poche parole, talvolta in italiano,
spera di farmi piacere, e promette che verrà a
trovarmi, ma penso che le farà assai bene star lontano il
più possibile da un uomo come me.
Ormai sono troppo vecchio per lei, e mi accade
sempre più spesso di ritrovarmi troppo vecchio persino
per me stesso. Il mio pianoforte, l'unico che suono,
raramente ha partiture lasciate sul leggìo: ormai eseguo
quasi tutto a memoria, preferisco trascurare quei segni
sottili che mi hanno accompagnato per una vita.
Solo quel manoscritto rimane aperto sulla mia scrivania,
come fosse un libro che ogni sera ho bisogno di
leggere, anche se ormai lo conosco alla perfezione,
perché è il libro della mia vita, della mia ossessione
per Chopin e per quel Secolo; e, ancora, per tutte le
donne che ho avuto, per quel senso di disagio che provavo
nel non saper comunicare con nessuno. E mi sentivo
in colpa e nel peccato, perché prediligevo il
linguaggio del corpo; e dopotutto anche la mia musica,
le mie esecuzioni, i miei concerti erano un sensuale
linguaggio del corpo. Non c'era differenza se le mie
mani toccavano e suonavano una tastiera oppure sfioravano
i seni di una donna appena conosciuta, di cui
quasi non sapevo ancora il nome.
Pensavo che nel tirare linee rette su un foglio di carta
- casuali, che si incrociavano, che partivano da direzioni
diverse - si potesse forse trovare un centro che
tutte le collegava. E credevo che l'esser entrato in
possesso di un manoscritto così prezioso, che rivelava
molti aspetti sconosciuti di un grande compositore,
fosse un'avventura fortunata, che poteva anche non
verificarsi: bastava che la mia casa di Parigi fosse stata
trecento metri più distante dal museo con i cimeli di
Chopin. Non volevo credere a un libro eterno dove
tutto era scritto. E se quel libro c'era, mi era inaccessibile.
Dunque, cosa potevo farmene di quelle pagine?
Avrei potuto trattenere con me la giovane Solange?
Scoprire qualcosa in più di tutte quelle lettere bruciate
da gelide scrittrici e ignari cosacchi? Potevo forse
decifrare la mia vita attraverso quella partitura, e scoprire
che tra mia madre e zio Arturo ci fu rancore, sì, ma il
rancore che arriva solo dopo una passione vissuta
violentemente e poi negata? Anche le lettere di casa mia
furono bruciate prima che potessi leggerle. Allora non
potevo che continuare a stupirmi per quella calligrafia,
e per quelle note enigmatiche, e qui devo aggiungerlo:
persino terribili.
Nessuno ha più visto queste pagine dopo il mio
amico James e Solange. James non c'è più e Solange è
una donna troppo giovane per avere la pazienza di
cercare qualcosa in pagine manoscritte che appartengono
a un mondo che non potrà mai conoscere, da cui
forse è per sempre esclusa. Evgenij è scomparso, con i
suoi ricordi e i suoi dolori. E Dio solo potrà sapere se è
riuscito ad ascoltarmi mentre suonavo la coda della
quarta Ballata. Quando il sole scende e brucia le cime
della catena della Jungfrau mi prende un senso di
angoscia. Potrei regalare a un pianista più giovane queste
pagine, farle incidere da qualcuno, ma sarebbe
tempo perso: infinite polemiche sezionerebbero questi
segni misteriosi. I biografi di Chopin mi giurerebbero
rancore eterno: non sopportano che si possa dubitare
del rapporto tra Solange e Chopin. E infine, come
lasciar fuori tutta una parte di storia che riguarda solo
me, la mia famiglia e la mia Solange?
Sono l'ultimo pianista al mondo che potrebbe incidere
queste pagine; l'ultimo che ha avuto un maestro nato
nel 1858; aveva settant'anni lui, io soltanto otto, e suonavo
già benissimo la prima e la terza Ballata, tutti i Preludi
e buona parte degli Studi. Il mio maestro conobbe
Liszt, Puccini, ed ebbe consuetudine con Brahms, di
fronte al quale avrebbe voluto suonare il suo primo
concerto per pianoforte e orchestra. Mi diceva sempre:
«Faccia attenzione a Schumann, può indurre pensieri
foschi e oscuri, ci sono le tenebre nella mente di Schumann,
e dunque nella sua musica». E mi recitava
Baudelaire, a memoria naturalmente. Io mi impaurivo, e
nascondevo le partiture di Schumann (e zio Arturo,
senza saperlo, le ricomprava).
Tante cose non ho suonato nella mia vita: perché le
detestavo, o perché mi impaurivano, o ancora perché
c'erano dei passaggi che io non avrei mai scritto. Ho
sempre trattato la musica come qualcosa di vivo, che io
dovevo scegliere, a dispetto della grandezza di
qualunque compositore. Oggi i pianisti non si permettono
opinioni: al massimo silenzi, omissioni, una forma frusta
del coraggio di scegliere. Li capisco, e non li biasimo
troppo. Ho sentito l'odore delle vecchie stoffe di
Brahms sui vestiti del mio maestro. Ho sentito il profumo
di una vecchia Europa che non c'è più da molto
tempo. Qui sento solo l'aria tersa di un luogo troppo
salubre e un po' noioso. Neppure più il peccato mi
sorregge, quello che mi faceva suonare così bene: perché il
mio virtuosismo era la mia grande arma di seduzione,
l'unica che mi sapevo concedere. Ho sentito l'odore
delle vecchie stoffe di Brahms, e nelle donne ogni tipo
di acqua di colonia, anche le più volgari, senza curarmene;
ho fatto grandi i miei desideri e le mie debolezze
barattandoli con un pensiero forte e un talento inarrivabile.
Ero il regista di un mondo che scompariva, sono
l'ultimo che forse chiuderà la porta e lascerà tutti gli
altri fuori, ad ascoltare pianisti mediocri ma dotati di
tecnica decente, quella che basta per suonare tutte le note
scritte in una partitura. Il resto lo faranno gli ingegneri
del suono, quelli che sapevano trasformare Gould in
un Frankenstein del pianoforte. E mi rimane il dubbio
che persino Solange sarebbe rimasta fuori da quella
porta, perché il mio è un mondo di codici che non capisce
più nessuno, di cose scomparse, ma che per merito
della mia celebrità rimangono nell'aria: e posso ancora
sentire musica che non suono più da anni, incontrare
persone che mi parlano di vecchi concerti, brani
dimenticati, compositori di cui non eseguo una sola pagina
da cinquant'anni. Persino i visi femminili che hanno
riempito gli spazi lasciati liberi dalla musica stento
ormai a ricordarli: perché con gli anni sono diventati solo
dei gesti, movimenti sensuali tra loro assai simili.
L'altro giorno ho ricevuto una lettera senza mittente,
la scrittura della busta era femminile, il francobollo
in alfabeto cirillico diceva che era stata spedita dalla
Russia. Non l'aprii subito, sperai ancora in una rivelazione;
volevo poche parole, del tipo: sappiamo che hai
il manoscritto. Oppure: sono la nipote di Andrej, lei
merita di leggere la sua ultima lettera. Invece era
un'avvocato di Mosca, talmente povera da non potersi
permettere neppure la carta intestata. Si riferiva ai
diritti di una mia vecchissima incisione di Mozart
appena uscita in Russia.
Lasciai cadere ogni illusione: se una calligrafia delle
passioni esisteva, forse ero davvero l'ultimo capace
di leggerla.
Epilogo in fa minore.
Oggi è tornato il mio accordatore; è come un medico
premuroso che ogni giorno passa per sapere se tutto
va bene, e per rassicurarmi. Quel terzo fa del
pianoforte non suona ancora come dovrebbe. E dire che
il fa è la nota che dà la tonalità alla mia Ballata. Ci siamo
guardati, lui ha controllato ancora il rullino e poi
mi ha detto che quel tipo di Steinway può avere un
difetto simile, ma che spesso passa assai rapidamente,
e da solo.
«E poi non torna?», gli ho chiesto con un'ansia
comprensibile.
«Chi può dirlo?», mi ha risposto. «Talvolta tutto va
a posto. Provi, maestro, mi sembra che ora suoni senza
fruscii.»
Mi ha lasciato il posto sul seggiolino, e ho suonato
quel fa una, due, tre volte. Premendo il pedale di risonanza
e ascoltando con attenzione l'eco che si diffondeva
nel salone, come fosse un profumo. Non udivo
alcun fruscìo, sembrava perfetto. Il mio accordatore ha
sorriso, senza alcun compiacimento: «Non è mio il
merito, maestro, questi pianoforti hanno qualcosa dentro
che li rende saggi. Quando è il momento, smettono di
fare i capricci e si comportano da bravi strumenti».
Ho riprovato ancora, non ero convinto: e mi è parso
di risentire il fruscìo del feltro, come fossi un malato
immaginario che cerca a ogni costo il sintomo che
non ha, e si prova più volte la temperatura finché
non pensa di intravedere qualche linea di febbre. Il
mio accordatore scuoteva la testa, con una confidenza
lieve affinata con gli anni e la consuetudine. Ma
quando comincia a riporre i suoi attrezzi, e lo fa con
calma, precisione e garbo, vuol dire che la visita è
terminata: per quel giorno ero stato viziato anche troppo.
Poi mi ha guardato, interrogativo: «Maestro, posso
confessarle una cosa?».
Il fatto che non osasse, che quasi esitasse, mi
incuriosiva.
«Certo, certo...», ho risposto fingendo distrazione,
mentre provavo la morbidezza del pedale di risonanza.
«Ho l'impressione che lei voglia quella nota imperfetta,
che lei cerchi a tutti i costi quel sottile fruscìo,
anche quando non c'è...»
L'ho fissato, muto, attento, forse anche con severità,
mentre lui continuava: «... in quel fruscìo lei cerca
l'imperfezione, e nell'imperfezione una forma della
libertà...».
Con quella nota, con quel terzo fa, inizia la coda
della quarta Ballata che Chopin dedicò a Solange
Dudevant.
Aveva ragione: soltanto un fruscìo mi ha liberato
da quell'affezione dell'anima, da quell'intreccio di
destini casuali che ho inseguito in tutti questi anni.
Così ho capito che il mondo è soltanto un fruscìo
impercettibile dentro una nota, dentro una vibrazione
perfetta.
E per la prima volta nella mia vita ho provato
sollievo.
FINE.