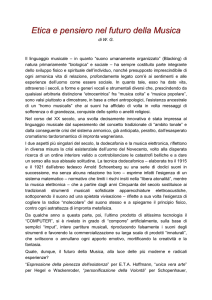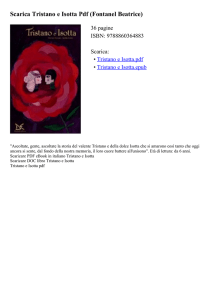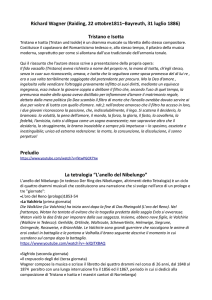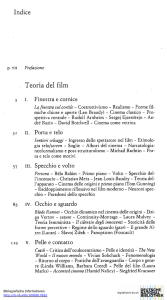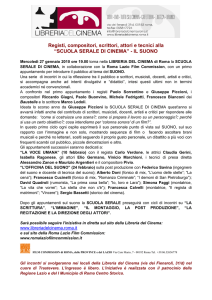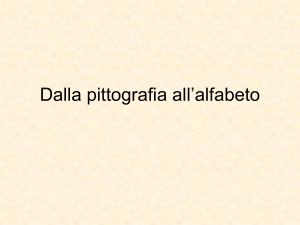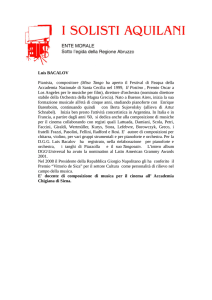La nota di Ernesto Di Marino
S
iamo reduci da
un’estate particolarmente fruttosa e felice che
ha visto la nostra programmazione - dodici
concerti nel Festival Paganiniano di Carro, tre
nel Festival Internazionale del Jazz e tre nella
rassegna I luoghi della
musica - premiata da un successo notevole; e questo successo riguarda sia il versante dell’affluenza
di pubblico, sia quello della critica degli addetti ai
lavori e non. Risultati, questi, non sempre semplici
da raggiungere contemporaneamente, ma che, di
sicuro, si raggiungono quando la programmazione
è di alta qualità. Tuttavia, basterà ricordare alcuni
nomi, tra quelli degli artisti impegnati in questa
estate 2008, per rendersi conto di quanto affermato: Mengla Wang, Herbie Hancok, Anna Tifu, Sergej Krylov, Bruno Canino, Alirio Diaz, Arnoldo Foà,
Gino Paoli, Diane Shuur, senza voler nulla togliere
a tutti gli altri ottimi strumentisti che ad essi hanno
fatto corona sono sicuramente nomi di rilievo internazionale.
Ma, esaurita l’onda dell’entusiasmo suscitato dalla
soddisfazione per la felice riuscita della campagna
estiva, già dobbiamo rivolgere il pensiero alla Stagione Invernale dei concerti che si svolgerà, com’è
tradizione, presso il Teatro Civico. Anche questo
segmento della nostra programmazione annuale
gode delle stesse attenzioni godute dagli altri cicli;
anzi, probabilmente viene realizzato con maggior
attenzione non foss’altro perchè, non essendo monografico, richiede accortezza nel dosare generi,
orchestre, solisti, strumenti...Tuttavia questa nostra
Stagione Invernale di concerti, fatte le debite proporzioni, non ha lo stesso riscontro che possiamo
verificare per i cicli estivi. E dire che prezzi contenuti, qualità della programmazione, uniti al vantaggio
dell’ascolto in teatro - ben più consono e appagante
dell’ascolto all’aperto - dovrebbero far sì che il pubblico accorresse ancor più numeroso che nelle manifestazioni estive. Il problema, a mio parere, non
risiede tanto nelle scelte artistiche, nella cadenza
delle manifestazioni o nell’assortimento del loro
genere, quanto piuttosto - ed è un tema sul quale ci
siamo già intrattenuti, ma saremo costretti anche a
ritornare - nella vivibilità della città. Lo spirito della
gita fuori porta, che anima i partecipanti alle manifestazioni estive, non è applicabile alla partecipazione
alle manifestazioni della stagione invernale. Quello
stesso appassionato di musica - perchè è bene sottolineare che le platee estive sono formate da veri
intenditori appassionati - che trova per sè stesso una
giustificazione per percorrere svariati chilometri ed
ascoltare un concerto all’aperto, non trova altrettanta giustificazione per uscire di casa nella stagione
invernale, dopo aver risolto il dilemma: mezzo pubblico o auto? (spesso il mezzo pubblico neanche c’è,
è per l’auto e stressante la ricerca di un parcheggio),
affrontare il clima non così invitante come d’estate e, finalmente, ascoltare un buon concerto nel
chiuso di un teatro acusticamente valido. Alla fine,
così com’è organizzata, è la città a render difficile
la fruizione della cultura, con buona pace della
funzione secolare che la città stessa ha svolto nella
civiltà occidentale. La città, che è il luogo fisico ove
risiedono gli strumenti della cultura - Istituti di alta
formazione, Istituzioni culturali, musei, biblioteche,
archivi, teatri...- non permette, a cagione della mancanza di una strutturazione finalizzata, il loro godimento, causando, così, una diseconomia davvero
macroscopica. Ma se grande è la sua dimensione
quantitativa, enorme è la dimensione sotto l’aspetto
sociale e culturale. Aspetto questo, da non sottovalutare, in quanto occorre considerare che la scuola
non può che fornire informazioni e strumenti adatti
all’approccio dei temi della cultura. E’, poi, durante
la vita di ciascuno di noi che quelle informazioni e
quegli strumenti vengono utilizzati per sviluppare
una crescita culturale, in senso vasto, che certo la
scuola, nei suoi tempi circoscritti, non può consentire. Se, però, il processo di acculturazione si ferma
alla prima fase - informazione e acquisizione degli
strumenti - gli effetti positivi che possono sortire,
tramite la loro fruizione, i presìdi culturali presenti
nella città vengono vanificati, impedendo la crescita
culturale e affievolendo anche l’effetto dell’inseminazione che una scuola seria abbia potuto realizzare. L’effetto ci appare deleterio: tanto da indurre
a chiederci se, così proseguendo, non causeremo
una controrivoluzione che non può portare se non
all’imbarbarimento dei nostri costumi.
Da pagina 2
AUTUNNO
INVERNO
2 0 0 8
I concerti
19
Giovedì 30 ottobre h. 10.30
Teatro Civico La Spezia
Concerto per le scuole
Orchestra del Teatro dell’Opera di
Zagabria
Gianluca Marcianò direttore
Giuseppe Bruno pianoforte
Musiche di W.A.Mozart, L.van Beethoven
Giovedì 30 ottobre h. 21.00
Teatro Civico La Spezia
Orchestra del Teatro dell’Opera di
Zagabria
Gianluca Marcianò direttore
Giuseppe Bruno pianoforte
Musiche di W.A.Mozart, L.van Beethoven
Mercoledi 12 novembre h. 21.00
La Spezia - Sala Dante
Ensemble del Conservatorio G.Puccini
della Spezia
Omaggio a Messiaen nel centenario della nascita
Musiche di autori contemporanei con una prima
esecuzione assoluta
Giovedi 13 novembre h. 10.30
La Spezia - Sala Dante
Concerto per le scuole
Caledonian companion
Musiche della tradizione celtica
Giovedì 4 dicembre h. 10.30
La Spezia - Sala Dante
Concerto per le scuole
La fiaba in musica
Ludwig van Beethoven
Parte la XL Stagione
C
on il mese di ottobre prossimo prenderà
il via la XL Stagione della Società dei Concerti onlus. Come prima cosa ci sia consentito, e
non già per volontà di autocelebrazione, di
considerare questo traguardo raggiunto un
traguardo di tutto rispetto. Quaranta stagioni consecutive significa aver saputo crescere,
adattarsi e rinnovarsi costantemente, così da
poter rimanere attuali e propositivi per un
periodo di tempo ragguardevole. Quarant’anni non sono lunghissimi ma, certamente, coprono la vita operativa di due generazioni; e
quelli che ci hanno preceduto non sono stati
quarant’anni qualsiasi. E’ stato un lasso di tempo che ci ha portato dagli anni Sessanta, con
tutte le problematiche di cui erano carichi, fin
dentro il terzo millennio, che di problematiche
ne apre delle nuove, ancora tutte da affrontare.
Ed il modo di affrontarle sarà determinato dalla Direzione artistica, nell’ambito delle risorse
che l’Istituzione sarà capace di acquisire e destinare, in massima parte - come è caratteritica
dei nostri bilanci - alle spese dirette per la produzione di concerti. I quali riprenderanno ad
ottobre prossimo - precisamente giovedì 30,
alle ore 21.00, al Teatro Civico - con l’esibizione dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Zagabria, diretta dal Maestro Gianluca Marcianò.
Con l’orchestra si esibirà il pianista Giuseppe
Bruno, in qualità di solista. La stessa formazione, la mattina dello stesso giorno, eseguirà
il primo concerto per le scuole della ripresa.
segue a pag. 5
Luigi Maio voce recitante
Enrico Grillotti pianoforte
Musiche di F.Poulenc, S.Prokofiev
Sabato 20 dicembre h. 21.00
La Spezia - Teatro Civico
Concerto Gospel
Talk of Da Town
Lunedì 22 dicembre h. 21.00
La Spezia - Chiesa di Sant’Agostino
Concerto di Natale
Gruppo 900 Vocalensemble
Massimo Peiretti direttore
Musiche di I.Stravinskij, F.Poulenc, A.Pärt,
C.Saint-Saëns, A.Dvorák, B.Mc Ferrin
Mercoledì 31 dicembre h. 20.30
La Spezia - Teatro Civico
Concerto di fine anno
Il Valzer e l’Operetta
Strauss Konzert Orchestra
Andrea Colombini direttore
2
di Giordano Giannini
Conversazione
con
Tomàs Sheridan
Come è nato questo progetto, Tom?
Due anni fa, ultimavo a Riomaggiore le riprese del mio lavoro di fine studi, un cortometraggio di finzione. Volevo girare il finale
sulla scogliera, così Alessandro Palermo,
che conosceva bene le Cinque Terre, mi
fece da guida. Fu lui a presentarmi Carlo
Roda. Era un suo caro amico, più di una volta collaborarono per l’allestimento di rassegne filmiche. Carlo rimase con noi sul set.
Mi raccontò la sua storia, i suoi trent’anni di
vita dedicati al cinema. A colpirmi fu soprattutto il suo carattere. Schivo, silenzioso ma
che lasciava intuire una grande esperienza.
Certo, in quel momento, la mia preoccupazione era finire il cortometraggio ma non dimenticai quell’incontro. Circa sei mesi dopo
tornai in Scozia dove partecipai come assistente alla realizzazione di altri film. All’inizio
è sempre così, si svolgono piccole occupazioni ma, allo stesso tempo, si acquisisce
maggiore esperienza sul campo. Sapevo di
un finanziamento che l’università metteva a
disposizione per eventuali ricerche e progetti dei neo-laureati. Coinvolsi Leo Bruges,
amico e compagno di corso (specializzato
in direzione della fotografia) e decisi di rivedere Carlo.
Immagino sia stato un intenso lavoro di
ricerca. Hai avuto delle difficoltà iniziali?
Si. L’assemblaggio del materiale occupò
ben diciotto mesi, utilizzai due terzi del finanziamento universitario. Contattai centri di attività culturale quali Bardonecchia,
Bologna. Ma non ottenni grandi consensi.
Fu una vera delusione. Nel novembre del
2007 scrissi alla G.M.A.C. (Glasgow Media
Access Center), un’organizzazione che gestisce fondi per sovvenzionare giovani registi. La selezione fu piuttosto dura: su circa
duecento progetti audiovisivi ne furono selezionati solo venti. Poi dieci, sei … infine, il
mio fu l’unico documentario ad essere stato
finanziato. Avevo le idee molto chiare su ciò
che volevo fare e ne ero orgoglioso.
Quando ho saputo che un giovane regista, tra l’altro non italiano, voleva realizzare un documentario su Carlo Roda ho
provato una grande soddisfazione. E un
po’ di curiosità. Qual è stata la sua reazione? Ha partecipato attivamente alle
riprese?
Beh, dire che ha partecipato è un eufemismo (ride). Il fatto stesso che abbia accettato, per me resta, tutt’ora, un mistero.
Qualche volta facevamo dell’umorismo per
rompere il ghiaccio, ma sentivo che lui provava un senso quasi di fastidio. Più di una
volta gli chiesi che cosa pensava del fatto
che qualcuno si interessasse a lui e alla sua
attività, ma rispondeva in modo evasivo. Al
massimo diceva che lo emozionava. Ma nulla più. Forse lo spingeva ancora l’amore per
il cinema. Forse era fiero di vedere lo stesso
sentimento in alcuni giovani, ragion per cui
non ci chiuse la porta in faccia. Al momento,
sono le uniche risposte che riesco a darmi.
Comunque, ha saputo trasmettervi il suo
amore per il cinema.
Senza dubbio. Conversando con noi, dimostrò la vasta conoscenza che aveva di
quest’arte. Non si limitava a guardare, sapeva toccare con mano. Di solito i cinefili
parlano dello stile, temi ricorrenti, contesto
culturale…lui no. La sua non era una conoscenza a sfondo accademico, preferiva
raccontare aneddoti legati alla produzione.
Interpretazioni personali, emotive. Sia sul cinema italiano che internazionale.
A proposito del cinema italiano, mi ricordo quando Carlo mi raccontò dell’esordio di Marco Bellocchio con “I pugni in
tasca” (1965). Giuseppe Lanci, direttore
della fotografia, era sommerso da richieste di ogni tipo. Sempre diverse, talvolta
improbabili. Non era certo l’autore per-
fezionista che oggi
possiamo ammirare.
Questo è un esempio
di come Carlo si avvicina al cinema. Gli
interessano soprattutto le relazioni umane.
A noi fece ascoltare
un’ intervista a Sergio
Leone sulla sua esperienza in America, registrata dalla radio.
Poi ci raccontò del
suo esordio, dell’introduzione delle pellicole in cinemascope.
Leone produsse degli
appositi fotogrammi
ristretti per risparmiare la metà dei costi: Roda ne aveva conservato un frammento in positivo.
I film di Andrej Tarkovskij trionfano spesso sui manifesti delle sue rassegne.
Carlo insisteva molto sul ruolo di fuga che
il cinema doveva ricoprire. Attraverso lo
schermo, lo spettatore viaggia nello Spazio
e nel Tempo. In Tarkovskij ricorrono costantemente visioni e ricordi. Entrambi preservano le emozioni. Non credo sia una scelta
casuale…
Negli ultimi tempi, molti spettatori uscivano dal Cinema Garibaldi lagnandosi
di come Carlo mantenesse la sala. Ne
avete mai parlato?
Ancora una volta, i clienti affezionati si
sono dimostrati più loquaci di lui (ride). Mi
riferivano di poltrone scomode, impianto di
riscaldamento mal funzionante, ma all’unanimità concludevano di non essere venuti
per divertirsi ma per vedere film che altrove
non avrebbero mai visto. L’amore per il cinema ha fatto passare il resto in secondo
piano.
Credi che la città della Spezia abbia
aiutato veramente Carlo Roda?
Molti hanno cercato di aiutarlo, ma, benché
sperasse nell’affetto dei suoi concittadini,
rimase una persona difficile da capire e
non tutti ebbero la pazienza necessaria. La
gente che ama il cinema ci sarà sempre,
ma quest’ultimo è per metà arte e per metà
business. Forse Carlo ha pensato che la
sua passione sarebbe stata sufficiente ma
il mercato contemporaneo non gli ha dato
ragione. Non mi sento di esprimere un giudizio di valore: La Spezia è una città che
presenta caratteristiche e difficoltà comuni
a tutte le città provinciali. Ad esempio il problema della gestione dello spazio. In essa
ho trovato una seconda casa. Ho conosciuto nuovi amici. Ho visto volti sfiduciati
e volti mossi da grande interesse come ad
esempio i giovani della Loggia dei Banchi.
Ricordiamo che è l’energia a muovere il
settore culturale e Carlo, da un po’ di tempo
si sentiva stanco.
Sono d’accordo. In molti spezzini è ancora forte il ricordo del Cinema Candor.
Gli amici di Carlo lo hanno menzionato?
Lo descrivono come l’epoca d’oro della sua
attività. Faceva quello che voleva, sempre
con grande entusiasmo. Lui non voleva ammetterlo, ma credo che il suo obiettivo fosse educare la gente per mezzo del cinema,
affinché non vada perduto. Il potenziale del
suo archivio era altissimo!
Come spettatore ho vissuto dolorosamente la chiusura del Garibaldi. E non
solo. Tra il 2002 e il 2004 abbiamo assistito a una vera e propria moria del
cinema in sala spezzino. Il primo fu il
Cinema Cozzani. Seguirono l’Odeon e la
Multisala Smeraldo. Anche in Scozia si
sono verificati fenomeni simili?
Si. Tutt’ora lavoro per il Cameo il cinema
d’essai più importante di Edimburgo. Una
vera istituzione. Dicono sia il cinema preferito da Quentin Tarantino. Forse perche fu
proprio al Festival di Edimburgo che presentò il suo primo film, Reservoir Dogs.
Pensa che telefonò al suo produttore affinché il Cameo si assicurasse almeno una
copia di Death proof (ride), la sua ultima
fatica. Insomma, poco tempo fa la sala stava per chiudere. Volevano trasformarla in
un ristorante a tema cinematografico. Ci
fu una reazione incredibile da parte della
popolazione. C’era da aspettarselo da una
città piena di studenti e manifestazioni cul-
19
turali! Il comune collassò per la mole di proteste! Venne fondata l’Associazione Amici
del Cameo. L’acquirente rinunciò e la sala
riprese la programmazione anche se parallela al mercato corrente. Il Film House,
legato al British Film Institute, è un altro
punto di riferimento per i cinefili di Edimburgo. Ogni anno accoglie molte pellicole
restaurate ottenendo un discreto successo. Certo, deve fare i conti con la realtà dei
Multiplex. D’altronde è un segno dei tempi.
Così come i piccoli esercizi di artigianato lasciano gradualmente il posto ai grandi mercati. Lo stesso Roda lo ha descritto come
un processo inevitabile: la costruzione del
Megacine alla Spezia non è stata la causa
principale della chiusura del Garibaldi e altre sale, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Quali sono i registi che ti hanno influenzato maggiormente?
Ho tratto insegnamenti da molte arti che ricorrono a immagini in movimento. Video, installazioni… Sicuramente ho imparato molto da Stanley Kubrick, dall’importanza che
ha attribuito alla parola scritta. Non ha mai
fatto film dello stesso genere e ciascun film
è il più importante del suo genere. Shining
per l’horror, 2001-Odissea nello Spazio per
la fantascienza e Paths of glory per il cinema bellico. Ammiro i fratelli Coen, hanno il
controllo totale della macchina-cinema. Io,
al contrario, scopro i miei film mentre li sto
facendo. Ho seguito con interesse la nuova
ondata polacca degli anni ’60, i primi film di
Roman Polanski… il mio obiettivo è riuscire
a comunicare distintamente un messaggio,
non sovraccaricarlo con le parole perche il
cinema è soprattutto comunicazione visiva.
Questo determina, a parer mio, la differenza
tra linguaggio televisivo e cinematografico.
Dunque, miri a un equilibrio. Mi tornano
in mente registi come Dreyer, Bergman.
Oppure gli ultimi film di Bresson, in
modo particolare la sequenza dell’aggressione ne “L’argent”: niente movimenti di macchina accentuativi, dettagli
o gesti espressivi. Solo la parola-chiave
o l’immagine nella sua pura manifestazione.
Precisamente.
Cosa ne pensi della recente produzione
filmica italiana?
A Edimburgo si svolge regolarmente un festival dedicato al cinema italiano. Ho conosciuto Paolo Sorrentino, abbiamo parlato a
lungo. Ho visto tutti i suoi film e mi sono piaciuti. Ho apprezzato anche La sconosciuta
di Tornatore. C’è qualcosa di inspiegabile
nel vostro cinema eppure immediatamente
riconoscibile. E’ come se la gente parlasse
con le mani. Non so se tutti all’estero sono
in grado di percepirlo. Ho vissuto molti anni
a Torino, ma mi è sempre mancato di viaggiare più assiduamente nel vostro paese.
Tornando a Carlo, pensi che riuscirà a
riprendere la sua attività?
Molte volte gli ho fatto la stessa identica
domanda. Lui, ogni volta, con la stessa
flemma rispondeva vedremo… Quando iniziai questo cammino volevo egoisticamente
che Carlo emergesse come un eroe non
riconosciuto dalla sua città, un sognatore
tenace che aveva battuto la testa contro il
muro. Poi ho capito che la sua apparente
malinconia celava un’inaspettata serenità.
Vuole solo ritirare il suo pensionamento e
godersi il meritato riposo fuori di città. Non
ha molti rimpianti. Ha accettato che il cinema non è più come prima, si ritiene un
elemento del cinema del passato. Come la
pellicola.
Qui si conclude la conversazione con Tom.
Come nota personale, concludo dichiarando la mia soddisfazione per aver incontrato
questo giovane regista e aver partecipato,
seppur per poche ore, alla sua indagine
appassionata e sincera. Mi rivolgo a Carlo
Roda, consapevole, nella mia piccola veste
di spettatore, di averlo trascurato nell’ora
più nera della sua attività. In nome della
forza scandalosa di Bresson, Kieslowski,
Buñuel… perfettamente in grado di rispondere all’onda putrescente del mercato odierno, dell’amicizia che ti lega a molte
persone… Torna. Con affetto.
Tomàs Sheridan ha 25 anni. Ha concluso da un
anno gli studi alla facoltà di Fotografia e Cinema
presso la Napier University di Edimburgo. Ora è un
film maker ricco di zelo e passione, che ha all’attivo alcuni cortometraggi, fiction e documentari.
Ha terminato le riprese del suo nuovo lavoro: uno
sguardo sull’Archivio di Carlo Roda, noto cinefilo e
operatore culrurale spezzino.
di Annalisa Stretti
libri
…Dimmi qualcosa…
E’ la prima notte di nozze di Edward e Florence, è il 1962, l’anno pre-rivoluzione sessuale, siamo a Chesil Beach e Florence
Non aveva mai immaginato che i preliminari d’amore potessero aver luogo in una
scena muta, circondati da un silenzio così
intenso.
…Dimmi qualcosa…, così Florence rompe l’ansioso silenzio generato dalla nuova e
troppa vicinanza dei due corpi.
Sarà perché questa frase mi è familiare…
ma quanta forza, desiderio, emozione, tensione, speranza ci sono in queste due parole!?
Florence è una promettente violinista, sognatrice, determinata e delicata. Edward è
un altrettanto promettente storico che sa
emergere da una famiglia non semplice.
Edward e Florence sono acuti e sensibili,
pieni di sogni raccontati.
Edward e Florence si amano moltissimo, si
sfiorano, dividono una storia fatta anche di
momenti di pura e commovente intensità.
Edward e Florence si sposano. Edward e
Florence riescono a perdersi.
Non posso non sentire, mentre ripercorro
la storia, il rumore delle onde, e non posso
non immaginare la battigia di Chesil Beach
e l’albergo a sud di Abbotsbury, nel Dorset.
Allo stesso tempo di questo romanzo mi affascina la creazione di quadri narrativi veloci, intensi e fortemente autonomi; le vite dei
due, gli spaccati familiari, le immagini pungenti dei ricordi che, come in un abbraccio,
gravitano attorno al nucleo centrale della
storia: l’iniziazione sessuale di una giovane
coppia e il suo destino.
Perché Edward e Florence, anime vicinis-
19 3
di Gisa di Janni Caramiello
cinema
Chesil Beach
AutoreMcEwan Ian
Prezzo15,50
Anno 2007
Pagine 136
Traduttore Basso S.
EditoreEinaudi
Collana Supercoralli
sime, sono corpi sconosciuti. Non si sono
mai scoperti non sanno comunicarsi i più
reconditi desideri e le più grandi paure…
Un’abile violinista ed un arguto storico,
ricchi di qualità, lei di ottima famiglia, lui di
estrazione modesta, arrivano a loro durante
il gioco dell’amore a cui sono estranei!
Forse Edward ha più desiderio di Florence?!
Forse Florence scopre su quel letto nunziale il suo carattere e il suo sentire… Da lì
si genera l’ineluttabile verità di …come il
corso di tutta una vita può dipendere dal
non fare qualcosa…
Ian McEwan racconta una verità (che può
sembrare scontata), e lo fa con una scrittura conquistante, puntuale, ricca e mai
oppressiva. Scrive della non conoscenza,
del non scambio, del non ascolto. Scrive di
verità dette, ma travestite di strategie che
falsano e non perdonano, per paura, per
orgoglio per accecamento. Scrive del generarsi della rabbia che passa all’inadeguatezza, all’amarezza, in un circolo perverso e
distruttivo, ma che paradossalmente svanirebbe con un solo segno. Al termine della
storia mi rimane la cullante malinconia dei
ricordi Di quando in quando, si trovava a
una biforcazione nel fitto bosco e gli capitava di pensare che in quel punto Florence doveva essersi fermata a consultare la
carta quella mattina di agosto… riusciva
a vederla risoluta ad andarlo a trovare. O
magari si fermava a guardare il panorama
della Stonor Valley e si chiedeva se era li
che Florence si era mangiata l’arancia. ma
anche la speranza per quella via di salvezza narrata attraverso il compiersi della storia
dei due, applicabile al destino di ognuno.
Ian McEwan (1948, Aldershott) ha scritto
nove romanzi, due raccolte di racconti ed
un libro per ragazzi. Vive a Londra.
TOPCINQUE
i più letti al 20.9.2008
FALLACI ORIANA
UN CAPPELLO PIENO DI
CILIEGE RIZZOLI
GIORDANO PAOLO
LA SOLITUDINE DEI NUMERI
PRIMI MONDADORI
BARBERY MURIEL
L’ELEGANZA DEL RICCIO E/O
PAUSCH RANDY; ZASLOW JEFFREY
L’ULTIMA LEZIONE. LA VITA
SPIEGATA DA UN UOMO CHE
MUORE RIZZOLI
SAVIANO ROBERTO
GOMORRAVIAGGIO NELL’IMPERO ECONOMICO E NEL SOGNO DI DOMINIO DELLA
CAMORRA MONDADORI
Russo d’origine, ma nato a Le Pec nel 1908,
Jacques Tati, pseudonimo di Jacques Tatischeff, inizialmente abile animatore di circo, mimo dilettante ed attore di un musical
professionista, approderà al cortometraggio, dal ‘31al ‘38 come imitatore dei gesti
e comportamenti tipici degli sport moderni,
dal pugilato al tennis, così da venir definito
comico di situazione o comico visivo, proprio per quella serie di sketch puramente
mimici che allora amava portare sulla scena. Mimica comica che abbandonerà invece
nel ‘47 quando affronterà il cinema-cinema
da costringerlo quindi a fare uscire il film in
bianco e nero, rimandando al ‘61 le scene
colorate, se pur fotogramma per fotogramma (sarà poi dal 10 gennaio del ‘95 che il
film potrà essere proiettato nella sua integrità cromatica.) Campi lunghi e profondità
di campo, per consentire con efficacia la
sua arte della gag, il personaggio di Tati
diverrà riconoscibile non solo per i baffi
scomposti e la figura allampanata, ma anche per quei pantaloni troppo corti e quella
voluta goffaggine che, con pipa impermeabile ed ombrello, potrà rimandarci ora alla
bombetta di Charlot, ora agli occhiali di
Harold Lloyd, ora al cappelletto di Buster
Ketaon. Sarà così che si presenterà nel
1953 il protagonista di quel Le Vacances
de Monsieur Hulot dove Hulot-Tati, calzini
a righe auto scoppiettante e racchetta da
tennis vecchio stile, vagherà per le spiagge
bretoni, personaggio lunare, malinconico e
silenzioso, in un insistito affondamento di
compongono la scena, e perchè la comicità possa attuarsi dentro una cornice
più ampia, e le azioni parallele frazionarsi
e moltiplicarsi, Playtime sembrava aprire,
in maniera astratta e straniante, la strada
al futuro audiovisivo, in una Parigi astratta
e straniante, dove persone suoni e parole
finivano per rinnovarsi in un disordine ordinato, sempre ai limiti di una rottura, peraltro mai avvenuta.
Scenografia così complessa e destabilizzante da provocare non solo scarsi incassi
ma anche una tale ostilità da parte della
critica da costringere Tati a ridurre la versione originale da 152 a 122 minuti.
Ma Playtime, film manifesto della poetica
di Tati, era già il Futuro, e proprio perchè
Futuro non fu capito. E soltanto negli anni
a seguire dopo che nel ‘71 il regista fu costretto a girare Trafic (Monsieur Hulot nel
caos del traffico) per riproporre, con risultati
ripetitivi, il M. Hulot in lotta con la mostruosità della meccanica
- soltanto allora Playtime, uscito nuovamente
nelle sale, comincerà
a conquistare il pubblico, e soprattutto quello
giovanile. Sarà poi il suo
ultimo film, Parade (Il
Circo di Tati), a riportare nel ‘74 Tati agli stadi
iniziali della sua carriera,
nelle riproposizione di
quella serie di sketch
puramente mimici che
all’inizio, e per quindici
anni, aveva portato sulla scena prima di girare
i lungometraggi. E con
Parade - girato con più
telecamere in video, e trasferita poi l’immagine su celluloide a 35 mm - Tati arriverà
ad immaginare, nei primi mesi del ‘73, quel
nuovo cinema elettronico di cui soltanto
molti anni dopo i grandi autori del cinema
mondiale riusciranno a scoprire quanto
fosse da privilegiare rispetto all’immagine
tradizionale. Visto tuttavia come film della
crisi o dell’esilio (fu girato in Svezia per
superare i problemi produttivi successivi
a Playtime), Parade, come già Playtime,
non solo riuscirà ad avvicinarsi, in maniera
quasi visionaria, al futuro dell’audiovisivo,
ma anche, opera sperimentale ed aperta,
a metà strada tra una scena da circo edun
set tv, riuscirà a diventare un documento
sulla scomparsa del circo e del music-hall.
Quasi che Tati, giunto alla fine del suo lavoro, volesse ristabilire un rapporto familiare con il suo pubblico più antico, forse nella malinconica ricerca di una spontaneità
perduta.
Jacques Tati
cent’anni dalla
nascita
con il suo primo lungometraggio, quel Juor
de fête che, se pur girato nel ‘47’, uscirà nelle sale solo nel ‘49’. Sarà qui che nel contrasto tra passato e futuro, nascerà la comicità
delle suoe gag nel personaggio del postino
di un paesotto della provincia francese che,
nel giorno della festa di Sainte-Sevère-surIndre, per celebrare la liberazione, ammaestrato da un cinegiornale sul dinamismo del
servizio postale americano, invano cercherà
di imitarne la velocità nella consegna delle
lettere, irrimediabilmente bloccato, non solo
dalla sua collocazione paesana, ma anche
dall’uso della bicicletta come suo unico
mezzo di trasporto. Tra comicità e poesia,
sulla scia del bourlesque, ora pietrificato
alla Buster Keaton, ora surreale alla maniera dei fratelli Marx, ma sempre innovandolo
e personalizzandolo il film, se pur premiato
alla Mostra del Cinema di Venezia per la
migliore sceneggiatura, sarà bloccato nella
distribuzione perchè considerato sperimentale, e solo in un secondo momento sarà
accettato nel circuito commerciale. Omaggio all’incapace ed all’inadeguato, Jour de
fête avrebbe dovuto essere il primo film a
colori del cinema francese, ma, per difendere la francesità, in contrasto con il luccicare
delle forti tinte del cinema della modernità (il tecnicolor), Tati userà un sistema così
obsoleto di riproduzione del colore, da non
permettere di proiettarne copie a colori e
tutta quella ritualità codificata, tipica della
piccola borghesia francese. Rarefatto e
refrattario a qualunque legame, timido e
maldestro, Hulot finirà per diventare una
sorta di antipersonaggio che vaga in un
mondo così in disordine da spostare l’attenzione dello spettatore dal comico del
personaggio al comico del mondo. Satira del mondo moderno che continuerà nel
‘58 con Mon Oncle, Oscar per il Miglior
Film Straniero e Gran Premio della Giuria
al Festival di Cannes, un Hulot che si aggira sullo schermo tanto pronto a coprire
le monellerie del nipote quanto a ridicolizzare le assurde tecnologie domestiche di
villetta giardino e garage dei suoi parenti
borghesi. E nel suo discorso sulla modernità, in una sorta di prima critica della società francese del dopoguerra, Tati finirà
per creare, quasi inconsciamente, un certo
neorealismo fantastico che, nel mostrare
la follia dei tempi moderni, voleva evidenziare il vuoto e l’inumanità del presente, in
una immensa nostalgia del muto, sempre
messo in risalto dalla crudeltà del sonoro.
Ci vorranno dieci anni perchè Tati possa
realizzare nel ‘67 quel Playtime (Tempo
di divertimento) che, se pur all’epoca non
compreso, rappresenterà una rivoluzione
nel cinema moderno.
Formato amplificato a 70 mm per aumentare la definizione degli elementi che
TOPCINQUE
i più visti al 20.9.2008
Kung Fu Panda
Le Cronache di Narnia:
Il principe Caspian
Doomsday
Piacere Dave
Il cavaliere oscuro
4
Tristano
Da Maria di Francia a Wagner
L
e opere che narrano la storia di Tristano, come manifestazione di quell’amor
cortese che si afferma
nelle corti europee
del XII secolo, formano un panorama con
lacune importanti nel
periodo iniziale, per
cui si parla di un Tristano di Chrétien de Troyes (fiorito nel 1170-’90)
andato perduto, e vi sono cenni a un possibile
Tristano provenzale, che proverebbe la forza attrattiva di questo personaggio fin negli àmbiti del
Mediterraneo. I testi che ci sono giunti iniziano
con un lai [motivo musicale, ma anche breve narrazione o poesia lirica, che poteva essere cantata]
della dolce Maria di Francia (fiorita nel 1160-’90),
quello del Chievrefoil [caprifoglio], di poco più
di un centinaio di versi, che narra come Marco,
re di Cornovaglia, irato contro il nipote Tristano,
per l’amore del giovane verso la regina Isotta la
bionda, lo avesse esiliato. Tristano se n’era andato nel Galles meridionale, suo paese natale, e
dopo circa un anno era tornato di nascosto. Informatosi sui movimenti della corte, si era posto sul
cammino di questa, incidendo il proprio nome su
di un ramoscello di nocciolo, che la regina andando a cavallo aveva visto, intuendo la presenza del
giovane, e con lui si era incontrata, presagendo
il perdono del re, già pentito di aver punito così
severamente il nipote, a causa, diceva, di accuse
mossegli da altri. Caprifoglio perché se si scioglie
tale liana dal ramo cui si avvolge, ramo e liana
muoiono, come avvenne ai due amanti di questa
storia.
Contemporaneamente al breve racconto di Maria, si hanno spezzoni della storia per circa tremila versi del francese Thomas (fiorito intorno al
1160) che costituiscono la versione più consona
al sentire cortese della Francia settentrionale di
quell’epoca. Altri frammenti ci giungono da Eilhart von Oberge (1170-’75), tedesco settentrionale, che poco rende dell’atmosfera tragica e
appassionata della vicenda; e da Béroul, francese della seconda metà del XII secolo, del quale
ci sono giunti circa quttromilacinquecento versi,
considerati, con quelli di Oberge, la versione antica della vicenda. Thomas invece si libera della
ingombrante eredità del romanzo arturiano, a cui
spesso la vicenda tristaniana veniva intrecciata,
ponendo l’azione del proprio poema una generazione dopo quella di re Artù e della Tavola rotonda. Quanto ci rimane del suo Tristano contiene
alcuni dei momenti culminanti del romanzo; tra
di essi il matrimonio di Tristano che, disperato
per non potere avere Isotta la bionda, moglie di
re Marco, si sposa con un’altra Isotta, Isotta dalle
bianche mani. Ma una volta fatto ciò s’accorge che
non potrà mai accostarla e possederla perché il
filtro che egli e la prima Isotta avevano per errore bevuto gli impedirà di avere rapporti d’amore
con qualsiasi altra donna che non sia la regina.
L’altro episodio è quello finale. Tristano viene ferito da una lancia avvelenata, e potrà guarire solo
per mezzo di un balsamo che la regina Isotta la
bionda possiede. Riesce comunque ad inviare alla
regina la sua richiesta d’aiuto: la regina risponde
alla chiamata partendo col balsamo, se non che la
legittima moglie di Tristano, Isotta dalle bianche
mani, avendo scoperto questa richiesta d’aiuto
del marito alla sua regale rivale, quando vede
giungere la nave, dice che essa ha le vele nere,
segnale che il balsamo salvatore non è giunto. Tristano smette di lottare contro la malattia e muore,
seguito poco dopo, in questo destino, dalla regina
Isotta che, sbarcata e vistolo morto, lo abbraccia
senza potergli sopravvivere.
Con Béroul, seconda metà del XII secolo, siamo
ancora in piena epoca arturiana, e invero Artù
prende parte ad alcune vicende della narrazione.
Ma anche la morale qui decisamente fallisce: Isotta tradisce apertamente re Marco con Tristano, e
diventa blasfema, equivocando sul significato delle frasi che usa nel fare giuramenti sacri sulla propria innocenza. A parte questo, lo stesso racconto
è ancora pieno di avventure, scontri, minacce,
travestimenti, violenze laddove la poesia cortese è interessata ai sentimenti, al corteggiamento
galante. Con il frammento di Béroul, che conta
poco meno di cinquemila ottonari, si chiude la
prima fase della leggenda tristaniana.
Gottfried von Strassburg è colui che viene accreditato di aver dato la forma classica a questa storia
con il suo Tristan und Isolde. Di questo poeta
alsaziano non si sa praticamente nulla. Fiorisce
intorno al 1210, e viene immaginato come artista
che si rivolge a una classe mercantile in fase di
arricchimento, giunta ormai alla parte alta della
scala sociale, con bisogni di raffinamenti e preziosità estetiche. E certo, egli ha prodotto uno dei
massimi racconti poetici, da Virgilio - come è stato
detto - ai giorni nostri. La sua fonte è il Tristano di
Thomas. Portroppo Gottfried morì prima di finire
il proprio poema, che consta di quasi ventimila
versi, giungendo a circa un sesto dalla fine. Una
delle soluzioni che alcuni moderni hanno divisato
per dare completezza alla sua storia è di pubblicare il poema di Gottfried, seguito dai frammenti
del Tristano di Thomas che, come abbiamo visto,
descrive la storia e, in particolare, la fine dei due
amanti.
Il maggiore dei romanzi tristaniani, che seguono
il periodo medioevale, è The Book of Sir Tristram
de Lyones di Sir Thomas Malory, che scrisse questo, assieme a vari romanzi della Tavola Rotonda,
in cella per violenza, furto e stupro, con date
biografiche incerte, salvo quella della morte, av-
venuta in prigione nel 1471. Malory è colui che
prende il ciclo arturiano e lo porta all’epoca moderna. Ovviamente egli trae molto dai racconti
che lo precedono, in particolare dalla tradizione
cavalleresca francese, ma dalla massa di quelle
narrazioni riesce a creare storie complesse e coerenti, appassionatamente leggibili ancor oggi. Il
Tristano che egli crea è sfortunato e generoso. Alla
nascita, sua madre Elyzabeth - sposa di Melyodas
re di Lyones, e sorella di Marco re di Cornovaglia
- muore di parto, ed è lei che, morendo, gli attribuisce il nome che porta. Quando dopo sette
anni re Melyodas si risposa, la nuova moglie gli dà
un figlio e, per assicurarne la successione al trono,
cerca anche di avvelenare Tristano, riuscendo solo
ad avvelenare il proprio figlio. E poiché il re, scoperte queste malefatte, invia al rogo la donna, a
salvarla è il fanciullo Tristano, che generosamente
implora il re di non dar corso alla condanna. Ma
è la sua incapacità di conseguire la felicità, che ne
informa il destino: di avere amore contrastato con
la donna che ama perché moglie di re Marco, suo
zio. E di non potere accostare altra donna perché
il filtro d’amore che ha bevuto gli rende possibile
di andare solo con la donna, la regina appunto,
che con lui ha bevuto il filtro. Non è possibile
qui seguire le folte trecento pagine di questa storia, che riesce a dare sostanza narrativa di grande
passionalità a uno dei personaggi che, per certi
aspetti, anticipa un’altra grande e tragica figura
della letteratura inglese, il principe Amleto.
Possiamo così passare al Tristan und Isolde di Richard Wagner, elaborato tra il 1857 e il 1859, con
la prima a Monaco nel 1865. Legato alle necessità
della rappresentazione teatrale, Wagner ha scelto
tre momenti topici della vicenda: il primo atto
si svolge sulla nave, al comando di Tristano, che
porta Isotta in Cornovaglia, come promessa sposa di re Marco. La giovane donna, disperata per
questa soluzione della propria vita, decide di por
fine alla storia bevendo, e facendo bere a Tristano, un veleno. Senonché la sua ancella Brangäne,
inorridita da tale soluzione, scambia il veleno con
una pozione d’amore, che rivelerà ai due giovani
di essere ineluttabilmente legati. Il secondo atto,
che si svolge nell’àmbito della reggia di re Marco,
vede un incontro notturno di Tristano e Isotta che
si comportano come se una follia amorosa, intrisa
di pulsioni di morte, li avesse presi. La scena è interrotta dall’irrompere di un gruppo di cacciatori,
con re Marco e Melot: quest’ultimo, fingendosi
amico di Tristano, è in realtà inteso alla sua rovina. Re Marco lamenta il tradimento di Tristano; i
due amanti si dichiarano pronti a un destino di
morte ma, dopo aver provocato Melot a un duello, Tristano non si difende e viene ferito. Il terzo
atto si svolge in Bretagna, nel giardino del castello
di Tristano, ferito. Il fedele Kurwenal, autore del
suo salvataggio, lo informa di aver chiesto l’aiuto
di Isotta, che sta per giungere su di un vascello
per guarirlo. Giunge il vascello e i due amanti si
abbracciano, ma ormai Tristano, allo stremo, muore, mentre Isotta gli sviene accanto. È intanto annunciato l’arrivo di un’altra nave, dalla quale scendono Melot e re Marco. Quest’ultimo, informato
della pozione amorosa, è venuto per perdonare
il nipote, ma negli scontri che seguono, Melot è
ucciso da Kurwenal, il quale sarà anch’egli ferito
a morte. L’ultima scena vede Isotta, che rinviene
per dichiarare ancora il suo amore per Tristano e
morire tra le braccia di Brangäne. L’opera si chiude con re Marco, che benedice le vittime di questa storia tragica.
È inevitabile che le vicende così descritte inaridiscano i propri temi ma, effettivamente, la sostanza della tragedia wagneriana è data dalla musica,
la quale si inscrive in un romanticismo intriso di
potenza e decadenza, amore e morte, tale che,
per spiegarlo, i critici si sono rifatti a nomi illustri:
Calderòn, Kant, Schopenhauer, Schiller, Novalis...
Ad essi si può aggiungere Thomas Mann, che su
Wagner ha scritto un saggio forse più vicino alla
nostra sensibilità. Mann è anche autore di una
novella, Tristano, in cui la musica di Wagner costituisce il fattore culminante e risolutivo del racconto. Nell’Ottocento altri si sono cimentati nella
narrazione di questa vicenda; tra di essi Matthew
Arnold, autore di un Tristram and Iseult, 1852; e
A.C. Swinburne, che nel 1882 produsse Tristram
of Lyonesse, rivisitazioni lontane dal nerbo lirico
e tragico che Wagner e altri hanno saputo darle
nei mille anni di storia in cui si svolge.
Spartaco Gamberini
Festival di Carro
Paganini
promosso
L’
ormai tradizionale
appuntamento
estivo
con il Festival Paganiniano di Carro (svoltosi dal
19 luglio al 14 agosto in
diverse località della val
di Vara) ci ha permesso,
oltre ad approfondire la
nostra conoscenza della
geografia, enogastronomia, delle tradizioni e dei modi d’essere liguri, di
trovarci davanti a eventi musicali di inusuale e smagliante bellezza e di altissima e indiscutibile qualità.
Vogliamo con queste righe lasciare una testimonianza tanto breve quanto sentita di tre di questi indimenticabili concerti.
Nella serata inaugurale (svoltasi, come il concerto di
chiusura, nella piazzetta antistante la chiesa di Carro) il ventottenne Mengla Huang, nato a Shanghai e
vincitore del Premio Paganini 2002, ha scelto un variegato programma che comprendeva non solo brani di bravura (Tartini, Sarasate e la Polacca Brillante
op.4 di Wieniawski), ma anche pezzi di notevole
densità musicale come la Sonata n. 4 di Beethoven
e, soprattutto, la Sonata per violino e pianoforte in
Re minore op. 65 di Camille Saint-Saens. Questa sonata ha un doppio fascino: ci presenta Saint-Saens in
una veste solida, seria - oseremo dire beethoveniana
-, e con risvolti compositivi particolarmente complessi - notevole l’uso della struttura ciclica -; una
veste molto diversa da quella ironica e fiabesca alla
quale ci hanno abituato la Danza Macabra e Il Carnevale degli Animali. D’altra parte, questo pezzo è
diventato uno dei temi basilari di uno dei libri più
importanti della letteratura mondiale: Alla ricerca
del tempo perduto di Marcel Proust. Patito dell’allora avanguardia di Wagner e Debussy, Proust odiava
Saint Saens, e non solo per motivi musicali... ma anche per la passione scattata tra il vecchio maestro e il
suo giovane e brillante allievo Reynaldo Hahn, uscito
poco prima da un tormentato sodalizio con Proust.
Comunque Reynaldo insistette a suonare per Proust
i pezzi di Saint-Saens, e - ironie del destino - il secondo tema del primo movimento della Prima Sonata
diventò la petite phrase della Sonata di Vinteuil, uno
dei leit-motivs del monumentale romanzo di Proust
e tessera fondamentale nel concetto di memoria
proustiana. Mengla Huang affrontò questo difficilissimo pezzo con grande fluidità e con un suono
suadente e voluttuoso, quasi da vocalise. Oltre alla
bravura del giovane violinista, è il caso di sottolineare la stupenda performance del pianista Giovanni
Casella, imprescindibile per la riuscita musicale di
un programma tanto rischioso tecnicamente come
esigente musicalmente.
Non esitiamo a qualificare la serata dell’11 agosto
presso l’Oratorio di Sant’Erasmo a Bonassola come
un evento storico. Nella prima parte Senio Dìaz, i
cui insegnamenti hanno formato la quasi totalità dei
chitarristi italiani delle nuove generazioni, ha dato
mostra del suo virtuosismo deciso e forte - suona
la chitarra come fosse uno Steinway - con brani di
Albèniz e Granados, il tanto delizioso quanto impegnativo Andantino variato di Paganini, e tre
pezzi del raramente eseguito Platero y Yo di Mario
Castelnuovo-Tedesco, compositore le cui lodi non
smetteremo mai di cantare. Ma il fulcro della serata è stata la seconda parte, in cui Senio (Figlio di
gatto, cacciatore di topi, si dice in Venezuela) ha
unito la sua grinta musicale con quella di suo padre
il leggendario Alirio Dìaz, il più grande chitarrista
vivente.
Alla soglia degli ottantacinque anni, Alirio è, con Julian Bream e John Williams, il decano di una triade
fondamentale per la storia della chitarra nel Novecento. Oltre alla sua tecnica robusta e precisa - che
gli permise di diventare assistente e successore di
segue a pag. 8
5
Strauss, Bach
segue da pag.1
Armonie di vita infinita
U
n paio d’anni fa,
dovendo trattare sulle
colonne del Rigo musicale il tema della musica di Strauss, ho fatto
ricorso alla scelta estetica del regista Stanley
Kubrick di commentare l’ipnotica sequenza
iniziale del film 2001:
Odissea dello spazio col
supporto musicale di un valzer di Strauss. Dicevo
allora che l’intuizione era assolutamente geniale,
poiché il film doveva trascinare nella fascinazione
di un’intelligenza astratta e disincarnata, così che
le armonie siderali trovavano nell’eleganza di quel
valzer un elemento primordiale che era
conato gioioso all’esistenza oggettiva,
e restava infinitamente lontano
delle vicende tortuose della
soggettività umana.
Per questo - dicevo anche - non
sarebbe risultato più adeguato né un
corale di Bach, nel quale l’armonia
cosmica è filtrata da una spiritualità pregna della vivente intuizione
del divino, né un brano atonale
dodecafonico, nel quale l’accento sarebbe passato su una
spiritualità negata e lacerata,
ma lasciando in entrambi i
casi inespressa quella pura
e impalpabile gioia oggettiva
dell’essere elementare.
Credo anche ora che questo sia
più o meno vero. Tuttavia mi è
capitato di rivedere in televisione quel Solaris di Andrej
Tarkovskij che al tempo del
film di Kubrick era noto come
la risposta della fantascienza russa - dunque della
cultura che allora si proponeva come alternativa a
quella dell’Occidente - appunto a quel film e alla
concezione dell’esistenza ad esso sottesa.
Mentre il film di Kubrick prendeva avvio dalle origini del mondo e raccontava l’avventura dell’intelligenza affascinata dal misterioso monolite che
già attraeva e spaventava gli uomini-scimmia e che
ancora dominava il futuro indeterminato nel quale
il protagonista, perso il controllo della navicella, si
trovava proiettato, il film di Tarkovskij immaginava
che in una delle tante spedizioni spaziali si fosse
scoperto l’oceano vivente denominato Solaris, il
quale aveva l’altrettanto misterioso potere di entrare in contatto con chi gli si avvicinava ricostruendo
materialmente le immagini della sua memoria e facendone per così dire omaggio all’ospite. Si determinava così la presenza inquietante di doppioni di
persone reali anche già morte, com’è il caso della
moglie del protagonista, e per lo spettatore sorgeva il senso struggente della pietas per la sofferenza
di queste persone riprodotte, la cui coscienza era
piena di tutti i sentimenti degli originali, ma anche
faceva loro avvertire la propria inautenticità, facendole sentire diverse, e come tali più o meno inconsciamente rifiutate.
Entrare in questo groviglio filosofico non è cosa
che possa essere qui tentata, ma neanche volevo
farlo, limitandomi ad una riflessione sui commenti
musicali. Via via che il protagonista, restando sulla
stazione spaziale prossima a Solaris, entra come gli
altri in una relazione più stretta con questa entità
che in fondo cerca di essere benefica, si vede restituire da lei, tramite la sua stessa memoria, la realtà
più profonda della sua vita, che si traduce nell’immagine finale del ritorno alla casa del padre, vicino
a una palude piena di muffe, muschi, nebbie e rugiada. Ebbene, in tutte le sequenze della memoria
che come fili di una ragnatela finiscono per tessere
la rete del senso, il commento musicale, sovrapposto a immagini della grande pittura fiamminga, è il
corale di Bach Ich ruf ’ zu dir, Herr Jesu Christ; ciò
che ha sicuramente accresciuto la mia emozione nel
rivedere quel vecchio film.
Allora: perché in un caso Strauss e nell’altro Bach?
Il fatto è che i due film erano effettivamente, in un
certo senso, dei manifesti culturali contrapposti
(anche se Tarkovskij c’entrava ben poco con l’effettiva realtà sovietica, e l’antitesi era dovuta probabilmente solo alla sensibilità del regista, simmetrica rispetto a quella di Kubrick). Per il primo
modello l’intelligenza è asciutta e astratta, ed ha a
che vedere con gli enti disincarnati della scienza
sperimentale. Per il secondo l’intelligenza è umida e concreta, ed ha a che vedere con la sapienza
del mondo della vita (cioè quel Lebenswelt il cui
recupero, secondo l’analisi del filosofo Edmund
Husserl, costituisce l’unica possibilità della rinascita dell’Occidente e l’unica alternativa al suo declino). Ebbene, per questa sapienza non c’è che
Bach e la sua profondità abissale, raggiunta con
un raziocinio musicale rigoroso eppure sempre
flessibile, arrotondato, particolare, sempre miracolosamente adattato ai casi singoli e sempre incredibilmente perfetto per ciascuno di essi.
Potremmo chiudere qui e accontentarci di questa
antitesi culturale, ma sarebbe ancora uno
stereotipo che non rende ragione né
alla complessità del reale né a Bach. I
termini di questa antitesi, che ormai
è molto nota (lo dico anche per esperienza diretta: è uno degli argomenti
più comuni nelle tesine d’esame degli
studenti liceali), sono da un lato la concezione informata dalla scienza sperimentale col suo corollario
tecnologico, dall’altro
la critica di questa concezione che, in qualche modo secondo
l’istanza filosofica
prima detta, cerca di portare l’attenzione della cultura
sul mondo della
vita (d’altronde
con poco successo, dato che
ogni scommessa dei poteri
mondiali va comprensibilmente in direzione del primo termine, così che le suddette tesine d’esame si inscrivono in genere nel registro
dell’utopia).
Ebbene, la novità rispetto a questo quadro stereotipato è che la scienza naturale, cioè quella
stessa scienza che gode dei favori di tutte le
centrali del potere, in parallelo con la crescente
consapevolezza conseguente la cosiddetta teoria
della complessità, comincia ad accorgersi che non
riesce più a perseguire i propri fini con modelli
euristici pensati sulla base del semplice geometrismo meccanicistico cartesiano: sempre più infatti
risulta chiaro che il tutto è più della somma delle
parti, e che la natura, perfino nella sua trama più
profonda, è dominata da forme trasversali d’insieme dotate di proprietà irriducibili agli elementi
del sistema. Al di là di ogni aspettativa, la scienza più avanzata deve escogitare modelli euristici
nei quali si tenta di piegare la stessa matematica
all’espressione del qualitativo, dell’analogico e
persino dell’antinomico, ossia alla struttura stessa
della vita. Così, ancora al di là di ogni aspettativa (ma qui neanche poi tanto), Bach si rivela più
moderno dei moderni, e molto più addentro alle
pieghe profonde dell’essere di quanto non fosse
la scorribanda policroma con cui si concludeva il
film di Kubrick iniziato con l’eleganza ineffabile
dei valzer di Strauss.
Antonino Postorino
A parità di programma, si avrà una esecuzione
opportunamente didascalica, quasi una prova
aperta in modo da coinvolgere nella comprensione dei brani eseguiti i giovani ascoltatori,
preventivamente preparati dai loro insegnanti. Il
programma comprende una delle piè belle e frizzanti ouvertures di Wolfgang Amadeus Mozart:
quella dalle Nozze di Figaro. Degna apertura di
un programma che continua con il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 4, op. 58 di Ludwig van
Beethoven, e si conclude con la Sinfonia n. 3,
op. 55, detta Eroica, dello stesso autore.
Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4, op.
58 è stato composto da Ludwig van Beethoven
nel 1805; pertanto è quasi coevo della sinfonia
n. 3, che conclude il conc erto. Esso appartiene, perciò, a quel periodo in cui Beethoven
aveva già compiuto il percorso che lo portò ad
abbandonare completamente i modi compositivi settecenteschi per approdare pienamente
al Romanticismo. E l’approdo di questo sentire
ed esprimersi tramite la musica è pienamente
evidente nell’Adagio del Concerto, del quale il
grande Cortot disse essere un brano dei più sublimi che esistano per il pianoforte.
Chiude il concerto la sinfonia Eroica, composta
l’anno prima. Essa, ispirata alla figura ed all’opera
di Napoleone,era destinata ad evidenziare tutta
la grandezza e la tragicità della figura del grande condottiero che inevitabilmente, con il suo
operare, genera una scia di lutti e di sangue. E la
Terza celebra proprio tutto ciò ed il tono in cui si
esprime raggiunge livelli di sublime maestosità.
Per un programma così impegnativo occorrono
esecutori degni della sua interpretazione. Noi
confidiamo di averli trovati bell’orchestra che
proponiamo ma, soprattutto, n ei Maestri Marcianò e Bruno, rispettivamente direttore e solista,
ambedue nostri concittadini.
L’Orchestra Filarmonica di Zagabria è la più illustre formazione orchestrale della Croazia, ed è
attiva sulla scena musicale dal 1871. Moltissimi
solisti di fama hanno collaborato con l’orchestra.
Sono numerose le registrazioni effettuate nel
corso degli anni dall’orchestra Filarmonica di
Zagabria con la direzione di Lovro von Matacic
e Milan Horvath. Gianluca Marcianò, direttore
d’orchestra e pianista, si diploma giovanissimo
con il massimo dei voti sotto la guida di Pier Narciso Masi con cui si perfezionò poi all’Accademia
Musicale di Firenze.
Studiò inoltre con Dimitri Bashkirov, Joaquin
Achucarro, Paolo Restani e Massimiliano Damerini per la musica contemporanea.
Ha lavorato come maestro sostituto presso le
principali Istituzioni italiane. E’ Direttore principale dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Zagabria e, in qualità di Maestro direttore, si è esibito
in tutto il mondo alla guida drelle principali orchestre. Giuseppe Bruno ha studiato a Firenze,
Milano, Salzburg, Siena
Si è successivamente perfezionato con Paolo
Bordoni (pianoforte) e Leopold Hager (direzione), nonché con Franco Gulli ed Enrica Cavallo
(musica da camera). Innumerevoli i premi vinti
nell’ambito di concorsi prestigiosi ed i concerti
tenuti in tutto il mondo presentando un repertori che si estende fino alla musica moderna e
contemporanea compositore e docente, è attualmente Direttore del Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia.
Nei prossimi numeri del Rigo musicale avremo
agio di presentare gli altri concerti, a mano a
mano che diverranno attuali; qui vi accenniamo
di passata. Altri dieci concerti completano questa Stagione Invernale. Un concerto di musica
contemporanea vedrà impegnato, come è ormai
tradizione, un’ensemble formato da docenti del
Conservatorio di Musica cittadino. E, poichè
quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita di Olivier Messiaen, il Conservatorio non
poteva non ricordare la figura di un musicista
che è stato uno dei punti di riferimento assoluto
per l’evoluzione del linguaggio musicale del nostro secolo. Le sue posizioni estetiche ed alcuni
procedimenti innovativi, fondendosi con le tesi
strutturalistiche della Scuola di Vienna, hanno
aperto orizzonti del tutto nuovi e, per certi versi,
non ancora esauriti.
Oltre ai brani cameristici del musicista francese,
verranno eseguite due prime assolute di Giorgio
Planesio e di Andrea Nicoli, entrambi docenti di
Composizione presso il Conservatorio spezzino.
Come di consueto non mancherà la musica di
Piero Luigi Zangelmi, musicista di adozione ligure scomparso da pochi anni.
Altri due concerti per le scuole dedicati alla musica etnica ed alla fiaba in musica; poi, i tradizionali concerti di dicembre: gospel, musica sacra
della tradizione europea sotto natale. L’ultimo
dell’anno vedrà ripetersi il tradizionale concerto che precede le feste nelle via cittadine con
l’impiego di un’orchestra che oltre a proporre le
musiche tradizionali di Struass proporrà - e qui
stà la novità - una selezione da celebri operette.
A gennaio, ancora un’orchestra con pianista; a
marzo il grande pianista Kiril Gerstein; quindi
l’orchestra sinfonica di San remo con Boris Belkin; chiuderà la stagione un concerto dedicato
all’opera compositiva di Nino Rota, nel 30° anniversario della scomparsa. Una stagione, come
di vede, ricca e varia, attraente e di grande spessore cultura. E se si pensa che ancora una volta
si è riusciti a contenere i prezzi dell’ingresso e
dell’abbonamento sui livelli della stagione passata (ma per la verità sono parecchi anni che i
nostri prezzi sono immutati) quasi viene spontaneo parlare di miracolo. Ma tant’è: in occasione del nostro 40° compleanno questo regalo al
pubblico che affettosamente ci segue, proprio
dovevamo farlo.
Treemme
6
Giacinto Scelsi
L’uomo di una sola nota
Il distacco
(o la seconda nascita)
comunque in Svizzera. Del resto sono là le cliniche
migliori, ma sono anche quelle in cui si muore di
più, i pazienti non hanno altra possibilità che quella di morire…Blanche Jouve la psicanalista, mi
disse un giorno: lei non è curabile; la sua cura è
di guarire gli altri’. Forse aveva ragione: in effetti
talvolta ho potuto aiutare delle persone (potete crederlo o no, ma è così). Tra i centoventisei medici
con cui ho avuto a che fare molti erano psichiatri,
il che mi ha reso mezzo pazzo, ma non più di prima. Uno di loro mi disse: ‘Come faccio a curarla,
lei è nato a metà! Lei è ancora nel pancione da cui
proviene!’. In un certo senso penso avesse ragione:
ecco perché suonavo il pianoforte dall’età di quattro anni, senza pensare. Ho avuto tutto: non ho mai
lavorato, non ho mai pensato, c’era già un contatto
inserito quando sono nato - non vorrei apparire
scortese dicendo questo. Ci sono a metà, ma questa
metà è sufficiente . (2)
La malattia
Sono nato nel 2637 a.C. - fate i calcoli e sapete
quanti anni ho - in Mesopotamia.
Sposai una ragazza assai carina e quando avevo
ventisette anni (lei ne aveva qualcuno in meno)
fummo uccisi in un palazzo assiro sulla riva
dell’Eufrate - un luogo bellissimo, caldo e con una
vista meravigliosa. Laggiù è rimasta nascosta nella
sabbia, l’effigie del mio viso, scolpita su una pietra alta più di due metri. E’ vicina alla riva, penso
che saprei ritrovarla. Un giorno o l’altro verrà alla
luce. Oltre a quella di me rimane solo una foto, ma
prima di morire la distruggerò: non voglio che resti
nulla (resterà la statua sotto la sabbia, ma quella
non la posso distruggere; non so in che condizioni
sia, ma c’è). Resteranno anche le partiture (purtroppo) che saranno eseguite, la maggior parte
delle volte male - d’altronde non avrei mai dovuto
scriverle, ma sarebbe difficile bruciare il palazzo
di Salabert. A ciascuno la sua verità. (1)
La scelta e la pratica del distacco in Giacinto Scelsi è
maturata gradualmente negli anni della sua vita ma
soprattutto è un parametro - quello dell’allontanamento - che permette di misurare l’intero suo percorso umano ed artistico.
Nato, l’8 gennaio nel 1905 alla Spezia poiché figlio
del capitano di vascello Guido Scelsi in forza presso
la nascente flotta aeronautica allora in seno alla Regia
Marina (suo padre si occupava di tutto il programma
di sperimentazione degli idrovolanti) il quale aveva
sposato la marchesa Giovanna d’Ayala Valva, passò la
sua infanzia principalmente nel castello di famiglia
di Valva in Irpinia studiando latino e scherma. Per
gran parte della sua gioventù, fino alla fine degli anni
trenta, fece piacevole vita di aristocratico in giro per
le principali città europee studiando musica prima
a Roma con Giacinto Sallustio e poi a Vienna con
Walter Klein. Parigi fu sempre la città di maggior richiamo. Alla fine degli anni venti effettuaò un viaggio che da Alessandria d’Egitto lo condusse in Terra
Santa e nel medio oriente da cui riportò significative
impressioni visitando conventi copti nel deserto e
conoscendo direttamente comunità sufi e assistendo
alle danze dei Dervisci. Qualche anno dopo farà uno
storico viaggio in India e in Nepal restandovi per più
di tre mesi. Dopo un grande e sofferto amore sposò la duchessa di York che lo abbandonò nei primi
anni quaranta. Intanto un malessere profondo stava
pervadendo il giovane uomo Scelsi; la sua storia di
vita e anche quella musicale (aveva già composto e
pubblicato numerose composizioni prevalentemente per pianoforte e il Quartetto n.1 con esecuzioni
di grande e prestigiosa risonanza a Parigi e in altre
città europee) sembravano chiudersi in una sorta di
vicolo cieco. Preso dal malessere di vivere si ritirò
per alcuni mesi in una clinica a Losanna nella quale
gli stessi medici non riuscirono a formulare una diagnosi precisa.
…Era una clinica notissima, lussuosa….Si trova
Questo stato d’indefinito malessere diverrà una sorta
di punto ultimo di distacco e al tempo stesso, nella
sofferenza, una presa di coscienza di nuova nascita.
La manifestazione di questo disagio fu che la sua vista
e il suo udito si fecero sempre più ipersensibili fino
al punto di renderlo fortemente vulnerabile ma anche sempre più permeabile e trasparente (a Parigi,
in occasione dell’esecuzione dei Quatto pezzi per
orchestra, all’hotel Ritz fu costretto a dormire negli
armadi, con curioso scandalo sui giornali dell’epoca).
Quando molti anni dopo, quasi a fine della sua vita,
gli fu chiesto da dove venisse la sua musica rispose:
dalla malattia.
Fu questa condizione di malessere, difficilmente catalogabile, che lo guidò alla ripresa di un gioco infantile di cui portava ancora i ricordi, ad entrare (o
ri-entrare) dentro al suono per schiudere a se stesso
e poi con le sue opere al mondo intero, mondi e dimensioni percettive e mentali fino ad allora inaudite.
Narrando, negli ultimi anni della sua vita, la celebre
storiella zen del pidocchio di cui il giovane allievo
dovrà vedere pulsare il cuore per raggiungere l’illuminazione, Scelsi racconta:
“Ecco come si deve ascoltare un suono. Ho fatto
questa esperienza da solo, senza conoscere la storia, quando ero in clinica, malato. Nelle cliniche
ci sono sempre dei piccoli pianoforti nascosti, che
quasi nessuno suona. Un giorno mi misi a suonare
:do, do , re, re , re… Mentre suonavo qualcuno disse: ‘Quello è più pazzo di noi!’. Ribattendo a lungo
una nota essa diventa grande, così grande che si
sente sempre più armonia ed essa vi si ingrandisce
all’interno, il suono vi avvolge. Vi assicuro che è
tutta un’altra cosa: il suono contiene un intero universo , con armonici che non si sentono mai. Il suono riempie il luogo in cui vi trovate, vi accerchia,
potete nuotarci dentro. Ma il suono è creatore tanto
quanto distruttore; è terapeutico: può guarire come
distruggere. La cultura tibetana ci insegna che con
un solo grido si può uccidere un uccello e non sò se
il suono lo possa far rivivere. Nell’epoca dell’elettronica e dei laser, i Tibetani possono essere il semplice
grido che uccide.
Per finire, quando si entra in un suono ne si è avvolti, si diventa parte del suono, poco a poco si è
inghiottiti da esso e non si ha bisogno di un altro
suono. Oggi la musica è diventata un piacere intellettuale – combinare un suono con un altro ecc.
– inutile. Tutto è là dentro, l’intero universo riempie
lo spazio, tutti i suoni possibili sono contenuti in
esso. La concezione odierna della musica è futile –
rapporti fra i suoni, lavoro contrappuntistico: così
la musica diventa un gioco.
….Mi sento più vicino ai filosofi orientali, che sono
contro la violenza, contro le manifestazioni pratiche della vita terrestre; preferisco vivere su altri piani, altrimenti rischio di distruggere il mio sistema
nervoso. E’ un rischio che bisogna correre ” (3)
Riuscì in tal modo a ridurre il sé in termini così minimi ed infiniti, da poter entrare dentro ai suoni e
a scoprirne le loro inimmaginabili qualità sonore e
cromatiche esplorandone le dimensioni più segrete
e profonde: i suoni diventano dei suoni-bolla.
I messaggi di un postino
Gradualmente non si fece più fotografare (perquisiva accuratamente i frequenti ospiti della sua casa in
via S. Teodoro a Roma), e si rappresenterà solo con
un simbolo zen con il cerchio e la linea. Non definendosi compositore amava autodefinirsi postino in
quanto portatore di messaggi dal mondo dei Deva,
sviluppando e praticando con rigore la disciplina della non azione oltre che nella vita anche nei confronti
dei suoni e della ‘sua’ musica, nulla facendo per farla
eseguire e ascoltare.
Postino di suoni, ma anche poeta – amava scrivere in
francese - con diversi volumi pubblicati (dallo storico
editore parigino GLM e in italiano per conto de Le
parole gelate di Luciano Martinis) autore di testi di carattere ermetico e musicologico illuminanti pubblicati e molti, per sua volontà, ancora da pubblicare,(Sens
de la Musique, Art et Connaissance, Évolution de
l’harmonie, Évolution du rytme, Il sogno 101…)
Giacinto Scelsi rinasce in musica agli inizi degli anni
cinquanta con la consegna di numerosi messaggi o
opere musicali prevalentemente destinate ad un solo
strumento; ancora il pianoforte ma sempre più distaccato o depurato da referenze formali di tipo più
o meno accademico (le Suites n. 8 – 11 realizzate il
1952 e il 1956) ma anche diversi altri strumenti solitari con i quali Scelsi sviluppa sempre più quel viaggio
dentro al suono con l’adozione del suono microtonale o a quarti di toni . Dai fiati come il flauto con
i brani Pwyll e Quays, al clarinetto a con Tre Studi,
Preghiera per un’ombra e Ixor, a varie pagine, sempre solistiche, per sax, corno, tromba, trombone, agli
archi soprattutto, il violino con i Divertimenti 2-5, la
viola di Coelocanth, Three studies e Manto, ma ancor
più le prime due parti di una Trilogia per violoncello
(Triphon e Dithome) realizzata tra il 1956 e 1957 che
sarà completata con la terza parte, Igghur nel 1965.
Significativi i titoli ma ancor più i sottotitoli , vere e
proprie matrici di riconoscibilità del pensiero scelsiano, che recitano, per le opere pianistiche: Bot-ba
Una evocazione del Tibet con i suoi monasteri sulle
alte montagne – Rituali tibetani – Preghiere e danze
della Suite n. 8 per pianoforte, alle Quattro illustrazioni sulla metamorfosi di Visnù o alla Suite n.9 Thai
nella quale è riportata la seguente indicazione: Una
successione di episodi che espime alternativamente
il Tempo, più precisamente, il Tempo in movimento
e l’Uomo come simbolizzato da cattedrali o da monasteri, con il suono dell’Om sacro. Questa suite deve
essere ascoltata e suonata con la più grande calma
interiore. Gli agitati se ne astengano! .
Altrettanto rivelanti i sottotitoli della Trilogia violoncellistica definita come I tre stadi dell’uomo:
Giovinezza-Energia-Dramma (Triphon), MaturitàEnergia-Pensiero (Dithome), Vecchiaia-Ricordi-Catarsi-Liberazione (Igghur).
Questa ri-nata vita nel suono di Scelsi negli anni cinquanta culmina nella stesura della sua opera maggiormente rappresentativa, I Quattro pezzi (su una
sola nota) per orchestra del 1958-1959, un vero e
proprio manifesto di altre vie per il suono del tutto
a latere della contemporanea vitalità dell’avanguardia
a Darmstatdt (proprio in quell’anno vi sbarcherà nei
celebri corsi estivi lo stesso John Cage, con la storica e radicale reazione di Luigi Nono con il testo La
Presenza storica nella musica d’oggi), o del celebre
Poème Electonique di Varèse-Xenakis-Le Corbusier
del Padiglione Philips di Bruxelles.
I Quattro Pezzi (su una sola nota) rappresentano
l’affermazione di un processo di distacco dalle forme
descrittive del suono (le cosidette note) attraverso la
piena concentrazione verso un centro, il cuore del
suono.
La mia musica non è né questa né quella, non è dodecafonica, non è puntilista, non è minimalista…
Cos’è allora? Non si sa.
Le note, le note, non sono che dei rivestimenti, degli
abiti. Ma ciò che c’è dentro è generalmente più interessante, no?
Il suono è sferico, è rotondo. Invece lo si ascolta sempre come durata e altezza. Non va bene. Ogni cosa
sferica ha un centro: lo si può dimostrare scientificamente. Bisogna arrivare al cuore del suono: solo
allora si è musicisti, altrimenti si è solo artigiani.
Un artigiano della musica è degno di rispetto, ma
(4)
non è né un vero musicista né un vero artista.
Grazie al postino Scelsi, verranno recapitati, fino agli
anni ottanta, con ritmo incalzante, una nutrita quantità di preziosi messaggi, tutti abilmente occultati
dall’autore e raramente eseguiti fino alla metà degli
anni ottanta, qualche anno prima della sua morte; da
altri quattro quartetti per archi (l’ultimo dei quali, il
n. 5 dedicato alla scomparsa del suo fraterno amico
Henry Michaux nel 1985), numerose composizioni
per grandi organici orchestrali e corali ( Hurqualia,
Aiôn, Hymnos, Uaxuctum, Pfhat e fra gli ultimi
Konx-Om-Pax sottotitolato Tre aspetti del suono: in
quanto primo movimento dell’Immutabile; in quanto Forza Creatrice; in quanto la sillaba Om) oltre a
numerose altre per orchestra da camera (Anahit, Natura Renovatur, per citarne alcune), corali (Tre canti
sacri , Antifona sul nome di Gesù) pianistiche e per
diversi altri strumenti per un catalogo complessivo di
circa centocinquanta opere attualmente pubblicate e
numerose altre ancora da pubblicare, anche a diversi
anni dal suo allontanamento.
Di queste ultime, i messaggi-partiture da pubblicare,
se ne attende ancora la trascrizione da un gran numero di nastri (diverse centinaia) registrati con rara perizia tecnica e maestria direttamente dal postino Scelsi.
Soprattutto per la pratica compositiva occidentale di
quest’ultimo secolo, è infatti insolita - pur essendo
diffusa largamente la pratica di aiutanti e trascrittori, normalmente giovani allievi, che aiutano i maestri
nella stesura e strumentazione delle opere -, la metodologia dell’arrivo e della lettura-manifestazione dei
messaggi scelsiani; registrate al pianoforte o su altri
particolari strumenti a tastiera d’uso già negli anni
cinquanta sui quali è possibile realizzare suoni microtonali e movimenti del suono enarmonici, Scelsi
affidava poi questi messaggi a vari trascrittori che a
vario modo riuscivano a scrivere in forme più o meno
fedeli e precise le partiture. Una pratica artigianale
- sul modello della bottega d’arte rinascimentale comunemente adottata da grandi autori soprattutto
per motivi editoriali (oggi del tutto annullabile, in
questa forma, con qualsiasi personal computer grazie
a software con i quali è possibile trascrivere automaticamente in note in forme assolutamente iperfedeli
su una partitura qualsiasi esecuzione su strumento
o voci con sistema midi) che invece, nel singolare
caso scelsiano, coniuga in un quadro di altra conoscenza - o sapienziale - le diverse manifestazioni del
suono (quella della mobilità orale e del mistero del
mondo devacanico da cui la musica giunge al mondo
fenomenico, con la fissità dello scritto) anche se da
Scelsi motivata quale forma autoterapica e di vitale
sopravvivenza.
Si, lui aveva un’idea musicale di fondo, ma non
era esattamente realizzata sulla carta. Era difficile
realizzarla anche perché aveva difficoltà a controllare sulla partitura. Era un problema visivo, di
impossibilità a concentrarsi, non glielo so dire con
esattezza. Ad ogni modo da quando l’ho rivisto ( al
rientro da Parigi nel 1952-53, n.d.a), dopo la guerra, ha avuto dei gravi problemi, direi quasi una
difficoltà organica. Ad esempio non poteva sopportare la luce ed aveva necessità di essere aiutato. Era
proprio una questione di salute: per anni non ebbe
possibilità di applicarsi, di concentrarsi a lungo.
Quindi ci sono stati dei giovani che lo hanno aiutato a stendere la musica, dietro i suoi suggerimenti,
naturalmente. E, d’altra parte, anche se Scelsi non
scriveva lui la sua musica, dava il suo ‘soffio’ e que(5)
sta è la cosa importante.
E’ facilmente intuibile e forse anche comprensibile,
il totale silenzio - dall’assoluta indifferenza fino alla
gratuita denigrazione - che il mondo musicale accademico italiano, troppo spesso caratterizzato da un
bigotto senso di chiusura e auto celebrazione, abbia
decretato nei confronti di così alte creazioni difficilmente classificabili o ascrivibili a qualche scuola. Ne
è testimonianza, ancor oggi, a distanza di oltre venti
anni dalla scomparsa di Scelsi che la sua musica non
sia ascoltabile - se non per qualche raro incidente di
percorso - nelle programmazioni radiofoniche italiane mentre cominciano ad esserlo un po’ più nelle
programmazioni concertistiche, pur essendo in gran
parte del mondo uno fra gli autori più riconosciuti
ed eseguiti.
…Sono buddhista.
Se nessuno vuol suonare la mia musica nessuna la
suoni, continui a non suonarla – mi è indifferente.
Qui in Italia la Rai non fa niente, non ha mai registrato nulla di mio. Sono andato in Francia. Gli
italiani hanno uno spirito del tutto diverso dal mio:
sono in generale materialisti., la trascendenza non
gli interessa – mentre io non vivo che per quella.
Non sono un compositore, perché essere compositore vuol dire unire una cosa ad un’altra : io non
faccio questo. Si arriva ovunque con la negazione,
è tutta una tecnica: non sei questo, non sei neppure
questo. Sei il tuo corpo? No, non sono il mio corpo. Sei i tuoi affetti, i tuoi sentimenti? No, essi sono
completamente cambiati da molto tempo. Sei il tuo
intelletto? No, pensavo una volta, ma ora penso in
modo completamente diverso. Allora cosa sei? Ebbe(6)
ne, ciò che resta…
Giacinto Scelsi, autore dell’Octologo (otto pensieri
pubblicati dall’editore Le Parole gelate in otto lingue
diverse nel 1987) muore a Roma la notte tra l’8 e il
9 agosto del 1988 dopo aver preannunciato con una
sua boutade alcuni mesi prima ai suoi amici più fedeli che l’incrocio degli otto di quello stesso anno lo
avrebbe visto allontanarsi da questa vita.
7
1
Non opacizzarsi
né lasciarsi opacizzare
2
Non pensare
Lascia pensare
coloro che hanno bisogno di pensare
3
Non la rinuncia
ma il distacco
4
Aspirare a tutto
e non volere niente
5
Tra l’uomo e la donna
l’unione
non la congiunzione
6
Fare arte
senza arte
7
Siete i figli
e i genitori
di voi stessi
non dimenticatelo
8
Non sminuite
il senso di ciò
che non comprendete
* L’immagine che introduce il testo su Scelsi rappresenta il simbolo da lui
adottato e diffuso in sostituzione della sua immagine dopo che, dalla fine
deglia anni quaranta, Scelsi gradualmente occultò, distruggenole, le vecchie
foto evitando accuratamente di averne di nuove. Resteranno solo le foto pubblicate precedentemente a quegli anni; l’ultima ufficale è una foto giovanile
apparsa sul programma di sala del XXIV Festival de la Societe Internationale
de Musique Contemporaine di Bruxelles nel 1950 in occasione della seconda esecuzione della Nascita del Verbo. Realizzato da Luciano Martinis, stretto
collaboratore ed editore di Scelsi, questo simbolo veniva inviato ogni qualvolta
editori, studiosi e musicisti richiedevano con particolare insistenza materiale
biografico.
1-4 Franck Mallet, Il suono lontano Conversazione con Gacinto Scelsi, in Giacinto Scelsi Viaggio al centro del suono (a cura di Pierre Albert Castanete e
Nicola Cisternino) , Luna Edizioni., La Spezia 2001
5 Intervista di Stefania Gianni a Goffredo Petrassi, in I suoni, le onde…Rivista
della Fondazione Isabella Scelsi n.2, Roma 1991 p.9)
6 Franck Mallet, ibid.
John Cage
L’uomo di tutti
i suoni (e silenzi)
... Fu alla Cornish School di Seattle (dove Cage aveva trovato lavoro,n.d.a) che venni a conoscenza del
buddismo zen, che più tardi, come parte della filosofia orientale, prese per me il posto della psicoanalisi. Avevo dei problemi sia nella vita privata sia nella mia vita pubblica di compositore. Non riuscivo
ad accettare l’idea accademica che lo scopo della
musica fosse la comunicazione, perché notavo che
quando scrivevo coscienziosamente qualcosa di triste , la gente e i critici spesso reagivano ridendo. Stabilii che avrei abbandonato la composizione se non
avessi trovato delle motivazioni migliori della comunicazione. Trovai la risposta da Gita Sarabhai,
una cantante indiana e suonatrice di tabla: lo scopo della musica è quello di placare e quietare la
mente rendendola in questo modo suscettibile agli
influssi divini. Trovai anche negli scritti di Ananda
K. Coomaraswamy che la responsabilità dell’artista
è quella di imitare la natura nel suo modo di agire.
Mi sentii meglio e tornai al lavoro.(1)
Se Giacinto Scelsi è l’uomo di una sola nota – o della
non azione, John Cage è l’uomo di tutti i suoni (e
silenzi), o della non intenzione. E’ forse per questa
ragione che l’intera opera di Cage, nella prospettiva
storica dell’arte del secolo XX, rappresenta una delle
vie più significative nella sfera del pensiero ( o del non
pensare) più che sul piano dell’azione (o del non agire), nonostante le evidenti apparenze. Acquisito dalla
storia soprattutto in quanto artista dell’azione (dalla
performance-happening, al grande impegno dedicato
alla danza, alla pittura , alla grafica, alla realizzazione
di nuove forme di scrittura dei suoni) l’opera di Cage
semina un radicale cambiamento di prospettiva nel
pensiero; l’azione, sganciata a quel punto da qualsiasi
significato o intenzione, ne sarà solo uno dei possibili
esiti o manifestazione. E’ una sorta di emancipazione
del pensiero che allarga a dismisura il vuoto (quello
del tempo) per fare spazio a tutti i possibili dello spazio; una oggettivazione dello spazio (e dei suoni) della mente nella non oggettivazione del tempo. Come
la pietra di Hogen, starà ad ognuno di noi definire se
Cage (e i suoni, i rumori, i silenzi liberati) è dentro o
fuori della nostra mente.
Il superamento dei limiti
Attendo con ansia il giorno in cui tutto sarà libero
piuttosto che proibito
La libertà dei suoni (e dei rumori e dei silenzi) per
Cage è la ragione della sua opera e della sua vita. Togliere i limiti e le restrizioni ad ogni manifestazione
del tempo (suoni, rumori, silenzi) significa distaccare
la manifestazione dalla sua intenzione o idea, ovvero
riconoscere al mondo sonoro una vita al pari di tutte
le creature viventi e come tali nel pieno diritto di vivere la propria durata. L’uomo ha la grande opportunità di porli (e porsi) in libertà potendo così assistere
con stupore al grande gioco della vita. La libertà dei
suoni può manifestarsi solo se l’uomo riesce a non
dargli una intenzione o un significato. Per l’uomo resta la conquista di un atteggiamento contemplativo
nei confronti della manifestazione dei mondi sonori,
ponendolo nella condizione di assoluta permeabilità
e ascolto. Il mondo dei suoni liberati aiuta l’uomo
dunque a porsi in ascolto di se e della Natura.
All’inizio fu l’atteggiamento sperimentale - in quanto
azione di cui non se ne preveda il risultato - a guidare
Cage sulla stada della liberazione dei suoni, pratica da
allora sempre più presente nel suo pensiero e nella
sua azione. Fu la fase giovanile, quella della fine degli
anni trenta, caratterizzata da un sempre maggiore interesse verso le percussioni o verso l’uso percussivo
- insolito - di altri strumenti, come quel particolare
uso del pianoforte in forma preparata (inserendo nella cordiera viti, pezzi di sughero, plastiche, vetri…)
che consisteva sostanzialmente nello spostamento di
senso (sonoro e musicale) e di estraniazione timbrica
dal contesto conosciuto (quello del suono pianistico
essenzialmente di ascendenza romantica) e dunque
una sorta di de-localizzazione mentale, uno spostare
l’attenzione (o l’intenzione) su qualcos’altro.
Successivamente fu il Caso, o la casualità, a rendere
possibile per l’uomo-musicista Cage liberare i suoni
dalle proprie intenzioni. Paradossalmente il Caso in
quanto espressione possibile (i fisici direbbero probabilistica, del Caos o dell’instabilità dei sistemi caotici) e manifesta di un Caos (in quanto molteplicità,
infinite opportunità di sempre nuove possibilità) rappresenta la stampella mentale per la non-intenzionalità. Sono gli anni quaranta, della scoperta della musica
e dell’India.
Non ho problemi né con l’idea di tempo, né con
quella di spazio. Ne ho invece con la parola “concetto”. Penso che in un modo o nell’altro dovremo
riuscire a sbarazzarcene.
…Questa è la ragione che mi ha condotto a usare
le operazioni casuali. L’uso che ne faccio mi porta
a fare una quantità di domande, piuttosto che di
scelte. Così se avrò l’opportunità di continuare a
lavorare, penso che il mio lavoro somiglierà sempre
di più non tanto al lavoro di un individuo, ma a
qualcosa che sarebbe potuto accadere anche se l’individuo non fosse esistito. Qualcosa del genere. (2)
Al tempo stesso, sempre negli anni quaranta, un
risvolto sempre più sociale e comunitario dell’agire
casuale, continuando già il lavoro dei decenni precedenti soprattutto con la danza (storica e di grande
fertilità creativa la collaborazione con Merce Cunningham) porta Cage a praticare l’happening come
incontro di tutte le espressioni artistiche ed umane
(storica la partecipazione al Blake Mountain College
oltre alla compagnia di Cunningham, anche di artisti
quali Rauschenberg, musicisti quali David Tudor o i
poeti Charles Olson e Mary Caroline Richards), una
pratica che con il movimento Fluxus sbarcherà poi
anche in Europa negli anni sessanta.
In silenzio nel silenzio
L’I-ching o libro dei mutamenti fu per Cage, fin dal
1951 con Music of changes un vero e proprio strumento di liberazione dalle operazioni intenzionali o
progettuali fino alla concezione, l’anno successivo, di
quella che lo stesso autore considererà la sua composizione-idea più riuscita ed efficace : 4’ e 33”.
I
TACET 33”
II
TACET 2’40”
III
TACET 1’20”
Libertà e disciplina
…se si limitano a fare una cosa qualsiasi (gli
interpreti della sua composizione Theatre Piece,
nda), faranno ciò che ricordano o che gli piace,
e diventerà evidente che proprio questo è quanto sta accadendo, e così l’esecuzione e il pezzo
stesso non costituiranno più quella scoperta che
avrebbero potuto essere qualora gli interpreti
avessero fatto un uso disciplinato delle operazioni
casuali….E anche per il pubblico, che è in grado
di dire immediatamente se qualcosa viene fatta
in modo disciplinato o improvvisato. La maggior
parte delle esecuzioni di Theatre Piece non sono
buone, perché la gente non comprende la necessità di una disciplina.(6) Limitata , riducendola
fortemente, la portata del suo pensiero al concetto
di Alea in musica fin dal suo arrivo in Europa, ovvero alla decisione (quanto libera ? quanto indotta?)
dell’interprete nella scelta del suono, del gesto o di
qualsiasi altro elemento costituzionale dell’evento,
la non-intenzionalità cageana si presta (anche se
con gioco… come l’amato Satie insegna) a infinite
possibilità, una delle quali, primaria, col concetto di
improvvisazione. Frequentemente il tutto è possibile della partitura cageana rischia sempre di tradursi,
nella sua realizzazione, in uno stereotipo intenzionale dell’interprete. Ciò che vuole liberare dall’intenzione individuale si traduce in un rafforzamento
di questa. Ciò che vuole portare alla consapevolezza
in un processo di distacco, rischia sempre di rivelarsi come la sua più forte opposizione.
Potranno rimuovere i miei demoni - dirà citando
Rilke - ma offenderebbero certamente i miei angeli
La libertà è posta in scacco dalla disciplina (e consapevolezza). E in questo Cage esce certamente dai comuni ambiti del solo suono, della musica e dell’arte,
per aprirsi all’emancipazione dell’uomo, ponendolo
di fronte alla questione o al fondamento, individuato nel nostro rapporto con la Natura (quella umana, del nostro pensare oltre che del nostro agire).
Si rivelerà così nella sua pienezza - con il distacco
storico di questi anni che comincia a delinearsi oltre
l’avanguardia storica e le sue letture di parte - un
percorso artistico e umano, quello di Cage, di carattere fortemente interrogativo, vera arte del porre le
domande: quelle sul tempo (e della vita) innanzitutto e delle sue possibili organizzazioni.
Rifacendosi all’insegnamento di Ananda Coomaraswamy, cercò di fare dell’arte imitando la natura nel
suo modo di procedere mentre titolò il suo diario,
citando Zhuangz, Come migliorare il mondo (Peggiorerai semplicemente le cose). In occasione dei
suoi settantanni poi disse: Sto gradualmente imparando ad avere cura di me stesso. Ci ho messo
molto tempo, ma penso che quando morirò sarò
in condizioni perfette.
Questa perfezione fu da Cage raggiunta il 12 agosto
del 1992 nella sua casa di New York.
Penso che forse il mio pezzo migliore, o almeno quello che mi piace di più, sia il ‘pezzo silenzioso’ 4’ 33”.
E’ composto da tre movimenti, e in ognuno di essi
non ci sono suoni. Volevo che il mio laoro non fosse
condizionato dai miei gusti personali, perché penso
che la musica debba essere indipendente dai sentimenti e dalle idee del compositore. Sentivo e speravo
di poter condurre altre persone alla consapevolezza che i suoni dell’ambiente in cui vivono rappresentano una musica molto più interessante rispetto
a quella che potrebbero ascoltare a un concerto.
Nessuno colse il significato. Il silenzio non esiste.
Ciò che pensavano fosse silenzio (nel mio 4’33”) si
rivelava pieno di suoni accidentali, dal momento
che non sapevano ascoltare. Durante il primo movimento (della prima esecuzione assoluta) si poteva
ascoltare il vento che soffiava fuori. Nel secondo delle gocce di pioggia cominciarono a tamburelare sul
soffitto, e durante il terzo, infine, fu il pubblico stesso a produrre tutta una serie di suoni interessanti,
quando alcuni parlavano oppure se ne andavano.
La gente cominciò a bisbigliare, e alcuni cominciarono a uscire. Nessuno rise, si irritarono quando
si accorsero che non sarebbe accaduto nulla, e di
sicuro dopo trent’anni non l’hanno ancora dimenticato: sono ancora arrabbiati.
…A causa di questo, persi degli amici ai quali tenevo molto. Pensavano che chiamare musica qualcosa che non sei stato tu a fare, equivalesse, in un
certo senso, a gettare fumo negli occhi (3) Fu grazie ad
una importante esperienza fatta nella camera anecoica (uno spazio artificiale costruito per esperimenti e
simulazioni scientifiche, nel quale si riesce ad annullare qualsiasi vibrazione esterna) presso l’Harward University, che Cage, alla fine degli anni quaranta, scopre
che il silenzio non è una categoria acustica (poiché
annullando le vibrazioni esterne si abbassa la soglia
percettiva fino al punto di ascoltare i suoni interni del
proprio corpo) ma un cambiamento della mente, un
mutare direzione. Da allora, com’egli stesso, ricorda
dedicai la mia musica al silenzio.
Allo stesso tempo, alla coltivazione del silenzio si af- 1 (R.Kostelanetz), John Cage Lettera a uno sconosciuto, J.Cage,1989, Ed.
fianca la passione per i funghi. Esperto micologo e Socrates 1996, Roma
fondatore della New York Mycological Society, quan- 2 Ibidem, J.Cage,1977
J.Cage,1977-1968
do John Cage sbarca in Europa (storico il fracasso 34 Ibidem,
Le tre immagini che intercalano la sezione su John Cage sono le tre parti
ideologico provocato dal suo arrivo a Darmstadt nel che compongono la partitura di Fontana Mix, per qualsiasi fonte sonora e/o
1958), nella sua breve tournée italiana fu invitato da azione scenica (1958), una superficie di punti (la prima), un intreccio di vari
di linee curve (la seconda), combinate con un retino cartesiano con l’uso
Bruno Maderna e Luciano Berio presso lo Studio di tipi
dell’I-ching (la terza); grazie a questa operazione è possibile per il composiFonologia della Rai di Milano attivo da qualche anno tore estrarre da infinite possibilità le rivelazioni oracolari del caso.
per comporre un lavoro elettronico (realizzerà con 5 Ibidem, J.Cage,1969
vari spezzoni di nastro magnetico Fontana Mix(4) la 6 Ibidem, J.Cage,1982
cui partitura grafica, nelle sue varie parti, accompagna
Nicola Cisternino
come immagini questo breve scritto).
Sarà proprio questa grande passione, quella dei funghi, che gli permise di poter finanziare (per primo
acquistò un furgone per i trasporti) la tournèe grazie
alla partecipazione e alla vincità di ben cinque milioni
di lire del tempo (!) al nascente quiz televisivo Lascia
o raddoppia con le esilaranti e immaginabili gags tra
un Cage sempre più aperto e casuale e un giovane
quanto impacciato Mike Bongiorno; questo sì, un
contributo eccezionale per la storia della televisione
italiana.
E’ possibile continuare a fare musica anche andando per funghi. Forse sembrerà un’idea bizzarra, ma
trovare casualmente un fungo ancora fresco è come
imbattersi in un suono, perché la vita di entrambi
ha la durata di un attimo(5)
segue da pag.4
Andrès Segovia a Siena - e al suo splendido curriculum di virtuoso, Alirio Dìaz vanta una sensibilità
umana e musicale immediata e profonda, che trova subito eco e risonanza nel publico. Per questa
serata scelse (in una sorte di jam-session nella quale padre e figlio si scambiavano i ruoli di primo
e secondo; quest’ultimo improvissando contrappunti che spesso imitavano il rasgueado tipico del
quattro, la chitarrina rinascimentale venezuelana)
il suo repertorio più caro: le danze e canzoni delle
pianure del suo paese natìo, il Venezuela; e i walzer del grande Antonio Lauro, figlio di italiani nato
ai margini della foresta amazzonica, tutti brani che
Alirio ha piazzato nel repertorio mondiale. Con la
sua signorile generosità, il Maestro ha corrisposto
ai calorosi applausi offrendo numerosi bis, tra di
loro il famoso El Diablo Suelto (Il Diavolo in libertà) che diede titolo ad un memorabile CD del suo
amico John Williams.
Il Festival ha chiuso in bellezza il 14 agosto a Carro.
Alle ore 18 presso Le Volte Mangianti, Palazzo Paganini, l’autore di queste righe ha sostenuto la ormai tradizionale Conversazione Paganiniana sul
tema L’altro Paganini - Paganini e gli altri (pubblicata in un bellissimo libretto edito dalla Società
dei Concerti della Spezia, presentato per l’occasione). Oltre agli aspetti sconosciuti o quasi della produzione del grande genovese (la musica sinfonica,
cameristica e per mandolino) è stato fatto un per
forza sintetico survey sugli autori, musicisti e non,
ispiratisi alle musiche e/o alla figura di Paganini.
Le chicche della conferenza sono state Le Couvent
du Mont Saint Bernard, brano per orchestra, coro
maschile, violino obbligato e campanella che, concepito come introduzione alternativa e angelica
alla celebre Campanella, anticipa modi e procedure compositive tipiche del tardo Novecento; e
le spettacolari Variations on a Theme by Paganini
for pedals per pedali d’organo di George Thalben-
Ball (1962), vera e propria sfida ai limiti della natura
umana, fino al punto di costringere l’organista a eseguire due, tre e quattro voci sulla pedaliera dell’organo. Alle ore 20 il giovane violinista Sergej Krylov (nato
a Mosca e residente a Cremona, dove vinse la prima
edizione del Premio Stradivari) scelse un repertorio
geograficamente piazzato agli estremi dell’Europa: le
Cinque melodie op. 35 bis e la Sonata n. 2 op. 94 di
Sergej Prokofiev, e brani spagnoli: trascrizioni di Manuel de Falla e la popolare Fantasia sulla Carmen di
Bizet di Sarasate. Nonostante la sua giovinezza, Krylov
possiede - oltre ad una tecnica virtuosistica a dir poco
eclatante - un focoso ed intenso senso della musicalità: per la prima volta una composizione non nata
per il violino come la Seconda Sonata di Prokofiev
(trascrizione dall’ autore della splendida Sonata per
flauto, volutissima da David Oistrakh e che in genere
convince poco, violinisticamente parlando) ci risulta
spontanea, fresca e scorrevole, come fatta apposta per
le quattro corde del giovane virtuoso. Inoltre, bisogna
sottolineare che Krylov è un vero e proprio Cristoforo
Colombo delle sonorità del violino. Mai avevamo sentiti armonici, pizzicati, doppie corde, sul ponticello...
così variegati, così inusuali e così sorprendenti, ma
mai eccessivi o impertinenti: una vera scatola musicale
di Pandora. Per quanto riguarda il pianoforte, basti il
nome di Bruno Canino: oltre ad essere, dopo la scomparsa di Gerald Moore, il più grande accompagnatore
vivente, il settantaduenne napoletano è anche solista,
duettista (celebre il duo Canino-Ballista), compositore, direttore, promotore di musica contemporanea...
La collaborazione tra il fantasioso e fantastico Krylov
e il grandissimo Canino - il quale, a volte, sembrava di
avere il pianoforte non sotto le dita, ma nelle dita - ci
ha regalato una serata che noi promuoviamo col massimo dei voti... cosa che sicuramente avrebbe fatto lo
stesso Paganini.
Antonio Mendoza
La Spezia