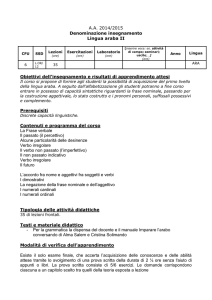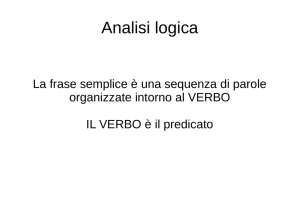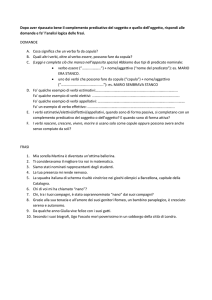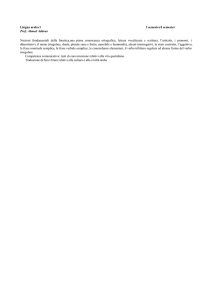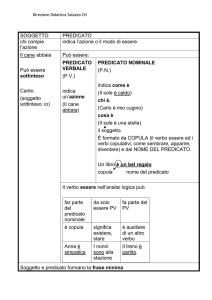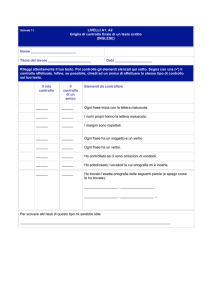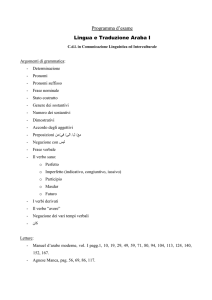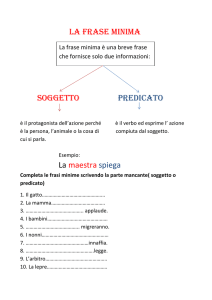A11
115
Gaetano Chiurazzi
Teorie
del giudizio
Copyright © MMV
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 a/b
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
88–548–0249–0
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: ottobre 2005
a Gianni Vattimo
Indice
9
17
17
21
26
30
33
41
41
45
50
55
59
59
62
66
69
73
73
76
82
88
94
Introduzione
Capitolo I
L’antecedenza della sostanza: Aristotele
1. «Dirsi di un soggetto» ed «essere in un soggetto»
2. Sostanza prima e sostanze seconde
3. Come è possibile la verità
4. La consignificazione temporale del verbo
5. Lo hypárchein come inesse: esistenza e identità
Capitolo II
L’a priori della sintesi: Kant
1. Giudizi analitici e giudizi sintetici
2. Giudizi di percezione e giudizi di esperienza
3. La deduzione trascendentale
4. La rivoluzione copernicana
Capitolo III
La verità dell’intero: Hegel
1. Il giudizio, punto di vista del finito
2. La copula: dal giudizio al sillogismo
3. Pensiero raziocinante e giudizio
4. La proposizione speculativa
Capitolo IV
La bilateralità del giudizio: Husserl
1. La «fenomenologia della ragione»
2. Dalla logica formale alla logica trascendentale
3. Dal giudizio all’esperienza
4. Intenzione significante e riempimento di significato
5. La dinamica del senso
7
8
97
97
100
105
112
117
123
123
129
Indice
Capitolo V
Il senso della copula: Heidegger
1. Logica formale e logica filosofica
2. La critica alla distinzione tra ideale e reale
3. Verita ed essere–nel–mondo
4. Il senso dell’essere come senso della copula
5. “In quanto” ermeneutico e “in quanto” apofantico
Capitolo VI
Prima del giudizio
1. L’inesse come esistere: Heidegger e l’a priori del tempo
2. L’antepredicativo: senso dell’essere o essere del senso?
Introduzione
La riflessione sulla struttura e sui momenti costitutivi del
giudizio, più precisamente del discorso apofantico — la forma
proposizionale “S è P” — rappresenta, a partire da Aristotele, un
momento fondamentale della riflessione filosofica, tanto che si
potrebbe dire con diritto che ogni ontologia, ogni metafisica, ogni
teoria della conoscenza trova il suo senso più profondo in una
particolare concezione del giudizio. La quale risulta determinante
anche per tutte quelle forme discorsive che non si rifanno a questa
tipologia, come, e l’esempio è ancora aristotelico, la preghiera o il
comando: esse, in un modo o nell’altro, si definiscono per differenza rispetto a tale forma privilegiata.
Un giudizio, secondo la definizione tradizionale, è un discorso che può essere vero o falso: poiché concerne il problema
della verità, una teoria del giudizio dovrebbe quindi essere
competenza della logica. Così di fatto è stato, sin da Aristotele,
che ne ha trattato appunto nei suoi scritti che oggi definiremmo
di carattere logico, l’Organon. Tuttavia, se ci chiediamo «che
cosa realmente comprendiamo in un giudizio?», vediamo che
una tale teoria ha motivi di interesse anche da un punto di vista
ermeneutico. Senz’altro con i giudizi noi descriviamo eventi o
stati di cose: ma la descrizione di un evento o di uno stato di
cose è davvero tutto ciò che comprendiamo in e tramite un giudizio? E che cosa può comportare questa eventuale “eccedenza
di senso” per la concezione della verità come adeguazione tra la
descrizione (il pensiero) e il fatto (la cosa)?
Una precisazione terminologica si impone in primo luogo. Il
termine “giudizio” deriva dal linguaggio giuridico e indica la
capacità di discernimento, una capacità cioè “discriminante”,
critica (krínein in greco significa “separare, giudicare”). Nel
suo senso più ristretto, tale capacità consiste nel discernere il
vero dal falso: in questo modo, “giudizio” è l’atto con cui si as9
10
Introduzione
sume qualcosa come vero, si esprime una credenza, si asserisce
qualcosa. In questo senso ristretto il termine “giudizio” è usato
in logica: Frege, riprendendo una distinzione già presente nella
logica terministica medioevale, distingue perciò il mero enunciato (Satz), come complesso di idee, dal giudizio, scrivendo il
primo nella forma Fx, il secondo |Fx. L’atto del giudizio è
simboleggiato dal tratto verticale aggiunto al simbolo del semplice enunciato1. Tuttavia, nella tradizione filosofica che fa riferimento a Kant e, prima di lui, a Cartesio, il termine “giudizio”
è usato in una accezione più ampia: esso indica l’atto tramite il
quale si aggiunge qualcosa all’idea che si ha di un oggetto, ovvero l’atto di sintesi tra varie rappresentazioni. La Logica di
Portoreale (1662) definiva infatti il giudizio come l’operazione
che consiste nell’unire e disunire le idee a seconda che convengano o meno tra loro: «Quando dico “Dio è giusto”, “Dio” è
il soggetto di questa proposizione, “giusto” è l’attributo; e la
parola “è” segna l’azione del mio spirito che afferma, cioè che
lega insieme le due idee di Dio e di giusto come convenienti
l’una all’altra» 2.
Si ha dunque un giudizio quando si collegano tra di loro
delle idee come concordanti, evitando di mettere assieme quelle
che non lo sono. Questa definizione del giudizio resta centrale
in tutto l’empirismo inglese ed è fatta propria da Kant (il quale
distingue la facoltà del giudizio, Urteilskraft, come facoltà di
sussumere sotto regole, di ricondurre il particolare all’universale, dal giudizio, Urteil, ovvero la proposizione in cui si
esprime l’attività unificatrice dell’intelletto), apportandovi delle
modificazioni importanti, nelle quali consiste in fondo il senso
stesso della sua rivoluzione trascendentale.
In questa, più ampia, definizione del giudizio viene in primo
piano il problema della sintesi, ovvero dell’atto di unificare rap1
Sul significato di questo tratto verticale si veda E. PICARDI, Frege, Peano e Russell sulle idee primitive della logica, in N. VASSALLO (a cura
di), La filosofia di Gottlob Frege, Franco Angeli, Milano 2003.
2
A. A RNAULD e P. NICOLE, La logique ou l’art de penser, a cura di P.
Clair e F. Girbal, P.U.F., Paris 1965, II, 3.
Introduzione
11
presentazioni o idee tra loro non incompatibili. Interrogarsi sul
giudizio significa allora interrogarsi sulla natura di questa sintesi: nel problema del giudizio vengono allora a condensarsi una
serie di questioni intorno alle quali si è concentrata la riflessione
filosofica sin dall’antichità, facendone il terreno stesso di quella
“battaglia intorno all’essere” di cui parla Platone3. La sintesi implica infatti un’unità, ovvero un’identità, e una molteplicità, ovvero una differenza: con essa si annuncia il fantasma del tempo
e del divenire. Parmenide, e poi soprattutto il suo allievo Zenone di Elea, con i suoi famosi paradossi sul molteplice e sul
movimento, ha lasciato in eredità al pensiero successivo la difficoltà, che per lui era vera e propria impossibilità, di pensare il
diverso, il non essere, la differenza, il movimento, il tempo. Le
filosofie platonica e aristotelica, e persino quella atomistica, per
quanto mosse dal tentativo di affrancarsi dall’eleatismo, non
sono in fondo riuscite ad emanciparsene completamente, in
quanto comunque ne assumono quello che possiamo definire il
suo assioma fondamentale: l’identità precede la differenza, la
tesi precede la sintesi. In questa forma, il parmenidismo ha continuato e continua a permanere nella filosofia sotto forma di
un’anteriorità logica e ontologica di ciò che è irrelato su ciò che
è connesso, dell’assoluto sul relativo, dell’identità sulla differenza, dell’ente in sé sulle sue possibili modalizzazioni, del
nome sul giudizio.
La forza di un tale assioma è tale che la logica stessa viene a
identificarsi con la sua esplicita e completa assunzione. La sua
portata si può misurare dal peso che esso ha avuto nella formulazione delle prime teorie sul linguaggio: tanto in Platone
quanto in Aristotele il linguaggio è pensato come costituito di
parti semplici, atomi indipendenti, tra i quali corrono delle relazioni, symplokaí, ad essi di principio esteriori e aggiuntive4.
Tutte le grammatiche e teorie linguistiche dell’antichità, da
3
PLATONE, Sofista, tr. it. di C. Mazzarelli, in Tutti gli scritti, a cura di G.
Reale, Milano, Rusconi, 1994, 246a.
4
Cfr. ivi., 253a sgg.; ARISTOTELE, Dell’interpretazione (tr. it. di M. Zanatta, Milano, Rizzoli, 1993), 3, 16b 24–25.
12
Introduzione
quella di Prisciano a quella di Diodoro Discolo, dalla logica
terministica a quella dei modisti5, dalla logica di Portoreale alla
logica matematica e al Wittgenstein del Tractatus, presuppongono che la significazione avvenga a partire da elementi semplici che sarebbero dati come tali prima e indipendentemente da
ogni sintesi e relazione con altro. Se c’è qualcosa che può caratterizzare il pensiero metafisico, e che dunque costituisce il
nucleo irriducibile di metafisica che si insinua in tutte queste
concezioni, anche quelle che si vogliono da essa più esplicitamente lontane (si pensi alle ricadute che l’atomismo logico ha
avuto sul neopositivismo, e in particolare alla Costruzione logica del mondo di Carnap), è esattamente questa idea di un
mondo, reale o ideale, materiale o logico, fatto di entità irrelate,
dotate di un’identità assoluta, in sé, presupposto di quel che
viene chiamato “realismo metafisico”. Oggi però è innanzi tutto
la fisica stessa a non rappresentarsi più in termini atomistici e
meccanicistici la struttura fondamentale della realtà6: un fatto
che induce a chiedersi che cosa questo comporti per una
filosofia come quella parmenidea (con le sue filiazioni platonico–aristoteliche), che in fin dei conti è da sempre la filosofia
nascosta di ogni logica, e di ogni teoria del linguaggio che si
lasci, più o meno consapevolmente, da essa dominare7.
5
Cfr. F. ILDEFONSE, La naissance de la grammaire dans l’Antiquité grecque, Paris, Vrin, 1997; G.L. BURSILL–Hall, Speculative Grammars of the
Middle Ages. The Doctrine of partes orationis of the Modistae, The Hague–
Paris, Mouton, 1971.
6
Su questa funzione di “avanguardia” della fisica sul pensiero metafisico,
le cui resistenze si riscontrano nei campi più disparati, cfr. G. BACHELARD, La
formazione dello spirito scientifico, tr. it. di E. Castelli Gattinara, Milano,
Cortina, 1995.
7
Un tentativo di esorbitare da questa logica, di decostruirla, è il progetto
grammatologico di J. Derrida, del quale può bastare questa breve citazione: il
gramma (cioè l’“oggetto” proprio della grammatologia) «è l’elemento senza
semplicità. Si intenda elemento come l’ambiente o l’atomo irriducibile
dell’archi–sintesi in generale, di ciò che ci si dovrebbe proibire di definire
all’interno del sistema di opposizioni della metafisica, di ciò che conseguentemente non si dovrebbe neppure chiamare l’esperienza in generale, né
l’origine del senso in generale» (J. DERRIDA, Della grammatologia, tr. it. di R.
Introduzione
13
La questione principale, dunque, è quella kantiana — e cioè
trascendentale — della sintesi, e anzi della “sintesi a priori”, che
avviene prima di ogni posizione tetica, che precede ogni posizione d’oggetto, e ne è anzi costitutiva. Nel giudizio, questa
funzione sintetica è attribuita alla copula “è”: un termine, questo, il cui uso, in riferimento alla terza persona singolare del
verbo essere in proposizioni della forma homo est mortalis, pare
sia stato introdotto da Abelardo 8, riprendendo e sviluppando
un’innovazione terminologica attestata in Boezio (l’operazione
connettiva che Aristotele chiama synthesis o symploké è definita
da Boezio copulatio).
Su questa “parolina” (Kant) o su questa “umile ‘è’” (Heidegger) si concentrerà pertanto l’attenzione in questo studio, nel
quale verranno prese in esame varie teorie del giudizio, di
Aristotele, Kant, Hegel, Heidegger, Husserl. La scelta di questi
autori è dovuta al fatto che per mezzo di essi si vuole tracciare
la linea di una riflessione sul giudizio alternativa a quella della
logica matematica, che a partire da Frege ha pensato il giudizio
in termini puramente funzionali: un giudizio (o, meglio, un
enunciato) è esprimibile nella forma Fx. Questa concezione funzionale, come solitamente si dice, costituisce un superamento
della forma soggetto–predicato, ma, come si evince facilmente
anche solo dalla sua semplice scrittura, il suo significato più
profondo è il fatto di evitare la formulazione copulativa, e ciò
per ragioni filosofiche sostanziali.
Si possono esplicitare tali ragioni osservando che, in effetti,
la proposizione con copula non è l’unico modo possibile con cui
è possibile esprimere la verità. Se la tradizione filosofica, a partire almeno da Aristotele, ha conferito, in maniera quasi esclusiva, la capacità di esprimere il vero e il falso alla forma enunciativa “S è P”, da un punto di vista linguistico tale forma non è
esclusiva. Nelle lingue indoeuropee — e non solo — esiste
Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, G. Dalmasso, A. C. Loaldi, Jaca Book, Milano 1969, p. 13).
8
Cfr. C. PRANTL, Geschichte der Logik im Abendlande, Fock, Leipzig
1927, II vol., p. 197, nota 370.
14
Introduzione
un’altra formazione linguistica che può avere valore di vero o
falso, e anzi che è usata unicamente per enunciare una verità assoluta, ma che è del tutto priva di copula: si tratta della frase
nominale. In un saggio del 1950, La frase nominale, Emile Benveniste mette a confronto la frase con copula e quella senza copula notando come ad esse corrisponda una diversa modalità
espressiva: la frase nominale, in particolare, ha
la caratteristica di essere atemporale, impersonale, non modale, in breve di
poggiare su un termine ridotto al suo esclusivo contenuto semantico. Una
seconda conseguenza è che questa asserzione nominale non può più
partecipare della proprietà essenziale di un’asserzione verbale, che
consiste nel mettere il tempo dell’evento in rapporto con il tempo del
discorso sull’evento. La frase nominale in indoeuropeo asserisce che al
soggetto dell’enunciato appartiene una certa «qualità» (nel senso più
generale), ma al di fuori di ogni determinazione temporale o d’altro
genere e al di fuori di ogni rapporto con il parlante9.
La frase nominale esprime dunque una verità che non ha alcun
rapporto con il tempo: essa ricorre perciò in testi dal contenuto
morale o dogmatico, dotati di un alto valore autoritativo, in
sentenze e proverbi (es. il latino varium et mutabile semper femina). La frase nominale abbonda nei Gths, testi iranici che si
presentano come un «catechismo rude, successione di affermazioni di verità e di definizioni implacabili, autoritario richiamo
ai principi rivelati»10. Viceversa, la frase verbale (o con copula)
ricorre in testi narrativi (è il caso di Erodoto), nei quali si vuol
far riferimento a una precisa situazione temporale. Così pure,
nelle espressioni di possesso rese con il verbo essere + dativo
(essere a qualcuno), la frase costruita lasciando implicita la copula indica un possesso permanente e assoluto, quella in cui è
esplicita indica invece un possesso temporaneo. La caratteristica
peculiare della frase con copula è dunque quella di esprimere
una determinazione temporale: essa «introduce nell’enunciato
9
E. BENVENISTE, La frase nominale, in Problemi di linguistica generale,
tr. it. di M. V. Giuliani, il Saggiatore, Milano 1971, p. 187.
10
Ivi, p. 195.
Introduzione
15
tutte le determinazioni verbali e lo situa in rapporto al parlante»11.
Da tutto ciò emerge una questione determinante: la presenza
della copula in un enunciato implica un riferimento temporale, e
dunque esprime una verità legandola necessariamente a un
tempo e a una situazione. È questa la funzione specifica del
verbo, quella di esprimere il tempo, e il verbo essere era, scrive
Benveniste, un verbo a tutti gli effetti, «prima di cadere — al
termine di un lungo sviluppo storico — al rango di “copula”»12.
Se allora si assume come forma canonica del giudizio la forma
“S è P”, inevitabilmente ciò comporta l’assunzione di una dimensione temporale. Tutti gli sforzi di costruire un linguaggio
logico che esprima la verità al di fuori di ogni determinazione
temporale hanno cercato perciò necessariamente di aggirare la
copula: l’espressione funzionale Fx ha esattamente questo
scopo. Tuttavia, come osserva C.H. Kahn, l’eliminazione della
copula nella scrittura Fx è solo apparente:
Non è un caso che Fa sia letto comunemente come “a è F”. E se questo è
quanto intendiamo col verbo essere come segno di predicazione, dovrebbe
esser chiaro che essere non può essere eliminato dalla struttura profonda,
nella misura in cui la struttura profonda deve comunque mantenere una
qualche analogia con le forme della logica predicativa. Ci deve essere
qualcosa nella struttura degli enunciati che corrisponda alla forma Fx, e
da qui alla forma x è F o S è P 13.
Se questo è vero, se cioè la forma “S è P” costituisce una
forma inaggirabile con cui noi comprendiamo ed esprimiamo
ogni verità, al punto che il verbo essere non può essere eliminato dalla struttura profonda dell’enunciato, quali sono le sue
ricadute sulla concezione della verità? A prima vista, si potrebbe dire che si tratta qui in fondo di un destino proprio della
lingua in cui tale fenomeno linguistico ha assunto un ruolo così
preponderante, tanto da orientare l’intera metafisica dell’Occi11
Ivi, p. 189.
Ivi, p. 188.
13
C.H. KAHN, On the Theory of the Verb “To Be”, in: M.K. MUNITZ (a cura
di), Logic and Ontology, New York University Press, New York 1973, p. 12.
12
16
Introduzione
dente: eppure, quello su cui possiamo riflettere, è se la copula
non sia solo il “rappresentante” eminente di una funzione che è
costitutiva di ogni lingua. Si tratta di un problema già noto agli
interpreti di Aristotele: significativa al proposito è l’osservazione di Averroé nel suo commento al De interpretatione. Rilevando come nella sua lingua, l’arabo, la frase nominale sia molto
più frequente di quella con copula, Averroé afferma che ciò non
esclude la presenza di una funzione congiuntiva, la quale viene
semplicemente esplicitata dalla copula (in actu et apparet
manifeste), ma che è già presente (in potentia et subintellectum)
nella frase nominale14. Anche nella frase nominale si attua
dunque una sintesi, per quanto non rappresentata da un elemento linguistico esplicito, ma da un semplice spazio vuoto15.
Se con il nome di “copula” si indica allora il correlato linguistico di un tale atto di sintesi, essa non può più essere
considerata un mero sovrappiù, che non contribuisce in nulla al
senso di ciò che per suo tramite è unificato, espresso e
compreso. Una teoria del giudizio deve, necessariamente, partire dalla domanda sul ruolo e sulla funzione della copula, porre
cioè il problema, per dirla in termini heideggeriani, del «senso
dell’essere»: essere quindi, non semplicemente una logica, ma
un’ontologia.
14
AVERROÉ, Commentum medium super libro Peri hermeneias Aristotelis, a cura di R. Hissette, Lovanii Peters, 1996, pp. 17–18.
15
Il problema perciò sembra essere meno quello della presenza effettiva
della copula che non piuttosto quello del ruolo o della funzione che essa rappresenta: per una discussione di questo punto, cfr. J. DERRIDA, Il supplemento
di copula, in Margini della filosofia, tr. it. di M. Iofrida, Einaudi, Torino 1997.