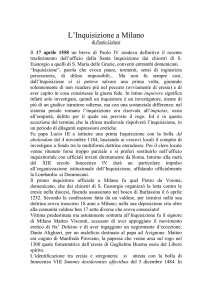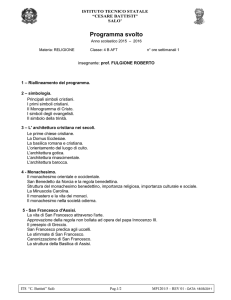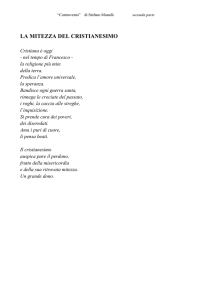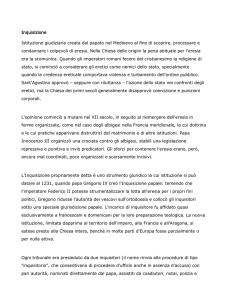RIFLESSIONI
Quale futuro?
di Kristjan Knez
«V
È doveroso
riconoscere tutto
Come andare avanti? Nel terzo millennio è ormai anacronistico guardare ai processi storici secondo una visione manichea, che
non tiene conto delle complesse vicende del confine orientale
e delle peculiarità di una regione plurale in cui s’intersecavano
interessi e posizioni diverse, anche all’interno delle stesse componenti nazionali.
E invece, l’era fascista per taluni costituisce l’unico metro per
misurare gli avvenimenti della storia recente delle nostre terre, per additare colpe, per evidenziare gli sbagli compiuti (a senso
unico) dal nazionalismo italiano,
che avrebbe oppresso gli Slavi già in epoca asburgica, aprendo così la strada alla successiva
snazionalizzazione fascista. Nella stagione in cui in tutta l’Europa sbocciava il sentimento nazionale, che poi, inevitabilmente
avrebbe portato al nazionalismo,
ha senso parlare di un nazionalismo “buono” in quanto difensivo
e di uno “malvagio” data la sua
natura aggressiva?
Nell’Impero austro-ungarico, anche grazie alla politica del
“divide et impera” caldeggiata da
Vienna, le contrapposizioni nazionali erano all’ordine del giorno. Attilio Tamaro, attento osservatore degli avvenimenti del suo
tempo entro i confini della duplice monarchia, aveva colto perfettamente i problemi che la attanagliavano e nel primo dopoguerra, in uno dei suoi innumerevoli scritti, molto opportunamente
rammentava che in realtà in quella compagine tutti erano sia oppressi sia oppressori.
Segue a pagina 8
Maggio è stato il mese degli appuntamenti importanti con i grandi
nodi del nostro passato ma, a giudicare dagli eventi annunciati, giugno... non sarà da meno. Attesa per
il nuovo volume del Centro di Ricerche storiche di Rovigno: il tomo
XLI degli “Atti” – la più feconda e prestigiosa collana dell’Ente
– verrà presentato venerdì prossimo alla Comunità degli Italiani di
Sissano (ore 18). In concomitanza
(ahimè) con la promozione a Trieste (Libreria “Minerva”) della monografia “Capodistria – la città e il
suo territorio”, di Salvator Žitko,
tradotta in italiano dal Centro Italiano “Carlo Combi”. Prima, però,
sbarcherà nel capoluogo giuliano,
nell’ambito di “Trieste, una storia
scritta sull’acqua – i lunedì marinari dei Civici Musei Scientifici”,
appunto lunedì prossimo 4 giugno
(ore 18, Civico Museo del mare)
la significativa opera “Gli ultimi
giorni della Serenissima in Istria
- L’insurrezione popolare di Isola
del 1797” (Edizioni “Il mandracchio” della Comunità degli Italiani
“Pasquale Besenghi degli Ughi”
di Isola d’Istria). Oggi, intanto,
alla CI capodistriana “Santorio Santorio”, si esploreranno e sonderanno
“in cucina” i legami
tra tradizione e storie
regionali articolate
nei secoli tra dominazioni, occupazioni e commerci per terra e per
mare. Una piacevole occasione
per approfondire queste tematiche sarà il
convegno internazionale “La
cucina istriana tra tradizione ed innovazione”. Interessanti i
due libri, “Il tempo
dei confini” (atlante storico dell’Adriatico nord-orientale
nel contesto europeo e
mediterraneo –, con un
grande numero di carte,
semplici e immediate, per
comprendere gli spostamenti
delle frontiere dal 1748 al 2008,
e “Un’epoca senza confini” (antologia sulla questione adriatica tra
Ottocento eprimo Novecento), editi
dall’Istituto regionale per la storia
del movimento di liberazione nel
Friuli Venezia Giuia, che verranno illustrati entrambi giovedì prossimo nel Settore italiano della Biblioteca centrale di Capodistria.
E probabilmente ce ne saranno ancora tanti altri di incontri da
segnalare, ma per il momento ci
fermiamo qui e veniamo ai contenuti di questo “Storia & Ricerca”. Grandi nodi del nostro passato, si diceva in apertura: e in
questo numero di parla innanzitutto di eventi che determinarono
le sorti della regione alla metà del
secolo scorso, di una lacerazione profonda e insanabile. Pubblichiamo la seconda parte del saggio di Ezio Giuricin sui retroscena
dei rapporti tra le varie Resistenze in Istria – “giochi” che trasformeranno la presenza italiana
maggioritaria in una minoranza spesso asservita al potere jugoslavo e comunista –,
ma ci soffermiamo pure a riflettere – con Kristjan Knez – sul significativo percorso della memoria
e della riconciliazione compiuto
a metà maggio da esuli e rimasti
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, spiegando anche perché,
come momento-simbolo di questo
nuovo dialogo, sia stata scelta la
foiba di Terli. E lo facciamo con
la collaborazione di Paolo Radivo, che ai fatti di maggio 2012 dedica ampio spazio sul nuovissimo
numero dell’ “Arena di Pola”, il
giornale degli esuli polesi.
Tanja Škopac ci guida alla riscoperta di un “tassello” istriano, anzi albonese, nella tragedia
del “Titanic”, rispettivamente del
transatlantico “Carpathia” che
ne soccorse i naufraghi cent’anni fa; in chiusura due “letture”
consigliateci da Fabio Sfiligoi e
Carla Rotta.
LA VOCE
ce
vo
/la
.hr
dit
w.e
ww
ae victis – Guai ai vinti”, credo non vi sia
locuzione
migliore
per indicare lo stato in cui si trovarono gli Italiani dell’Adriatico
orientale al termine della seconda
guerra mondiale. Precipitati in una
sorta di limbo, erano destinati a
subire le nefaste conseguenze della politica scellerata del fascismo,
che per due decenni aveva seminato vento nella Venezia Giulia,
e dalla primavera del 1941 anche
nello scacchiere balcanico, commettendo non poche nefandezze.
Ma a differenza dei connazionali
residenti in altre parti dello Stivale, che, dopo la stagione plumbea
della guerra civile, dei bombardamenti alleati o delle dure rappresaglie naziste, poterono avviarsi
a una vita nuova, contraddistinta
dalla ricostruzione e da una volontà di rinascita in senso lato, al confine orientale ci fu un corso diverso degli eventi.
La cosa fu evidente già all’indomani dell’8 settembre. Dopo
l’armistizio, le Nuove Province
cessarono d’appartenere al Regno.
Se Trieste, a seguito delle articolate vicende diplomatiche, durate
quasi un decennio, ritornò all’Italia, a oriente di Muggia la cesura
fu completa e un ambiente umano, sociale, linguistico e culturale sarebbe scomparso per sempre.
Quella metamorfosi che produsse
un dramma, che si consumò con
modalità e in tempi diversi a seconda della località interessata, ha
diritto di entrare nel ricordo della
Nazione italiana? E la sua popolazione può interrogarsi su quanto
accadde in quella parte del Paese?
Oppure si dovrebbe stendere, nuovamente, il velo del silenzio e fare
finta che nulla accadde, ossia considerare quegli accadimenti come
la giusta conseguenza della precedente politica fascista, che aveva
portato un intero popolo sull’orlo
del baratro?
Sono domande che a distanza di tanti decenni fanno ancora discutere animatamente e, nonostante il tramonto delle ideologie, questi argomenti suscitano ancora polemiche e sollevano
vespai. Almeno tra le nostre contrade. Non è inusuale individuare
dei circoli che argomentano quei
problemi usando schemi fossilizzati, che ormai dovrebbero essere
tutt’al più oggetto di indagine storiografica in quando superati, ma
significativi per cogliere i nessi di
determinate scelte e prese di posizione nell’immediato dopoguerra
e negli anni successivi.
IN QUESTO NUMERO
DEL POPOLO
storia
e ricerca
An
no
VII
• n.
012
62 • Sabato, 2 giugno 2
2 storia e ricerca
Sabato, 2 giugno 2012
I momenti cruciali della Resistenza in Istria e a Fiume (2 e continua)
CONTRIBUTI
Le sorti di queste terre
Terli,
erano già state decise altrove La vicenda è stat
di Paolo Radivo
di Rosanna Turcinovich Giuricin
“Gli Italiani dell’Adriatico orientale”: questo il titolo del convegno
organizzato a Perugia, dove la Società di Studi fiumani ha raggiunto con
l’ISUC (Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea) un accordo
per stimolare soprattutto le scuole al dibattito sulle vicende di Istria, Fiume e Dalmazia. Al dibattito sulla Resistenza, Ezio Giuricin ha spiegato
il coinvolgimento degli italiani nella Lotta popolare, il rapporto con gli
jugoslavi, il passaggio da popolo di maggioranza a minoranza nazionale attraverso i complessi e controversi risvolti che il fenomeno della resistenza ha assunto in Istria ed a Fiume. In un numero precedente abbiamo riportato una prima parte del suo intervento; proponiamo di seguito
la continuazione. Giuricin aveva ripercorso la fondazione dell’Unione
degli Italiani, tra il luglio del 1944 e il marzo del 1945, risultato più esplicito del complesso processo politico, ideologico e militare che ha portato al completo assoggettamento degli antifascisti e dei comunisti italiani
di quest’area al movimento popolare di liberazione e al partito comunista jugoslavi (croati e sloveni). Processo tutt’altro che semplice e lineare, anzi, contrassegnato da tensioni e contrasti che hanno posto in risalto l’esistenza di profonde divisioni all’interno del fronte resistenziale.
Nell’area istriana e giuliana si sono di fatto sovrapposte (e a tratti confrontate) due diverse “resistenze”: quella italiana e quella jugoslava. Si
è trattato di due concetti diversi di lotta di liberazione: nazionale e so-
ciale, in un quadro di radicalismo rivoluzionario, per i croati e gli sloveni; sociale, diretta prevalentemente a scacciare l’occupatore ed a lavare l’onta dell’oppressione nazi-fascista, per gli italiani. La resistenza
jugoslava era monopolizzata dal Partito comunista jugoslavo (croato e
sloveno), attraverso le strutture del Movimento Popolare di Liberazione (MPL), in un contesto caratterizzato da un disegno rivoluzionario di
radicale sovvertimento degli assetti e degli equilibri nazionali, sociali ed
economici del territorio. Quella italiana, almeno inizialmente, seguiva
invece lo schema – ampiamente collaudato in tutta l’Italia settentrionale
– della collaborazione fra tutte le forze antifasciste nell’ambito dei Comitati di Liberazione Nazionale. Diverse erano anche le concezioni dei
comunisti: per quelli croati e sloveni il disegno rivoluzionario coincideva ampiamente con quello di liberazione e di espansione nazionale, anzi
risultava essergli subordinato; i comunisti italiani invece erano legati ad
una visione profondamente internazionalista in cui l’obiettivo della costruzione di una società più “giusta” prevaleva su ogni considerazione
di carattere nazionale. Il movimento comunista jugoslavo era riuscito a
“saldare” le forze antifasciste e gran parte delle masse popolari croate e
slovene attorno al suo progetto nazionale e di annessione. Durante l’occupazione tedesca l’antagonismo nazionale segnò pesantemente le scelte
e i comportamenti delle genti giuliane.
L
a situazione divenne difficile specie per gli
antifascisti italiani, in quanto le loro strutture organizzative, nei principali centri urbani, subirono un collasso quasi totale. Infatti, mentre
nell’Italia occupata presero piede quasi dappertutto i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN), che
accomunavano tutti i partiti antifascisti, in Istria
l’azione delle varie forze antifasciste di matrice liberale e democratico-borghese si rivelò quasi sempre limitata e molto debole. Inoltre, gran parte di
queste componenti, disorientate dalle rivendicazioni nazionali del movimento di liberazione croato
e sloveno, furono spinte ad assumere una posizione defilata in attesa dello sviluppo degli eventi. Al
loro isolamento contribuì anche la linea di condotta intransigente del Movimento popolare di liberazione, avversa all’affermazione in questi territori di
qualsivoglia componente antifascista indipendente
e autonoma, compresa quella comunista italiana,
che non accettasse la supremazia e lerivendicazioni nazionalijugoslave (croate e slovene). A Trieste
venne costituito, con il contributo di tutti i partiti democratici antifascisti, prima il Fronte Democratico Nazionale (composto da Gabriele Foschiatti del partito d’Azione, dal comunista Zeffirino Pisoni, dal socialista Edmondo Puecher, dal liberale Gandusio e dal popolare Giovanni Tamasco) e
quindi il Comitato di Liberazione Nazionale (guidato, nella sua seconda e terza composizione, dopo
l’arresto e la morte a Dachau di Foschiatti, da don
Edoardo Marzari e da Ercole Miani).
Il CLN giuliano di allora venne però subito a
trovarsi in una posizione del tutto differente da
quelli operanti nel resto del Paese. Il comitato triestino si trovò ad agire in un isolamento sconfortante: impegnato da un lato nella lotta antinazista,
che richiedeva spirito di sacrificio, mobilitazione
di uomini e mezzi e una forte organizzazione militare, dall’altro a contrastare le pressioni degli sloveni che puntavano ad ottenereil totale controllo
sulle forze resistenziali. Il CLN giuliano venne distrutto per ben tre volte (la prima con l’eliminazione dell’azionista Gabriele Foschiatti – che morì a
Dachau – e l’arresto di Ercole Miani, e le altre con
l’arresto di don Edoardo Marzari), e la sua dirigenza spazzata via, a seguito delle dure azioni di repressione condotte dai nazisti e dai fascisti.
Dopo la decapitazione del PCI triestino e gli
arresti (le cui circostanze avrebbero alimentato a
lungo sospetti e polemiche) dei suoi massimi dirigenti (Luigi Frausin – torturato e ucciso alla Risiera di S. Sabba –, Vincenzo Gigante, anch’egli
torturato e ucciso, Natale Colarich – fucilato – e di
Ermanno Solieri) le sue strutture, completamente
assoggettate alla linea del Partito comunista sloveno, finirono con il sostenere apertamente le tesi annessioniste jugoslave rompendo la collaborazione
con il CLN di Trieste.
L’arresto e l’uccisione di Luigi Frausin
nell’agosto del 1944 dette adito al sospetto – non
confermato – che il dirigente fosse stato catturato a seguito di una delazione pilotata dall’organizzazione slovena (a causa delle posizioni contrarie
da lui assunte sulla questione dei confini durante il
secondo incontro – avvenuto a Milano nel luglio
del 1944 – tra il CLN Alta Italia e l’”Osvobodilna
Fronta” della Slovenia,così come delle sue proteste contro la decisione di trasferire all’interno della
Slovenia il battaglione italiano “Alma Vivoda”).
Sogni autonomistici
A Fiume sorse pure un CLN, seppure in un
contesto molto più confuso e senza l’apporto dei
comunisti ormai inseriti nell’ambito dell’MPL;
situazione che relegò l’organismo ad un’inerzia
e ad un isolamento quasi totali. Forte era al contrario la presenza a Fiume del Movimento autonomista zanelliano che, risorto dopo la caduta del
fascismo, godeva di un largo seguito tra le masse popolari.
Alla componente autonomista i tedeschi avevano persino chiesto di assumere l’amministrazione della città, memori del ruolo da questa sostenuto nel passato austro-ungarico. Gli autonomisti però rifiutarono tale collaborazione, decisi
ad evitare il pericolo di “compromettersi legando la causa fiumana al carro della Germania”.
Lo stesso fecero con i reiterati inviti a collaborare avanzati dall’MPL, anche se in molti casi gli
autonomisti simpatizzarono con i partigiani, porgendo loro aiuto e sostegno.
Altri CLN minori vennero costituiti in alcune
cittadine dell’Istria nord-occidentale, in particolare a Pirano, Isola e Capodistria, sull’esempio di
quello triestino. Pola, invece, per quanto si fosse distinta creando, sin dall’agosto 1943, uno dei
primi organismi unitari denominato “Fronte unico antifascista italiano” (che ebbe un ruolo significativo, in città, nelle tragiche giornate seguite
all’armistizio), non riuscì a costituire, nonostante
tutti i tentativi, un proprio CLN durante la ripresa
della resistenza.
Troppe debolezze
e critiche inascoltate
Di questa estrema debolezza delle forze antifasciste italiane approfittarono gli esponenti del Movimento popolare di liberazione controllato dal Partito
comunista jugoslavo (croato e sloveno) che, specie
in Istria e a Fiume, riuscirono ad imporre gradualmente la loro egemonia strumentalizzando e soggiogando gli antifascisti di matrice italiana e in particolare i militanti del Partito comunista italiano.
Nel mese di dicembre 1943 vennero registrati
altre due importanti avvenimenti: il convegno istriano del PCC dell’Istria, svoltosi a Brgudac il 10 dicembre, e la prima Conferenza istriana del PCC,
che ebbe luogo a Račice (Pinguente) il 25 dicembre.
A Brgudac venne trattato ampiamente il problema
dei rapporti con il PCI, alla presenza di diversi rappresentanti dello stesso, tra cui Vincenzo Gigante Ugo, Ermanno Solieri, Giorgio Sestan e Pino Budicin. Durante il dibattito Pino Budicin criticò il carattere troppo nazionale assunto dal Movimento popolare di liberazione, rilevando grande disappunto per
il modo in cui erano stati liquidati i fascisti durante
l’insurrezione armata. L’oratore si soffermò in particolare sul dramma delle foibe che, come disse, “in
seguito alla propaganda fascista ha generato sconcerto e disorientamento tra la popolazione italiana”.
A Budicin rispose Vincenzo Gigante: “Noi siamo comunisti – disse l’anziano membro del Comitato centrale – e non possiamo parlare in questo momento di divisioni territoriali, ma soltanto di lotta
armata per la sconfitta definitiva del nazifascismo”.
Una delle più importanti conclusioni della riunione
fu che la resistenza in Istria e a Fiume doveva essere
condotta da un solo partito, quello comunista croato, e dalle strutture del Movimento popolare di liberazione jugoslave.
L
a foiba di Terli (in croato
Trlji) è stata la terza delle
quattro tappe del percorso
della memoria e della riconciliazione fra italiani dell’Adriatico
orientale che il Libero Comune
di Pola in Esilio, l’Unione Italiana e FederEsuli hanno attuato sabato 12 maggio in omaggio alle
vittime degli opposti totalitarismi del ’900 in Istria. La voragine si trova nel comune di Barbana presso l’omonimo villaggio,
un centinaio di metri a est della strada che da Vorichi (Orihi)
a nord conduce a Saini (Šajini)
a sud, in una suggestiva area di
landa e boscaglia carsica ancora integra. Davanti a circa 150
convenuti, l’on. Furio Radin, deputato della Comunità nazionale italiana al Sabor e presidente
dell’Unione Italiana, Argeo Benco, sindaco del Libero Comune
di Pola in Esilio, e Silvio Mazzaroli, direttore de “L’Arena di
Pola” e consigliere dell’LCPE,
hanno posizionato a lato della voragine una corona d’alloro con la scritta “Gli italiani di
Istria-Fiume-Dalmazia”. Quindi il parroco di Barbana, di nazionalità polacca, ha pronunciato
una preghiera in italiano. Mazzaroli ha poi recitato l’Invocazione
per le vittime delle foibe, scritta
dall’esule rovignese mons. Antonio Santin quand’era vescovo
di Trieste e Capodistria. Infine lo
stesso Mazzaroli e Sara Harzarich Pesle, nipote del maresciallo
dei Vigili del Fuoco di Pola Arnaldo Harzarich, hanno lanciato nell’inghiottitoio una seconda
corona. Con tale composta cerimonia quasi tutte le associazioni
degli esuli e l’organizzazione degli italiani “rimasti” hanno voluto manifestare umana pietà verso
le vittime italiane innocenti del
totalitarismo comunista jugoslavo, suggellando così la ritrovata
unità e concordia dopo decenni
di vicende e memorie separate.
Una certezza
in un mare di oblio
Ma perché gli organizzatori
hanno scelto proprio Terli quale simbolo degli eccidi compiuti
dai partigiani titoisti fra il 1943
e il 1945 nell’Istria oggi appartenente alla Croazia? Perché è una
delle non molte foibe istriane riguardo alle quali disponiamo di
certezze sul numero, l’identità,
l’età e altre caratteristiche delle vittime, nonché sulla data e le
modalità del loro assassinio. E
inoltre perché, alla luce di questi
dati inoppugnabili, Terli smentisce clamorosamente le residue
teorie giustificazioniste, minimaliste e assolutorie delle stragi
del 1943 propagate per decenni e
oggi ancora diffuse.
Ecco i fatti. A metà ottobre
del 1943, subito dopo la conquista tedesca dell’intera Istria,
la ricostituita Procura di Stato
provinciale affidò al Distaccamento di Pola del 41° Corpo dei
Vigili del fuoco la ricognizione
delle foibe e cave dove i partigiani filo-jugoslavi avessero
compiuto eccidi fra l’8 settembre e la prima decade di ottobre, dopo la liquefazione delle
strutture istituzionali e militari
storia e ricerca 3
Sabato, 2 giugno 2012
La foiba testimonia gli eccidi compiuti dai partigiani titoisti fra il 1943 e il 1945
la strage nascosta assurta a simbolo
ta ricordata a metà maggio nell’ambito del percorso comune compiuto da esuli e rimasti
È stata scelta questa
foiba perché è un
raro caso in cui
si conoscono il
numero, l’identità,
l’età e altre
caratteristiche delle
vittime, nonché
la data e le modalità
del loro assassinio.
Dati inoppugnabili,
che smentiscono
clamorosamente
le residue teorie
giustificazioniste,
minimaliste e
assolutorie delle
stragi del 1943
propagate per
decenni e oggi
ancora diffuse
del Regno d’Italia. Il comandante del Distaccamento, ing. Gaetano Vagnati, incaricò delle indagini
speleologiche e del recupero delle eventuali salme una squadra coordinata dal maresciallo Arnaldo
Harzarich.
I pompieri polesi agirono subito alacremente malgrado le minacce
lanciate, gli ostacoli frapposti e gli
agguati compiuti dai partigiani alla
macchia i quali volevano impedire
che emergessero le prove dei loro
crimini. Il 2 novembre 1943 la squadra di Harzarich si calò nell’orrido
di Terli, stimandone la profondità
in 95 metri e accertando la presenza
di cadaveri. Il 4 novembre continuò
l’ispezione fino a una profondità di
125 metri e, con un’apposita impalcatura, si recuperarono i poveri resti di 26 persone. Il 12 luglio 1945
il maresciallo Harzarich consegnò
all’Ufficio “J” del Governo Militare
Alleato di Pola (Zona A della Venezia Giulia sotto occupazione angloamericana) una relazione sull’intero
lavoro svolto fra l’ottobre 1943 e il
febbraio 1945.
Carnizza, era il nonno del dirigente Fiat Sergio Marchionne. Davvero struggente la vicenda della famiglia Lazzari, di Medolino. A Terli vennero infoibati sia il padre che
il figlio: Aldo, 18 anni, studente, e
Luca, 40 anni, fuochista. Al momento di riconoscere i cadaveri del
marito e del figlio, la signora Lazzari impazzì per il dolore: potremmo
considerarla la quinta donna vittima
di quel terribile eccidio.
Antifascisti «scomodi»
Questa foto, scattata il 4 novembre 1943 al momento del recupero delle salme, mostra i corpi delle quattro donne infoibate a Terli il 5 ottobre 1943: Albina Radecchi, di anni 21, Caterina Radecchi, di anni 19,
Fosca Radecchi, di anni 17 e Amalia Ardossi, di anni 45 circa
che mentre queste stavano ormai
precipitando.
Grazie a una ricerca incrociata
presso parenti e compaesani, nonché al lavoro di alcuni storici, furono poi identificati i cadaveri di
25 delle 26 vittime, perlopiù residenti nella bassa Polesana: 8 a Medolino, 6 a Carnizza, 5 a Marzana,
3 a Lavarigo, 1 ad Altura, 1 a Gallesano e 1 a Visignano. Erano tutti
civili innocenti: nessun funzionario statale, ex gerarca fascista o affamatore del popolo. C’erano anche 3 minorenni, considerato che
la maggiore età si raggiungeva a
21 anni.
Il calvario era cominciato nella
seconda metà del settembre 1943,
quando furono arrestati nelle loro
abitazioni dai partigiani con la stella rossa. Molti erano stati dapprima
rilasciati, ma nuovamente prelevati la notte del 2 ottobre. Essendo
difatti partita l’operazione “Wolkenbruch”, costoro sapevano troppo, avrebbero potuto fare le spie e
dunque andavano tacitati per sempre, nel caso i nazisti avessero sba-
ti alla vista impedendone il ritrovamento. Così li fecero precipitare
dentro, alcuni ancora vivi o solo feriti. Tanto di là non sarebbero potuti uscire…
Sui corpi i segni
di brutali violenze
Il triste elenco comprendeva
quattro donne. Tra queste le sorelle Radecchi (o Radecca), di Lavarigo: la 21enne Albina (nata il 23
marzo 1922), in avanzato stato di
gravidanza, la 19enne Caterina e
la 17enne Fosca. La loro imperdonabile colpa? Non essersi concesse spontaneamente e “per tempo” ai rispettivi carnefici. Lavoravano tutte in una fabbrica di Pola
e ogni sera, rientrando a casa, si
intrattenevano con dei militari italiani al distaccamento della Regia Aeronautica di Fortuna, presso Altura. In una notte successiva
all’8 settembre i titoisti le rapirono da casa portandole a Barbana
in un edificio dove le costrinsero a
fare le sguattere, le maltrattarono
Furono identificati 25 dei complessivi 26 cadaveri recuperati dai
pompieri polesi. Si trattava di persone perlopiù residenti nella
bassa Polesana: 8 a Medolino, 6 a Carnizza, 5 a Marzana, 3 a
Lavarigo, 1 ad Altura, 1 a Gallesano e 1 a Visignano. Erano tutti
civili innocenti: nessun funzionario statale, ex gerarca fascista o
affamatore del popolo. C’erano anche 3 minorenni, considerato
che la maggiore età si raggiungeva a 21 anni
Ricerche incrociate
Uno dei capitoli era dedicato
alla foiba di Terli. I partigiani titoisti di Barbana vi avevano gettato,
nella notte del 5 ottobre 1943, subito prima dell’arrivo dei tedeschi,
un numero imprecisato di persone.
I Vigili del fuoco polesi ne riesumarono 26, più la carogna di un
cane nero. Su gran parte dei corpi
riscontrarono segni di colpi d’arma da fuoco alla testa o al viso.
All’imboccatura dell’inghiottitoio
notarono poi molte tracce di proiettili, segno che gli assassini avevano sparato contro le vittime an-
ragliato i loro carcerieri. I 5 residenti a Marzana subirono una gogna pubblica: furono radunati nella
piazza del loro paese e “dovettero
bere, alla presenza dei parenti e dei
paesani impotenti, mezzo litro di
nafta”, con quali effetti sulla salute e lo stato d’animo è facile immaginare… In attesa degli eventi,
gli aguzzini rinchiusero gli arrestati dell’entroterra polese in un edificio di Barbana, dove inflissero loro
violenze e sevizie.
Nella notte del 5 ottobre, quando ormai i tedeschi erano alle porte, se ne sbarazzarono pensando che
la foiba di Terli, sperduta in mezzo
alla campagna, li avrebbe occulta-
e le violentarono. Ai primi di ottobre le trasferirono in un rustico
di campagna, dove per tre giorni
di fila continuarono a stuprarle e
seviziarle fino a che, la notte del 5
ottobre, le infoibarono. I Vigili del
fuoco trovarono Albina con una
ferita d’arma da fuoco forse rivelatasi letale subito prima della caduta nell’abisso, mentre Caterina
e Fosca con fratture craniche, probabile segno che furono precipitate ancora vive.
Sugli abusi subiti non vi sono
dubbi; scrisse infatti il maresciallo Harzarich: “si può notare la
Albina addirittura senza mutande e le due sorelle con le mutan-
dine stracciate ai fianchi, il che
dà la certezza che anche agli ultimi istanti le ragazze hanno dovuto impotentemente lottare contro
la brutale violenza partigiana”.
Pietro Gonan, un commerciante 52enne nato il 28 luglio 1891 a
Marzana, venne infoibato per vendetta da tre slavi locali che una decina d’anni prima erano stati condannati a una pena carceraria per
aver violentato e ucciso sua figlia.
La stessa fine toccò al fratello minore Severino, nato il 15 febbraio
1900 a Marzana, semplice carbonaio. C’è però da aggiungere che
Pietro era un antifascista di sentimenti italiani, così come forse Severino.
Antifascisti “colpevoli” di non
volere la Jugoslavia di Tito erano
anche i fratelli Antonio e Guido (o
Giulio) Del Bianco, scalpellini di
Carnizza, staccatisi dal movimento di liberazione jugoslavo dopo
avervi inizialmente militato. E lo
stesso Nicolò Carmignani, vecchio comunista di Gallesano. Gaetano La Perna e Luigi Papo lo dan-
Alla base del fatto vi erano a stragrande
maggioranza cause squallidamente personali:
magari nemmeno vendetta o ritorsione, ma
solo banale invidia, gelosia e/o lussuria
Ancor più inequivocabili sono le
foto dei cadaveri scattate il 4 novembre 1943. Una quarta donna
finì i suoi giorni a Terli: Amalia
Ardossi, di Medolino. Dopo aver
invano tentato di impedire l’arresto del marito Francesco Lorenzin, ne volle seguire la tragica
sorte dimostrandogli il suo amore in questo modo commovente.
I corpi dei coniugi erano legati
assieme col fil di ferro all’altezza del gomito. Di professione Lorenzin faceva il fuochista.
Agricoltore e sagrestano della
chiesa di Medolino era invece il fratello di Amalia, Giacomo Ardossi.
Pietro Basilisco aveva 46 anni, essendo nato a Carnizza nel 1897, e faceva l’ingegnere. Giuseppe Bedrina (o Bedrino), nato a Carnizza nel
1893, aveva 50 anni. Il 23enne Ferruccio Bartoli (o Bertoli), nato a
Padova nel 1920, faceva il commerciante a Carnizza. Martino Chiali,
nato a Marzana il 2 febbraio 1887,
aveva 55 anni. Di Gregorio Clari
sappiamo solo che abitava a Medolino ed era manovale. Giovanni De Prato aveva 56 anni, essendo nato a Marzana nel 1887, e faceva l’oste. Giovanni Garbin era un
manovale 43enne, nato a Visignano
nel 1900. Giovanni Pravich, nato
nel 1920 ad Altura, aveva appena 23
anni e faceva l’agricoltore. Il macellaio 52enne Giuseppe Radolli (Radollovich) era nato a Marzana il 27
dicembre 1890. Di Matteo Tonello
(o Tomillo), nato a Medolino, conosciamo la professione: guardia giurata della società mineraria “Arsa”.
Il 42enne Pietro Vogliacco, nato a
Medolino nel 1901, faceva l’autista.
Il 46enne Giacomo Zuccon, nato a
Medolino nel 1897, commerciante a
no per ucciso nella foiba di Orizi
il 30 ottobre 1945, ma l’improbabile data dell’avvenimento e la verosimile identità tra Orizi (Vorichi)
e Terli fanno propendere per il suo
infoibamento a Terli, come sostenuto dall’esperto prof. Guido Rumici. Alla base della strage di Terli
vi erano dunque per la stragrande
maggioranza cause squallidamente
personali: magari nemmeno vendetta o ritorsione, ma solo banale
invidia, gelosia e/o lussuria.
Ignorata, eppure
si sapeva tutto...
Visto poi che di fascisti in giro
dopo il 25 luglio 1943 non ve
n’erano più, occorreva eliminare
i più pericolosi concorrenti politici: gli antifascisti, democratici o
anche comunisti, che rifiutavano
l’annessione alla nuova Jugoslavia filo-sovietica e volevano rimanere nell’ambito di una nuova Italia libera. L’identikit delle
vittime di Terli confuta perciò in
modo lampante la versione ufficiale del regime jugoslavo secondo cui le foibe del 1943 furono
una spontanea rivolta popolare
dei contadini slavi (buoni) contro
i loro sfruttatori fascisti, capitalisti, latifondisti o comunque italiani (cattivi). Il mito della “jacquerie” istriana dunque non regge alla prova dei fatti.
Dopo la guerra la foiba di Terli
non venne più ispezionata, né furono mai aperti procedimenti giudiziari per individuare i colpevoli del
truce massacro. Eppure si conosceva sia il nome, sia il cognome, sia
il nomignolo del capo dei partigiani jugoslavi barbanesi…
4
storia e
Sabato, 2 giugno 2012
CURIOSITÀ Grazie a una recente ricerca, in cui si combinano fonti orali, documenti e bib
«Carpathia», nave di marinai... i
Furono complessivamente 32 i navigatori provenienti dal territorio dell’odierna Albon
di Chersano e Santa Domenica che si trovarono a bordo della nave in quel fatidico apr
di Tanja Škopac
E
Mate Kiršić e il nipote Redi Kiršić
Ivan Vozila
rano complessivamente 32 i
navigatori provenienti dal territorio dell’odierna Albona e
dai comuni di Chersano e Santa Domenica che si trovarono a bordo della nave “Carpathia” nell’aprile 1912,
cioè nella notte tra il 14 e il 15 aprile
di quell’anno, in cui affondò il “Titanic”. Questo e altri dati sull’equipaggio emergono da una ricerca condotta a scoprire l’esatto numero
degli albonesi che si trovavano
a bordo dell’imbarcazione che
per prima arrivò sul luogo del
disastro e soccorse i naufraghi
del celebre transatlantico della
White Star Line.
Un primo studio sui navigatori istriani sull’RMS “Carpathia”, della compagnia navale “Cunard Line”,
è stato condotto da Lucian Mrzlić,
studente della seconda classe liceale
della Scuola media superiore “Mate
Blažina” di Albona, e dalla sua docente di storia Dijana Muškardin. La ricerca, intitolata “‘Carpathia” – brod
istarskih mornara” (“’Carpathia’ –
nave dei marinai istriani”), è stata premiata alle gare regionali di storia che
si sono svolte il 7 marzo, rispettivamente presentata a quelle nazionali a
inizio maggio, a Ragusa. Infine, il lavoro è stato illustrato ad Albona, nel
Teatrino in cittavecchia, alla presenza delle famiglie di alcuni navigatori
dell’Albonese e dello zagabrese Slobodan Novković, conosciuto quale
unico studioso delle navi “Titanic” e
“Carpathia” in Croazia.
Rimasti fuori
perché... italiani
Prima di quest’indagine era risaputo che tra i 300 membri del personale di bordo del “Carpathia” c’erano pure 70 navigatori provenienti dal
territorio dell’Istria e del Quarnero.
A individuarli tutti era stato proprio
il Novković, e ciò in base all’elenco fornito dalla compagnia “Cunard Line”, proprietaria del transatlantico, il più attendibile in materia,
come confermato ora pure dal Mrzlić
e dalla Muškardin. Tuttavia, essendo
i nomi riportati nella loro grafia/versione italiana o di fatto italiani, tipici cognomi dell’Albonese, trattandoIl documento del Vosilla
Certificato d’imbarco di Francesco Verbanaz
si di alcuni connazionali provenienti
dalla penisola istriana, il Novković,
che ignorava tale fatto, ne aveva tralasciati alcuni. La ricerca svolta da
Mrzlić-Muškardin aggiunge così
alla lista dei navigatori dell’Istria e
del Quarnero una decina di albonesi.
ni che avevamo ricevuto da alcuni membri della nostra famiglia e
dei nostri concittadini. Da tali dati
abbiamo capito che molti marittimi di questa parte dell’Istria erano rimasti sconosciuti alle liste
ufficiali e alle fonti bibliografiche
e letterarie relative alle vicende
del ‘Carpathia’. Noi abbiamo cercato di individuarli in base ai loro
cognomi”, ha spiegato Mrzlić, la
cui famiglia, come pure quella
della sua insegnante Muškardin
e quelle di molte altre nell’Albonese, ebbe in quegli anni
tra i suoi membri (almeno) un
“uomo di mare”. Come risulta dall’analisi svolta da Mrzlić
– Muškardin, gli albonesi lavorarono a bordo come camerieri, fuochisti, ma anche come
traduttori, quest’ultima una delle
prestazioni meglio pagate.
Al Novković,
ad esempio, erano
“sfuggiti” Antonio Vozila, Mate Santaleza,
Domeniko Vozila,
Mate Kiršić e Ivan
Klapčić. A loro si
aggiungono Ivan
Kerševanić, riportato nella lista del Novković,
ma senza la specifica del luogo
di residenza, come
pure tre navigatori
che facevano parte del
personale di bordo sbarcati prima della tragedia, cioè
Mateo Zupičić, Josip Vozila e Antonio M. Dundara, nonché Francesco Verbanaz, il cui imbarco si
Spunta anche
ebbe nel 1914 e che è stato aggiunto nella lista per l’importanza del
un’altra medaglia
suo libretto di navigazione austroOltre ad ampliare la lista dei naungarico e della lettera in italiano
in cui descrisse le difficili condi- vigatori istriani appunto parlando
con i discendenti delle famiglie dei
zioni di vita dell’equipaggio.
marinai, la ricerca ha portato alla
I ricordi raccolti
scoperta della presenza nel territorio dell’Albonese di un’altra medadai discendenti
glia di bronzo di quelle che ciascun
“Ciò che ci ha spinti a fare que- navigatore del “Carpathia” ricevetsta ricerca sono state le informazio- te per aver aiutato i naufraghi del
ricerca
Sabato, 2 giugno 2012
5
bliografia, sono stati «identificati» nuovi nomi nell’elenco dell’equipaggio del transatlantico
istriani
na e dai comuni
rile del 1912
Antonio Vosilla
“Titanic”, assieme al doppio stipendio. In effetti, a quella conferita dai
sopravvissuti a Jakov Kranjac, della
cui esistenza già si sapeva in precedenza, si è aggiunta quella assegnata
a Mate Kiršić. La prima è finita nelle mani di Fabio Juričić, pronipote
del Kranjac, mentre a possedere la
seconda è un suo discendente, Redi
Kiršić.
Alcune testimonianze
Ma nel patrimonio lasciato dai
navigatori albonesi del “Carpathia”,
figura pure il libretto d’imbarco sulla nave “Carpathia”, affondata da
un sottomarino nel 1918, appartenuto ad Antonio Vosilla. Nella notte del naufragio del “Titanic” Antonio Vosilla, che lavorava come magazziniere, dovette aiutare a calare
le scialuppe di salvataggio in mare
e il cameriere e traduttore Jakov
Kranjac ebbe l’ordine di contribuire all’accoglienza dei naufraghi. Per
Mate Santaleza uno dei momenti
più traumatici della sua vita fu l’arrivo del “Carpathia” a New York,
a Ellis Island, dove le famiglie e i
parenti dei passeggeri del “Titanic”
aspettavano la nave con la speranza
di vedere tra i circa 700 sopravvissuti i loro cari.
Si continuerà a indagare
“La gente gridava i nomi dei passeggeri e piangeva”, questo il ricordo
lasciato dallo Santaleza. Mesi dopo
lo sbarco, lo stesso Santaleza ricevette da una certa signora Astor di New
York una lettera con alcune monete
d’oro: era un gesto di ringraziamento da parte di una delle sopravvissute
del “Titanic”. Secondo la Muškardin,
la ricerca sui navigatori albonesi del
“Carpathia” non finisce qui. È lecito,
dunque, attendersi nuovi dati e informazioni sugli eroi che parteciparono all’operazione di salvataggio dei
naufraghi del “Titanic”. Come dichiarò in un’occasione al rotocalco
“Vikend” uno dei marittimi albonesi, Mate Peršić, quando il capitano
del “Carpathia”, Arthur Henry Rostrom, ordinò di cambiare rotta nessuno dell’equipaggio poteva capacitarsi del fatto che accorrevano in aiuto ai passeggeri del “Titanic”, che era
colata a picco la nave “inaffondabile”. O almeno così tutti avevano creduto fino a quel fatale impatto con un
iceberg.
Le foto e i materiali sono
stati forniti delle famiglie dell’Albonese e pubblicate nella ricerca
Mrzlić – Muškardin
Jakov Kranjac e moglie
La medaglia del Kranjac
6 storia e ricerca
Sabato, 2 giugno 2012
Le intercettazioni dei militari tedeschi prigionieri degli Alleati
«Soldaten»: combattere,
uccidere, morire
C
erto a leggere il titolo il primo pensiero che un po’ banalmente viene in mente è
una raccolta di strisce di “Sturmtruppen”, il più apprezzato e famoso
fumetto creato da Franco Bonvicini,
meglio conosciuto come Bonvi. Ma
“Soldaten” titolo del libro stampato dalla Garzanti è lontano anni luce
dalla satira del fumetto e molto più
vicino ad essere un documento di rilevanza storica capace di aprire una
nuova quanto inedita finestra sui fatti della Seconda guerra mondiale.
Rettungswiderstand: è la parola tedesca con cui si identificano
forme di resistenza palese agli ordini di sterminio impartiti ai “Soldaten” durante il conflitto. “Soldaten” è appunto il libro che raccoglie
le registrazioni, oggi si direbbero le
intercettazioni, dei colloqui di circa diecimila prigionieri tedeschi selezionati da inglesi e americani in
due luoghi di detenzione speciali
perché potessero appunto parlare
tra loro in apparente libertà e fornire quindi informazioni.
Cento su 17 milioni
Dai colloqui registrati per anni
da inglesi e americani, dai rapporti interni tedeschi e dai documenti
della efficientissima burocrazia tedesca risulta che i casi di “Rettungswiderstand” furono cento. Cento
su diciassette milioni di arruolati
nei sei anni del conflitto. Cento su
diciassette milioni fecero almeno
un tentativo di non ubbidire fino in
fondo ad Hitler quando l’ordine era
di sterminare civili o “sotto umani”.
Cento su diciassette milioni, neanche una percentuale, un nulla. Cento “soldaten” su diciassette milioni
che esitarono e mostrarono di esitare nel doversi trasformare da soldati
in assassini. È una cifra della storica vergogna tedesca ed è soprattutto una cifra della epocale vergogna
umana, di tutta l’umanità.
Fermatevi un attimo, ritornate inietro nel tempo anche con la
fantasia se si vuole, e immaginate
le voci in tedesco, pioverci addosso da un’ altra era e un altro luogo, appunto come un viaggio a ritroso nel tempo. Dai campi di prigionia inglesi e americani durante
la Seconda guerra mondiale: Trent
Park e Wilton Park nel Regno
Unito e di Fort Hunt negli Usa. La
lingua è aspra, come le storie che
racconta: sono soldati dell’esercito del Fürher finiti tra le maglie
del nemico. Tra di loro è in corso
una gara a chi la spara più grossa,
a chi ne ha viste e fatte di più. Un
modo come un altro per vincere la
noia della detenzione e dimostrare
che la banalità del male ha molte
facce: persone comuni trasformate in aguzzini e boia dall’insensatezza della guerra.
I verbali sono il frutto del lavoro della rete dei Secret Interrogation Center, allestiti da Londra già
all’inizio della guerra, e degli Joint
Interrogation Centre, resi operanti
dagli americani a partire dall’estate
del 1941. Sul milione di prigionieri caduti in mano alleata sono circa 10.000 i militari tedeschi e 563
gli italiani (su questi in “Soldaten”
emerge piuttosto poco) trasferiti,
dopo opportuna selezione, in questi luoghi di detenzione speciale.
L’obiettivo non è raccogliere prove per punire azioni criminali, ma
fornire all’intelligence alleata materiale prezioso sull’avversario che
si sta ancora fronteggiando.
di crimini innegabili e l’uccisione
era per loro normale routine, anche
quando riguardava donne, bambini e civili innocenti, presi com’erano a risultare “perfetti nazisti spietati“. Inglesi e americani operarono intercettazioni sistematiche nei
campi di prigionia, registrando su
vinile i passi più interessanti e redassero copie a stampa riempiendo oltre 150 mila pagine di verbali.
Così nelle trascrizioni degli interrogatori, si leggono dichiarazioni talvolta raccapriccianti, come quando
i soldati tedeschi parlano di “divertimento” e “puro divertimento” nel
massacrare civili innocenti e truppe
nemiche.
Uccidiamone venti
per stare calmi
Pohl: “(…) Era il nostro giochetto prima di colazione, andare
con i mitra a caccia di soldati solitari per i campi, e poi, con due pallottole, stenderli e lasciarli a terra
alla rinfusa.”
Meyer: “Ma sempre contro i
soldati?”
Pohl: “Anche contro le persone. Abbiamo attaccato la gente in
fila per strada. Eravamo un aereo
dietro l’altro”. (…)
Schmid: “Ho sentito del caso di
quei due furfanti quindicenni. Erano in uniforme e sparavano all’impazzata. (…) Alla fine, li hanno
scovati entrambi (…) Gli hanno
fatto scavare la fossa, due buchi,
poi hanno fucilato il primo. Che
però non è caduto nella fossa, ma lì
davanti. Allora hanno detto all’altro
che doveva spingerlo dentro, prima
di essere fucilato anche lui. E l’ha
fatto, con aria spavalda! Un delinquente di quindici anni! Questo sì
Un caporale chiamato S. raccontava di quando la sua unità si
trasferì in un villaggio in Italia
dopo la caduta del governo Mussolini, il primo compito era sempre
quello di uccidere un paio di civili, poi l’asticella si alzò:”In Italia,
in ogni posto dove arrivavamo, il
tenente diceva sempre: “Per prima
cosa facciamone fuori qualcuno!
Fatene fuori venti, così avremo un
po’ di calma, che non si facciano
strane idee!”.
Si legge poi nel libro, in una
conversazione del 19 dicembre
1944. Dal fronte orientale, alle incursioni sulla Gran Bretagna, alle
invasioni in Italia, Francia e Nord
Africa, le testimonianze coprono larga parte del teatro di guerra.
Un aviatore della Luftwaffe, identificato come B pilot, riferisce del
“divertimento enorme” nello sparare sulle colonne di civili in fuga
lungo le strade di Francia e Belgio
Harald Welzer
che è fanatismo, o idealismo!”.
Ecco questi sono solo alcuni esempi di quanto si può trovare
nel libro. “Soldaten” – Combattere, uccidere, morire” (il titolo completo) da più parti è stato definito
un libro sconvolgente: per realizzarlo gli autori Sönke Neitzel (storico) e Harald Welzer (psicologo)
hanno spulciato per anni negli archivi di Stato di Londra e Washington, a caccia delle intercettazioni
delle conversazioni tra migliaia di
prigionieri tedeschi, avvenute dal
’40 al ’45.
Il libro ci racconta che i ligi soldati dell’esercito tedesco, così come gli ufficiali della Luftwaffe “non erano migliori delle SS”. Si sono macchiati
“Soldaten” è una sorta di vivisezione operata su una significativa
campionatura del grande corpo delle armate di Berlino
nel sangue, amico mio che divertimento“.
Che dispiacere
per i cavalli...
Un altro si vantava: “Nella nostra squadra ero conosciuto come
il “sadico professionale”. Ho buttato giù tutto: gli autobus, un treno di civile a Folkestone. Ho ucciso ogni ciclista”. Un altro aviatore, denominato P pilot, ha raccontato come fosse stato “davvero
triste” avere mitragliato i cavalli
dell’esercito polacco durante l’attacco a Poznan nei primi giorni della guerra: “La gente non
mi preoccupava, ma mi dispiace-
Sonke Neitzel
nel 1940 “è stato un grande successo, bello, enorme, fantastico divertimento!“.
Le case tremavano
In un’altra intervista, lo stesso
pilota parlando della celebre Battaglia d’Inghilterra, diceva che era
“favoloso” vedere le finestre delle case tremare e aggiungeva: “Sul
mercato abbiamo visto persone
che si sono riunite, la gente parlava. Abbiamo tirato fuori le pistole.
È stato divertente”. E sempre durante la Battaglia d’Inghilterra, un
altro pilota: “…abbiamo visto una
festa in una villa, abbiamo sparato, ragazze in abito sexy e uomini
in abito elegante schizzavano via
rà per quei poveri cavalli fino alla
fine dei miei giorni...”. L’elenco di
atrocità è lungo, si parla – tra l’altro – di stupri atroci e di navi affondate cariche di bambini, l’inimmaginabile.
Ha detto un critico che prima
di “Soldaten”, i tedeschi potevano
trarre conforto dal fatto che i crimini dei loro soldati fossero limitati a
pochi. Non è più vero tutti, o molti, a quanto pare, furono contaminati dal nazismo e infausi di sete di
sangue. E cade anche quanto sostenuto fino ad oggi dagli storici, ovvero che era quasi impossibile per
un soldato della Wehrmacht avere
informazioni circa l’uccisione degli
ebrei. Le conversazioni intercettate
confermano invece che praticamente tutti sapevano, o almeno avevano
il sospetto e non sono mancati soldati che di tanto in tanto hanno partecipato volontariamente alle fucilazioni di ebrei.
Come si può notare da questo
breve “assaggio” Soldaten” può essere interpretato come un catalogo
degli orrori. Crudeltà che vanno ben
al di là della ferocia insita in ogni
guerra. Lo storico Sonke Neitzel e
lo psicologo sociale Harald Welzer
cercano di ricostruire il mondo interiore dei soldati di Hitler, e com si
intuisce non è lettura per palati fini.
O per sensibilità delicate. Ma è un
documento di inestimabile valore
per gli storici: una sorta di vivisezione operata su una significativa
campionatura del grande corpo delle armate di Berlino. I kamaraden,
ignari – o, forse, in alcuni casi, incuranti – di essere intercettati dalle “cimici” installate nelle baracche di questi campi speciali, si raccontano l’un l’altro quella che per
loro, alla fine, è stata solo la pratica
quotidiana del mestiere di soldati
di Hitler. Le nefandezze e i delitti vengono descritti come se fossero la cosa più scontata e normale.
“Soldaten” spiega come questi siano i frutti maturati in Germania in
poco più di sei anni – dall’avvento
di Hitler nel 1933 allo scoppio della guerra –, della convinta adesione
della maggioranza della società tedesca al mito della “razza eletta”.
Ancora una volta la Storia dimostra che non conta l’irrealtà di una
situazione quanto il fatto che “chi
vi è immerso la possa percepire
come reale”.
Come sottolinea il sociologo
americano William I. Thomas, anche i fatti immaginari – ad esempio
il “complotto ebraico” da estirpare
per salvare la Germania – finiscono
con l’avere conseguenze reali: l’infinito sgranarsi di brutalità e crimini rievocato, senza rimorsi né dubbi, nelle intercettazioni di Soldaten,
ne è la prova. Secondo lo storico
Wolfram Setter furono poco più di
un centinaio i casi di “Rettungswiderstand”, ovvero di resistenza agli
ordini finalizzata a salvare vittime.
Cento su oltre 17 milioni di soldati della Wehrmacht nel corso di sei
anni di guerra. Tutti gli altri si adeguarono. Da volonterosi carnefici,
da zelanti complici o da obbedienti
boia. (fas)
storia e ricerca 7
Sabato, 2 giugno 2012
LETTI PER VOI «L’Inquisizione», di Michael Baigent e Richard Leigh
Pagine di persecuzioni,
ideologie, potere, morte
di Carla Rotta
“Un’indagine storica sobria e documentata. Un resoconto incisivo e, spesso, sconvolgente che ricorda a tutti come, in certi periodi, la
chiesa e la camera delle torture fossero terribilmente vicine...”. Cosi il “The Sunday Telegraph” su “L’Inquisizione”, di Michael Baigent e
Richard Leigh. Abbiamo letto per voi il volume pubblicato dalla Marco Tropea Editore. Oltre 300 pagine di avvincente e coinvolgente (e a
volte scabroso) viaggio nell’Inquisizione, nelle
sue diverse vite e diversi meccanismi in geografie diverse, ma con un denominatore unico fatto di torture, violenza, paura, sangue, cinismo,
corruzione, fanatismo... Di primo acchito, e a
S
iamo nell’estate del 1206. Il
vescovo e il vicepriore della
cattedrale di Osma, Domenico Guzman, sta attraversando il
meridione francese. L’eresia catara sta già impensierendo la Chiesa:
anzi, decisamente si è andati oltre
il fastidio.
Il 27 novembre 1095 papa Urbano II aveva bandito la I crociata. La Chiesa aveva affilato le armi
contro gli infedeli islamici e incitato alla riconquista del Santo Sepolcro. Nel 1208, mentre in Terra
Santa le spade e le lance si incrociavano ancora con inaudito fervore, Innocenzo III bandiva la quinta crociata, solo che non si guardava più all’Outremer, perché il “nemico” da affrontare e vincere era
in casa, nel sud della Francia: bisognava avere ragione dell’eresia
catara (o albigese, dal primo centro dell’attività, Albi). I catari erano oppositori della Chiesa romana;
essenzialmente erano dualisti, consideravano la creazione materiale
malvagia e quella spirituale “superiore”.
Era una buona risposta alla corrotta Chiesa del tempo. All’epoca
il papa in persona diceva dei suoi
preti che erano “peggiori delle bestie che sguazzano nel loro stesso
letame”, i vescovi “pescatori di denaro e non di anime”. Ma le defezioni che si manifestavano all’interno del cattolicesimo impensierirono il papa, che cercò di fermare
il fenomeno. Bezeries, roccaforte
catara, venne messa a ferro e fuoco, saccheggiata, e quando al legato pontificio Arnald Amaury venne chiesto di distinguere gli eretici dai cristiani, in modo da punire
solo i primi, questi rispose dicendo
“Uccideteli tutti: Dio riconoscerà i suoi“. Il Mezzogiorno francese venne incendiato. Letteralmente. Gli eretici finivano sul rogo, chi
tentava di difenderli veniva impiccato.
non conoscere la storia, si potrebbe affermare che tanto sia difficilmente sposabile al cattolicesimo romano, eppure, nell’ambito di questo stesso cattolicesimo romano l’Inquisizione
è stata uno degli aspetti di notevole importanza, ma che comunque non va identificata con la
Chiesa nella sua globalità.
L’Inquisizione “fu il prodotto di un mondo
brutale, insensibile e ignorante”, e quindi non
potè essere altro che brutale, insensibile e ignorante a sua volta. Comunque, è fuori di dubbio
che con tutti i suoi orrori ed errori, l’Inquisizione è stata importante nell’ambito del cattolicesimo. Vediamone premesse, genesi e percorsi.
le questioni di fede”, nella caccia
agli eretici. Lentamente divennero
indispensabili alla Chiesa.
Domenico morì nel 1222. Nel
1223 divenne papa Gregorio IX,
un amico di Domenico: nell’aprile
dello stesso anno il pontefice con
una Bolla affidò ai frati il compito di sradicare l’eresia. Una seconda Bolla indirizzata direttamente ai
Domenicani specificava che avevano il potere “di privare i clerici
dei loro benefici per sempre, e di
procedere contro di loro e contro
tutti gli altri, senza appello, chiedendo l’aiuto del braccio secolare
ove necessario”.
Il papa istituì un tribunale permanente composto da frati Domenicani e cosi, nel 1234 nasceva a
Tolosa la Santa Inquisizione. Ora,
mandare gli eretici al rogo aveva la benedizione della massima
autorità della cristianità. Piromania istituzionalizzata e all’odor di
incenso. L’Inquisizione si lasciò
dietro una scia di dolore e fiamme, organizzò punizioni che mandarono a morte, in un giorno solo
parecchie centinaia di persone.
Una somma che tenga di conto di
tutta la geografia dell’Inquisizione darebbe numeri da genocidio.
Fuoco purificatore
nobili, che andavano trattati con
rispetto.
Gli interrogatori servivano per
ottenere la confessione: gli strumenti di tortura si affinarono (si
fa per dire), sempre attenti a non
far spargere sangue. La condanna
a morte era l’ultimissima risorsa;
macabro il rituale del fuoco, non
meno macabro quello della distruzione dei resti carbonizzati.
Mentre da una parte si moriva,
dall’altra si faceva di conto. Anche del materiale speso. Per dire,
in riferimento al rogo del 24 aprile
1323 a Carcassone, venne compilato questo elenco spese:
- Per il legname grosso:
55 soldi e 6 denari
- Per i tralci di vite:
21 soldi e 3 denari
- Per la paglia:
2 soldi e 6 denari
- Per i quattro pali:
10 soldi e 9 denari
- Per le funi con cui legare i condannati: 4 soldi e 7 denari
- Per i quattro boia, 20 soldi ciascuno: 80 soldi.
L’Inquisizione fece il suo anche
nel meridione d’Europa: Bulgaria,
Grecia, Bosnia (qui si rifugiarono
molti catari). Per mano dell’Inquisizione scomparirono anche i Templari: troppo forti, troppo potenti,
troppo ricchi, troppo tutto. Davano
fastidio.
Ma nel gioco delle associazioni, a dire Inquisizione si pensa subito alla Spagna. In effetti, lì l’Inquisizione si fece strada molto più
tardi. Si instaurò nel 1238 in Aragona, ma era disordinata e nel
Quattrocento totalmente inattiva.
Nel 1474 salì al trono Isabella di
Castiglia, cinque anni più tardi suo
marito, Ferdinando, divenne re di
Aragona. Isabella e Ferdinando
volevano una Spagna unita, purificata dall’islam, dall’ebraismo e
da qualsiasi eresia. E furono i monarchi a volere l’Inquisizione. Nei
meccanismi poco si differì da quella in atto in altri Paesi.
Non si andò per il sottile. Il fuoco divenne lo strumento principe
dell’Inquisizione. Che, sembra, nel
rispetto di un’antica norma risalente al IX secolo, non doveva far versare sangue. Forse agli inquisitori
il dettaglio sarà dispiaciuto, ma riuscirono a trovare strumenti orribili, che attraverso il dolore fisico
salvavano e redimevano l’anima:
la ruota, lo schiacciapollici, il supplizio della corda, l’immersione in
acqua.
L’Inquisizione metteva paura
anche al solo sentirla nominare.
La delazione era poi diventata una
sorta di sport nazionale e spesso lo
strumento dell’Inquisizione veniva
La nascita
usato per pareggiare conti e beghe
dei Domenicani
assolutamente privati che nulla
avevano da spartire con la Chiesa Il «caso spagnolo»
e del Tribunale
Il 1.mo novembre 1478 papa
e l’eresia. Che clima! PraticamenNella loro visita, sentite le la- te ognuno aveva in una tasca il bi- Sisto IV diede il placet all’istitumentele dei legati papali di Mon- glietto di eretico e nell’altra quello zione di un’Inquisizione particolatpellier sui catari, il vescovo e Do- della spia.
re per la Spagna. Tra i vari sacerdomenico concepirono un piano per Concesso quasi tutto ti e domenicani nominati inquisitoaverne ragione: il vescovo morì
ri si distinse, diventando l’incarnaGli inquisitori ascoltavano fiu- zione dell’Inquisizione spagnola,
e cosi fu Domenico a metterlo in
pratica. Al proselitismo itineran- mi di parole, segreti... e lentamen- il priore del monastero di Segovia,
te degli albigesi Domenico rispo- te si costruivano un archivio che Tomas de Torquemada. La sua folse con il proselitismo itinerante del non avrebbe avuto di che vergo- lia sanguinaria è nota. Ad ondate,
gnarsi di fronte agli archivi delle le esecuzioni fecero diminuire nocattolicesimo.
La Chiesa, insomma, uscì dalle più temute polizie segrete di re- tevolmente il numero dei vivi e auchiese per andare incontro alla gen- cente memoria. Si passava quindi mentare vorticosamente quello dei
te: con i frati di Domenico, istruiti, all’arresto e agli interrogatori. Nel morti.
ottimi oratori, modesti, semplici, corso dei quali, come detto, non si
Alcuni numeri per dire quanto
frugali. L’ordine crebbe e il papa andava per il sottile, fatta eccezio- fossero radicate la paura e l’insicuiniziò a chiedere il suo aiuto “nel- ne per medici, soldati, cavalieri e rezza: alla fine del Quattrocento a
Maiorca (dopo la lettura dell’editto inquisitorio) si autodenunciarono 337 persone, nel 1406 a Toledo ben 2400. Tra il 1480 e il 1490
vennero mandate al rogo nella sola
Castiglia 1.500 persone, tutto sulla base di false denunce. E quindi arsero 1.500 innocenti. Ma l’Inquisizione teneva molto alla quantità. Dall’arresto alla sentenza passavano spesso moltissimi anni, nel
frattempo i sospetti venivano privarti dei loro beni e, mentre questi
aspettavano in carcere il loro destino, le famiglie, magari una volta
ricchissime, morivano di fame.
Espellere gli ebrei
e i musulmani
In Spagna l’Inquisizione si rivolse anche contro gli ebrei. Moltissime famiglie abiurarono la
loro religione abbracciando il cristianesimo: venivano etichettati
come “conversos”. Ma l’Inquisizione aveva messo gli occhi sulle
immense ricchezze della comunità ebraica, e spesso si diffondeva
la voce che in realtà i conversos
continuassero a praticare la loro
fede e questo apriva la porta agli
orrori dell’Inquisizione. Molti
conversos prosperarono, ad onor
del vero, ma la bilancia tra i perseguitati e i fortunati non ha certo
i piatti in equilibrio.
Sembra che ad un certo punto
Corona e Inquisizione (nella persona di Torquemada) vennero ad
un accordo per espellere gli ebrei
dalla Spagna. La battaglia si combatteva, come detto, contro ebrei
e islamici: una ad una caddero le
enclave musulmane. Feroce, implacabile, l’Inquisizione infiammò (è il caso di dirlo) la Spagna
per oltre duecento anni. Assopita, ebbe un risveglio nel 1814,
ma ormai operava senza schedari,
senza dati. L’ultima persecuzione
di un ebreo in Spagna si ebbe a
Cordova nel 1818.
Caccia alle streghe
L’Inquisizione spagnola arrivò
al Nuovo Mondo: laddove con-
quistadores, esploratori, soldati o
coloni spagnoli mettevano il piede, portavano con sé i missionari cattolici e questi l’Inquisizione.
Gli indigeni certo non potevano
venir tacciati di eresia, in quanto la dottrina cristiana non era la
loro, ciononostante l’Inquisizione
riuscì a crearsi il pane.
Mentre l’Inquisizione spagnola
metteva in croce la penisola Iberica e il Nuovo Mondo, l’antica Inquisizione pontificia aveva trovato
un nuovo bersaglio: la stregoneria.
La lotta alla stregoneria aveva un
suo codice, il “Malleus Maleficarum”, scritto da Heinrich Kramer
e Johan Sprenger, un ignobile e
vergognoso fai-da-te per gli inquisitori, i giudici e autorità varie.
Senza girarci troppo intorno è
la prova provata di psicopatologia
sessuale e comportamenti deviati. Gronda di rapporti carnali tra
streghe e diavolo, offre tecniche di
diagnosi, formule per esorcismi.
A leggerlo, non c’è donna che si
salvi, essendo “animale imperfetto
che inganna per natura.” Lo spazio non ci consente di entrare nei
dettagli dei processi, degli interrogatori e delle esecuzioni. La caccia alle streghe raggiunse livelli di
follia. La stregoneria e la lotta a
questa inficiò l’Europa tutta, giunse nel Nuovo Mondo e fece vittime forse più di quelle contate nella già deleteria e infausta crociata
albigese.
E ci fermiamo qua. Il libro
tratta ancora della lotta contro
l’eresia protestante, dei mistici,
di massoneria, dei rotoli del Mar
Morto, della Congregazione per
la dottrina della fede (un eufemismo per dire Inquisizione, senza
fiammiferi però), delle apparizioni della Madonna.
Interessante, senza dubbio, lo
scritto di Baigent e Leigh, al punto che per trattarlo tutto avremo
bisogno di molto più spazio. Consigliamo di leggerlo. Il viaggio
spazio temporale, culturologico,
sociale ed altro che le 300 e passa
pagine offrono ne vale realmente la pena.
8 storia e ricerca
Sabato, 2 giugno 2012
RIFLESSIONI Una storia complessa, un percorso tortuoso della memoria e della riconciliazione
Italiani dell’Adriatico orientale: quale futuro?
R
dalla prima pagina
iteniamo non abbia alcun
senso soppesare il dolore, caso mai è doveroso
riconoscere tutto, senza censure,
escludendo le minimizzazioni o le
mezze verità, perché non giovano
a nessuno. Bisogna avere l’onestà
intellettuale e riconoscere i torti,
non è però assolutamente condivisibile il ragionamento del chiodo schiaccia chiodo, per cui ciò
che accadde dopo dev’essere visto
solo e soltanto come la giusta reazione, mentre il male è riconducibile esclusivamente a ciò che era
accaduto precedentemente.
Le indubbie colpe
del fascismo
Se l’Italia di Mussolini non
avesse occupato il Regno di Jugoslavia, i confini, forse, sarebbero rimasti immutati. E invece,
nella primavera del 1941, i venti di guerra si spostarono sulla
“creatura voluta a Versailles”, il
regio esercito occupò e annesse
quei territori che l’Italia liberale
non ricevette con i trattati di pace
del primo dopoguerra e che furono uno dei simboli della “vittoria
mutilata”; il confine si dilatò anche all’interno e porzioni territoriali, come la cosiddetta Provincia di Lubiana, divennero parte
integrante dell’Impero.
Negli anni del conflitto il comportamento italiano non fu certo irreprensibile, ampie zone furono messe a ferro e fuoco e non
pochi furono gli atti di barbarie
nei confronti della popolazione
civile. Sono episodi documentati che non si possono confutare.
Devono essere conosciuti, celarli non avrebbe alcun senso, altrimenti sarebbe inutile auspicare
che le brutture successive siano
riconosciute in Slovenia e Croazia. Bisogna altresì evitare anche
il perverso ragionamento secondo
il quale proprio quegli atti perpetrati dal regime avrebbero portato
alle foibe e all’esodo.
Ma siamo sicuri che quegli
episodi sono riconducibili esclusivamente al “prima”. Sono solo
il macabro epilogo, la brutta eredità della dittatura fascista? Se ci
addentriamo nelle cose ci rendiamo conto che la questione è molto complessa, e allora l’impalcatura crolla al primo scossone. Se
nel resto della penisola la capitolazione e la firma dell’armistizio rappresentavano la fine delle
ostilità sui vari fronti, e qualcuno,
ingenuamente, intravide la pace,
nelle terre di recente acquisizione
lo scenario fu alquanto diverso.
Per la componente slava, che il
regime aveva conculcato mettendo in atto un genocidio culturale
che avrebbe dovuto cancellare la
presenza slovena e croata, quella
data fu vista come lo schiudere di
una nuova epoca.
Lo Stato italiano con la sua
azione illiberale aveva certamente esacerbato gli animi e giunse
il momento della resa dei conti.
Arrivò il momento in cui si iniziò a raccogliere tempesta. Il progetto politico messo in atto non
era estemporaneo bensì preparato nella fase finale del conflitto (già accolto con le dichiarazioni del 1943 a Pisino, a Kočevje,
a Jajce), perciò le armate con il
loro potenziale bellico furono impegnate in due distinte corse: a
occidente in direzione di Trieste
e a settentrione verso Klagenfurt,
che raggiunsero a costo di grosse perdite.
Le chiare mire annessionistiche jugoslave
L’ordine era chiaro, d’altra
parte fu lo stesso Edvard Kardelj, nel settembre 1944, a sostenere che “diventerà nostro territorio tutto ciò che si troverà nelle mani del nostro esercito”, pertanto non vi era grande premura
a liberare Zagabria o Lubiana, né
puntare immediatamente contro i
forti nuclei della Wehrmacht ancora presenti sul territorio oppure colpire le forze collaborazioniste, cioè gli acerrimi nemici con i
quali i comunisti avevano lottato
per quattro anni in una guerra civile cruentissima. Erano incombenze che potevano attendere,
era solo questione di tempo.
Non era ammissibile, invece,
che gli Alleati mettessero piede
per primi in due luoghi simbolici.
Ma non erano emblemi del 1945,
erano due città “perse” dopo la
Grande Guerra, ma mai dimenticate. Che si dovessero pareggiare
i conti era pressoché inevitabile
e alla violenza si rispose con altrettanta durezza. Fu una costante registrata praticamente ovunque. Ma dalle nostre parti il disegno era un altro: non furono
colpiti solo quanti avevano avuto
un ruolo decisivo all’interno del
regime del littorio oppure si erano macchiati con crimini di vario genere.
Finirono nel vortice tutti coloro che venivano classificati come
“nemici del popolo”, come pure
coloro che non volevano il comunismo o osteggiavano la politica
annessionistica jugoslava. Era la
cosiddetta “epurazione preventiva”. Ogni discordanza o critica rappresentava un pretesto per
percuotere l’“eversione fascista”.
L’antifascismo divenne un
alibi per colpire tutto ciò che si
discostava dalla linea del regime jugoslavo. Gli Italiani dei lidi
orientali dell’Adriatico erano dipinti per lo più come i carnefici,
non mancavano poi i riferimenti
a una presunta connivenza con il
regime mussoliniano. L’opposizione a quest’ultimo e il contribuito dato dagli Italiani alla Resistenza erano dettagli insignificanti. “Noi pagavamo lì tutte le
colpe del fascismo e della guerra
perduta, ed insieme della leggerezza e della superficialità italiane”, scrive Guido Miglia, esule
da Pola, nell’introduzione al suo
volume “Dentro l’Istria. Diario
1945-1947”, edito nel 1973.
Una minoranza
discriminata
Il terrore e la politica discriminatoria nei confronti degli Italiani non fu una costante solo al termine delle ostilità e nel frangente
antecedente la firma del Trattato
di pace, continuarono per oltre un
decennio e, sebbene con dinamiche diverse, sarebbero continuati ancora per decenni contro ciò
che rimaneva della popolazione
italiana, ridotta a sparuta minoranza, controllata dal regime in
ogni sua espressione e “ammonita”, ma anche pesantemente colpita, ogniqualvolta osava sollevare il capo.
Il Ventesimo secolo con le sue
devianze dovrebbe essere inteso
come uno scrigno di tragedie perché andò a colpire tutti, in primis
la popolazione comune. Le divisioni nette non sono d’aiuto, a
meno che non si vogliano far passare delle “verità” imposte, quel-
le cioè che per essere credibili dovevano, per forza di cose, poggiare
sulla menzogna. I regimi totalitari con il loro utilizzo del terrore di
massa come prassi quotidiana, sotto la regia dell’ideologia, colpirono a prescindere dall’appartenenza
nazionale. Perciò tra le vittime del
fascismo annoveriamo anche tanti
Italiani, ed è assolutamente falso
ritenere fossero solo gli Sloveni e
i Croati (nel caso di questi due popoli inclusi entro i confini di Rapallo alla discriminazione generale si aggiunse quella nazionale,
particolarmente dura), così come
quest’ultimi furono pure perseguitati dal comunismo.
L’offesa maggiore:
l’assenza di rispetto
Nelle aree eterogenee come le
nostre, le ideologie, impregnate di
nazionalismo, ebbero conseguenze
devastanti. L’eliminazione del “diverso”, secondo programmi particolari, studiati a tavolino, fu una
pratica comune a tutti e mostra pa-
lesemente l’incapacità di gestire
aree così peculiari. Quell’assenza di rispetto è forse l’offesa maggiore che ancora oggi brucia nelle
vittime e nei discendenti di queste.
Quei torti andrebbero riconosciuti senza distinzioni. Meritano rispetto sia coloro che furono insultati negli anni Venti e Trenta perché parlavano in “slavo” o non poterono ricevere un’istruzione nella
propria madre lingua, sia verso chi
fu dichiarato d’ufficio “sloveno” o
“croato” e perciò finì in una classe la cui lingua gli era sconosciuta,
o chi dovette abbandonare il luogo
natio troncando in tal modo i legami secolari con la propria terra.
Guido Miglia ricorda che, appena diciottenne, fu mandato come
insegnante in uno sperduto villaggio croato fra Gimino e la valle
dell’Arsa – Milojski Brig (Montemilotti) –, il suo racconto riassume meglio di tanti ragionamenti l’insensatezza umana. “Poveri
bambini, io parlo nell’unica lingua
che conosco, e comprendo che i
più piccoli non mi capiscono; du-
rante la ricreazione li sento parlare piano tra loro, nel dialetto croato, e credo allora che il mio dovere
sia quello di rimproverarli e di farli
parlare italiano. Solo a mie spese,
da adulto, fatto pensoso dalle sciagure vissute dalla mia terra, capirò l’aberrazione di voler impedire
all’altro gruppo etnico di manifestarsi liberamente nella lingua materna. Ma quando lo capirò, nulla
potrà essere modificato nel destino
della penisola, e la vendetta travolgerà la mia gente, che conosceva
soltanto la lingua veneta”.
Ricordare le ingiustizie compiute e subite da tutti e comprendere il
dolore degli altri sono i primi passi da compiere per fare un salto di
qualità. La memoria non può essere
condivisa, può essere però appresa
e riconosciuta. È questo l’obiettivo
tanto auspicato. Ma la strada è ancora tortuosa, sebbene si scorgano
dei momenti che fanno ben sperare,
e, non meno importante, contribuiscono alla riflessione. Per superare i
luoghi comuni.
Kristjan Knez
«Lezione» di Dean Krmac all’Archivio di Stato di Pisino
La popolazione dell’Istria
L’Archivio di Stato di Pisino già da qualche
anno organizza, in diversi appuntamenti mensili,
delle lezioni didattiche di illustri esperti di scienze sociali, che si occupano di storia dell’Istria sulla base di fonti conservate presso archivi collocati
in differenti aree e un approccio multidisciplinare.
Di recente la sala conferenze dell’istituto pisinese
ha accolto il dott. Dean Krmac, editore di diverse
riviste storico-demografiche, storico e ricercatore dell’Università di Trieste, che ha tenuto un intervento sul tema: “L’evoluzione demografica del
popolo istriano ai tempi della Monarchia asburgica
dal 1815 al 1918”.
Fonti archivistiche e di stampa, censimenti, registri anagrafici e parrocchiali sono stati utilizzati dal Krmac, che ha preso in esame il periodo che
va dal XIX agli inizi del XX secolo. Scopriamo, ad
esempio, che nella penisola istriana nel 1815 vivevano 360.173 persone e 103 anni dopo, nel 1918,
la popolazione era lievitata di ben 157mila unità.
Nel 1815 però non fu possibile censire tutte le case
dei villaggi, dei comuni e delle città e le autorità
austriache si servirono pertanto dei dati rilevati dai
francesi nel 1811.
Nel 1840 nacque a Vienna l’Istituto di statistica, che cominciò a raccogliere tutte le informazioni relative ai vari movimenti e spostamenti demografici. In Istria la zona più popolata della seconda
metà dell’Ottocento era quella nordoccidentale, da
Parenzo a Trieste. Pola nel 1830 contava all’incirca 700 abitanti; qualche anno più tardi, nel 1870,
con il conferimento da parte della monarchia dello
stato di “porto di guerra”, la popolazione aumenterà fortemente toccando le 60.000 persone. La città
di Pisino nel 1918 aveva 14.450 abitanti, un numero superiore a quello di oggi. Trieste, alla fine del
XIX secolo era una delle città più popolate, soprattutto a causa del forte aumento dell’immigrazione:
il 33% degli immigrati erano donne dai 16 ai 30
anni. (blj)
Anno VII / n. 62 2 giugno 2012
“LA VOCE DEL POPOLO” - Caporedattore responsabile: Errol Superina
IN PIÙ Supplementi a cura di Errol Superina
Progetto editoriale di Silvio Forza / Art director: Daria Vlahov Horvat
edizione: STORIA E RICERCA
Redattore esecutivo: Ilaria Rocchi / Impaginazione: Borna Giljević
Collaboratori: Kristjan Knez, Branko Ljuština, Paolo Radivo, Carla Rotta,
Fabio Sfiligoi e Rosanna Turcinovich Giuricin / Foto: Archivio