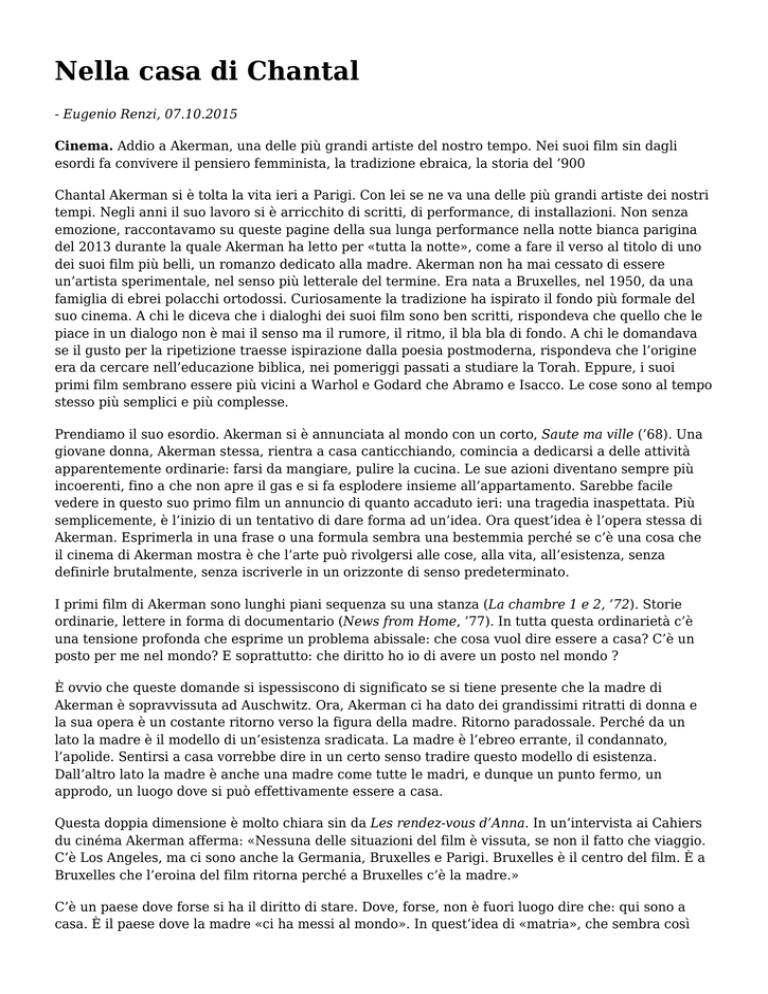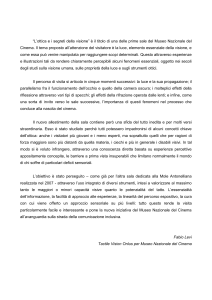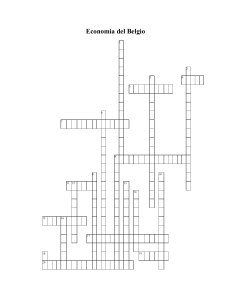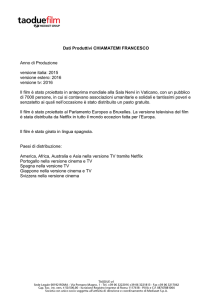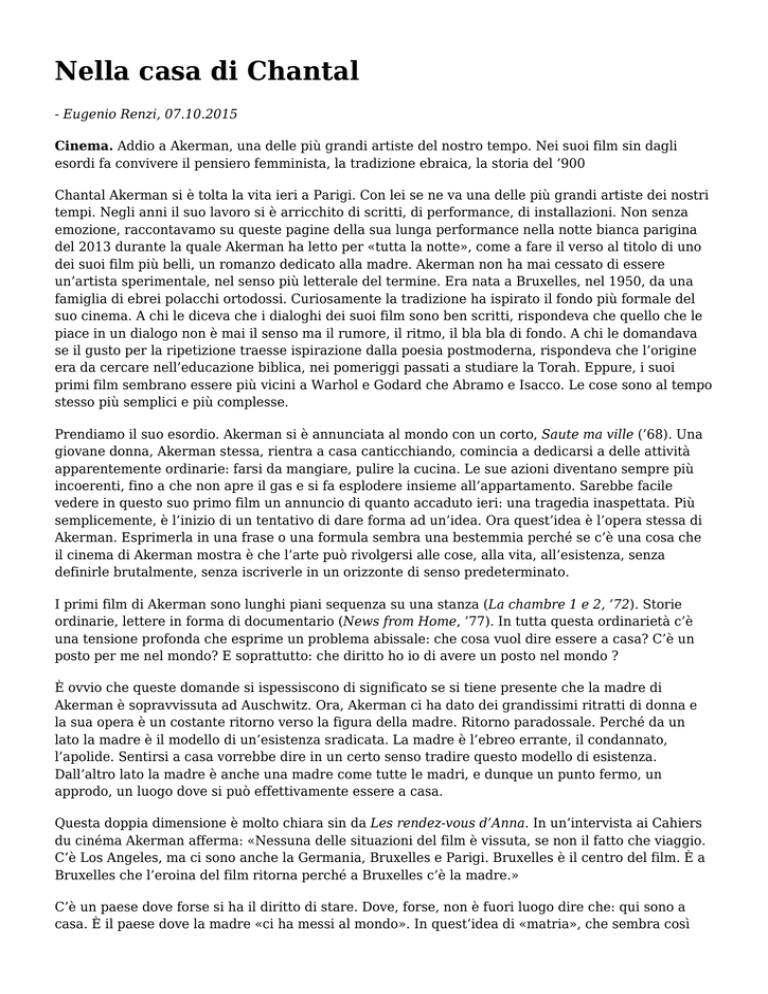
Nella casa di Chantal
- Eugenio Renzi, 07.10.2015
Cinema. Addio a Akerman, una delle più grandi artiste del nostro tempo. Nei suoi film sin dagli
esordi fa convivere il pensiero femminista, la tradizione ebraica, la storia del ’900
Chantal Akerman si è tolta la vita ieri a Parigi. Con lei se ne va una delle più grandi artiste dei nostri
tempi. Negli anni il suo lavoro si è arricchito di scritti, di performance, di installazioni. Non senza
emozione, raccontavamo su queste pagine della sua lunga performance nella notte bianca parigina
del 2013 durante la quale Akerman ha letto per «tutta la notte», come a fare il verso al titolo di uno
dei suoi film più belli, un romanzo dedicato alla madre. Akerman non ha mai cessato di essere
un’artista sperimentale, nel senso più letterale del termine. Era nata a Bruxelles, nel 1950, da una
famiglia di ebrei polacchi ortodossi. Curiosamente la tradizione ha ispirato il fondo più formale del
suo cinema. A chi le diceva che i dialoghi dei suoi film sono ben scritti, rispondeva che quello che le
piace in un dialogo non è mai il senso ma il rumore, il ritmo, il bla bla di fondo. A chi le domandava
se il gusto per la ripetizione traesse ispirazione dalla poesia postmoderna, rispondeva che l’origine
era da cercare nell’educazione biblica, nei pomeriggi passati a studiare la Torah. Eppure, i suoi
primi film sembrano essere più vicini a Warhol e Godard che Abramo e Isacco. Le cose sono al tempo
stesso più semplici e più complesse.
Prendiamo il suo esordio. Akerman si è annunciata al mondo con un corto, Saute ma ville (’68). Una
giovane donna, Akerman stessa, rientra a casa canticchiando, comincia a dedicarsi a delle attività
apparentemente ordinarie: farsi da mangiare, pulire la cucina. Le sue azioni diventano sempre più
incoerenti, fino a che non apre il gas e si fa esplodere insieme all’appartamento. Sarebbe facile
vedere in questo suo primo film un annuncio di quanto accaduto ieri: una tragedia inaspettata. Più
semplicemente, è l’inizio di un tentativo di dare forma ad un’idea. Ora quest’idea è l’opera stessa di
Akerman. Esprimerla in una frase o una formula sembra una bestemmia perché se c’è una cosa che
il cinema di Akerman mostra è che l’arte può rivolgersi alle cose, alla vita, all’esistenza, senza
definirle brutalmente, senza iscriverle in un orizzonte di senso predeterminato.
I primi film di Akerman sono lunghi piani sequenza su una stanza (La chambre 1 e 2, ’72). Storie
ordinarie, lettere in forma di documentario (News from Home, ’77). In tutta questa ordinarietà c’è
una tensione profonda che esprime un problema abissale: che cosa vuol dire essere a casa? C’è un
posto per me nel mondo? E soprattutto: che diritto ho io di avere un posto nel mondo ?
È ovvio che queste domande si ispessiscono di significato se si tiene presente che la madre di
Akerman è sopravvissuta ad Auschwitz. Ora, Akerman ci ha dato dei grandissimi ritratti di donna e
la sua opera è un costante ritorno verso la figura della madre. Ritorno paradossale. Perché da un
lato la madre è il modello di un’esistenza sradicata. La madre è l’ebreo errante, il condannato,
l’apolide. Sentirsi a casa vorrebbe dire in un certo senso tradire questo modello di esistenza.
Dall’altro lato la madre è anche una madre come tutte le madri, e dunque un punto fermo, un
approdo, un luogo dove si può effettivamente essere a casa.
Questa doppia dimensione è molto chiara sin da Les rendez-vous d’Anna. In un’intervista ai Cahiers
du cinéma Akerman afferma: «Nessuna delle situazioni del film è vissuta, se non il fatto che viaggio.
C’è Los Angeles, ma ci sono anche la Germania, Bruxelles e Parigi. Bruxelles è il centro del film. È a
Bruxelles che l’eroina del film ritorna perché a Bruxelles c’è la madre.»
C’è un paese dove forse si ha il diritto di stare. Dove, forse, non è fuori luogo dire che: qui sono a
casa. È il paese dove la madre «ci ha messi al mondo». In quest’idea di «matria», che sembra così
arcaica e moderna al tempo stesso, Akerman fa convivere e sostenersi a vicenda la tradizione
ebraica, la storia del ’900 e il pensiero femminista.
Il frammento come forma, l’esistenza sradicata come contenuto, sono la figura e il colore con i quali
Akerman dipinge il ritratto di Bruxelles all’inizio degli anni ’80 di Toute une nuit (’82) Si tratta di
una serie di brevi scene, quasi sempre silenziose, sconnesse l’una dall’altra che fermano per un
attimo il corso e il fluire dell’esistenza. Un uomo e una donna seduti l’uno accanto all’altra in un bar,
si scambiano qualche occhiata. Una coppia di mezza età, risvegliata dal rumore di una televisione
decide di fare due passi Nella notte di Toute une nuit, girata in un magnifico 16 millimetri e
illuminata dalla fotografia di Caroline Champetier, l’erranza diventa danza. Akerman vi fa
convergere diverse pratiche artistiche come la canzone e il ballo (l’ispirazione sono le coreografie di
Pina Bausch). Toute une nuit ha la particolarità di essere un film leggero, pieno di ironia a tratti
euforico. È una commedia musicale che in un certo senso dice addio al cinema ascetico degli anni
’70.
Lo abbiamo già accennato, c’è sempre qualcosa di ripetitivo nel cinema di Chantal Akerman: la
scena del consumo nevrotico di zucchero in In Je tu il elle (’74), il rito ossessivo di Jeanne Dielman
(’75), il succedersi dei discorsi maschili in Les Rendez-vous d’Anna. Il punto estremo di questo
spostamento verso il tempo e la finzione è Nuit et jour (’91), film dove è il cinema stesso a tornare
con i suoi ritornelli preferiti: quello di Godard (la coppia) e quello di Truffaut (il triangolo amoroso).
Nel ’93, Akerman firma uno straordinario documentario: D’Est. Il titolo internazionale, From the
East, rima con News From Home, del 1975. L’est è certo una delle case possibili di Akerman.
Sarebbe meglio dire la più impossibile. Ora, è significativo che Akerman abbia scelto di
intraprendere il suo viaggio ad est solo dopo la caduta del Muro. Non perché la fine del socialismo
renda questo luogo emblematico, l’oriente, il paese del socialismo, più facile d’accesso, ma al
contrario, il viaggio si impone perché la nebbia che circonda la cortina di ferro, invece di dissolversi
si infittisce. La prima parte del film cerca dei paesaggi: un albero, un incrocio deserto. La seconda
cerca dei volti, Levinas direbbe «l’altro»: in gruppi al mattino o nella notte, in attesa del bus o di un
treno. Dei visi ci guardano, e nel fondo del loro sguardo leggiamo una domanda: siamo a casa ?
In La Folie Almayer (2011) Akerman (che ha sempre disprezzato Coppola) ha voluto fare un
anti-Apocalypse Now: un film in cui il viaggiatore non raggiunge una meta, dove il mistero non viene
tolto ma viene solo vissuto, e di certo dove non viene spiegato né «ora» né mai. Si può trovare
l’impresa assurda, ma in un certo senso è l’impresa di una vita, il punto più alto, più radicale
dell’esperienza artistica e umana di Akerman. Pensare l’etica dell’essere un ente errante fino alla
sua estrema conseguenza: l’impossibilità di muoversi, il fatto di essere di casa nel non trovarsi mai a
casa propria.
© 2017 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE