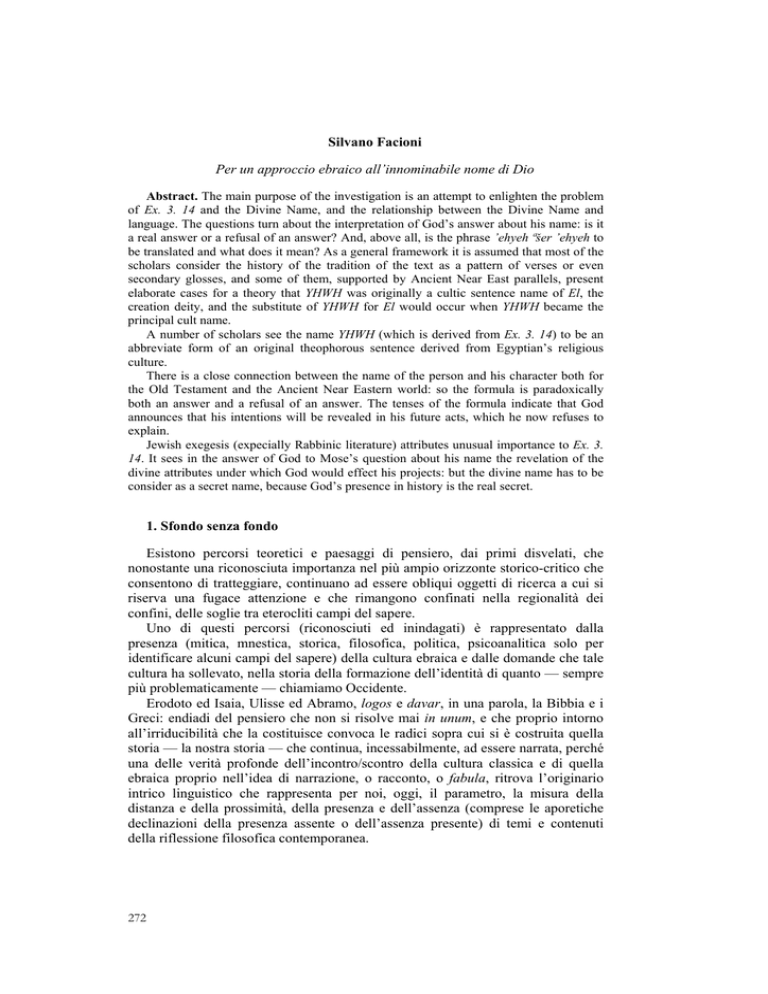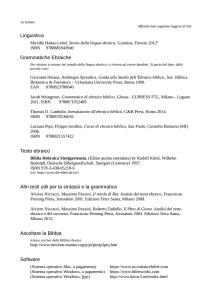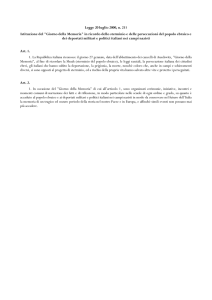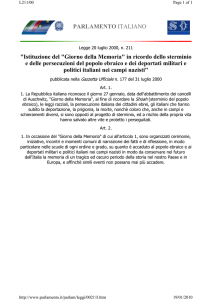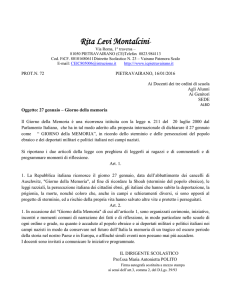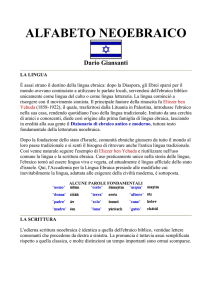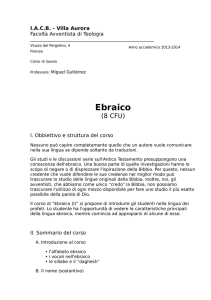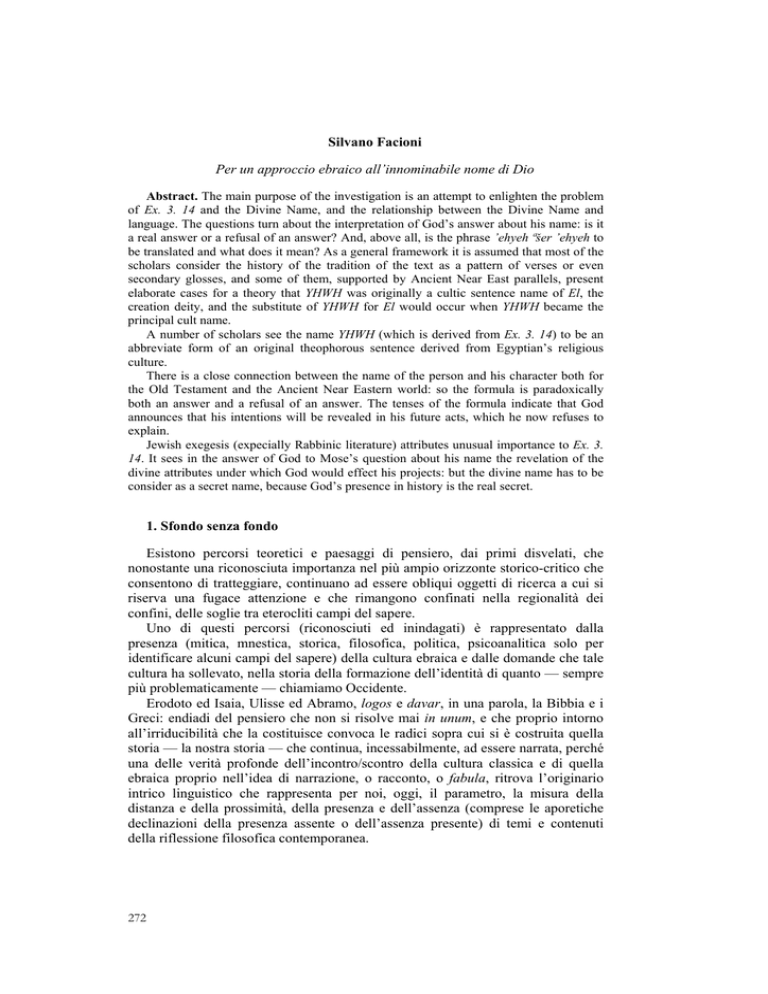
Silvano Facioni
Per un approccio ebraico all’innominabile nome di Dio
Abstract. The main purpose of the investigation is an attempt to enlighten the problem
of Ex. 3. 14 and the Divine Name, and the relationship between the Divine Name and
language. The questions turn about the interpretation of God’s answer about his name: is it
a real answer or a refusal of an answer? And, above all, is the phrase ’ehyeh ªšer ’ehyeh to
be translated and what does it mean? As a general framework it is assumed that most of the
scholars consider the history of the tradition of the text as a pattern of verses or even
secondary glosses, and some of them, supported by Ancient Near East parallels, present
elaborate cases for a theory that YHWH was originally a cultic sentence name of El, the
creation deity, and the substitute of YHWH for El would occur when YHWH became the
principal cult name.
A number of scholars see the name YHWH (which is derived from Ex. 3. 14) to be an
abbreviate form of an original theophorous sentence derived from Egyptian’s religious
culture.
There is a close connection between the name of the person and his character both for
the Old Testament and the Ancient Near Eastern world: so the formula is paradoxically
both an answer and a refusal of an answer. The tenses of the formula indicate that God
announces that his intentions will be revealed in his future acts, which he now refuses to
explain.
Jewish exegesis (expecially Rabbinic literature) attributes unusual importance to Ex. 3.
14. It sees in the answer of God to Mose’s question about his name the revelation of the
divine attributes under which God would effect his projects: but the divine name has to be
consider as a secret name, because God’s presence in history is the real secret.
1. Sfondo senza fondo
Esistono percorsi teoretici e paesaggi di pensiero, dai primi disvelati, che
nonostante una riconosciuta importanza nel più ampio orizzonte storico-critico che
consentono di tratteggiare, continuano ad essere obliqui oggetti di ricerca a cui si
riserva una fugace attenzione e che rimangono confinati nella regionalità dei
confini, delle soglie tra eterocliti campi del sapere.
Uno di questi percorsi (riconosciuti ed inindagati) è rappresentato dalla
presenza (mitica, mnestica, storica, filosofica, politica, psicoanalitica solo per
identificare alcuni campi del sapere) della cultura ebraica e dalle domande che tale
cultura ha sollevato, nella storia della formazione dell’identità di quanto — sempre
più problematicamente — chiamiamo Occidente.
Erodoto ed Isaia, Ulisse ed Abramo, logos e davar, in una parola, la Bibbia e i
Greci: endiadi del pensiero che non si risolve mai in unum, e che proprio intorno
all’irriducibilità che la costituisce convoca le radici sopra cui si è costruita quella
storia — la nostra storia — che continua, incessabilmente, ad essere narrata, perché
una delle verità profonde dell’incontro/scontro della cultura classica e di quella
ebraica proprio nell’idea di narrazione, o racconto, o fabula, ritrova l’originario
intrico linguistico che rappresenta per noi, oggi, il parametro, la misura della
distanza e della prossimità, della presenza e dell’assenza (comprese le aporetiche
declinazioni della presenza assente o dell’assenza presente) di temi e contenuti
della riflessione filosofica contemporanea.
272
Per un approccio ebraico al nome di Dio
Narrazione che, mentre tenta di guadagnare l’origine (qui il ‘nome proprio’ di
Dio) si scopre intrinsecamente contestata dalle forme del discorso pure che ha
assunto, narrazione che si dispiega come discorso incompibile perché proprio nel
luogo del suo stesso generarsi si spalanca, si spazia, si rinvia, impedendo una
cattura asseverativa, meridiana, strutturalmente padroneggiabile.
In questo senso, allora, assumerò quale presupposto della mia ricerca sul ‘nome
proprio’ di Dio l’idea di una complessità di metodi che, senza rinunciare allo
specifico che li caratterizza, osmoticamente si richiamano e si intersecano: critica
testuale e formalizzazione logica, come pure indagine eminentemente storica ed
ipotesi teoretiche non potranno imporsi secondo il procedimento logico
dell’opposizione ma dovranno muoversi in direzione di una concordia discors, o di
una diaphorà che dichiara, prima di qualsiasi differenza, il destino di una più
originaria inseparabilità tra luoghi del sapere.
2. Crucialità storiche
Quando, all’incirca intorno alla metà del III secolo a.C., Alessandro Magno
conquistò la Palestina, non era ancora possibile ipotizzare né tantomeno misurare la
portata che l’incontro della cultura classica con quella giudaica avrebbe prodotto
nella nostra storia di occidentali: Ioudaismòs e Ellenismòs compaiono per la prima
volta nel Secondo libro dei Maccabei come termini che indicano, rispettivamente,
l’appartenenza politica e la fede nell’unico Dio di Israele (2 Macc. 2,21ss.) contro
l’idea di un’imposizione politico-culturale in contrasto con la fedeltà alla Torah
che caratterizza l’identità del popolo ebraico (2 Macc. 4, 13ss.). La rivolta
maccabaica accadrà all’incirca 150 dopo la conquista della Palestina da parte di
Alessandro Magno, ed è lecito supporre che l’incontro/scontro fra le due culture
avesse già cominciato a produrre effetti valutabili soprattutto in termini di
trasformazione del messaggio biblico (HENGEL 2001: 22): la ‘sapienza’ greca si
insinua nel monoteismo ebraico fino a mutare, come testimoniato dal corpus di
testi scritturistici noti come ‘Sapienziali’ (Qohelet, Siracide, Sapienza, Cantico dei
Cantici ecc.), lo stesso paradigma di comprensione del divino che diviene, appunto,
‘Dio-Sapienza’, con rilevanti conseguenze dal punto di vista filosofico-teologico
(come il famoso problema dell’ellenizzazione del giudaismo) ma, soprattutto, con
l’effetto di ‘distoglimento’ dell’attenzione critica da quanto era accaduto
precedentemente, ovvero da come l’intera Scrittura aveva affrontato il nodo
centrale del ‘nome proprio’ di Dio.
Dal mio punto di vista, allora, i rivolgimenti epistemici avvenuti a seguito
dell’incontro tra giudaismo ed ellenismo, rappresentano da un lato
l’imprescindibile banco di prova per la verifica di come — prima ancora delle
mutazioni avvenute nel corso della storia biblica — il problema del nome di Dio
fosse stato declinato nella cultura biblica, e dall’altro il recupero della questione sul
nome di Dio come indice categoriale del più ampio problema della nominazione e
del rapporto tra nome e realtà (o ente) nominato: la Scrittura (e la cultura biblicogiudaica che ne è derivata) infatti, ha scritto Goldberg,
è una moltitudine di segni grafici definita con precisione. L’artefatto ‘Scrittura’ è fissato
con precisione e non può subire alcuna mutazione. A questa quantità determinata, finita,
di segni grafici, corrisponde una moltitudine ancora aperta di segni linguistici. La
Filosofia & Linguaggio in Italia 2002 — sez. 10
273
Silvano Facioni
quantità di segni linguistici aumenta nell’interpretazione, poiché si scopre sempre più
come tutto sia segno linguistico. (GOLDBERG 1987: 14, tr. dello scrivente).
Ancora oggi, però, se escludiamo un ristretto numero di specialisti solitamente
confinati nel reame della filologia, sembra difficile riuscire ad abbozzare una
‘storia degli effetti’ della frizione tra le due culture, e la ragione di tale difficoltà
risiede principalmente nel fatto che siamo ancora coinvolti nel processo provocato
da tale frizione, o, meglio, siamo uno degli ‘effetti’ che tale storia dovrebbe portare
alla luce, al punto che sembra legittimo domandarsi se la stessa ‘rimozione’ di cui
stiamo tentando di sagomare i bordi non appartenga al senso profondo di tale
incontro.
Le domande allora si moltiplicano ed accelerano la propria forza dirompente:
cosa significa, in senso proprio, che l’Occidente è segnato in maniera potente dalla
‘polemica’ presenza di due culture — greca ed ebraica — che continuano a
consegnarsi il ‘testimone’ di una presenza che se da un lato, rimane ‘duale’,
endiadica, dall’altro non consente di ordinare una tassonomia in grado di restituire
il peso specifico di ciascuno dei precipitati culturali? In che senso la
contemporaneità filosofica non può fare a meno, pena la condanna ad
un’insignificanza che oblia la questione del senso riducendola a residuo metafisico,
di verificare i propri assetti e le proprie procedure mettendo innanzitutto in
discussione il proprium di un’eredità che si mostra come la trama infinita di un
tessuto fatto di testi che vivono solo nel loro mobile intersecarsi e rinviarsi? Intorno
ad Atene e a Gerusalemme si sono accumulate, nel corso del tempo, le più
disparate ipotesi, ma si direbbe che tali ipotesi abbiano impedito, in ultima istanza,
un reale dispiegamento del problema di cui volevano essere testimoni: come si
pensa ‘dentro’ Atene e ‘dentro’ Gerusalemme? E più ancora: come si pensa
l’Occidente dentro quella ‘doppia’ cittadinanza che lo costituisce?
La questione, in prima battuta, sembra appartenere ad un ordine di discorso che
revoca sia l’idea di ordine sia, soprattutto, quella di discorso, perché attacca,
sbaragliandola, la possibilità di pensare una rappresentabilità (da cui il discorso)
della posta in gioco, ovvero perché dichiara sbarrata da subito, vale a dire da
sempre, la possibilità di pervenire ad un origine che si lasci catturare nelle forme di
una rappresentazione.
E allora nella questione del linguaggio (parola, scrittura, segno) si riflette
l’originarietà della domanda sull’origine, o, in altri termini, l’originarietà del
problema della rappresentazione: la domanda relativa al ‘come’ si pensa dentro
Atene e Gerusalemme si articola nell’incavo della domanda relativa a ‘come’ si è
rappresentato il pensiero e allo statuto linguistico che ha istituito la stessa idea di
rappresentazione. E ancora: solo da un’indagine sulla questione sull’origine della
rappresentazione può scaturire, oggi, una riconsiderazione dell’apporto veritativo
del discorso ermeneutico che impegna, estenuandola, la contemporaneità. Senza
invocare nostalgicamente ritorni a supposti ordini del pensiero che non hanno retto
il confronto o tenuto il passo con l’esigenza di un rigore epistemologico della
dottrina della verità, è necessario reinterrogare la nostra storia ai fini di una nuova
categorizzazione dei metodi e delle finalità dell’impresa filosofica: corrispondere
all’esigenza di senso implicherà, qui, il riattraversamento di alcuni momenti della
nostra storia per estrarne quanto in essi è presente come assente, non detto,
impensato.
274
Per un approccio ebraico al nome di Dio
3. Il problema del nome di Dio
Una cornice teoretica che assuma il linguaggio quale paradigma categoriale
della domanda di senso propria dell’uomo non può non raccogliere le sfide che
proprio dal linguaggio derivano e che anzi lo assumono come orizzonte e oggetto
del discorso.
Un esempio, tratto dall’esperienza biblico-rabbinica del problema che stiamo
tentando di mettere a tema potrà senz’altro contribuire ad una chiara definizione sia
del problema stesso, sia nei riverberi epistemologici sulla storia della
autocomprensione della civiltà occidentale, sia nel compito che la ricerca filosofica
è chiamata a svolgere oggi e, soprattutto, domani.
Il versetto biblico di Esodo 3, 14 rappresenta senza alcun dubbio uno dei luoghi
massimamente problematici non solo per la comprensione del tema, tipicamente
ebraico, della lotta contro l’idolatria, ma anche l’orizzonte in cui è stato pensata,
sub specie philosophiae, la questione della rappresentabilità/dicibilità di Dio:
E disse Mosè a ’Elohim: «Chi sono io che andrò dal faraone? E che farò uscire i figli
d’Israele dall’Egitto?» E disse: «Poiché io sarò con te e questo è per te il segno che io ti
ho mandato: quando farai uscire il popolo dall’Egitto servirete ’Elohim sopra questa
montagna». E disse Mosè a ’Elohim: «Ecco io vado versi i figli d’Israele e dirò loro:
‘’Elohim dei vostri padri mi ha mandato a voi’. E diranno a me: ‘Quale è il suo nome?’
Cosa dirò loro?» E disse ’Elohim: «’ehyeh ’ªšer ’éhyeh». E disse: «Così dirai ai figli
d’Israele: ’ehyeh mi ha mandato a voi» (Esodo 3, 11-14)*.
La risposta di Dio, nella sua disarmante semplicità, rappresenta a tutt’oggi uno
degli enigmi che nemmeno la più raffinata esegesi scientifica è riuscito a risolvere:
Dio risponde a Mosè rifiutandosi di rispondere e dichiara che il suo nome proprio è
non avere alcun nome. «’ehyeh ’ªšer ’ehyeh» (che morfologicamente corrisponde
alla prima persona singolare dell’imperfetto del verbo hayah) può essere tradotto in
molti modi, anche se nessuno di questi riesce fino in fondo ad esaurire le
potenzialità semantiche in esso presenti (unitamente ai problemi che pone): «io
sono colui che sono»; «io sono colui che è»; «io sarò presente come colui che sarà
presente»; «io sono perché io sono»; «io sarò colui che sarò»; «io sono colui che è:
io sono» sono soltanto un ridottissimo campionario di possibili traduzioni che
vorrebbe illustrare le difficoltà che la risposta di Dio a Mosè ha posto ad esegeti e
filosofi nel corso dei secoli.
La critica testuale contemporanea ha provato a leggere la risposta divina alla
domanda di Mosè mettendo in relazione il versetto 14 con tutto il libro dell’Esodo.
Senza passare in rassegna tutte le ipotesi che sono state prodotte (CHILDS 1974: 6071) mi limito in questo contesto a rammentare che le ipotesi maggiormente
accreditate sostengono che il rapporto tra la tradizione israelitica e le tradizioni
dell’Antico Oriente (Ugarit, tradizioni proto-semitiche, tradizione amoritica ecc.)
permette di riconoscere la novità di Israele ovvero la rottura e la discontinuità con
le tradizioni parallele. Ma tale novità, pur riconosciuta, continua a rimanere
difficilmente comprensibile proprio a motivo dell’intraducibilità del sintagma che
svelerebbe il nome divino.
*
Le traduzioni dei passi biblici, dei passaggi talmudici e della letteratura rabbinica sono mie.
Filosofia & Linguaggio in Italia 2002 — sez. 10
275
Silvano Facioni
Il problema, inoltre, è ulteriormente complicato dalla questione del nome (e, più
ancora, del nome proprio) nell’insieme delle culture dell’Antico Oriente: sappiamo
infatti che, a differenza di quanto accade nella tradizione filosofico-teologica greca,
il nome proprio possiede uno statuto semantico che rinvia all’essere della persona
(o dell’ente) che lo porta, e dunque il nome proprio è sempre legato ad una
rivelazione/manifestazione dell’essere (come tutti i nomi propri biblici
patentemente attestano). Yosef Giqatilla, cabbalista vissuto in Spagna tra la fine del
XIII e l’inizio del XIV secolo, nel suo Ghinat egoz (Il giardino delle noci) ha
scritto che «la radice della parola ‘nome’ (šem) viene dalla parola ‘là’ (šam). Ogni
volta che c’è ‘nome’ c’è un ‘là’ e reciprocamente» (GIQATILLA 1989: 103, tr. dello
scrivente), come a dire che il nome proprio è sempre connesso ad una spazialità che
è sia fisica sia simbolica: il nome proprio è lo spazio di una tessitura simbolica di
significazioni che sono il proprium dell’identità di quanto nominato. È
probabilmente nel solco di tali considerazioni che Martin Buber avanzerà la
spiegazione secondo cui la risposta divina data a Mosè
[...] rifiuta di legarsi a forme di rivelazione ben definite; come potrebbero gli uomini
tentare di evocare Dio e porgli dei limiti! [...] Come sfondo di una rivelazione di questo
genere si deve tenere presente l’Egitto dove il mago poteva minacciare gli dei non solo di
tradirli, dando i loro nomi ai demoni se essi non eseguivano il suo volere, ma anche di
strappar loro i capelli, come si colgono i fiori di loto dallo stagno. La religione non era
qui molto di più di una serie di regole di magia. Nel discorso del roveto la religione viene
demagificata. (BUBER 1983: 48, c.m.).
Una simile spiegazione, come si vede, lascia comunque irrisolto il problema del
nome proprio di Dio. E ad illustrare tale difficoltà (che, ricordiamolo, è di natura
teologica perché primariamente di natura semantica), contribuiscono le numerose
traduzioni correnti dal testo ebraico come pure le più antiche ed autorevoli
traduzioni della Scrittura (LXX per il greco e Vulgata per il latino) che attraversano
come un filo rosso la nostra storia e che, dalla LXX (che traduce con «egò eimì o
ov») passando attraverso la Vulgata (che invece tradurrà con «ego sum qui sum»)
fino a Lacan (che proporrà — riascoltando l’ipotesi dello Schelling della Filosofia
della Rivelazione — un irriverente «Vai a farti sfottere» in cui va a fondo
qualunque pretesa di presa concettuale fosse pure nella forma della congettura),
hanno proposto traduzioni che, se venissero analiticamente discusse,
consentirebbero il dispiegarsi di un’inedita storia del pensiero occidentale (A. DE
LIBERA e E. ZUM 1986).
All’interno della stessa storia giudaica, come ci è stata tramandata dalla
Scrittura, il nome di Dio (si tratti di ’El o ’Elohim, o Šadday o YHWH) rappresenta
un problematicissimo indice che proprio in Esodo 3, 14 ritrova, simultaneamente, il
suo punto di origine e l’esito impensato (ed impensabile): sono stati rintracciati, per
spiegare questo versetto, passi paralleli con la cultura egizia, che conosce due verbi
che significano ‘essere’: uno di questi — jw — svolge funzioni di copula, mentre
l’altro — wnn — tenderebbe a significare l’esistenza reale ed effettiva di qualcosa.
Come ha sottolineato LEFÈBVRE (1955: § 349), prendendo esempio da un passo
della Saggezza di Mérikar (linea 94) in cui si trova l’espressione «wnn. j wnn. koj»
(«io sono e sarò qui») il verbo è ripetuto nelle due forme dell’imperfetto — che
denota la durata — e nello pseudo-participio, che invece indicherebbe uno stato.
Ora, anche se lo pseudo-participio egiziano (che si coniuga) non corrisponde al
276
Per un approccio ebraico al nome di Dio
participio ebraico (che non si coniuga) e nonostante il participio ebraico di hayah
sia usato piuttosto raramente, è certo che un autore ebreo avrebbe potuto trovare
nella formula di Mérikar un aiuto per esprimere la presenza indicibileirrapresentabile di Dio.
Se invece, come fa CROSS (1962: 225-259) ci muoviamo sull’altro confine di
Israele, verso Est, possiamo scoprire paralleli linguistici con Ugarit che
permetterebbero di ricostruire la sequenza storica linguistica che si concluderebbe
con la formula di Esodo 3, 14: Cross sostiene che «’ehyeh ’ªšer ’ehyeh» sia un
nome-formula che doveva essere letto alla terza persona singolare dal momento che
ad Ugarit, verso la fine della tarda Età del Bronzo, il pronome ’ªšer prese il posto
del relativo du. Dal momento che du yahwi era in origine un epiteto di ’El (il nome
della divinità in proto-semitico), e che il nome YHWH sostituirà quello di ’El nel
corso della storia biblica, ecco che la formula originaria doveva dunque essere: «’el
du yahwi», divenuta successivamente «yahwi du yahwi» e poi di nuovo — nel
passaggio dalla terza alla prima persona singolare dell’imperfetto hayah — «’ehyeh
’ªšer ’ehyeh».
Abbiamo citato solo due tra le tante ipotesi che sono state sviluppate per
spiegare l’origine del sintagma di Esodo 3, 14 (tralasciando, ad esempio, quelle
non meno importanti di Albright o di de Vaux), anche perché lo scopo di questo
scritto è mostrare come l’impossibilità di giungere ad una esaustiva spiegazione di
tipo storico-critico della formula non riguarda soltanto la scarsità o inaccessibilità
delle fonti, ma ha a che fare, in senso stretto, con quell’indecidibilità che
caratterizza — e chiude dentro un paradossale double bind — ogni domanda
sull’origine (qui, in particolare, l’origine del nome proprio e della nominazione). In
questo senso allora, come detto in apertura, è necessario rivolgere lo sguardo
all’idea di ‘effetto’ inteso come movimento, attività, effettività di una verità che si
dice in una parola che è in relazione vivente con l’origine del proprio dire
(DALMASSO 1996).
Ed infatti ognuna delle ipotesi fatte è riconducibile, in ultima istanza, ad un’idea
di identità intesa in termini sostanzialisti, ovvero ad una concezione dell’essere (qui
inteso nella sua accezione verbale) riconducibile a quell’*es- di matrice
indoeuropea il cui senso, ha scritto BENVENISTE (1971: 224), «è ‘avere esistenza,
trovarsi nella realtà’, e questa ‘esistenza’, questa ‘realtà’ si definisce come ciò che è
autentico, costante, vero»; mentre il termine ’ehyeh che in ebraico indica la prima
persona singolare dell’imperfetto hayah che solo convenzionalmente viene tradotto
come verbo ‘essere’, denota al contrario un divenire o un’esistenza che si manifesta
attraverso un’attività. Il fuoco linguistico delle discussioni deve essere allora
rintracciato nel campo e nelle funzioni del verbo ‘essere’ nella lingua ebraica: le
frasi che nelle lingue di matrice indoeuropea ricorrono alla copula ‘è’ non hanno in
ebraico alcun verbo corrispondente alla nostra copula (l’ebraico infatti ricorre
sempre alla frase nominale che è peraltro piuttosto diffusa in area semitica), ed
anche se l’idea di ‘copula’ si direbbe indicare più una funzione logica che un fatto
linguistico, rimane indiscutibile che il verbo hayah corrisponde al verbo ‘essere’
solo in maniera approssimativa e nella maggioranza dei casi in cui ricorre deve
essere tradotto con ‘divenire’ o ‘accadere’ (BARR 1968: 86-105).
3. Linguaggio, filosofia, enigmi
Filosofia & Linguaggio in Italia 2002 — sez. 10
277
Silvano Facioni
Il problema dell’incompiutezza del nome che si volge all’imperfetto (perché la
coniugazione verbale ebraica, che è di tipo aspettuale, considera ‘imperfetto’ un
processo non ancora compiuto o non ancora iniziato, e quindi può rinviare ad un
presente/futuro) apre all’infinità del senso (in una sorta di filologia messianica)
ovvero al senso da cercare sempre di nuovo, sempre — letteralmente — a-venire, a
partire dalla prima rivelazione di Dio stesso, la quale rimanda ad un primato del
nome che è ‘archeo-logia’ del linguaggio: il discorso sul divino è sempre, anche un
discorso sul linguaggio fino all’identificazione del divino con la parola. Ma, come
nel caso di Esodo 3, 14, la più profonda ragion d’essere della parola risiede
nell’assenza. La dinamica filosofico-teologica del nome e del ritrarsi del nome
(perché l’impossibilità di tradurre «’ehyeh ’ªšer ’ehyeh» svuota come dall’interno
sia il nome, sia, di conseguenza, l’atto della nominazione) che è gioco di presenza e
di assenza contrasta in radice l’idea di rivelazione intesa quale ‘luogo’ di una
presenza a sé del divino con la conseguente ‘disponibilità’ del divino da parte
dell’uomo (come nell’ipotesi di Buber che abbiamo citato sopra).
Il nome proprio è, nello stesso tempo, ‘esplicito’ e ‘nascosto’ — «ha-meforaš»
dice la tradizione (SCHOLEM 1998: 23) — e la sua pronuncia è legata
all’impossibilità di una pronuncia, come se il gioco di manifestazione e
dissimulazione volesse richiamare la prossimità e la distanza del divino rispetto
all’uomo che lo invoca, o, meglio, la prossimità come distanza e la distanza come
prossimità: Dio è il nodo semantico di un ‘Tu’ e di un ‘Egli’, di una trascendenza
immanente che si annuncia come a-venire, che nel presente dell’annuncio apre al
futuro dell’evento di senso che attraverso, per mezzo e con essa si dichiara. «Il
nome ha un nome» ha scritto LÉVINAS (1986: 204) in un’analisi dei nomi divini
nella tradizione ebraica, memore forse di quanto Buber aveva scritto —
riprendendo a sua volta un’ipotesi di Bernhard Duhm — a proposito del significato
del Tetragramma (che va considerato come paradossale declinazione dell’«’ehyeh
ªšer ’ehyeh» e che vede conglobate, nelle lettere che costituiscono il termine
YHWH, le modalità aspettuali/temporali del presente, del passato e del futuro di
hayah) che riprenderebbe, estendendolo, il pronome hu’ che in ebraico significa
‘egli’:
la forma originaria del grido può essere stata Ya-huwa, se nell’arabo huwa, ‘egli’,
possiamo riconoscere la forma protosemitica del pronome ‘egli’ che in ebraico si dice
hu’. Il nome Ya-huwa significherebbe allora ‘oh! Egli’, espressione con la quale, ad
esempio nel culto, si accoglieva spontaneamente qualche epifania divina visibile o
percepibile o intuibile o si reagiva ad essa nel proprio intimo [...]. Da questo Ya-huwa si
può spiegare sia Yahu che YHWH (in origine forse YAWA). (BUBER 1983: 45).
L’incompiutezza dell’imperfetto con cui Dio si rivela a Mosè dice il
differimento del senso che non è altro che una modalità della premessa sotto la
forma della promessa: Dio è presente come promessa, ovvero Dio è ‘presente’
come futuro. L’incompiutezza dell’imperfetto non cessa di non compiersi, ovvero
di sottrarsi al potere del linguaggio che, nelle mani dell’uomo, è talvolta sinonimo
di violenza.
Solo riconducendo a questa incompiutezza l’insieme dei nomi perifrastici che,
nella Bibbia, nominano Dio, è possibile comprendere come, dal punto di vista
ebraico, la questione dell’impronunciabile nome di Dio (impronunciabilità che,
278
Per un approccio ebraico al nome di Dio
ricordiamolo, viene ‘detta’, è presente nella voce che nomina Dio sottraendolo alla
nominazione) può essere considerata come l’inserimento, nel linguaggio, di un
non-linguaggio che è il ‘nome’ del fuori del senso, il discontinuo nel continuo del
linguaggio: storicità che fa del linguaggio un discorso, un ritmo, e che costituisce la
soggettività dell’uomo come un tutt’uno fra ciò che nomina e l’origine del proprio
nominare.
In questo senso allora la questione dell’impronunciabilità del nome di Dio è
istituita/determinata da un eccesso di senso che sbarra la strada sia al principio
allegorico che a quello metaforico (che funzionano all’interno di una struttura
linguistica di cui il nome ‘proprio’ di Dio rappresenta il rovescio) dando invece
luogo all’idea di un’ascosità di Dio stesso che sarà assente dal linguaggio, ma
assente come eccesso di senso.
Nell’esperienza biblica e rabbinica l’idea che la trascendenza sia costituita da un
fuori-linguaggio inserito nel linguaggio ritrova più di un luogo in cui essere
verificata: dai ‘settanta volti’ della Torah alle quattro categorie di lettura che
costituiscono il ‘giardino’ (pardes) dell’interpretazione, e ancora dall’idea delle
‘seicentomila’ letture del testo biblico pari al numero degli israeliti presenti al Sinai
al momento della consegna della Legge (figura, questa, dell’idea di un accesso alla
Torah proprio ad ogni uomo), tutto sembra testimoniare di un’infinità del senso che
annoda in un unico movimento il linguaggio e chi lo parla, ovvero l’uomo e
l’origine del suo dire.
Forse non è un caso se la tradizione rabbinica considera Esaù (che, lo
rammentiamo, nella storia narrata in Genesi 27 è il primogenito di Isacco ed il
figlio a cui Giacobbe, con un inganno, usurperà la primogenitura) prototipo
dell’Occidente perché, dicono i commentatori, egli nacque già adulto, compiuto
(Rashi scriverà nel suo Commento alla Genesi che «Esaù è chiamato così perché
era già tutto compiuto, vale a dire che era nato già tutto peloso come un uomo
adulto»): la rigidità delle lingue indoeuropee che, secondo il dettato della
linguistica contemporanea, possiedono una densità di saturazione che fissa il
semantema del radicale il quale non cambia che attraverso la flessione delle
desinenze, forma un sistema chiuso che invece non può dirsi carattere proprio della
lingua ebraica in cui, al contrario, si perviene addirittura ad una significazione dello
stesso livello fonematico (per cui il segno non soltanto designa il reale senza
lasciare residui, ma lo stesso significante è anch’esso ‘incarnazione’ del
significato).
Della lingua ebraica si direbbe essere costitutivo l’oltrepassamento non soltanto
della materialità linguistica, ma più ancora l’idea che il senso (della creazione e
dunque del linguaggio che della creazione è ‘voce’ e ‘parola’) possa darsi in un
senso diverso che non sia quello della ricerca infinita: l’ebraico/‘ivrit possiede la
stessa radice del termine ‘embrione’/‘uvar, ed entrambi i termini rinviano al
radicale ‘avar che è la matrice, la «sostanza materia» secondo la definizione di
GUILLAUME (1964: 34), del campo semantico che ruota intorno all’idea di
«passaggio, oltrepassamento, trasgressione, futuro». Oltrepassamento che non è
tanto il termine sinonimo che vuole esprimere una semplice modalità di tipo
metaforico attraverso cui si veicolerebbero significati altri rispetto a quanto
proclamato, ma che è il modo d’essere costitutivo dell’essenza dell’ebreo (prima
ancora che dell’ebraismo): in Genesi 14, 13 Abramo è definito, per la prima volta
nella Bibbia ebraica, ‘ebreo’, e il significato del termine è cosi spiegato in Berešit
Filosofia & Linguaggio in Italia 2002 — sez. 10
279
Silvano Facioni
Rabbah: «Rabbi Yehudah disse: tutto il mondo andava da una parte (‘ever) e lui
dall’altra».
«Dall’altra parte»: se l’ebreo è l’uomo dell’altrove allora l’ebraico sarà la lingua
dell’oltranza, ovvero la lingua in cui Dio si manifesta e si lascia dire come
trascendenza della lettera, lettera della lettera, nome del nome, presenza di
un’assenza che non è buio ma eccesso di senso, eccesso come esorbitazione (da cui
il sistema-linguaggio), come spaziatura (il nome come ‘là’), come mondo (la
creazione avviene, secondo la tradizione cabbalistica, attraverso le lettere
dell’alfabeto, o meglio è essa stessa disposizione alfabetica della lingua originaria).
Lingua-mondo, l’ebraico converge nel Tetragramma da cui pure deriva,
secondo quella singolare scansione del tempo-mondo in cui creazione e redenzione
(che ne rappresentano le estasi diacroniche) si mostrano secondo un ordine che è
rovesciamento/oltrepassamento delle dimensioni del tempo: abbiamo già detto
della coniugazione aspettuale del tempo, secondo cui esiste un perfetto/compiuto e
un imperfetto/incompiuto. Ebbene il compiuto è quanto di trova davanti a me
(come recita l’avverbio lephanim che significa anche ‘davanti’, ‘prima’, ‘passato’),
mentre l’incompiuto è sempre ’aharith ovvero ‘dietro’ come ciò che non posso
vedere: nel Tetragramma il futuro è guadagnato attraverso l’origine, ovvero
attraverso quel rapporto con l’origine che è determinato dalla parola che è aperta al
senso quando si rivolge, sincronicamente, davanti e dietro sé, quando, ancora una
volta, trans-corre, oltre-passa (come l’etimo del pronome relativo ’ªšer, da cui
deriva anche il termine ’ªšur che significa ‘pianta del piede’ con evidente rimando
al passo, al passaggio, sembra suggerire), quando, in una parola, lo stesso futuro si
futurizza, rilanciandosi incessantemente ‘dietro’ di sé (come la ripetizione di
’ehyeh nel versetto di Esodo 3, 14). In questo movimento che dal nome proprio di
Dio prende avvio ed intorno ad esso orbita lungo il corso della storia, è
rintracciabile il senso della profezia di Zaccaria 14, 9: «In quel giorno il Signore
sarà uno ed il suo nome uno».
Ma forse, per tornare a Esodo 3, 14, si deve ascoltare, ancora una volta, la voce
degli antichi commentatori rabbinici: il versetto 15 del capitolo 3 del libro
dell’Esodo infatti, prosegue la rivelazione di Dio in questo modo: «Questo è il mio
nome per sempre e questo il ricordo di me di generazione in generazione».
Riferendosi alla radice ebraica della parola ‘sempre’ (le‘olam) scritta nella
Bibbia in maniera defettiva (ovvero senza la lettera vav, che sarebbe la ‘o’ di
le‘olam), Rashi — riprendendo un insegnamento talmudico (Qiddušin 71a) —
interpreta la risposta di Dio come: «Questo è il mio nome che deve rimanere
nascosto (ha‘alimenu)». La stessa radice (‘ayin-lamed-mem) che produce
l’avverbio ‘per sempre’ produce anche, in ebraico, il verbo ‘nascondere’, vale a
dire che l’omografia ha reso possibile il disvelarsi di un senso all’interno del senso.
Un senso che, nell’atto stesso del suo manifestarsi, si dichiara ‘nascosto’, segreto,
da cercare all’infinito. Esattamente come Dio.
Bibliografia
DE LIBERA, A. e ZUM BRUNN, E., 1986: Celui qui est. Interprétations juives et
chretiennes d’Exode 3, 14, Cerf, Paris.
BARR, J., 1968, The Semantics of Biblical Language, Oxford University Press, London
(1961); tr. it. Semantica del linguaggio biblico, Il Mulino, Bologna.
BENVENISTE, E., 1971: Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris (1966); tr.
it. Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano.
280
Per un approccio ebraico al nome di Dio
BUBER, M., 1983: Moses, Kösel Verlag, München (1945); tr. it. Mosè, Marietti, Casale
Monferrato.
CHILDS, B.S., 1974: The Book of Exodus, The Westminster Press, Philadelphia.
CROSS, F.M., 1962: ‘Yahweh and the God of the Patriarchs’, Harvard Theological
Review, 55, pp. 225-259.
DALMASSO, G., 1996: La verità in effetti. La salvezza dell’esperienza nel neoplatonismo, Jaca Book, Milano.
GIQATILLA, Y., 1989, Ghinat Egoz, a c. di M. Attia, s.e., Jerusalem.
GOLDBERG, A., 1987: ‘Die Schrift der rabbinischen Schriftausleger’, Frankfurter
Judaistische Beiträge, pp. 1-15.
GUILLAME, G., 1964: Langage et Science du langage, Nizet/Laval, Paris/Québec.
HENGEL, M., 2001: Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter
besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh.sv. Chr., J.C.B. Mohr,
Tübingen (1988); tr. it. Giudaismo ed ellenismo. studi sul loro incontro, con particolare
riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a. C., Paideia, Brescia.
LEFEBVRE, G., 1955: Grammaire de l’Ègyptien classique, s.e., Le Caire.
LEVINAS, E., 1986: L’au-delà du verset, Les Editions de Minuit, Paris (1982); tr. it.
L’aldilà del versetto, Guida, Napoli.
SCHOLEM, G., 1998, Der Name Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala, Suhrkamp
Verlag, Frankfurt a.M. (1970); tr. it. Il Nome di Dio e la teoria cabbalistica del linguaggio,
Adelphi, Milano.
Filosofia & Linguaggio in Italia 2002 — sez. 10
281