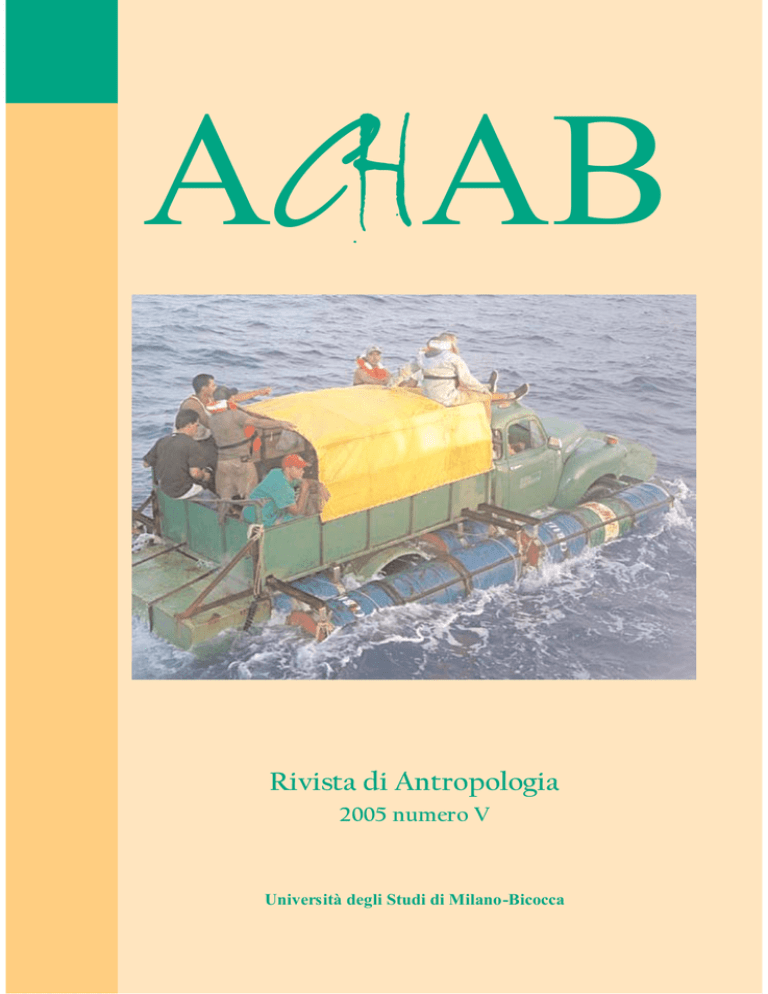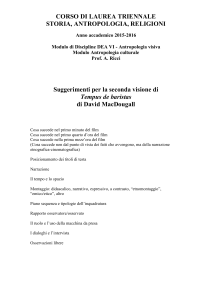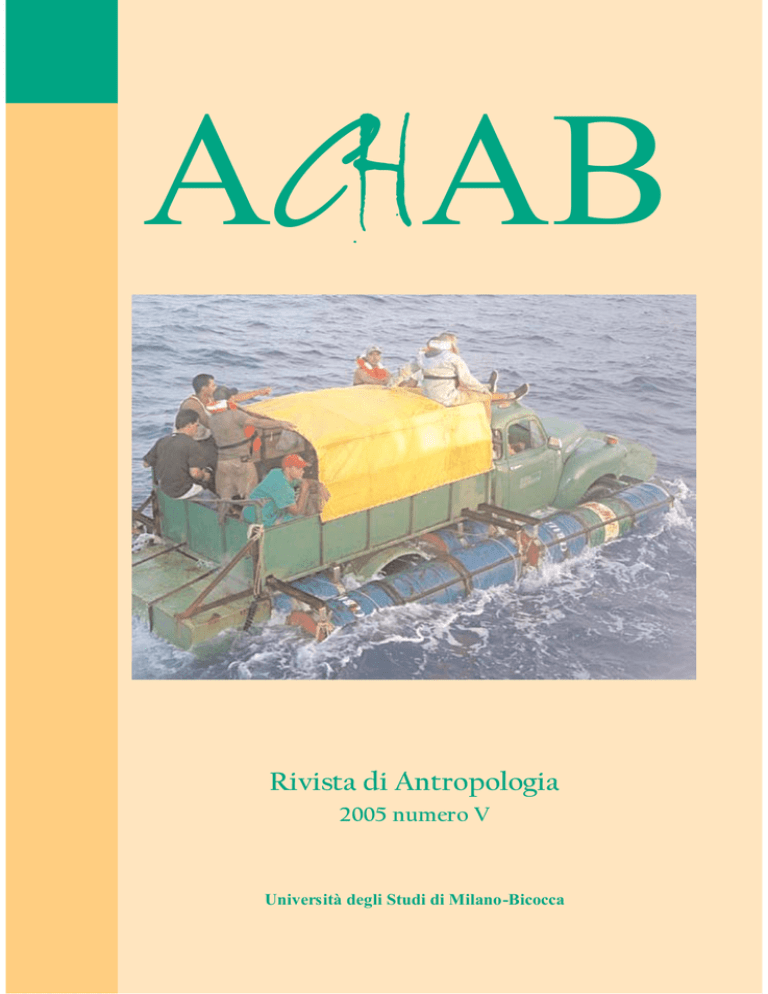
ACHAB
Rivista di Antropologia
2005 numero V
Università degli Studi di Milano-Bicocca
AChAB
Rivista studentesca di Antropologia dell'Università di
Milano-Bicocca - Numero V
Direzione editoriale
Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi
Se volete collaborare con la Rivista
inviando vostri articoli, oppure,
contattare gli autori, scrivete a:
[email protected]
Redazione
Paolo Borghi, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele
Parodi, Fabio Vicini
Progetto Grafico
Lorenzo D'Angelo
Impaginazione
Paolo Borghi, Fabio Vicini
Tiratura: 500 copie
Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del domino di alcune immagini
utilizzate in questa rivista. Gli autori sono invitati a contattarci.
*Immagine in copertina tratta da www.corriere.it (profughi cubani).
*Le immagini a lato e sotto a questo box sono di Anna Sambo (Benin 2004)
Visitate il sito www.studentibicocca.it/achab
In questo numero...
2
Achab, tra alterità radicale e molteplicità di prospettive
di Michele Parodi
3
L'identità Mizrahi nella società israeliana.
Riflessioni sulle categorie di nazione, etnia e classe
di Rossana Di Silvio
12
Una ricerca etnomusicologica nell'ambito delle cure 'alternative':
tre pratiche musicali di guarigione
di Patrizia Santoro
21
Dialogo sulla guerra
Siamo in guerra di Pietro Clemente
Spade e crisantemi. Antropologi in tempo di Guerra di Valerio Fusi
31
Itinerari di pre-comprensioni tra narrazione e riflessività
di Paolo Benini e Gabriella Erba
42
Quale fine per la ricerca etnografica?
Alcune osservazioni suscitate dalla lettura di "Itinerari di pre-comprensioni tra narrazione e riflessività"
di Michele Parodi
44
Relazione da Bomalang`ombe, regione di Iringa, Tanzania.
di Edoardo Occa
47
Libri e poesie
a cura di Antonio De Lauri
Gruppo di antichi cavalieri, cimitero nella valle di Bashgal, Kafiristan.
Musée Guimet, Paris.
1
Achab, tra alterità radicale e
molteplicità di prospettive
di Michele Parodi
Nella figura di Achab convergono due immagini, il re empio di
Israele raccontato dalla Bibbia e il capitano di baleniere del
romanzo di Melville.
dalla empia Gezabele, figlia del re dei Sidoni, fece si che gli dei
fenici diventassero dei nazionali in Israele. Andò a servire a Baal
e ad adorarlo. Eresse un tempio ai Baal in Samaria (Terzo libro
dei Re, 16, 29). Baal, un nome divino, teonimo polivalente dietro
cui si celano molteplici manifestazioni.
Così in Acab paradossalmente confluiscono il singolare, il Dio
unico di Israele, e il plurale, il multiforme Baal. E ancora una
volta questo rapporto impossibile può essere pensato come
metafora del rapporto dell'antropologia con i suoi oggetti, oggetti
di cui descrive la forma unica, scientifica, al medesimo tempo
negandone però l'assolutezza. Giudizi inevitabilmente
compromessi da un particolare punto di vista. Ad ogni descrizione
l'antropologia accosta segretamente il compagno nascosto, l'altro
volto senza espressione e senza occhi. Molteplicità indefinita
irriducibile ad un unico sguardo, forza ribelle e destabilizzante
attraverso cui aprirsi al mondo.
Alla fine su Acab-Baal trionferà la potenza del Dio unico. Il
profeta Elia dirà: "Prendete i profeti di Baal: non ne scampi
nemmeno uno… Elia li fece scendere al torrente Cison, ove li
uccise tutti" (Terzo libro dei Re, 18, 40). Anche Acab sarà ucciso,
ucciso in battaglia travestito per non farsi riconoscere. Come
profetizzato i cani leccheranno il suo sangue (Terzo libro dei Re,
22, 38).
In Moby Dick Achab è il capitano del Pequod all'inseguimento
della balena bianca: Moby Dick,
l'essere misterioso,
irraggiungibile e inafferrabile che affiora all'orizzonte con uno
sbuffo per poi immergersi nuovamente negli abissi marini
inaccessibili all'uomo, in acque che sembrano infinite, che tutto
ricoprono e celano. La balena bianca è il prendere forma del
sacro, il trascendente che affiora mostrando per un istante la sua
ambiguità incomprensibile.
Ma Moby Dick ha strappato una gamba ad Achab ed egli non si
rassegna a quella perdita senza spiegazione. Esige una risposta o
una vendetta. Ricerca sacrilega impossibile, senza fine, destinata
alla sconfitta.
La ricerca di Achab è pensabile come metafora dell'antropologia,
alla perenne ricerca di un'alterità che sempre gli sfugge e che
sempre gli deve sfuggire. Antropologia empia poiché non
rassegnata ad un rapporto negativo con la natura e l'uomo, ma
impegnata a svelarne la fecondità creatrice.
Contro l'intangibilità delle cose proclamata dal religioso e dalla
cultura, dall'ideologia, l'antropologia afferma il suo sguardo
kinico e sovversivo. L'antropologia come critica, come
operazione decostruttiva delle sicurezze tranquillizzanti con cui
l'alterità può essere consumata in differenza. L'antropologia
quindi sempre contro se stessa, ironicamente impegnata in
descrizioni seguite al tempo stesso dalle prove della loro precaria
incompletezza.
Ma Moby Dick può essere irresistibile incantatrice, come le
sirene di Ulisse, voce che attira. Bisogna allora tapparsi le
orecchie, attraversare l'oceano rimanendo sulla soglia dell'abisso.
Nel romanzo di Melville Achab è invece vinto dalla sua brama di
vendetta, vuole uccidere, vuole possedere la balena. Per questo la
sua lotta è destinata alla sconfitta. Uccidere Moby Dick vorrebbe
dire reificare ciò che invece trascende ogni mira totalizzante.
Achab preso e strangolato dal cappio della corda del suo arpione
scompare trascinato negli abissi dalla balena. L'alterità radicale,
al posto di suggerire un dialogo mai conclusivo, può divenire una
costruzione altrettanto ideologica con cui affermare e reificare
una diversità che impone una separazione insanabile.
Continua...
“Achab”, dipinto di Gianni Fochi
http://homepage.sns.it/fochi/Quadri.html
Achab, Acab, è anche il più empio re d'Israele, colui che sedotto
2
L'identità Mizrahi nella società israeliana
Riflessioni sulle categorie di nazione, etnia e classe
di Rossana Di Silvio
nazionale in "movimento sionista attuativo" (Barnavi, 1996).
Con l'Illuminismo e la Rivoluzione francese, anche l'ebreo si
trova ad essere proiettato nei cambiamenti che si susseguono e
che avvolgono la società in una benefica atmosfera di liberalità. In
un mondo teso all'efficienza ed aperto al talento individuale, egli
si fa strada in tutti i campi, dalla scienza, alla finanza, all'arte,
diventa "ebreo in casa e uomo nel mondo", come vuole la
haskalah, la versione ebraica dell'Illuminismo (Barnavi, 1996).
Ma questo compromesso non lo ripara dai sentimenti rancorosi
dei Gentili che vedono in lui, in quanto uomo nel mondo, il
concorrente pericoloso ed invadente, ed in quanto ebreo dunque"diverso"- facile e credibile "capro espiatorio" di tutti i
mali sociali del momento. D'altro canto, in questo mondo aperto,
liberale, borghese e nazionalista l'ebreo si inserisce male perché,
per quanti sforzi faccia, le sue radici sono sempre altrove, e nel
suo spasmodico desiderio di fondersi con la cultura circostante,
assomiglia sempre più a quel patetico personaggio kafkiano che
diventa più indigeno degli stessi indigeni, e proprio per questo
viene rifiutato.
Ancora nella seconda metà del XIX sec., gli ebrei che vivono in
Occidente continuano a sostenere con convinzione un processo di
emancipazione che sfoci naturalmente nella assimilazione alla
cultura secolare, trasformandoli in israeliti, ovvero cittadini di
pari grado dei loro compatrioti gentili, con diversa appartenenza
di culto (Barnavi, 1996). Un principio che per definizione esclude
l'emancipazione degli ebrei in qualità di nazione.
Diversa è la situazione degli ebrei dell'Europa Centro-Orientale, i
quali, proletarizzati e ghettizzati, hanno poche speranze di
assimilazione e le cui tradizioni ed istituzioni religiose
comunitarie hanno mantenuto tutta la loro energia unificatrice. La
lotta di questa comunità si orienta al riconoscimento in quanto
nazione ebraica, identificabile anche attraverso una propria
lingua, lo yiddish, una nazione pensata in quel medesimo luogo
geografico, di cui rivendicano l'appartenenza al pari degli altri
popoli coabitanti. Il Bund socialista diventa lo strumento di lotta,
espressione dell'autonomismo politico e culturale della comunità
ebraica centro-orientale, partito operaio antisionista, che vede la
luce nell'ultimo decennio dell'ottocento. Ma l'esperienza del
Bund, oltre a suscitare l'ostilità degli altri partiti operai per la sua
specificità culturale, non sarà in grado di proteggere i propri
membri dalle vessazioni non solo di classe, ma anche
antisemitiche del proletariato gentile, e andrà a confluire nel
movimento sionista politico, connotandolo in senso ideologico e
socialista, caratteristiche che gli saranno proprie da quel momento
e che andranno a condizionare fortemente la fisionomia dello
Yishuv prima e dello Stato poi (Barnavi,1996).
Questo lavoro intende proporre alcuni elementi di riflessione per
la comprensione del fenomeno di etnicizzazione della società
israeliana prendendo come riferimento paradigmatico la
condizione degli ebrei Mizrahim, sefarditi od "orientali", che dir
si voglia. Il materiale utilizzato proviene da diversi campi, storico,
etnografico, geo-politico e urbanistico, prospettando
un'interazione multidisciplinare che informa molto bene della
complessità dell'argomento (Goldberg e Salomon, 2002).
Verrà tratteggiato il contesto storico in cui ha preso idea e forma
la costruzione della nazione israeliana, sottolineando l'aspetto di
contaminazione con la cultura europea dominante e con le sue
categorie portanti, verranno analizzate la trasposizione e la
riformulazione di tali idee nell'ambito del nascente contesto
socio-politico israeliano e si concluderà con uno specifico
approfondimento sulla condizione identitaria degli ebrei Mizrahi,
sul loro strutturarsi in etno-classe e su alcune forme di resistenza
adottate contro la perifericità socio-culturale di cui sono stati fatti
oggetto.
Il contesto storico
Il 14 maggio 1948 Ben Gurion legge la Dichiarazione
d'Indipendenza di Eretz Israel, un sogno plasmato nel corso
dell'ultimo secolo ad opera di un movimento, quello sionista, che
affonda le sue radici nelle ideologie dell'ottocento europeo,
habitus sociale e culturale dei primi sostenitori provenienti
dall'Europa Centrale e Orientale. Così nazionalismo, laicità e più
tardi socialismo operaio, costituiranno le idee portanti di ciò che
diventerà un apparato statale ancor prima di avere una definizione
territoriale. Tuttavia, queste idee di nazionalismo saranno fin da
subito scarsamente condivise dall'intera collettività ebraica perché
mal si accordavano con un'altra idea di nazione, strettamente
interrelata con la religione, le cui radici spirituali, pratiche e
rituali, hanno permesso al popolo ebraico di conservare la sua
peculiarità di nazione, la sua specificità, lungo i duemila anni
dell'ultima diaspora. E non solo gli ortodossi europei, gli
haredim, sono contrari al sogno secolare sionista, anche lo Yishuv,
l'antica e scarna comunità ebraica sopravvissuta nei secoli in terra
di Palestina, gli è apertamente avverso per i medesimi motivi.
Secondo queste realtà centrate sull'ebraicità spirituale e sul "Mito
dell'Attesa", i sionisti, in gran parte atei e secolarizzati, con il loro
terreno desiderio di emancipazione sfidano apertamente la
volontà di Dio, mostrando un atteggiamento empio. Fu il nascente
antisemitismo europeo (termine coniato nel 1874) e, con il tempo,
il suo terrificante ingrossarsi, a costituire lo strumento di
maggiore forza nella traduzione del vecchio movimento religioso-
3
Alla fine dell'ottocento molti ebrei sono costretti a migrare verso
nazioni più tolleranti, gli Stati Uniti in modo particolare, ed in
Europa cominciano a circolare idee più corpose sulla
autoemancipazione del popolo ebraico. A farsi portavoce di
questa prospettiva sarà innanzitutto un medico di Odessa, Lev
Pinsker, il quale, diagnosticando l'antisemitismo come una
"perversione patologica dell'animo umano" e per ciò stesso,
"incurabile", propone come rimedio l'"occupazione di un focolare
nazionale[….]un pezzo di terra di cui avere proprietà e dal quale
nessuno straniero ci possa scacciare"(Barnavi, 1996). Non
saranno però gli ebrei occidentali, troppo impegnati nel processo
di assimilazione, a raccogliere il messaggio auto-emancipatorio
del medico di Odessa. Saranno piuttosto le comunità "orientali" a
dare concreto vigore all'azione sionista. La comunità orientale,
non solo russa ma anche polacca e rumena, affiderà a Pinsker la
leadership del movimento il cui scopo è la creazione di Eretz
Israel, innanzitutto mediante la raccolta di fondi per acquistare
terre in Palestina, e poi attraverso la migrazione in Terra Santa
che, iniziata numerosa già nel 1882, proseguirà in una successiva
ondata ai primi del novecento.
Il successo e l'entusiasmo dell'operazione non fornisce, tuttavia,
quello slancio comunitario generale che ci si sarebbe aspettato. Il
movimento sionista europeo ristagna, frammentato in centinaia di
società e con notevoli frizioni interne. L'elemento che trasmette
una nuova accelerazione sarà ancora una volta l'antisemitismo
crescente, ed in particolare il caso Dreyfus in Francia, nonché
dell'elezione di un sindaco antisemita a Vienna. Ma ancor più
varrà il pensiero e l'opera di Theodor Herzl, che intravede in
questi segnali l'anomalia storica rappresentata dagli ebrei, popolo
dotato pienamente di cultura propria ma nella particolare
condizione, per l'appunto storicamente anomala, di essere privo di
una collocazione geografica e di una identità statuale. Con "Lo
Stato degli ebrei: soluzione moderna per un problema antico" del
1896, testo fondante del sionismo politico, Herzl trasformerà in
poco tempo un movimento ormai amorfo in una macchina potente
ed efficace. Nel 1897, a Basilea, il primo Congresso Sionista
definisce chiaramente lo scopo del movimento: la creazione di un
focolare per il popolo ebraico in Palestina, che fosse garantito dal
diritto pubblico. Il movimento sionista entra realmente in azione:
viene creata un'Organizzazione Sionista Mondiale, una banca,
una struttura di divulgazione a mezzo stampa in più lingue. Lo
Stato, che si prefigura come prodotto della lunga memoria del
popolo ebraico, sarà al tempo stesso una rottura e una
continuazione della tradizione (Barnavi, 1996): rottura nel
pensiero di uno stato moderno e laico, in stretta sintonia con il
modello culturale assimilato dall'ebraismo occidentale, e
continuità nell'entusiasmo messianico di cui sono portatori quei
proletari dell'est che s'impossesseranno concretamente di quello
Stato. L'essenza del nascente Stato israeliano sarà, negli anni a
venire, proprio in questa sua doppia origine, rivelandone ogni
volta le incoerenze, i tentennamenti, le frammentazioni, l'elevata
complessità, le numerose anime che ancora nel presente
esprimono tutta la fatica della fusione, mai del tutto raggiunta, in
una unica realtà sociale (Giorgio, 2000).
Il contesto socio-politico
Si può affermare che il sionismo rappresenta la versione moderna
di un'antica ossessione ebraica: la ricerca di "normalità" (Barnavi,
1996). Un sentimento che tuttavia ha sempre espresso una sua
intrinseca ambiguità, la normalità cercata non ha mai avuto il
significato di "essere uguale agli altri", anzi l'ebraicità, ancorché
svuotata delle sue implicazioni religiose, non ha mai smesso di
essere preservata. Lo Stato così costruito sull'ideologia sionista, di
stampo fortemente socialista, doveva avere carattere di
democrazia occidentale e al tempo stesso essere Stato "ebraico",
uno Stato conforme agli ideali profetici, debitamente laicizzato e
aggiornato alle tendenze nazionalistiche dell'epoca. Una
condizione per certi versi non difforme da quella delle giovani
nazioni di recente emancipazione dal dominio coloniale: come
queste il nascente Stato israeliano prendeva a prestito da realtà
esterne, quella occidentale in primo luogo, modelli e forme di vita
sociale e politica che non gli appartenevano storicamente
(Anderson, 1996 -Hobsbawm e Ranger, 2002), ma,
differentemente da questi, gli ebrei avevano una lunga esperienza
diretta di forme riccamente elaborate di vita comunitaria
all'interno dei diversi paesi che per tanti secoli li avevano accolti,
ospitati, integrati.
L'imperativo divenne "ricollegare l'ebreo alla terra", ristabilire
concretamente questo vincolo che, assolutamente scontato per
quelle nazioni europee dispensatrici di ideologie nazionaliste, egli
aveva perduto nell'esilio prolungato (Barnavi, 1996). Era
necessario far rivivere una lingua nazionale, ormai sepolta nel
tempo, inventare una tradizione nazionalistica, un apparato
statuale, un esercito, festività ed eroi nazionali, un corpus
cerimoniale, attraverso i quali rivestire l'ebreo di un abito di
nuova foggia, nazional-moderna, rimaneggiando la storia, ma
soprattutto il mito, in modo particolare quello relativo
all'indissolubile omogeneità del popolo ebraico (Yiftachel, 1999).
Tuttavia, già nello Yishuv pre-statale, emergono numerosi
contrasti, legati principalmente alla difficoltà della co-presenza di
laici e religiosi, di cui il più importante e duraturo sarà quello tra
Mizrahi o sefarditi (la comunità di rito spagnolo proveniente
dall'area musulmana) e Ashkenazi (comunità di rito tedesco
proveniente dall'Europa centro-orientale).
Il neo Stato d'Israele erediterà, e in esso perdureranno, tutti i tratti
dell'ambivalenza insita nella coesistenza di questi due presupposti
identitari, laico e religioso, di provenienza orientale e occidentale,
che si esprimeranno nell'estrema frammentazione partitica e nella
marcata polarizzazione ideologica del Paese, nonché nella
spaccatura a livello giudiziario tra tribunali civili, fondati sul
diritto occidentale, e tribunali rabbinici, fondati sulla Torah, cui
sono tutt'oggi demandate le competenze in materia di statuto
personale dei cittadini di culto giudaico, siano essi credenti o
agnostici (Guolo, 1997 - Vidal e Algazy, 2003). Così il significato
simbolico di questi elementi della tradizione religiosa
reintroducono quel substrato che si voleva espulso dalla nuova
esegesi nazionale: una immagine spirituale della nazione ottenuta
attraverso la forzatura biblica in senso attivistico, ma anche tesa a
4
ridefinire l'autorità in campo religioso e a porsi come fonte di in cui poter consumare il mito della unicità del popolo ebraico,
legittimazione dei nuovi significati di antichi simboli.
non è riuscito nella realtà a strutturare nessuna forma di "meltingAll'interno del quadro politico e di governo del Paese tale pot" (Galili, 2004). Anzi, più premeva la spinta migratoria, più
situazione ha comportato nel tempo una tendenza generale al s'incrinava l'unitarietà della cultura politica nazionale fondativa,
raggruppamento delle forze in tre macro espressioni, già di matrice sionista-laburista, basata sul binomio identità
ampiamente visibili negli anni '20: la sinistra dell'area sionista nazionale-laicità, dando sempre più spazio alle fratture culturali o
socialista, la destra dell'area "revisionista" sionista e il Partito neoetniche e ad ulteriore frammentazione sociale (Vidal e Algazy,
Nazionale Religioso, con un'ampia componente Mizrahi.
1999).
In linea generale, dunque, il governo dello Stato israeliano ha
comportato un continuo e assai precario equilibrio dello status L’ etnicizzazione della società
quo tra l'anima laica e religiosa del costrutto identitario nazionale, Gli studi sui nazionalismi hanno esplorato raramente le
creando in definitiva un sistema fondato sulla neutralizzazione del stratificazioni sociali intra-nazionali che sono correlate al
conflitto religioso attraverso una concezione del "politico" che, processo di costruzione della nazione (Yiftachel,1997). Nel caso
anziché secolarizzare i concetti teologici, riteologizza concetti di Israele, dove i paradigmi dell'occupazione e del possesso della
secolarizzati (Barnavi, 1996 - Guolo, 1997). Inoltre, le tensioni terra, tipici del discorso sionista, sono fondanti la costruzione
culturali derivanti dalla difficoltà di scindere identità religiosa e della nazione, lo studio delle "frontiere interne", frutto della
nazionale, hanno reso impervia la
colonizzazione del territorio, può
strada della piena laicità dello
spiegare la creazione e la
Stato, anche in ragione di una
riproduzione della disparità tra gli
continua emergenza bellica che ha
ebrei Ashkenazi e Mizrahi
imposto una ricerca ad oltranza di
(Yiftachel,1998).
Dopo
un certo grado di coesione
l'indipendenza, Israele entra in una
nazionale (Giorgio, 2000). Le
fase di radicale ristrutturazione del
continue crisi, comunque, non
territorio, con una intensificazione
sono mai approdate, di fatto, a vere
delle tattiche e delle strategie nella
e
proprie
rotture;
anzi,
costruzione culturale etnocentrica
l'opposizione religiosa, anche nel
dello Yeshuv pre-statale, favorito
lungo governo delle sinistre, è
dalla acquisizione di un apparato
riuscita ad inserirsi con profitto
statale, di un esercito e della
nelle intercapedini delle divisioni
legittimazione internazionale. La
interne
ai
grandi
partiti
ristrutturazione del territorio
(Guolo,1997), e l'atteggiamento di
ruotava attorno al principio
compliance mostrato dai governi di
fondamentale della giudaizzazione
maggioranza nei confronti delle
del territorio attraverso un capillare
opposizioni religiose ortodosse è
programma di diffusione della
Le dodici tribù d’Israele
spiegabile solo se inquadrato
popolazione ebraica, fondato sul
nell'azione di un patto di sistema insito nelle
presupposto dell'appartenenza della terra al
modalità di costruzione dell'ordinamento statale (Barnavi, 1996). popolo ebraico. Il nascente stato israeliano sviluppò una forma
L'esempio più rilevante di applicazione della politica dello status esclusiva di etnonazionalismo, di cui le frontiere divennero
quo è la rinuncia del nuovo Stato a darsi una costituzione, che l'icona portante: la colonizzazione fu considerata una delle
viene in qualche modo "sostituita" dalle undici Leggi massime acquisizioni di ogni sionista, e i kibbutzim di frontiera
Fondamentali, di cui la più importante, per misurare i rapporti tra fornirono il modello per la riconquista della "Terra di
laici e religiosi, è la "Legge del Ritorno", che permette di definire Redenzione" (Yiftachel, 1999 - Massey e Jess, 2001). Prima del
chi è ebreo e le modalità di acquisizione della cittadinanza 1948, solo il 7-8% della Palestina era in mano agli ebrei, ma
israeliana. Anche in questo caso, i forti contrasti derivanti da una durante la prima ondata migratoria, tra il '49 e il '52, furono
doppia definizione, quella etnico- religiosa (appartenenza per insediati circa 240 villaggi comunitari (kibbutzim e moshavim, la
ascendenza o per conversione) e quella nazionale (appartenenza versione sionista-religiosa della comunità agricola)
per cittadinanza), sono stati risolti attraverso compromessi, sulla prevalentemente lungo la Linea Verde (Barnavi, 1996 - Yiftachel,
base dei rapporti di forza degli attori in campo, obbligando la 1999).
politica ad adottare un modello di tipo consociativo, retta sul Nel corso della seconda ondata, tra i primi anni '50 e la metà degli
meccanismo dell'"integrazione per divisione" o, più anni '60, sorsero 27 città di sviluppo e ulteriori 56 villaggi,
semplicemente sul meccanismo separazione/compensazione popolati principalmente da migranti Mizrahi, ebrei nord-africani
(Barnavi, 1996 - Guolo, 1997). Lo stato ebraico, dunque, inteso in prevalenza, ma anche medio-orientali e caucasici. Nello stesso
nel senso classico sionista di luogo d'accoglienza per tutti gli ebrei periodo numerosi gruppi di Mizrahim furono allocati in quartieri
5
urbani di "frontiera", nelle adiacenze dei quartieri o delle aree
palestinesi. Nel corso della terza ondata migratoria, circa venti
anni dopo, sorsero più di 150 piccole "città di sviluppo", situate
proprio nel cuore di entrambi i lati della Linea Verde. Questi
ulteriori insediamenti furono presentati all'opinione pubblica
come un rinnovato sforzo di giudaizzare le frontiere ostili di
Israele, usando la tipica retorica della "sicurezza nazionale"
(Yiftachel, 1998).
Dato il basso livello delle risorse socio-economiche di molti
Mizrahim, minore istruzione e basse competenze professionali,
nonchè della loro provenienza maggioritaria dalla cultura araba e
la mancanza di legami con le elites israeliane, le "città di
sviluppo" e i "quartieri di frontiera" divennero velocemente, e
così sono rimasti, specifiche concentrazioni di popolazione
Mizrahi povera, segregata e deprivata (Eickelman, 1993 Yiftachel, 1998). La politica nei confronti degli ebrei "orientali"
può considerarsi un ottimo esempio di applicazione di quel
meccanismo di separazione/compensazione su cui, si diceva, si
fonda la dinamica dello status quo in campo sociale.
Dagli studi del Centro ADVA relativi al decennio 1990-2001,
emerge la profonda disparità salariale tra ebrei di origini
occidentali ed ebrei "orientali" o asiatici; ugualmente l'istruzione
risulta nettamente a favore dei giovani appartenenti al gruppo
ashkenazi ed il dato è direttamente correlato con lo status socioeconomico (ADVA Center, 2003). Le profonde disuguaglianze tra
i diversi segmenti della popolazione, già ampiamente evidenti a
partire dagli anni settanta, sono state ulteriormente aggravate dal
recente passaggio, da parte dello Stato, da un sistema economico
fondato sulla ridistribuzione del reddito nazionale ad un'economia
di tipo liberista e globalizzata. Nel 2000, circa un terzo degli
abitanti e dei lavoratori dei kibbutz vivevano sotto la soglia di
povertà e in generale si evidenziava un peggioramento generale
delle condizioni di vita di una parte consistente della società
israeliana, in particolare a carico degli ebrei sefarditi, cui solo il
movimento-partito Sha'as faceva fronte assicurando un sistema di
assistenza sociale alternativo (Giorgio, 2000). Come agli esordi, il
carattere del nazionalismo in Israele è ashkenazi, costruito
attraverso un discorso frutto della contaminazione occidentale; la
stessa percezione del ruolo dello stato è ashkenazi, e gli ebrei
occidentali hanno raccolto più degli altri gruppi etnici i vantaggi
offerti dall'aver "occupato un focolare per il popolo ebraico".
L'autorizzazione all'imponente ondata migratoria degli anni
novanta di quasi un milione di ebrei russi, ritenuti di cultura
occidentale, va inquadrata nell'obiettivo di restituire agli
Ashkenazi quel ruolo maggioritario perduto in seguito
all'avanzamento sulla scena politica dei Sefarditi e di arginare di
conseguenza la crescente domanda di differenziazione e
riconoscimento identitari del gruppo "orientale", divenuta
nell'ultimo ventennio sempre più forte (Vidal e Algazy,
1999).Questa nuova immigrazione però ha ulteriormente
destabilizzato i già fragili equilibri preesistenti, non solo perché i
russi, a differenza degli orientali a suo tempo, sono stati accolti
con grande generosità dallo Stato (prestiti considerevoli a fondo
perduto, facilitazioni immobiliari, priorità nelle assunzioni, ecc.),
ma anche, e forse soprattutto, perché le motivazioni sottostanti
non sono di certo rappresentate da convinzioni sioniste, quanto
dalla ricerca di condizioni di vita ed economiche migliori
(Giorgio, 2000). I russi, inoltre, sono fieri della loro identità
europea, del loro modo di vivere, che ostentano e tentano di
imporre, e della loro capacità di auto-organizzarsi, anche dal
punto di vista della rappresentanza politica (Galili, 2000). Dal
canto loro gli "orientali" Mizrahi, che spesso si sono trovati a
dover condividere lo stesso spazio geografico e sociale con i
nuovi arrivati, hanno risposto con un irrigidimento di quelle
posizioni sioniste, marcatamente di tipo nazionalistico-religioso,
mostrando, tra l'altro, di aver interiorizzato l'immagine sprezzante
e quasi razzista che gli Ashkenazi avevano di loro (Vidal e
Algazy, 1999). Tuttavia, i fenomeni di intolleranza etnica che
hanno percorso Israele negli ultimi decenni hanno radici lontane,
in quella stessa figura di "ebreo nuovo" che il sionismo sognava:
un ebreo-israeliano monolitico a fondamento di una società
unitaria che aveva condotto, soprattutto negli anni '50 e '60, ad
una omogeneizzazione brutale il cui costo attuale comporta che
ogni gruppo rivendichi non solo una sua identità e collocazione,
ma l'egemonia, e che l'attuale sistema elettorale ha in qualche
modo legittimizzato attraverso l'etnicizzazione della politica
(Giorgio, 2000).
Le elites ashkenazim si sono sempre più legate ai settori avanzati
dell'economia mondiale, lasciando indietro larghi strati di
popolazione ebraica, in prevalenza Mizrahim, mentre i russi
appaiono in questo gioco ancora una incognita.
Non sono pochi gli studiosi israeliani di scienze sociali, e non
solo, a sostenere che per Israele il carattere democratico del Paese
è unicamente una costruzione percettiva, cui hanno contribuito, e
contribuiscono, a vario titolo, oltre agli apparati governativi
dominanti, i media, le accademie e la retorica politica (Yiftachel,
1999 - Warschwski, 2004). Infatti, se per democrazia s'intende la
presenza di elementi strutturali fondanti, come confini chiari entro
cui sviluppare aspetti diversificati della società civile, una
costituzione, uguaglianza di diritti politici ecc., Israele non può
dirsi una democrazia. Al massimo si può parlare di aspetti
democratici che vanno a costruire, per l'appunto, un'immagine
percettiva, interna ed esterna, intra-nazionale ed internazionale.
In realtà, così come sostiene Oren Yiftachel, ad un' indagine più
approfondita emerge il carattere prevalentemente "etnocratico" di
Israele: un regime dove l'appartenenza etnica e non di
cittadinanza è la logica principale della distribuzione delle risorse;
dove i confini dello stato e le specificità politiche sono sfuocati e
dovuti principalmente al ruolo delle diaspore etniche e alla
posizione subalterna delle minoranze; dove un gruppo etnico
divenuto dominante si è appropriato dell'apparato statuale e
determina la gran parte delle politiche pubbliche (Yiftachel,
1999).
Il carattere costitutivo di questa etnocrazia è quello della
colonizzazione etnica, ma la fusione dei principi etnocentrici con
le dinamiche della colonizzazione ha creato modelli di
stratificazione sociale e di frammentazione etnica all'interno della
stessa società. Infatti, la ragione fondante della etnocrazia ebraica,
6
ovvero l'esclusione spaziale dei palestinesi, ha subito una sorta di
diffusione intra-sociale ed ha legittimato i modelli di
etnicizzazione interna vistosamente visibili nella segregazione
spaziale e nella tensione tra ebrei Ashkenazim e Mizrahim. Come
i palestinesi, anche i Mizrahim hanno subito una
marginalizzazione spaziale all'interno del progetto di
colonizzazione israeliano, per la quale sono stati confinati nelle
periferie più isolate del territorio o nei quartieri più poveri delle
principali città israeliane, limitando fortemente il loro potenziale
di mobilitazione economica, sociale e culturale. Inoltre il
medesimo modello segregativo è stato utilizzato sia nei confronti
dei gruppi Haredim (gli ebrei ultraortodossi) che dei russi di
recente immigrazione. In altre parole, la logica segregazionista
del regime etnocratico è stata infusa nelle pratiche spaziali e
culturali che hanno lavorato per "etnicizzare" Israele (Yiftachel,
1999).
Questo processo ha comportato una serie crescente di
ripercussioni sui livelli di eguaglianza dei diritti legali e politici,
sul pluralismo culturale, sui livelli di tolleranza nei confronti degli
"altri" e, soprattutto, su genuine aperture politiche che
superassero lo stile ideologico di vita delle comunità
(Warschawski, 2004). Al contrario, la tendenza etnicistica è stata
così potente da incrementare in modo smisurato l'affiliazione
politica di matrice etnico-classista-religiosa, come è risultato
evidente nelle elezioni del '96, dove questi tipi di formazioni
politiche hanno surclassato i due partiti storici principali, i
Laburisti e il Likud, tradizionalmente più eterogenei dal punto di
vista etnico (Tzfadia e Yiftachel, 2003). Il prezzo più alto di
questa operazione è stato ovviamente pagato dai palestinesi,
seguiti a poca distanza dai Mizrahim insediati nelle città di
frontiera, nei villaggi agricoli periferici e nei quartieri poveri delle
città.
Sembra esistere un chiaro legame tra la de-arabizzazione del
territorio e la marginalizzazione dei Mizrahim. Essi sono stati
posizionati, geograficamente e culturalmente, tra gli arabi e gli
ebrei, tra Israele e i suoi vicini ostili, tra un passato orientale
sottosviluppato e un futuro occidentale di progresso (Yiftachel,
1997). Ma la profondità e l'estensione della discriminazione tra
palestinesi ed ebrei "orientali" è decisamente diversa, in quanto i
Mizrahim, ricompresi loro stessi nel progetto sionista, hanno
svolto e svolgono tuttora un ruolo attivo nella oppressione dei
palestinesi e nella giudaizzazione dei territori contesi e
colonizzati.
E' possibile dunque individuare uno stretto legame tra la
costruzione della nazione e le relazioni spaziali di gruppo
all'interno della nazione, tra impatto della colonizzazione delle
frontiere e divisione socio-politica dello spazio. Spesso gli studi
sul nazionalismo israeliano e le sue implicazioni spaziali si sono
mossi a partire dalla dicotomia oppositiva riguardo i confini
arabo-israeliani, scotomizzando l'evoluzione dei rapporti e dei
conflitti interni alla stessa società israeliana e l'impatto dello
spazio e della sua costruzione sociale sulla evoluzione delle
relazioni tra Ashkenazi e Mizrahi. Al contrario, la
individuazione/divisione dello spazio "stato-nazione" non è un
processo naturale, ma un progetto attraverso cui si costruisce una
realtà spaziale immutabile e la si radica nelle culture territoriali
mediante un rimaneggiamento degli elementi storici, diventando
in definitiva un modo efficace per legittimare la dominazione
sociale e politica di particolari gruppi (Hobsbawm e Ranger,
2002). Il lato oscuro e spesso poco discusso di questo progetto, è
l'oppressione delle minoranze socialmente periferiche, che si
manifesta attraverso svariati meccanismi, tutti finalizzati alla
riproduzione dell'egemonia della maggioranza in nome della
storia, del territorio e delle istituzioni dello stato (Massey e Jess,
2001). Interiorizzando una estrema e massificata sintesi della
prospettiva orientalista per cui le culture non-europee sono
inferiori, le elite dominanti utilizzano la medesima logica di
divisione/individuazione dello spazio per marginalizzare e
controllare socialmente i gruppi periferici in nome del cosiddetto
"interesse" della costruzione della nazione, fornendo in tal modo
una sorta di "licenza" sociale per la selezione dell'assetto culturale
e territoriale delle minoranze e creando, attraverso il mito
dell'unità nazionale, oppressione e disuguaglianza.
In questo quadro un caso particolare è rappresentato dalle società
colonizzanti, le quali secondo alcuni modelli teorici combinano
tre principali raggruppamenti sociali, spesso in relazione
gerarchica tra loro sia per quanto riguarda il potere che il
prestigio: un gruppo di potere costitutivo, il gruppo dei successivi
immigrati che vengono incorporati nel gruppo dominante ma con
status inferiore, e un debole gruppo indigeno, spesso escluso dalla
"nazione" (Massey e Jess, 2001). Una specifica strategia di
politica pubblica sancisce e definisce le profonde divisioni tra i
tre gruppi ed esercita pratiche pervasive di controllo sociale nel
percorso di costruzione della nazione: una di queste è la
colonizzazione delle regioni di frontiera e la divisione sociale
dello spazio nazionale, come nel caso di Israele (Yiftachel, 1998).
Le regioni di frontiera, dislocate ai margini geografici, politici e
culturali della società principale, giocano un ruolo centrale nella
costruzione delle identità nazionali e statuali. Esse sono zone
fisicamente e metaforicamente "indistinte", al margine del
controllo collettivo, ma che delineano la direzione dell'espansione
e della crescita, forniscono le basi per simboli, leggende e miti
usati nella costruzione dell'identità nazionale: sono il luogo dove
la collettività affina la sua identità nell'interazione con gli
"altri"(Yiftachel, 1999). La promozione e la costruzione sociale
delle regioni di frontiera hanno rappresentato un pilastro centrale
del progetto di costruzione dell'identità in molte società di
colonizzazione, ed in alcune società post-coloniali i governi
hanno deliberatamente re-insediato piccoli nuclei di gruppi etnici
maggioritari in alcune aree di frontiera interne, con lo scopo di
rinsaldare il controllo dello stato.
Le frontiere interne spesso sono presenti in quelle regioni con
un'alta concentrazione di minoranze etniche, dove il gruppo
dominante usa immagini ed ethos positivi dello sviluppo per
espandere l'influenza dell'apparato statale e riprodurre il proprio
potere. Tale operazione comporta in particolare il controllo della
pianificazione urbana e regionale, attraverso cui le elite dirigono
la collocazione e gli insediamenti in particolari aree, guidano lo
7
sviluppo, regolano l'uso del territorio ed impongono confini
municipali e burocratici (Tzfadia e Yiftachel, 2003). La divisione
sociale dello spazio è dunque fondamentale nella comprensione
delle relazioni tra gruppi, dal momento che essa riproduce
ineguaglianze sociali ed identitarie, come l'accesso ai servizi o il
prezzo della terra, con l'obiettivo di rinforzare e riprodurre una
determinata distribuzione delle risorse e delle opportunità
(Yiftachel, 1998). Come ci ricorda Edward Said, i processi di
insediamento e colonizzazione raramente sono neutrali, piuttosto
riflettono la subordinazione e la colonizzazione dello spazio, il
quale, in quanto produzione sociale, ristruttura costantemente le
percezioni sociali, in un continuo rimaneggiamento della
memoria collettiva di gruppo (Massey e Jess, 2001- Said, 1999).
Fra le altre peculiarità del colonialismo israeliano bisogna notare
che esso si è configurato più dal punto di vista territoriale che
economico (Yiftachel, 1999), ma soprattutto che, a differenza di
altre società coloniche dove il nazionalismo è stato uno sviluppo
di seconda data (Stati Uniti, Australia, Canada, ecc.), Israele è
stato portatore sin dall'inizio di uno specifico etno-colonialismo,
di matrice europea, assodato come modello a-priori del progetto
di costruzione della nazione.
Lo stato israeliano si è configurato sulla base di tre gruppi sociali:
un nucleo costitutivo di coloni, in prevalenza Ashkenazi, un
gruppo indigeno costituito dai Palestinesi, e un gruppo di
immigrati post-indipendenza, in prevalenza Mizrahi. Alla fine del
'96 la composizione di Israele contava il 34% della popolazione
Ashkenazi, il 37% Mizrahi, il 16% arabi e il rimanente 14% di
russi recentemente immigrati, con un gruppo costitutivo
dominante per il quale il controllo etnico, sia sugli arabi che sulle
minoranze ebraiche, era motivato dalla paura di una
"orientalizzazione" del Paese e della conseguente erosione della
dominazione Ashkenazi (Vidal e Algazy, 1999). La linea più
comunemente adottata è stata quella di diffondere una serie di
immagini negative sui Mizrahi e sulla loro cultura sin dagli anni
'50, quando lo stesso Ben Gurion si riprometteva, a nome dello
Stato, di assorbire queste popolazioni e di imprimere loro i valori
della Nazione ebraica (Barnavi, 1996). In parallelo la politica
pubblica si è orientata verso strategie specifiche di controllo
sociale che mantenessero e rinforzassero il ruolo dominante
Ashkenazi, come ad esempio la rapida de-arabizzazione degli
ebrei orientali, la stigmatizzazione della cultura e della lingua
araba e una generale regolamentazione di carattere restrittivo di
tutti i cittadini israeliani di origine araba.
In questo quadro, la diffusione territoriale attraverso gli
insediamenti colonici ha giocato un ruolo di primo piano,
assolvendo a due funzioni prevalenti: la ricollocazione di molti
Mizrahi nella periferia del Paese e della società, lontano dal
potere e dalle risorse più vantaggiose, e l'insediamento di molti di
questi sulle terre e sui villaggi confiscati agli arabi; una politica
che ha in tal modo orientato il conflitto tra i due principali gruppi
non-Ashkenazi (Giorgio, 2000). Parallelamente gli insediamenti,
soprattutto di frontiera, sono stati celebrati come l'asse portante
della costruzione della nazione, esempio illuminante di sacrificio
personale e strumento vitale a favore della collettività, tramite una
retorica discorsiva utile sia ad unificare la causa di ebrei
provenienti da diversi retroterra culturali, sia a consolidare la
nuova identità nazionale. La divisione sociale dello spazio è stata
resa possibile dall'attuazione di tre pratiche prevalenti: la prima
consistente nella dispersione e nel "confinamento" della
popolazione ebraica disagiata (Mizrahi), la seconda con l'uso di
meccanismi di segregazione che hanno trasformato queste località
in veri e propri ghetti, ed infine l'impiego di "procedure di
screening dei residenti" tramite cui selezionare nelle aree urbane
candidati appropriati da destinare agli insediamenti municipali
periferici (Tzfadia e Yiftachel, 2003), con lo scopo di creare una
enclave di classe media e di provenienza urbana che fungesse da
supporto alle istituzioni dello stato, ai poteri legali, nonché da
principale gestore delle risorse destinate allo sviluppo (Barnavi,
1996). Questi processi hanno portato ad una sempre maggiore
marginalizzazione degli ebrei Mizrahi che ne ha bloccato la
mobilità sociale, rinforzando ed approfondendo la loro posizione
inferiorità ed ampliando il divario che li separa dal gruppo
Ashkenazi.
La resistenza dei Mizrahim
Il movimento Mizrahi, presente in Palestina fin dai primissimi
anni del '900, ha da sempre avuto una specifica connotazione
religiosa, che a breve divenne nazional-religiosa andando a
confluire tra le correnti di minoranza del sionismo. Nonostante
l'apparente marginalità del Partito Mizrahi esso riuscì ad
esercitare all'interno del sionismo un ruolo considerevole per la
sua capacità di attrarre all'idea e al progetto sionista gli ebrei
sefarditi, più religiosi che nazionalisti. Successivamente farà parte
di tutte le coalizione di governo del Mapai (il Partito Operaio
Sionista), con l'unico scopo di consolidare il carattere ebraico
dello Stato di Israele, contribuendo a dare una connotazione
religiosa al sionismo laico ed inscrivendolo nella continuità della
tradizione, come movimento di un popolo che aspira al Ritorno e
ad un'esistenza nazionale (Guolo, 1997). Così, mentre le forze
politiche sioniste secolari sono impegnate nella costruzione dei
confini fisici dello Stato, dei nuovi miti nazionali e della
definizione dell'identità israeliana, il Mizrhai, insieme con gli altri
partiti religiosi ortodossi, parteciperà attivamente alla costruzione
di questa stessa identità attraverso una strategia di "progressiva
ebraicizzazione" dello Stato (Guolo, 1997), che punterà a stabilire
una "religione civile", come lo stesso Ben Gurion augurava, che
gradualmente sostituisse il giudaismo talmudico e rabbinico con
una esegesi biblica selettiva, di tipo mito-simbolico, in cui
venissero valorizzati elementi, come l'eroismo biblico del popolo
d'Israele, a sostegno dell'identità nazionale (Barnavi, 1996). E'
solo a partire dagli anni '70 che le espressioni di resistenza da
parte dei Mizrahim alla dominazione Ashkenazi diventano più
sostanziali e visibili. Seguendo sinteticamente le evoluzioni
temporali del movimento, prenderemo in considerazione alcuni
elementi attraverso cui, a nostro parere, si è espressa e si esprime
la rivendicazione identitaria della popolazione Mizrahi, che non si
configura soltanto come un'espressione di mera resistenza alle
politiche dominanti, ma che possiede caratteri più originali e
8
creativi.
i due modelli e questa differenza è in stretta correlazione con la
Come abbiamo detto, a partire dagli anni '70 il diffuso sentimento questione geografica e con il suo significato socio-politico.
di dissonanza dei Mizrahi si condensa in chiare manifestazioni di Secondo questa prospettiva, se sul piano nazionale la protesta dei
protesta, che a livello politico sfociano nella costituzione del Mizrahim ha dato voce alla domanda di una più equa
movimento giovanile delle "Black Panthers" e nella successiva distribuzione delle risorse pubbliche, soprattutto di natura socioascesa del Likud a scapito dei Laburisti, un partito ritenuto ormai economica, ma lo ha fatto con un tono accomodante e comunque
rappresentante esclusivo degli interessi delle elites Ashkenazi e ancorata al discorso politico sionista dei confini "legittimi", a
della classe media (Barnavi, 1996). Tuttavia, la vera novità si livello locale viene portata avanti una sfida aperta alla classe
riscontra nelle "città di sviluppo", insediamenti periferici di dominante Ashkenazi, manifestata dallo sviluppo di visioni e voci
piccola e media grandezza demografica, dove nel corso degli anni alternative (come, ma non solo, l'identità ultra-ortodossa
'50 vennero allocati la maggior parte degli immigrati mizrahim, sefardita) e con l'obiettivo di trasformare il sionismo dall'interno,
secondo una specifica strategia di "dispersione della mettendone in dubbio i paradigmi discorsivi fondanti, primo fra
popolazione", resa operativa dal cosiddetto "Piano Sharon" tutti l'essenza collettiva ebraica (Tzfadia e Yiftachel, 2003).
(1948-52), attraverso cui il nascente stato israeliano si preparava I due autori evidenziano come un gruppo etnico possa fare uso di
alla
colonizzazione
e
alla
ciò che considera essere la "corretta"
giudaizzazione del territorio (Tzfadia e
identità ed avvantaggiarsene per
Yiftachel, 2003).
soddisfare i propri interessi. L'identità
Le mobilitazioni politiche in queste
infatti si caratterizza per una natura
aree collocate lontano dai centri di
multistratificata,
frutto
delle
potere nazionali, e quindi caratterizzate
costruzioni identitarie cristallizzatesi
dalla marginalità geografica, la
nel tempo e nello spazio all'interno di
persistente deprivazione e l'instabilità
una specifica comunità, e ciò sembra
demografica, hanno assunto negli
essere particolarmente vero per quei
ultimi anni tratti sempre più radicali a
gruppi di migranti la cui identità è vista
seguito di ulteriori fattori di pressione
come segno di un basso status sociale
sociale quali le recenti e massicce
o, aggiungono gli autori, la cui identità
ondate migratorie dalle ex-repubbliche
è "intrappolata" ai margini di una
sovietiche, il cui afflusso è stato in gran
società coloniale (Yuval-Davis, 2000 parte direzionato verso queste città,
Tzfadia e Yiftachel, 2003). L'identità
nonché le ripetute crisi economiche
"intrappolata" solitamente occupa
dovute alla svolta neo-liberista e
un'area incolore collocata fra i centri di
globalizzante dell'economia israeliana
potere e benessere, in cui le possibilità
(Giorgio, 2000 - Ramadan, 2004).
di mobilità sono estremamente scarse.
Tuttavia, va sottolineato come,
La principale opzione percorribile
nonostante la loro marginalità socioresta infatti l'inclusione nella struttura
politica, le "città di sviluppo", con una
centralizzatrice nazionale, che viene
popolazione attuale di circa 800.000
tuttavia pagata con una inferiorità
unità (su 5 milioni circa di abitanti),
strutturale all'interno della società
stiano diventando sempre più una
(Tzfadia e Yiftachel, 2003). Questa è la
componente significativa della politica
strada percorsa fino ad alcuni decenni
nazionale
e
della
formazione
fa dalla comunità Mizrahi, quando ha
Gerusalemme
identitaria.
adottato l'opzione nazionale di
Erez Tzfadia e Oren Yiftachel dell'Università "Ben Gurion" di bypassare il sistema politico esistente con la nascita e il costante
Be'er Sheva, partendo dall'assunto che gli obiettivi etnici ed rafforzamento dei gruppi ultra-ortodossi (Sha'as) (Guolo,1997).
identitari sono costantemente rimodellati dal materiale e dal Diversa è la situazione (nella dimensione) a livello locale, dove
discorso politico dominante, hanno studiato le campagne di l'immediatezza e la concretezza degli interessi strettamente
mobilitazione politica dei Mizrahim dislocati nelle "città di interrelata alla difesa di uno spazio percepito come "nostro" dalla
sviluppo" prendendo in considerazione due arene fondamentali popolazione, possono favorire piccole ma paradigmatiche rotture
entro cui essa si esprime: la protesta, diciamo così, extra- nella egemonia nazionale. Le mobilitazioni degli immigrati, siano
parlamentare di respiro nazionale e le campagne per le elezioni esse nazionali o locali, hanno in comune il riconoscersi in una
locali. Queste due prospettive danno conto in modo illuminante etno-classe, ovvero rinsaldano ed emotivizzano un legame tra
dei modelli di cambiamento della mobilitazione stessa e delle origini etniche, condizioni materiali attuali e mobilitazione
forme identitarie che tali modelli sottendono (Tzfadia e Yiftachel, politica (Massey e Jess, 2001). Ciononostante la definizione di
2003). La ricerca, infatti, informa di una sostanziale differenza tra identità immigrate ed identità locali non è mai netta perché, nel
9
tempo, i gruppi immigrati sviluppano un sentimento domestico
verso il luogo in cui si sono insediati, sentimento che può
diventare "illusorio" quando il pre-dominio è minacciato
dall'arrivo e/o della presenza di nuovi gruppi etnici. In questo caso
il "luogo" diventa lo spazio di contesa e contestazione, dando vita
a mobilitazioni etniche e intensificazioni, anche violente, del
conflitto identitario.
Dalla ricerca effettuata da Tzfadia e Yiftachel sulle mobilitazioni
dei Mizrahim riportate dai due maggiori quotidiani israeliani
Ha'aretz e Ma'ariv, in particolare la protesta pubblica e la politica
locale nelle città di sviluppo nel periodo compreso tra il 1960 e il
1998, si evidenzia che, se da una parte le manifestazioni di
protesta mettono in luce il carattere di "intrappolamento" del
gruppo all'interno del discorso di potere sionista della società
coloniale israeliana, con una conseguente dimensione di
collusione, dall'altra a livello locale la protesta si carica del
sentimento di possesso identitario del luogo e aderenza spaziale
dell'identità, ed in ragione di questa forza, essa è in grado di
esprimere contrasti più aperti alle linee fondanti egemoniche,
come ad esempio verso l'indiscriminata politica di immigrazione
che riguarda il paradigma sionista dell'indiscussa omogeneità e
solidarietà tra ebrei (Tzfadia e Yiftachel, 2003).
Questo diverso carattere della mobilitazione, tra il nazionale e il
locale, informa della multistratificazione dell'identità dei
Mizrahim periferici, come del resto di gran parte delle identità
collettive, nel senso che, come argomenta Nira Yuval-Davis, per
spiegare il sentimento di cittadinanza è necessario tenere presente
come, all'interno della collettività, esso appaia una costruzione a
più strati: locale, etnico, nazionale, statale, intra/sovra-statale e
come sia influenzato, ed in fin dei conti costruito, dalle relazioni
e dai posizionamenti di ogni strato in specifici contesti storici
(Yuval-Davis, 2000).
Così l'identità Mizrahi viene giocata su più piani, anche
contraddittori tra loro, ma ugualmente espressivi delle dinamiche
cui sono sottoposti i gruppi etnici deprivati: nel gioco nazionale il
sentimento prevalente sembra essere quello di un'attiva e leale
partecipazione al progetto sionista Ashkenazi, quasi a voler
offuscare le differenze tra la periferia (le città di sviluppo) e il
centro (la società dominante), anche se ciò perpetua
"l'intrappolamento" del gruppo ai margini di quella società che ne
ha favorito la deprivazione, ma dalla quale dipendono; mentre nel
gioco locale il carattere di etno-classe si fa più preciso ed
aggressivo, ed il gruppo appare in grado di costruire anche una
contro-narrazione al discorso dominante della solidarietà ebraica.
Tzfadia e Yiftachel concludono sottolineando come la condizione
e i movimenti di resistenza dei Mizrahim periferici, la nuova e
crescente identificazione con il partito/movimento Sha'as e
l'incremento dell'uso delle categorie religiose ( in particolare
contro i russi "atei e forse nemmeno ebrei"), siano immagini delle
"fratture" che cominciano a delinearsi nel predominio della
etnocrazia secolare Ashkenazi, a partire dalle sue periferie ma con
una reale potenzialità di diffusione verso la dimensione nazionale
(Tzfadia e Yiftache, 2003 - Galili, 2004).
Conclusioni
Oren Yiftachel utilizza una suggestiva ma quanto mai esplicita
metafora per spiegare la contraddizione dello stato israeliano e il
paradosso del discorso che ha costruito attorno alla sua
contemporanea natura di stato ebraico e democratico. Esso è
come la torre di Pisa: dall'interno non è possibile coglierne le
distorsioni geometriche perché tutto è perfettamente in asse, ma
da uno sguardo esterno si nota immediatamente la sostanziale
differenza con quanto la circonda e con strutture architettoniche
simili (Yiftachel, 1999). Allo stesso modo, la maggior parte degli
ebrei accetta il carattere ebraico dello stato e lo giustifica quale
paradigma fondante del discorso sionista che è alla base del
progetto di giudaizzazione del paese e della società, anche se
questo invece di favorire una reale integrazione delle diverse
anime culturali israeliane, produce una frammentazione ed una
segregazione delle minoranze più marginalizzate, dando luogo ad
una forma statuale fondata sull'ethnos piuttosto che sul demos.
Come si è cercato di evidenziare, gli ebrei Mizrahi hanno assolto
ed assolvono a quella funzione tipica dei gruppi deprivati nei
contesti egemonici descritti da Gramsci, dove la verità dominante
viene diffusa con l'uso di narrazioni diverse sull'intera società da
parte delle elite di potere al fine di prevenire il sorgere di voci
alternative e di riprodurre in tal modo le relazioni di dominio
sociale e politico (Gramsci, 1975). Ma è altrettanto evidente che
la mobilitazione sta assumendo, seppur a partire dagli spazi
periferici, una connotazione sempre più oppositiva e dirompente.
Vorrei sottolineare come l'etnicizzazione della società israeliana e
le sue numerose implicazioni, oltre ad essere un argomento poco
trattato in lingua italiana, permetta di visualizzare le complesse
dinamiche che sottendono la costituzione e costruzione identitaria
dello Stato d'Israele, una realtà mediaticamente a noi così vicina
eppure tanto sconosciuta. L'attuale riproporsi del discorso
coloniale, dove l'immagine e il costrutto percettivo forniti dal
discorso dominante hanno un valore essenziale, non riguarda solo
quelle minoranze arabo/palestinesi che siamo abituati a
considerare in rapporto dicotomico/antinomico con Israele, ma
riguarda soprattutto gli stessi gruppi ebraici che hanno reso
possibile l'esistenza spazio-culturale della nazione. La caduta dei
miti fondanti nazionali sui quali si sono costruite le politiche e le
istituzioni, e la lotta per egemonizzare l'israelianità aperta in
tempi recenti, fanno intravedere probabili scenari di grandi
trasformazioni socio-culturali, dove i Mizrahim insieme con la
comunità russa giocheranno sicuramente un ruolo determinante.
10
Bibliografia
ADVA Center, Information on inequality and social justice in Israel: a social report, 2003,TelAviv
ANDERSON, Comunità Immaginate, 1996, Il manifesto Libri
BARNAVI, Storia d'Israele. Dalla nascita dello stato all'assassinio di Rabin, 1996, Bompiani
EICKELMAN, Popoli e culture del Medio Oriente,1993, Rosemberg & Sellier
GALILI, The end of the melting-pot ethos, 2004, Ha'aretz 29/09
GIORGIO, Disuguaglianze ed integralismi. Israele: una crisi sociale, 2000, La Rivista del Manifesto n.10
GOLDBERG, SALOMON, From Laboratory to Field: Notes on Studying Diversity in Israeli Society, 2002, Hagar n.3(1): 159-171
GRAMSCI, Quaderni del carcere, 1975, Einaudi
GUOLO, Terra e Redenzione. Il fondamentalismo nazional-religioso in Israele,1997, Guerini&Ass.
HOBSBAWM-RANGER (a cura di), L'invenzione della tradizione, 2002, Einaudi
YIFTACHEL, Nation-building or Ethnic Fragmentation? Ashkenazim, Mizrahim and Arabs in the Israeli Frontiers, 1997, Space and
Policy vol.1:149-169
YIFTACHEL, Nation-building and Social Division of Space: Ashkenazi Control over Israeli Periphery, 1998, Nationalism and
Ethnic Politics vol.4:33-58
YUVAL-DAVIS, Multilayered citizenship and boundaries of the "nation-state", 2002, Hagar n.1(1): 112-127
MASSEY, JESS (a cura di), Luoghi, culture, globalizzazione, 2001, Utet
RAMADAN, I conflitti etnici tra israeliani: un fenomeno in crescita, 2004, da www.aljazeera.net del 7/6
SAID Orientalismo (1999) Feltrinelli
TZFADIA, YIFTACHEL, Between Urban and National: Political Mobilization among Mizrahim in Israel's "developed towns", 2003,
The International Journal of Urban Policy and Planning n. 589
VIDAL ALGAZY, Il mosaico d'Israele si scompone, 1999, Le Monde Diplomatique (ed.it.), maggio
WARSCHAWSKI, A precipizio. La crisi della società israeliana, 2004, Bollati Boringhieri
11
Una ricerca etnomusicologica nell'ambito delle cure
'alternative': tre pratiche musicali di guarigione
di Patrizia Santoro
Tra il 2003 e il 2004, in occasione della tesi1 , ho realizzato una ricerca etnomusicologica con l'obiettivo di studiare alcuni metodi di
guarigione con musica utilizzati nell'ambito delle cure non convenzionali della medicina olistica. Ho focalizzato l'attenzione su tre
performance praticate in prevalenza nell'area milanese che utilizzano la musica, la danza, il canto e stati alterati di coscienza, con
finalità terapeutiche: la Trance Dance, il Vocal Harmonics in Motion e l'Arpeincoro in Meditazione. Queste tre pratiche evidenziano
e riassumono un fenomeno che si è molto sviluppato e diffuso negli ultimi anni e che consiste nella reinterpretazione e reintroduzione
sincretica di concetti, comportamenti, aspetti rituali e simbolici, tecniche musicali e terapeutiche desunte da contesti culturali "altri".
Nella mia ricerca ho tentato di comprendere l'uso e la funzione dei procedimenti tecnico-musicali e di fare emergere le connessioni
con la prassi terapeutica. L'analisi degli eventi ha rivelato l'esistenza di una rete di significati che cercherò di riassumere in queste
pagine.
Premesse
La medicina ufficiale non riconosce l'efficacia terapeutica delle
cure olistiche che quindi restano relegate su un terreno di confine
con l'ufficialità. Si qualificano comunque come terapie, ma il loro
campo di intervento si limita ad una più generica proposta di
benessere psico-somatico o spirituale.
Una convinzione comune che collega tra loro le diverse discipline
"alternative" è l'idea che esista una unità di corpo, psiche,
emozioni e mente e il presupposto che solo l'integrità dell'essere,
data dal riconoscimento e dall'accettazione di tutte le sue
componenti, garantisca una buona 'salute olistica'.
L'uomo contemporaneo è strutturalmente 'scisso' in quanto la
mente e la razionalità predominano e controllano il piano
emozionale e spirituale. I sintomi somatici sono l'espressione e la
rappresentazione simbolica del malessere più profondo e sottile
dell'anima. La strada per reintegrare le parti separate passa
dall'esclusione del predominio della componente razionale. Nel
silenzio della mente si ritrova il contatto con il proprio sé e la
comunione con l'universale. Il fondamento, che può essere
definito metafisico, delle cure olistiche si basa sul concetto di
"energia". L'energia è una grande forza che presiede alla vita, è la
vita stessa. E' presente nell'universo e nell'essere umano in una
sorta di identità tra aspetto soggettivo e universale. La sua
essenza rimanda all'idea di movimento e di trasformazione. In
quest'ottica la malattia si verifica quando il libero fluire
dell'energia è ostacolato. Un altro tratto distintivo delle cure
olistiche è la convinzione che i poteri di guarigione siano frutto di
concentrazione e di consapevolezza, condizioni psichiche che si
raggiungono attraverso la sperimentazione di stati di coscienza
fuori dall'ordinario. L'agente curativo, qualunque esso sia, non ha
potere di guarigione in sé. La sua capacità è quella di risvegliare
le energie di autoguarigione latenti. L'alterazione di coscienza,
che può andare dallo stato contemplativo o meditativo, alla trance
vera e propria, è funzionale al raggiungimento di questo obiettivo.
Questi metodi di guarigione si collocano su una sottile linea di
demarcazione tra aspetti terapeutici e sfera del sacro. Convivono
teorie derivate da correnti della psicologia contemporanea,
suggestioni religiose e spirituali, tecniche corporee orientali,
medicine cinesi, miti pagani, informazioni scientifiche e
tecnologie informatiche. Collaborano categorie concettuali e
simboliche dalle origini diverse - sia temporali che geografiche che, estrapolate dai loro contesti tradizionali originari e
riassemblate a mosaico, danno origine a nuovi universi di
significato. All'interno di questo contenitore si attuano dinamiche
di trasformazione e di ricontestualizzazione in cui alcune pratiche
connesse alla musica, alla danza e a stati modificati di coscienza
hanno trovato una nuova collocazione significante. I criteri di
formazione e di fruizione delle pratiche terapeutiche rispondono
ad esigenze di utilità e di esperienza. Quando una pratica
terapeutica non è più ritenuta utile viene abbandonata e sostituita.
L'esperienza è la prima verifica dell'utilità. Il loro denominatore
comune si può individuare in una ricerca di senso che dia risposte
integrative o sostitutive a quelle della medicina ufficiale, ritenute
inefficaci, quindi inutili.
Gli informatori e le tecniche d'indagine
L'indagine preliminare si è basata sulla consultazione di riviste
specializzate nel settore del benessere e delle tecniche alternative
e del web, che si è rivelato essere un enorme serbatoio di
informazioni riguardanti le offerte di medicina olistica presenti
sul mercato ed un efficace mezzo di pubblicità e di diffusione
delle stesse. Ho preso contatto con alcuni terapeuti che hanno
accettato di divenire gli informatori per la ricerca. Essi sono:
Tiziana Dainotto detta Anand Nirava2 per la Trance Dance,
Lorenzo Pierobon per il Vocal Harmonics in Motion e Cristina
Ruffino per Arpeincoro in Meditazione. La ricerca sul campo si
12
è basata sulla tecnica delle interviste strutturate agli informatori e
sull'osservazione degli eventi che è avvenuta, il più delle volte,
durante la partecipazione agli stessi. 'L'osservazione partecipante'
di malinowskiana memoria si è dovuta trasformare in
'partecipazione osservante' a causa della struttura fortemente
ritualizzata degli eventi che impedisce l'accesso a qualsiasi
osservatore: se si è all'interno dello spazio riservato al rituale è per
partecipare al rituale stesso, altrimenti non si è ammessi.
Le interviste sono state strutturate in modo da rilevare alcuni
elementi socio-anagrafici degli informatori e le dinamiche
personali e familiari connesse all'esercizio delle attività
terapeutico-musicali. Le domande si proponevano di chiarire gli
obiettivi degli interventi terapeutico-musicali, i concetti e i
comportamenti sottesi ai procedimenti tecnico-musicali, gli
aspetti rituali e simbolici delle pratiche e degli strumenti utilizzati,
le tradizioni di riferimento. Ho cercato di fare emergere
l'orizzonte ideologico e culturale relativo ai concetti di cura e di
guarigione ed i loro rapporti con la medicina ufficiale.
La loro attività si svolge prevalentemente a Milano e provincia,
dove abitano. Spesso, però, le sessioni terapeutico-musicali si
svolgono fuori Milano, e a volte anche fuori dell'Italia. Infatti, le
performance scelte per questa ricerca, non si praticano in una sede
fissa e i conduttori si definiscono dei "professionisti itineranti".
Quest'aspetto fa parte di un modello culturale e professionale. Le
occasioni di lavoro devono essere create di continuo attraverso
forme di pubblicità costituite da conferenze di presentazione,
distribuzione di materiale a stampa, presenza nella rete Internet3.
Le strutture che di solito accolgono proposte nell'ambito del
benessere e delle tecniche alternative sono costituite da: palestre,
istituti di medicina olistica, centri culturali, agriturismi. In
un'occasione ho seguito una conferenza in un ospedale4. Gli
eventi hanno caratteristiche in grado di adattarsi agli ambienti in
cui si realizzano. Può essere valorizzato l'aspetto di performance
musicale o coreutica in contesti di svago ed intrattenimento,
oppure fatto risaltare quello terapeutico fino ad assumere una
dimensione specificatamente medica5. Tra i partecipanti nessuno
ha assunto il ruolo di informatore perciò le informazioni
provengono prevalentemente dalle interviste ai terapeuti. Durante
la partecipazione agli eventi ho fatto qualche "chiacchierata"
informale per capire le motivazioni del ricorso alla medicina
alternativa ed in particolare alle pratiche oggetto della ricerca, il
livello di adesione ideologica all'orizzonte culturale e operativo
proposto dai conduttori e l'efficacia delle pratiche in relazione agli
obiettivi enunciati e alle aspettative riposte.
Una prima considerazione si può fare sul genere dei partecipanti:
la maggioranza è costituita da donne. Gli informatori danno
un'interpretazione che fa riferimento ad una più alta
consapevolezza ed autonomia femminile nel riconoscere il
proprio malessere psico-fisico e ad una maggiore determinazione
nella ricerca di soluzioni efficaci e alternative per affrontarlo e
risolverlo. Un'altra considerazione riguarda il primato della
pratica in questi eventi, ossia la partecipazione e il
coinvolgimento attivo dei pazienti. Gli utenti sostengono la
necessità, prioritaria rispetto alla credenza, di fare l'esperienza;
affermano che uno stato modificato di coscienza, come è quello
meditativo, non può essere spiegato, può solo essere provato.
Attraverso l'azione agita in prima persona si verifica l'utilità, si
sperimentano gli stimoli positivi per il corpo e la salute e si accede
all'espansione di coscienza che consente di prendere contatto con
le proprie emozioni, i propri sentimenti ed i comportamenti
ripetitivi che ostacolano l'autorealizzazione.
"C'è un'antropologia della musica, e si colloca in ambito
musicologico e antropologico […] poiché la musica non è altro
che un elemento che si aggiunge alla complessità del
comportamento umano."6
Alan P. Merriam
Tre metodi di guarigione 'alternativi': prassi terapeutica e
musicale
La musica "in grado di emozionare"7 gli stati modificati di
coscienza, il movimento e la danza, attraverso i quali scoprire,
esprimere ed esteriorizzare sentimenti ed emozioni, sono gli
strumenti fondamentali di molte pratiche di guarigione
'alternative'.
La Trance Dance, il Vocal Harmonics in Motione e Arpeincoro in
Meditazione sono caratterizzate da alcuni tratti comuni:
esibiscono una struttura formale fortemente ritualizzata,
utilizzano tecniche per l'induzione di stati modificati di coscienza
che vanno dalla meditazione alla trance, si basano sul principio
delle terapie di gruppo secondo il quale le manifestazioni
individuali si inseriscono in un contesto aggregativo,
partecipativo e di condivisione che garantisce l'espressione e il
contenimento.
Dal punto di vista della prassi musicale questi metodi presentano
alcuni aspetti peculiari, individuabili nel ritmo e nella danza per
la Trance Dance, nel canto corale per Vocal Harmonics in Motion
e nella pratica strumentale del suonare insieme per Arpeincoro in
Meditazione.
La Trance Dance è una terapia coreutico-musicale compresa in un
percorso neo-sciamanico8 che fa riferimento soprattutto alla
tradizione degli indiani nord americani. Si serve del ritmo delle
percussioni, di tecniche respiratorie e della danza rituale
attraverso la quale si accede ad uno stato di trance, che
rappresenta l'agente curativo di questa tecnica terapeutica. Alcuni
oggetti rivestono il valore di paraphernalia, ossia di oggetti
liturgici che, nel particolare contesto cerimoniale, assumono un
carattere sacro. In particolare una 'bandana' da collocare sugli
occhi per escludere l'esterno e concentrare l'attenzione su se
stessi. L'esclusione della vista, senso prevalente nella nostra
'cultura', induce un potenziamento della capacità percettiva degli
altri sensi, altera la mappa delle rappresentazioni sensoriali e di
conseguenza modifica le rappresentazioni della realtà. Erbe ed
incensi, bruciati durante il rituale, concorrono ad un'alterazione in
senso iperestesico delle percezioni dei partecipanti. Alcuni
strumenti, come il tamburo sciamanico e il sonaglio sciamanico,
per la loro valenza simbolico-rituale, devono essere annoverati
piuttosto tra gli oggetti 'sacri' che tra gli strumenti musicali. Il
13
primo rappresenta "il battito del cuore di madre terra", il secondo
"la voce dello spirito". Entrambi sono considerati "strumenti di
potere sciamanico" e vengono suonati dalla guaritrice per
facilitare la risoluzione di blocchi che si possono verificare nella
danza terapeutica.
Secondo la conduttrice durante la danza si accede sempre ad uno
stato di trance, nella quale lo "spirito" si incarna nel danzatore.
Attraverso questo stato è possibile modificare i comportamenti
condizionati che bloccano l'espansione creativa e prendere
contatto con il proprio vero sé. L'etnomusicologo Gilbert Rouget
ha studiato la trance religiosa di molti riti tradizionali e ha
analizzato i rapporti tra la musica e la trance. Confrontando
questo rituale contemporaneo con quelli osservati in contesti
tradizionali da Rouget, si può affermare che la Trance Dance è
strutturata formalmente come un rito di possessione. Dal punto di
vista musicale i partecipanti non sono i musicanti della propria
trance, ruolo tipico dello sciamano, bensì i posseduti, ovvero i
"musicati", secondo la definizione usata da Rouget.
Le similitudini si limitano però a questi elementi. Nel contenuto
della terapia sono rilevabili connessioni con alcune correnti della
psicologia contemporanea mescolate con la spiritualità 'non
convenzionale' espressa dai movimenti neo-sciamanici. Di fatto
questa pratica neo-sciamanica è estranea a qualsiasi implicazione
religiosa e l'entità chiamata "spirito" non è una divinità, ma è
piuttosto assimilabile al concetto di energia. E' una forza presente
nell'universo ed una delle componenti che, insieme a corpo,
mente ed emozioni, costituisce l'integrità dell'essere umano,
condizione imprescindibile per la buona "salute olistica". La
trance, indotta dalla musica e dalla danza, è una strada per
reintegrare le parti separate, o, per dirlo con le parole della
terapeuta, per "riportare a casa i pezzi di anima mancante", quindi
l'orizzonte concettuale dell'evento si colloca nell'ambito dei
principi della medicina olistica.
Per quanto riguarda la prassi musicale la Trance Dance utilizza
strumenti a percussioni, suonati dal vivo. Si tratta di vari tipi di
membranofoni (tamburo sciamanico, congas, bongos, djembe,
tam del Kenia), di idiofoni (sekere, maracas, diversi tipi di
sonagli) e il mixer. Qualche volta, quando sono disponibili
strumentisti in grado di suonarli, vengono usati il didgeridoo, la
tampura e le cristal bowls9, tutti strumenti con un forte valore
simbolico dal punto di vista terapeutico.
Gli esecutori sono musicisti professionisti, il loro ruolo è molto
importante ai fini del buon esito della performance perché si
occupano di organizzare, attraverso il ritmo, le diverse fasi della
terapia coreutico-musicale. La guaritrice, oltre a condurre la
sessione terapeutica, interpreta un ruolo musicale attraverso la
scelta e il mixaggio delle sonorità e dei ritmi adatti alle varie fasi
dell'evento. Suona anche alcuni strumenti a percussione
caratterizzati soprattutto da una valenza simbolico-rituale, come il
tamburo sciamanico e il sonaglio sciamanico.
Le percussioni agiscono su una base musicale costituita, di solito,
da CD ideati per questo tipo di rito, ma può essere utilizzato
qualsiasi pezzo musicale debitamente mixato. L'analisi musicale
di alcuni brani contenuti nei CD ha rilevato elementi di
globalizzazione culturale nei timbri, che propongono percussioni
europee, orientali, sudamericane ed un uso rilevante della tastiera
e di suoni campionati, come la voce e il respiro. Sono presenti
tratti del minimalismo americano, sonorità mediate da musica
etnica, ma anche dalla discomusic e dalla techno. I canoni sono
assolutamente occidentali per quanto riguarda gli aspetti formali,
ma soprattutto per l'utilizzo della tecnologia musicale. Un
prodotto senza anomalie interne, molto professionale, che utilizza
alcuni elementi di nota utilità comunicativa, adatto all'obiettivo
terapeutico per il quale è pensato.
Il Vocal Harmonics in Motion è un metodo che fa riferimento alle
teorie che derivano dalla visione energetica della medicina cinese.
Utilizza un tipo di canto tradizionale, movimenti e tecniche
respiratorie ripresi dalle arti marziali orientali, procedure
sperimentali della musicoterapia contemporanea, per ottenere uno
stato meditativo funzionale al raggiungimento del benessere
psico-fisico. E' l'atto stesso del cantare, ascoltando i propri suoni
e quelli del gruppo, che induce l'alterazione dello stato di
coscienza in cui si sperimenta una dimensione di sospensione
della realtà spazio-temporale. I partecipanti alle sessioni di Vocal
Harmonics in Motion vengono istruiti e messi in grado di
produrre suoni armonici vocali che, secondo questa pratica
terapeutica, procurano un effetto salutare sull'equilibrio emotivo.
Dal punto di vista musicale il canto si chiama 'canto difonico'.
Viene utilizzata una tecnica che enfatizza i suoni armonici vocali
e rende percepibili chiaramente due voci: un suono bordone di
altezza fissa e una seconda voce dal timbro penetrante che esegue
una linea melodica in armonici. Le tradizioni di riferimento sono
quella del canto armonico tibetano, ma soprattutto quella del
canto xöömij, una parola mongola che significa faringe. Il canto
di gola xöömij, è un canto tradizionale praticato in Asia Centrale
(a Bashkiria, vicino ai monti Urali, in Kazakhstan e Uzbekistan,
in Mongolia e Khakassia, ad Altai e Tuva10, due repubbliche
autonome della federazione Russa, a nord del confine mongolo)
principalmente in ambito sciamanico e animista, ma anche con
finalità estetiche ed artistiche.
Il Vocal Harmonics in Motion è prevalentemente una pratica di
libera improvvisazione corale con l'emissione di armonici vocali,
durante la quale tutti i partecipanti assumono un ruolo musicale.
L'organizzazione del canto non ha norme esecutive e questo
consente solo descrizioni probabilistiche. Non si può parlare di
esecuzione musicale, ma di un insieme di suoni organizzati
secondo una finalità terapeutica dove è il contesto, definito dalla
natura terapeutica dell'evento nell'ambito della visione olistica
della cura, a rendere significativa e comunicativa la prassi canora.
Questo metodo prevede anche l'uso di alcuni strumenti musicali.
I più adatti sono quelli che producono suoni ricchi di armonici, in
particolare alcuni idiofoni (gong, campane tubolari, cimbali,
singing bowls), alcuni cordofoni (sitâr, vînâ, tampura)11 e tra gli
aerofoni soprattutto il didgeridoo. Tutti gli strumenti utilizzati
sono accomunati dal fatto di possedere un forte valore simbolico
in quanto si ritiene che vengano utilizzati tradizionalmente nel
corso di cerimonie sacre o di guarigione.
L' Arpeincoro in Meditazione è' una pratica strumentale in cui la
14
sonorità dell'arpa celtica, una selezione di melodie della
tradizione nordica con valenze simboliche ed una prassi esecutiva
di gruppo vengono usate per indurre una condizione di
concentrazione attiva e lo stato meditativo. La teoria alla base di
questa tecnica di benessere è che il distacco dal contingente ed il
ritrovamento di se stessi nel silenzio interiore, consentano di
riappropriarsi della gestione della propria vita e della propria
salute. Si fonda sul presupposto che ogni strumento sia capace di
entrare in risonanza con un certo tipo di energia. L'arpa, ed in
particolare quella celtica, rappresenta il femminile, aiuta a
sciogliere le emozioni, a ritrovare la creatività ed è in grado di
riequilibrare l'energia del chakra12 del cuore. La sua sonorità
rappresenta una via per ritrovare il benessere. L'aggettivo 'celtico'
adottato in questo ambito si deve intendere come un concetto,
un'idea, più che come una tradizione culturale reale, esistente e
collocabile in un'area storico-geografica. La 'celtitudine' può
considerarsi come una condizione umana, una predisposizione
della mente e dell'anima, un modo di rapportarsi alla vita e alla
morte che non prevede solchi profondi, ma un'interazione
continua.
Dal punto di vista musicale la performance si basa sulla
riproduzione, estemporanea ed in gruppo, di alcune melodie
tradizionali insegnate secondo un modello di trasmissione orale
della pratica musicale. La conduttrice e le partecipanti13 hanno un
ruolo attivo nel 'fare musica', l'insegnamento è basato su tecniche
imitative e non prevede alcuna conoscenza della scrittura
musicale.
Il repertorio musicale è costituito da brani caratterizzati da una
struttura strofica regolare, da un alto livello di ridondanza di ogni
strofa e dall'utilizzo di riferimenti ricorrenti e prevedibili, che
rendono le melodie facili da memorizzare. L'uso prevalente della
scala minore naturale conferisce ai brani un carattere che appare
intrinsecamente malinconico. Queste melodie assumono un forte
valore affettivo in quanto divengono un linguaggio delle
emozioni. Ogni sequenza musicale, ogni nota assume il valore di
segno o di simbolo che rinvia a significati extra-musicali. Le
figure musicali vengono usate per meditare e per evocare
sentimenti ed emozioni, in questo modo l'intero repertorio si
carica di valenze simboliche ed affettive che coinvolgono
l'aspetto formale e ciò che le forme significano in termini di
esperienza umana e relazionale. E' una musica che può essere
considerata l'espressione della solidarietà del gruppo in cui anche
le strutture sonore diventano segni di appartenenza alla comunità.
interesse specifico nei confronti dello strumento musicale.
Qualcuno ha manifestato un interesse prevalente per le tecniche
musicali, canore o coreutiche, piuttosto che l'obiettivo di un
percorso di guarigione. Le adesioni, pur rispondendo a
motivazioni più eterogenee rispetto a quanto emerge dalle
interviste agli terapeuti, rivelano un livello di condivisione
piuttosto elevato dell'orizzonte culturale e operativo proposto dai
conduttori.
Spesso queste attività coprono un fondo di esperienze e sofferenze
che derivano da una condizione generalizzata di malessere,
considerato tipico della società contemporanea. Alcuni esprimono
motivazioni legate a storie personali difficili, al senso di
solitudine o ad episodi di depressione. I terapeuti stessi sono
approdati alle cure alternative in seguito ad eventi dolorosi o
luttuosi accaduti a familiari o a loro stessi, in seguito ai quali
hanno sentito di dover trovare un senso alla loro vita. Nei
momenti di condivisione di gruppo i partecipanti hanno
raccontato storie di attacchi di panico, di cure mediche classiche
senza fine e senza soluzioni durature, di frustrazione, di
abbandono a loro stessi in situazioni di debolezza e di paura a
causa della malattia. L'opinione espressa più comunemente è che
le terapie olistiche siano in grado di ripristinare un rapporto di
partecipazione attiva nei confronti della propria salute e che
esprimano il loro valore 'alternativo' soprattutto nel superamento
delle limitazioni tipiche della medicina ufficiale, relative alla
considerazione parcellizzata dell'essere umano.
In questo ambito si realizzano strutture di significato stabilite
socialmente nei cui termini sono prodotti, percepiti ed interpretati
pratiche e comportamenti.
Un aspetto che diviene subito evidente ad un estraneo che si
avvicini a questo ambiente è il fatto che i partecipanti si
immaginano come parti di un insieme, una comunità. Essi,
nell'ambito della 'filosofia alternativa', condividono credenze,
conoscenze, ideali, comportamenti, pratiche salutistiche,
linguaggio e il sentimento comune di utilizzare le tecniche e i
rimedi proposti per conservare o ritrovare il proprio benessere
psico-somatico. In particolare le comunità frequentate nel corso
della ricerca sono risultate piuttosto omogenee in quanto i tre
eventi osservati, oltre l'obiettivo connesso al benessere e alla
salute psico-fisica, avevano caratteristiche comuni quali l'uso
della musica, o del suono, del movimento e degli stati modificati
di coscienza. Si può adottare per queste formazioni comunitarie la
denominazione di "comunità immaginate" proposta da Benedict
Anderson nel suo saggio sui nazionalismi. Secondo Anderson le
comunità immaginate sono entità costituite da un certo numero di
individui che, pur non conoscendosi personalmente, sono
caratterizzati dal fatto che "nella mente di ognuno [di loro] vive
l'immagine del loro essere comunità"14. Queste comunità
esprimono il desiderio di distinguersi dai modelli socio-culturali
rappresentati dalla medicina ufficiale e dalla società
contemporanea, verso i quali esprimono critiche. Le pratiche
collettive offrono ai partecipanti supporto e contenimento in
quanto si realizzano nell'ambito di un'atmosfera di
coinvolgimento emozionale collettivo, una fonte di rassicurazione
"Comunità immaginate"
Come già detto, le informazioni relative ai partecipanti
provengono dalle interviste ai terapeuti, i quali hanno definito la
maggior parte di loro come persone che "sono alla ricerca",
individui che integrano un percorso di guarigione con diverse
pratiche 'alternative'. Durante la 'partecipazione osservante' è
emerso che gli elementi musicali e coreutici, distintivi delle
pratiche analizzate, costituiscono discriminanti di scelta da parte
dei partecipanti. Risulta abbastanza evidente, per fare solo un
esempio, che decidere di meditare con l'arpa presuppone un
15
e di immediata comunicazione e sperimentabilità. Le tecniche di
modificazione dello stato di coscienza, la creazione di situazioni
rituali e l'accesso alla conoscenza e alla sperimentazione di
pratiche, considerate non comuni e di antiche origini, rafforzano
il senso di appartenenza e di collaborazione.
Veda, e la sua riattivazione nell'esperienza del presente contiene
implicitamente una continuità con quel passato antico e
importante. Un linguaggio con queste caratteristiche è
sicuramente adatto a svolgere una funzione unificatrice della
comunità attraverso il sentimento della condivisione di una
tradizione comune e antica, inoltre definisce il confine tra i
membri della comunità e gli estranei.
Il codice linguistico
Benedict Anderson sottolinea l'importanza della diffusione e
dell'utilizzo di una lingua condivisa nella formazione di
"comunità immaginate". E' ovvio che in questo contesto non si
possa parlare di una lingua diversa dall'italiano comune, si può,
però, affermare l'esistenza di un codice linguistico caratterizzante
che, come i metodi osservati, accoglie termini provenienti dalle
diverse lingue del globo e del tempo presente e passato. Le parole
definiscono tal volta pratiche religiose orientali o degli indiani
americani. Altre volte denominano tecniche terapeutiche cinesi o
indiane. In alcuni casi designano fenomeni di nuova formazione
risultanti dalla combinazione, revisione o riadattamento
contemporaneo di tecniche diverse, religiose o terapeutiche, della
più varia provenienza culturale. Alcune parole sono il risultato di
neo composizioni provenienti da qualche autorevole lingua
antica. Per citare solo alcuni esempi: Rebirthing, in lingua inglese
significa rinascita è una tecnica terapeutica basata sulla
respirazione; Respirazione Olotropica, termine composto
derivante dal greco olos tutto, l'intero, la totalità e trepein volgersi
verso, è una tecnica terapeutica basata sulla respirazione; Reiki
termine giapponese composto da rei universo e ki energia: tecnica
terapeutica corporea ad indirizzo energetico; Meditazione
Tibetana: tipo di meditazione che fa riferimento alla pratica
religiosa dei monaci tibetani e si colloca a metà strada tra l'aspetto
sacro e il contesto terapeutico.
I segni verbali sono conosciuti, compresi e utilizzati dai membri
della comunità. La terminologia fa riferimento a precisi contenuti
e la condivisione avviene sia sul piano linguistico, sia nel
contenuto significante. Non è considerato importante che le
tecniche designate o le tradizioni richiamate siano ancora
utilizzate nei luoghi di provenienza. E' significativo, invece,
rilevare la suggestione che questo linguaggio riesce a creare: un
senso di origini antiche e di efficacia di terapie che affondano le
loro radici in un passato fuori dal tempo e dalla storia. Il segno
linguistico assume un valore insolito e riporta in luce qualcosa che
è già stato presente. Accanto al senso immediato, in cui viene
accoppiato un suono ad un significato, emerge il senso
dell'unione, della continuità del passato con il presente,
l'attualizzazione di qualcosa che avveniva e sta avvenendo ancora.
La parola richiama nell'immaginario tradizioni millenarie e la loro
riattivazione nell'esperienza del presente contiene implicitamente
una importante continuità con quel passato antico. Per fare ancora
un esempio: quando nel corso di una sessione viene proposto di
lavorare sull'energia di un chakra i membri della comunità
riconoscono il termine e sono in grado di renderlo significante.
Sanno cogliere le implicazioni simboliche e fisiologiche connesse
allo squilibrio chakra in questione. La parola, inoltre, richiama
nell'immaginario la millenaria tradizione orientale, contenuta nei
Alcune riflessioni sugli eventi
Dalla ricerca è emersa l'applicazione di un criterio di creatività
adattiva, rilevabile sia nelle storie personali dei terapeuti, sia nelle
peculiarità dei metodi elaborati. A questa caratteristica,
riconducibile al concetto di "rottura di schemi mentali
convenzionali e limitanti", gli terapeuti attribuiscono una valenza
positiva, anche dal punto di vista del recupero della salute. E' un
atteggiamento che viene adottato sia nella scelta del modello
professionale, ritenuto gratificante in quanto consente loro di
esprimere una maggiore coerenza tra piano degli ideali e piano del
reale, sia nella struttura delle pratiche di guarigione, basata su un
alto livello di flessibilità e adattabilità che rende gli eventi
convertibili a situazioni di natura diversa da quella prettamente
terapeutica. Il loro orizzonte ideologico, culturale e operativo,
relativo ai concetti di cura e di guarigione si colloca senz'altro
all'interno dei principi delle medicine olistiche, anche se è forse
più corretto parlare di una 'filosofia alternativa' della quale
condividono principi e ideali. E' in questo ambito che i conduttori
hanno elaborato i metodi terapeutici che propongono e al quale si
sono rivolti essi stessi per trovare sollievo ai loro malesseri. Tutti
e tre i conduttori hanno posto l'accento sulla necessità di
recuperare dai modelli tradizionali i concetti di appartenenza,
condivisione, collaborazione, partecipazione, da loro espressi con
le dizioni: "cerchio", "tribù", "radici", "mettersi intorno a
qualcosa per farla insieme".
Le tre performance, infatti, si basano sul principio della terapia di
gruppo. All'interno del gruppo le manifestazioni psicologiche
individuali acquistano importanza e valore. La condizione di
aggregazione comunitaria e la struttura partecipativa, offrono un
contesto di condivisione e propongono un sistema di valori nel
quale è possibile trovare una motivazione appagante e il
riconoscimento di identità, dignità e significato personale. Esse,
inoltre, presentano nella loro struttura formale alcuni elementi
centrali che le designano come eventi ritualizzati e che
specificano la loro funzione particolare nel campo della
guarigione. Nel momento in cui i partecipanti si collocano nello
'spazio sacro' si trasformano in attori di una drammatizzazione,
condizione funzionale alla creazione di una situazione evocativa
adatta all'esperienza degli stati modificati di coscienza attraverso
i quali si realizzano le aspettative di benessere. La struttura
contrassegnata dalle regole delle forme ritualizzate - che è
ritenuta dai terapeuti una prerogativa delle culture tradizionali - è
utilizzata anche nella moderna psicoterapia. Il setting
psicoterapico ortodosso si distingue proprio per una serie di
connotazioni rituali: di saluto, di commiato, di distanza, di
posizione, di cadenze temporali della seduta, ecc., in quanto è una
16
struttura che risulta efficace al contenimento, utile al
coinvolgimento emozionale e al rafforzamento del senso di
appartenenza e di supporto del gruppo.
La ritualizzazione degli eventi dà forma ad un reale 'altro', si
definisce così un nuovo codice condiviso all'interno del quale si
esplicano nuove modalità di comunicazione. Attraverso la
connotazione rituale e la valorizzazione dell'aspetto sacrale, si
crea una suggestione; diviene possibile superare una logica
meramente strumentale, legata a procedure razionali e l'azione sul
mondo si realizza con mezzi che trasfigurano il reale permettendo
l'entrata nell'immaginario. Si realizza in questo modo la
partecipazione ad una dimensione esistenziale che va oltre il
banale e l'ovvio dell'universo umano quotidiano.
L'etnomusicologo Francesco Giannattasio, nell'introduzione ad
un seminario di studi sui rapporti tra musica e stati alterati di
coscienza, ha ipotizzato che alcune questioni studiate dagli
antropologi si sono paradossalmente riverberate al di fuori degli
ambiti scientifici. L'interesse delle nuove generazioni occidentali
per alcune pratiche coreutico-musicali tradizionalmente connesse
alla trance o all'estasi ha favorito il proliferare di nuovi fenomeni,
come lo sviluppo di tecniche terapeutiche con musica. Tra queste
cita ad esempio la respirazione olotropica sperimentata a partire
dagli anni '70 dal medico praghese Stanislav Grof in California.
L'antropologo Vittorio Lanternari nei risultati di un'inchiesta sulle
terapie carismatiche ha sostenuto che negli ultimi due decenni, in
occidente, si è osservato l'incremento rapido e la diffusione
estensiva delle medicine alternative. Ritiene che questo non sia
altro che "una delle risposte della società contemporanea alle
illusioni mitizzanti di una razionalità scientifica e tecnologica che,
nel suo assolutismo dogmatico, rischia di obliterare alcune tra le
più pressanti istanze psicologiche avverse all'alienazione e alla
disautenticazione"15.
Queste stesse considerazioni sono state espresse di frequente dai
terapeuti nel corso delle interviste. L'idea di base è che la prassi
medica ufficiale abbia perduto il senso dell'unità soma-psiche e il
rapporto di fiducia tra medico e paziente per privilegiare gli
aspetti tecnologici e le sofisticate procedure specialistiche di cura.
L'obiettivo delle nuove pratiche 'alternative' è la riconquista
dell'unità perduta dell'individuo attraverso la mediazione o del
corpo o della psiche. La persona è spirito, mente, emozioni,
corpo, e quindi bisogna usare per ogni individuo un approccio
olistico ed integrato delle quattro sfere.
Il rapporto tra malattia e guarigione assume un significato che
trascende l'ambito strettamente medico-fisiologico e assume
connotati quasi metafisici, riconducibili al concetto di "equilibrio
energetico". La malattia viene vissuta come una particolare
manifestazione di un "male dell'anima" e la guarigione o la salute
sono segno di una coerenza tra la realizzazione materiale e la
spinta ideale. La considerazione del nesso tra la salute corporea e
il benessere spirituale è un elemento essenziale. Questo nesso si
ritiene rispettato nelle società tradizionali, nelle medicine orientali
e nelle nuove pratiche terapeutiche che si rifanno a queste
tradizioni. Accanto ai limiti rilevati nella medicina ufficiale i
terapeuti esprimono critiche anche nei confronti delle
degenerazioni della civiltà occidentale e di denuncia verso le
contraddizioni aperte dal modello socio-culturale contemporaneo.
Il recupero, la trasformazione e l'adattamento di concetti e valori,
definiti tradizionali, rappresentano una risposta elaborata in
funzione di un obiettivo di presa di distanza e differenziazione da
condizioni socio-culturali criticate. L'ipotesi percorribile è che
attraverso le prassi elaborate vengano valorizzati ideali di
equilibrio etico-sociale e di significatività esistenziale che si
ritengono prerogative appartenenti alle culture tradizionali dalle
quali vengono desunte le tecniche di guarigione.
Subculture
La Trance Dance, il Vocal Harmonics in Motion e l'Arpeincoro in
Meditazione si rifanno ai metodi della moderna medicina
psicosomatica, alla quale vengono unite pratiche musicali,
mistiche, spirituali e di guarigione ispirate a criteri extrascientifici, riprese da tradizioni diverse. Le componenti
ideologiche
riscoperte,
rivalorizzate
e
reintrodotte
sincreticamente risultano essere di varia origine etnica e storicoculturale. Dal punto di vista strutturale si è realizzata la creazione
di 'nuove forme' che sono state rielaborate in modo da essere
"digerite" da individui occidentali dell'epoca contemporanea. Si
possono considerare nuovi sistemi significanti, ricontestualizzati
nell'attualità contemporanea, condivisi dagli ideatori-conduttori e
dai partecipanti, che esibiscono una logica interna che rende
leggibili ed interpretabili i fatti ed i comportamenti agiti e
conferisce loro anche una certa efficacia rispetto agli obiettivi di
benessere che si propongono.
Fabietti, Malighetti e Matera affermano che all'interno di un
contesto culturale si possono organizzare forme di resistenza e di
adattamento nei confronti di forze esterne, anche attraverso
l'elaborazione di sincretismi: "i sincretismi e i profetismi possono
costituire la risposta che una certa cultura elabora in funzione di
un discorso di "resistenza" e di "adattamento" nei confronti di
forze esterne"16. Questo tipo di risposte e di forme di resistenza
culturale "non sono solo espressione delle singole culture, ma
anche della dialettica - talvolta conflittuale - che le può
caratterizzare al loro interno"17. Quando si tratta di una dialettica
conflittuale che si manifesta all'interno della cultura più generale
di appartenenza si deve parlare di subculture. "Le subculture sono
"reti" di significati condivisi da determinati individui (e non da
altri) all'interno di un contesto significante più vasto (la "cultura")
a cui pur tuttavia quegli stessi individui appartengono"18 e per le
quali si realizzano le stesse risposte di resistenza e adattamento a
forze esterne, osservate nelle culture. Alcuni esempi di subculture
riportati dai suddetti antropologi sono il sistema delle
confraternite religiose nell'Italia e nella Spagna, gli Hooligans, gli
intellettuali progressisti, i massoni, i cinofili, ecc. Tra questi
ritengo che si debba inserire anche la comunità costituita dai
'fedeli' alle cure alternative. E' in questo contesto subculturale che
prende forma l'universo immaginativo condiviso, all'interno del
quale il sistema di simboli può essere interpretato e descritto in
modo intelligibile. E' la 'subcultura alternativa' l'ambito in cui si
può rintracciare il filo conduttore che riguarda la tematica della
17
decontestualizzazione di pratiche, comportamenti, azioni
simboliche riprese da contesti "altri", della loro trasformazione e
del riadattamento in nuove forme significative ai fini delle
particolari concezioni relative all'integrità dell'essere umano, ai
concetti di salute, di equilibrio etico-sociale e di significatività
esistenziale. La riproduzione delle pratiche, ritenute proprie di
tradizioni culturali delle quali gli individui appartenenti alla
'subcultura alternativa' condividono i valori e gli obiettivi, è
funzionale alla riattivazione simbolica di quegli stessi valori ed
obiettivi.
recupero del benessere.
Per fare qualche esempio, l'osservazione fenomenica di una
sessione di Arpeincoro in Meditazione, o di una fase di
movimento di Vocal Harmonics in Motion, consentirebbe solo di
vedere persone che suonano l'arpa o che fanno ginnastica. Saper
interpretare questi comportamenti come "fare meditazione con
l'arpa" o "eseguire una procedura di riequilibrio energetico",
presuppone la conoscenza del codice che informa tali gesti, agito
e condiviso all'interno della comunità.
Lo stesso discorso si può estendere agli strumenti musicali, che
sono stati sottoposti ad un processo di ricontestualizzazione e di
riadattamento immaginativo alla funzione di guarigione alla quale
sono dedicati. Essi, inseriti nei particolari contesti rituali, ancor
prima di essere 'oggetti con i quali fare musica', sono simboli,
'oggetti liturgici' dotati di potere. Se fossero sconnessi dall'ambito
delle pratiche di guarigione contemporanee in cui vengono
utilizzati, apparirebbero completamente fuori luogo. Il loro uso
acquisisce senso se è interpretato alla luce delle credenze relative
ad ogni pratica e se si considera l'apparato simbolico di cui sono
caricati. E' proprio il loro valore simbolico che giustifica la loro
applicazione e la rende efficace sia per i conduttori che per i
partecipanti agli eventi. Ad esempio il didgeridoo, utilizzato per la
sua caratteristica sonorità ricca di armonici, deriva il suo potere
simbolico soprattutto dal fatto di essere considerato uno
strumento da sempre usato dagli sciamani aborigeni nelle
cerimonie di guarigione. Il tamburo sciamanico, strumento a
percussione, funzionale in una pratica in cui l'agente curativo è
costituito dal ritmo che sollecita la danza di guarigione, assume
maggior valore in quanto rappresenta il "battito del cuore di
madre terra" e "l'oggetto di potere dello sciamano per richiamare
lo spirito". La pratica strumentale con l'arpa celtica funziona nel
contesto terapeutico soprattutto perché è considerata un oggetto in
grado di riequilibrare "l'energia del cuore".
L'analisi dei repertori musicali ha rilevato che si tratta di prodotti
dai canoni occidentali e contemporanei per l'uso degli elementi
formali e per l'impiego della tecnologia musicale nella produzione
e, talvolta, anche nella fruizione. I richiami ad aspetti tradizionali
si riferiscono in alcuni casi alle tecniche musicali, in altri al
contenuto sonoro.
Nel complesso le situazioni musicali osservate possiedono una
capacità evocativa che si può attribuire alla ricombinazione e
all'applicazione di elementi formali eterogenei capaci di
richiamare sonorità "altre", al loro valore simbolico e all'uso
ritualizzato adottato nelle pratiche di guarigione osservate. In
tutti i metodi si è in presenza di un 'nuovo prodotto musicale',
rielaborato in modo da essere funzionale all'uso che ne viene
fatto. Bisogna ricordare che la musica, la danza e il canto, in
queste pratiche, sono considerati gli elementi essenziali per aprire
l'accesso a quegli stati modificati di coscienza, attraverso i quali
si ritiene possibile la guarigione. Il suo ruolo deve essere valutato
all'interno del sistema ed è 'contesto' la parola chiave per
comprenderne la funzione e l'uso. La valutazione esclusiva delle
caratteristiche estetico-musicali non consentirebbe di considerare
gli aspetti simbolici che essa assolve.
Processi mimetici
La circolazione di simboli e di modelli di comportamento, di
valori e di stili di pensiero, e anche la loro ri-significazione in
contesti diversi da quelli originari, possono attivare dei processi
mimetici che consistono in manifestazioni di "adeguamento e di
imitazione simbolica e pratica, da parte dei componenti di una
cultura, nei confronti dei simboli e delle pratiche degli
appartenenti a una cultura 'altra'"19. La mimesi, che costituisce un
meccanismo inerente al processo di traffico culturale, si può
definire come la ripresa di forme culturali 'altre' da parte dei
soggetti di una determinata cultura.
La riattivazione simbolica e pratica di valori ritenuti tradizionali
che si manifesta nell'ambito osservato nel corso della ricerca, si
può considerare un processo mimetico in cui "il piano del
comportamento e quello del senso non sono distinguibili in
maniera assoluta"20 e il livello pratico e quello simbolico sono
strettamente collegati, come sempre avviene nell'agire umano.
Questo processo mimetico consente di esprimere l'opposizione ai
valori e ai modelli rappresentati dalla cultura di appartenenza e
rende concreta la possibilità di riconoscersi in un modello ritenuto
valido e di apprenderne i principi.
Conclusioni
La prassi musicale non può essere analizzata al di fuori
dell'ambito delle terapie alternative in cui si inscrive. Strumenti,
repertorio, occasioni e modalità esecutive sono elementi che
concorrono alla definizione del contesto ritualizzato e rivelano
significati se vengono interpretati all'interno dello stesso. Spiega
Clifford Geertz che per comprendere i comportamenti delle
persone non ci si può limitare ad un'osservazione meramente
fenomenica, perché altrimenti non è possibile "distinguere un tic
da un ammiccamento"21. Infatti, dal punto di vista esclusivamente
comportamentale, in entrambi i casi, si contrae una palpebra. La
sostanziale differenza tra un tic e un ammiccamento è definita
dall'esistenza di un codice comunicativo, pubblico e socialmente
condiviso. Queste considerazioni si possono estendere agli eventi
trattati. In questa luce assumono senso i comportamenti musicali,
l'uso e la funzione della musica, i richiami ai concetti ripresi dai
contesti tradizionali "altri".
E' l'esistenza di questa rete di significati, conosciuta dai terapeuti
e dai partecipanti, che rende la prassi efficace, in relazione agli
obiettivi di modificazione dello stato di consapevolezza, al
raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico e di
18
Note
[1] La tesi intitolata Concetti, comportamenti e tecniche musicali nella pratica delle cure alternative. Analisi di tre realtà dell'area
milanese, è stata discussa il 2 dicembre 2004 presso la facoltà di Lettere Moderne, indirizzo Etnomusicologico, Università agli Studi
di Milano. Relatore prof. Nicola Scaldaferri, correlatore prof. Stefano Allovio. Le parole o le frasi poste tra virgolette in questo lavoro,
se non diversamente indicato, provengono dalle interviste agli informatori.
[2] Tiziana Dainotto è il nome legale dell'informatrice. Dal 1995 lo ha mutato in Anand Nirava che in lingua hindi significa
beatitudine nel silenzio. L'attribuzione di un nuovo nome è parte del rituale di iniziazione di coloro che "chiedono il sannya" e
scelgono di considerare Baghwan Raijneesh (1931-1990), detto Osho come maestro spirituale. Divengono così "sannyasi", ossia
discepoli. L'informatrice racconta di avere deciso di diventare una "sannyasi" dopo avere sperimentato una sessione di meditazione
dinamica ed aver provato una intensa "energia d'amore". Spiega che la procedura di iniziazione prevede l'invio della richiesta a Puna,
in India, dove ha sede il Centro fondato da Osho, per tramite di una sede italiana intermediaria. Dopo qualche tempo si riceve un
attestato con il nuovo nome. Il nome "sannyasi" è rappresentativo delle caratteristiche che il discepolo deve sviluppare e fare emergere
nel suo percorso evolutivo. Intervista del 26 Maggio 2004.
[3] Delle tre performance trattate in questa tesi Arpeincoro in Meditazione di Cristina Ruffino non è presente nel web. L'informazione
è stata reperita sulla rivista "Guida al Ben-Essere" editore Organizzazione Due G., Milano. Trance Dance di Tiziana Dainotto e Vocal
Harmonics in Motion di Lorenzo Pierobon si trovano nella rete rispettivamente agli indirizzi: www.altropensiero.com;
www.laviadeglienergizzatori.com, e www.musicoterapia.monza.net, Consultazione del 24 giugno 2004.
[4] La conferenza dal titolo: Il suono dell'anima è stata condotta da Lorenzo Pierobon a Villa Serena, ospedale S. Gerardo di Monza,
con lo scopo di presentare il metodo terapeutico da lui ideato, Vocal Harmonics in Motion, e di promuovere seminari rivolti ai gruppi
di volontari che operano nell'ospedale. Il loro lavoro consiste nel dare sostegno ai parenti dei malati con patologie gravi o incurabili
o alle persone che hanno perduto una persona cara. In sala era presente un medico dell'ospedale. Lorenzo Pierobon, conferenza Il
suono dell'anima, Villa Serena, Ospedale S. Gerardo - Monza, Conferenza del 17 maggio 2004.
[5] Lorenzo Pierobon collabora con alcuni medici psicoterapeuti che integrano le tecniche propriamente psicanalitiche di gruppo con
sessioni musicali col metodo del Vocal Harmonics in Motion. Per la specificità terapeutica di questi interventi non mi hanno
autorizzato all'osservazione delle sessioni.
[6] Merriam Alan P., Antropologia della musica, Sellerio Editore, Palermo, 2000, Trad. it. Elio Di Piazza, pref. Diego Carpitella, Ed.
or. The Anthropology of Music, Northwestern University, Evanston, Illinois (U.S.A), 1964, p. 16.
[7] Gilbert Rouget, Musica e Trance, Einaudi, Torino, 1986, ed. or. La musique et la trance, Gallimard, Paris, 1980, p. 436.
[8] I movimenti neo-sciamanici perseguono ideali ispirati ad un ambientalismo naturista e manifestano una spiritualità 'non
convenzionale', combinando pratiche di guarigione derivate dallo sciamanesimo di diverse tradizioni, con aspetti di alcune correnti
contemporanee della psicologia, come quella transpersonale. Sono sorti intorno agli anni novanta negli Stati Uniti e successivamente
si sono diffusi anche in Europa e in Italia. Si propongono l'obiettivo di soddisfare le richieste e le aspettative degli uomini
contemporanei. La loro nascita è stata influenzata da alcune pubblicazioni, che hanno ottenuto grande risonanza di massa, relative alle
tecniche dell'estasi, al viaggio sciamanico nel mondo degli spiriti e ai metodi di guarigione tramite la trance, la danza ed il suono, come
ad esempio il libro sui nativi americani dell'antropologo Piers Vitebsky, The Shaman, Duncan Baird Publishers Ltd, Londra, 1995, Ed.
It. Gli sciamani. Viaggi dell'anima. Trance, estasi e rituali di guarigione. EDT, Torino, 1998, trad. it. Maria Nicola; il libro
dell'antropologo Georges Lapassade, Essai sur la transe, Iean-Pierre Delarge, Paris, 1976, Ed. It. Saggio sulla transe, Feltrinelli,
Milano, 1980; la tesi di dottorato in antropologia di Carlos Castaneda sugli stregoni indiani Yaqui e l'universo conoscitivo degli
sciamani dell'antico Messico, che si è trasformata in una lettura di consumo dei giovani degli anni '80: The Teachings of Don Juan a
Yaqui way of Knowledge, Baror International, Inc., Armonk, New York, 1968, Ed. It. A scuola dallo stregone, gli insegnamenti di don
Juan, RCS Libri, Milano, 1999, trad. it. Roberta Garbarini. La Trance Dance fa parte del metodo terapeutico neo-sciamanico ideato
da Frank Natale, musicista, terapeuta e presidente del Natale Institute for Experiential Education (Amsterdam). Ha scritto Trance
Dance The Dance of Life, 1995, Great Britain.
[9] Il didgeridoo è una tromba naturale, si suona utilizzando la tecnica della respirazione circolare che consente di produrre un flusso
d'aria ininterrotto. La tampura è un grande liuto a manico lungo, di origine indiana, la cui cassa è ricavata da una zucca e la tastiera
non è tastata. Ha quattro corde che vengono pizzicate. Il suono è ronzante e penetrante si presta bene a creare una vibrazione che
rimane di sfondo. Le cristal bowls sono bocce cave di cristallo, intonate. Si suonano con un bastone, che ha un'estremità rivestita in
pelle, mediante sfregamento sull'imboccatura o leggera percussione.
[10] "Secondo la tradizione di Tuva, ogni cosa è animata o abitata da entità spirituali. Le leggende narrano che gli abitanti di Tuva
hanno imparato il canto xöömij per stabilire un contatto con queste entità e assimilare il loro potere attraverso l'imitazione dei suoni
naturali. Il popolo di Tuva crede infatti che il suono sia il modo preferito dagli spiriti della natura per rivelarsi e comunicare con gli
altri esseri viventi", Piero Cosi, Graziano Tisato, On The Magic of Overtone Singing, in Voce, canto, parlato, a cura di Piero Cosi,
Emanuela Magno Caldonegnetto, Alberto Zamboni, Unipress, Padova, 2003, p. 84 (t.d.a.).
19
[11] I gong sono dischi in metallo. Vengono suonati mediante percussione con un bastone; le campane tubolari sono una serie di
tubi metallici di uguale diametro, ma diversa lunghezza, si suonano mediante percussione con un mazzuolo;
i cimbali sono costituiti da due campane solo leggermente cave, tenute insieme da un cordino. Si suonano mediante percussione
reciproca; le singing bowls o campane tibetane o nepalesi hanno forma di ciotola, sono in lega metallica a prevalenza bronzea e si
suonano mediante percussione o strofinamento lungo il bordo con un bastone di legno. Il sitâr è un grande liuto di origine indiana,
tastato. La sua particolarità è di avere corde simpatiche che vengono messe in risonanza dalla vibrazione delle corde principali; la
vînâ è uno strumento usato nella musica classica indiana. E' derivato dalla cetra a bastone con l'aggiunta di risuonatori costituiti
da zucche cave. Ha quattro corde per la melodia e tre corde per il bordone.
[12] Dal sanscrito cakra: cerchio, ruota, disco, che gira intorno. Secondo la teoria contenuta nei Veda il chakra è un centro di attività
che riceve, assimila ed esprime l'energia della forza vitale. Sono disposti sul corpo lungo la colonna vertebrale in corrispondenza
dei gangli nervosi. I più importanti sono sette che controllano ed influenzano ghiandole, funzioni e organi corporei. Ogni chakra
ha una sua 'zona di competenza' a livello fisico, mentale, emozionale. Se il chakra è armonico l'energia fluisce e scorre liberamente,
assicurando uno stato di salute olistica. Il chakra del cuore è il quarto, è situato al centro del petto, controlla la ghiandola del timo,
corrisponde al sentimento dell'amore puro, senza vincoli. E' considerato il chakra fondamentale per la presa di coscienza e
l'evoluzione personale. Anodea Judith, Il libro dei chakra. Il sistema dei chakra e la psicologia, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1998,
Trad. It. Francesca Diano, ed. or. Eastern Body, Western Mind. Psychology and the Chakra System as a Path to the Self, Celestial
Arts Publishing, Berkeley, 1996.
[13] L'utenza di questa pratica di benessere è esclusivamente femminile.
[14] Benedict Anderson, Comunità immaginate, Manifestolibri, I° ed. discount, Roma, 2000 (I° ed. 1996), Trad. it. Marco Vignale.
[15] Vittorio Lanternari, "Le terapie carismatiche, Medicina popolare e scienza moderna", La Ricerca Folklorica, anno 2002. n. 8.
[16] Ugo Fabietti, Roberto Malighetti, Vincenzo Matera, 2002, p. 127.
[17] Ibidem, p. 127.
[18] Ibidem, p. 127.
[19] Ibidem, pp. 112.
[20] Ibidem, p. 111.
[21] Clifford Geertz, op. cit., p. 12.
Bibliografia
Anderson Benedict, Comunità immaginate, Manifestolibri, I° ed. discount, Roma, 2000 (I° ed. 1996), Trad. it. Marco Vignale, Ed.
or. Imagined Communities, Verso, London-New York, 1991.
Bellinzaghi Roberta, "La storia dei Celti", allegato al disco Patrick Ball, Magia dell'Arpa Celtica, Edizioni Red, Como, 1996.
Combi Mariella, Corpo e tecnologie, Meltemi editore, Roma, 2000.
Cosi Piero, Tisato Graziano "On the Magic of Overtone Singing", in Voce, canto, parlato, a cura di Piero Cosi, Emanuela Magno
Caldonegnetto, Alberto Zamboni, Unipress, Padova, 2003.
Fabietti Ugo, Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione, Gius. Laterza & figli, Roma-Bari, 2001 (I° ed. 1999).
Fabietti Ugo, Malighetti Roberto, Matera Vincenzo, Dal tribale al globale, Paravia Bruno Mondadori Editori, Milano, 2002.
Geertz Clifford, "Verso una teoria interpretativa della cultura", in Interpretazione di culture, Soc. Editrice Il mulino, Bologna,
Nuova Ed. 1998, (I° ed. 1988), Trad. it. Eleonora Bona, Ed. or. The Interpretation of cultures, Basic Books Inc., New York, 1973.
Giannattasio Francesco, "Musica e stati alterati di coscienza: una questione ancora aperta", Relazione introduttiva Seminario
Internazionale di Studi, Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati, Fondazione Cini, Venezia, gennaio 2002, www.cini.it.
Giannattasio Francesco, Il concetto di musica. Contributi e prospettive della ricerca etnomusicologica. Bulzoni Editore, Roma,
1998, (I° ed. Nuova Italia Scientifica, 1992).
Hornbostel Erich M.v. e Curt Sachs, "Sistematica degli strumenti musicali. Un tentativo" (1914), Trad. it. Febo Guizzi, in Febo
Guizzi, in Gli strumenti della musica popolare in Italia, Lim, Lucca, 2002.
Judith Anodea, Il libro dei Chakra. Il sistema dei chakra e la psicologia, ed. Pozza, Vicenza, 1998, Trad. It. F. Diano, ed or. Eastern
Body, Western Mind. Psychology and the Chakra System as a Path to the Self, Celestial Arts Publishing, Berkeley, 1996.
Lanternari Vittorio, "Le terapie carismatiche, Medicina popolare e scienza moderna", La Ricerca Folklorica, anno 2002. n. 8
Merriam Alan P., Antropologia della musica, Sellerio Editore, Palermo, 2000, Trad. it. Elio Di Piazza, pref. Diego Carpitella, Ed.
or. The Anthropology of Music, Northwestern University, Evanston, Illinois (U.S.A), 1964.
Natale Frank, Trance Dance. La danza della vita, Edizioni l'età dell'acquario, 1997, Trad. It. Chiara Bosio e Isabella Bresci, Ed.
or. Trance Dance - The Dance of Life, Element Books Limited, Great Britan, 1995.
Rouget Gilbert, Musica e trance, Einaudi, Torino, 1986, ed.or. La musique et la trance, Gallimard, Paris, 1980.
20
Dialogo sulla guerra
Nelle pagine che seguono Achab accoglie i contributi di Pietro Clemente e Valerio Fusi sul tema della guerra. Il testo di Clemente
nasce come spunto di riflessione per una serie di conferenze tenute tra marzo e maggio di quest'anno sotto il titolo di "Violenza, corpo,
emozioni". Il seminario si è tenuto tra Siena, Firenze e Roma e ha coinvolto e messo a confronto antropologi, scrittori, fotografi,
cooperanti, studenti... su un tema sempre più centrale, non solo per la sua drammatica attualità ma anche per il rilievo teorico che
molti cominciano a riconoscergli. Il contributo di Fusi, come ha modo di precisare lo stesso autore nell'introduzione al suo articolo,
nasce come risposta "informale" al testo di Clemente ed è qui presentato nella sua forma originaria di lettera aperta.
Achab segue con interesse tale dibattito e spera di incentivare nei suoi lettori ulteriori riflessioni che possano venire riprese nei
prossimi numeri.
La Redazione
Siamo in guerra
di Pietro Clemente
Pieve e Riondino
"Siamo in guerra", lo ha detto Davide Riondino, chiamato ad
esprimersi a suo modo sul palco piovoso di una Piazza di Pieve
Santo Stefano. Era il ventesimo anniversario della nascita
dell'Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano (Arezzo), la
grande banca di scrittura personale della gente comune che reca la
firma del suo inventore Saverio Tutino, che l'anno passato
abbiamo festeggiato per gli ottant'anni. Riondino era sul palco
della premiazione dei dieci diari finalisti scelti da una giuria
popolare della Val Tiberina, e della proclamazione del vincitore
scelto da una giuria nazionale di esperti. Avevano parlato alcuni
dei diaristi, intervistati da una équipe di Radio tre, e già delle
storie dolorose erano emerse all'ascolto. Una donna, Antonina
Azoti, poi risultata vincitrice, ha raccontato di come a 4 anni,
poco prima di Natale (aveva intravisto già "il dono che la vecchia
Natala, la befana, mi avrebbe portato per il Natale ormai
imminente" ha scritto nella prima pagina della sua memoria) le fu
ucciso il padre dalla mafia, e di aver passato la giovinezza
sentendo rimproverare quel padre sindacalista che, per non aver
voluto accettare le regole vigenti , aveva lasciato la figlia orfana.
La storia scritta da questa donna era la storia del riscatto della
memoria paterna contro il senso comune, fino all'orgoglio di
sentirsi vicina a Falcone e Borsellino come testimone e vittima di
mafia. Nell'intermezzo la parola era andata a Riondino, erano le
18 dell'11 settembre (una data ormai indimenticabile con migliaia
di morti visti e rivisti morire in pochi istanti). Riondino si è alzato
ed ha preso la chitarra, il microfono non funzionava bene, dietro
di lui c'era Saverio Tutino che aveva già raccontato il suo
perdurante amore e stupore per le memorie scritte dalla gente.
Doveva Riondino introdurre con parole una canzone assai bella
che aveva scelto di cantare e che riguardava un uccello che dorme
e sogna in volo, visto in un viaggio a vela sull'oceano. Prima di
farlo ci ha spiegato in che tempo siamo, in che mondo siamo, cosa
lo caratterizza con quelle semplici parole: "siamo in guerra". La
guerra è il principale argomento delle memorie di Pieve Santo
Stefano, quelle memorie che, depositate in Archivio, hanno pian
piano superato il numero degli abitanti, che sono 3.500 mentre i
testi sono 4.792, quasi 5.000. A Pieve la guerra è soprattutto la
seconda guerra mondiale, ed anche la prima. Che impressionante
continuità. Uno che avesse alzato la testa dai diari immerso nel
tempo di quelle pagine in Albania, in Yugoslavia, sotto i
bombardamenti americani, in mezzo agli invasori tedeschi,
sentendo Riondino avrebbe potuto pensare: allora la guerra non è
mai finita!
Dunja, Diana, Simona
"Siamo in guerra", forse pensava all'Irak, o alla Cecenia, o al
trattato di Kyoto, ma Riondino diceva che è un po' che gli capita
di dirlo, tanto per collocare se stesso e il suo pubblico in una
cornice che riconnetta lo spettacolo con il mondo. In effetti
eravamo in guerra anche quando lo era, a pochi passi da casa, la
Yugoslavia, quel paese che ora non c'è più, ed è chiamato come
un ex -paese.
Io sono un ottimista e poi, nato nel 1942, ho potuto credere di
avere vissuto tutta la mia vita (salvo i primi tre anni che però in
Sardegna non si sentivano come in Toscana o in Emilia) in un
mondo di pace e non mi rassegno all'idea che siamo in guerra. Ho
bisogno non tanto che mi pizzichino né di guardare la televisione,
quanto piuttosto di avere quelle dolorose guide ermeneutiche nel
mondo, esterno ai nostri sogni, che sono le persone che conosci,
cui vuoi bene, e che stanno fisicamente dentro l'innominabile
pantano di disperazione che è la guerra.
Per la ex-Yugoslavia fu l'amicizia di Dunja Rihtman a
coinvolgermi. Ora Dunja non c'è più, e la sua storia di donna di
21
Fiume, ex partigiana, poi militante nel mondo socialista, poi
critica verso il regime titino insieme al marito Drago, giornalista,
e quindi di nuovo nella guerra, di nuovo nei rifugi antiaerei, a
condividere la lotta contro la Serbia vista come nemico
dell'Europa e residuo di violenza antidemocratica, e quindi il
nazionalismo, che poi fu esaltato dal governo di Trudman, così da
farla essere di nuovo contro, è una storia che aiuta a capire il
mondo in cui viviamo. Dunja si era messa a studiare le forme del
simbolismo nei processi di impetuosa trasformazione politica,
voleva legarsi all'attualità, non voleva concedere nulla a
quell'ottimismo colpevole di cui accusava i suoi colleghi
antropologi. C'è ancora, a ricordarlo, l'articolo-lettera che scrisse
per la rivista Ossimori nel dicembre del 1991: "Anche altrove la
vita non è rosea, ma qui, nel sangue di Vukovar, nella distruzione
e nello spopolamento di Dubrovnik e di tanti villaggi, i simboli
stanno acquistando delle connotazioni nuove."
Forse è da allora che siamo 'in guerra', da 13 anni. Da poco ho
sentito P.Matveievic che, alla radio, ricordava che l'assedio di
Serajevo è stato il più lungo della storia del primo millennio.
Incredibile. In questo mondo brancolo nel buio. Vado per
paradossi. Non avrei mai pensato da giovane che un giorno avrei
avuto come riferimenti in politica internazionale un presidente di
destra come Chirac, e il Papa. Vedo nero il futuro e sono
preoccupato per i miei nipoti. Ma far conto sulle relazioni
personali, gli allievi, mi aiuta ad essere meno dogmatico e più
problematico. Da quando una mia allieva romana vive a
Gerusalemme ho rivisto alcuni stereotipi filopalestinesi della mia
formazione, ed è a lei che penso quando sento parlare
dell'incomprensibile intreccio di ammazzamenti che è diventato
lo spazio israelo-palestinese. L'Irak per me è la storia delle due
'Simone', e in particolare quella di Simona Torretta, studentessa
romana della quale ho un forte ricordo di impegno, ma anche di
mio disagio verso un'esperienza dell'alterità che si faccia
dedizione e rischio di vita. Quando ho visto sugli schermi quel
volto familiare, intenso, mediterraneo, ho sentito che la guerra ci
aveva raggiunto, ci era saltata addosso e non potevamo più non
vedere che ce la avevamo in casa. Ho vissuto il doloroso periodo
del silenzio con l'angoscia dei genitori. Essere in guerra è anche
questo, com'era nella seconda guerra mondiale, chiedersi dove
sarà un figlio, vivere con la possibilità della morte vicina.
Ma ora che le due simone sono felicemente tornate ma che la
guerra e la morte continuano in Irak e altrove, e che la morte
innocente di Jessica e di Sabrina, poco più che adolescenti in
vacanza, ha reso ancora più odioso e spaventoso quel mondo di
guerra a tutto campo, la domanda che mi faccio e che molti ci
fanno è che cosa l'antropologia può dire di questo nuovo scenario
di conflitti in cui gli aspetti religiosi, culturali ed etnici sono
sempre più marcati. Cosa sappiamo dell'Irak, dell'Afghanistan,
dell'Europa baltica, della ex Yugoslavia, del Pakistan, che serva a
capire. E può l'antropologia vivere come attività conoscitiva,
senza doversi confondere con la cooperazione, con il volontariato,
con la dedizione, il coraggio, la solidarietà? Forse se siamo in
guerra non è possibile più farlo. L'antropologo deve tornare ad
essere intellettuale, uomo che fa politica, padre o nonno
preoccupato per i figli, che si interroga su un futuro dove
l'Occidente rischia di diventare un mondo opulento blindato e
minacciato di vendetta da tanti popoli della terra? La guerra
spinge ad economizzare le distinzioni di sfere, a riconnettere
tutto.
Il ponte di Mostar
Non so come si possa farlo, faccio parte di una generazione che
ha peccato di dogmatismo e di semplificazione, due cose di cui
proprio non abbiamo bisogno oggi, perché la guerra ci coglie in
un mondo di estrema complessità, in cui ogni semplificazione è
perdita di comprensione. Ma credo che dobbiamo provare, anche
per non essere costretti a tacere come finora è capitato troppo
spesso. Forse dobbiamo farci più europei e prendere le distanze
dal gigante imperiale che riduce le differenze culturali dei popoli
con eserciti e bombe? L'antropologia è in ritardo anche su questo
fronte europeo. Dobbiamo di nuovo guardare alla generazione dei
padri fondatori, alla capacità di dare voce alla gente, al mondo
non ufficiale, che hanno avuto un Nuto Revelli, un Saverio
Tutino, Zavattini, il neorealismo, Dolci, Scotellaro, Gianni Bosio
e tanti che furono antropologi anche se non lo facevano di
mestiere? Anche per i beni culturali vederli entro il mondo in
guerra ci aiuta a relativizzare, a riconoscere i valori che ci
costruiamo intorno e la precarietà di essi. Ricordo che ero a Pieve
Santo Stefano quando crollava il ponte di Mostar, un evento
inimmaginabile per me, dopo la seconda guerra mondiale. Mi fu
di grande conforto allora che a Pieve si potesse parlare dell'amore
raggiunto da una donna dall'infanzia infelice, e della lunga e
sofferta subordinazione a un marito di una donna costretta dai
familiari a sposarsi, storie oggetto di memoriali che avevano
avuto il premio ad ex aequo, e pensavo che vale la pena di darsi
da fare perché nel mondo abbiano senso le storie di vita di
ciascuno, i dolori e gli amori, e non prenda il centro della scena
sempre la morte e l'orrore, il nazionalismo e l'odio, il terrorismo e
la vendetta.
E' paradossale che a 60 anni dal 1944 che fu in Italia e in Europa
sia inizio di libertà che inasprimento di sofferenze sia ripreso un
dibattito sul significato dell'odio razziale e della violenza, sul
22
valore del ricordo e del perdono. E' paradossale il ritardo, che però
segnala che ci sono traumi che hanno bisogno di tempi
lunghissimi per dischiudersi, e che ci sono state condizioni
politiche che hanno impedito di farlo prima, ma è ancora più
paradossale che questi temi si adeguino a un presente in cui le
stragi, gli assassini, di stato o di banda, sono tornati all'ordine del
giorno e in cui la stessa distinzione tra civili e belligeranti non ha
più senso.
So che dobbiamo parlare, indagare, domandarci di più su questo
inquieto presente, non so bene come e con quali risorse che non
siano trite ideologie, paradigmi rimasticati. Bisogna ritrovare
percorsi comuni con storici delle religioni, politologi, economisti
e giuristi che abbiano voglia di vedere il mondo da vicino nelle
sua grande varietà. Ci vuole una grande fantasia e audacia di
pensiero e una forte connessione con il mondo, approfittando
della rete, dei contatti e delle voci che possiamo attivare. Cose che
oggi non abbiamo, ma in guerra bisogna tirare fuori tutte le risorse
e sentire la responsabilità del futuro.
Spade e crisantemi.
Antropologi in tempo di guerra
di Valerio Fusi
Il testo che segue è stato scritto come contributo informale ad una discussione su guerra e antropologia promossa da Pietro Clemente,
in occasione di alcuni seminari organizzati tra Prato e Roma. L'ho lasciato così come è nato, nella forma di un dialogo a distanza con
Pietro, e con il bel testo che lui aveva preparato per il dibattito (vedi sopra).
Non si tratta di un contributo accademico, che non ho titoli né dottrina sufficiente per produrre. Piuttosto una riflessione a mente
fredda su alcuni temi di interesse antropologico che mi stanno a cuore; un poco ridondante, forse, a tratti declamatoria, ma non così
tanto da invogliarmi a correggerla ora. Una perorazione sentimentale ed emotiva contro l'ingerenza dell'emotività e del sentimento
nell'approccio professionale e politico degli antropologi ai temi della guerra: uno di quegli ossimori che dovrebbero piacere a Pietro.
Vorrei che il lettore non si lasciasse trarre in inganno dal tenore retorico, che qualcuno ha ritenuto - a torto, credo - troppo giocato
sul registro dell'invettiva, del cinismo e del paradosso, e che è soltanto l'involucro di una argomentazione che spero di aver reso invece
crudamente realistica, così come appare a me.
Il titolo, naturalmente, allude al libro di Ruth Benedict sulla cultura giapponese, che le fu commissionato dal governo americano
durante la seconda guerra mondiale per scopi che non avevano molto a che fare con la promozione della fratellanza tra i popoli. Mi
è sembrato un esempio interessante del modo di intendere il ruolo degli antropologi in tempo di guerra: un esempio che dovrebbe
renderci meno ottimisti sull'uso, sugli effetti e sulla reputazione del nostro sapere in questo momento della storia..
pensiero - per quanto difficile e complesso - che ce l'avrebbe
mostrata per quello che è. L'ontologia arrogante di chi immagina
un mondo che è lì per essere compreso, la pretesa che lo scopo
dell'uomo su questa terra, il valore della sua vita stia nel capire,
nell'estrarre una regola, una cifra, un algoritmo, una ragione, un
senso, una lex abscondita che stavano lì prima dell'uomo - o che
erano nati con lui -, e che il possesso di questa ragione, di questo
senso, fosse un bene in sé, che avrebbe reso il mondo migliore, e
dato un senso a sua volta al nostro esserci dentro. Una pretesa del
genere, per quanto generosa (ma anche non priva di qualche
torbido risvolto) era destinata alla fine desolante che oggi
lamentiamo. Mi sembra semplicistico, e inutile, chiedersi quale
formula abbiamo sbagliato, quale errore abbiamo commesso nel
decifrare la cabala della cosa in sé, illudendoci ancora che basti
raddrizzare la rotta, mettere in sesto la bussola, e ritornare al
punto in cui abbiamo perso di vista la verità perché sia possibile
Caro Pietro,
non so se quella che offro qui sia - come chiedi - una
testimonianza esperta. Certo ho molto poco da testimoniare, e la
mia esperienza è quella che è. Forse sono finito per errore sulla
tua lista di indirizzi, ma ormai ci sono, e tanto vale dire come la
penso. Potrebbe anche servire a qualcosa, dopotutto.
Questa volta, però, per tanto che mi piaccia leggere quello che
scrivi - l'intensità, la densità, il pathos, ma anche lo sguardo lucido
e sofisticato - non riesco a trovarmi d'accordo.
Non mi ritrovo in primis nel tuo sgomento epistemico davanti alla
incomprensibilità del mondo contemporaneo.
A me pare invece che il mondo sia così spaventosamente
prevedibile. Lo sentiamo incomprensibile ora solo perchè
abbiamo passato la vita a pensare che non lo fosse, e ci siamo
gingillati con l'idea titanica che tutto potesse essere spiegato, che
per quanto difficile, complessa, opaca fosse la realtà, c'era un
23
afferrarla di nuovo. Condivido il tuo disincanto, ma lo trovo
ancora troppo ottimista, troppo poco disincantato, come quello di
un innamorato tradito che maledice il suo amore, ma non riesce
ad impedirsi di amare.
Forse il mondo che abbiamo conosciuto era troppo semplice,
troppo seducente il suo invito ad essere decifrato, troppo facili, e
ingannevoli, i successi delle nostre traduzioni. Le cose che ci
sgomentano oggi, e che ci fanno dubitare della ragionevolezza,
della compresibilità del mondo, c'erano già allora, c'erano state.
Sapevamo che c'erano: la guerra, i campi di sterminio, la morte,
le atrocità. Alcuni di noi c'erano passati attraverso. Ma tutto era
previsto nella Grande Spiegazione. I buoni avevano vinto la
guerra, e questo aveva rimesso in sesto l'universo.
Il male c'era ancora, eccome. Con il nostro potente telescopio lo
vedevamo in tutta la sua minaccia, laggiù, ai confini del nostro
mondo. Alcuni si erano spinti fino a lì, al seguito di certi
compaesani armati fino ai denti che aderivano ad ontologie meno
sofisticate delle nostre, e ne avevano riportato referti terrificanti.
Ma era come andare al cinema, in un certo senso. Sistemiamo le
contraddizioni principali, e il resto si metterà a posto da solo, in
qualche modo. Prima o poi saremmo arrivati anche laggiù, noi o
qualcuno come noi, o qualcuno per noi.
Oggi però il male bussa direttamente alla nostra porta, anzi, come
dice quella canzone, scuote i muri e fa tremare i vetri delle
finestre. Forse è già riuscito ad entrare dalla finestra sul retro, e si
è seduto sulla nostra poltrona preferita senza che ce ne
accorgessimo. Ci rendiamo conto che niente è più come
credevamo che fosse, che niente, forse, lo è mai stato veramente.
E' successo ad altri, prima di noi, in momenti storici di altrettanta
sgomentevole incertezza. Non c'è niente di nuovo in questi
sentimenti di dubbio, di sconcerto, di impotenza, anche se è del
tutto nuovo - del tutto - il contesto, e la misura, e la potenza del
male.
Su questo nel 1941 ha scritto una poesia Wystan H. Auden alla
quale non c'è niente da aggiungere:
Possiamo solo dire che è presente, e che nulla
Di quanto imparammo ora ci serve minimamente,
Perchè nulla di simile era accaduto mai. E' come se
Avessimo lasciato la casa cinque minuti appena per spedire una
lettera
E nel frattempo la stanza di soggiorno avesse cambiato posto
Con quella dietro lo specchio del caminetto;
È come se, svegliandoci all'improvviso, ci trovassimo
Sdraiati sul pavimento, ad osservare la nostra ombra
Pigramente stirarsi alla finestra.
Intendo dire che il mondo dello spazio in cui gli eventi si ripetono
c'è sempre
Ora soltanto non è più reale; quello reale non è in alcun luogo,
È dove il tempo permane immobile e niente può accadere;
Intendo dire che per quanto ci sia una persona di cui sappiamo
tutto,
che ancora porta il nostro nome e ama se stessa come prima
quella persona è divenuta una finzione; la nostra vera esistenza
è decisa dal caso e non ha importanza l'amore.
Ecco perchè disperiamo; ecco perchè vorremmo dare il
benvenuto
Al babau della nursery o allo spettro della cantina, perchè anche
L'ululato violento dell'inverno e della guerra è divenuto
come un motivo da juke-box che non si osa fermare.
Temiamo il dolore, ma temiamo di più il silenzio;
Perchè nessun incubo di oggetti ostili potrebbe essere terribile
come questo vuoto.
Questa è l'Abominazione. Questa è l'ira di Dio.
Spade e crisantemi
La guerra, allora. E' la guerra, con tutto il suo seguito di lutti,
atrocità, distruzioni e sangue, che ci fa dubitare di tutto. Ci
spaventa, ci atterrisce, certo, ci sconvolge, ma sconvolge
soprattutto la consolatoria architettura razionale del futuro in cui
avevamo ottimisticamente riposto la nostra fiducia, su cui
contavamo di costruire le nostre vite, le nostre e quelle dei nostri
figli e nipoti. Devasta l'idea che ci eravamo fatti del mondo e di
noi stessi, e ci obbliga a rimettere tutto in discussione.
Dobbiamo capire, ripetiamo a noi stessi.
Ma capire che cosa? Capire per che cosa? Perché tutto torni come
prima, e il male venga di nuovo respinto in quei territori lontani
che esploravamo con il telescopio, in attesa di annetterli ai nostri
possedimenti? E in base a quale ragionamento associamo il
progresso del bene all'incremento delle nostre conoscenze? Cosa
ci fa credere con tanto ottimismo che la sconfitta del male sia
conseguenza necessaria della sconfitta dell'ignoranza, della
superstizione, della confusione mentale, dell'entropia concettuale
di cui ci sentiamo vittime? Vogliamo capire. E poiché la guerra è
guerra con l'altro, è soprattutto l'altro che vogliamo capire.
Finalmente un lavoro adatto a me, pensa l'antropologo, che ha
passato la vita a cercare di capire l'altro, che ha costruito su questo
la propria professione, seppure con esiti ambigui.
Ma anche concedendo la praticabilità epistemologica di una
conoscenza del genere, siamo davvero certi che conoscere l'altro
Fino ad ieri non sapevamo d'altro, e credevamo
Di avere quanto ci occorreva - l'adrenalinico coraggio della tigre,
La discrezione del camaleonte, la modestia della daina,
O la devozione della felce alla necessità spaziale
Esercitare la propria virtù civica non era
Così impossibile dopo tutto; ridurre le nostre perdite
E seppellire i nostri morti era davvero facile...
Ma allora eravamo bambini: questo era un momento fa,
Prima che una novità offensiva fosse introdotta
Nelle nostre vite. Perchè non siamo stati messi in guardia? Forse
lo siamo stati
Forse quel misterioso ronzio dietro il cervello
Che sentivamo a volte - sedendo soli
Nella sala d'aspetto di una stazione di campagna, guardando in
alto
la finestra della latrina - non era indigestione
ma questo Orrore che cominciava già a farsi strada?
Come e quando avvenne non lo sapremo mai:
24
sia di per sé uno strumento per appianare i conflitti? O non serve
semmai al contrario, come sanno bene i servizi di intelligence di
tutti i paesi, che da sempre - come gli antropologi, e qualche volta
anche con l'aiuto degli antropologi - studiano e cercano di capire
il nemico perché sia possibile colpirlo meglio? In fondo è per
questo che si chiamano come si chiamano, no?: intelligence.
"… dovevamo bombardare il palazzo dell'imperatore? … Che
cosa dovevamo dire nella nostra propaganda che servisse a
salvare vite americane e indebolisse la determinazione dei
Giapponesi di combattere fino all'ultimo uomo? Doveva prendersi
in esame anche l'eventualità di un annientamento del popolo
giapponese?" Queste le domande che il governo americano
rivolse a Ruth Benedict nel 1944. Non saprei dire se la preferenza
che fu poi accordata all'ultima opzione di quella lista sia stata
propiziata anche dal lavoro della Benedict, ma trovo comunque la
circostanza piuttosto inquietante.
Mi pare allora che non è tanto offrendo la sua presunta (e tutta da
dimostrare) competenza nella comprensione dell'altro che
l'antropologia potrebbe dare un contributo alla riduzione del
conflitto (o almeno alla riduzione del nostro proprio sconcerto
cognitivo), quanto piuttosto riproponendo la consapevolezza - che
sta all'inizio ed alla fine di ogni antropologia rispettabile - della
relatività delle culture e della impossibilità di ricondurne la
varietà (e la comprensione) ad una struttura invariante di principi
e di valori.
Paradossalmente, cioè, esibendo non i suoi successi come
disciplina, ma il proprio intrinseco scacco epistemologico.
come siamo dei nostri, ci sembra sempre talmente evidente che
quelli dei nostri nemici siano sbagliati, nonostante che loro si
ostinino a considerarli valori, nonostante che anche loro siano
disposti (qualche rara volta, ma sempre più spesso di quanto non
accada a noi) a morire (e uccidere) per loro. C'è sempre una lotta
tra il bene e il male, e tra il giusto e l'ingiusto, ma il problema è
che immancabilmente entrambi i contendenti ritengono di stare
dalla parte del bene, e che essere collocati in tale posizione
privilegiata renda sacro il loro compito: ne santifica il fine e
rende lecite pratiche che in altri contesti sono considerate
inaccettabili. In questo contesto, se è uno dei nostri ad uccidere,
sarà esentato dall'esecrazione universale che si riserva a chi
sopprime una vita umana. Se invece si fa uccidere, diventerà un
eroe, o un martire, o tutte e due le cose insieme. Al contrario i
nostri nemici, nelle stesse circostanze, saranno rispettivamente
assassini e fanatici. Lo stesso vale, simmetricamente, anche per
loro, anche se gli aggettivi possono cambiare. E possono
cambiare anche le modalità di esercizio: si può essere assassini e
fanatici barricandosi dietro una cortina di armi potenti, non
diversamente da quelli che invece scelgono di legarsele al corpo
con una cintura, lasciando che Sansone muoia con i filistei,
piuttosto che sterminarli tutti a distanza, fumando il sigaro in uno
studio ovale.
Non è che tutte le ragioni siano uguali, che tutti i valori siano
uguali. Non è, come dice la critica rozza del relativismo (ma non
si ha idea di quanti sofisticati pensatori vi si affidino) che tutto è
indifferente, che una cosa vale l'altra, che un valore vale l'altro. Il
vero relativismo, non lo spauracchio da operetta con cui si
confrontano gli antropologi a corto di argomenti, non sostiene
l'inesistenza o l'impraticabilità, o l'assenza di senso degli assoluti,
ma piuttosto l'esistenza di assoluti relativi, validi per ciascun
relativo ambito culturale, e in esso assolutamente cogenti.
Personalmente sono molto affezionato ai miei valori assoluti, che
non cambierei con quelli di nessun altro. Per alcuni di essi sarei
disposto (forse) anche a morire, o almeno ad accettare di subire (o
infliggere) una quantità ragionevole di sofferenza. La
consapevolezza della loro relatività non me li rende meno cari,
meno cogenti, meno assoluti nella mia vita. Dal mio punto di vista
relativo sono assolutamente convinto, per esempio, che la ragione
e il torto non possano mai essere divisi in parti uguali, e che
qualche volta accade persino che la ragione stia tutta da una parte
(per dirne una, io non accetterei mai di chiamare la Palestina come fa Pietro salomonicamente - lo spazio israelo-palestinese).
Ma come posso pensare che solo la mia vita sia illuminata dalla
luce della verità, e che tutti gli altri siano condannati all'errore?
Come posso non riconoscere che il mio vicino (e a fortiori il mio
lontano simile, e il mio potenziale nemico) possa averne di diversi
e altrettanto assoluti, e che ami conformare ad essi la sua vita e le
sue aspettative, così come accade a me?
I nemici. Ci saranno sempre i nemici. Li possiamo (qualche volta
dobbiamo) combattere, e uccidere, anche, per affermare la bontà
dei nostri valori, per garantirne la sopravvivenza (e la nostra,
insieme a loro). Ma possiamo combattere meglio (e forse uccidere
meno) non se tentiamo di capire i loro valori (impresa dagli esiti
Giudizi di valore
Accettare un punto di vista relativistico (eh, sì: questa è la parola,
per quanto dubbia sia la sua reputazione nel senso comune come
presso gli ambienti accademici, e susciti invariabilmente sdegno e
ripulsa) significa per prima cosa diffidare dei giudizi di valore.
Qui la parola chiave è diffidare. Non è possibile (non ha senso)
escludere i giudizi di valore dall'orizzonte conoscitivo di
ciascuno. Il rifiuto stesso dei giudizi di valore nasce peraltro esso
pure da un giudizio di valore. Ogni passo della nostra vita
quotidiana e ogni parola del nostro sapere di antropologi gronda
di giudizi di valore. La nostra vita è costruita sui valori, sono i
valori l'impalcatura del nostro mondo, sulla quale appoggiamo le
nostre convinzioni minute, la percezione del nostro essere al
mondo, alla quale affidiamo il senso della nostra esistenza. Se si
dà il caso, siamo anche disposti ad uccidere per i nostri valori.
Qualche rara volta persino a morire. Non potremmo mai farne a
meno.
Possiamo però tentare di amministrarli con una maggiore
consapevolezza: diffidare - appunto - delle formulazioni troppo
assertive, degli universalismi e dei fondamentalismi. Un requisito
di buon senso, prima ancora che una premessa metodologica; ma
anche qualcosa di più del frusto elogio liberale della tolleranza
che tutti abbiamo visto naufragare così miseramente alla prova di
questi anni di fuoco.
Questo è importante soprattutto per la guerra: la guerra è per
l'appunto anche e principalmente un conflitto di valori. Sicuri
25
quanto mai incerti), ma se ci rendiamo conto che anche i nostri
nemici, come noi, agiscono sulla base di valori, e che anche loro,
come noi, non accetterebbero di vivere secondo altri valori che
non siano quelli, per quanto a noi sembrino assurdi, infondati,
ridicoli, malvagi.
uno che semina terrore, a differenza dei bombardieri e dei tank,
che invece suscitano tenerezza e allegria. E se sei un terrorista,
sarò comunque costretto a combatterti, ma questa volta anch'io
sarò un po' più lasco nelle mie regole. Sarò costretto a torturarti,
a sbatterti in galera senza garanzie, a ucciderti subito, senza
lasciarti neanche parlare, a radere al suolo la casa dei tuoi
familiari, a spezzarti le braccia, e umiliarti, ecc. ecc.
Sei un terrorista, soprattutto, perché te la prendi con vittime
innocenti, e con i civili. Certo, anche io, con la mia guerra
regolare, faccio vittime innocenti, forse cento o più volte di
quanto ne faccia tu nelle gelaterie e nelle metropolitane. Per
venire a prendere te nei tuoi introvabili nascondigli, mi sentirò
autorizzato a radere al suolo il quartiere dove ti nascondi, ad
assediarlo togliendo a migliaia di civili ogni mezzo di sussistenza,
ad imbottire di mine le tue strade, a lasciar morire per embargo i
tuoi torpidi concittadini che non si decidono a liberarsi di te. Per
scoprire le tue armi proibite potrò seminare morte e terrore con le
mie armi certificate. Ma tu sei un terrorista, e se sei un terrorista,
in fondo, te la sei cercata, e se la sono cercata i tuoi familiari, i
tuoi vicini di casa, i tuoi connazionali.
Ma noi non odiamo solo i terroristi. Aborriamo, per esempio,
anche i popoli che vorrebbero praticare la pulizia etnica. Ma non
tutti allo stesso modo. Alcuni di questi ci piace bombardarli, ad
altri preferiamo rivolgere un invito educato a non esagerare.
Anche qui vige la regola delle 'certe condizioni'. Abbiamo fatto a
pezzi i serbi per difendere i Kossovari, ma abbiamo lasciato senza
battere ciglio che i kossovari facessero a loro volta a pezzi quello
che restava dei serbi. Processiamo Milosevic come un criminale
di guerra, ma invitiamo alla nostra tavola, con tutti gli onori, il
macellaio di Sabra e Chatila. Abbiamo esaltato come un eroe del
nostro secolo lo studente cinese che fermò i carri armati sulla
piazza Tien an Men, ma consideriamo gli adolescenti palestinesi
che combattono a sassate i tank israeliani, al meglio, come illusi,
se non come fastidiosi fanatici che non si vogliono rassegnare
realisticamente al destino che il mondo libero ha riservato per
loro.
Il nostro senso universale di giustizia è molto tollerante con i
nostri propri comportamenti e con quelli dei nostri amici e
compari, ma possiamo ragionevolmente sperare che la stessa
tolleranza sia condivisa da quelli che ne fanno le spese?
I nostri valori
Vediamo i nostri valori come leggi, attribuiamo loro tutta
l'autorità delle leggi, ci aspettiamo che diano legalità al nostro
mondo. Ma qualche volta diventa necessario proteggersi,
difendersi dal rigore delle leggi, dal principio primordiale
dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Ci deve essere
comunque sempre un modo di aggirare la legge, una via laterale
d'uscita, e legulei esperti in cavilli che siano in grado di far
assolvere chi la infrange.
Non c'è tabù più grande di quello posto sulla vita umana. Ma tutti
accettiamo da sempre che sotto certe condizioni possa essere
lecito, o giusto, o inevitabile, sopprimere una vita. E' una cosa che
non sanno solo i cappellani militari, o il boia di Alcatraz, ma fa
parte del nostro senso comune. Il trucco, naturalmente, sta tutto in
quel 'sotto certe condizioni'. Basta stabilire quali sono le
condizioni che si possono accettare, e quelle inaccettabili, e
avremo un confine entro cui trasgredire tranquillamente i nostri
tabù. La guerra è un buon affare, sotto questo punto di vista,
perché offre un salvacondotto onnicomprensivo rispetto alle
proibizioni più cogenti. Quasi tutto quello che si fa in una guerra,
ogni sopruso, ogni strazio, ogni tortura, ogni strage diventa in una
certa misura accettabile e legittimo, perché la guerra è un valore
così totalitario che relativizza a se stessa tutti gli altri. Allora - con
il cuore che sanguina - si può ammettere di poter torturare (sotto
certe condizioni), colpire per sbaglio civili innocenti, colpire con
premeditazione civili innocenti (quando sia strettamente
necessario), arrostire mezzo milione di giapponesi con una bomba
atomica, ecc. ecc. Perché è così che si fa: la guerra si fa con le
torture, con il dolore, con la morte parossistica, con il terrore,
senza nessuna regola. Abu Ghraib e Guantanamo non sono
eccezioni, degenerazioni. Sono il nostro modo di sgozzare con il
coltellaccio, per arrivare lì dove non arriva la bomba intelligente,
o la missione chirurgica.
In questo contesto un altro principio che sembrerebbe marginale
si dimostra invece fondamentale: entrambi i contendenti devono
indossare una divisa riconoscibile, ed entrambi ricorrere allo
stesso tipo di armi. Vanno benissimo i carri armati, fucili con la
baionetta, bombe di tutti i tipi, portaerei, satelliti spia,
bombardieri atomici, parecchi tipi di gas. Tutti bene. Chi li
possiede può partecipare alla guerra, essere accreditato come un
combattente regolare. Ma se non ti puoi permettere questo tipo di
armi, è meglio che ti tenga alla larga dalla guerra. E' meglio, per
dirlo con parole chiare, che tu ti sottometta direttamente, come se
la guerra l'avessi già persa. Se non vorrai accettare questa
condizione, e pensi di farti saltare in aria in una gelateria sul
lungomare, o in una metropolitana, o rapire qualche innocente
giornalista, sei solo un terrorista. Parola terribile: letteralmente:
Cuius regio, eius religio
Cuius regio, eius religio: la saggezza degli antichi. Purtroppo è
facile essere tolleranti con una religio, finchè la sua regio se ne sta
tranquilla laggiù, a distanza di sicurezza. Ma a differenza delle
religiones, le regiones hanno la fastidiosa tendenza, soprattutto di
questi tempi, a mutare continuamente i propri confini, l'una a
danno dell'altra, essendo lo spazio disponibile sempre lo stesso. In
particolare, la regio dell'occidente, indipendentemente dai confini
delle carte geografiche, ha finito per espandersi indefinitamente,
e per espandere indefinitamente la portata della sua religio, e si è
determinato di fatto un problema per la sopravvivenza delle altre
religiones, quando non anche molto concreti problemi di
26
sopravvivenza tout court per i relativi credenti.
Il conflitto diventa allora inevitabile: è una lotta per la
sopravvivenza che non può conoscere mezze misure o
sincretismi. E' solo un'illusione, un wishful thinking, una
stucchevole ipocrisia l'idea che le culture, e le etnie, possano
precedere mano nella mano, imparando l'una dall'altra in un clima
di conciliazione e di reciproco rispetto, cantando a turno i
rispettivi inni sacri, ognuna indossando il suo costume
tradizionale, come nei sussidiari delle elementari, senza che i loro
rapporti siano condizionati dalla molto concreta contabilità del
dare e dell'avere culturale, degli interessi reali dei popoli e della
loro affezione ai propri valori.
L'occidente è diverso, certo. Lo riteniamo diverso intanto perché
in quanto occidentali siamo in grado di apprezzare quel tipo di
diversità (come naturalmente ogni cultura fa per la sua propria
diversità). Ma è anche diverso, oggi, a causa della sua
incomparabile, spropositata potenza, che si accompagna ad una
altrettanto terribile fragilità. Noi conosciamo bene questa
diversità, e la conoscono altrettanto bene i nostri nemici, che
hanno imparato col tempo a sperimentare la nostra potenza, e
stanno imparando ora a colpire la nostra fragilità.
Questa consapevolezza ci obbliga ad una responsabilità. Ma
ancora, non necessariamente, non prioritariamente ad una
responsabilità etica, che individui un dovere altruistico. E'
innanzitutto una responsabilità verso noi stessi. La supremazia di
potere che abbiamo conquistato nei secoli non ci impone il
rispetto degli altri come valore morale. Ce lo impone
essenzialmente come condizione ormai indispensabile di stabilità
del sistema che abbiamo costruito, per la semplice ragione che
l'equilibrio del sistema di cui siamo padroni è ora minacciato dalla
sproporzione intollerabile del nostro dominio, e che la
moderazione non è più tanto una virtù, quanto una strategia
irrinunciabile per proteggerlo.
E' per questo che la scelta di fare la guerra è stata una scelta
sbagliata. Non voglio dire che sia stata una scelta amorale, o
ingiusta (questo lo penso io, ma non lo pensavano, forse (forse)
quelli che hanno deciso di farla, e di sicuro non lo pensano quelli
che l'hanno approvata). Sarei ingenuo se credessi di poter
convincere queste persone che la loro guerra è amorale e ingiusta,
convincerli cioè della bontà dei miei valori. Anche con i valori si
dovrebbe usare il rasoio di Occam: se non possiamo condividere
gli stessi principi etici, forse potremo trovarci d'accordo sulla
misura della ragionevolezza e utilità di una guerra come questa,
condividere una logica, piuttosto che un ideale (pur sapendo che
anche la logica è un valore, e di quelli più a rischio in caso di
guerra).
Posso sperare, così, di trovare un punto di incontro con i miei
interlocutori sui parametri per valutare l'efficacia della guerra, o
la corrispondenza tra gli esiti reali e gli intenti proclamati. E
argomentare, con qualche speranza in più di farmi capire, che è
stata sbagliata perché ha preteso ingenuamente (o stupidamente, o
furbescamente) di compensare con un atto di forza una situazione
ben diversamente complessa di squilibrio, ed ha rovinosamente
sbagliato nell'individuare i suoi nemici. E' stata sbagliata cioè
perché ha contraddetto alla sua stessa logica, ai suoi principi, ai
suoi intenti, e ha prodotto risultati opposti a quelli che si era
ripromessa di raggiungere (ammesso naturalmente che fossero
davvero quelli dichiarati).
Quello che mi sento di criticare innanzitutto della guerra
americana, è la sua inefficacia. Non la sua ingiustizia, la
sopraffazione, la violenza parossistica, non la sua crudeltà, non la
sua odiosa pretesa imperiale, non tutte quelle cose disgustose che
mi ripugnano in questa guerra, e che contraddicono e feriscono i
miei valori. Quello che non posso accettare è che questa guerra
non produca risultati. Che dimostri così vistosamente la sua
inadeguatezza rispetto ai fini che si è prefissa, ed ai costi morali
che si è assunta. Che sia diventata - come prevedibile - non la
cura, ma ormai la causa principale della nostra insicurezza e della
nostra angoscia per il futuro. Non pretendo che gli americani
realizzino la democrazia in medio oriente (tutti sanno che non lo
vogliono davvero e non lo faranno mai), e non mi interessa, e non
credo di volere che lo facciano. Mi aspetto però che gli americani
e chi li sostiene garantiscano (oltre alla loro) anche la mia
sicurezza e quella della mia famiglia. Il mio cuore di sinistra
sanguinerà un poco se per fare questo gli americani dovessero fare
del male agli arabi, ma del resto è quello che noi occidentali
abbiamo sempre fatto con gli arabi nell'ultimo secolo, e per secoli
ad una quantità di altri popoli. Non è stato così con gli indios, gli
indiani d'america, gli indiani dell'India, con i maori, con tutti
senza eccezione gli africani? Cattivi. Eccome se siamo stati
cattivi! Ma per fortuna gli indiani, e i maori, e gli aborigeni
australiani, e i dannati dell'Africa non hanno imparato a farsi
saltare con la dinamite nelle metropolitane, o non avevano
metropolitane dove farsi saltare, e tutto è andato per il verso
giusto. Ora si contentano di premere alle nostre porte, a spingere
alle frontiere con la sola forza della moltitudine, e anche questo ci
costerà qualcosa.
Questa guerra non li terrà lontani, li spingerà anzi sempre più
verso di noi, sempre più contro di noi.
La guerra giusta è un ossimoro. Esistono guerre che qualche volta,
e sotto certe condizioni, possono essere utili, o inevitabili, o
servire a uno scopo, essere il male minore. Non è questo il caso.
Ma gli argomenti pacifisti non sono abbastanza efficaci per
dimostrarlo. Il pacifismo come ideologia è altrettanto vacuo,
fondamentalista ed ipocrita del suo opposto, come tutte le
ideologie, appunto.
L'ipocrisia qui sta nell'assumere una visione ecumenica di
fratellanza che è falsa dall'inizio alla fine. Una illusione di
comunicabilità, di convivenza pacifica, di universalità del bene, di
naturale socievolezza delle etnie e dei popoli che non è mai
esistita se non nei compitini degli antropologi politicamente
corretti, e nelle favole che si raccontano ai bambini per farli
addormentare.
E' il conflitto, il sangue, la morte, la sopraffazione che hanno
sempre funzionato, e funzionano perchè servono a qualcosa,
hanno uno scopo, una dinamica, una logica, una inerzia terribile
ed inevitabile.
Il problema è che oggi l'impazzimento occidentale ha reso pazzo
27
il sistema della guerra, e da modalità fisiologica delle relazioni
interetniche ne ha fatto l'unico linguaggio praticabile, un
linguaggio totalitario troppo facile da somministrare avendo alle
spalle carri armati invulnerabili e bombardieri invisibili, e davanti
moltitudini di barbari male in arnese.
E' questo che produce un senso generalizzato, incurabile di
disperazione e di ingiustizia.
condizione temporanea di equilibrio alle tensioni tra le culture,
assestando le dinamiche interculturali su un livello di stabilità
omeostatica garantito dalla sua inarrivabile superiorità
tecnologica ed energetica.
Ma c'è una soglia critica oltre la quale non conviene, non è saggio
spingere il proprio vantaggio, l'estensione del proprio dominio.
Non si può vivere per secoli comprimendo le condizioni di vita
dell'altro; non senza offrire qualcosa in cambio. E non perché sia
immorale, ma perché non funzionerà. Non è necessario sentirsi in
colpa. Forse non ha neanche senso. Il conflitto e la sopraffazione,
insieme con la morte, la tortura, gli stupri, gli strazi, gli
sgozzamenti col coltellaccio stanno tutti nel palinsesto dei
rapporti tra le culture. Si vince o si perde. Ma conviene a chi vince
di adottare strategie sensate perchè le sue vittorie non conoscano
soste, perché il suo dominio sia duraturo. C'è una necessità di
condivisione, di ragionevole compensazione che non ha niente a
che vedere con la carità o con il risarcimento. Siamo arrivati al
punto in cui l'occidente deve decidersi a risarcire quelli che ha
stuprato non perchè sia giusto farlo, ma perché ormai questo è
l'unico modo per tenerli a bada. Non perchè è etico, non perchè e
doveroso, ma perché è conveniente, perché è indispensabile
Bisogna venire a patti, perchè i nostri nemici (per quanta simpatia
possa avere per loro, per quanta pietà, comprensione, amore possa
avere per loro, loro sono i miei nemici, non ci posso fare niente,
per il semplice fatto che io sono il loro nemico) hanno armi
altrettanto potenti delle nostre - più potenti, forse - anche se di un
genere diverso, ed hanno in più dalla loro l'aver superato la soglia
dell'interesse alla propria sopravvivenza. Davvero vogliamo
credere che i kamikaze si fanno esplodere perchè sognano le
ventiquattro vergini del paradiso coranico, o perchè qualche
malvagio sceicco capitalista, o qualche fanatico imam li plagia o
compra le loro famiglie, o paga per l'educazione dei loro figli?
Certo non sono i disperati delle baraccopoli che si fanno saltare.
Non sempre, almeno, e non certo guidando aerei contro i
grattacieli. Ma questo non ha importanza. Sarebbe ingenuo
cercare una linearità così banale in questo scenario complesso di
azioni e reazioni, di debiti e crediti storici e culturali vecchi di
secoli, di sangue sedimentato e di ingiustizie, di contrasti
voraginosi nelle condizioni di vita. Non fa differenza se sono i
ricchi sceicchi a finanziare i kamikaze, per i propri interessi, o se
è solo fanatismo religioso quello che li spinge, o il desiderio di
vendicare un fratello, un figlio assassinato: è lo scenario che
conta, l'intreccio insuperabile di interessi, credenze, sofferenze
individuali, fanatismi, ingiustizie occidentali ed orientali, di
sangue mai redento, di famiglie straziate. In questa contabilità, è
soltanto la somma finale che ha la sua terribile evidenza, un
significato inequivocabile.
Dobbiamo venire a patti, allora. Se quei poveri pezzenti dei
palestinesi che vivono da quaranta anni nelle tende ai margini
della loro terra occupata stessero buoni e calmi, o si sterminassero
tra di loro, o si lasciassero disciplinatamente morire di fame come
tutti quei disperati in Africa, senza venirsene a casa mia a far
saltare le gelaterie sul lungomare, i miei grattacieli e le mie
metropolitane - o senza che qualcuno decida di farlo con la scusa
Omeostasi
L'ingiustizia: reagiamo all'ingiustizia perchè sentiamo violato,
offeso un imperativo morale. Ma non è solo questo. Non è
soprattutto questo. Perché quella che noi chiamiamo giustizia che altri chiamano utu, dike, voor, drast - è essenzialmente un
principio intrinseco di equilibrio, un valore termodinamico che ha
a che fare più con la biofisica che con i sentimenti e con l'etica. Se
la natura ha orrore del vuoto, le culture aborrono lo squilibrio. E'
per questo che l'ingiustizia si paga, e si paga anche a distanza di
centinaia di anni. E' per questo che le colpe dei padri ricadono sui
figli. Perché ogni ingiustizia compromette la bilancia sensibile dei
campi di forza, inserisce una frattura nella continuità e nella
stabilità delle energie locali, impone un salto nella natura delle
culture che non ammette salti.
E' la morte che fa la differenza. La morte che dissolve
permanentemente ogni equilibrio, che giustifica qualunque
vendetta. E' la mimesi reciprocante della morte - come dice con la
solita sofisticata ovvietà Rene Girard - che finisce inevitabilmente
per produrre una spirale crescente di violenza e ritorsioni. Alla
morte non si può che rispondere con la morte. Al di là del bene e
del male, del giusto e dell'ingiusto. La morte produce una
mutilazione che chiede di essere risarcita ad un prezzo
equivalente: chi dà la morte sarà ripagato, se e non appena
possibile, con la morte.
Ma è appunto quello che l'occidente, oggi, non può fare, quello
che non può permettersi di fare, proprio perchè le energie di cui
dispone sono esorbitanti, e ogni sua vendetta, ogni cieco tentativo
di ristabilire col sangue l'equilibrio perduto apre un ciclo
inarrestabile di reazioni che non possono essere sostenute senza
che ne escano danneggiate permanentemente le condizioni stesse
della nostra esistenza. Non quando la vita quotidiana di ognuno di
noi può essere devastata da pochi chilogrammi di tritolo in una
metropolitana a mille miglia da casa nostra.
La morte produce un danno. Si può discutere in eterno su come
siano stati cattivi gli occidentali nell'impossessarsi del mondo. Ma
questo non ha importanza. Chiunque si fosse impossessato del
mondo sarebbe stato altrettanto malvagio, e noi occidentali non
possiamo che rallegrarci di aver avuto la meglio alle porte di
Vienna, o a Poitiers, a Kartoum o a Tenochtitlan a suo tempo. Ha
importanza però avere consapevolezza che questo processo ha
prodotto un danno, ed il danno prima o poi chiede di essere
compensato. Chi l'ha subito, magari venti generazioni dopo,
cercherà in qualche modo (in tutti i modi) di ottenere il suo
risarcimento.
Nella modernità il dominio occidentale aveva imposto una
28
della loro sofferenza - continuerei a piangere sinceramente per
loro, la mattina presto, mentre sorbisco il mio cappuccino caldo
con croissant, come ho fatto per i curdi, per gli africani, come altri
hanno fatto prima di me per gli ebrei, per gli armeni. E poi
continuerei - com'è giusto - ad occuparmi dei casi miei.
Quello che oggi rende tutto diverso - più preoccupante, e
pericoloso, e angoscioso - è la spaventosa contiguità dei nostri
mondi rispettivi. Alziamo gli occhi dal telescopio, e ce li vediamo
davanti, i nostri nemici, i barbari, a grandezza naturale. E non è
una vista piacevole.
accetteremmo di nutrirci staccando a morsi la carne dal corpo
vivo dell'animale. Ma a conti fatti siamo solo noi che poniamo in
valore questa differenza, e agli atti pratici, crudamente biologici,
non c'è molta differenza (non ce n'è alcuna) tra il sussiegoso
gourmet seduto al tavolo del Ritz, e la iena della savana che si
guadagna senza ipocrisie la propria colazione.
Uno, nessuno e centomila
Senza ipocrisie. Piangiamo la ragazzina di Tel Aviv che viene
fatta a pezzi sul lungomare mentre mangia il suo gelato, e allo
stesso modo soffriamo per il piccolo pezzente della tendopoli
palestinese ucciso (per errore!) dai militari israeliani. Ma proprio
allo stesso modo? In realtà quella ragazzina è troppo simile a
nostro figlio, con le sue scarpe di marca identiche alle nostre, con
il portatile e le cuffie alle orecchie. Veste come lui, ascolta la
stessa musica, si aspetta dal mondo le stesse cose. Nella sua morte
vediamo morire qualcosa anche di nostro figlio. L'altro è solo un
poveraccio, uno dei tanti che abbiamo imparato a compiangere
nelle parrocchie e sui banchi delle elementari, con un misto di
compassione e retorica. Quella morte, quel tipo di morte sta nel
conto, fa parte del suo destino. Centinaia di migliaia di africani,
milioni di asiatici, milioni e milioni, morti senza pietà, allora e
ancora. Troppi, per averne pietà: la pietà occidentale ama i piccoli
numeri, l'individuo, esalta e cura la sofferenza individuale. Le
morti cumulative gli fanno orrore, ma l'orrore è un sentimento
tutto particolare: prendiamo atto del conteggio con un senso di
tiepida, torpida ripugnanza, perchè non siamo in grado di
rappresentarcene davvero l'enormità. Un milione di persone
morte, di africani morti, non sono come un milione di individui,
uno per uno i nostri vicini di casa. Per questo tremila americani
andati a fuoco in un grattacielo ci hanno sconvolto, perchè in quel
caso abbiamo dovuto moltiplicare per tremila il nostro dolore, la
nostra individuale pietà, e soprattutto le nostre paure private.
Sono tremila Frank, Alan, Rose, Valerio, Pietro, ognuno con la
sua faccia, ognuno con la sua storia, come noi, come ciascuno di
noi. Come ciascuno di noi che potrebbe trovarsi nelle stesse
circostanze. Non come quella montagna indistinta di cadaveri neri
che ingombra tutta l'Africa, non come la massa sterminata di
morti che la nostra civiltà si lascia dietro da sempre. Quelli si
possono contare solo tutti assieme: massa, appunto. Ci
commuovono, ci fanno pena, la loro sorte ci fa indignare, ma
pazienza. Stasera dormiremo tranquilli, come ieri, come il giorno
prima. Non siamo stati noi, e prima o poi faremo qualcosa; di
sicuro, faremo qualcosa.
Ma tutto questo ha una sua tragica naturalezza. E' così che vanno
le cose: ogni cultura riconosce solo il proprio simile, gli altri sono
comunque inumani, o comunque meno umani. Non c'è niente di
cui dovremo scandalizzarci. La sorte ci ha riservato di stare dalla
parte di chi ha vinto, noi abbiamo solo ereditato una fortuna
accumulata con mezzi equivoci. Ma quello che è stato è stato, e
comunque è certo che i nostri nemici non si sarebbero comportati
diversamente da noi, nelle stesse circostanze.
Che cosa ho fatto per meritare tutto questo?
Siamo davvero così ingenui - o ipocriti - da non vedere come il
nostro benessere, le condizioni stesse di esercizio della nostra vita
quotidiana, la possibilità stessa di coltivare i nostri valori nascono
dalla sofferenza altrui, dalla rinuncia che gli altri hanno dovuto
fare alle cose che noi abbiamo avuto, che noi ci siamo presi? Non
so, non credo che dovrei sentirmi in colpa per questo. Non l'ho
fatto io questo mondo. Non c'ero, io quando tutte queste brutte
cose sono accadute. Sono condannato a raccoglierne i frutti, e non
potrei fare diversamente. Lo dice bene il poeta:
"chi è disposto ad affrontare la disperata catabasi nel ringhio
dell'abisso che sempre giace sotto il nostro allegro picnic nella
brughiera del dilettevole, dove ci sdraiamo, avendo già deciso ciò
che non chiederemo, miti, scaldati dal sole, assuefatti alla luce
della menzogna accettata" (ancora Auden: il cuore fino dei poeti
arriva molto più in là, e prima, dei cervelli ben temperati degli
antropologi e degli scienziati in genere).
E' per questo che non sono affatto d'accordo con Pietro quando
dice che il nostro rischia di divenire un mondo opulento e
blindato. Il nostro è un mondo opulento e blindato, lo è sempre
stato. Il rischio, oggi, è proprio del contrario: che non sia più
abbastanza opulento, e abbastanza blindato. E questo fa paura,
vero?
E' solo un'illusione infantile l'idea che il nostro giardino di
principi felici possa espandersi indefinitamente, e che solo
l'ignoranza, la pazzia, la stoltezza degli altri - o la malvagità di
alcuni dei nostri per la quale ci rifiutiamo di assumere
responsabilità - abbia impedito e ancora impedisca loro di
diventare come noi, l'ingenuo e confortante accecamento sul dato
di fatto incontrovertibile che la nostra felicità, il nostro benessere,
il nostro sistema di vita si reggano su un debito infame e
spropositato di sangue, di morte e di sofferenza.
Ci piace mangiare la nostra bistecca allegramente seduti al tavolo
del ristorante, ma non vogliamo pensare alla sofferenza della
vacca, a ciascuna delle fasi durante le quali è stata ingrassata
forzosamente, e poi sanguinosamente soppressa, squartata,
eviscerata, fatta a pezzi, da uomini con un coltellaccio tra le mani
e il grembiule sporco di sangue. Ci rifiutiamo vedere l'animale
nella bistecca, ci rifiutiamo di vedere il macellaio, e rifiutiamo di
riconoscere il debito che abbiamo contratto con uno come lui, che
non inviteremmo mai alla nostra tavola. D'altra parte non
29
Perplessità essenziali
Resta da vedere cosa è possibile fare in uno scenario del genere.
Che cosa possono fare gli antropologi, come chiede Pietro. Una
domanda impegnativa, ma anche ambigua. Non si capisce se ci
può essere qualcosa che gli antropologi possono fare proprio in
quanto antropologi, in quanto amministratori di una conoscenza
specifica che può essere utilizzata per comprendere la sostanza di
questa guerra - o addirittura per difendersene - oppure se si chiede
loro di fare qualcosa come lo chiederemmo ai professori di storia
antica, o ai dentisti, agli idraulici, qualcosa che li riguarda come
uomini, come parte in gioco, come portatori di interessi.
Pietro sembrerebbe - com'è ovvio - interessato alla prima di
queste opzioni, ma le sue domande, subito dopo, i suoi
interrogativi, sembrano soprattutto riguardare la seconda.
Il classico dubbio dei chierici, com'è riassunto nella presentazione
dei seminari: "che ne è del confine tra scienza e politica, fra
l'istanza, cioè, di una conoscenza criticamente distaccata e quella
di una partecipazione attiva e militante al corso degli eventi?"
Bella domanda. Una volta sapevamo come rispondere, vero
Pietro? Tutti quei discorsi
sulla non-neutralità della
scienza, il posto degli
intellettuali, la "battaglia
delle idee". Allora sì che
avevamo idee chiare da
mandare in battaglia, e
alcune
hanno
fatto
egregiamente
il
loro
dovere.
Ora invece quello che
prevale è il dubbio e
l'incertezza, ed è questo
soprattutto
che
ci
sgomenta.
La lettera di Pietro pullula
di espressioni di dubbio e
di
incertezza:
"incredibile","brancolo nel
buio", "vedo nero", "innominabile pantano", "incomprensibile
intreccio", "evento inimmaginabile", "non so bene come", ecc.
Tutto il suo testo è intessuto di sconcerto e di amarezza, di ansia,
e a poco vale, mi pare, quell'invito finale ad essere "più
problematici", ad usare una "grande fantasia ed audacia di
pensiero". Messo lì dove si trova, suona più come un fervorino
consolatorio per non finire in tristezza, qualcosa che in mancanza
di meglio ha dovuto prendere il posto di una ormai impraticabile
proposta di metodo scientifico.
La chiave di questo sta in quel "faccio parte di una generazione
che ha peccato di dogmatismo e semplificazione". Un peccato: è
un modo di dire, certo, ma rivelatore. Sembra che dobbiamo
pentirci di qualcosa, vero? Certo, se il mondo va così, in questo
momento, siamo noi che abbiamo perso (qualsiasi cosa si intenda
con questo 'noi'). Ma abbiamo perso perché eravamo dogmatici e
semplificatori? E abbiamo perso perché i nostri nemici hanno
saputo essere problematici e laici? I carri armati, le portaerei:
sono queste le cose più dogmatiche e semplificatrici che conosco.
Non sarei così severo con il nostro passato: il dogmatismo e la
semplificazione di allora erano la forma che aveva preso il nostro
impegno, la nostra voglia di combattere, la ragione per cui
abbiamo amato la nostra vita, e vi abbiamo riconosciuto un senso,
ed ora invece ci sentiamo persi ed imbelli, e pretendiamo di lenire
questa sofferenza ontologica con una risanatrice onnipotenza
conoscitiva che deve pur essere da qualche parte, una conoscenza
che pure perseguiamo, ancora una volta, con dogmatismo e con
semplificazione.
La storia, anche quella buona, anche quella in cui ci
riconosciamo, l'ha fatta gente che non ha avuto paura di
semplificare, davanti a scelte che andavano fatte. Quelli che la
sapevano lunga, quelli che non seguivano dogmi, quelli che non
semplificavano, quelli che
volevano capire hanno
continuato ad interrogarsi
per tutto il tempo con i
piedi al caldo nelle loro
ciabatte, mentre qualcun
altro faceva il lavoro per
conto loro.
Caro Pietro, non saprei
davvero dove tracciare
quel confine che si diceva,
quella
tranquillizzante
linea retta "fra l'istanza di
una
conoscenza
criticamente distaccata e
quella
di
una
partecipazione attiva e
militante al corso degli
eventi". Sono stanco, molto stanco e incattivito. In queste
condizioni la mia fantasia si è inaridita, per non parlare
dell'audacia di pensiero.
In queste condizioni anch'io, come te, provo "disagio verso
un'esperienza dell'alterità che si faccia dedizione e rischio di vita"
(anche se temo che sia il disagio di chi viene messo davanti alle
proprie paure ed alla propria viltà).
In queste condizioni, immagina, non mi sento neanche di
condannare quelli che scelgono di tagliare il nodo con la spada, e
mettono in gioco la propria vita con una esplosione
semplificatrice.
30
che segue, frutto del lavoro di un docente in psicologia sociale e dinamica, e di una counselor sistemico relazionale,
L’ articolo
affronta alcune questioni centrali del discorso psico-terapeutico. Benini ed Erba cercano di riconsiderare la riflessione teoricometodologica che riguarda il rapporto terapeuta-paziente, alla luce della rottura epistemologica segnata dall'avvento della "teoria
della complessità" e del "costruttivismo". Secondo gli autori, l'apporto dei modelli socio-costruzionisti ha portato ad intrecciare la
riflessione sulla conoscenza terapeutica con la riflessione sui processi comunicativi in cui si genera tale conoscenza, spostando
l'attenzione sugli aspetti relazionali, dialogici e riflessivi che strutturano la relazione terapeuta-paziente, la quale viene nei loro
termini a configurarsi come "conversazione terapeutica" e "narrazione". In questa ottica essi propongono una metodologia di
intervento che intende ridefinire in senso orizzontale le relazioni di forza e potere che tradizionalmente caratterizzano il contesto
clinico, per allontanare la pratica biomedica dai rischi di perpetuare un "colonialismo della salute mentale" e lasciare invece spazio
alla narrazione interindividuale e biografica terapeuta-paziente, quale pratica di "non potere" e "antioppressiva". Pur non liberandosi
completamente da una tradizione di sapere che riduce il disagio ad un problema individuale del "paziente", senza inserirlo nel quadro
di una più ampia serie di fattori sociali, economici e politici, ci pare che l'articolo di Benini ed Erba costituisca un prezioso contributo
ed un interessante spunto di riflessione che cerca di mettere in discussione dall'interno le pretese egemoniche del sapere biomedico.
Anche l'antropologia medica da tempo si dedica alla riconsiderazione critica dei presupposti bio-medici, che comprendono quindi
anche l'ambito psico-terapeutico. In questo contesto, gli antropologi hanno prodotto un intenso dibattito che, intrecciandosi agli
sviluppi delle teorie pedagogiche e psicologiche, ha permesso di ripensare alcune categorie fondamentali quali quella di terapeuta,
paziente, malattia, salute, etc. In questa prospettiva, la pratica medica va considerata un terreno in cui il complementarismo diviene
necessità. Per comprendere a fondo la natura dei suoi presupposti e delle sue implicazioni è necessario superare le barriere
disciplinari ed affrontarne i temi da diversi punti di vista: politico, sociologico, antropologico ed anche dal punto di vista di coloro
che in tale ambito agiscono come attori principali, quindi medici, psico-terapeuti, educatori, etc, e soprattutto, dal punto di vista di
quelle categorie di attori che comprende tutti e nessuno, i cosiddetti pazienti, utenti, malati.
La Redazione
Itinerari di pre-comprensioni tra narrazione e
riflessività*
di Paolo Benini e Gabriella Erba
Premessa
Questo lavoro nasce come elaborazione di una serie di
conversazioni che ci hanno condotto a riflettere sulla nostra
esperienza di counseling e sulla nostra stessa formazione. E' un
lavoro a due mani, o meglio sarebbe dire a "due voci", che sconta
la fatica di rendere per iscritto la trama conversativa. Il motivo di
questa difficoltà è probabilmente da ricondurre ai nostri limiti
come autori, ma per noi è stata anche l'indicazione delle
potenzialità che i processi comunicativi dialogici hanno nel
generare e coordinare significati.
Nella bibliografia di riferimento e nel discorso complessivo, si
sono spesso sovrapposti due insiemi di significanti, uno riferito
all'ambito della terapia familiare, da cui i significanti di terapeuta,
conversazione terapeutica, etc., l'altro riferito al nuovo ambito di
Counseling, in cui i significati citati sono, per così dire, sostituiti
e/o ricollocati da termini quali counselor, colloquio d'aiuto, etc.
In questo lavoro, abbiamo deciso di optare prevalentemente per i
significati suggeriti dalla pratica sociale denominata "terapia
familiare". Questa scelta, non corrisponde a una assimilazione
concettuale tra counseling e terapia, ma dal nostro interesse per la
pratica del "counseling psicologico" e dall'opportunità di far
riferimento a risorse teoriche già piuttosto consolidate, come la
riflessione teorico-metodologica che ha accompagnato lo
sviluppo della terapia familiare dalla seconda metà del
Novecento.
L'ambito del counseling si trova in una fase iniziale, in cui vanno
lentamente definendosi le premesse per discorsi metodologici e
teorici capaci di reggere sviluppi differenti e coordinamenti di
significato tra le diverse scuole e tra i "nuovi" counselor. Sul
piano pratico, il riconoscimento sociale di questa pratica è solo
all'inizio. Per questi motivi ci sembra proficuo appoggiare la
riflessione sui contributi di terapeuti/studiosi che già da molto
tempo praticano e ricercano in un campo di intervento che, da una
prospettiva d'insieme, appare accomunare terapia e counseling: il
sostegno, la facilitazione, la mediazione con persone e famiglie,
in un contesto in cui la conversazione è il principale "strumento"
di lavoro.
Le principali risorse teoriche sono state: alcuni lavori
riconducibili alla "Scuola di Milano", le proposte teoriche sulla
costruzione sociale delle forme comunicative e sociali avanzate
*L'articolo è già apparso sulla rivista elettronica "la rete" (http://www.terapiasistemica.info/larete/2003/itinerari.htm).
Si ringraziano gli autori per averne concesso la pubblicazione.
31
da Pearce, alcuni lavori di terapeuti/studiosi come Lynn Hoffman,
Harlene Anderson, Harold Goolishian, Tom Andersen che sono
tra i principali fautori di quello che è definito "approccio
narrativo" in terapia familiare. Sicuramente, tante altre fonti
precedenti o trasversali ci hanno orientato a scrivere queste cose
piuttosto che altre.
sistema familiare o il sistema terapeutico? Le implicazioni di
questa scelta non sono da poco. Scegliendo la prima opzione
l'attenzione si focalizzerebbe sulla famiglia e il discorso
prenderebbe probabilmente la forma di una riflessione sul suo
disagio. Facilmente, questa scelta ci condurrebbe a costruire un
discorso sulla sofferenza simile ai discorsi terapeutici connotati da
una "centrazione sulla patologia" (Barbetta 1990), nei quali il
processo terapeutico e in modo particolare il ruolo del terapeuta
restano sullo sfondo.
La seconda possibilità, ci appare più impegnativa ma anche più
interessante, poiché chiama nel discorso anche il "terapeuta",
mettendo quindi in discussione quella posizione per così dire di
"osservatore esterno" che orienta dall'alto di una "professionalità"
un discorso esplicativo e prescrittivo sul disagio delle persone;
una posizione quest'ultima che ci appare una sorta di "messa in
sicurezza" delle proprie risorse (Pearce 1989), a scapito
dell'ammissione di un proprio coinvolgimento nella definizione di
un disagio.
Vorremmo scegliere questa seconda opzione, consapevoli che non
è tanto questa scelta preliminare, quanto ciò che riusciremo a
sviluppare in termini di riflessione e, in termini di lavoro con
famiglie e persone, che potrà dire della nostra capacità di
rimanere coerenti con questa prospettiva.
Introduzione
I fili conduttori di questo lavoro sono essenzialmente due: la
narrazione e la riflessività, che appaiono essere ricorsivamente
una l'espansione dell'altra. L'ottica narrativa, che connota la
conversazione terapeutica come contesto di costruzione e
condivisione di discorsi e storie, e la posizione riflessiva, che
porta a beneficiare dei processi di co-costruzione innescati da
relazioni aperte e paritarie. Nel campo della terapia familiare
degli ultimi decenni, le due prospettive si richiamano a vicenda e
tendono a comporsi in un copione di "utilità terapeutica" che
guarda alle possibilità di far emergere le risorse delle persone e
delle famiglie, piuttosto che alle opportunità di "cura".
Nel primo capitolo cerchiamo di comporre, a grandi linee, una
mappa dei cambiamenti teorici e metodologici avvenuti in
conseguenza dell'intreccio tra il mondo della terapia familiare e il
pensiero costruttivista e costruzionista. Possiamo dire che in
questa parte esplicitiamo le nostre premesse teoriche, o, per
utilizzare un termine di Cecchin (1997), i nostri "pregiudizi"
teorici.
Nel secondo capitolo focalizziamo l'attenzione sui processi
comunicativi nei contesti terapeutici o di counseling. La terapia
come narrazione, la riflessività sui propri pregiudizi, l'idea di
"innesto nella situazione emotiva", il colloquio filosofico, sono i
temi messi a fuoco. Per certi aspetti, facciamo solo un accenno a
queste tematiche. Non abbiamo cercato un'analisi articolata e
estesa, per noi è stato importante soprattutto riuscire a collocarle
su un piano di riflessione.
Seguono tre capitoli su altrettante connessioni che ci sono
sembrate significative. La prima riguarda le persone e il
linguaggio, vale a dire la doppia faccia di una conversazione
terapeutica: una dell'incontro tra persone e l'altra del fluire del
linguaggio. La seconda connessione riguarda il potere e il
contesto terapeutico o di counseling. L'idea che si debbano
ricercare "pratiche antiopressive" è la premessa (o il pregiudizio)
della riflessione su questo tema. La terza connessione è tra
biografia e lavoro sociale. In questa parte non potevano mancare
alcuni riferimenti autobiografici. L'accenno a questi ci ha guidati
in una breve riflessione su ciò che scaturisce dall'intricata trama
che si crea tra storie di vita e professioni sociali.
Cibernetica e altre "perturbazioni"
Focalizzato il "sistema" cui guardare, una seconda domanda
potrebbe essere: come concepire i sistemi umani e quindi anche il
sistema umano specifico che si crea in un contesto terapeutico?
Non si tratta ovviamente di trovare una risposta esaustiva a questo
quesito, ma piuttosto di rendere esplicite le premesse teoriche da
cui la nostra riflessione prende le mosse. La "rivoluzione"
epistemologica denominata variamente secondo i contesti teorici
e le scuole di pensiero "cibernetica di secondo ordine", "teoria
della complessità", "costruttivismo", ha avuto riflessi
estremamente significativi nel campo della terapia familiare, a
partire dagli anni '80.
I dubbi e gli interrogativi che si generarono dall'incontro tra
l'emergente pensiero epistemologico e il campo della terapia
familiare non riguardavano tanto i modelli esplicativi del disagio
della famiglia (come era successo con i cambiamenti suggeriti
dalla nozione di sistema introdotta della "prima cibernetica"),
quanto la dimensione epistemologica dell'agire terapeutico. L'idea
racchiusa nella famosa frase di Varela "Tutto ciò che è detto è
detto da un osservatore" e il complesso quadro di riflessione
epistemologica che attraversò quest'idea posero sostanzialmente
la questione della responsabilità dei terapeuti rispetto alle
possibili conseguenze del loro agire conoscitivo e relazionale nei
confronti delle persone in terapia. Ciò che venne messo in
discussione, secondo un intricato piano di de-costruzione e ricostruzione teorica e metodologica, fu sia la pretesa di
conoscenza "oggettiva", sia l'idea della possibilità di distinguere il
"conoscere" e l'"agire", cioè il momento diagnostico e il momento
terapeutico. L'azione di "conoscere" cominciò ad essere
interpretata in stretta e indissolubile relazione con l'azione di
1. Sistemi e cambiamento
"Nella cultura terapeutica è molto difficile non farsi sedurre dal
pensiero di come le cose dovrebbero essere, piuttosto che
concentrarsi maggiormente su come sono" (Cecchin e coll. 1997)
Una prima possibile domanda, parlando di sistemi umani
nell'ambito terapeutico è quale sistema interessa osservare. Il
32
"intervenire" e la conoscenza che poteva scaturire dal contesto
terapeutico si connotò sempre più come un'estensione delle
risorse di senso del terapeuta, piuttosto che la rappresentazione
esperta delle caratteristiche "oggettive" che le famiglie e le
persone manifestavano.
A partire da questa prospettiva, il sapere terapeutico comincia a
perdere la caratteristica di "imparzialità" e "oggettività", per
connotarsi come un'azione che contribuisce a creare ciò che
denomina, con la conseguente possibilità che esso possa dare
avvio sia a processi di evoluzione positiva, sia a processi nocivi.
L'idea "strutturale" di famiglia va in crisi e molti terapeuti
cominciano a pensare che non esista un modello unico di famiglia
e a mettere in discussione l'idea che i problemi siano sempre e
comunque necessariamente individuabili nella famiglia.
In un certo senso, i cambiamenti cui abbiamo accennato hanno
posto fortemente l'attenzione sulla figura del terapeuta, sul suo
modo di comunicare e sui suoi sistemi di significato, non
riducibili però ai soli riferimenti teorici. Emblematico di questo
spostamento di attenzione è la messa a fuoco della questione dei
pregiudizi (Cecchin e coll. 1997). In questa riflessione, la
consapevolezza dei propri pregiudizi è auspicata non con la
finalità di combatterli e neutralizzarli, ma bensì di conoscerli e
poterli utilizzare in modo responsabile nella relazione terapeutica.
La responsabilità corrisponde all'impegno di "presentare" al
cliente le proprie opinioni non come la "verità" che
necessariamente lui deve apprendere per vivere bene con gli altri
e con se stessi, ma come costruzioni personali di significato.
proponendo la conversazione come metafora e strumento centrale
della terapia stessa. In altre parole, si registra una "svolta
linguistica" nella terapia familiare. La conversazione terapeutica
si colloca al centro dell'attenzione, a scapito della direttività che
viene messa da parte.
Nei lavori di studiosi come Lynn Hoffman (1998), Harold
Goolishian e Harlene Anderson (1988), Tom Andersen (1992), si
rintraccia un comune riferimento all'idea dei sistemi umani come
sistemi linguistici che co-costruiscono significati e si coglie un
invito a concepire la conversazione come momento saliente della
terapia.
In questi approcci, la terapia acquista una dimensione "narrativa",
si delinea cioè come un contesto comunicativo entro cui terapeuti
e persone in terapia cercano di costruire copioni conversazionali
diversi da quelli in cui i "problemi" si sono originati e dai quali
invece si possano generare nuovi modi di narrarsi e quindi anche
di essere. La finalità della terapia si configura non tanto come
scoperta dei modi "disfunzionali" di essere e relazionarsi delle
persone e delle conseguenti "giuste" contromosse, ma piuttosto
quanto la costruzione delle possibilità per le persone di crearsi
liberamente altri copioni narrativi per raccontare e raccontarsi.
Gli sviluppi in senso costruttivista e sociocostruzionista della
terapia familiare ci appaino come una sorta di doppio invito. Da
una parte l'invito a "mettersi in gioco" nelle relazioni terapeutiche,
dall'altra un invito a assumere un atteggiamento culturale di
moderazione nel definire le situazioni di disagio e il proprio ruolo.
Per noi è estremamente utile avere questi riferimenti. Non è facile
imparare a "guardare" le persone attraverso lo spiraglio
dell'apertura comunicativa. Ciò che ci sembra di dover imparare e
re-imparare continuamente è soprattutto dare alla conversazione
un carattere "aperto"; nel doppio senso di essere in grado di vivere
forme comunicative che non si interrompono e di stare in esse
senza appoggiarsi necessariamente su una gerarchia "espertopaziente".
I sistemi umani come sistemi linguistici
Se la riflessione epistemologica sulla qualità costruttiva della
conoscenza ha condotto a una profonda revisione del modo di
intendere la figura del terapeuta, un'altra riflessione,
interconnessa alla prima, ha contribuito a svelare la natura sociale
di tali processi costruttivi. Il riferimento in questo caso è alla
prospettiva teorica denominata socio-costruzionismo e, in
particolare, a alcuni modelli in campo sociologico che hanno
avuto una notevole influenza in terapia familiare. Tra questi, il
modello della CMM (Coordinated Management of Meaning) di
Pearce.
Lo sviluppo in senso costruzionista della svolta costruttivista ha
condotto a intrecciare la riflessione sulla conoscenza terapeutica
con la riflessione sui processi comunicativi in cui si genera tale
conoscenza e a orientare l'attenzione verso la negoziazione e il
coordinamento, verso gli scambi linguistici, conversazionali e
dialogici interni al sistema terapeutico. Lo stesso linguaggio ha
registrato significativi cambiamenti. Il termine "terapia" viene
preferibilmente sostituito con "conversazione terapeutica", si
preferisce pensare ai problemi in termini di "narrazioni" piuttosto
che di "diagnosi" e al posto del termine "cura" si preferiscono
espressioni come "dissoluzione dei problemi".
In questa prospettiva a più facce, diversi studiosi impegnati a
conoscere e a lavorare con i sistemi familiari danno un impulso
decisivo in direzione di una "svolta interpretativa" (Hoffman L.,
1998), vale a dire "ermeneutica" della terapia familiare,
2. La comunicazione e le "regole del gioco"
"…ciò che prendiamo per vero o giusto è largamente prodotto da
testi narrativi… Se vogliamo operare per il cambiamento sociale,
dovremo quindi utilizzare i linguaggi condivisi e, nel contempo,
cercare di trasformarli. Ma questa trasformazione non può essere
attivata dalla volontà individuale, da un esperto che tutto vede e
conosce. La trasformazione è invece intrinsecamente
relazionale." (Hoffman 1981)
"… il fatto di pensare in termini di storie non fa degli esseri umani
qualcosa di isolato e distinto dagli anemoni e dalle stelle di mare,
dalle palme e dalle primule. Al contrario, se il mondo è connesso,
se in ciò che dico ho sostanzialmente ragione, allora pensare in
termini di storie deve essere comune a tutta la mente, a tutte le
menti, siano esse le nostre o quelle delle foreste di sequoie e degli
anemoni di mare." (Bateson 1984)
"La terapia avviene nell'interazione dei pregiudizi del terapeuta e
33
del cliente. Essa implica inevitabilmente uno scambio costante tra
terapeuta e cliente, in cui le azioni e le espressioni dell'uno sono
costantemente ispirate, assumono significato, vengono modellate
e modellano quelle dell'altro. Il processo è cibernetico in quanto
sono i suoi risultati a determinare il comportamento di entrambi"
(Cecchin 1997).
Parlare di regole potrebbe far pensare alla definizione di
meccanismi di interazione predeterminati. Non siamo interessati a
questo; piuttosto vorremo riflettere su cosa significhi considerare
una situazione "terapeutica" come un sistema linguistico che si
basa sulla comunicazione e che funziona in base alle "regole" del
significato.
L'approccio narrativo
Le persone nel corso della loro esistenza costruiscono storie. Sin
dall'infanzia, agli albori di una memoria linguistica, impariamo a
connettere le esperienze in termini di storie. Nella giovinezza
prefiguriamo il futuro in termini di storie possibili. Nell'età adulta
siamo immersi nelle narrazioni che costruiamo su noi stessi e sul
mondo, narrazioni spesso date per scontate e immutabili. Nella
vecchiaia, tempo dell'otium tempo di avvicinamento alla morte, la
propria storia di vita o le proprie storie di vita diventano il centro
dell'esistenza, riacquistano significato nel loro bisogno di
narrazione, nell'essere la vita stessa.
In un'esistenza che scorre veloce, nella quotidiana occupazione
del vivere, il desiderio di narrazione che caratterizza la nostra
umanità, trova urgenza narrativa e spazio nelle "esperienze apicali
della vita" (Demetrio 2000): la morte, la nascita, la separazione,
la malattia, la perdita, il dolore. E' di fronte a questi eventi che
cerchiamo l'altro come medium che consenta la narrazione,
poiché "ognuno di noi costruisce e vive un racconto e…questo
racconto è noi stessi, la nostra identità" (Formenti 2002 p. 32)
Melucci (2001) sottolinea come le storie o narrazioni, hanno
sempre a che fare con "soggetti parlanti" in relazione. Da questa
premessa traccia una mappa possibile dei modi in cui si "creano
storie", che si basa sulla dinamica io-altro.
Noi raccontiamo a noi stessi prima di tutto e raccontiamo noi
stessi; poi raccontiamo agli altri e raccontiamo gli altri. …
"Raccontiamo a noi stessi", vuol dire che investiamo una parte dei
nostri discorsi e delle nostre rappresentazioni a costruire la nostra
identità. …Ma anche "raccontiamo noi stessi", cioè investiamo
una parte altrettanto importante delle nostre risorse a chiedere
riconoscimento, a domandare agli altri che confermino la nostra
costruzione di noi. … Esiste una circolarità tra i due aspetti: nel
costruire noi stessi attraverso i discorsi, identifichiamo degli
interlocutori cioè ci "raccontiamo agli altri". … In ogni caso, che
gli altri ci riconoscano o no, nel nostro raccontare storie noi
sempre "raccontiamo gli altri", ce li rappresentiamo e ci
costruiamo quell'immagine di loro che ci serve per stare in
relazione, una immagine congruente con quella rappresentazione
di noi stessi e della relazione che rende l'identità sostenibile per
noi (Melucci, 2001, 127). Per Hannah Arendt il "sé narrabile"
postula sempre l'altro come necessario, un "altro" che può essere
incarnato nel dialogo interiore ma soprattutto un altro da sé poiché
il significato dell'identità personale è sempre affidato al racconto
altrui.
Alla corte dei feaci Ulisse scopre il senso della propria storia
grazie al racconto dell'altro e ascoltando la propria storia si
commuove, il dolore acquista un significato, il proprio desiderio
di narrazione emerge nella sua umanità, evidenziando la sua
umanità. "Fra identità e narrazione… c'è infatti un tenace rapporto
di desiderio… Per questo, davanti all'inatteso realizzarsi del suo
desiderio di narrazione, Ulisse - alla corte dei feaci - piange. Il
racconto gli ha infatti svelato, all'un tempo la sua identità
narrabile e il suo desiderio di sentirla narrare…" (Cavarero 2001
p. 46)
Questo desiderio non è solo degli eroi ma è presente, troppo
spesso sottaciuto, in ognuno di noi e vede peraltro nel contesto
famigliare un ambito che consente di inserire le singole esistenze
in un tempo relazionale, condiviso, comune, storico, in continuo
divenire. "Poiché è proprio dicendo "noi" che paradossalmente,
possiamo arrivare ad affermare l'"io"…" (Formenti 2000)
Chiunque abbia vissuto separazioni dolorose sa quanto il non
poter dire più "noi" produca una mutilazione dell"io.
Diverse e fondamentali sono le funzioni del narrare, della
memoria famigliare: essa garantisce la continuità sia nel ricordare
che nell'obliare, connette alle proprie origini, coltiva la
riviviscenza, attiva la riflessività, produce retroazioni, genera
identità. "Senza narrazioni, senza storie non c'è famiglia", non c'è
individualità (Formenti 2002), esse costruiscono un ponte, un
orizzonte ermeneutico tra la concretezza del presente e le
dimensioni simboliche del passato, del futuro e dello stesso
presente in una costante relazione ricorsiva.
Nella contemporaneità gli spazi di narrazione famigliare si
contraggono sempre più trovando all'esterno contesti di
narrazione. Talvolta questi sono rappresentati dalle realtà sociosanitarie, terapeutiche, assistenziali, educative troppo spesso
parcellizzanti, centrate sull'oggetto, sul problema, sulla diagnosi,
sul bisogno percepito più che sulla domanda. Un ampliamento
(una maggiore o diversa qualificazione) dell'offerta di interventi a
favore della famiglia e della singola persona nell'area del sostegno
e della facilitazione (Formenti 2000) e quindi del counseling, e un
approccio multidiscilinare, potrebbero essere un utile strumento
di confronto, crescita, prevenzione e soprattutto benessere.
E' chiaro che l'assunzione di un approccio narrativo implica una
significativa rimessa in gioco professionale e personale da parte
dell'operatore psico, socio, educativo. L'attenzione alla propria
storia, il coltivare capacità autoriflessive, l'ascolto dell'altro-sé e
dell'altro-da-sé, (Previtali 1995), la cura del contesto, una
metodologia accorta, la tensione all'"utilità", al "bene", l'agire
pratiche antiopressive, l'adozione di pensieri deboli, capaci di
cambiamento rappresentano alcune coordinate dell'intervento
terapeutico, educativo, sociale e al contempo tratteggiano sfide
professionali ineludibili.
Nell'ambito della terapia famigliare negli ultimi anni diversi
contributi teorici hanno rimesso al centro dell'attenzione
l'approccio narrativo e le storie di vita. Per Michel White "le
34
persone conferiscono senso alla loro vita attraverso il racconto
delle proprie esperienze" (White 1992, pag. 20) e il contesto
terapeutico rappresenta uno dei possibili contesti nei quali le
persone possono decostruire e ricostruire nuove narrative.
Gianfranco Cecchin (1987) ricolloca i fondamentali concetti di
neutralità, ipotizzazione e circolarità all'interno di una cornice più
ampia, indicando la curiosità come forma mentis che apre alla
molteplicità, alla polifonia di storie ed è capace di abbandonare la
naturale pulsione di spiegare in termini scientifici, lineari, per
assumere una prospettiva estetica "basata sulla nozione che
ciascun sistema ha una sua logica. Questa logica non è né buona
né cattiva, né giusta né sbagliata… Poiché non conosciamo
ancora quale particolare copione avrà successo per quella
famiglia, non possiamo che interagire in un modo che forse
perturberà il sistema così che esso trovi da sé (o riscriva) il suo
copione" (Cecchin G. 1987 p. 34).
Implicitamente Cecchin riconosce alla famiglia l'essere l'unica
esperta di sé stessa, poiché essa sola può scrivere e riscrivere la
propria storia, accompagnata in questa ricerca narrativa dal
terapeuta che si colloca come l'"altro necessario" perché una o più
narrazioni emergano. Anderson e Goolishian, invece, mettono in
risalto l'aspetto dialogico della conversazione che "E' una ricerca
ed esplorazione congiunta attraverso il dialogo, uno scambio
bidirezionale, un intrecciarsi di idee in cui nuovi significati
emergono continuamente" (1998 p. 41).
La conversazione terapeutica implica così il parlare con l'altro e
non il parlare all'altro, implica il rinunciare ad una posizione
strategica dove le domande, la ricerca dei giochi nascosti, le
interpretazioni vengano messe da parte per lasciare spazio alle
narrazioni ai significati del cliente che "in tal modo può muoversi
liberamente nello spazio della conversazione, dato che non deve
più cercare di affermare e proteggere la propria visione del
mondo" (ivi p. 44).
In generale, l'ottica "narrativa" che ha esteso la "svolta"
linguistica avvenuta a partire soprattutto dagli anni '80 nelle
scienze sociali, prefigura il dialogo come il processo costitutivo
del sistema terapeutico. Un sistema che si costruisce attorno a
qualche "problema" e che, attraverso lo sviluppo di scambi
comunicativi, tende a creare nuovi significati che possano essere
utili alla dissoluzione del problema (Anderson H., Goolishian H.
1988). La posizione del terapeuta è resa da un atteggiamento di
ascolto, partecipazione e facilitazione del dialogo.
Partendo dalle premesse sociocostruzioniste sulla natura
linguistica delle forme sociali e sulla dimensione costruttiva degli
scambi comunicativi che generano linguaggio e significati,
l'approccio "narrativo" in campo terapeutico ha aperto uno
spiraglio che, utilizzando la terminologia di Pearce (1989),
potremmo definire di "eloquenza sociale", cioè un'intenzionalità
terapeutica orientata a mantenere aperta la conversazione e a
comporre e mantenere aperti contesti comunicativi anche tra
persone che "non si conoscono" e magari esprimono differenze
significative sul modo di intendere le relazioni, i problemi e la
vita in generale. Questa prospettiva ha significato uno
spostamento di attenzione verso la possibilità di creare spazi di
dialogo aperto, partecipato e libero da relazioni egemoniche e
direttive. L'impostazione e le punteggiature di tale prospettiva
riconfigurano costantemente l'incontro terapeutico in termini di
conversazioni tra persone "alla pari" non regolate da rapporti
asimmetrici e gerarchici. L'atteggiamento di "non sapere"
(Hoffman L. 1998) si è definito come un modo rispettoso e
responsabile di interpretare il ruolo di terapeuta
Riconoscendo ai sistemi umani una natura linguistica e quindi
costruttiva, molti terapeuti/studiosi si sono impegnati a essere utili
a tante persone nel costruire l'uscita da situazioni problematiche,
senza far ricorso a letture e prescrizioni ricavabili da un discorso
esperto che definisce regolarità e invarianze del disagio e dei
modi per uscirne.
I pregiudizi fanno parte delle storie?
Mentre l'approccio narrativo riconducibile a autori come Lynn
Hoffman, Harlene Anderson, Harold Goolishiam, Tom Andersen,
Michel White, Rwnos K. Papadopulos ha alimentato un interesse
crescente per la terapia come creazione di storie e una tensione
verso l'arte di non interferire con le proprie idee nella costruzione
delle storie da parte delle persone, l'approccio sviluppato dalla
"Scuola di Milano" ha elaborato l'idea dell'impossibilità di
"neutralizzare" il proprio punto di vista, individuando il "cuore"
della terapia proprio nella relazione tra pregiudizi della persona e
del terapeuta. Metaforicamente, la Scuola di Milano pone
l'attenzione sui "mattoni" che terapeuti e persone utilizzano per
co-costruire storie. I due approcci ci appaiono condividere
un'analoga intenzionalità: riconoscere i limiti del terapeuta e
rispettare la libertà delle persone.
La questione posta dalla nozione di "pregiudizi" corrisponde alla
necessità di riflettere sui nostri punti di vista e sul modo in cui
consideriamo quelli delle persone che con noi parlano. Troviamo
avvincente, a riguardo, il termine "pregiudizi" per indicare il
"punto di vista" di una persona. Siamo quindi riconoscenti a
Cecchin e coll. (1997) per averci suggerito questo modo
"intuitivo" (e come loro stessi lo qualificano, anche un po'
"irriverente"), di considerare la questione.
Troviamo una corrispondenza tra l'approccio di Cecchin e coll. e
la teoria di Pearce (1989) sulle forme di comunicazione. Cecchin
parla di pregiudizi in termini di opinioni, pensieri, valori,
convinzioni, emozioni da cui una persona, più o meno
consapevolmente, prende le mosse per tessere relazioni
comunicative; Pearce fa riferimento alle "risorse di senso" come
strutture di significato che contestualizzano e quindi rendono
possibile la comunicazione. Per entrambi, le regole costitutive
della comunicazione sono quelle dei significati portati dalle
persone in gioco e la questione del cambiamento è da ricondurre
alla "disponibilità" dei partecipanti a riconoscere come proprie (e
quindi non assolute) le costruzioni di significato a cui si fa
riferimento e a considerare come altrettanto plausibili quelle
dell'altro. In altre parole possiamo dire che in entrambi gli
approcci, le relazioni comunicative mettono in campo il punto di
vista dei partecipanti e si sviluppano in modo più o meno aperto
in base alla capacità dei dialoganti di scoprire insieme le
35
implicazioni dell'incontro di punti di vista differenti.
senso "medico", cioè atto a "riparare" qualcosa che non funziona
nei sistemi umani. Ma se è vero che le persone cercano di dare
senso all'esistenza e se è vero che il disagio è configurabile come
una perdita o un occultamento di questo senso, perché non
pensare anche a un'attinenza della terapia al campo filosofico?
Cosa possa significare dare una risposta positiva a questa
domanda non lo sappiamo bene. Pensiamo che questa idea più che
un nuovo modo di conversare con le persone, suggerisca da una
parte di tenere aperto nella conversazione un orizzonte di senso
che va al di là della lettura (sia pur sistemica) dei problemi attorno
ai quali si costruisce il contesto terapeutico e delle relazioni che
in esso avvengono; dall'altra di riconoscere la portata di "verità"
di esperienze conoscitive come quelle estetiche, letterarie e
filosofiche.
Ci sono storie e storie…
Un aspetto significativo del cambiamento che può avvenire nel
contesto di relazioni "terapeutiche" è espresso dal tema della
risonanza emotiva della conversazione. Si è detto che la
dimensione "narrativa" della terapia consiste nella possibilità di
far emergere le narrazioni delle persone e di dare loro la
possibilità di confrontarsi con altri copioni che ripunteggiano le
loro storie in modo diverso. Ma quali sono le "nuove narrazioni"
che producono cambiamento?
Gabriela Gaspari parla di "innesto nella situazione emotiva delle
persone". Non è tanto la "differenza" della narrazione con cui la
persona si confronta che può innescare il cambiamento, quanto la
possibilità che questa "differenza" sia percepita dalla persona
come potenzialmente utile e significativa in relazione al suo modo
di vivere e intendere il "problema", divenendo così "una
differenza che dà la differenza". Per molti aspetti, ciò che si può
innestare nella situazione emotiva delle persone non è
prevedibile; per questo diventa importante accorgersi, nel dialogo
in essere, quali siano le parti della conversazione che colpiscono
e possono generare una ridefinizione. Costruire questa capacità di
individuazione richiede esperienza, ma soprattutto curiosità e
apertura. Se, durante la conversazione, ci si costruisce copioni
alternativi ma rigidi e si rimane ligi ad essi, difficilmente ci si
accorge di eventuali sfumature che indicano l'interesse delle
persone verso direzioni o punteggiature diverse.
Pain -expand the time
Ages coil within
The minute Circumference
Or a single Brain
Pain expand - the Time Occupied with Shot
Gammuts of Eternities
Are as they where not
E. Dickinson
(Il dolore allunga il tempo
Aggomitola secoli all'interno
Della circonferenza irrilevante
Di un singolo cervello
Il dolore abbrevia il tempo
Schiantate da uno sparo
Scale di eternità
Come mai esiste)
Filosofia e dintorni
In questo paragrafo vorremmo solo accennare alla possibilità di
leggere la conversazione terapeutica o almeno alcuni momenti di
essa in termini di colloquio filosofico.
Metaforicamente parlando, filosofare significa affrontare ad occhi
aperti il proprio destino; significa auto-domandarsi, trovare sé
stessi, interrogare l'esistenza e accorgerci che stiamo esistendo.
Nella pratica come counselor, ma molto più nel corso della nostra
esistenza ci siamo sentiti soli di fronte agli interrogativi
dell'esistere, del dolore, della vita e della morte, dell'ingiustizia.
Scoprire a volte nella filosofia, nella letteratura e nell'arte gli
stessi interrogativi ci ha aiutati, a volte, se non a superare questi
sentimenti (forse non ha nemmeno senso parlare di superamento),
a sentire di appartenere a un'umanità che in ciò si accomuna. E
allora se la filosofia, l'arte e la letteratura hanno aiutato noi a
sentire che i nostri interrogativi, i nostri disagi non erano solo
nostri e che perciò stesso potevano farsi sentire meno gravosi e
più carichi si significato (perché altri ancor meglio di noi erano
riusciti a, esprimerli) allora ci chiediamo se in un contesto
terapeutico non abbia senso provare ad esplorare strade che
portino a connette la riflessione "terapeutica" con la riflessione
"filosofica".
L'idea del "colloquio filosofico" ci è stata suggerita da Pietro
Barbetta. Il contesto della riflessione era l'attinenza della
"psicoterapia" a un campo più vasto. Sono molti a ritenere che
l'ambito terapeutico sia un ambito "clinico" e quindi, in un certo
3. Ascoltare persone? Ascoltare linguaggi?
"L'altro è sempre un sé narrabile a prescindere dal testo… Pur
essendo immerso in questo racconto, il sé narrabile non è
comunque il prodotto della storia di vita che la memoria gli
racconta … non è una costruzione del testo…Esso coincide
piuttosto con l'impadroneggiabile pulsione narrativa della
memoria che produce il testo e nel testo medesimo lo cattura..
L'effetto di una storia di vita … consiste sempre in una
reificazione del sé che cristallizza l'imprevedibilità dell'esistente"
(Cavarero 2001)
"Noi vorremmo riflettere sul linguaggio e soltanto su di esso. Il
linguaggio è linguaggio e nient'altro. Il linguaggio è il
linguaggio. L'intelletto educato alla logica, uso a tutto sottoporre
il processo calcolante, e perciò appunto il più delle volte
presuntuoso, chiama questa proposizione una vuota tautologia.
Dire due volte nient'altro che la stessa cosa: linguaggio è
linguaggio, come è possibile che questo ci porti avanti? Ma noi
non vogliamo andare avanti. Vorremmo soltanto ci fosse dato di
36
giungere là dove già siamo.
Per questo facciamo oggetto di riflessione la domanda: che si
deve dire intorno al linguaggio? Per questo chiediamo: in che
modo è e opera il linguaggio come linguaggio? Rispondiamo: il
linguaggio parla.."
(Heidegger 1959)
significati usati a tutte queste cose; poter separare l'immagine
che le cose hanno in sé dall'immagine che è stata loro imposta.
Poter scorgere nella pescivendola la sua realtà umana a
prescindere dal fatto che sia chiamata pescivendola, e dal sapere
che esiste e che vende. Guardare un vigile urbano come lo guarda
dio. Capire tutto per la prima volta non in modo apocalittico,
come se fosse una rivelazione del Mistero, ma direttamente, come
una fioritura della realtà." (Pessoa 2001)
In questo paragrafo, vorremmo semplicemente "ricordarci" del
linguaggio e "ricordarci" che ne facciamo esperienza nel contesto
di relazioni umane.
Si potrebbe dire che ascoltiamo e parliamo con persone, ma ciò
che c'è dato di sentire e dire è il linguaggio. Ascoltare e parlare ha
quindi una duplice faccia. Da una parte l'essere rivolti verso
qualcuno, dall'altra produrre e sottoporre alla nostra attenzione un
testo, una narrazione. Guardando la prima faccia possiamo vedere
il riflesso del "coinvolgimento umano" che la relazione
terapeutica evoca in sé; guardando l'altra s'intravede la possibilità
di "prendere le distanze" da chi narra per concentrarsi ciò che è
narrato.
E' possibile specchiarsi contemporaneamente nelle due facce? E'
possibile "avvicinarsi" alle persone alla ricerca di un'empatia e
nello spesso tempo "allontanarsi" da loro per cogliere ciò che il
loro parlare racconta?
Nel campo della terapia familiare, l'approccio non direttivo e
l'approccio ermeneutico sembrano tradurre questi due riflessi.
Due approcci che non si escludono a vicenda, anzi costituiscono
forse l'uno la condizione per l'altro. Avvicinandoci emotivamente
in modo paritario alle persone, partendo dalla consapevolezza di
"non sapere" (Anderson H. e Goolishiam H. 1998) costruiamo
possibilità di meglio comprendere ciò che ci raccontano;
permanendo nel dominio di ciò che è detto costruiamo possibilità
di riconoscere a noi stessi e all'altro capacità e libertà di costruire
e cambiare.
Siamo propensi a ritenere che la predisposizione all'ascolto è
forse la maggiore possibilità di "specchiarsi" in entrambe le facce,
a ritenere cioè fondamentale l'ascolto nel counseling come nella
terapia. Un ascolto empatico, partecipativo, curioso, ermeneutico,
ma non interpretativo nel senso tradizionale del termine che vede
cioè l'esperto come colui che solo possiede chiavi di volta. Non è
forse casuale che il significato del termine "interpretazione" trovi
la propria origine in colui che interpreta il volere degli dei, nel
sacerdote, nel profeta, trasformato nella modernità in esperto.
In questo nostro lavoro vogliamo dedicare uno spazio al tema del
potere, non del potere all'interno delle relazioni famigliari ma di
come il potere possa essere esercitato all'interno del contesto
terapeutico o di counseling, di come taluni pratiche possano
contribuire a riprodurre situazioni di dominio e sottomissione, e
soprattutto desideriamo evidenziare alcuni contributi che in questi
anni hanno cercato di porre all'attenzione le "pratiche
antiopressive".
I fautori dell'approccio narrativo hanno introdotto una importante
riflessione sul "colonialismo della salute mentale" (Hoffman L.
1998). L'idea di colonialismo si riferisce alla mentalità di
terapeuti e studiosi che, mossi dall'idea di una scienza sociale
"oggettiva", hanno costruito discorsi che stabiliscono "a priori"
quali siano i modi, gli argomenti e le persone da considerare in
terapia. Ciò che ne è derivato è, metaforicamente, un modello di
terapia "dall'alto in basso".
A riguardo, gli studi di Michel Foucault (1969, 1971) sono stati
un riferimento perché, in un certo senso, svelano da quale
"potere" derivino le "posizioni di potere". Le sue tesi sulla forza
che i discorsi hanno nell'esercitare una funzione concreta nella
storia delle idee, delle istituzioni e delle persone hanno
delegittimato la visione "oggettiva" della patologia e delle
pratiche attuabili e hanno spiegato come i presupposti di tale
visione abbiano radici nella storia della cultura e siano in
relazione con l'esercizio del potere.
Foucault analizza il potere positivo che caratterizza le società
occidentali. Positivo non in senso morale ma in quanto usa la
"realtà" per assoggettare le persone a "verità" normalizzanti
inscritte in una logica di potere
"Dobbiamo smettere una volta per tutte di descrivere gli effetti del
potere in termini negativi: 'esclude', 'reprime', 'censura',
'maschera', 'nasconde'. Di fatto il potere produce, produce realtà;
produce interi settori di oggetti e rituali di verità. L'individuo e il
sapere che può essere da lui conquistato appartengono a questa
produzione" (Foucault in White 1992 p. 65).
In ambito sistemico un fondamentale contributo al tema del
potere ci deriva da Bateson che propose il termine schismogenesi
definito come: "processo di differenziazione nelle norme di
comportamento individuale risultante dall'interazione cumulata
tra individui"(Bateson in Hoffman1972 p. 47). Questo processo
genera due schemi di relazione reciproca definiti complementare
e simmetrico. Bateson ascrive la schismogenesi simmetrica a
"tutti quei casi in cui gli individui di due gruppi hanno le stesse
aspirazioni e le stesse strutture di comportamento, ma sono
differenziati quanto all'orientazione di queste strutture" (ivi p. ).
4. Narrazioni "forti" e narrazioni "deboli"
" Coloro cui sfugge completamente l'idea che è possibile aver
torto non possono imparare nulla, se non la tecnica" (Bateson
1984)
"Come vorrei, lo sento in questo momento, essere una persona
che fosse capace di vedere tutto questo come se non avesse con
esso altro rapporto se non vederlo: contemplare le cose come se
io fossi il viaggiatore adulto arrivato oggi alla superficie della
vita! Non avere imparato fino dalla nascita ad attribuire
37
Relazione complementare e relazione simmetrica descrivono
relazioni di potere, non a caso l'uso della metafora one-up/onedown dichiara l'implicita dimensione di forza non
necessariamente sempre agita dall'alto verso il basso.
Seguendo le prospettive accennate, ogni pratica sociale,
educativa, terapeutica è esposta al rischio di essere pratica
coloniale, cioè una pratica verticale dall'altro al basso. E allora, la
capacità di analizzare i propri presupposti teorici, di attuare
pratiche sociali riflessive (Pakman 1998), ci consente di
individuare azioni di dominio-sottomissione implicite nel
contesto e nei discorsi che caratterizzano la relazione terapeutica.
Una domanda che a questo punto possiamo porci è: quali forme
può assumere il potere o il "non potere" nelle relazioni
terapeutiche? A noi sembra che un confronto tra approccio
strategico e approccio ermeneutico possa chiarire un po' la
questione.
Adottare un approccio strategico significa sostanzialmente
orientarsi verso la scoperta dei giochi e della "struttura" delle
famiglie e delle persone, al fine di individuare e
attuare/prescrivere ciò che porta una situazione problematica al
cambiamento. L'interpretazione diagnostica e prescrittiva non può
che basarsi su modelli predefiniti del funzionamento
normale/patologico dei sistemi umani. Un terapeuta potrà poi
avere una visione più o meno flessibile e sistemica, ma la sua
lettura della situazione si basa comunque su discorsi che ne
definiscono "a priori" i confini. Il potere da parte del terapeuta
consiste, in questo caso, nel padroneggiare in modo esclusivo il
dominio dei discorsi su cui la relazione va strutturandosi. Adottare
un approccio ermeneutico significa invece andare alla scoperta
dei significati e del senso della vita delle persone. Un senso che
emerge attraverso la narrazione della propria storia o meglio
attraverso le narrazioni. Se come dice la Cavarero (2001) noi
siamo "sé narrabili", la narrazione di noi stessi è ciò che ci
restituisce il senso della nostra storia. In quest'ottica il contesto
terapeutico diviene uno dei possibili contesti nei quali questa
storia può trovare uno spazio di narrazione, a condizione che il
terapeuta lasci spazio al sé narrabile. In questo caso, lasciare
spazio alla narrazione si configura come una pratica di "non
potere", attraverso la costruzione di un contesto nel quale il "sé
narrante" (ovvero il sapere di essere una storia) trova spazio e può
trasformarsi in un "sé narrante autobiografico ".
Il senso autobiografico risiede soprattutto nel fatto che è il
protagonista a narrare le proprie storie, in un contesto relazionale
nel quale il terapeuta è invitato a non proporre narrazioni forti che
rischierebbero di trasformare l'"autobiografia" in "biografia".
Bateson con il linguaggio che lo caratterizza ci porge un monito:
"Infrangete la struttura che connette gli elementi di ciò che si
apprende e distruggerete necessariamente ogni qualità" (Bateson
1984 pag. 21). E la qualità di un individuo è il proprio essere una
storia unica di vita, l'essere sé narranti.
Nonostante i recenti contributi teorici che hanno messo al centro
dell'attenzione il pensiero debole, l'immagine dell'esperto
depositario di sapere, di chiavi interpretative, di tecniche e
metodologie che pretendono e presumono l'esistenza di "menti
incorporee" strappate da una corporeità (Pakman 1998), resta
forte. Il pregiudizio dell'esistenza di una scissione mente/corpo,
che vede le proprie origini nel pensiero Platonico e il proprio
apice nel positivismo ereditato dal pensiero moderno, rappresenta
un'idea di quest'immagine dell' "esperto".
E' in un contesto di dominanza del pensiero razionalistico che
psicologia e pedagogia, per strappare lo status di scienza, si sono
a lungo fossilizzate alla ricerca di metodologie, tecniche,
fondamenti scientifici, perdendo di vista le dimensioni
teleologiche e axiologiche. Come sostiene Pakman, (1998)
l'attaccamento a astratte nozioni di classe sociale e una pratica
terapeutica come processo tra menti incorporee consentono e
favoriscono "l'instaurarsi della cecità e della razionalizzazione nei
confronti dell'ineguaglianza sociale" Questa dominanza,
unitamente all'implicita presunzione etnocentrica di sapere come
va vissuta una vita, rischia di condurre il terapeuta e in generale
gli operatori sociali su un terreno definibile in termini di "abuso
di potere"; intendendo quest'ultimo come possibilità di "definire
unilateralmente ciò che è da considerare come "reale" in un certo
contesto per tutti i partecipanti" (Pakman1998 p. 37). Un terreno
ove le tecniche rischiamo di trasformarsi in tecnicismo, se non
accompagnate da una teleologia e da una axiologia che orienti e
dia senso all'agire professionale; dove le diagnosi reificano la
persona nella patologia, dove anche una psicoterapia o un
counseling che non sanno recuperare un pensare filosofico
rischiano di non leggere l'inquietudine, il disagio, il dolore, se non
in chiave intrapsichica. Andare oltre una lettura prettamente
individualistica significa in questo senso riconoscere le istanze, le
angosce, che ci accomunano in quanto abitatori della
contemporaneità; significa recuperare una "pratica sociale
critica", che riconosca e si soffermi ad analizzare i processi di
costruzione delle situazioni di potere e privilegio, anche
all'interno di contesti sociali e terapeutici; significa attivare una
pratica riflessiva che nulla dà per scontato.
Se riflettiamo sulla nostra esperienza professionale in campo
sociale e educativo e come counselor, possiamo faticosamente
constatare come spesso utilizziamo le tecniche, le metodologie, i
gerghi professionali come strumenti di autolegittimazione e di
presa di distanza da storie, persone, dolori che facciamo fatica ad
avvicinare o che temiamo; come strumenti di potere a sostegno di
professioni che percepiamo come socialmente "deboli" (poco
riconosciute). E' necessario un po' di "coraggio" professionale e
senz'altro personale, per accantonare un apparato tecnologico e
rimettere al centro la "debolezza" come risorsa, per essere
consapevoli e responsabili delle nostre "Teorie in uso". Esse
inevitabilmente contengono un'idea di uomo e di donna, un'idea
di come va vissuta una vita e quindi rischiano di imporre la nostra
visione della "realtà" se non le assoggettiamo a pratiche riflessive
critiche.
E allora quali sono le possibili strade? Ci sembrano
particolarmente significativi l'approccio narrativo (di cui abbiamo
parlato) e una sorta di recupero di un pensare "filosofico",
"politico". S. Kraemer, (1999) nel suo contributo in "Voci
multiple", sostiene che la terapia non è un intervento sociale se
38
non in senso molto lato, collocando i bisogni delle persone che
richiedono una terapia nell'ambito della sfera personale quasi
contrapponendola a quella politica.
Forse vale la pena richiamare il concetto aristotelico di politica
come scienza orientata al bene, il cui fine ultimo è rappresentato
dal raggiungimento dell'eudaimonia, della felicità. Se intese in tal
senso, allora anche il counseling e la terapia famigliare come
"pratiche sociali" finalizzate al benessere non possono discostarsi,
seppure con le proprie specificità, da un agire politico. Se
possiamo in parte concordare che le persone "non vengono da noi
per sanare le ingiustizie del mondo politico" (1999 Kraemer in R.
K. Papadopulos, J. Byng-Hall p. 59), esse tuttavia non vivono nel
vuoto sociale; si può anzi dire con Aristotele che l'uomo è animale
politico e che "le identità … sono anche inscritte nelle relazioni di
status e di potere …" (1999C. Burck in R. K. Papadopulos, J.
Byng-Hall p.71). Lo stesso Campbell, poche pagine prima
dell'intervento di Kraemer ce lo ricorda, quando accenna alla
fatica di armonizzare il proprio intervento nel caso di famiglie
operaie, "il cui linguaggio e le cui aspettative sono più distanti da
quelle del terapeuta" (1999 Campbell in R. K. Papadopulos, J.
Byng-Hall p. 19). Più avanti, Anne McFayden ci dice che "il
contesto della "persona" rispecchia l'individualità della singola
narrazione ma si riferisce anche ai legami che vengono stabiliti tra
livelli diversi di significato. Per esempio, le vedute etiche,
politiche o religiose di una persona forniscono un contesto ma
nello stesso tempo fanno parte di lei a un livello molto personale,
cioè sono quella persona" (1999 A. McFayden in R. K.
Papadopulos, J. Byng-Hall p. 160).
termine "riflessivo" si espande, divenendo non solo una modalità
del porre domande ma caratteristica della stessa relazione clienteterapeuta. Hoffman propone l'immagine del numero 8, "segno
dell'infinito - (dove) c'è spazio per il dialogo interno di ogni
individuo e un'intersezione che rappresenta la piazza in cui
incontrarsi e parlare (Hoffman 1981)".
Lynn Hoffman lascia intendere come la manifestazione di
emozioni e aspetti autobiografici abbiano rappresentato per lei un
importante passaggio verso un nuovo modo di essere in relazione
con l'altro, dove la verticalità insita nella relazione d'aiuto viene
compensata dall'orizzontalità esistenziale. Salvador Minuchin
(1974) rimarca invece la biografia come esperienza di vita, come
la condizione necessaria per "potersi permettere di", in qualche
modo riprendendo l'antica figura del saggio come colui che sa
orientare la propria scelta nell'ambito dell'opportuno, non del
vero, del plausibile e non dell'incontrovertibile" (Natoli 1990 p.
11). Pakman, invece, riconnette la dimensione tecnicoprofessionale con la dimensione biografica introducendo il
concetto di "Teorie in uso" come prodotto di contaminazione
(sintesi) di thecnos e biografia..
Se si accetta l'idea che la professionalità di un operatore sociale è
rappresentata sia dalla dimensione tecnica sia dalla dimensione
personale, allora la biografia rappresenta uno strumento di lavoro,
una risorsa potenzialmente utile. Certo è difficile, in un contesto
scientifico incline al pensiero razionale, dare legittimità a una
dimensione, quella personale, che viene comunemente
interpretata come "privata", come "interiore", e che in taluni casi
viene connotata come negativa ("Per essere professionali, il
privato va lasciato fuori dalla porta"). Eppure è proprio in questa
dimensione, che definiremmo biografica più che privata, che
possiamo rintracciare le radici di ragioni, valori, forme,
"sensibilità", stili, vicinanze e lontananze che caratterizzano la
nostra pratica professionale. Le rare volte nelle quali ci siamo
sentiti dire dai nostri clienti, utenti, allievi che si sentivano
compresi, erano anche le volte nelle quali la loro narrazione
risuonava profondamente in noi; erano le volte nelle quali, come
Gurdulù, ci sentivamo immigrati, matti, devianti, marginali,
separati, violati, figli incompresi, genitori apprensivi …
I dubbi che hanno preceduto queste parole, la fatica a trovare un
linguaggi adatto, la necessità di definire dentro di noi i confini
accettabili di ciò che andremo dicendo, è la cifra della mancata
consuetudine a parlare di noi e della frequentazione di un pensiero
e di una certa letteratura psico-educativa che si muovono su un
terreno "modernista" e che abbiamo abitato nel corso della nostra
formazione e pratica come operatori sociali. Eppure,
recentemente, abbiamo scoperto come sia possibile in un testo
scrivere di scienza e di sé al contempo, come il lavoro
sociale/educativo/terapeutico necessiti di questa sintesi per
acquisire pregnanza ed incisività, poiché ognuno di noi, tutti noi,
siamo "gesti carichi di responsabilità" (Erbetta 2001).
Ebbene, è con questa fatica che ci accingiamo a fare, a due mani,
questo tentativo di ricerca e esplicitazione degli elementi
autobiografici che ci accomunano, poiché riteniamo che la nostra
professionalità, ma soprattutto il nostro essere esistenze, abbia un
5. La dimensione autobiografica dell'operatore
Nel corso di questo lavoro abbiamo più volte detto che il terapeuta
e, in generale, ogni operatore sociale non è un osservatore esterno
al contesto, bensì esso fa parte integrante del sistema nel quale
opera, all'interno del quale è portatore non solo di conoscenze
teoriche, ma di "Teorie in uso", che sono intimamente legate alla
sua biografia.
Vogliamo accennare brevemente ad alcuni terapeuti che hanno
introdotto la dimensione biografica nel loro lavoro clinico,
partendo da Lynn Hoffman che introduce nella terapia familiare la
propria biografia, le proprie emozioni, come forma di
superamento di ciò che lei stessa definisce "la freddezza
tecnocratica" dell'approccio sistemico. "Mostravo le mie
emozioni, fino, talvolta, al pianto. Chiamavo questo mio modo di
lavorare "terapia sentimentale"…cominciai a cercare nuove
strade per far sentire i clienti a proprio agio. Quando era il caso
raccontavo loro storie della mia vita… se mi sentivo in difficoltà,
specialmente se qualche mio problema personale sembrava
intrufolarsi nel percorso comune, ne parlavo apertamente, e
spesso ottenendo buoni risultati"(Hoffman 19921 p.29).
In qualche modo Hoffman modifica una relazione clienteterapeuta da una relazione gerarchica verticale ad una relazione
orizzontale, trasformando la terapia in un'esperienza dialogica
partecipativa dove il termine "esperto" viene completamente
annullato o quantomeno sostanzialmente ricollocato. Anche il
39
senso se collocato in un vivere appassionato in un progettarsi
accorto.
Cosa, nella nostra esistenza ci ha condotto ad essere qui, a cercare
di "essere utili " agli altri, e in che modo la nostra biografia
rappresenta una risorsa? In che modo si esplica questo comprendere, questo prendere l'altro dentro di sé? L'infanzia, periodo
di vita rappresentato come età del gioco, dell'irresponsabilità della
leggerezza, ha significato per noi, in misura e con specificità
diverse, una fase di vita a contatto con le fatiche e in un certo
senso con il dolore. Una fase assoggettata dal potere positivo di
cui Foucault (1969, 1971) parla: "Nulla è più materiale, nulla è
più fisico, più corporeo dell'esercizio del potere" (Foucault, in
Natoli 1990 p. 84). Un potere dei servizi, della scuola, dei precetti
familiari, un potere che interna, un potere che si esercita sul corpo
(nella sua globalità corpo-mente) poiché "dispone del senso della
vita e della morte" (Natoli 1990 p. 68), di ciò che è "reale" e di ciò
che non lo è, di come va vissuta una vita.
La concreta esperienza del potere, si incontra nella nostra
giovinezza, in un epoca che ancor vive l'onda lunga di un
movimento giovanile e operaio che fa dello smascheramento e
abbattimento del potere l'obiettivo della propria lotta. E' in quegli
ambiti, nazionali ed internazionali - dove viviamo l'esperienza del
"viaggio iniziatico" (Dallari) - che finalmente intravediamo uno
spazio di condivisione di istanze morali, etiche, politiche,
assaggiate precedentemente.
Una giovinezza vissuta alla ricerca dell'autenticità esistenziale, di
moralità assoluta, di fedeltà a noi stessi; di viaggi reali e
immaginari; spazio nel quale diventare quel che si è piuttosto che
quello che il mondo ci impone di essere. Paul Nizan , archetipo di
giovinezza esistenziale, interpreta in modo esemplare la fatica
dell'essere giovani e idealisti. "Avevo vent'anni. Non permetterò a
nessuno di dire che questa è la più bella età della vita. Tutto
congiura a mandare il giovane in rovina: l'amore, le idee, la
perdita della famiglia, l'ingresso tra gli adulti. E' duro imparare la
propria parte nel mondo". (Nizan 1931, p. 5)
Una giovinezza, la nostra, vissuta all'insegna di un intransigenza
che non accetta mediazioni. Tuttavia essa non è stata, o almeno
non completamente, una giovinezza passata dietro i banchi di
scuola, al contrario essa guardava questi banchi, questi studenti
diligenti come qualcosa di lontano nel loro privilegio, eppure
vicino nel comune vivere la giovinezza in modo appassionato, nel
rifiuto a candidarsi ad un vita da quarantenni soddisfatti, nel
rifiuto di vivere un'"esistenza da larve a balia in attesa di diventare
insetti cinquantenni" (Nizan, 1931), nel rifiuto di vedere nella
maturità una meta. Gallerano direbbe che ciò che in quell'epoca
accomuna il giovane proletario con lo studente borghese è il
comune appartenere a quella che venne definita da Simone Weil
la condizione giovanile.
Ci prendevamo sin troppo sul serio, Boine direbbe che
conoscevamo le leggi e non i casi, le regole e non le eccezioni. E
nel vedere oggi questa nostra intransigenza giovanile
riconosciamo che forse Boine aveva in qualche modo ragione
quando diceva che i giovani sono più vecchi dei vecchi:
"…guarda più a fondo e ti parran più presso al nulla che all'essere,
più presso la morte, perché l'essenza è il nulla se non è corposa di
caso. (E perciò tu vedi così spesso un giovane passar di colpo
dalle idealità affermate alle imbrogliate brutture della cotidiana
vita; vedi così spesso i giovani scordarsi d'un tratto, come se un
soffio solo di vento avesse bastato a spazzarli, a sgombrarli della
dorata nebbia. E perciò ancora i migliori, i più delicati, finiscono
così spesso invece che nell'azione, nel sogno. Confinano,
chiudono, sperdono come disgustati le aspirazioni intime loro in
una specie di perfezione conventuale. Perché l'aspirazione dei
giovani è molto vicina all'irrealtà, alla povertà del sognare). E son
essi i giovani, dunque, i vecchi davvero, son essi i morituri e gli
astratti. Non sanno il peccato: han la purità della morte, non la
purità della vita" (Boine in Erbetta p. 49). Tuttavia, la giovinezza
ha rappresentato per noi e per molti altri la fase di ricerca di
un'autenticità esistenziale. "Archetipo di una moralità che tanto
più esperisce la propria libertà quanto più si avvicina al
sentimento tragico della vita…". (Erbetta 2001 p. 113)
Giovinezza come fase fondamentale della vita, nella quale
abbiamo esperito la fatica di imparare il mestiere di vivere, di
gestire la totale libertà e la responsabilità a cui ci sentivamo
chiamati. Che cosa ne abbiamo fatto della nostra giovinezza? E'
questo l'interrogativo che a volte ci poniamo e al quale è difficile
rispondere, tanto più che ad interrogarci è la nostra stessa
intransigente giovinezza.
Ora, per noi la "maturità" rappresenta il momento di messa alla
prova, innanzi tutto nel mantenere viva la nostra immaturità, la
nostra capacità di sognare, di emozionarci, di vivere
appassionatamente. Maturità per noi significa anche costruire
"situazioni privilegiate" nelle quali sentire che stiamo esistendo,
che siamo esseri-nel-mondo ed esseri-con-gli-altri, significa
"plonger les mains dans la merd e dans le sang", significa fare i
conti con il dio che presumevamo di essere. E' a partire da quanto
sinora detto che si comprende come, nella nostra maturità, la
professione che ci siamo scelti rappresenti uno dei contesti nei
quali vorremmo costruire "situazioni privilegiate", nel quale la
nostra biografia, oltre che la nostra competenza tecnica, divenga
una risorsa. A condizione che, come don Chisciotte, sappiamo
inseguire i nostri sogni con coraggio. Serve coraggio per
emozionarsi, serve coraggio per vivere appassionatamente, serve
coraggio per com-prendere l'altro, serve coraggio per farsi comprendere, serve coraggio per sporcarsi le mani, serve coraggio per
rischiare di divenire strumenti di un potere positivo, serve
coraggio per amare non le persone ma quell'uomo, quella donna,
serve coraggio per vivere con giustizia, servono coraggio e
responsabilità per vivere.
Certo quello di vivere è un "mestiere difficile" e spesso, troppo
spesso, nonostante gli sforzi, ci lasciamo vivere, trasformandoci
in "insetti quarantenni". (Nizan 1931) E allora chiederci che cosa
ne abbiamo fatto della nostra giovinezza risveglia in noi l'energia
la capacità di recuperare quell'istanza di idealità e di eticità. Ci
rendiamo conto di aver toccato dimensioni "macro biografiche",
non avrebbe d'altronde potuto essere altrimenti essendo un lavoro
a due mani, tuttavia riteniamo importante esserci presi questo
spazio.
40
Bibliografia
Andersen, T. (1992) Riflessioni sul riflettere con le famiglie; in La terapia come costruzione sociale. a cura di McNamee S..,
Gergen K. Tr.it.Franco Angeli, Milano
Barbetta, P. (1990) Ermeneutica e cibernetica del second'ordine: lineamenti teorici per una ridefinizione della terapia relazionale. Il
Bollettino N° 21 Centro Milanese di Terapia della Famiglia 1990
Bateson,G. (1972) Verso un'ecologia della mente; Tr.it Adelphi, Milano, 1976
Bateson, G. (1979) Mente e natura. Tr.it Adelphi, Milano, 1984
Campbell D L'altra faccia della storia L'esperienza terapeutica dell'assistito; in Voci multiple : la narrazione nella psicoterapia
sistemica famigliare; a cura di Papadopulos R. K., Byng Hall J., Mondatori, Milano 1999
Cavarero A. (2001) Tu che mi guardi tu che mi racconti: filosofia della narrazione; Feltrinelli, Milano
Cecchin (1987) Revisione dei concetti di ipotizzazione, circolarità e neutralità. Un invito alla curiosità trad. da Family Process
volume 26 dicembre
Cecchin G., Lane G., Ray W. A. (1997) - Verità e pregiudizi. Un approccio sistemico alla psicoterapia; Cortina Editore, Milano
Demetrio D (2000) L'educazione interiore - introduzione alla pedagogia introspettiva;. La nuova Italia, Milano
Erbetta A. (2001) Il tempo della giovinezza; La nuova Italia - Enciclopaidea Milano
Formenti L. (2002) La famiglia si racconta. La trasmissione dell'identità di genere tra le generazioni, San Paolo, Milano
Formenti L. (2000) Pedagogia della famiglia, Guerini Studio, Milano
Foucault M. (1969) L'archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969: tr.it. L'archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1971
Foucault M. (1971) L'ordre du discours, Gallimard, Paris 1971; tr.it. L'ordine del discorso, in Il discorso, la storia, la verità; Rizzoli
Milano 2001
Anderson H. e Goolishiam H. (1998) Il cliente è l'esperto: il non sapere come approccio terapeutico; in La terapia come
costruzione sociale; a cura di S. McNamee, K. Gergen Tr.it Franco Angeli, Milano
Harlene Anderson e Harold Goolishian (1988) Human Systems as Linguistic Systems: Preliminary and Evolving Ideas about the
Implications for Clinical Theory; in Family Process vol 27. N4; tr.it, I sistemi umani come sistemi linguistici: implicazioni per una
teoria clinica, Connessioni, 1992
Heidegger M. (1959) In cammino verso il linguaggio trad. it. di Caracciolo A e Caracciolo Perotti M., Tr.it. Mursia, Milano, 1973
Hoffman L.(1981) Principi di terapia della famiglia, Tr.it Astrolabio, Roma 1981
Hoffman L.(1992) Un ottica riflessiva per la terapia famigliare in La terapia come costruzione sociale, a cura di S. McNamee, K.
Gergen, Tr.it., Franco Angeli 1998
Kraemer S.(1999) Quale narrazione; in Voci multiple : la narrazione nella psicoterapia sistemica famgliare; a cura di Papadopulos
R. K., Byng Hall J. Mondatori, Milano
McFayden A. (1999) Alla ricerca del senso nell'esperienza dell'assistenza neonatale intensiva; in Voci multiple : la narrazione nella
psicoterapia sistemica famgliare; a cura di Papadopulos R. K., Byng Hall J. Mondatori, Milano
Melucci A. (2001) Su raccontar storie e storie di storie, in Chiaretti G., Rampazi M., Sebastiani C. (a cura di) Conversazioni, storie,
discorsi, Carocci
Minuchin S. (1974) Families and Family Therapy, Trad Ital. Famiglie e terapia della famiglia. Astrolabio, Roma, 1976.
Natoli S. (1990) Vita buona vita felice - scritti di etica e politica, Feltrinelli, Milano
Nizan P. Y. (1931) Aden Arabie; tr. It. Aden Arabia, Mondatori 1996, Milano
Pakman M. (1998) Educazione e terapia ai confini culturali - un esortazione ai processi sociali critici nei servizi umani, in
Pluriverso n° 3 1998
Pakman M. (1997) La micro-politica delle classi sociali nella vita famigliare, in Connessioni
Pearce (1989) Comunication and human condition; tr. It Comunicazione e condizione umana, Franco Angeli 1993 Milano
Pessoa F. (2001) Il libro dell'inquietudine di Bernardo Soares Feltrinelli, Milano
White M. (1992) La terapia come narrazione: proposte cliniche, Astrolabio, Roma
41
Quale fine per la ricerca etnografica?
Alcune osservazioni suscitate dalla lettura di "Itinerari di pre-comprensioni
tra narrazione e riflessività"
di Michele Parodi
consente di individuare azioni di dominio-sottomissione implicite
nel contesto e nei discorsi che caratterizzano la relazione
terapeutica".
Ciò che conta, come è ben noto, non è raggiungere una
impossibile conoscenza "autentica" del punto di vista nativo, non
compromessa dal contatto, ma è invece, a mio parere, conoscere,
attraverso l'interazione dialogica dell'orizzonte culturale del
ricercatore e dei suoi interlocutori, qualcosa dei modi in cui tali
orizzonti, incontrandosi, possono affrontare i reciproci vincoli
ideologici, vincoli che resistono ai desideri e alle sofferenze che
le proprie esistenze esprimono senza ricevere il sollievo di un
ascolto e di una parola capace di configurare prospettive utopiche.
In questo senso l'attività etnografica può essere considerata
"terapeutica". Non certo in quanto ricerca di modi culturali
"disfunzionali", ma piuttosto in quanto "costruzione delle
possibilità per le persone di crearsi liberamente altri copioni
narrativi per raccontare e raccontarsi".
La dimensione conoscitiva dell'antropologia, lo studio
etnografico dei "tratti culturali", delle dinamiche sociali, e persino
l'analisi delle strutture economiche e delle contraddizioni interne
o globali delle società dei propri interlocutori, deve essere
subordinata ad una seria riflessione sugli effetti, sul campo e
altrove, della propria attività di ricerca. Se gli obiettivi
dell'antropologo sono in contrasto con gli obiettivi nativi questo
fatto può essere problematizzato, può costituire il punto di
partenza di un processo di negoziazione che deve avere come
sfondo un impegno responsabile e cosciente del proprio ruolo,
della propria posizione e delle sue conseguenze. Lo stesso oggetto
della ricerca può essere patteggiato sul campo. L'antropologia
deve assumere il carico delle sue responsabilità senza pretendere,
in nome della scienza, di poter muoversi alla cieca,
disinteressandosi dei suoi effetti.
Da qui l'assonanza del lavoro di campo con le pratiche
terapeutiche "anti-oppressive" proposte da Benini-Erba e con la
loro riflessione sul "colonialismo della salute mentale". Nella loro
prospettiva "l'idea di colonialismo si riferisce alla mentalità di
terapeuti e studiosi che, mossi dall'idea di una scienza sociale
‘oggettiva’, hanno costruito discorsi che stabiliscono ‘a priori’
quali siano i modi, gli argomenti e le persone da considerare in
terapia". Nel caso dell'etnografia l'idea di colonialismo è invece
associata a discorsi che si arrogano il diritto di stabilire - senza
considerare l'opinione, i bisogni e i modi di esprimersi dei propri
interlocutori - quali siano i fatti sociali, e le teorie degne di
interesse per il lavoro di campo.
Il potere da parte dell'esperto consiste, in questo caso, "nel
Perché l'Occidente si preoccupa tanto delle culture "altre"? Quale
è il motivo che spinge gli antropologi ad andare sul campo? Esiste
una questione etica che riguarda il lavoro etnografico?
Se per gli psicologi impegnati nella cura dei propri pazienti il
problema della responsabilità e dell'effetto del proprio intervento
è connaturato all'attività terapeutica, per l'antropologo sul campo
questo problema non è scontato. Nonostante il problema della
responsabilità sia stato posto anche tra gli antropologi, in ambito
accademico per lo più ha prevalso la volontà di considerare
prioritaria l'impresa scientifica e gli interessi teorici dei
ricercatori, rispetto alle esigenze locali degli interlocutori e degli
informatori con cui gli etnografi sono venuti a contatto.
Nel caso dell'antropologia applicata, la ricerca sul campo nonostante il nobile fine di teorizzare o proporre un cambiamento,
una direzione, uno sviluppo sulla base di una potenziata capacità
di comprendere l'"altro" - ha nascosto a volte, dietro una
intenzione "filantropica", una volontà di dominio che si è tradotta
spesso in una profonda disattenzione verso le specifiche
differenze e i particolari bisogni delle persone che ha preteso
aiutare, una "disposizione" in cui l'apparente neutralità del
conoscere prelude alla conquista e all'assimilazione culturale1.
Come ci ricordano Benini-Erba nell'articolo che qui
pubblichiamo, menzionando gli assunti delle teorie costruttiviste,
il primo passo per rispondere a queste domande consiste nel
riconoscere che l'azione di sapere, di "venire a sapere" è in stretta,
indissolubile relazione con l'azione di "intervenire". È necessario
riconoscere la questione della responsabilità rispetto alle
conseguenze del proprio agire conoscitivo e relazionale.
Autorizzare questa ammissione, citando Gramsci, significa
accogliere una filosofia della prassi, "una filosofia liberata… in
cui lo stesso filosofo non solo cerca di comprendere le
contraddizioni, ma pone se stesso come elemento della
contraddizione".
Per superare la visione paternalista dell'intervento occorre però
che la propria responsabilità corrisponda all'impegno di
raggiungere una consapevolezza sempre più profonda dei propri
pregiudizi: "consapevolezza… auspicata non con la finalità di
combatterli e neutralizzarli, ma bensì di conoscerli e poterli
utilizzare in modo responsabile…"2.
È necessario riflettere sul proprio ruolo di "esperti", sul ruolo che
hanno i codici di comunicazione nel reprimere la possibilità
dell'"altro" di esprimersi: "ogni pratica sociale, educativa,
terapeutica è esposta al rischio di essere pratica coloniale, cioè
una pratica verticale dall'alto al basso… la capacità di analizzare
i propri presupposti teorici, di attuare pratiche sociali riflessive ci
42
padroneggiare in modo esclusivo il dominio dei discorsi su cui la
relazione va strutturandosi. Adottare un approccio ermeneutico
significa invece andare alla scoperta dei significati e del senso
della vita delle persone. Un senso che emerge attraverso la
narrazione della propria storia o meglio attraverso le narrazioni".
La condizione del campo può costituire allora "uno dei possibili
contesti nei quali le persone possono decostruire e ricostruire
nuove narrative", nuove pratiche, nuovi valori, nuove identità.
Citando Gianfranco Cecchin, Benini-Erba ci ricordano che
assumere la curiosità come forma mentis - che apre alla
molteplicità e alla polifonia di storie - ci consente di
"abbandonare la naturale pulsione di spiegare in termini
scientifici, lineari, per assumere una prospettiva estetica".
Naturalmente, l'attenzione per "il punto di vista nativo", non
implica l'abbandono dei propri modelli interpretativi, non
significa rinunciare ai propri strumenti di analisi. L'analisi sociale,
i sistemi di status e di potere, i processi di incorporazione, le
relazioni di conflitto e di assoggettamento, devono restare parte
dei propri discorsi, ma sul campo e nella successiva
testualizzazione del proprio lavoro, dovrebbero confrontarsi
dialogicamente con i discorsi che i propri interlocutori ritengono
importanti. Bisogna essere così in grado di riflettere sul ruolo che
il potere assume anche all'interno dei contesti sociali dove
l'antropologo produce il suo sapere. Senza pretendere di "sanare
le ingiustizie del mondo politico", il proprio impegno deve essere
in grado di espandersi e ritrarsi in modo da sapersi rivolgere, al
medesimo tempo, al particolare e al generale, al locale e al
globale.
I frammenti del testo di Benini-Erba qui riportati, e ancor più i
numerosi spunti contenuti in tutto il loro articolo, penso
racchiudano delle possibili risposte alla domanda sul senso che
può avere oggi un'antropologia "militante" nel momento in cui
affronta sul campo i suoi interlocutori.
L'importanza di assumere una metodologia ermeneutica,
riflessiva e dialogica, in antropologia, non è una novità. Da Geertz
a Clifford, a Crapanzano, solo per fare alcuni nomi illustri, questa
strada è stata percorsa con grande impegno e creatività ormai da
più di trent'anni. Sorprende forse, che un movimento analogo
abbia attraversato anche altre discipline con la stessa vitalità. Pur
partendo da problemi e riferimenti teorici e tecnici molto diversi,
possiamo osservare tra psicologia clinica ed etnografia una
convergenza verso la tematizzazione di un problema comune:
l'esigenza di assumere una teleologia e una assiologia che, al di là
dei diversi tecnicismi disciplinari, orienti e dia senso all'agire
professionale sul "campo", seguendo modelli più partecipativi e
dialogici.
Rimane però ancora aperta una questione. Se un impegno etico in
antropologia è possibile, lo è solo in quanto capace di riflettere
così in profondità su se stesso da giungere a considerarsi
altrettanto ideologico, aprendo così uno spazio di autocomprensione ancora tutto da esplorare. Vi è qui in gioco la
possibilità di una critica radicale, capace di riconoscere gli
autoinganni e la negatività del pensiero liberale. In questo
smascheramento, apparentemente nichilistico, l'irrazionalismo
che ne deriva non rappresenta l'abdicare del pensiero. Al
contrario, "ciò che si oppone alla ragione è il pensiero stesso" (G.
Deleuze, Nietzsche e la filosofia). Affermazione di un divenire
che non si vuole mediare o conciliare ma assumere nella sua
molteplicità.
Costruire testi intrinsecamente "deboli", riflessivi, dialogici
costituisce allora anche una forma di lotta e di resistenza
decentrata al potere, potere pervasivamente inscritto anche nei
propri desideri e nel proprio sapere.
Note
[1] Su questo tema ormai da anni l'antropologia post-coloniale ha imparato a riflettere. Autori come Wolf, Asad e Said hanno
chiarito i modi in cui il contesto di dominio coloniale e neo-coloniale "occidentale" ha dato forma ai resoconti antropologici.
[2] Le citazioni quando non indicato diversamente rimandano al testo di Benini/Erba.
43
moderna, fin dalle origini, ha dovuto interrogarsi sul suo rapporto con altre professionalità presenti sul campo
L’ antropologia
(quelle di missionari, amministratori coloniali, tecnici e successivamente militanti, cooperanti, volontari); consapevole che
ognuna di esse era ed è portatrice di differenti sguardi, saperi, esigenze, obiettivi. La condivisione forzata di spazi e interlocutori ha
spesso generato profondi contrasti e confronti dialettici che hanno assunto nei decenni forme diverse, contribuendo così a ridefinire
ruolo, statuto, finalità, tanto degli antropologi quanto degli altri attori sociali. Oggi il discorso antropologico si delinea anche in
relazione al grande e variegato mondo della cooperazione internazionale. E' in questo contesto che Achab pubblica la relazione di
Edoardo Occa, capo progetto di un programma di sviluppo dell'ONG Cefa (Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura) a
Bomalang'ombe (Tanzania). L'intento è di fornire ai lettori l'opportunità di sapere cosa pensa chi "è là", su un campo sempre più
affollato di sguardi che si incrociano, si interrogano, si manipolano a vicenda, per continuare a riflettere sulla distanza fra intenzioni
e risultati, sulle sinergie possibili (e le idiosincrasie) fra antropologia e cooperazione, sull'ambiguo e opaco spazio che separa noi
dagli altri.
La Redazione
Relazione da Bomalang`ombe,
regione di Iringa, Tanzania
di Edoardo Occa
Quello di cui faccio parte, con la qualifica di capo progetto, e` un
programma di sviluppo integrato che l`ONG Cefa (Comitato
Europeo per la Formazione e l`Agricoltura) ha iniziato nel
villaggio di Bomalang`ombe nel 1994.
Il villaggio, sede della "kata" (sottodistretto), e` composto da circa
9000 persone ed e` situato a 2000 s.l.m. sugli altipiani meridionali
della Tanzania.
Il clima e` caratterizzato da frequenti piogge e da una stagione
secca piuttosto breve (in media da meta` maggio a meta` ottobre),
e presenta un'economia prevalentemente agricola. Le colture
prevalenti sono il mais (che rappresenta la maggior parte della
dieta alimentare), fagioli, patate; la frutta e` presente in gran
quantità. A dispetto del nome della cittadina, (Bomalang`ombe
significa "recinto delle mucche", appellativo attribuito
dall'amministrazione coloniale tedesca) l'allevamento non
costituisce, invece, una delle attività prevalenti.
Il paesaggio e` costituito da ampie valli e colline estremamente
rigogliose, grazie soprattutto ai numerosi corsi d'acqua presenti
nella zona (siamo molto vicini al fiume Ruaha, che da il nome
all'omonimo parco nazionale, distante meno di 200 km).
In città sono presenti una scuola primaria, una secondaria ed un
dispensario medico, eredità della storia di villaggio "ujamaa", la
filosofia di socialismo africano promulgata dal tuttora venerato
Baba ya Taifa, "il padre della patria", Mwalimu J.K. Nyerere..
Il ceppo etnico è quello Bantu, la tribù è quella degli Wahehe
(uomini Hehe), la lingua ufficiale, come in tutta la Tanzania e in
buona parte dell'East Africa , è il Kiswahili (lingua conosciuta da
tutta la popolazione, anche se nel villaggio prevale l'utilizzo del
"dialetto" Kihehe).
Il progetto Cefa ha costruito nel tempo, innanzitutto, una centrale
idroelettrica grazie alla quale al momento viene fornita la corrente
per l'illuminazione pubblica del villaggio. Da 3 anni e` cominciata
la fornitura di corrente alle abitazioni private (attualmente ne
beneficiano circa il 15% delle abitazioni, nonche` alcune attivita`
quali mulini, una falegnameria ed alcuni piccoli shop).
Dopo la realizzazione della centrale, il cui servizio di erogazione
dovrebbe passare entro la fine di quest'anno ad una co-gestione
Cefa-villaggio, e` stato costruito un acquedotto sfruttando una
falda naturale, cosa che ha permesso la realizzazione di 35
fontane pubbliche di acqua prevalentemente potabile, o
comunque non inquinata da animali, la cui gestione e
manutenzione e` seguita da noi insieme ad un comitato del
villaggio.
Successivamente e` stato realizzato un centro sociale che viene
utilizzato per organizzare seminari su varie tematiche quali la
prevenzione all` HIV/AIDS (problema che nel villaggio assume
proporzioni decisamente preoccupanti, le statistiche tuttora non
sono precise, ma si calcola abbiano contratto il virus circa il 30%
degli uomini adulti e una percentuale minore ma altrettanto
preoccupante di bambini appena nati), in collaborazione col
medico del dispensario locale e con le autorità tanzaniane. Altri
seminari formativi hanno per oggetto tecniche per il
miglioramento della produttività agricola, le leggi che
regolamentano le varie vicissitudini della quotidianità secondo i
diversi codici legali in vigore (attualmente sono ben 3, il diritto
ufficiale tanzaniano, di matrice europea, la shari'a islamica,
utilizzata sulla costa a prevalenza musulmana ed il diritto
consuetudinario, legato all'autorità degli anziani), le tematiche "di
genere". Infine stiamo organizzando alcuni incontri sull'igiene
domestica.
Sempre sul versante igienico-sanitario, la situazione presenta
problematiche soprattutto per l'infanzia; la carenza di proteine
44
nella dieta alimentare e` un fatto evidente, cosi` come sono Io e mia moglie Laura (che nonostante sia laureata in filosofia
frequenti i disturbi derivanti dall'assenza di calzature (varie forme teoretica si sta dimostrando un'ottima contabile; uno dei problemi
di verminosi); fortunatamente, data l'altitudine, il villaggio non e` contingenti maggiori riguarda le annose procedure di rendiconto
zona malarica, mentre lo e` invece la cittadina di Iringa (e l'ho delle spese ai vari donatori) lavoriamo qui da circa un mese (il
constatato di persona…), più in generale, sono presenti varie primo mese di soggiorno tanzaniano l'abbiamo trascorso nella
forme di patologie derivanti dalle scarse condizioni igieniche cittadina di Morogoro, per un corso di Kiswahili) e ci resteremo,
degli abitati.
se tutto va bene, per 2 anni…per cui, nonostante si sia veramente
Altra attività che seguiamo è l'erogazione di micro-crediti in agli inizi, vorrei comunque proporre alcuni spunti di riflessione su
partenariato con una ONG tanzaniana. Il] progetto ha effettive cui ho iniziato a ragionare.
ripercussioni positive sulla comunità, in quanto permette di Dopo circa 10 anni che il Cefa è presente nel villaggio, le
diversificare le fonti di reddito e di riequilibrare in parte, tuttavia problematiche principali riguardano la partecipazione della
senza sconvolgere le dinamiche interne, il rapporto tra uomini e comunità nella gestione dei servizi e la reale percezione del nostro
donne che ad oggi, secondo una visione prettamente lavoro, questioni causate, crediamo, da una scarsa capacità
occidentalizzata, vede le donne decisamente sottoposte comunicativa da parte nostra e dal fatto di aver investito risorse ed
all'autorità maschile (sono infatti proprio le donne le maggiori energie prevalentemente in ambito infrastrutturale, tralasciando
beneficiarie del progetto).
un'adeguata sensibilizzazione ed
Qualche anno fa e` partito inoltre il
informazione sui motivi della
progetto BVC (Bomalang`ombe
nostra presenza sul territorio (il
Village Company), una microCefa e` in Tanzania dai primi anni
industria che produce marmellate,
80, su esplicita richiesta fatta
succhi di frutta, miele, salsicce ed
dall'allora presidente tanzaniano
ha inoltre un'officina ed una
Nyerere al fondatore del Cefa, on.
falegnameria.
Bersani, in un incontro avvenuto
Lo scopo di questo progetto
nel `79. Il primo progetto e` stato
sarebbe quello da fungere da
quello nel villaggio di Matembwe,
"motore di sviluppo" per l'intero
che tutt'ora continua felicemente, al
villaggio reinvestendo in esso gli
quale si sono aggiunti interventi nei
eventuali utili, anche se al momento
villaggi di Njombe, Ikondo e
non rappresenta ancora una risorsa
Bomalang`ombe).
in grado di auto sostenersi né
In quanto rappresentanti del Cefa
economicamente né dal punto di
in loco, una delle nostre funzioni
Bomalang'ombe
vista della progettualità.
sarà quella di valutare l'effettiva
Il villaggio, composto prevalentemente da capanne di argilla e efficacia del progetto nella sua storia e la lungimiranza di alcune
tetto di frasche ( è da notare che la costruzione di case in mattoni, scelte avvenute in passato; ci riferiamo in particolar modo alla
pavimento in cemento e tetto in lamiera è requisito indispensabile, scarsa attenzione posta alla traslazione culturale dei significati
in base alla legge tanzaniana, per richiedere l'allaccio alla corrente impliciti agli interventi di "sviluppo".
elettrica), e` servito unicamente da un pullman che, teoricamente, Essendo passati ormai un certo numero di anni dall'arrivo del
dovrebbe arrivare una volta al giorno dalla città di Iringa, distante Cefa nel villaggio, ci troviamo in una fase fisiologicamente
70 km, ma che in realtà, a causa del pessimo stato della viabilità, delicata del progetto; l'atteggiamento assunto dalle autorità locali
arriva nel villaggio una volta ogni 2-3 giorni…
(villaggio, distretto e regione, che ora stiamo cercando di
Ovviamente, a Bomalang`ombe non esiste rete telefonica, ne` coinvolgere anche nella fase progettuale degli interventi) è quello,
fissa ne` mobile, (noi comunichiamo tramite ponte radio con le purtroppo, di una sorta di accettazione passiva di qualsivoglia
altre sedi Cefa in Tanzania e con alcune missioni presenti nella proposta che il Cefa possa avanzare, sintomo, forse, di una
zona) e l`unico televisore presente nel villaggio e` utilizzato per fragilità endemica delle istituzioni locali e di una malcelata
trasmettere VHS (film o documentari che utilizziamo nei dipendenza dagli interventi della cooperazione internazionale
seminari) una volta la settimana nelle sale del centro sociale.
(nella regione di Iringa operano diverse altre organizzazioni,
Nel villaggio sono presenti ben 9 confessioni cristiane differenti, italiane, danesi, giapponesi, inglesi. Sulla effettiva funzione di
(chiesa cattolica, luterana, Chiesa del Sabato, Tempio di miriadi di organizzazioni umanitarie, non solo nel contesto
Betlemme, Assemblea di Dio, pentecostali, anglicani, avventisti, africano, ormai da qualche anno è aperto il dibattito, volto, spero,
Nuova Chiesa Apostolica), non sono presenti musulmani ma a rimettere in discussione il paradigma epistemologico degli
bisogna considerare che, come recitava un vecchio adagio "interventi di sviluppo" più che all'ennesima, sterile, opera di
"l'Africa è al 50% cristiana, al 50% musulmana, e al 100% auto celebrazione).
animista…", i fenomeni di sincretismo nelle varie liturgie sono Un altro punto critico è rappresentato dai modi in cui le opere fin
infatti fortemente radicati.
qui realizzate hanno agito sui dispositivi che regolano il principio
45
di autorità all'interno del villaggio; infatti, data la necessita` di
trovare tra gli abitanti del villaggio degli "omologhi"
(sull'efficacia di una tale terminologia, che riporto in quanto è
quella con cui convivo, sarebbe interessante soffermarsi, la
matrice del "discorso" mi sembra assolutamente tautologica…),
nel corso del tempo sono state selezionate un ristretto numero di
persone aventi incarichi di responsabilità in ambiti prettamente
tecnici, senza che venissero coinvolte le autorita` morali del
villaggio, così in parte delegittimando il loro ruolo politico;
questo fatto sta comportando tensioni sociali e l'insorgere di
comportamenti ai limiti della legalità tra coloro che godono di tali
"benefici".
Un ulteriore rischio e` rappresentato dall'approccio di carattere
assistenzialistico che tuttora alberga in alcuni di noi operatori; è
ben noto ormai, come il desiderio di "aiutare i poveri" possa
generare comportamenti che, oltre ad avere scarsa efficacia,
ignorano gli equilibri propri di una società già profondamente
scossa da molteplici sollecitazioni esterne difficili da
metabolizzare e da ri-tradurre in significati comuni.
Lungi dal voler proporre un`immagine "museificata" e statica
della società e della cultura di Bomalang`ombe (anche se gli
Wahehe sono noti per l`orgoglio verso la propria storia; furono
loro i protagonisti della celebre rivolta al colonialismo tedesco,
guidata dal celeberrimo capo Mkwawa, che duro` dal 1890 al
1898, anno in cui, vedendosi ormai sconfitto dai cannoni
teutonici, decise di suicidarsi piuttosto che arrendersi, divenendo
così figura leggendaria tuttora estremamente rispettata nella
regione ), ci preme pero` far notare come la difficoltà principale
rilevata sia proprio l'assenza di filtri adeguati ad arginare la
velocità di stimolazioni che agiscono su codici comunicativi
estremamente differenti da quelli comunemente utilizzati; è su
questo registro che credo la pratica antropologica, propria di un
sapere che abbia come finalità la declinazione del ventaglio di
possibilità a cui si apre lo scenario contemporaneo, possa rivelarsi
strumento fondamentale nella lettura e nell'ermeneutica del
contesto particolarmente ricco di tematiche di un progetto
integrato di sviluppo.
Spero dunque di essere in grado di calarmi in questo
caleidoscopio di esperienze diverse e di fare, in qualche modo, la
"mia parte" per il villaggio di Bomalang`ombe. Per il momento,
mi limito a seguire il consiglio che Malinowski diede al giovane
Evans-Pritchard in partenza per l'Africa, ossia quello di badare
soprattutto a "non fare lo stupido".
Strada di Bomalang'ombe
46
Libri e poesie
A cura di Antonio De Lauri
Da questo numero Achab introduce la "Sezione libri e poesie" che si propone con una duplice funzione: presentare alcuni testi
particolarmente significativi per la loro capacità di stimolare riflessioni attente alla complessità del mondo contemporaneo ed iniziare
una narrazione poetica, pensata come un dialogo tra le forme dell'arte e le forme del sapere, uno spazio per lasciar esprimere, alle
semplici parole, il senso dell'esperienza quotidiana.
Chomsky N., Herman E. S. "Bagno di sangue" (1975)
Il Formichiere, Milano.
Gray J. "Al Qaeda e il significato della modernità" (2004)
Fazi editore, Roma
Incontrare una persona può essere un'esperienza formativa ed
illuminante. Lo stesso può accadere con un libro; il testo di
Chomsky ed Herman ne è un esempio.
Una riflessione attenta e lineare dei nostri tempi, in una
prospettiva stimolante e teoricamente impegnata.
Attraverso l'esame dettagliato delle conseguenze politiche,
militari, economiche e sociali della globalizzazione, il testo, con
straordinario acume e capacità di sintesi, getta una luce
profondamente nuova sull'esplosione dell'Islam radicale, sugli
errori commessi dagli Stati Uniti nel loro ruolo di nuova potenza
imperiale - sugli eventi più tragici e i fenomeni più
preoccupanti della storia dei nostri giorni.
Che questo libro sia stato sequestrato negli Stati Uniti non
sorprende. Chomsky ed Herman hanno raccolto una serie di
documenti, la maggior parte rapporti ufficiali, che mostrano
come gli Stati Uniti abbiano "amministrato" i più efferati bagni
di sangue degli ultimi decenni. Inoltre - e per questo la loro
analisi rimane unica ed esemplare - smontano con implacabile
rigore la gigantesca macchina ideologica che ha permesso di
legittimare e rendere "accettabile" all'opinione pubblica la
politica estera americana.
L'attenzione si sposta su vari
luoghi del pianeta fino a toccare
il punto cruciale: il Vietnam. Ma
prima passa per il Guatemala,
San Domingo, il Brasile, la
Grecia, la Thailandia, le
Filippine, la Corea ecc. I bagni
di sangue si succedono,
"benigni", "costruttivi" e sotto
l'egidia della "pacificazione", ma
tutti come effetti di un'unica
causa, la politica del
"mondo libero" costretto a
esportare
la
morte
per
sopravvivere.
Edward S. Herman è autore di saggi di economia e libri di analisi
critica delle società occidentali.
Noam Chomsky è nato a Filadelfia nel 1928 da una famiglia di
immigrati russi. Allievo di Roman Jakobson, ha rivoluzionato gli
studi di linguistica sviluppando i principi della teoria generativa
trasformazionale. Autore di numerosi saggi specialistici e di
analisi critiche del mondo contemporaneo, Chomsky è uno dei
pochi grandi intellettuali capaci di cogliere la complessità della
nostra epoca da un punto di vista critico, militante, costruttivo.
John Gray è uno fra i maggiori pensatori inglesi viventi; insegna
alla London School of Economics.
47
I poeti conclamano il vero,
potrebbero essere dittatori
e forse anche profeti
perché dobbiamo schiacciarli
contro un muro arroventato?
Eppure i poeti sono inermi,
l'algebra dolce del nostro destino.
Hanno un corpo per tutti
e una universale memoria,
perché dobbiamo estirparli
come si sradica l'erba impura?
[…]
Lasciamoli al loro linguaggio, l'esempio
del loro vivere nudo
ci sosterrà fino alla fine del mondo
quando prenderanno le trombe
e suoneranno per noi.
(Alda Merini)
Il prossimo
Troppo vicino non mi piace il prossimo:
che se ne vada in alto e ben lontano!
Diverrebbe altrimenti la mia stella?
(Friedrich Nietzsche "Le poesie" (2000) Einaudi, Torino)
Vivere una sola vita
in una sola città,
in un solo paese,
in un solo universo,
vivere in un solo mondo
è prigione.
Conoscere una sola lingua
un solo lavoro
un solo costume
una sola civiltà
conoscere una sola logica
è prigione.
(Ndjock Ngana)
48
Foto di Anna Sambo, (Benin 2004)
Note per la consegna e la stesura degli articoli.
Gli articoli devono essere in formato Word o Rich Text Format (.rtf). Si consiglia di usare il carattere
times o times new roman corpo 12.
L'articolo deve avere una lunghezza minima di 3 cartelle e massima di 15 (interlinea 1,5; corpo 12).
Si consiglia di ridurre al minimo le note che non dovranno essere inserite in automatico ma digitate come
testo alla fine dell'articolo. Nel testo il numero della nota deve essere inserito mettendolo tra parentesi.
Gli articoli devono essere spediti al seguente indirizzo: [email protected]. La redazione provvederà a
contattare gli autori.
49