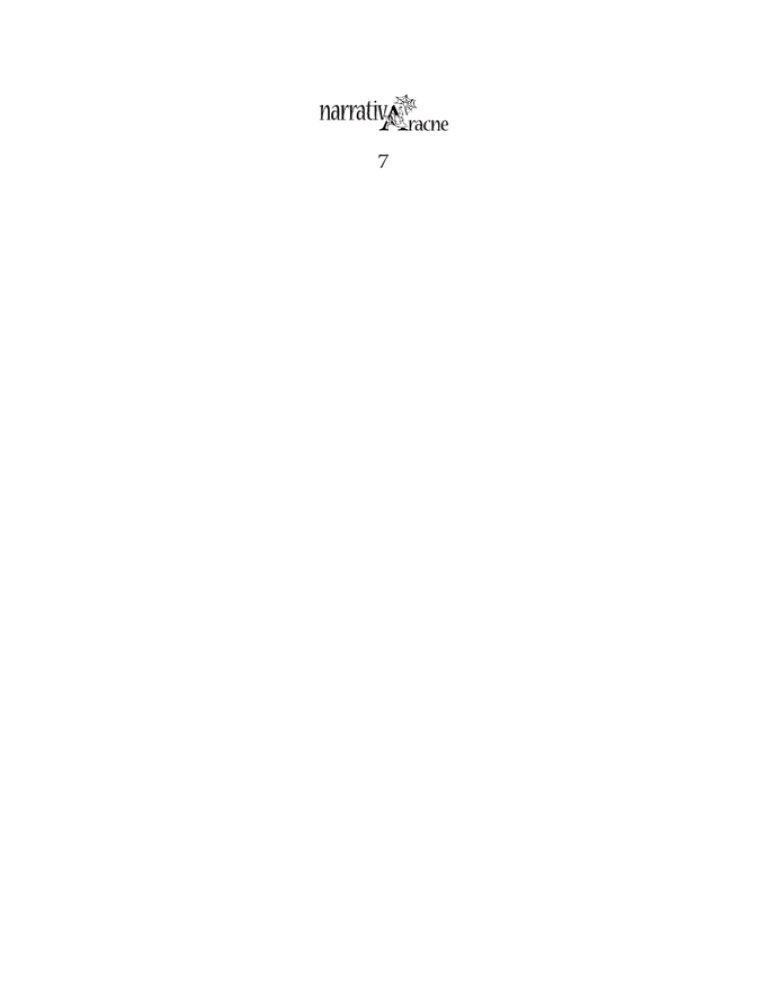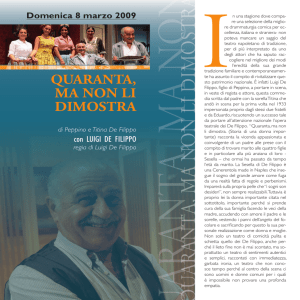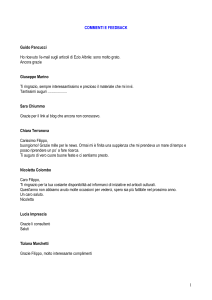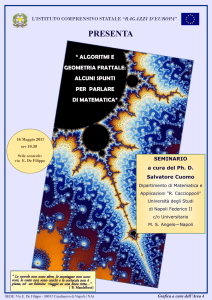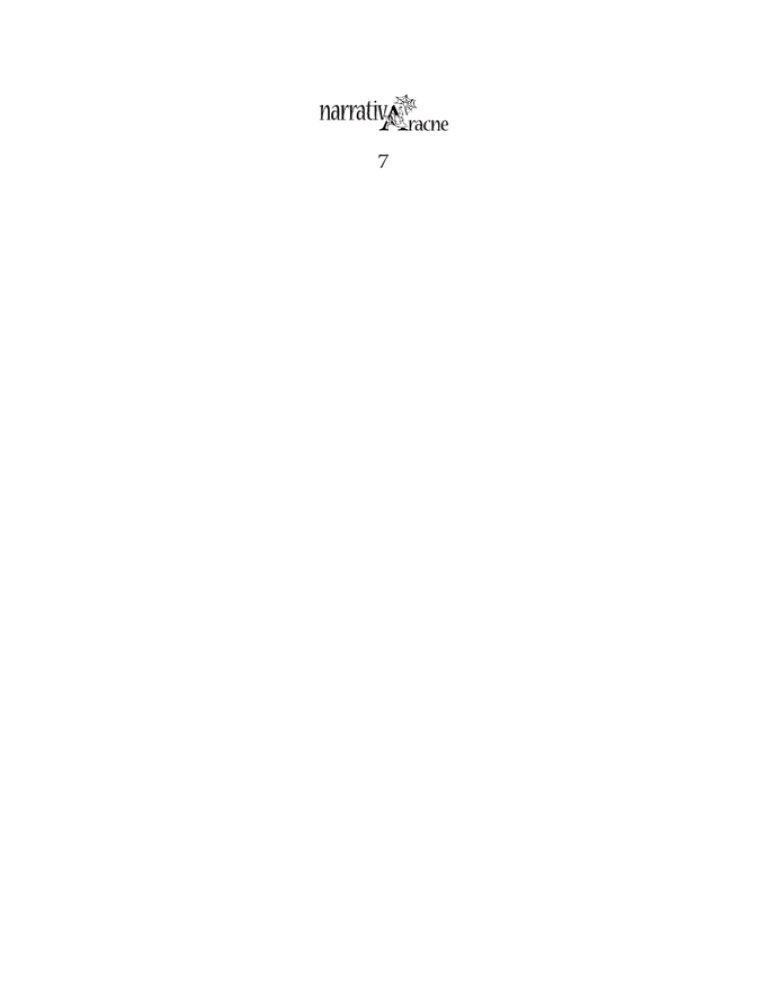
7
Allemand
Federico
Gli olivi
non fanno ombra
Copyright © MMXIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
www.narrativaracne.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065
isbn
978-88-548-6180-0
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: luglio 2013
Premessa
Ho sentito l’esigenza di scrivere questo libro, rielaborazione più meditata del precedente Cronache distanti, quando
mi sono avvicinato ai sessant’anni, perché ho cominciato a
temere che troppi ricordi potessero scolorirsi e dissolversi.
Volevo, al contrario, che alcuni eventi che avevano riguardato la famiglia di cui porto il cognome restassero in modo
duraturo e ho creduto che attraverso questa microstoria si
potessero aprire degli squarci sulle vicende più generali del
nostro paese, in particolare su quelle che hanno caratterizzato il periodo tra la metà dell’Ottocento e gli anni Sessanta
del Novecento.
Non si tratta di una cronistoria sempre e comunque fedele agli eventi accaduti, solo lo scheletro è totalmente aderente alla realtà. I particolari minori, invece, sono spesso modificati o del tutto inventati, anche se ho cercato di renderli
sempre del tutto verosimili e quindi sostanzialmente “veri”.
Non ho mai nominato il paese in cui sono nato e in cui si
svolge gran parte della narrazione, non per motivi letterari
o per aumentare la curiosità del lettore, ma solo per pudore.
La gran parte delle frasi in dialetto del romanzo sono
tratte dal libro di Cesare Chiominto, Lo parlà forte della pora
ggente, nei riguardi del quale sono quindi debitore.
F.A.
5
Capitolo 1
Filippo
La nebbia scivolava lentamente sui fianchi delle colline
che chiudevano a nord e a est l’abitato severo del vecchio
paese latino. Un sole lattescente si intravedeva a tratti, quando riusciva a fatica a forare la coltre biancastra; il paesaggio
si indovinava appena, sfumava, spariva, riappariva in un
gioco incessante di grigi. Poi, progressivamente, la foschia
cominciò ad alzarsi e squarci di azzurro cominciarono ad
apparire, facendosi via via sempre più ampi.
Alla fine i raggi del sole ebbero il sopravvento e cominciarono a riscaldare la terra, i muri delle case irrigiditi dal
freddo della notte, i primi passanti, i cani randagi, i gatti che
stiravano eleganti le membra intorpidite.
La nebbia si dissolse poi rapidamente e tutto cominciò
a tingersi di colori morbidi, slavati, poi sempre più caldi e
nitidi.
Il calesse nero e ocra appena raggiunto dal sole era fermo, come ogni inizio mese, di fianco all’ingresso della modesta locanda che si affacciava su piazza Roma e ne chiudeva il lato orientale.
La piazza era in realtà poco più che uno slargo della strada che da Porta Romana, all’ingresso nord-occidentale del
paese, conduceva a Porta Ninfina e segnava il confine tra
i due terzieri che componevano la parte bassa dell’antica
7
Allemand
città. Era dominata da un grande fontanile che fungeva soprattutto da abbeveratoio per gli animali e che serviva da
quinta scenografica in direzione del mare.
La presenza del calesse era il segno certo che Filippo
Aubriòt era in paese per il suo consueto giro di ispezione
alle manifatture di tabacchi e ai campi di produzione della
zona.
L’arrivo del funzionario forestiero costituiva uno dei pochi elementi di novità che risvegliavano l’atmosfera sonnacchiosa del piccolo centro della campagna romana, grigio
delle sue vecchie mura, del selciato sconnesso delle strade
tortuose, degli intonaci delle case abbarbicate sui fianchi
della collina e della polvere dei suoi venticinque secoli di
storia, di storia minore da almeno due millenni.
Filippo alloggiava sempre nello stesso posto, l’Albergo
Centrale, vecchia bicocca che odorava di vinaccio acidulo,
di verdure lesse, di fritto rifritto e di stantio.
Ma non c’era altra scelta.
Non erano giorni qualunque, quelli.
L’assassinio di Sarajevo aveva fatto precipitare l’Europa
in una guerra fratricida, tra gli Imperi Centrali e l’Intesa,
che si prevedeva lunga e sanguinosa.
L’Italia ne era fuori, per il momento, ma non si sapeva
per quanto. Le notizie giungevano in ritardo, frammentarie, lontane, in quell’angolo del Lazio antico isolato, chiuso,
quasi impermeabile agli influssi del mondo esterno.
La mattina presto e all’imbrunire i vicoli risuonavano
come sempre degli zoccoli dei muli, degli asini e dei cavalli;
le donne continuavano ad andare impettite in corteo alle
rare fontane, con conche di rame e brocche d’argilla; gli artigiani lavoravano nelle loro botteghe, ripetendo gesti sempre uguali e sempre diversi; torme di bambini correvano
scalzi e infangati dietro cerchi arrugginiti di barili e bigonce;
i vecchi sostavano in crocchio, inerti, ingobbiti, al sole or-
8
Gli olivi non fanno ombra
mai pallido di quell’inizio d’autunno del 1914. Scambiavano poche parole, rigorosamente in dialetto, con movenze
lente, quasi ieratiche, spesso appoggiati al bastone, la pipa
di legno tra i denti, i volti di cuoio da antichi romani, la
schiena irrimediabilmente piegata dall’uso di zappa e vanga, le mani indurite, nodose.
La vendemmia era già praticamente finita nelle poche
vigne a radi filari che sostituivano a quote più basse gli uliveti che coronavano i colli attorno al paese.
Ancora più in basso, verso la piana, verdeggiavano i
campi di tabacco, interrotti qua e là da frutteti striminziti e
da seminativi squadrati.
Più in fondo, a sud-ovest, il nastro turchino del mare,
apparentemente a portata di mano ma in realtà lontano,
straniero, sconosciuto ai più, guardato solo dall’alto e con
sospetto.
Tra gli ultimi campi a coltura e la costa, terre malsane e
acquitrinose, inospitali, rifugio di rane, bisce e zanzare, regno incontrastato di bufali massicci, possenti. Lì imperversava la malaria che risparmiava, però, la popolazione che
si inerpicava sui primi contrafforti dei Monti Lepini. E gli
abitanti delle colline sbirciavano la palude con un misto di
terrore e soggezione e facevano di tutto per tenersene alla
larga.
Terra di butteri e pastori, la palude, di ricotta e mozzarella, di febbri terzane e quartane, di brividi e morte.
Filippo Aubriòt uscì dalla porta quasi di corsa, salutò calorosamente l’oste seduto sull’uscio sopra una vecchia sedia
impagliata, l’eterno stecchino tra i denti, il ventre prominente, le gambe divaricate, la barba ispida e già di qualche
giorno. Saltò agile sul calesse, afferrò le redini, spronò il cavallo e partì.
«Sarò di ritorno per pranzo – gridò già in movimento al
padrone della locanda – datti da fare in cucina!»
9
Allemand
10
L’oste lo degnò appena di uno sguardo ironico e di un
breve sorriso accondiscendente.
Uscendo da Porta Romana, Filippo si diresse a trotto
sostenuto verso la piccola frazione che distava pochi chilometri dal capoluogo in direzione nord-ovest, chiusa nei suoi
bastioni rinascimentali, dominata dalla massiccia mole del
palazzo baronale e, con più discrezione, dalla chiesa seicentesca dedicata a San Giuliano.
Stava lì la manifattura dei tabacchi e da lì iniziava sempre il suo giro.
Uscendo da Porta Romana la strada tagliava la collina
a mezza costa, passava sotto il camposanto del paese, più
assolato e più vasto della città dei vivi, e poi scendeva verso la strada ferrata che risaliva all’epoca del Papa re e che
collegava la capitale con il sud del Lazio. Olivi e muretti a
secco costeggiavano la strada – in salita erta sulla destra,
in discesa a sinistra, quasi un dirupo – verso la pianura e il
mare. Era una strada abbastanza larga, bianca di breccia
compatta, polverosa nella stagione calda ma percorribile
anche in inverno senza problemi; e ripeteva il tracciato di
una strada antichissima, che collegava Roma alle città latine
e alle colonie romane del meridione del Lazio quando la via
Appia ancora non esisteva. Giunta al casello della ferrovia,
la strada proseguiva verso le prime case della frazione poste intorno a un incrocio, da cui partiva un’altra strada che
andava verso l’interno e la valle del Sacco e lungo la quale
si trovavano la piccola stazione ferroviaria e la manifattura
dei tabacchi. La parte più antica del paese era invece più in
alto, nel borgo rinascimentale, circondata da mura in buona
parte crollate o sconnesse, tutta compresa tra il monumentale palazzo, con annesse scuderie e magazzini, e la chiesa
barocca. Era composta di piccole case, vicoli stretti, brevi
scale esterne, rari negozi e cantine, molto omogenea e compatta, costruita per lo più di tufo e calcare.
Gli olivi non fanno ombra
Filippo, lasciato il capoluogo, cominciò a rallentare; reggeva le redini senza porre molta attenzione al paesaggio ricco di tutte le sfumature del verde, dell’ocra, del giallo e del
marrone. Appariva pensieroso, a tratti fischiettava con poca
convinzione, incoraggiava il cavallo con la voce, quasi per
obbligo. Per strada pochi viandanti, alcuni a piedi, spesso
appoggiati a bastoni, altri su vecchi carretti trainati da buoi
o da cavalli, i più in groppa a muli e somari, i maschi tutti
con il cappello, le femmine con il fazzoletto annodato in
testa, sulla nuca. Rarissime le carrozze e i calessi, inesistenti
le automobili.
Raggiunse il piccolo borgo rinascimentale in circa
mezz’ora, fermò il calesse sotto un vecchio platano e si diresse a piedi verso il tabacchificio, un edificio basso e anonimo,
con passo lento, quasi incerto: il buon umore del primo mattino era sparito; non aveva alcuna voglia di iniziare la sua
ispezione e sembrava voler rimandarne l’inizio il più a lungo
possibile. Poi, a un tratto, si decise, allungò il passo, gonfiò il
torace, tenne dritta la testa, si ravvivò i capelli ed entrò.
Filippo Aubriòt aveva superato da qualche anno la trentina, era ancora scapolo ed era originario di Cava dei Tirreni; aveva studiato a Salerno e a Napoli ed era entrato ancora giovane nell’amministrazione dello Stato. I compiti del
suo ufficio lo portavano a viaggiare spesso per ispezioni e
controlli, anche lontano dalla sua casa campana.
Non era molto alto ma robusto, ben piantato, elegante
nei suoi completi gessati col panciotto e la catena dell’orologio da taschino bene in mostra.
Gli occhi erano scuri, profondi, illuminati da lampi ironici improvvisi; le palpebre pesanti non riuscivano ad attenuare la forza pungente dello sguardo.
La faccia era larga, il naso prominente e carnoso, il labbro superiore sottile, dominato da imponenti baffi corvini,
il labbro inferiore più molle, sensuale. La fronte ampia, i
11
Allemand
12
capelli ondulati pettinati con la riga a destra, folti, nerissimi,
a formare a sinistra e all’indietro un ciuffo imponente e in
perenne disordine.
Nel complesso lo si sarebbe definito un bell’uomo.
Ma era soprattutto il modo di muoversi e il portamento
che lo rendevano attraente: spostava il suo corpo con energia e vigore, usava le mani con naturale eleganza, camminava con andatura elastica e scattante, anche se dondolante
per un accenno di zoppia; e questo particolare, la zoppia,
lungi dall’essere un difetto, arricchiva di personalità le sue
movenze. Il linguaggio aveva chiare ascendenze napoletane
ma senza grossolanità; anzi, denotava quell’eleganza tipica
dei campani di buona famiglia, con la erre lievemente arrotata e qualche leziosità.
Anche il suo comportamento risultava peculiare e piacevolmente strano: aveva ereditato dal padre piemontese,
oltre al cognome d’ascendenza francese, un tratto quasi
severo, solido, rassicurante. Ma il sangue partenopeo della
madre gli conferiva una buona dose di mediterranea passionalità condita di fatalismo.
A volte questi elementi così distanti si alleavano e convivevano in armonia; più spesso si alternavano con risultati
spiazzanti e perfino perturbanti per coloro che lo frequentavano.
Tuttavia ciò non impediva che la presenza di Filippo in
paese fosse sempre occasione di grandi mangiate e bevute, partite a carte, storielle piccanti e discussioni vivaci col
gruppo di compagni che, mese dopo mese, aveva raccolto
attorno a sé e che ne apprezzavano la generosità impulsiva,
la passione, la signorilità, il cameratismo e anche, con qualche distinguo, gli atteggiamenti più strani: i lunghi silenzi,
gli improvvisi scoppi d’ira, le malinconiche riflessioni, i giudizi trancianti, le idee qualche volta strampalate.
Le idee strampalate, del resto, servivano anche a rafforzare negli autoctoni latini l’incrollabile certezza della loro
Gli olivi non fanno ombra
superiorità millenaria sull’orbe terracqueo tutto e sul franco-napoletano Aubriòt in particolare.
13