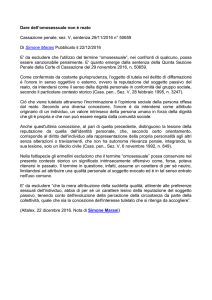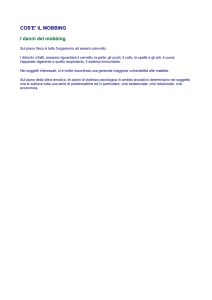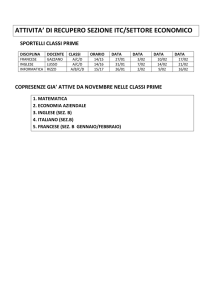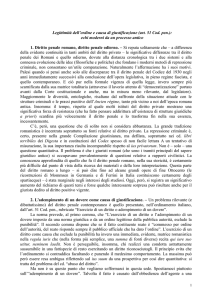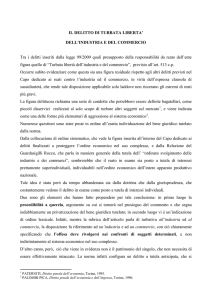www.ildirittoamministrativo.it
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA PENALE
AGGIORNATO AL 30 NOVEMBRE 2011
a cura di Cristina Cilla
Corte di Cassazione, sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43100: affinché il mobbing possa configurare
il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che il rapporto tra datore di lavoro, autore dei
maltrattamenti, e dipendente che subisce la condotta, abbia natura para-familiare.
La pronuncia in esame offre alla Suprema Corte di Cassazione l’occasione per analizzare la
rilevanza penale del mobbing.
Nell’ambito dell’organizzazione aziendale, con il termine “mobbing” si fa riferimento alle diverse
angherie e pratiche di vessazione, persecuzione, ritorsione e violenza psicologica messe in atto
deliberatamente e ripetutamente nel tempo dal datore di lavoro o dai superiori (mobbing verticale)
ovvero da dipendenti di pari livello o subalterni (mobbing orizzontale), nei confronti di un soggetto
designato come vittima, sì porlo in una condizione di emarginazione ed isolamento. Tale condizione
può danneggiarne gravemente l’equilibrio psico–fisico della vittima, menomandone la capacità
lavorativa e la fiducia in sé, provocando crisi emotive, depressione; in casi estremi può persino
portarla al suicidio, determinarne l’estromissione dall’azienda ovvero indurla a rassegnare le
dimissioni (c.d. mobbing strategico o mobbing dall’alto o bossing).
La particolarità del mobbing, dunque, è evidente sin dall’etimologia del nome, derivante dal verbo
inglese “to mob” (assalire in massa, accerchiare) ed utilizzato in etologia per individuare il
comportamento aggressivo del branco nei confronti di un animale isolato.
Il fenomeno in parola manca però di una regolamentazione di tipo normativo.
Pur nella varietà delle definizioni fornite dagli studiosi della materia, si ritiene che gli elementi
necessari della fattispecie di mobbing siano l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico;
la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo; il suo andamento progressivo; le
conseguenze patologiche gravi per il mobbizzato.
In senso conforme la Cassazione ha di recente individuato gli elementi qualificanti il mobbing,
quali: 1) la protrazione nel tempo della condotta illegittima attraverso una pluralità di atti, giuridici
o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi; 2) la volontarietà (intento persecutorio o di
emarginazione); 3) la lesione attuata sul piano professionale, sessuale, morale, psicologico o fisico
alla vittima (Cass., n. 22858/2008).
In seno alla giurisprudenza civilistica tra le figure del mobbing e del danno esistenziale si è
manifestato uno stretto legame. Tale rapporto è risultato vantaggioso per entrambe, in quanto, da un
lato, il danno esistenziale ha permesso di dare rilevanza giuridica a comportamenti illeciti che
rischiavano di rimanere sommersi e privi di sanzione a causa della mancanza di una figura di danno
idonea a dar voce al particolare tipo di pregiudizio subito dal dipendente, dall’altro, il recepimento
della figura del mobbing da parte della giurisprudenza ha, però, permesso di concentrare
l’attenzione degli interpreti proprio sulle conseguenze tipiche e più dirette di una tale condotta
1
www.ildirittoamministrativo.it
vessatoria, cioè sulla compromissione delle attività realizzatrici del lavoratore, come tali rientranti
proprio nella figura del danno esistenziale.
Fatte queste premesse e posto che il mobbing, inteso come coacervo di azioni dirette
all’eliminazione di uno o più lavoratori, non esiste ancora come figura tipica, occorre valutare la
possibilità di reagire di fronte a comportamenti c.c. mobizzanti.
La risposta in molti casi sarà positiva, in termini di tutela sia civile che penale. Ad esempio, se
nell’ambito di una attività di mobbing viene disposto un trasferimento non sorretto da comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive o la vittima viene assegnata a mansioni dequalificanti,
questi provvedimenti potranno essere impugnati ai sensi dell’art. 2103 c.c., tanto nei modi ordinari
quanto, sussistendone i presupposti, in via d’urgenza. Se la pressione esercitata dal mobbing
conduce alle dimissioni della vittima, queste potranno essere impugnate ai sensi delle norme
generali che riguardano i vizi del consenso nella formazione della volontà contrattuale (con
particolare riguardo all’ipotesi della violenza ex art. 1434 e segg. c.c.). Se invece la strategia sfocia
in un licenziamento questo, ferme restando le tutele di cui alle leggi in materia, potrà giustificare la
condanna ad un ulteriore risarcimento nel caso in cui, per la forma o le modalità del recesso, le
espressioni contenute nella lettera di recesso, le conseguenze morali e sociali che ne derivano,
possano definirsi “ingiuriose” od “offensive”. Infine, l’eventuale danno alla salute subito dalla
vittima a causa delle persecuzioni potrà essere risarcito secondo i canoni tradizionali della materia,
ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2087 c.c.
Le singole azioni mobbizzanti possono sicuramente avere anche una rilevanza penale, oltre
che civile. Aver provocato un danno alla salute può comportare l’incriminazione per lesioni
personali colpose (art. 590 c.p.). I richiami del superiore che superano il limite della proporzione
con il fatto addebitato attraverso l’utilizzo di espressioni denigratorie non necessarie potranno
essere perseguiti quali ingiuria o diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.). Altre figure di reato possibili
sono poi l’abuso di ufficio (art. 323 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), le molestie sessuali (l. n.
66/1996). In ogni caso poi, è da considerare l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11, per aver commesso
il fatto con abuso di autorità, di relazioni d’ufficio o di prestazione d’opera.
Non esiste tuttavia nel codice penale una norma che sanzioni il mobbing in quanto tale. La figura di
reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il mobbing è quella dei maltrattamenti
commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione (cfr. Cass. pen., n.
33624/2008).
Quanto sopra esposto è sicuramente valido di fronte a situazioni di mobbing che potremmo definire
degenerato. Vi possono però essere dei casi non garantiti da tali forme di tutela, sia perché la
strategia del mobber è attuata lungo una sottile linea di confine tra il lecito e l’illecito, il comando e
l’abuso, oppure a mezzo di azioni non così gravi e significative da giustificare, esse sole
considerate, il ricorso all’autorità giudiziaria, sia perché la vittima reagisce alle violenze riuscendo a
riportare conseguenze patologiche. In tutti questi casi, molto diffusi nella pratica, il vuoto
legislativo rischia di lasciare senza tutela le vittime. Ciononostante, l’apertura di dottrina e
giurisprudenza in materia di danno esistenziale ha permesso di tutelare anche i soggetti che, pur non
essendo stati colpiti da provvedimenti di per sé palesemente illeciti e pur non avendo riportato danni
economici o alla salute, nondimeno sono state vittime di una sofferenza ingiusta.
Nel solco della problematica della rilevanza penale del mobbing si colloca la sentenza in epigrafe.
2
www.ildirittoamministrativo.it
Nella fattispecie in oggetto un Sindaco maltrattava un dipendente comunale svolgente mansioni di
operatore ecologico, sottoponendolo a una serie continua di arbitrarie vessazioni (mortificazioni in
presenza di terzi, minacce di licenziamento, assillanti e ingiustificati controlli anche durante
l'espletamento di incombenze fisiologiche, ingiustificati pedinamenti e appostamenti notturni), a
seguito delle quali quest’ultimo si suicidava.
Si poneva la questione se la condotta del Sindaco integrasse gli estremi del reato di maltrattamenti
in famiglia.
In primo grado, il Sindaco veniva condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato
dalla circostanza della morte del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 572 comma 2 c.p., per aver, in
qualità di Sindaco di un piccolo comune, sottoposto un dipendente dell’ente ad una serie continua di
vessazioni, inducendolo al suicidio. In secondo grado, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado, veniva esclusa l’aggravante di cui al comma 2 dell’art 572 c.p. e veniva dichiarato non
doversi procedere per intervenuta prescrizione, pur confermandosi le statuizioni civili sia a carico
dell’imputato che del comune da questi amministrato.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando
l’erronea applicazione dell’art 572 c.p., nella parte in cui il giudice di merito non aveva considerato
che ai fini della punibilità ai sensi dell’art. 572 c.p., nell’ambito del rapporto di lavoro, occorre un
rapporto tra datore e dipendente di natura para-familiare, requisito mancante nel caso di specie.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione accoglie l’impianto argomentativo della difesa,
ritenendo non giuridicamente configurabile nel caso di specie il reato di cui all'art. 572 c. p.
Più nello specifico, argomenta la Suprema Corte, affinché ricorra il reato di maltrattamenti in
famiglia è necessario che il soggetto agente eserciti, di fatto o di diritto, un potere autoritativo sul
soggetto passivo, il quale viene a trovarsi in una condizione di soggezione. Trattasi di una
fattispecie tradizionalmente confinata nell'ambito familiare, specialmente in relazione alla posizione
preminente del marito rispetto alla moglie o dei genitori rispetto ai figli, come già prevedeva l’art.
391 del codice penale del 1889, e successivamente estesa dal codice penale del 1930 ai rapporti
educativi, di istruzione, di cura, di vigilanza, di custodia o a quelli che si instaurano nell'ambito di
un rapporto di lavoro.
Con particolare riguardo ai rapporti di lavoro, l’orientamento giurisprudenziale è concorde nel
richiedere che l’agente versi in una posizione di supremazia, che si traduca nell'esercizio di un
potere direttivo o disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche
di natura meramente psicologica, del soggetto passivo, riconducibile a un rapporto di natura
para-familiare (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, 07/04/2011, n. 16164; Cass., sez. VI, 22/09/2010, n.
685; Cass., sez. VI, 20/05/2009, n. 32366; Cass., sez. VI, 06/02/2009, n. 26594; Cass., sez. III,
05/06/2008, n. 27469; Cass., sez. VI, 22/01/2001, n. 10090).
Al di fuori di queste particolari situazioni di fatto o di diritto, nell'ambito di rapporti di natura
professionale o di lavoro non è configurabile il reato in esame. Di qui le varie iniziative legislative
volte a dare rilevanza penale alle condotte di mobbing.
Con riguardo al casus decisus, relativa al rapporto tra il Sindaco, capo dell'amministrazione
comunale, e un dipendente comunale, non qualificabile in termini di lavoro subordinato, è da
3
www.ildirittoamministrativo.it
escludersi un nesso di supremazia-soggezione che esponga il soggetto più debole a situazioni
assimilabili a quelle familiari, come invece potrebbe dirsi nei rapporti tra il collaboratore domestico
e le persone della famiglia presso la quale il primo presta attività lavorativa o in quelli intercorrenti
tra il maestro d'arte e l'apprendista.
Esclusa, dunque, la configurabilità del reato di maltrattamenti, la Suprema Corte annulla la sentenza
impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art.
622 cod. proc. pen., affinché verifichi se residuino condotte produttive di responsabilità civile.
Con tale pronuncia la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, non avendo il mobbing ancora
un’autonoma disciplina in ambito penale, esso deve necessariamente ricondursi a singole
fattispecie costituenti reato già previste dal legislatore.
Corte di Cassazione, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646: integra il reato di esercizio abusivo
della professione medica ex art. 348 c.p. l’effettuazione della circoncisione rituale per motivi
etnici da parte di chi non è un medico.
Con la pronuncia in esame viene sottoposta alla Suprema Corte la questione della rilevanza penale
della pratica della circoncisione c.d. rituale, ovverosia quella non terapeutica, bensì effettuata per
tradizione etnica, culturale o religiosa.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte una cittadina nigerina veniva dichiarata colpevole di
concorso nel delitto di cui all'art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione medica), con
l’addebito di avere fatto sottoporre il proprio figlio, nato da appena un mese, ad un intervento di
circoncisione da parte di un soggetto non abilitato all'esercizio della professione medica, con la
conseguenza che il neonato, poche ore dopo l'intervento, aveva avuto una imponente emorragia, che
ne aveva imposto il ricovero d'urgenza in ospedale per gli interventi terapeutici del caso.
Anzitutto, la Corte si interroga sulla possibilità di considerare l’intervento con il quale viene
effettuata la circoncisione come un atto medico, indispensabile ai fini della sussumibilità della
fattispecie in seno all’art. 348 c.p.
Dalla considerazione nei Paesi occidentali della circoncisione come una mutilazione genitale per il
bambino, oltreché una palese violazione del fondamentale comandamento del “primum non nocere”
che deve ispirare l'attività del sanitario, ne discende la sua natura di atto medico. Ciò perché “pur
in assenza di finalità terapeutica, essa interferisce sull'integrità fisica della persona, presuppone un
attento esame delle condizioni della medesima prima di essere eseguito, richiede l'osservanza di
determinate tecniche e di opportune precauzioni, impone il monitoraggio del decorso postoperatorio per prevenire eventuali complicazioni”. Insomma, trattasi di un vero e proprio intervento
chirurgico che comporta una manipolazione del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute.
Dichiaratane la natura di atto medico, la Corte ritiene, ciononostante, che non possa essere ignorato
il forte carico simbolico che connota la pratica della circoncisione rituale in determinate religioni,
come l'ebraismo e l'islamismo.
4
www.ildirittoamministrativo.it
In particolare, nell’ebraismo il riferimento nella Bibbia alla circoncisione come patto di sangue,
come alleanza tra Dio e il popolo ebraico è presente sin dal libro della Genesi; la pratica di tale rito
nell'osservanza di rigide regole rappresenta, considerate le profonde radici della civiltà ebraica in
occidente, una forte sfida culturale sia per l'imponenza (sotto il profilo numerico) del fenomeno, che
per le tematiche in esso coinvolte.
Dunque, alla luce degli imprescindibili legami tra la pratica della circoncisione e l’identità di talune
religioni, quali quella ebraica, occorre verificare se è possibile conciliare - ed entro quali limiti - allo
stato della legislazione vigente, due opposte esigenze: da un lato, la volontà di determinate
minoranze che vivono in Italia di rivendicare l'appartenenza alla propria etnia e l'osservanza delle
proprie tradizioni; dall'altro, il rispetto dei diritti inviolabili della persona, principio cardine del
nostro ordinamento giuridico.
Tale verifica, inoltre, per le implicazioni di carattere etico e giuridico che vengono in rilievo, deve
essere guidata da una prudente e illuminata interpretazione delle norme di riferimento, senza
sottovalutare la peculiare posizione del soggetto coinvolto nell'atto rituale incriminato.
Sennonché, avverte la Suprema Corte, sul tema della circoncisione rituale non esiste in Italia
una espressa normativa di legge, che specifichi il soggetto che può praticarla e il luogo in cui
può essere praticata.
Nell'ebraismo la circoncisione rituale è una cerimonia religiosa (c.d. brit milah, ossia patto del
taglio) con cui si dà il benvenuto ai neonati maschi nella comunità. Essa è effettuata, solitamente in
casa o in altro luogo privato, all'ottavo giorno dalla nascita del bambino, dal mohel, che di solito è
un medico o, comunque, una persona specializzata nella pratica della circoncisione e dei relativi
rituali. Quindi, il padre del neonato, avendo l'obbligo biblico di eseguire la circoncisione, ma non la
formazione medica necessaria ad eseguirla, affida a tale soggetto il compito di effettuarla.
La legge 8/3/1989 n. 101, di attuazione dell'Intesa stipulata nel 1987 tra lo Stato e l'Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, contiene un implicito riconoscimento della conformità della pratica
circoncisoria ebraica ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. Tanto si evince dal combinato
disposto degli artt. 2, comma 1, e 25 legge cit., in forza dei quali è garantito “il diritto di professare
e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma...e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto e i riti”', con la precisazione che l'attività di religione e di culto si svolge
liberamente in conformità dello Statuto dell'ebraismo italiano, senza alcuna ingerenza da parte dello
Stato, delle Regioni e degli altri Enti territoriali.
Pertanto, la circoncisione rituale praticata dagli ebrei su neonato non è in contrasto con il
nostro ordinamento e ha una preminente valenza religiosa che sovrasta quella medica.
In particolare, essa non contrasta con l’art. 19 Cost., che riconosce il diritto alla libertà di religione,
purché non vengano compiute pratiche contrarie al buon costume; ipotesi, questa, da escludere con
riguardo alla circoncisione, che non può considerarsi una pratica contraria ai principi etici o alla
morale sociale e non pregiudica la sfera dell'intimità e della decenza sessuale della persona.
5
www.ildirittoamministrativo.it
Inoltre, non vi è alcun contrasto con l'art. 30 Cost., che riconosce il diritto-dovere dei genitori di
educare i figli, nel quale deve comprendersi il riferimento all'educazione religiosa.
Ciò posto, giammai il mohel potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione
medica e la sua condotta, che oggettivamente integra il reato di lesione personale, è scriminata
se non determina una apprezzabile lesione permanente e non mostra segni di negligenza,
imprudenza o imperizia.
La causa di giustificazione a favore del mohel è quella del consenso dell'avente diritto ex art. 50
cod. pen., prestato validamente ed efficacemente dai genitori del neonato, per il compimento di un
atto che rientra tra quelli di disposizione del proprio corpo consentiti a norma dell’art. 5 cod. civ., in
quanto non determina una menomazione irreversibile con indebolimento permanente, né modifica il
modo d'essere dell'individuo sotto il profilo dell'integrità funzionale ovvero della capacità di vita di
relazione.
L’ipotesi di circoncisione non terapeutica per motivi religiosi è però diversa da quella, sempre
non terapeutica, riconducibile a motivazioni che esulano da esigenze religiose e identitarie e
affondano le loro radici soltanto in tradizioni culturali ed etniche, assolutamente estranee alla
cultura occidentale e non sempre compatibili, sul piano operativo, con la nostra legislazione.
In questi casi l'esecuzione dell'intervento cruento, a differenza di quanto accade nel mondo ebraico,
è affidata a persona non qualificata, ovverosia non dotata di adeguata e riconosciuta competenza,
che vi procede in modo empirico e senza alcuna concreta garanzia circa la sua corretta
effettuazione, lo scrupoloso rispetto dell'igiene e dell'asepsi, la continuità dell'assistenza anche dopo
l'intervento. In tali ipotesi, il nostro ordinamento considera prevalente il pericolo per la salute del
bambino rispetto ai contingenti fattori culturali ed etnici che ispirano, in certi contesti sociali, la
pratica in questione.
Ciò è riscontrabile nella vicenda oggetto della presente pronuncia, in cui la madre nigeriana,
pacificamente di fede cattolica, si è adeguata ad una pratica in uso presso la comunità di
appartenenza e notoriamente estranea al rito della religione cattolica, affidando il compito di
eseguire l'intervento circoncisorio ad una non meglio identificata donna nigeriana, certamente priva,
per ammissione implicita della stessa imputata, di qualsiasi professionalità adeguata al caso, tant’è
vero che il bambino, subito dopo l'intervento, ebbe un'emorragia che lo pose in pericolo di vita.
Al riguardo la Corte ravvede che “la scelta operata dalla predetta [madre] va letta come
espressione della cultura dalla medesima interiorizzata nell'ambito della comunità di provenienza e
nulla ha da condividere con la circoncisione rituale di matrice religiosa praticata dagli ebrei,
sicché non è invocabile, nella specie, l'esercizio del diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa.” In tal caso, non si può sottovalutare la delicatezza dell'intervento di circoncisione che,
per quanto semplice, rimane pur sempre un atto di natura medica e, in quanto tale, non può essere
affidato al libero esercizio di una qualsiasi persona, ma deve essere eseguito, di norma, da un
medico, in quanto soggetto professionalmente attrezzato per assolvere tale compito.
In tal caso, dunque, mancando una previsione legislativa del nostro ordinamento che legittimi tale
pratica, non può che operare la “riserva professionale” finalizzata a garantire la qualificazione e la
specifica competenza della persona che deve procedere all'intervento. Donde, in astratto è
6
www.ildirittoamministrativo.it
configurabile il precetto di cui all'art. 348 cod. pen., la cui violazione è contestata all'imputata a
titolo di concorso.
Si è in presenza, quindi, di un reato culturalmente orientato (detto anche reato culturale o reato
culturalmente motivato), che gli americani definiscono cultural offence. Nel reato culturalmente
orientato non viene in rilievo il conflitto interno dell'agente, vale a dire l'avvertito disvalore della
sua azione rispetto alle regole della sua formazione culturale, bensì il conflitto esterno, che si
realizza quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della
tradizione di un determinato gruppo etnico, migra in un'altra realtà territoriale, dove quelle norme
non sono presenti. Il reato commesso in condizione di conflitto esterno è espressione della fedeltà
dell'agente alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha interiorizzato sin dai primi
anni della propria vita.
Sennonché, pur essendo astrattamente in presenza del reato di cui all’art. 348 c.p., la Suprema Corte
esclude, tuttavia, la sussistenza del concorso nel reato de quo in capo all’imputata, per mancanza
dell’elemento soggettivo.
Difatti, il reato di cui all'art. 348 cod. pen. è punito a titolo di dolo, consistente nella coscienza e
volontà di concorrere nel compimento di un atto di abusivo esercizio della professione medica. La
citata norma è una norma penale in bianco, integrata da altre norme che disciplinano la professione
protetta e che penetrano nella struttura della prima, formando con questa un tutt'uno.
Occorreva, dunque, che i giudici di merito valutassero il processo di formazione della volontà
dell'imputata nel decidere di fare circoncidere il proprio bambino, di sottoporre lo stesso ad un
intervento di chirurgia minore, che, secondo la nostra legislazione, è normalmente di competenza
medica. Tale aspetto, invece, non è stato adeguatamente approfondito dalla sentenza impugnata, che
si limita ad affermare l'irrilevanza dell'eventuale 'errore/ignoranza' incidente sul precetto penale,
omettendo di valutare la posizione dell'imputata alla luce dell'art. 5 cod. pen., nel nuovo testo
risultante a seguito della sentenza additiva n. 364/1988 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
costituzionalmente illegittima la citata norma “nella parte in cui esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile”.
Il principio testè enunciato opera anche con riferimento alla norma extrapenale che va ad
incorporarsi nella fattispecie penale, in quanto la prima diventa anch'essa penale ai fini della
disciplina dell'ignorantia legis, con l'effetto che l'errore - se scusabile - deve essere apprezzato
come fattore di esclusione della colpevolezza, in forza del disposto dell'art. 5 cod. pen., nel testo
risultante dall'intervento del Giudice delle leggi.
La rilevanza dell’ignorantia legis scusabile implica che il giudizio di rimproverabilità del soggetto
agente deve necessariamente estendersi alla valutazione del processo formativo della sua volontà,
per stabilire se il medesimo soggetto, al momento dell'azione posta in essere, si sia o no reso conto
dell'illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma violata.
Ai fini di tale valutazione occorre raffrontare dati oggettivi, che possono avere determinato
nell'agente l’ignorantia legis circa l'illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi, attinenti
7
www.ildirittoamministrativo.it
invece alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di
non incorrere nell’error iuris.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ravvisa gli estremi dell'error iuris scusabile e,
conseguentemente, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Segnatamente, la Suprema Corte constata il dato oggettivo nel fatto che la donna di etnia africana,
migrata in Italia, non si era ancora integrata nel relativo tessuto sociale del nostro Paese, trovandosi
in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con immediatezza, valori e divieti a lei ignoti;
il dato soggettivo è invece ravvisato nel basso grado di cultura dell'imputata e nel mancato
avvertimento di un conflitto interno, circostanze queste che sfumano il dovere di diligenza
dell'imputata finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel diverso contesto
territoriale in cui era venuta a trovarsi.
Inoltre, conferma indiretta dell’assenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 348 c.p. si
coglie altresì nel comportamento post delictum dell'imputata che, resasi conto che il figlio
necessitasse di assistenza medica, non esitò a ricoverarlo in ospedale e a riferire ai sanitari, senza
alcuna reticenza e con molta naturalezza, quanto accaduto.
In conclusione, può dirsi che la pronuncia in epigrafe offre uno spunto di riflessione sul tema più
generale dei reati culturalmente orientati e di come la giurisprudenza se ne sia occupata negli ultimi
anni con riguardo a diverse fattispecie penali. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di lavoro o
contro la libertà sessuale, commessi in danno di minori non considerati tali dal gruppo di
appartenenza; reati contro la famiglia (maltrattamenti in famiglia; matrimoni incestuosi, poligamici,
imposti, ecc.) commessi in contesti culturali nei quali è ancora imperante una concezione dello ius
corrigendi o dell’autorità maritale o della potestà genitoriale differente da quella europea; reati
contro la persona commessi mediante mutilazioni, ecc.
Conferma del recente interesse del legislatore verso tali fattispecie è data dall’introduzione, ad
opera della legge del 9 gennaio 2006, n. 7, dell’art. 583-bis c.p., che incrimina le pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili. Desta perplessità però la mancata previsione di
un’analoga fattispecie incriminatrice con riguardo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali
maschili.
Corte di Cassazione, sez. II, 24 novembre 2011, n. 43317: configura i reati di estorsione e tentata
estorsione l'utilizzazione di immagini di persone famose riprese in luoghi pubblici per fare
pressione sulle stesse a scopo di lucro. La condanna del fotografo dei vip, Fabrizio Corona, nel
famoso caso “Vallettopoli”.
La pronuncia in epigrafe prende le mosse dalla famosa inchiesta sul caso “Vallettopoli”, termine
coniato dai mass media per indicare l’indagine condotta dalla Procura di Potenza a partire dal
giugno 2006, che ha coinvolto noti imprenditori, nonché personaggi dello sport, dello spettacolo e
della politica.
8
www.ildirittoamministrativo.it
Nel caso in esame, i reati contestati al principale imputato, l’imprenditore Fabrizio Corona, sono
quelli di estorsione e tentata estorsione in danno dei calciatori Coco ed Adriano, per essersi il
Corona procurato immagini fotografiche delle presunte vittime, ritenute più o meno
“compromettenti”, ed averne offerto la restituzione agli interessati dietro compenso, affinché ne
fosse evitata la pubblicazione giornalistica.
Mentre il Tribunale di Milano dichiara colpevole il Corona per i reati in questione, la Corte di
Appello di Milano, in riforma della sentenza appellata, pronuncia la parziale assoluzione
dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, ritenendo che la somma pagata dal
Coco, pari a seimila euro, fosse corrispondente a quanto Corona avrebbe potuto ricavare vendendo
lecitamente le foto in considerazione della notorietà del personaggio.
Come avverte la Corte d’Appello, il caso di specie necessita della ricostruzione del quadro
normativo e giurisprudenziale rilevante ai fini dell’identificazione dei criteri di contemperamento
tra il diritto all’immagine, alla riservatezza, all’onore, al decoro e alla reputazione, da un lato, e il
diritto all’informazione, dall’altro.
Sotto il profilo normativo, si osserva che il diritto all’immagine è tutelato dagli artt. 10 c.c., 96 e
97 L. 22.4.1941 n. 633; a presidio del diritto alla riservatezza soccorrono le norme
sull’inviolabilità del domicilio, l’art. 14 della Cost., gli artt. 614, 615 e 615 bis c.p., il d.lgs.
30.6.2003 n. 196; quanto al diritto alla reputazione, vengono in rilievo gli artt. 595, 596, 596 bis
c.p., la legge sulla stampa n. 47 dell’8.2.1948, la legge sul sistema radiotelevisivo n. 223 del
6.8.1990.
Sotto il profilo giurisprudenziale, la corte territoriale richiama importanti arresti della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
- la diffusione di immagini di persone note può ritenersi lecita soltanto se corrisponda ad esigenze di
pubblica informazione (Cass., I sez. civile, n. 1503 del 6.2.1993; Cass., sez. III civile n. 8838 del
13.4.2007; Cass., I sez. civile, n. 21172 del 29.9.2006; Cass., III sez. civile, n. 6507 del 10.5.2001);
- anche gli aspetti della vita privata di persone famose nel campo dello sport o dell’economia
rientrano nell’interesse pubblico che giustifica la loro diffusione qualora abbiano riflessi sull’attività
dei soggetti medesimi;
- è comunque abusiva l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine quando sia tale da arrecare
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta;
- il diritto alla reputazione è un diritto perfetto, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale
della persona umana, trovando fondamento normativo nell’art. 2 Cost. Esso trova importanti
deroghe nella possibilità per l’interessato di provare la verità del fatto prevista dall’art. 596 c.p. e va
contemperato con l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, la cui efficacia esimente è da tempo
normativamente consolidata.
La Corte di Cassazione, pur apprezzando la sopracitata ricostruzione del quadro normativogiurisprudenziale, ritiene però che la Corte territoriale finisca per attestarsi sul criterio tradizionale
del contenuto oggettivamente denigratorio della diffusione di notizie o immagini della vita privata
di taluno.
9
www.ildirittoamministrativo.it
In secondo luogo, secondo la Cassazione, la Corte territoriale non considera che il danno alla
reputazione o all’onore, che può ricollegarsi alla diffusione delle immagini di una persona senza il
consenso dell’interessato, non è un elemento necessariamente condizionante né della tutela
civilistica (si pensi, ad esempio, al fatto che l’art. 10 c.c., in assenza di danni per il decoro e la
reputazione, accorda comunque all’interessato una tutela interdittiva), né della rilevanza penale
della condotta di abuso. Difatti, nella più recente legislazione in materia, si è ormai affermato il
principio secondo cui nessuno può essere espropriato, se non a determinate condizioni e in
vista del soddisfacimento di interessi altrettanto meritevoli di tutela, del diritto esclusivo di
disporre della propria immagine come di ogni altro dato personale. In senso conforme a tale
principio, infatti, il legislatore ha utilizzato in senso ampio l’espressione “dato personale”, da
intendersi come “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 2 lett. c. L. 31
dicembre 1996, n. 675, successivamente confluito nell’art. 4, comma 1, lett.b) del d.lgs. 196/2003).
All’ampiezza di tutela in ambito civilistico corrisponde altresì un’accentuazione della tutela
penalistica.
Difatti, l’art. 35 l. 675/1996 punisce con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni, la condotta di chi al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 20 e 27 leg. cit., salvo che il fatto costituisca più
grave reato (comma 1); con la reclusione da tre mesi a due anni la condotta di chi, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24 leg. cit., ovvero del divieto di cui
all’articolo 28, comma 33 leg. cit. (comma 2); con un aggravamento della pena se dai fatti “deriva
nocumento” (comma 3).
Dalle richiamate disposizioni si evince che la considerazione del danno (al pari del fine di profitto),
sub specie di dolo specifico, nonché la previsione come semplice circostanza aggravante del
nocumento effettivo che derivi all’interessato dalla condotta incriminata, indicano che nella
fattispecie di trattamento abusivo di dati personali la tutela penale è attivata già dalla sola
comunicazione o diffusione non autorizzata degli stessi dati per gli scopi tipicamente previsti
dalla norma. Il danno rimane estraneo alla struttura oggettiva del reato, giacché inteso come
conseguenza pregiudizievole della condotta del reo distinta dalla lesione del diritto alla riservatezza
invariabilmente tutelato.
Con particolare riguardo al trattamento di dati personali nell’esercizio della professione di
giornalista, l’art. 25 della legge n. 675/1996 prevede che “le disposizioni relative al consenso
dell’interessato e all’autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall’articolo 24, non si
applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell’esercizio della
professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità”.
Donde, la rigorosa limitazione della deroga alla tutela della privacy quando sia in questione
l’interesse pubblico legato all’informazione giornalistica, cosicché il perseguimento delle finalità
giornalistiche costituisce condizione della legittimità della diffusione di dati personali in assenza
dell’autorizzazione dell’interessato.
10
www.ildirittoamministrativo.it
Da tale impianto normativo la Suprema Corte fa discendere alcuni corollari.
- “il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i
dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico”;
- “non sono date alternative alla pubblicazione giornalistica di dati personali altrui come forma
di utilizzazione commerciale delle informazioni da parte di chi ne sia venuto in possesso.
L’equazione pubblicabilità - commerciabilità delle immagini, sostenuta dalla difesa,
comporterebbe invece la dilatazione dei limiti di comunicazione-diffusione di dati personali altrui
espressamente previsti dalla legge, fino ad una sostanziale libertà di offerta del prodotto ad un
pubblico indeterminato di possibili acquirenti. L’allargamento dell’area di contendibilità
commerciale di “prodotti” riguardanti la persona comporterebbe evidenti effetti distorsivi in un
mercato in cui sono implicati essenziali valori umani (tanto che persino il diritto all’informazione
subisce dei limiti, secondo principi di essenzialità e di continenza”, superati i quali va riaffermata
la rilevanza penale del fatto; cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 17215 del 17/02/2011)”. Pertanto,
“l’unica alternativa alla diffusione, nel circuito mediatico, di immagini di personaggi noti, in
assenza dell’ autorizzazione degli interessati, è costituita dalla rinuncia alla loro utilizzazione, e
ogni diverso tentativo di utilizzazione integrerà un abuso punibile ai sensi dell’art. 35 L.
675/1996 (oggi 167 d.lgs. n. 196 del 2003)”;
- “non è consentito al possessore dell’informazione “sensibile” di lucrare i vantaggi del
coinvolgimento, nella possibile competizione, del diretto interessato, e di sfruttare, nel versante
“privato”, le variabili percezioni soggettive della potenziale dannosità della diffusione dei propri
dati personali, in un ambito in cui la motivazione all’acquisto sarebbe inevitabilmente
condizionata da comprensibili aspetti emotivi”;
- il diritto di pubblicare le immagini di cui all’art. 25 della legge n. 675/1996 e succ .mod. non
integra un’esimente allorché esso non venga esercitato per gli scopi consentiti dalla legge, ma per
scopi della legge chiaramente vietati, mercé la formula dell’esclusività dell’utilizzazione
giornalistica;
- oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico vigente è anche l’interesse della persona, fisica o
giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, ovverosia di
coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione
che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro
comportamenti altrui che menomino tale immagine pur senza offendere l’onore o la reputazione
(tanto in consonanza con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass.
pen., sez. V, 16 giugno 2011, n. 37383).
Alla luce di tali considerazioni, con riguardo al caso di specie, la Suprema Corte ritiene incongrua la
valutazione in termini di “neutralità” della somma di ben 6.000 euro sborsata dal Coco per rientrare
in possesso delle fotografie oggetto dell’imputazione, stante l’irrilevanza della corrispondenza di
detto importo al prezzo delle foto sul mercato giornalistico. Al contrario, è proprio la costante
presenza sui mass media delle persone offese che avrebbe fatto abbassare il prezzo nel caso in cui si
fosse trattato di foto di routine. Peraltro, a far aumentare la tariffa è la particolare circostanza nella
quale i soggetti in questione sono stati ripresi.
11
www.ildirittoamministrativo.it
Rilevante risulta, quindi, la peculiare condizione personale dei soggetti passivi del reato, calciatori
di fama nazionale, nonché soggetti avvezzi, per la loro notorietà, ad una ovvia esposizione
mediatica. Sennonché un soggetto abituato alla notorietà mediatica non avrebbe avuto alcun motivo
di affrontare un impegno economico non indifferente per evitare la pubblicazione di una delle sue
tante immagini, se non per la preoccupazione di ricavare un qualunque pregiudizio dalla loro
diffusione, ed in ragione del fatto che i dati personali desumibili dalle immagini si prestassero in
concreto, in qualunque misura, a letture maliziose potenzialmente pregiudizievoli rispetto alla
rappresentazione di entrambi nel pubblico come seri professionisti dello sport. Trattasi, infatti, di
soggetti professionalmente impegnati in attività sportive che potevano avere interesse a proporre di
sé al pubblico un’immagine pienamente conforme alle sobrie abitudini di vita congeniali a chi deve
massimizzare la propria forma fisica; immagine che poteva essere offuscata, al contrario, dalla
rivelazione “pubblica” di abitudini di vita sospette di sregolatezza.
Né può paragonarsi l’interesse commerciale di una testata giornalistica a quello personale di un
“privato”, sicché la circostanza che il Coco si stato indotto all’acquisto a quelle particolari
condizioni conferma gli indebiti vantaggi che il possessore di dati personali altrui può ritrarre
dall’allargamento della competizione commerciale per l’acquisto del prodotto oltre i limiti di
utilizzazione previsti dalla legge.
Il Corona, quindi, avrebbe avuto il diritto di far pubblicare le foto in suo possesso, ma alla stregua
dell’unica forma di utilizzazione economica consentitagli, mentre egli fece valere la prospettiva
della pubblicazione come strumento di pressione sulle persone offese per ottenere da loro un
compenso per la restituzione delle foto. Di qui l’applicabilità nel caso di specie del principio
richiamato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui anche la
prospettazione, all’apparenza legale, dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al
soggetto agente diviene “contra ius” allorché sia diretta ad ottenere scopi non consentiti o
risultati non dovuti e non conformi a giustizia (cfr. ad es., Cass. pen., sez. II, 04/11/2009, n. 119).
Donde, configura i reati di estorsione e tentata estorsione l’utilizzazione di immagini di
personaggi noti ripresi in locali pubblici al fine di fare pressione sui diretti interessati a scopo
di lucro, giacché uso distorto del diritto a vendere immagini del giornalista. Soltanto
l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere la notizia rende lecita la commercializzazione
dell'immagine.
12