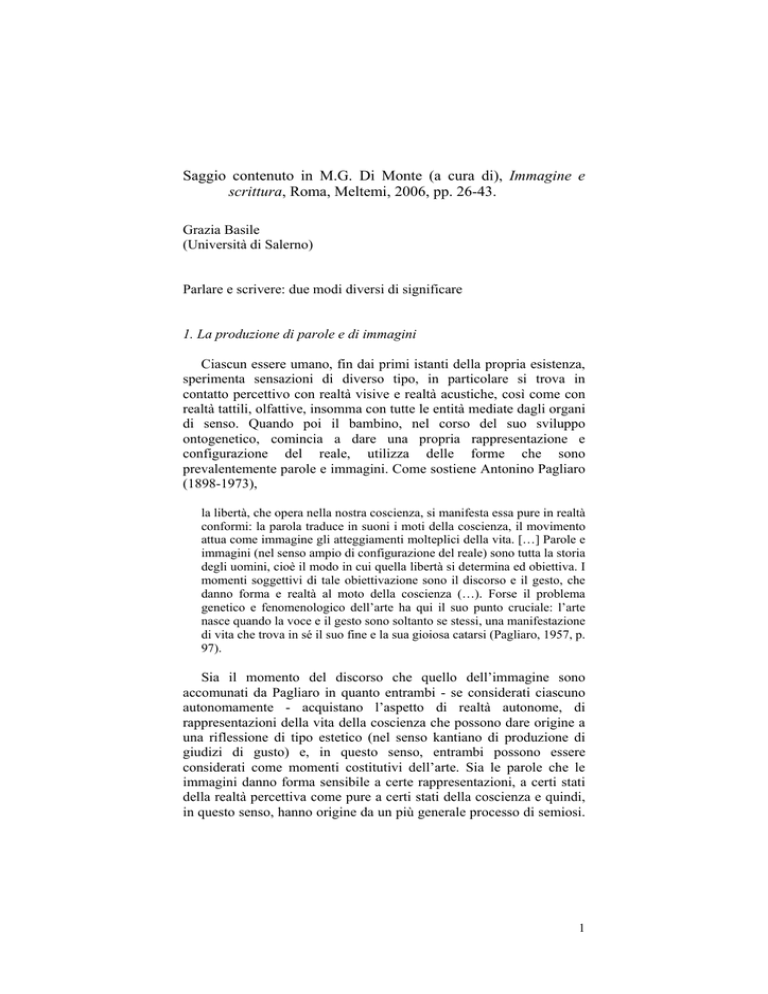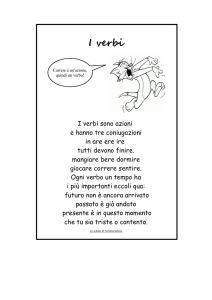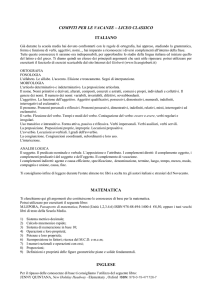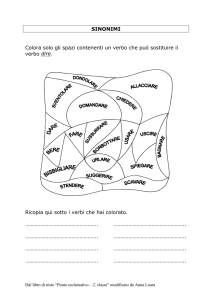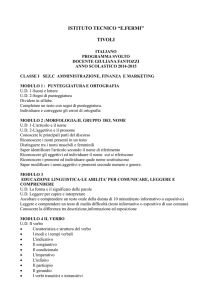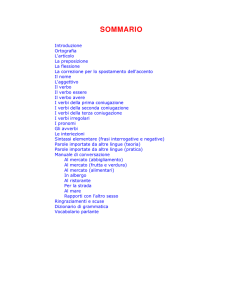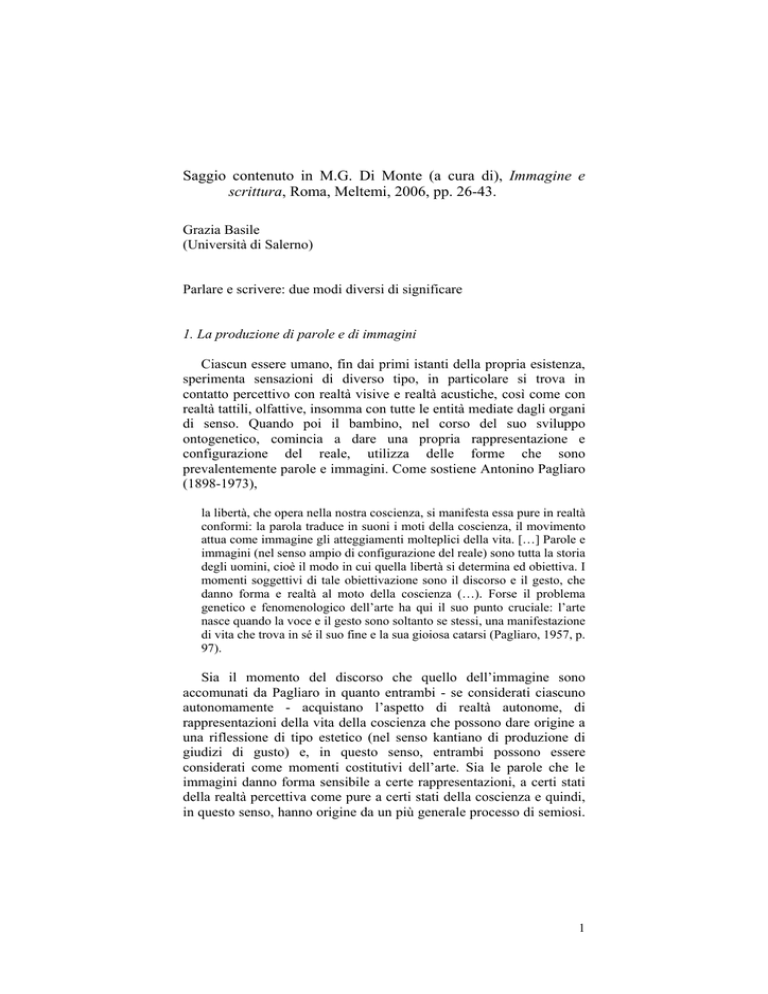
Saggio contenuto in M.G. Di Monte (a cura di), Immagine e
scrittura, Roma, Meltemi, 2006, pp. 26-43.
Grazia Basile
(Università di Salerno)
Parlare e scrivere: due modi diversi di significare
1. La produzione di parole e di immagini
Ciascun essere umano, fin dai primi istanti della propria esistenza,
sperimenta sensazioni di diverso tipo, in particolare si trova in
contatto percettivo con realtà visive e realtà acustiche, così come con
realtà tattili, olfattive, insomma con tutte le entità mediate dagli organi
di senso. Quando poi il bambino, nel corso del suo sviluppo
ontogenetico, comincia a dare una propria rappresentazione e
configurazione del reale, utilizza delle forme che sono
prevalentemente parole e immagini. Come sostiene Antonino Pagliaro
(1898-1973),
la libertà, che opera nella nostra coscienza, si manifesta essa pure in realtà
conformi: la parola traduce in suoni i moti della coscienza, il movimento
attua come immagine gli atteggiamenti molteplici della vita. […] Parole e
immagini (nel senso ampio di configurazione del reale) sono tutta la storia
degli uomini, cioè il modo in cui quella libertà si determina ed obiettiva. I
momenti soggettivi di tale obiettivazione sono il discorso e il gesto, che
danno forma e realtà al moto della coscienza (…). Forse il problema
genetico e fenomenologico dell’arte ha qui il suo punto cruciale: l’arte
nasce quando la voce e il gesto sono soltanto se stessi, una manifestazione
di vita che trova in sé il suo fine e la sua gioiosa catarsi (Pagliaro, 1957, p.
97).
Sia il momento del discorso che quello dell’immagine sono
accomunati da Pagliaro in quanto entrambi - se considerati ciascuno
autonomamente - acquistano l’aspetto di realtà autonome, di
rappresentazioni della vita della coscienza che possono dare origine a
una riflessione di tipo estetico (nel senso kantiano di produzione di
giudizi di gusto) e, in questo senso, entrambi possono essere
considerati come momenti costitutivi dell’arte. Sia le parole che le
immagini danno forma sensibile a certe rappresentazioni, a certi stati
della realtà percettiva come pure a certi stati della coscienza e quindi,
in questo senso, hanno origine da un più generale processo di semiosi.
1
Non è un caso, a questo proposito, che in quasi tutte le civiltà gli inizi
della scrittura presentino delle caratteristiche simili:
i primi tentativi sono sempre stati disegni, pittogrammi o combinazioni di
pittogrammi. Alcuni di questi ultimi, pur appartenendo a civiltà molto
diverse tra loro, presentano rassomiglianze sorprendenti (Jean, 1986, pp.
46-47).
Partiamo dunque da un punto di vista semiotico più generale,
richiamandoci alla definizione di semiotica data da Umberto Eco nel
Trattato di semiotica generale (1975), per cui la semiotica ha a che
fare con qualsiasi cosa possa essere assunta come segno, intendendo
genericamente per segno ogni cosa che possa essere assunta come un
sostituto significante di qualcosa d’altro (cfr. Eco, 1975, p. 17)1. Il
momento - per dir così - costitutivo e trascendentale di un segno è
dato dalla nascita di una qualsivoglia rappresentazione, la quale
prevede sia un’operazione di tipo intellettuale, sia lo stabilirsi di un
principio di intesa con se stessi e con gli altri.
Noi esseri umani partiamo da un primo livello di semiosi in cui
fissiamo la nostra attenzione su qualcosa (per esempio su un animale,
un oggetto, il volto di una persona ecc.), insomma individuiamo
qualcosa che desta la nostra attenzione e con cui dobbiamo fare i
conti2, e quindi ci poniamo in rapporto unicamente con la referenza.
Tuttavia, nel momento in cui stabiliamo che quel qualcosa debba
avere un nome, e dunque nel momento in cui ci poniamo all’interno di
un codice di tipo linguistico che regola il processo di significazione,
compiamo un salto teorico molto importante e la questione diventa più
complessa. Siamo in presenza di un segno, di un’entità - per rifarci
all’insegnamento del Corso di linguistica generale di Ferdinand de
Saussure (1857-1913) - concepita come l’unione di un significante
(inteso come classe astratta di fonie) e di un significato (inteso come
classe astratta di significazioni), e, di conseguenza, di un codice come
sistema di segni. L’esistenza di un codice è la condizione di possibilità
1
È interessante notare – soprattutto in relazione al rapporto tra immagine e scrittura - come
la parola latina signum, da cui deriva la parola italiana segno era lo stendardo che ciascuna unità
dell’esercito romano innalzava in modo che potesse essere identificato visivamente. Come
documenta Ong (1982, p. 110), “etimologicamente, indicava l’ ‘oggetto che uno segue’, dalla
radice proto-indoeuropea sekw- seguire. Sebbene i Romani conoscessero l’alfabeto, questo
signum veniva inteso non come una parola scritta, ma come una specie di disegno o immagine
pittorica, ad esempio un’aquila”.
2
Cfr. Eco (1997), il quale a questo proposito sostiene che questo qualcosa è la condizione di
ogni semiosi e “precede persino quell’atto di attenzione (già semiosico, già effetto di pensiero)
per cui decido che qualcosa è pertinente, curioso, intrigante, e deve essere spiegato attraverso
un’ipotesi. Viene prima ancora della curiosità, prima ancora della percezione dell’oggetto in
quanto oggetto” (Eco, 1997, p. 6).
2
perché ci sia significazione e perché ci sia comunicazione tra gli esseri
umani.
Come aveva ben sottolineato Ernst Cassirer (1874-1945) nel suo
Saggio sull’uomo, il produrre/fruire di segni e significazioni appare
connaturato alla condizione specie-specifica del soggetto umano,
concepito quale animale simbolico-culturale. L’uomo condivide con
le altre specie animali il sistema ricettivo e quello reattivo, ma tipico
dell’animale umano è un terzo sistema che Cassirer chiama “sistema
simbolico, l’apparizione del quale trasforma tutta la sua situazione
esistenziale [corsivi nel testo]” (Cassirer, 1944, p. 79). L’uomo quindi
non vive più in un universo soltanto fisico ma in un universo simbolico. Il
linguaggio, il mito, l’arte e la religione fanno parte di questo universo,
sono i fili che costituiscono il tessuto simbolico, l’aggrovigliata trama
della umana esperienza. (…) Invece di definire l’uomo come un animal
rationale si dovrebbe dunque definirlo come un animal symbolicum. In tal
guisa si indicherà ciò che veramente lo caratterizza e che lo differenzia
rispetto a tutte le altre specie e si potrà capire la speciale via che l’uomo
ha preso: la via verso la civiltà (Cassirer, 1944, pp. 80-81).
In quest’ottica è di importanza cruciale il rapporto tra il linguaggio
e tutto il mondo non linguistico della nostra esperienza. A questo
proposito, parliamo di lessicalizzazione per riferirci a quel
fondamentale processo per cui nel e attraverso il sistema linguistico
diamo forma a configurazioni e agglomerati esperienziali con una
forte rilevanza (vedi Violi, 1997, p. 5). In pratica ciò che viene
lessicalizzato è tutto ciò che è avvertito come maggiormente rilevante
o saliente a livello percettivo, esperienziale, culturale, simbolico ecc.,
e dunque tutto il rapporto tra la lingua e il mondo extralinguistico
passa attraverso il filtro del nostro apparato fisico, percettivo e
simbolico di esseri umani finiti e inseriti in un determinato ambiente
naturale e culturale.
Tuttavia i modi di dare forma a configurazioni e agglomerati
esperienziali di rilievo non sono soltanto - come si sa - modi
linguistici, nel senso che, a livello di costituzione del segno, la parte
materiale di quest’ultimo può essere di tipo fonico-acustico, visivo,
mimico-gestuale ecc., a seconda dei diversi tipi di codici di cui come
esseri umani disponiamo. Come sottolinea Pagliaro,
la difficoltà in cui si trovò il primo uomo che volle richiamare la visione
di una lepre in fuga, è in sostanza dello stesso ordine di quella di un
pittore che voglia visivamente rappresentare uno stato d’animo, legato
con una sensazione acustica. Supponiamo che egli intenda obiettivare con
i mezzi della sua arte il rumore del vento: non avrà altra possibilità se non
di rifarsi a esperienze di ordine visivo, che nella sua e nell’altrui
3
coscienza sono in grado di evocare le sensazioni di vario ordine provocate
da quel valore acustico. Potrà, ad esempio, rappresentare un gruppo di
alberi che si piegano sotto la raffica, un cascinale con le imposte battute a
mezz’aria, scompiglio di panni sull’aia e magari un cavallo che nitrisce
gagliardamente alle aure (Pagliaro, 1957, pp. 77-78).
Nelle parole di Pagliaro è espresso un aspetto semiotico di primaria
importanza, ossia la possibilità di trasferire un contenuto di tipo
mentale, percettivo ecc. in un codice di qualche tipo. Il materiale
contenutistico a cui vogliamo dar forma (sia essa grafica, pittorica,
mimica ecc.) è, in un certo senso, multimediale: è composto da
percezioni, affetti, emozioni, ricordi ecc. e i vari tipi di codice nei
quali può trovare espressione sono prodotti, in parte, dai vari organi
percettivi: abbiamo così immagini, odori, sapori, sensazioni tattili,
suoni. Tra i vari tipi di codice esiste una sorta di comunicazione
intrinseca, nel senso che è possibile quella che Roman Jakobson
(1896-1982) aveva chiamato la traduzione intersemiotica (vedi
Jakobson, 1959, p. 57), che consente da una parte - come sostiene
Jakobson - l’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di sistemi
di segni non linguistici, e, dall’altra – potremmo dire - anche la
traduzione, la comunicazione tra tipi di codici diversi.
Nel caso particolare della produzione dei testi orali e/o scritti, è
come se nella mente dell’autore che decide di produrre, di comunicare
un determinato contenuto informativo cominciasse a prendere forma
un cosiddetto testo mentale. Questo testo mentale non è – come
potrebbe apparire a prima vista – interamente frutto della creatività
individuale dell’autore. Ognuno di noi infatti è sottoposto a continue
influenze che vengono dall’esterno, e ciò che pensiamo è frutto sì
della nostra originale creatività e capacità di elaborazione, ma risente
anche delle caratteristiche dell’ambiente culturale in cui ci troviamo.
Una volta pensato, tale testo mentale può materializzarsi, trovare una
forma percepibile dai nostri organi di senso in vari modi. In questa
sede prenderemo in considerazione il modo in cui il piano dei nostri
contenuti mentali, il piano del nostro immaginario trova forma
espressiva nell’oralità e/o nella scrittura.
2. Sulle origini della scrittura
Prendiamo ora in esame alcune teorie sull’origine della scrittura.
Platone (427-347 a.C.) nel Fedro attribuisce al faraone egiziano
Thamus un elogio dei discorsi parlati e una serie di argomentazioni
volte a deprezzare l’invenzione della scrittura, opera del dio Theuth
che avrebbe creato la scrittura e ne avrebbe poi fatto dono agli
4
uomini3. In sostanza, Thamus rimprovera a Theuth di avere inventato
un’arte che offre soltanto finzioni artificiose e spurie dei discorsi veri,
che sono i discorsi parlati. La prima obiezione che il Socrate di
Platone muove alla scrittura è la seguente:
E ora tu, padre di esse lettere, per amore hai affermato esse fare il
contrario di quello che fanno. Conciossiaché elle cagionano
smemoramento nelle anime di coloro che le hanno apprese, perocché più
non curano della memoria, come quelli che, fidando della scrittura, per
virtù di stranii segni di fuori si rammentano delle cose, non per virtù di
dentro e da sé medesimi. Dunque trovato hai medicina, non per accrescere
la memoria, sibbene per rievocare le cose alla memoria (Platone,
Phaedrus, LIX; trad. it. 1970, pp. 561-562).
La seconda obiezione è che la parola scritta è simile alla pittura, in
quanto non sa rispondere e, se interrogata “maestosamente tace”, non
entra nello scambio dialettico e continua a significare sempre la stessa
cosa, senza possibilità di tornare su se stessa e offrire spiegazioni di
altro tipo. Sostiene infatti il Socrate di Platone:
Ché, o Fedro, la scrittura ha di grave questo; ed è proprio simile alla
pittura. Imperocché i figliuoli di questa stanno lì come vivi; ma se alcuna
cosa domandi, maestosamente tacciono: e così le orazioni scritte. Le quali
tu crederesti che un poco abbiano a intendere quel che dicono; ma se le
interroghi su alcuna delle cose che dicono, per desiderio di apprendere,
significano sempre il medesimo [corsivi nostri] (Platone, Phaedrus, LIX;
trad. it. 1970, p. 562).
Il discorso scritto sarebbe un figlio bastardo di quello orale e
nient’altro. Al contrario, la parola parlata, in quanto evento sonoro,
sarebbe “agonistica ed enfatica, frutto di una situazione concreta,
dell’interagire immediato tra esseri umani” (Ong, 1982, p. 7).
Se passiamo brevemente in rassegna i vari sistemi di scrittura
prodotti dall’uomo - dal sistema cuneiforme in Mesopotamia nel 3500
a.C. ai geroglifici egiziani nel 3000 a.C., dalla cosiddetta scrittura
lineare B minoica o micenea nel 1200 a.C. alla scrittura della Valle
dell’Indo dal 3000 al 2400 a.C., dalla scrittura cinese del 1500 a.C. a
quella maya del 50 d.C. o a quella azteca del 1400 d.C. - possiamo
osservare che la maggior parte di essi “risale direttamente o meno a
qualche tipo di pittografia, o forse a volte a un livello ancora più
elementare, all’uso di oggetti simbolici” (Ong, 1982, p. 127). La
3
La parola geroglifico, che viene usata per designare questo tipo di caratteri della scrittura
egizia, letteralmente significa “scrittura degli dèi” (dal greco hieròs “sacro” e gluphèin
“incidere”). Le prime attestazioni di iscrizioni geroglifiche risalgono al III millennio a.C., anche
se sembra che tale tipo di scrittura fosse in uso già nei secoli precedenti (cfr. Jean, 1986, p. 27).
5
differenza fondamentale tra i pittogrammi e i sistemi di scrittura è che
nei primi il disegno di un albero, ad esempio, significa effettivamente
la parola albero, mentre i secondi sviluppano altri tipi di
simbolizzazione. Questa presenza dell’attività di simbolizzazione
dell’uomo è presente già negli ideogrammi, il cui significato è
stabilito dal codice linguistico adottato da una determinata comunità
linguistica e non è direttamente raffigurato dal disegno. Come
documenta Ong, “nel sistema pittografico cinese un disegno stilizzato
di due alberi non rappresenta le parole ‘due alberi’, ma la parola
‘bosco’; i disegni stilizzati di una donna e di un bambino affiancati
rappresenta la parola “bene”, e così via” (Ong, 1982, p. 129).
Nel caso dei geroglifici, insomma, ci sarebbe una certa somiglianza
o congruenza tra notazioni e idee, mentre nel caso degli ideogrammi e
poi delle parole il legame sarebbe arbitrario e basato su una
convenzione. Gli alfabeti sarebbero dunque derivati da scritture
simboliche, come quella geroglifica, e se ne sarebbero via via
allontanati fino a perdere ogni somiglianza con le entità significate4.
3. A proposito di parlato e di scritto
Tornando al dialogo platonico, i linguisti hanno spesso ripreso le
affermazioni del faraone Thamus, evidenziando la secondarietà dello
scritto rispetto al parlato (cfr. De Mauro, 1971). Prendiamo spunto da
questo dialogo per evidenziare le differenze tra scritto e parlato che
negli ultimi anni sono state al centro di numerosi dibattiti tra i
linguisti.
Parlato e scritto sono costitutivamente diversi nel senso che danno
espressione per mezzo di una sostanza diversa (fonico-acustica o
grafico-visiva) al continuum del dicibile e dell’esprimibile. In
generale, lo scritto viene spesso definito come un prodotto piuttosto
che come un processo, mentre il parlato rappresenterebbe in maniera
più iconica il fluire degli eventi. La scrittura - in sostanza - pone il
discorso davanti ai nostri occhi e, contestualmente, accresce le
potenzialità della conoscenza cumulativa e dell’immagazzinamento di
informazioni nella nostra memoria.
4
A questo proposito cfr. Givón (1985, p. 193 sgg.) a proposito dell’evoluzione graduale
della lettera A nel nostro alfabeto a partire dalla rappresentazione pittorica della testa di un toro
con le corna e proseguendo per successivi livelli di astrazione fino a giungere alla nostra A, così
che “the magic of iconicity has been lost, and the gradual process of abstraction/generalization of
the isomorphic/iconic model has been completed” (Givón, 1985, p. 195).
6
In questa sede5 ci soffermeremo, da un lato, sulle diverse funzioni
che caratterizzano il parlato rispetto allo scritto, e, dall’altro, su alcuni
dati lessicali, in particolare, sulle differenze quantitative e qualitative
dei nomi e dei verbi nel parlato e nello scritto, per cui nel primo caso
abbiamo una prevalenza di verbi e nel secondo di nomi. Tali
differenze - a nostro parere - sono da attribuire non tanto a fattori
specificamente semantici, quanto piuttosto, in un’ottica in cui la
semantica interagisce con le strategie discorsive e testuali, sono da
ricondurre alla base pragmatica che caratterizza gli eventi
comunicativi e influenza la categorialità.
3.1. Le funzioni del parlato e dello scritto
Negli ultimi anni il parlato e lo scritto sono stati ricondotti,
secondo una terminologia introdotta da Alberto Mioni (1983), alla
variazione cosiddetta diamesica, ossia a quel tipo di variazione
condizionata dal mezzo (orale o scritto) impiegato nella
comunicazione. È una variazione di tipo particolare che taglia - per dir
così - trasversalmente le altre varietà, proprio perché sia a livello
diacronico, diatopico, diastratico e diafasico possiamo trovare delle
realizzazioni scritte e parlate (cfr. lo schema proposto da Gaetano
Berruto, 1987: 21 per dar conto delle varietà presenti nel repertorio
linguistico dell’italiano contemporaneo). Nella tradizione linguistica
italiana è sempre esistita una profonda separazione tra il livello della
scrittura e il livello dell’oralità, tanto che in taluni momenti l’uso
dell’uno o dell’altro mezzo era sufficiente a selezionare un codice
linguistico diverso, ad esempio l’italiano letterario per la scrittura e il
dialetto locale per l’oralità, comportando pertanto non soltanto
variazione, ma addirittura una situazione di bilinguismo. In generale,
nell’architettura degli usi sociolinguistici di tutte le lingue, tali poli
sono di norma piuttosto distanti tra loro, innanzitutto perché non
poche lingue sono soltanto parlate (e dunque non presentano varietà
differenziate diamesicamente), e, in secondo luogo, perché nelle
lingue in cui esiste la scrittura questa nasce per riprodurre,
memorizzare e trasmettere il parlato a distanza di spazio e di tempo, e
questo fatto la rende, di conseguenza, conservatrice rispetto alla
dinamicità del suo modello parlato. Senza contare che in una gran
parte delle comunità linguistiche la scrittura è, almeno nelle fasi
iniziali, appannaggio di ristrette cerchie (di intellettuali, di sacerdoti,
di aristocratici ecc.) che tendono ad accentuare il conservatorismo
delle produzioni scritte a fini discriminatori. Se ci poniamo in una
5
Per quanto riguarda le principali caratteristiche del parlato a livello di percezione, di
ricorso a elementi deittici per l’organizzazione del discorso, a livello sintattico, di ordine dei
costituenti, a livello di morfologia, di pronuncia e di lessico rimandiamo a Berruto (1993; 20005).
7
prospettiva storica ed evolutiva, il parlato è chiaramente primario, nel
senso che viene acquisito prima dello scritto, tuttavia, una volta che
una cultura ha sviluppato la comunicazione scritta, non c’è nessuna
ragione di considerare lo scritto come secondario6.
Sebbene sia lo scritto che il parlato possano essere usati per quasi
ogni bisogno comunicativo, noi - come ha messo in evidenza Douglas
Biber in Variation across Speech and Writing (1988) - di fatto non
usiamo le due forme in maniera intercambiabile, ma, a seconda delle
diverse situazioni comunicative, scegliamo una modalità piuttosto che
un’altra. Infatti, una volta che una cultura ha sviluppato una forma
scritta in aggiunta a una forma orale, le due modalità rispondono a
differenti scopi comunicativi.
Parlato e scritto sono insomma diversi e nessuno è primario
rispetto all’altro. Lingua scritta e lingua parlata sono funzionalmente
diverse nel senso che significano in modi diversi. Come abbiamo già
visto nel paragrafo 1, noi esseri umani ci cimentiamo fin dai primi
istanti della nostra vita con operazioni di semiosi, ossia tentiamo di
dare una forma, di porre delle delimitazioni sia alla serie di fenomeni
che ci si presentano dinanzi, sia, più in generale, alla materia del
contenuto di cui parla il linguista danese Louis Hjelmslev (18991965), dunque a tutto ciò che è pensabile, esprimibile e dicibile. Ad
una prima considerazione, la funzione principale del linguaggio
sembra essere dunque proprio quella di significare, ossia di dare
espressione a dei contenuti, a delle idee, a dei pensieri ecc.
Espressione e contenuto sono - per riprendere la definizione proposta
da Hjelmslev ne I fondamenti della teoria del linguaggio (1943) solidali, nel senso che si presuppongono reciprocamente in maniera
necessaria. Un’espressione è tale se e solo se è espressione di un
contenuto, e, viceversa, un contenuto è tale se e solo se è contenuto di
un’espressione. Insomma, espressione e contenuto hanno fra loro un
rapporto solidale che è di funzione segnica e quindi, considerando
rispettivamente il rapporto tra la forma dell’espressione e la forma del
contenuto, abbiamo un segno. Quando però abbiamo a che fare con la
lingua parlata o con la lingua scritta è proprio la sostanza
dell’espressione che è diversa, essendo costituita da materiale fonicoacustico nel caso del parlato e da materiale grafico-visivo nello scritto.
Ed è proprio tale diversità a livello di sostanza, oltre alle diverse
condizioni e ai diversi contesti di enunciazione che caratterizzano il
parlato rispetto allo scritto, che fa sì che il parlato e lo scritto si
6
La scrittura non è una semplice appendice del discorso orale “poiché trasportando il
discorso dal mondo orale-aurale a una nuova dimensione del sensorio, quella della vista, […]
trasforma al tempo stesso discorso e pensiero. Le incisioni sui bastoni e gli altri aides-mémoire
conducono infine alla scrittura, ma non ristrutturano l’ambiente vitale umano come fa la scrittura
vera e propria” (Ong, 1982, p. 127).
8
rapportino in maniera diversa al continuum di tutto ciò che è dicibile,
pensabile, esprimibile ecc.
Il parlato e la scrittura, in sostanza, impongono delle griglie diverse
all’esperienza e che, in un certo senso, creano realtà diverse, in
quanto, molto schematicamente, la scrittura creerebbe un mondo di
cose, di prodotti e il parlato un mondo di avvenimenti, di eventi (cfr.
Halliday, 1985, p. 167). La lingua scritta presenta una visione sinottica
della realtà e definisce il suo universo (cfr. supra, § 3) come prodotto
piuttosto che come processo. La lingua parlata, invece, presenta una
visione dinamica della realtà, in quanto essa definisce il suo universo
in prima istanza come processo, codificandolo non come una struttura,
ma come una costruzione e/o una demolizione7. Nella lingua parlata i
fenomeni - per dir così - non esistono, ma accadono, sono osservati
mentre nascono, cambiano, si muovono dentro e fuori il momento
dell’enunciazione e interagiscono tra loro in un flusso continuo e
progressivo. Inoltre, cambia anche il punto di vista del
parlante/scrivente, nel senso che, nel caso del parlato, il parlante (o
emittente) e l’ascoltatore (o ricevente) sono inestricabilmente immersi
nel processo comunicativo e hanno una funzione intercambiabile, in
quanto il parlante/emittente può diventare, in un turno successivo,
l’ascoltatore/ricevente e viceversa, mentre, nel caso dello scritto, chi
scrive è distante non solo dal/dai destinatario/i del messaggio scritto,
ma anche dal prodotto della propria attività, ossia dal foglio di carta,
di stoffa, di sughero ecc., dalla pergamena, dalla videata di un
computer ecc., insomma da tutti i supporti materiali sui quali si
depositano le parole scritte.
La differenza più saliente fra parlato e scritto sembrerebbe dunque
la forte discontinuità funzionale intrinseca che caratterizza il parlato
(vedi Basile, Voghera, 2003). Sebbene sia il parlare che l’ascoltare
siano processi continui e on-line, i testi parlati si presentano
intrinsecamente discontinui: basti pensare alle interruzioni o ai cambi
di progetto durante una conversazione spontanea faccia a faccia o
telefonica. Un testo parlato è in sostanza il risultato di un processo di
formazione di coerenza che avviene per approssimazioni successive
cui partecipano tanto il produttore quanto il ricevente. Nel parlare è
necessario rinnovare continuamente il contatto con l’ascoltatore e
ricordargli l’argomento di cui si sta parlando. L’informazione viene
così data secondo un andamento - per riprendere le parole di Giorgio
7
A questo proposito cfr. Cardona (1983) a proposito delle espressioni e dei modi di dire
correnti che ci ricordano come, per noi che siamo alfabetizzati, lo scritto rappresenti il certo, il
duraturo, di contro alla caducità di quanto viene affidato alla sola voce: v. per esempio
espressioni come scrivere qualcosa a chiare lettere, mettere nero su bianco, carta canta ecc.,
laddove il parlato permette continui ripensamenti e cambi di progetto (per es. qui lo dico e qui lo
nego ecc.).
9
Raimondo Cardona (1983) - epicicloidale, per cui il discorso (secondo
un processo di cosiddetta incremental repetition) si riavvolge
continuamente su se stesso in spire, ma ogni spira si sposta un poco
più avanti, e non solo ripete tutto il già detto, ma aggiunge qualcosa di
nuovo, qualcosa in più. È un meccanismo che possiamo osservare, ad
esempio, nel dialogo, che, in quanto sistema di modellizzazione
primario del parlato (vedi Voghera, 2001: 72), si presenta - per dir
così - frammentato, ricco di interruzioni, di cambi di progetto. Nel
dialogo ognuno dei partecipanti affianca le proprie battute a quelle
dell’interlocutore, richiamando una parte di ciò che è stato detto, e
aggiungendovi poi quel qualcosa di suo che vuole mettere in evidenza.
Seguendo i suggerimenti di Michael Alexander Kirkwood Halliday
(1985), possiamo insomma immaginare il parlato come più vicino alla
realtà, come una rappresentazione più diretta del fluire degli
avvenimenti, mentre lo scritto sarebbe caratterizzato da una – per dir
così – distanza comunicativa. Come afferma Cardona (1943-1988) in
Antropologia della scrittura (1981), l’adozione del codice grafico
rappresenta una vera e propria rivoluzione cognitiva, in quanto si
realizza la possibilità di una manipolazione di un determinato
contenuto sui piani dello spazio visivo (con gli occhi, infatti, si può
raggiungere un punto qualsiasi del testo e soffermarcisi a volontà) e
del tempo (si possono confrontare messaggi differenti, quale che sia
stato il momento della loro enunciazione) rispetto all’asse obbligato
della linearità propria del discorso orale8.
3.2. Differenze lessicali tra parlato e scritto: i nomi e i verbi.
A livello di lessico l’elemento che caratterizza maggiormente il
parlato rispetto allo scritto è una maggiore presenza di verbi (sia a
livello di types che di tokens) nel parlato e, di conseguenza, una
maggiore presenza di nomi nello scritto. Halliday (1985) ha analizzato
la frequenza d’uso di nomi e verbi in testi parlati e scritti italiani,
inglesi, tedeschi e francesi e ha osservato delle differenze costanti
nella frequenza d’uso di nomi e verbi. In generale, si può sostenere
che la frequenza dei nomi e dei verbi è fortemente connessa al grado
di dialogicità e di pianificazione dei testi, in particolare, la frequenza
dei nomi sembra essere direttamente proporzionale al grado di
pianificazione e inversamente proporzionale al grado di dialogicità. Di
norma, infatti, un testo parlato è più dialogico e meno pianificato di un
testo scritto, e, di conseguenza, esso tenderà ad avere un minor
8
Nel testo scritto si realizza infatti uno spostamento dal campo uditivo a quello visivo,
rendendo possibile il riordinamento e il perfezionamento non solo delle frasi, ma delle singole
parole (cfr. Goody, 1977).
10
numero di nomi rispetto ai verbi, mentre in un testo scritto si registrerà
la tendenza inversa. Queste diversità non sono affatto diversità di
superficie, e, in realtà, mettono in luce delle scelte discorsive
profondamente diverse, le quali sono dipendenti dalle caratteristiche
che assume il processo ideativo e produttivo nelle due modalità di
trasmissione.
Cerchiamo dunque di vedere se la diversa distribuzione di nomi e
verbi nel parlato e nello scritto sia attribuibile o meno a fattori
specificamente semantici. Il nome e il verbo sono stati riconosciuti, a
partire dalle riflessioni dei primissimi grammatici, come le due parti
del discorso più basiche: a questo proposito ricordiamo la posizione di
Antoine Meillet (1866-1936) e quella di Edward Sapir (1884-1939), i
quali, rispettivamente nel 1920 e nel 1921, hanno riconosciuto da un
lato l’universalità di nomi e verbi (in quanto elementi comuni a tutte le
lingue conosciute), e, dall’altro, la loro natura, potremmo dire, di
condizioni semiotiche di base per il costituirsi di qualsiasi
grammatica9.
Nel corso del Novecento la questione è stata ripresa da studiosi di
diversa provenienza e impostazione. In questa sede intendiamo
soffermarci, in particolare, su Talmy Givón e Ronald Langacker, i
quali tendono a dare una fondazione ontologica alle categorie
linguistiche in termini temporali. Givón (1979, 1984) individua
innanzi tutto il criterio della stabilità temporale per classificare le
entità; infatti: “An entity x is identical to itself if it is identical only to
itself but not to any other entity (y) at time a and also at time b which
directly follows time a” (Givón, 1979, p. 320). Di norma nelle lingue
ciò che è temporalmente più stabile ha più probabilità di essere
lessicalizzato come un nome, mentre, ipotizzando una scala di stabilità
temporale, dall’altro lato del continuum lessicale troviamo i verbi, che
solitamente categorizzano azioni o eventi, dunque entità che, in un
certo senso, sono meno concrete dei nomi e che hanno un’esistenza
9
Cfr. quanto dice Meillet: “Il n’y a, en réalité, que deux espèces de mots dont la distinction
soit essentielle, commune à toutes les langues, et qui s’opposent nettement l’une à l’autre: la
catégorie du nom et celle du verbe. Le nom indique les ‘choses’, qu’il s’agisse d’objets concrets
ou de notions abstraites, d’êtres réels ou d’espèces: Pierre, table, vert, verdeur, bonté, cheval
sont également des noms. Le verbe indique les ‘procès’, qu’il s’agisse d’actions, d’états ou de
passages d’un état à un autre: il marche, il dort, il brille, il bleuit sont également des verbes»
(Meillet, 1920, p. 175). Sapir un anno dopo scrive: “Deve esserci qualcosa di cui parlare, e, una
volta scelto un soggetto di discorso, qualcosa deve essere detto a proposito di esso. (…) Il
soggetto del discorso è un sostantivo. Dal momento che il più comune soggetto di discorso è una
persona o una cosa, il nome gravita intorno a concetti concreti di questo tipo. Poi, dal momento
che la cosa che si predica di un soggetto è generalmente un’azione, nel senso più lato di questo
termine, cioè un passaggio da uno stato di esistenza a un altro stato di esistenza, la forma che è
stata messa da parte per svolgere la funzione della predicazione, e cioè il verbo, gravita intorno a
concetti di azione. Nessuna lingua manca in modo completo della distinzione tra verbo e nome,
benché in casi particolari la natura della distinzione possa essere elusiva” (Sapir, 1921, pp. 120121).
11
solo nel tempo (Givón, 1979: ib.). Insomma, la temporalità e la nontemporalità sono per Givón le condizioni - per dir così - trascendentali
che sono alla base della categorizzazione delle nostre esperienze e che
si riflettono rispettivamente nella distinzione tra nomi e verbi10.
Anche Langacker (1987a, 1987b) sottolinea il ruolo della priorità
temporale nella codificazione dei nomi, per cui, mentre un nome
designa una regione nello spazio concettuale, la quale viene definita
per interconnessione e densità (interconnectedness and density Langacker, 1987b, pp. 198-203), il verbo è caratterizzato dalla
temporalità, e dunque dal divenire attraverso il tempo.
Sia per Givón che per Langacker il tempo è la caratteristica
essenziale che definisce i verbi, ma, mentre il primo cerca di cogliere
dei punti di stabilità all’interno del tempo, il secondo privilegia la
caratteristica del processo. È proprio a queste differenze semanticocognitive che si richiama Halliday (1985) quando attribuisce la
diversa frequenza di nomi e verbi nel parlato e nello scritto ad aspetti
semantici. In particolare Halliday sostiene che la preferenza del
parlato per i verbi dipende dalla sua dinamicità e processualità: il
parlato infatti tende a presentare i fatti come processi. Al contrario lo
scritto preferisce i nomi, e le nominalizzazioni, perché tende a
presentare i fatti come prodotti, come oggetti più o meno statici.
Questa posizione, che presuppone l’esistenza di un rapporto biunivoco
tra il modo di significare e le categorie, ha un carattere un po’ troppo
assertivo, ragion per cui proponiamo di adottare una spiegazione delle
categorie di nome e di verbo che tenga conto dei diversi aspetti che
entrano in gioco nei processi comunicativi.
Nell’ambito delle riflessioni sugli aspetti iconici delle lingue Paul
J. Hopper e Sandra Thompson propongono un approccio allo studio
dei nomi e dei verbi “in terms of the diagrammatically iconic nature of
linguistic categories” (Hopper, Thompson, 1985, p. 151). Anche
questi due studiosi partono dalla definizione più comune di nomi e
verbi, secondo la quale i nomi si riferiscono per lo più a cose o a
oggetti, mentre i verbi a azioni o a eventi, per cui sembrerebbe esserci
una tendenza universale ad associare le entità stabili nel tempo con la
categoria dei nomi, e le entità non stabili nel tempo con quella dei
verbi (cfr. Hopper, Thompson, 1984, p. 705). Questa correlazione,
tuttavia, è spesso smentita da alcuni fatti linguistici concreti: molti
verbi, infatti, si riferiscono a situazioni decisamente stabili (per
esempio, to tower “sovrastare”), così come molti nomi possono
riferirsi a situazioni di durata temporale molto limitata (per esempio,
fire “fuoco” o fist “pugno”) o a entità che non possono essere
10
L’impostazione di Givón è ripresa da John M. Anderson, per il quale i nomi sono specifici
di entità e i verbi sono specifici degli eventi (cfr. Anderson, 1997, p. 14).
12
percepite direttamente (per esempio, astrazioni quali la giustizia, il
coraggio, l’orgoglio ecc.).
Allo stesso proposito si era già espresso Hjelmslev (1948), il quale
aveva criticato l’opinione comune per cui il verbo sarebbe una parola
che indicherebbe unicamente un processo. Hjelmslev di fatto aveva
messo in discussione proprio la nozione di processo (1948, p. 194
sgg.), che sarebbe un concetto vago, tanto più che vi sono parole che
indicano sì esplicitamente dei processi, ma che si presentano in forma
nominale (per esempio fuga, conversazione, pensiero, ecc.). Sulla
stessa nozione di processo era intervenuto un paio di anni dopo anche
Émile Benveniste (1902-1976) in un saggio dal titolo La phrase
nominale (1950). In questo saggio Benveniste si era soffermato sulla
distinzione tra nome e verbo e sulle definizioni che comunemente
vengono date a queste due parti del discorso, per cui il verbo
indicherebbe un processo e il nome un oggetto, o, ancora, il verbo
implicherebbe il tempo mentre il nome no. Per un linguista entrambe
queste definizioni sono inaccettabili, in quanto in linguistica
un’opposizione tra processo e oggetto non può avere né una validità
universale, né essere un criterio costante. Abbiamo piuttosto a che fare
con dei concetti relativi, il che è verificabile, da un lato, come aveva
messo in evidenza Hjelmslev, rilevando l’esistenza, all’interno delle
lingue, di nomi che denotano un processo (come negli esempi di fuga,
conversazione, pensiero ecc. sopra riportati), e, dall’altro, vedendo
cosa succede in lingue diverse. A questo proposito Benveniste riporta
infatti numerosi esempi tratti dalle lingue più diverse per vedere che
cosa realmente esprimono sia i nomi che i verbi11. Ad esempio, in
hupa (lingua amerindiana parlata nell’Oregon) vi sono delle forme
verbali attive o passive alla terza persona usate come nomi: nañya
“scende” è la parola per pioggia; nilliñ “scorre” designa il ruscello;
naxowilloi “è attaccato intorno a lui” designa la cintura ecc. (v.
Benveniste, 1950, p. 181). Nemmeno il tempo, che di solito è assunto
come tratto caratteristico del verbo, è necessariamente legato ad esso.
Per esempio, in hopi il verbo non implica alcuna modalità temporale,
ma solo modi aspettuali, in tübatulabal, una lingua dello stesso gruppo
uto-azteco dell’hopi, la più chiara espressione del passato non
appartiene al verbo ma al nome, come nel caso di hani·l “la casa” vs.
hani·pi·l “la casa al passato” (ossia ciò che era una casa e non lo è
più).
11
La scoperta e la descrizione di lingue cosiddette esotiche hanno spinto i linguisti a
riesaminare l’universalità o meno della distinzione tra nomi e verbi e, a questo proposito, gli
studi di tipologia linguistica offrono degli spunti di riflessione molto interessanti. Questi studi
affrontano la questione “soit en elle-même (…) soit à propos de la description de telles langues
particulières (…), soit en traitant de questions plus générales, comme celles de la prédication
(…) et des classes de mots ou ‘parties du discours’” (Lazard, 1999: 389).
13
Torniamo al punto di vista di Hopper e Thompson: i due studiosi,
lungi dal considerare i nomi e i verbi come categorie date
aprioristicamente al fine di costruire enunciati, sostituiscono alla base
semantica la base pragmatica della funzione del discorso come il
fattore-chiave che condiziona la categorialità. In sostanza, essi
giungono a formulare un principio che si configura come un principio
semiotico-discorsivo, in quanto “the categories of N and V actually
manifest themselves only when the discourse requires it” (Hopper,
Thompson, 1984, p. 747).
Insomma, le caratteristiche semantiche dei nomi e dei verbi, il loro
riferirsi a cose percettivamente più concrete e stabili o ad azioni,
eventi, processi ecc. non sono - dal nostro punto di vista - sufficienti a
riconoscere una data forma come decisamente nominale o
decisamente verbale. L’individuazione di una determinata categoria
linguistica come nome o come verbo non dipende solo da proprietà
semantiche assunte indipendentemente dagli effettivi contesti di
realizzazione, ma anche, e forse in modo teoricamente più fecondo,
dalla sua funzione linguistica nel discorso. In quest’ottica la semantica
interagisce con gli altri fattori relativi alla strategie discorsive e
testuali che caratterizzano il discorso parlato o il discorso scritto, e
dunque la maggiore o minore presenza di nomi e verbi nel parlato o
nello scritto non è altro che una - per dir così - ricaduta semantica di
processi semiotico-discorsivi più generali.
Bibliografia
Anderson, J. M., 1997, A Notional Theory of Syntactic Categories, Cambridge,
Cambridge University Press.
Basile, G., Voghera, M., 2003, “Deverbali e denominali nel parlato e nello scritto
dell’italiano d’oggi”, in N. Maraschio, T. Poggi Salani, a cura, Italia linguistica anno
mille. Italia linguistica anno duemila, Atti del XXXIV Congresso internazionale di
studi della Società di Linguistica Italiana (SLI), Firenze, 19-21 ottobre 2000, Roma,
Bulzoni, 2003, pp. 475-489.
Benveniste, É., 1950, La phrase nominale, «Bulletin de la Société de Linguistique de
Paris», XLVI, fasc. 1, n. 132, poi in Problèmes de linguistique générale, Paris,
Gallimard, 1966; trad. it. 1971, “La frase nominale”, in Problemi di linguistica
generale, vol. 1, Milano, Il Saggiatore, pp. 179-199.
Berruto, G., 1987, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, La Nuova
Italia Scientifica.
Berruto, G., 1993, “Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche”, in A. Sombrero, a
cura, Introduzione all’italiano contemporaneo, vol. II, La variazione e gli usi, RomaBari, Laterza, 20005, pp. 37-92.
Biber, D., 1988, Variation across Speech and Writing, Cambridge, Cambridge
University Press.
Cardona, G. R. , 1981, Antropologia della scrittura, Torino, Loescher.
14
Cardona, G. R., 1983, “Culture dell’oralità e culture della scrittura”, in A. Asor
Rosa, a cura, Letteratura italiana, vol. II, Produzione e consumo, Torino, Einaudi, pp.
26-101.
Cassirer, E., 1944, An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human
Culture, New Haven, Yale University Press; trad. it. 2000, Saggio sull’uomo.
Introduzione ad una filosofia della cultura umana, Roma, Armando Armando Editore.
De Mauro, T., 1971, “Tra Thamus e Theuth. Uso scritto e uso parlato dei segni
linguistici”, in Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica, Bari, Adriatica
Editrice, pp. 96-114.
Eco, U., 1975, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 9a ed. 1989.
Eco, U., 1997, Kant e l’ornitorinco, Milano, Bompiani.
Givón, T., 1979, On Understanding Grammar, New York, Academic Press.
Givón, T., 1984, Syntax: A Functional-typological Introduction, I, Amsterdam, John
Benjamins Publishing Company.
Givón, T., 1985, “Iconicity, Isomorphism and Non-Arbitrary Coding in Syntax”, in J.
Haiman, a cura, Iconicity in Syntax, Amsterdam, John Benjamins, pp. 187-219.
Goody, J., 1977, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge, Cambridge
University Press; trad. it. 1981, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, Milano,
Franco Angeli.
Halliday, M. A. K., 1985, Spoken and Written Language, Victoria, Deakin University;
trad. it. 1992, Lingua parlata e lingua scritta, Firenze, La Nuova Italia Editrice.
Hjelmslev, L., 1943, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, København,
Munksgaard; trad. ingl. 1953, Prolegomena to a Theory of Language, Indiana
University Publications in Anthropology and Linguistics, Memoir 7
dell’«International Journal of American Linguistics», Baltimora, Waverly Press; trad.
it. 1968, I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino, Einaudi.
Hjelmslev, L., 1948, “Le verbe et la phrase nominale”, in Essais linguistiques, Paris,
Éditions de Minuti; trad. it. 1981, “Il verbo e la frase nominale”, in Saggi di
linguistica generale, Parma, Pratiche Editrice, pp. 191-219.
Hopper, P., Thompson, S., 1984, The discourse basis for lexical categories in
universal grammar, «Language», 60, pp. 703-752.
Hopper, P., Thompson, S., 1985, “The iconicity of the universal categories ‘noun’ and
‘verb’”, in J. Haiman, a cura, Iconicity in syntax, Amsterdam, Benjamins, pp. 151183.
Jakobson, R., 1959, “On Linguistics Aspects of Translation”, in R. Brower, a cura, On
Translation, Harvard, Harvard University Press, pp. 232-239; ora in R. Jakobson,
Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit, 1963; trad. it. 1966, Saggi
di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 19805, pp. 56-64.
Jean, G., 1986, L’écriture, mémoire des hommes, Paris, Gallimard; trad. it. 1992, La
scrittura, memoria degli uomini, Trieste, Electa/Gallimard.
Langacker, R., 1987a, Nouns and Verbs, «Language», vol. 63, pp. 53-94.
Langaker, R., 1987b, Foundations of Cognitive Grammar, vol. I, Theoretical
Prerequisites, Stanford, CA, Stanford University Press.
Lazard, G., 1999, La question de la distinction entre nom et verbe en perspective
typologique, «Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae», XXXIII/34, pp. 389-418.
Meillet, A., 1920, Sur les caractères du verbe, «Revue philosophique», t. LXXXIX,
genn.-febbr., ora in Linguistique historique et linguistique générale, Paris, Editions
Champions, 1965, pp. 175- 198.
Mioni, A. M., 1983, “Italiano tendenziale: osservazioni su alcuni aspetti della
standardizzazione”, in AA.VV., a cura, Scritti linguistici in onore di Giovan Battista
Pellegrini, Pisa, Pacini, pp. 495-517.
15
Ong, W. J., 1982, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, London and
New York, Meuthen; trad. it. 1986, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola,
Bologna, il Mulino.
Pagliaro, A., 1957, La parola e l’immagine, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
Platone, Phaedrus; trad. it. 1970, Fedro, a cura di F. Acri, Torino, Einaudi; edizione
CDE spa, Milano su licenza della Giulio Einaudi editore.
Sapir, E., 1921, Language: an Introduction to the Study of Speech, New York,
Harcourt, Brace & World; trad. it. 1969, Il linguaggio. Introduzione alla linguistica,
Torino Einaudi.
Saussure, F. de, 1916, Cours de linguistique générale, Paris, Editions Payot, 1922;
trad. it. 1967, Corso di linguistica generale, con introd., trad. e comm. di T. De
Mauro, Roma-Bari, Laterza; 12a ed. 1996.
Violi, P., 1997, Significato ed esperienza, Milano, Bompiani.
Voghera, M., 2001, “Riflessioni su semplificazione, complessità e modalità di
trasmissione: sintassi e semantica”, in M. Dardano, A. Pelo, A. Stefinlongo, a cura,
Scritto e parlato. Metodi, testi e contesti, Atti del Colloquio internazionali di studi
(Roma, 5-6 febbraio 1999), Roma, Aracne editrice, pp. 65-78.
16