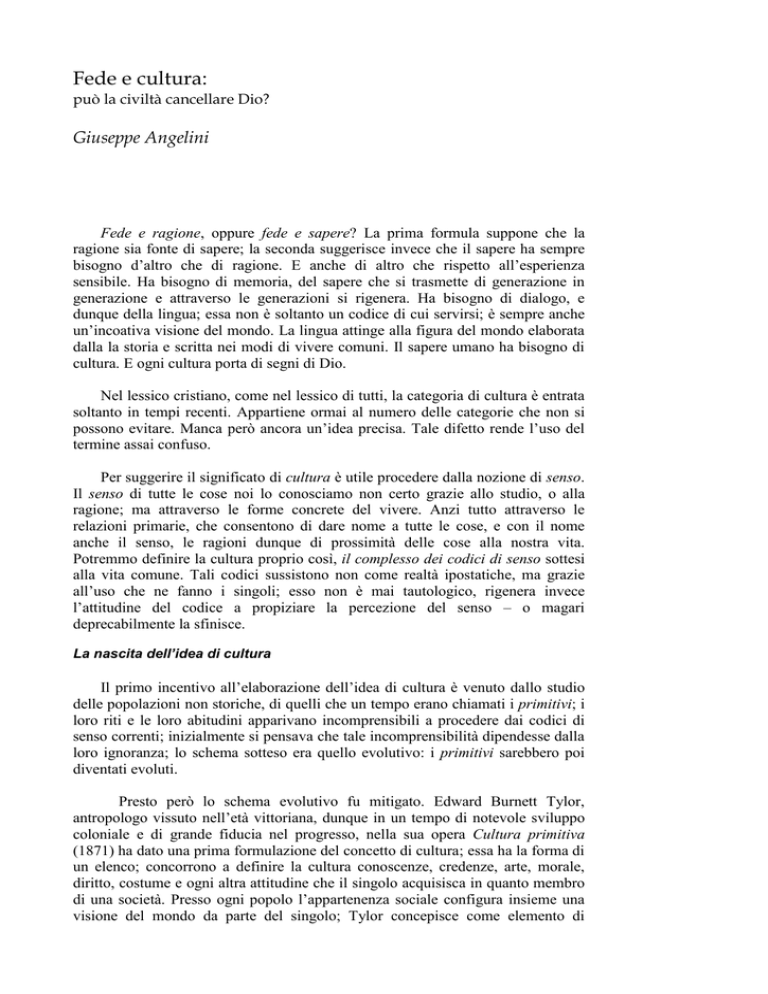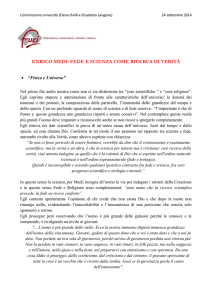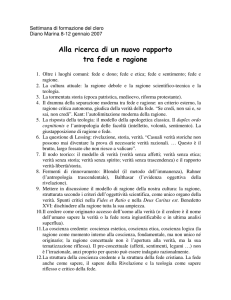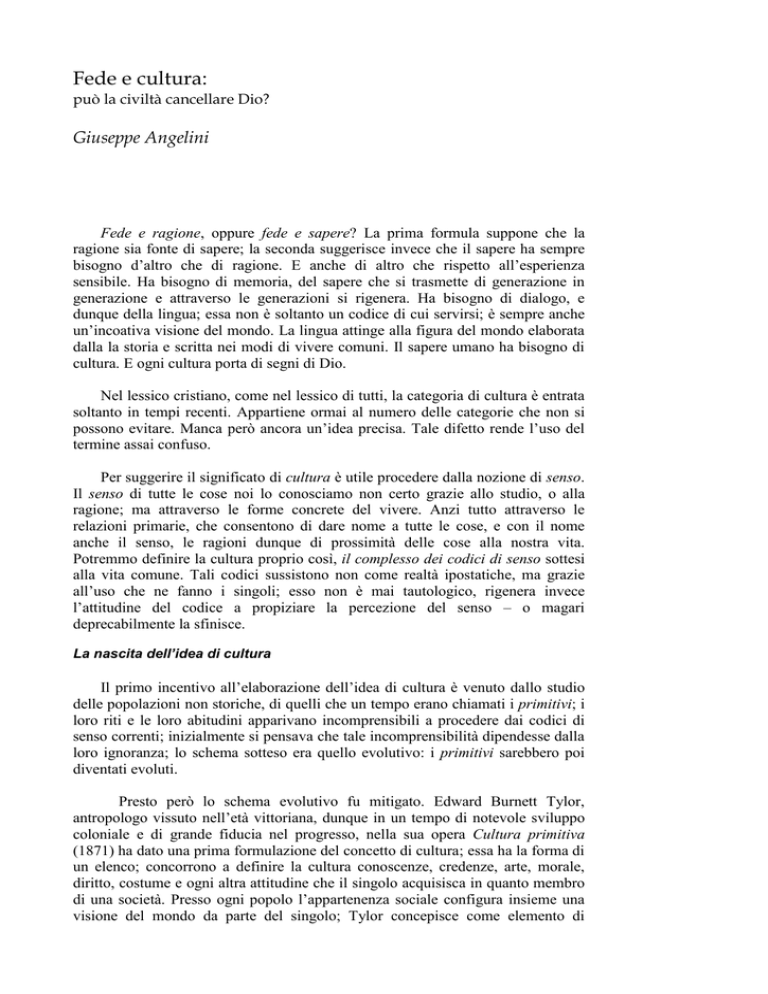
Fede e cultura:
può la civiltà cancellare Dio?
Giuseppe Angelini
Fede e ragione, oppure fede e sapere? La prima formula suppone che la
ragione sia fonte di sapere; la seconda suggerisce invece che il sapere ha sempre
bisogno d’altro che di ragione. E anche di altro che rispetto all’esperienza
sensibile. Ha bisogno di memoria, del sapere che si trasmette di generazione in
generazione e attraverso le generazioni si rigenera. Ha bisogno di dialogo, e
dunque della lingua; essa non è soltanto un codice di cui servirsi; è sempre anche
un’incoativa visione del mondo. La lingua attinge alla figura del mondo elaborata
dalla la storia e scritta nei modi di vivere comuni. Il sapere umano ha bisogno di
cultura. E ogni cultura porta di segni di Dio.
Nel lessico cristiano, come nel lessico di tutti, la categoria di cultura è entrata
soltanto in tempi recenti. Appartiene ormai al numero delle categorie che non si
possono evitare. Manca però ancora un’idea precisa. Tale difetto rende l’uso del
termine assai confuso.
Per suggerire il significato di cultura è utile procedere dalla nozione di senso.
Il senso di tutte le cose noi lo conosciamo non certo grazie allo studio, o alla
ragione; ma attraverso le forme concrete del vivere. Anzi tutto attraverso le
relazioni primarie, che consentono di dare nome a tutte le cose, e con il nome
anche il senso, le ragioni dunque di prossimità delle cose alla nostra vita.
Potremmo definire la cultura proprio così, il complesso dei codici di senso sottesi
alla vita comune. Tali codici sussistono non come realtà ipostatiche, ma grazie
all’uso che ne fanno i singoli; esso non è mai tautologico, rigenera invece
l’attitudine del codice a propiziare la percezione del senso – o magari
deprecabilmente la sfinisce.
La nascita dell’idea di cultura
Il primo incentivo all’elaborazione dell’idea di cultura è venuto dallo studio
delle popolazioni non storiche, di quelli che un tempo erano chiamati i primitivi; i
loro riti e le loro abitudini apparivano incomprensibili a procedere dai codici di
senso correnti; inizialmente si pensava che tale incomprensibilità dipendesse dalla
loro ignoranza; lo schema sotteso era quello evolutivo: i primitivi sarebbero poi
diventati evoluti.
Presto però lo schema evolutivo fu mitigato. Edward Burnett Tylor,
antropologo vissuto nell’età vittoriana, dunque in un tempo di notevole sviluppo
coloniale e di grande fiducia nel progresso, nella sua opera Cultura primitiva
(1871) ha dato una prima formulazione del concetto di cultura; essa ha la forma di
un elenco; concorrono a definire la cultura conoscenze, credenze, arte, morale,
diritto, costume e ogni altra attitudine che il singolo acquisisca in quanto membro
di una società. Presso ogni popolo l’appartenenza sociale configura insieme una
visione del mondo da parte del singolo; Tylor concepisce come elemento di
cultura ogni competenza a vivere acquisita dal singolo grazie alla sua
appartenenza sociale. La credenza in esseri spirituali – egli nota tra l’altro – è un
ingrediente essenziale di ogni cultura; appunto da tale credenza si dipana una
visione via via più complessa della religione. Il concetto di cultura introduce
insieme l’idea che le singole credenze e usanze si possono comprendere soltanto
nella correlazione reciproca e nella loro relazione con una pratica di vita; non
invece per comparazione alla visione moderna del mondo.
L’introduzione dell’idea di cultura nei discorsi sull’uomo si accompagna
spesso ad uno schema semplicistico, che distingue natura e cultura, e addirittura le
oppone. Quel che è solo culturale sarebbe per ciò stesso convenzionale,
contingente, mutevole, non tale da impegna la libertà del singolo. In realtà, tra
natura e cultura non si può tracciare una divisione materiale, sicché si possa
attribuire l’una cosa alla natura e l’altra alla cultura; tutto è culturale, e insieme
tutto trova il proprio fondamento nella comune natura umana. Il fatto che essa non
sia mai adeguatamente nota, non si possa mai definire in termini concettuali, non
è argomento sufficiente per smentire quest’evidenza: l’dea di natura umana è
irrinunciabile; essa è nota sempre e solo in forme sempre parziali, disposte dalla
cultura.
Propongo un’illustrazione concreta, riferendomi alla differenza tra
maschio e femmina. Naturale o culturale? Certamente naturale, e tuttavia
riconosciuto nel suo senso grazie alle forme della cultura. Soltanto a condizione
che alla differenza sia riconosciuto un senso essa è la differenza propriamente
umana. Un recente filone di pensiero nord americano distingue – come noto – tra
sex e gender; attribuisce il primo alla natura e lo intende in termini riduttivamente
biologici (“scientifici”); attribuisce invece il gender alla cultura e lo intende come
in nessuno modo normativo; addirittura disfare il genere e la sua indebita
apparenza normativa è l’imperativo che propone la più nota fautrice della teoria
del gender, Judith Butler.
Quale sia il compito della teologia a fronte del processo di
indeterminazione obiettiva del genere a livello di cultura per un lato, e a fronte
della teoria che sancisce la fine del genere per altro lato, è facile intuirlo;
l’intelligenza che procede dalla fede nel Dio Creatore, che maschio e femmina li
creò, li benedisse e disse loro …, deve tenere insieme i due dati, la qualità
naturale della differenza e la necessaria mediazione culturale del suo senso. Per
tenere insieme le due cose, deve anzitutto produrre una teoria della cultura, così
come una teoria della differenza sessuale che non la riduca in termini biologici;
deve poi, con l’aiuto delle categorie elaborate, chiarire le dinamiche sottese ai
presenti processi civili di indeterminazione del genere.
La frattura tra cultura e coscienza
Come accade per tutti i temi di riflessione fondamentale sull’umano, anche
nel caso della cultura si produce un nesso prevedibile: finché la cultura va da sé
non ha bisogno d’essere pensata; quando cessa di funzionare nasce l’interrogativo,
e quindi la necessità dell’elaborazione teorica. In che senso la cultura cessa di
‘funzionare’? e quando cessa di funzionare?
Possiamo distinguere, schematicamente, due momenti maggiori: quello
segnato dall’epopea del moderno, e quello segnato invece dal momento di crisi
del moderno e quindi del passaggio al postmoderno. Comune ai due momenti è
l’aspetto di un distacco della coscienza del singolo dai codici di senso espressi
dalla cultura comune; mentre in un primo momento al distacco si accompagna una
sostanziale fiducia della coscienza soggettiva di potere sostituire al codice
culturale messo in dubbio le risorse offerte da un’evidenza interiore, in un
secondo momento la coscienza soggettiva riconosce di non potere prescindere
dalle risorse simboliche della tradizione culturale; e tuttavia rivendica il potere di
ricombinarle a propria discrezione. Anzi, afferma addirittura il dovere di una tale
ricombinazione, senza della quale mancherebbe un’appropriazione personale e
libera.
Proprio l’esperienza religiosa offre le illustrazioni più eloquenti.
Espressione tipica del distacco moderno della coscienza individuale dal codice
sociale – in questo caso ecclesiastico – dei comportamenti è il rifiuto dei segni
sacramentali. Il caso più chiaro è quello della confessione; il singolo dice: “Non
ho bisogno del prete per confessarmi davanti a Dio, per chiedere e ottenere il suo
perdono; lo posso fare interiormente, anzi è meglio che lo faccia così”. In effetti,
la persona che ha avuto una pratica precoce della confessione attraverso di essa ha
appreso un senso della confessione del peccato davanti a Dio, che può poi
praticare senza atto sacramentale. L’esperienza insegna tuttavia come facilmente
accada che, con il distendersi dei tempi, quella pratica della confessione interiore,
che inizialmente era apparsa possibile e convincente, addirittura più convincente
della confessione davanti al prete, conosca un progressivo illanguidimento e poi
l’abbandono. Non molto diverso dal caso della confessione è quello stesso della
Messa. Molti fino ad oggi dicono: “In chiesa vado più volentieri quando la chiesa
è vuota e silenziosa; si prega meglio”; non considerano che quella loro preghiera
silenziosa è resa possibile dal prolungato ascolto del vangelo da parte di loro
stessi, e da parte dei molti attraverso la cui testimonianza ha preso forma la loro
fede; la chiesa stessa, nella quale essi trovano il clima adatto per pregare, è uno
spazio che ha potuto essere scavato nella città grazie alla celebrazione liturgica.
Il distacco della coscienza singola dal codice ecclesiastico della vita
cristiana è possibile, in un primo momento, proprio grazie all’interiorità della
fede, che la tradizione ecclesiastica ha reso possibile. E tuttavia, la religione
interiore è vissuta poi di fatto, ed è anche pensata, quasi fosse soltanto interiore. In
un secondo momento – ed è il momento di quanti oggi sono ancora giovani e non
hanno vissuto in età infantile una pratica ecclesiastica della fede
proporzionalmente distesa nel tempo – viene a mancare la risorsa della memoria
per vivere in forma interiore l’esperienza religiosa; in quel momento conosce
facile fortuna il bazar religioso, nella forma della ripresa del Lumen orientale,
magari del New Age, o anche della ripresa di tradizioni cattoliche tramite le nuove
aggregazioni con forte connotazione emotiva.
Qualche cosa di simile accade anche nel caso del rapporto tra coscienza
individuale e cultura, tra vita del soggetto e forme nelle quali i significati
elementari della vita trovano oggettivazione nella vita comune. Il soggetto singolo
protesta la propria autonomia rispetto ai codici sociali, dai quali al di là della sua
consapevolezza continua a dipendere.
All’origine di tale frattura tra coscienza e cultura stanno i profondi e rapidi
mutamenti della cultura, propiziati dall’avvento delle scienze, dal disincanto
quindi del mondo, dall’avvento del mercato e quindi dalla separazione sistemica
tra scambio economico e scambio simbolico, dalla laicità civile, e dunque dalla
fine di ogni referenza della vita comune alla visione religiosa del mondo. Tutti
questi fattori, oltre a mettere in crisi la cultura precedente, accedono un sospetto
nei confronti della cultura in genere; paiono addirittura pregiudicare la possibilità
che si realizzi una nuova cultura, e cioè una nuova oggettivazione sociale dei
significati elementari della vita.
Per rimediare alla crisi dell’antica visione del mondo i filosofi moderni
progettano di sostituire la ragione e la scienza in genere alla tradizione
(illuminismo). Nella stagione civile più recente (postmoderna) ci si rende però
conto che le pretese evidenze di ragione, o comunque le evidenze della coscienza
morale del soggetto, potevano apparire come evidenze non grazie alla ragione, ma
soltanto grazie a una tradizione culturale. Gli ideali forti del moderno – libertà,
uguaglianza e fraternità – erano evidenze propiziate dal costume costruito dalla
lunga tradizione cristiana; lo sgretolamento di quel costume nella stagione recente
dispone le condizioni per un vuoto culturale, che pregiudica la percezione del
senso di tutte le cose ad opera della coscienza singola. Tale circostanza mette in
evidenza la necessaria dipendenza della coscienza dalla tradizione.
Il pensiero postmoderno prospetta una comprensione decostruttiva della
tradizione culturale: ad essa sarebbe necessario attingere, certo; ma essa non
proporrebbe alcuna visione del mondo, ma soltanto le risorse simboliche mediante
le quali il singolo si costruisce in maniera autonoma, o addirittura autarchica, una
propria visione del mondo. Rimane la negazione di ogni valore normativo alla
tradizione; ma si riconosce la necessità che la coscienza del singolo attinga ad una
tradizione per costruirsi un mondo. Prende allora consistenza la tesi del
relativismo culturale: di qualche cosa come una patrimonio culturale non
possiamo fare a meno; esso però deve servire al singolo per costruire un senso del
mondo, non può invece valere come documento di una pretesa verità che lo
preceda e lo convochi.
La Chiesa cattolica e la nuova cultura
Il cattolicesimo, che già s’era opposto in maniera vivace al progetto
illuministico, quello dunque di un’emancipazione del singolo dalla tradizione e
dal costume, da capo si oppone al relativismo culturale. E tuttavia, a partire dal
Concilio esso registra la distanza ormai intollerabile che si è venuta a creare tra la
propria lingua e la cultura comune, tra i propri costumi e quelli raccomandati dai
nuovi stili di vita. In fretta proclama un programma di aggiornamento.
In Italia la Chiesa, con il suo famoso progetto culturale, ha addirittura
riconosciuto che il mutamento culturale costituisce il fattore fondamentale di crisi
della fede stessa; la fede incontra difficoltà croniche a divenire principio di vita –
sorgente di una visione del mondo e anche forma morale della vita – proprio a
motivo della rapida trasformazione antropologica. Di conseguenza, la riforma
pastorale della Chiesa deve di necessità passare attraverso un confronto critico con
le nuove forme della cultura; deve descriverne la dinamica, denunciarne i rischi e
suggerire i rimedi. L’uso della categoria di cultura è diventato nella lingua
ecclesiastica recente assai insistente, addirittura inflattivo; ma ad esso non
corrisponde ancora un’idea proporzionalmente precisa, né tanto meno una
diagnosi articolata della transizione culturale che stiamo vivendo.
Il difetto di pensiero dispone lo spazio propizio a rappresentazioni
banalizzanti del compito di aggiornare la pastorale. Consistente è il rischio che il
compito sia inteso come necessità di un adeguamento alle verità del giorno. Il
compito è invece di prendere atto dei nuovi codici mediante i quali si realizza il
riferimento ai significati elementari della vita o forse la loro rimozione, nelle
forme effettive dello scambio sociale; quei codici non possono essere ignorati, se
il ministero pastorale vuole comunicare con i contemporanei. La necessità di un
aggiornamento del ministero è segnalata dalla percezione diffusa della grande
distanza che divide predicazione, catechesi, e forme tutte del ministero dalla
coscienza diffusa. Prendere atto dei nuovi codici non significa però adeguarsi ad
essi. Occorre invece, a procedere dalla fede, istruire una critica determinata dei
luoghi comuni dell’epoca. È un luogo comune – ad esempio – quello che descrive
l’obiettivo della vita come autorealizzazione, o quello che pensa l’imperativo
morale in termini di valori; la lingua oggi corrente nella Chiesa accoglie questi
luoghi comuni come verità scontate; non sa riconoscere invece in essi la cifra di
una malattia spirituale del nostro tempo, a riguardo della quale la coscienza
cristiana deve essere istruita.
La verità stessa del vangelo non è nota alla coscienza a monte della
mediazione culturale. La teologia convenzionale non riconosceva il debito
essenziale della coscienza nei confronti della cultura, della lingua appresa, delle
forme tutte della vita comune; il modello della psicologia razionale faceva
dipendere la conoscenza e ogni esercizio spirituale dell’uomo unicamente dalle
sue facoltà. Il debito nei confronti delle condizioni sociali della vita s’impone alla
comune evidenza soltanto a seguito dei rapidi mutamenti recenti; essi rendono
trasparente il nesso che lega forme della coscienza e qualità dei costumi; quel che
a una generazione appariva ovvio cessa di apparire tale alla successiva. Assume
allora rilievo proporzionalmente maggiore il momento di un discernimento critico
da parte della coscienza individuale nei confronti dei modi di dire, di fare, di
sentire comuni.
Il mutamento culturale rapido propizia la crescente distanza tra modi di
pensare e vivere del singolo e codici sociali. Questi difettano di densità morale; il
difetto è particolarmente evidente nel caso dei temi che più interessano gli stili di
vita personale. I codici sociali appaiono agli occhi del singolo sempre più come
regole convenzionali, non invece come indicazioni che interpretano il sentimento
del dovere che connota l’esperienza della prossimità; essi distinguono ambiti di
competenza e servono alla coesistenza pacifica, non ad essere buoni. Le regole
sociali appaiono come regole di etichetta più che come leggi della vita buona; non
possono essere ignorate, ma non hanno valore edificante.
Ad una tale distanza è possibile rimediare soltanto conferendo al ministero
della Chiesa un profilo di più alta attenzione al vissuto soggettivo, che i codici di
senso espressi dalla cultura corrente sempre più ignora. Non a caso di vissuti
soggettivi si occupano sempre più gli psicologi, e in una prospettiva clinica, per
rimediare alla sofferenza o anche solo al disagio. I vissuti soggettivi, sempre più
ignorati e non interpretati dalle forme della vita comune, regrediscono a livello
inconscio e operano sulla coscienza del soggetto in maniera incontrollata. La
trattazione clinica del disagio minaccia di rinforzare la rimozione sociale
dell’obiettiva consistenza morale delle ragioni del disagio.
Perché il ministero della Chiesa possa assolvere a compiti tanto
impegnativi ha bisogno di essere assistito da un deciso incremento del sapere
teorico a proposito di tali fenomeni, dunque dalla teologia. Siamo ancora molto
lontani da un tale obiettivo. Di conseguenza avviene della simbolica religiosa e
cristiana qualche cosa di simile a quel che avviene di tutti i codici di senso offerti
dalla tradizione culturale; il singolo ne fa un uso soggettivo; nel caso dei simboli
religiosi l’uso soggettivo è quello consolatorio assai più che quello edificante. Il
vangelo serve – così pare – a immaginarsi buoni assai più che a diventarlo. La
tradizione religiosa appare come una riserva simbolica alla quale attingere per
dare parola alla vita ‘interiore’, a una vita altra rispetto a quella delle relazioni
umane effettive, siano esse famigliari, professionali e civili; a una vita che le
forme correnti della cultura ignorano.
2.4.4. La differenza tra senso e verità
Tra codici culturali del senso e verità ultima, verità di Dio, alla quale sola
si riferisce in ultima istanza il consenso della fede sussiste un nesso indubitabile, e
insieme una differenza, Come chiarire l’uno e l’altro?
Merita di sottolineare come tra cultura e religione, oltre che una differenza,
e addirittura prima che una differenza, sussista un nesso: la cultura ha sempre una
incancellabile referenza religiosa, e alla verità di Dio il singolo non può accedere
altrimenti che istruito dai significati elementari della vita, ai quali dà articolazione
la cultura. La religione individuale ha indispensabile bisogno di attingere alle
risorse della cultura. Esse offrono una mediazione, soltanto una mediazione;
grazie a tale mediazione, il singolo deve rapportarsi poi in maniera personale alla
verità di Dio. La ripresa delle tradizioni culturali comporta sempre anche una loro
rinnovata e più univoca determinazione ad opera della coscienza; la ripresa potrà
(o magari dovrà) assumere anche la forma di un discernimento critico; di quelle
tradizioni infatti vengono sempre fatti a livello sociale anche usi arbitrari.
Le tradizioni di senso articolate dalla cultura sono mediazioni necessarie
della percezione del senso di tutte le cose da parte del singolo. Come precisare la
nozione di senso, con tanto insistenza impiegata per parlare di cultura? E come
distinguere tra senso e verità? La tradizione teologica e filosofica non prevedeva
la nozione di senso, ma solo quella di verità; oggi invece la questione del rapporto
tra senso e verità è uno dei compiti essenziali della riflessione cristiana; soltanto
un tale così permetterà di correggere la concezione intellettualistica di verità, che
affligge il discorso sulla fede anche a livello pastorale.
Il senso attestato attraverso le forme della cultura indica una direzione
nella quale il soggetto deve muoversi per conoscere la verità. La verità non è mai
accessibile mediante parole, né mediante una qualsiasi altra forma di
oggettivazione sociale del senso, ma sempre e solo attraverso un cammino
personale; soltanto le forme effettive dell’agire del singolo rendono manifesta la
verità fin dall’inizio promessa attraverso le forme dell’esperienza sensibile. La
cultura è mediazione; non dispensa il singolo dal compito di rapportarsi
direttamente alla verità, che sta sempre al di là della cultura. Proprio perché
soltanto mediazione, la cultura ha essenziale consistenza simbolica; non definisce
la verità, ma rimanda ad essa; istituisce un rapporto pratico con essa. Offre uno
schema suggestivo per descrivere un tale intreccio la sentenza pronunciata da
Gesù all’indirizzo di quei Giudei che avevano creduto in lui, che pensavano di
avere creduto: Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi (Gv 8, 31s); la fede non termina alle
parole, ma alla cosa stessa, e la cosa stessa – la verità di cui Gesù dice – è
raggiunta soltanto mediante la pratica delle sue parole.
Per chiarire la forma che assume la mediazione della cultura occorre
descrivere il processo disteso nel tempo attraverso il quale soltanto il singolo
giunge alla conoscenza della verità, che pure fin dall’inizio egli intuisce attraverso
le forme dell’esperienza passiva. L’esperienza iniziale del mondo ha infatti i tratti
dell’essere affetti dalla realtà. Il singolo è colpito e proprio la sorpresa accende in
lui l’interrogativo: “Che cos’è?”. All’interrogativo egli può rispondere unicamente
cimentandosi con la realtà, andando ad essa incontro, andando anzi tutto incontro
all’altro che prossimo; appunto attraverso il prossimo il singolo è raggiunto
dall’appello che la realtà tutta gli rivolge. Il confronto con l’altro, d’altra parte, è
possibile soltanto grazie alla parola, e più in generale grazie alle risorse
simboliche attraverso le quali trovano oggettivazione sociale i significati della
vita. Soltanto attraverso una tale risposta pratica si configura per il singolo
l’immagine del mondo, e insieme la sua stessa identità.
Una nuova immagine per l’uomo
Per rendere ragione di questa connotazione pratica che assume l’accesso
alla visione del mondo e insieme della necessaria distensione nel tempo che
caratterizza il processo di identificazione è necessario passare dallo schema
essenzialistico di comprensione dell’uomo allo schema drammatico.
Essenzialistico è lo schema della psicologia razionale; lo schema drammatico
esige invece attenzione al momento empirico. Già Kant aveva segnalato la
necessità di un approccio empirico all’umano e aveva scelto per esso il nome di
antropologia pragmatica. Egli distingueva in tal senso l’antropologia pragmatica
da quella fisiologica:
La conoscenza fisiologica dell’uomo si propone di indagare ciò che fa dell’uomo la
natura, la pragmatica ciò che fa o può fare di se stesso l’uomo stesso, in quanto essere
libero1.
Nel caso della teologia cristiana la prospettiva pragmatica appare obbligatoria. Per
dire dell’uomo infatti la fede passa attraverso il racconto di una storia, quella che
va da Adamo a Gesù. La conoscenza dell’uomo, e della verità credendo alla quale
soltanto è possibile che l’uomo viva, attinge ad evidenze dischiuse appunto dalla
vicenda passata. Soltanto attraverso la memoria di quella vicenda si dischiude alla
coscienza la verità, che dà senso e speranza alla sua avventura.
Il nesso radicale che lega l’identità dell’uomo alla storia, alla memoria, e
più precisamente alla memoria di Gesù Cristo è rimasto latente nel pensiero
cristiano della tradizione; come latente è rimasto il nesso tra conoscenza della
verità e sua pratica; in ogni caso, quei nessi non sono stati chiariti in maniera
riflessa. Appunto per pensare la mediazione culturale della coscienza appare
indispensabile passare per questo chiarimento riflesso.
La necessità obiettiva che la considerazione dell’uomo passi a una
prospettiva empirica, attenta alla vicenda storica e al rapporto sociale, aiuta a
1
I. KANT, Antropologia dal punto di vista pragmatico, in Scritti morali, a cura di P. Chiodi,
Torino, UTET, 1970, p. 541, traduzione lievemente corretta.
capire le ragioni del progressivo passaggio dell’interesse per l’uomo dalla
filosofia alle scienze umane. Tale passaggio si annuncia già nell’Ottocento, con la
grande lievitazione delle conoscenze storiografiche, la nascita dell’etnologia, poi
anche della sociologia e della psicologia. Si realizza però in forma cospicua
soltanto nel Novecento. E soltanto allora assume rilievo crescente la categoria di
cultura.
Pur senza fare ricorso esplicito alla categoria di cultura, già il progetto di
Max Weber di una “sociologia comprendente” (il saggio Alcune categorie della
sociologia comprendente è del 1913) procede dalla consapevolezza del nesso
essenziale che lega i rapporti sociali all’agire intenzionale, e dunque alla
condivisione dei significati elementari del vivere. Per comprendere l’agire sociale
è indispensabile comprendere il senso che orienta l’agire del singolo; in ordine a
tale interpretazione, Weber propone lo strumento dei tipi ideali, modelli
generalizzanti che descrivono le caratteristiche ricorrenti di determinate classi di
agire; tipi ideali sono, ad esempio, i due modelli dell’agire, razionale rispetto allo
scopo e razionale rispetto al valore; e quindi ai due tipi di etica, della convinzione
e della responsabilità. Il progetto di una sociologia comprendente consente a
Weber di concepire un’opera come L’etica protestante e lo spirito del capitalismo
(del 1905), che studia la correlazione tra sorgere del capitalismo e visione del
mondo propria delle chiese riformate.
Sul solco dal progetto di una sociologia comprendente, aperto da Weber, si
colloca una linea di ricerca sociologica, e poi psicosociologica, che ha dato
contributi assai significativi alla comprensione delle nuove forme dell’esperienza
religiosa nella società tardo moderna. Ricordiamo in particolare la riflessione di
Th. Luckmann e P. Berger sulla visione del mondo come costruzione sociale2, e i
numerosi saggi dedicati singolarmente dai due autori al tema della religione.
Berger assomma alla competenza sociologica quella teologica; sotto tale profilo
appare come interprete di una sorta di rinnovata teologia liberale, che accorda
grande credito ad una consistenza trascendentale del rapporto religioso; nelle
forme simboliche offerte dalla cultura esse cercherebbe risorse espressive, ma per
dire di un vissuto che non avrebbe bisogno dei rapporti sociali per prendere
forma; l’approccio teorico neoliberale funge da giustificazione – così
interpretiamo - per lo spiccato tratto soggettivo della religione dell’uomo
occidentale contemporaneo3.
Più critica e preoccupata è la diagnosi di Luckmann, che certo condivide la
tesi di Berger circa il nesso privilegiato tra religione e questione dell’identità, e
tuttavia sottolinea il difetto obiettivo delle risorse offerte all’abitante della società
secolare per realizzare la propria identità. Provvedere a tale identità è diventato un
Insieme essi hanno firmato l’opera di carattere teorico generale La realtà come costruzione
sociale (1966), Il Mulino, Bologna 1969.
2
3
Di P.L. BERGER ricordiamo, come rilevanti per il tema, La sacra volta (1967), SugarCo, Milano
1984, un saggio di sociologia della religione nella civiltà secolare, sotteso dalla tesi che fa della
religione l’equivalente della generica istanza del senso, e dunque una forma della vita dello spirito
che a stento si distingue dalla morale; Il brusio degli angeli (1969), Il Mulino, Bologna 1970,
dedicato in particolare alla possibilità della teologia, del discorso sensato su Dio, in un mondo
secolare; L’imperativo eretico. Possibilità contemporanee di affermazione religiosa (1979),
ElleDiCi, Leumann (Torino) 1987: l’espressione pittoresca imperativo eretico intende suggerire la
necessità per l’uomo secolare di scegliere il proprio credo religioso, senza la possibilità di
appoggiarsi ad alcuna ortodossia rassicurante, e quindi la necessità di vivere accompagnati dalla
costante consapevolezza del tratto solo congetturale della convinzione religiosa.
compito ‘privato’; il singolo deve provvedere da solo; lo soccorre in tal senso la
tradizione religiosa, certo; e tuttavia la sua religione, devenuta ormai invisibile e
senza verifica pratica, appare più libera e ‘creativa’, ma illusoria:
L’identità personale diventa, essenzialmente, un fenomeno privato. È questo forse
l’aspetto più rivoluzionario della società moderna. Il frazionamento istituzionale
ha lasciato non strutturate ampie zone della vita dell’individuo e non determinato
il contesto biografico globale della significanza. Dagli interstizi della struttura
sociale derivanti dal frazionamento istituzionale è sorta quella che potremmo
chiamare la sfera privata. La liberazione della consapevolezza individuale dalla
struttura sociale e la libertà nella sfera privata costituiscono la base per quel
senso alquanto illusorio di autonomia che caratterizza la persona tipica della
società moderna4.
La descrizione dei fattori sistemici che alimentano lo scollamento tra coscienza e
società nella stagione postmoderna offre spunti illuminanti per intendere lo stesso
scollo tra fede e Chiesa che largamente interessa lo stesso cattolicesimo
contemporaneo. La fede è vissuta oggi con frequenza crescente senza
appartenenza alla Chiesa; il consenso del singolo alle credenze, alle pratiche
cultuali e morali proposte dalla Chiesa appare sempre meno ovvio e sempre più
selettivo. Riflesso di tale spiccata soggettività della fede è la soggettività della
stessa coscienza morale; occorre certo riconoscere anche una soggettività buona,
assolutamente essenziale alla coscienza morale; il vigore della norma per il
singolo non è garantito dalla semplice notizia che egli ne ha, per quanto essa sia
autorevole; richiede invece una vicenda pratica che garantisca l’iscrizione della
norma nella coscienza; cattiva è la soggettività in forza della quale il soggetto,
sollecitato dalla fastidiosa coscienza dell’un indice di arbitrio che vizia tutti i suoi
comportamenti, sceglie di darsi una regola, ma appunto solo sceglie, così come
sceglie una religione; immagina che scegliere basti a conferire un profilo di libertà
alla sua vita; ma quel senso di autonomia appare alquanto illusorio.
Gli interrogativi elusi
Che cos’è dunque cultura? Il complesso delle forme simboliche mediante
le quali trovano articolazione i significati elementari del vivere. Essa è ingrediente
assolutamente essenziale del singolo, e prima ancora del rapporto umano
attraverso il quale il singolo prende coscienza di sé; vivere insieme si può soltanto
sulla base di un’intesa circa i significati elementari; l’intesa è garantita non da un
sapere antecedente al rapporto; essa si realizza grazie ad evidenze che la stessa
vita comune dischiude; realizzandosi, la vita comune produce insieme le risorse
che consentono l’intesa. L’idea di cultura illustra una qualità del rapporto sociale,
che tradizionalmente era ignorata: quel rapporto concorre in maniera essenziale
alla configurazione della coscienza. Cicerone riconosceva che, perché sussista una
res publica, non basta l’accordo sull’utile, ma occorre quello su ciò che è giusto5,
o addirittura su ciò che è buono e rende degna la vita. La necessità di un consenso
morale perché sussista res publica spiega il nesso stretto che lega la nascita della
città o della civiltà alla nascita dell’uomo.
4
TH. LUCKMANN, La religione invisibile (1963), Il Mulino, Bologna 1976, p. 137; cfr. in generale
tutto il cap. VI, pp. 107-152, dedicato appunto al rapporto tra “Religione e identità personale nella
società moderna”.
5
Egli definiva la res publica come un coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione
sociatus, CICERONE, De re publica 1,39.
Soltanto la città consente di dare nome a tutte le cose, e con il nome un
senso; tutte le cose sono iscritte entro la cornice della vita buona. Soltanto grazie a
tale attitudine a plasmare la percezione del senso di tutte le cose, l’alleanza civile
dispone insieme le condizioni che consentono di promettere, che anzi impongo al
singolo di promettere; la promessa è possibile soltanto sullo sfondo di un mondo
che conosce un ordine morale condiviso. La vita comune addomestica – per così
dire – il mondo, lo rende come una casa (domus), un luogo familiare e
amichevole, propizio alla vita comune.
Alla cultura, intesa come sistema simbolico che rende possibile il consenso
su quel che è buono, corrispondono i modi di vedere del singolo. Tra forme
oggettive della cultura e visione del mondo del singolo sussiste un rapporto
circolare. La cultura intesa come codice di senso sotteso allo scambio sociale non
sussiste che grazie all’uso effettivo che ne fanno i singoli; la cultura vive grazie a
tale uso; esso determina sempre da capo i contenuti della cultura e li trasmette da
una generazione all’altra. Soltanto l’uso effettivo consente al singolo di accedere
alla verità del codice. Il debito del codice nei confronti dell’uso illustra appunto il
carattere circolare del rapporto che lega cultura e coscienza. Non è vero che il
singolo è in grado di sapere e volere a monte rispetto al rapporto con altri, e alle
indicazioni che appunto dalla cultura condivisa gli vengono; soltanto grazie alla
vox suggerita dalla lingua comune egli viene a coscienza del verbum interiore6.
Vale a proposito della cultura quel che più volte è stato osservato a
proposito della lingua: essa prefigura una visione del mondo, ma non la realizza.
La cultura non è ancora una visione del mondo, ma la prefigura. La ripresa delle
sue risorse simboliche ad opera della coscienza non è tautologica; essa
ulteriormente determina i significati della cultura comune; ma di una ripresa pur
sempre si tratta, che sconta vantaggi e pregiudizi connessi alla qualità del codice.
Nel giorno della sua vocazione Isaia vide Dio nel tempio; si spaventò
moltissimo, cadde a terra e disse: Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle
labbra impure io sono, eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli
eserciti; la sua confessione si accompagna a una sommessa scusa, in mezzo a un
popolo dalle labbra impure io abito; come potrei essere sincero? Egli confessa
d’essere dalle labbra impure; ma prima ancora delle sue, impure sono le labbra
del popolo a cui appartiene; ha imparato a parlare grazie a una lingua che mente;
come potrebbe dire la verità? La lingua è espressione della cultura tra le più
qualificanti; soltanto grazie alla lingua i membri di un popolo possono intendersi.
Il profeta segnala un profilo del rapporto tra cultura e religione troppo trascurato;
rimuove un tale profilo una concezione troppo interiore della religione. La qualità
del nostro rapporto con Dio è segnata dalla tradizione civile della quale viviamo,
dalla sua cultura. Essa non è certo al di sopra di ogni sospetto; anche espone
all’inganno; nella sua ripresa delle risorse della cultura la coscienza ha sempre un
compito di discernimento; la ripresa del singolo non è tautologica. I discorsi
ecclesiastici sulla cultura e sulla necessità di aggiornare le forme del ministero
troppo spesso ignorano questo aspetto non asettico dell’aggiornamento. Le riprese
di elementi di cultura nella prospettiva della fede non possono essere tautologiche;
comportano una rinnovata interpretazione di quegli elementi; comportano, sotto
altro profilo, la rinnovata determinazione del senso stesso della verità di fede.
6
La distinzione tra vox esteriore che passa e verbum interiore che rimane è, come a tutti noto, di
sant’Agostino; essa è svolta a interpretazione della differenza e insieme del rapporto tra il
Precursore e il Verbo fatto carne (vedi Tractatus in Johannis Evangelium 4,7).
I modi correnti di esprimersi suggeriscono l’idea che il singolo sappia da
solo quel che pensa e quel che vuole; si serva delle risorse offerte dalla cultura
comune soltanto per dirlo ad altri. In realtà la dinamica è più complessa. A monte
della parola udita da altri il singolo non ha pensiero proprio, e neppure volontà
propria. La coscienza del singolo è resa possibile dalle risorse offerte dal codice
civile. Non c’è prima il soggetto, e soltanto poi il rapporto sociale; il singolo viene
a capo di sé attraverso il rapporto con altri, attingendo al codice comune. Il
soggetto articola la propria visione del mondo appunto mediante le risorse offerte
dal codice della cultura, e mediante le risorse offerte dai rapporti pratici con altri;
essi gli consentono di accedere alla verità intesa dal codice.
Occorre ricordare anche l’altro lato della questione: il codice comune
sussiste soltanto grazie alla vicenda che lo ha generato. Il codice, proprio perché
tale, appare universale, sembra quasi cancellare la memoria della vicenda che lo
ha generato. Che tale vicenda possa generare un codice universale, si capisce
soltanto quando di consideri la necessità che le vicende individuali mostrano fin
dall’inizio di riferirsi appunto a una legge universale per trovare la loro verità.
L’affermazione dev’essere meglio chiarita. In che senso si può parlare di
verità a proposito di una vicenda singolare? Come chiarire l’idea che sia
necessario riferirsi a una legge universale per trovarne quella verità? Ogni vicenda
singolare genera rapporti di prossimità, che promettono d’essere per sempre;
“vera” appare in tal senso la vicenda che sappia determinare la figura di quel per
sempre che all’inizio promette. Appunto per definire tale figura è indispensabile il
riferimento a una legge.
Il nesso tra singolare e universale si chiarisce meglio appunto per
riferimento alla figura della promessa. La prossimità sorprendente con altri è
subito apprezzata da chi la vive come buona, come il bene – infatti non è bene che
l’uomo sia solo (Gn 2, 18). Per trovare la verità alla quale rimanda, la prossimità
postula che intervenga una promessa; essa d’altra parte è possibile soltanto a
condizione di trovare la parola, che iscrive la vicenda singola nell’orizzonte della
legge per sempre. A meno di promettere, di poter dire una parola ferma per
sempre, la prossimità reciproca appare mancante, esposta al rischio di apparire
come menzogna.
La verità di tali affermazioni trova chiaro riscontro nel rapporto tra uomo e
donna. Convincenti indizi mostrano come proprio tale rapporto sia l’archetipo di
ogni relazione umana. A procedere da esso nasce la parola, e quindi la lingua, la
cultura, l’universo intero dei significati. Ora appunto quel rapporto illustra in
maniera eloquente il nesso tra parola e promessa. Il legame tra uomo e donna,
annunciato dal desiderio che tra di essi si accende, e poi dall’affetto che la
consuetudine di rapporti genera, invoca un’alleanza per sempre; invoca in tal
senso la parola capace di iscrivere il rapporto entro l’ordine universale; solo così è
possibile la promessa. L’alleanza coniugale ha appunto la forma di una promessa,
di uno sposalizio (il latino spondere significa promettere).
Invocano un per sempre anche i rapporti tra genitori e figli o tra fratelli,
certo; essi diventano possibili però unicamente a seguito dell’alleanza tra uomo e
donna. Il carattere universale della parola, o del concetto, non può essere inteso
nei termini troppo formali che presumono di vedere in esso l’opera della ragione.
La parola è universale, non perché astratta e senza riferimento alla storia di chi la
pronuncia; al contrario, soltanto quella vicenda consente di istituire il senso della
parola; la parola è universale, perché la vicenda concreta istituisce per i singoli
una speranza per sempre, e quindi la necessità morale di promettere.
Il nesso tra carattere universale della parola ed esigenze della promessa si
rinnova da ogni volta che ha inizio una nuova vicenda, ogni volta che l’incontro
tra uomo e donna da capo suscita il desiderio della promessa. I singoli apprendono
le parole della promessa dalle generazioni che li hanno preceduti, certo; e tuttavia
la verità di quelle parole è come risuscitata grazie a evidenze dischiuse non dalle
parole, ma dal rinnovato evento dell’incontro.
La verità di cui è gravido il codice della lingua, e sono gravidi i codici tutti
che concorrono a definire la cultura di un popolo, diventa manifesta grazie alle
vicende singolari; possiamo verificare nella maniera più perspicua e persuasiva la
pertinenza del principio considerando il rapporto con l’infante senza parola;
soltanto attraverso il suo apprendimento gli adulti toccano con mano l’effetto
magico della parola, la capacità ch’essa ha di addomesticare il mondo, di
dischiudere in tal modo il suo volto accogliente e promettente agli occhi del
bambino. Una tale esperienza vive in maniera eloquente in primo luogo la madre;
la virtù della parola sembrava ormai come dimenticata, ma grazie al bambino essa
rivive.
Questa circolarità di rapporti tra lingua e parola, e in generale tra cultura e
vicende singolari, è esposta a minacce sistemiche nell’esperienza civile presente;
la rottura di tale circolarità pare pregiudicare la stessa efficienza formativa della
cultura. In tal senso, la cultura sociale (Kultur) rischia di venire separata dalla
formazione (Bildung) della coscienza del singolo. A misura in cui avviene questo,
è compromessa l’attitudine della cultura stessa a fungere quale legge dell’alleanza
sociale, documento di quel che accomuna e rende vera la prossimità. La coscienza
del singolo diventa una faccenda privata; le leggi della vita comune sanciscono
l’estraneità reciproca e non provvedono in alcun modo alla prossimità.
La separazione tra cultura pubblica e forme della Bildung individuale trova
spiegazione in molteplici ragioni. La più radicale è il regime di sostanziale
separazione che regola i rapporti tra famiglia e società. Proprio nella famiglia,
luogo dei rapporti “primari”, trovano sempre rinnovata espressione i significati
elementari della vita. La sottrazione dei rapporti famigliari alla competenza
pubblica, la loro rappresentazione come rapporti soltanto affettivi, e quindi il
regime di clandestinità in cui sono vissuti, sono fattori che erodono lo spazio della
famiglia quale luogo di tradizione. Se la consegna della cultura alle nuove
generazioni si produce nel quadro di rapporti secondari, soprattutto di rapporti tra
pari, pregiudicata è la possibilità che la cultura conosca quei processi di
rigenerazione che si producono grazie alle evidenze dischiuse dalle esperienze
primarie della vita.
Nella vita pubblica hanno rilievo egemonico le forme scientifiche del
sapere, che per loro natura rimuovono l’interrogativo sul senso di tutte le cose;
quelle forme istruiscono soltanto sul come fare, su ciò che serve per rapporto a
obiettivi di esclusiva competenza del singolo. I saperi pubblici sempre meno
investono i territori dei rapporti primari. Minaccia in tal modo di ottundersi quella
valenza simbolica della città, o della civiltà, o della cultura, che un tempo era
invece fondamentale.
L’interruzione della circolarità spontanea tra codici sociali e rapporti
primari propone con urgenza un compito alla teologia, e in generale al pensiero
che ha a cuore la questione umana, quello di chiarire la dinamica dei rapporti tra
cultura ed esperienza personale. La ricerca di carattere antropologico culturale,
che statutariamente privilegia l’uso della categoria di cultura, privilegia
decisamente l’attenzione al codice precostituito e ignora le risorse per
comprendere il codice che sono disposte dalle vicende individuali; si occupa di
cultura non nell’ottica della coscienza, ma in quella della funzionalità sociale. In
tal senso l’antropologia culturale appare assai distante dalla sensibilità per i
problemi posti dalla transizione civile tardo moderna, che pure appaiono
clamorosamente evidenti. Tanto maggiore appare la responsabilità della
riflessione teologica, la quale, per natura sua attenta al punto di vista proprio della
coscienza individuale, e sotto altro profilo attenta al rilievo determinante che deve
essere riconosciuto alla memoria in ordine al riconoscimento del senso di tutte le
cose, è nelle condizioni più propizie per cogliere la gravita dello scollo presente
tra cultura e coscienza.
Occorre però che la teologia superi finalmente quella prospettiva troppo
ingenua, che affronta il problema dei rapporti tra fede e cultura subito e solo nei
termini dell’“aggiornamento”. Occorre che la teologia abbia occhi per i problemi
sistemici della trasformazione culturale recente. A tal fine appunto appare
indispensabile un’elaborazione di carattere propriamente teorico a proposito
dell’idea di cultura; non basta la ricognizione delle forme effettive della cultura
contemporanea; questa stessa ricognizione, per essere realizzata in maniera
consapevole e critica, ha bisogno di quell’elaborazione.