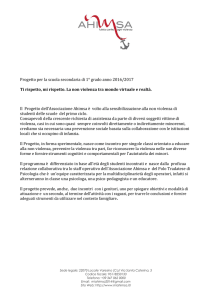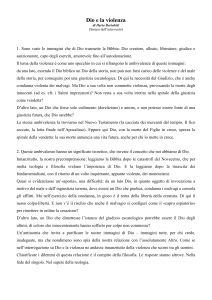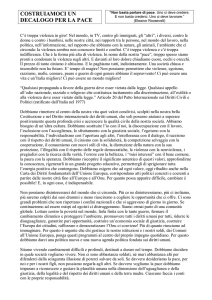SCUOLA PER LA PACE
della Provincia di Lucca
VIOLENZA COME CRISI
DELLA RELAZIONE
Incontro con Adriano Zamperini
1 ottobre 2007
Quaderno n. 50
Adriano Zamperini è Professore di “Psicologia sociale” e di “Relazioni interpersonali nei
contesti organizzativi” alla Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. Svolge attività di
ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Generale della medesima università. I suoi interessi
sono rivolti in modo particolare alla comprensione del comportamento umano in situazioni
estreme (come nel genocidio) e all'estensione di queste conoscenze al mondo della scuola per
la formazione alla convivenza e alla tolleranza. Fra le sue pubblicazioni: Psicologia sociale della
responsabilità (Utet, Torino, 1998); Psicologia dell'inerzia e della solidarietà. Lo spettatore di
fronte alle atrocità collettive (Einaudi, Torino, 2001); Psicologia sociale (Einaudi, Torino, 2002)
(con I. Testoni); Responsabilità civica e psicologia della convivenza (Angeli, Milano, 2005);
L'indifferenza. Conformismo del sentire e dissenso emozionale (Einaudi, Torino 2007).
Ha curato, apportando contributi personali, l'edizione italiana di classici della psicologia, tra
cui: W. Reich, Psicologia di massa del fascismo (Einaudi, Torino, 2002); S. Milgram,
Obbedienza all'autorità (Einaudi, Torino, 2003). È tra i fondatori e Presidente della Società
Italiana di Scienze Psicosociali per la Pace.
Introduzione di Ilaria Vietina
Coordinatrice Scuola per la Pace
Inizia oggi la settimana della pace e intendiamo dare a questa settimana una particolare rilevanza
iniziando con un impegno a celebrare con enfasi e con entusiasmo la prima Giornata Mondiale della
Nonviolenza, indetta dall’ONU per il giorno 2 ottobre.
La nonviolenza non è un atteggiamento passivo o rinunciatario, non è una semplice negazione; è piuttosto un
atteggiamento coraggioso e di sfida. La lezione sulla nonviolenza è quella di Gandhi, nato il 2 ottobre :per
questo motivo l’ONU ha voluto riconoscere – su sollecitazione dell’India – proprio questa giornata come
occasione dedicata alla nonviolenza..
Tra le figure di riferimento della nonviolenza desidero ricordare Aldo Capitini,. il filosofo italiano
che ha pensato e praticato la nonviolenza nell’epoca fascista. Capitini ha vissuto con un coraggio ed una
determinazione veramente unici, esercitando un comportamento critico verso il fascismo che non fosse a sua
volta ispirato alla violenza. Il messaggio di Capitini è poco conosciuto in Italia ed è stato ignorato
esottovalutato da molti. Gli scritti di Capitini sono opere molto profonde che meritano di essere recuperate,
studiate, diffuse.
C’è una cosa da lui ideata che è molto conosciuta: la Marcia Perugia-Assisi. Capitini ha pensato e realizzato
la Marcia tra mille difficoltà, vedendola come il simbolo del cammino deigli amici della nonviolenza che
vogliono praticare con un particolare impegno, la lotta contro ogni tipo di violenza.
La sua riflessione è molto ampia e inizia dalle piccole comunità per arrivare all’orizzonte internazionale. Ed
è proprio su quest’ultimo livello su cui ci vogliamo concentrare, sostenendo la lotta nonviolenta dei monaci e
della popolazione birmana, che, con la loro testimonianza, stanno dimostrando che è possibile lottare con la
nonviolenza. Tutti noi dobbiamo imparare qualcosa da questa esperienza.
Oggi il nostro mondo è scosso da nuovi venti di guerra, sia negli Stati Uniti che in Francia si sta parlando
della futura guerra all’Iran.
Questa sera non abbiamo cercato l’aiuto di uno studioso che si sia occupato di nonviolenza, ma di
violenza. Abbiamo compiuto questa scelta, perché nella nostra città e nel nostro territorio sono emerse con
forza gravi violenze, praticate e considerate come modalità di gestione delle relazioni. Tale violenza negli
ultimi tempi ha invaso alcune fasce della popolazione non solo giovanile, ed è stata caratterizzata da forme di
aggressione violenta e motivata anche da forme di riconoscimento ideologico. Tutto ciò ha provocato nella
nostra città una forma di protesta molto forte ed ampia.
Per questo abbiamo deciso di dedicare la giornata della nonviolenza ad una riflessione sulla violenza
qui a casa nostra. A questo proposito uno degli slogan della Marcia Perugia-Assisi di quest’anno è
“costruiamo la pace a casa nostra”…slogan che per noi lucchesi ha un significato particolare. C’è bisogno di
educarci ed aiutare la cittadinanza a ricostruire modalità di convivenza rispettose e pacifiche.
Ecco perché abbiamo invitato il prof. Zamperini, professore di psicologia sociale, studioso dell’aggressività e
del ruolo dello spettatore di fronte agli atti violenti. Zamperini ha studiato anche il tema della ricostruzione
della convivenza civile. Noi vogliamo partire proprio dalla sua esperienza per riuscire a leggere meglio
quello che sta attraversando la nostra città.
Ovviamente la violenza non è interpretabile solo come “crisi della relazione”. Ci sono anche analisi storiche
e politiche da fare, ma questa sera noi vogliamo concentrarci sul versante psicologico.
Lascio la parola ad una rappresentate del movimento dei genitori contro le violenze, movimento che
è riuscito a diventare un punto di riferimento per tutta la cittadinanza ed è riuscito a scuotere le istituzioni che
in una prima fase avevano sicuramente sottovalutato la situazione.
Introduzione di Marimma Menelao
Comitato Genitori “Fermiamo la violenza”
Posso raccontarvi come è iniziata questa “avventura”. Tutto è cominciato con i racconti dei nostri
ragazzi che narravano di minacce, inseguimenti, aggressioni fisiche e verbali. All’inizio rimanevamo
increduli, perché il nostro territorio sembrava immune dalla violenza.
Una sera i ragazzi hanno chiesto a noi genitori di partecipare – insieme a loro – ad una assemblea. Ci
incontrammo, discutemmo, e piano piano iniziarono ad emergere tantissimi fatti: aggressioni, inseguimenti,
persone che giravano armate di spranghe e coltelli, ecc.
Pochi giorni dopo, nell’ambito di un’inchiesta sui fenomeni di violenza e di bullismo lanciata dal Tirreno,
una professoressa scrisse un articolo nel quale, finalmente, il fenomeno veniva chiamato con il suo vero
nome: rigurgiti di nazifascismo.Effettivamente i personaggi protagonisti delle violenze erano legati al mondo
dell’estrema destra lucchese.
Costituimmo un comitato di genitori con l’obiettivo di denunciare e portare alla luce una verità, per molti
molto scomoda, e scrivemmo qualche articolo sul giornale.
Successivamente abbiamo cercato di coinvolgere le nostre sonnacchiose istituzioni locali: abbiamo
incontrato il questore ed il prefetto che inizialmente parlavano di bullismo. Siamo riusciti a fargli capire che
il bullismo era solo una componente di questa violenza che aveva alla base una ideologia ben precisa.
L’intolleranza verso tutto quello che era diverso: l’immigrato, l’omosessuale, il ragazzo di sinistra, il tifoso
di un’altra squadra, ecc. Questi personaggi avevano eletto la curva dello stadio di Lucca come terreno di
proselitismo.
Successivamente abbiamo scritto una lettera al Presidente della Provincia, al Commissario Straordinario del
Comune di Lucca ed al Ministro degli Interni. La lettera è stata corredata da una cronologia di eventi
ricostruita dai ragazzi stessi; una ricostruzione solo parziale, perché molti dei fatti che sono successi non
sono mai stati denunciati alle Forze dell’Ordine, sia per paura di ritorsioni che (nel caso di immigrati) per
difficoltà di rapportarsi alle forze dell’ordine. Fu inoltre lanciato un appello che ebbe moltissime
sottoscrizioni.
Probabilmente le inchieste che oggi hanno portato a diversi arresti sono partite dalla feroce
aggressione ad Emanuele Pardini, selvaggiamente picchiato e accoltellato nel febbraio 2007. I violenti –
come ha dichiarato il Procuratore della Repubblica Quattrocchi – facevano capo a forze di estrema destra
come Forza Nuova e Fiamma Tricolore.
Come genitori e cittadini vorremmo che la città di Lucca riuscisse a creare un clima veramente
diverso di convivenza pacifica tra le persone, convivenza che non può passare unicamente attraverso la
repressione, ma anche per mezzo di un’educazione diversa sia in ambito scolastico che extrascolastico.
Intervento di Adriano Zamperini
Come molti di voi ormai sanno, sono legato affettivamente a Lucca da parecchi anni, soprattutto per
motivi personali ma pure professionali. Anche quando sono distante mi informo sempre su ciò che accade in
questa città. E quando sono stato chiamato a tenere questo incontro, già sapevo dei gravi ultimi avvenimenti
che vi hanno colpito. Sono rimasto comunque ben impressionato da come la cittadinanza ha reagito a questa
ondata di violenza. Come sappiamo, la violenza si nutre di passività e aspira a creare un deficit di minorità in
chi la subisce. E’ quindi evidente che ogni forma di contrasto alla violenza passa attraverso una
mobilitazione che sia in grado di non lasciare sole le vittime. Perché la violenza si alimenta e si rafforza
quando le vittime sono isolate. Una condizione di isolamento spesso subita dalla vittima: per vergogna, per
paura o per impossibilità di denunciare gli aggressori. In questi frangenti è fondamentale il ruolo della
comunità. Una comunità che sa dare risposte pubbliche, come quella di questa sera, che ci trova qui riuniti
per confrontarci e discutere.
Vorrei iniziare dall’introduzione di Ilaria Vietina. Ilaria sosteneva l’esigenza di una pace che non sia
semplicemente una pace tra nazioni, oppure una pace che riguarda solo gli altri. Bisogna essere sì attenti a
quello che accade nel mondo, ma anche guardare con attenzione a quello che accade a casa nostra. Per
questo vorrei parlare non tanto di pace secondo i termini consueti e abituali, ma discutere di pace urbana.
Oggi, nella nostra realtà, sempre più spesso i conflitti e le violenze si manifestano nel tessuto urbano,
coinvolgendo direttamente la popolazione residente. Io vivo e insegno a Padova, e anche questa città deve far
fronte a gravi conflitti. In questo caso legati alla difficile convivenza tra italiani e stranieri. Tempo fa, come
ben sapete, Padova era famosa per due cose: la sua Università e il Santo. Oggi è purtroppo famosa anche per
il muro di Via Anelli. Il simbolo del “Bronx di Padova”, il “ghetto” degli immigrati. Attualmente, su incarico
dell’Amministrazione Comunale, sono al lavoro con altri colleghi per contribuire a creare un clima
sostenibile di convivenza. Nel Nord-est tutti reclamano gli immigrati come forza lavoro indispensabile per
l’economia. Ma non arrivano solo “braccia da lavoro”. Arrivano persone. Con bisogni ed esigenze che fanno
uscire il fenomeno migratorio dalle fabbriche, per diventare fenomeno quotidiano. Sul treno, al bar, in coda
alla posta, nelle scuole, e così via. Il fenomeno migratorio si riversa così in tutti gli ambiti della vita
quotidiana. E come reagiamo ai nuovi problemi di convivenza diventa un test per tutti noi. Un test che ci fa
capire come pensiamo la collettività e soprattutto quali relazioni sociali siamo in grado di sostenere e di
promuovere.
Cercherò allora di ragionare sul tema della violenza intesa come crisi della relazione. Mentre ero in
viaggio verso Lucca, in treno ho riletto alcuni ritagli di giornale in merito alle ultime vicende accadute in
questa città. E ho notato che in tutti gli atti di violenza c’è un elemento ricorrente: la violenza colpisce
sempre un “diverso”. In questi casi, diverso per orientamento sessuale o per orientamento politico. La
violenza è un fenomeno articolato ed è necessario, per capirla, iniziare mettendo in evidenza un elemento di
fondo: la violenza è sempre il segnale della crisi della capacità di convivere con chi è diverso da noi. Capire
questa difficoltà non significa giustificarla, ma bisogna comprendere che – come detto nel precedente
intervento – non è sufficiente un’azione repressiva per fermarla. Dobbiamo capire la violenza, comprendere
cosa la sostiene, cogliere quale energia l’alimenta. Dico questo perché la violenza non è un raptus istintuale.
La violenza è un sistema pianificato e sistematico per offendere, psicologicamente e fisicamente, singole
persone o interi gruppi sociali. Essa impegna emotivamente e cognitivamente vittime e carnefici, coloro che
la subiscono e coloro che la praticano. Per questo, dobbiamo cercare di stare dalla parte non solo di chi
subisce violenza, ma anche dalla parte di chi fa violenza. Certamente, compito quest’ultimo molto più
difficile. Perché, se è ovvio e tutto sommato facile stare dalla parte della vittima, non lo è altrettanto
immedesimarci nei panni del violento. Eppure è una operazione necessaria per capire cosa instrada una
persona verso il circolo della violenza. Cosa la sorregge? Cosa la porta a compiere gesti violenti? Senza
questa operazione rischiamo di pensare che ci sia una sorta di “cattiveria” che alberga dentro singole
persone. Ma in realtà non è così. Noi psicologi non parliamo mai di cattiveria, ma di aggressività. E
cerchiamo di comprenderla analizzando che cosa accade tra esseri umani.
Perché è importante capire il mondo di chi agisce la violenza? Perché la violenza non si manifesta
mai in un vuoto, ma sempre all’interno di una cornice di significato. Perché chi mette in atto una condotta
violenta ha bisogno di una cornice che lo orienta e lo informa sul modo di pensare e di agire. E’ quindi
importante capire come gli individui che fanno ricorso alla violenza danno un senso a se stessi, come
leggono gli avvenimenti che li vedono protagonisti, e in che modo regolano la propria condotta nei diversi
ambienti, risultando in alcuni brutali e in altri persone tranquille e socievoli. Cosa trasforma le persone? Cosa
le fa diventare aggressive? Per questo il giudizio negativo deve essere accompagnato dal problema del
capire, perché se non capiamo ci limitiamo a mettere a tacere il problema, sanzionando semplicemente la
condotta. Sanzionare è legittimo e giusto, ma non basta.
Cosa significa capire la cornice entro cui una persona agisce? Siamo abituati a pensare che il mondo
in cui viviamo sia ben definito e che tutti condividiamo i valori che lo regolano. E’ indubbio: noi esseri
umani diamo un senso al nostro ambiente. Ma non sempre nello stesso modo. E così il mondo non è
uniforme come si possa credere. Ne consegue che anche il modo di muoversi nella realtà sociale è mutevole.
Per capire meglio vi racconto una storiella. Durante una notte buia e tempestosa un cavaliere galoppa senza
sosta. A un certo punto, nota in lontananza una luce fioca, che prontamente raggiunge. Giunge così a una
locanda. Bussa alla porta e dopo pochi attimi il locandiere si affaccia e lo guarda tra l’incuriosito e
l’esterrefatto. Il locandiere gli chiede da dove proviene e come sia arrivato fin lì. Il cavaliere, senza
nemmeno più il fiato per rispondere, si limita a indicare con la mano la direzione alle proprie spalle. Allora il
locandiere – assai stupito – gli chiede: “Mah, come…, lei avrebbe cavalcato così a lungo sopra un lago
ghiacciato?”. Il cavaliere, sentite queste parole, viene colto da malore e muore all’istante. Cosa sappiamo di
importante di questa storia? Sappiamo certamente che il cavaliere ha lanciato il suo cavallo al galoppo su un
sottile strato di ghiaccio per diversi chilometri. Ma udito che cosa aveva veramente fatto, il cavaliere morì sul
colpo, probabilmente a causa di un forte spavento postumo. Allora, per noi è evidente che mentre cavalcava
credeva di cavalcare sopra il terreno di una prateria. Non certo sopra una sottile pellicola di ghiaccio. Se
l’avesse saputo, non si sarebbe lanciato al galoppo. La prateria (immaginata) e non il lago ghiacciato
rappresenta l’ambiente psicologico. E ogni essere umano dona un senso al proprio ambiente, agendo di
conseguenza. Dobbiamo quindi chiederci qual è l’ambiente psicologico di chi agisce violenza. Sapendo che i
rapporti umani subiscono dei cambiamenti in funzione del rispettivo ambiente: ad esempio, in certi ambienti
una pratica è ammissibile, mentre in altri no. E oggi, nella nostra società, a livello generale, non è certo lecito
agire violenza. Eppure non mancano episodi del genere.
Agire violenza in maniera pianificata non è allora facile, e nemmeno banale. E non stiamo parlando
di violenza come reazione a un torto subito. Parliamo di violenza indiscriminata. Apparentemente, ma solo
apparentemente, insensata. Come abbiamo già indicato, il punto di partenza è l’idea che alla base di ogni atto
di violenza vi sia un’incapacità di gestire il rapporto con chi è diverso da noi. Questo sul piano generale, ma
dobbiamo ora abbassare lo sguardo al concreto accadere dell’incontro. Quando si materializza il contatto con
questo diverso. Sappiamo che gli esseri umani, davanti a una persona stesa a terra, sanguinante perché
brutalmente picchiata, possono benissimo non provare alcuna compassione ma addirittura euforia. Come è
possibile sperimentare questa euforia? Cosa fa gioire della sofferenza altrui? Come è possibile che l’essere
umano possa fare qualcosa di così atroce, qualcosa che è comunemente bandito dalla comunità? Un
fenomeno molto studiato in psicologia prende il nome di “disimpegno morale”: gli esseri umani, quando
sono coinvolti attivamente in situazioni di violenza, tendono a disimpegnare se stessi, a vedere ciò che
accade non come qualcosa di negativo, ma come qualcosa che è lecito e pertinente. Come è possibile che un
simile processo si presenti in ragazzi cresciuti in una realtà dove, almeno così credo, non si insegna certo a
bastonare a sangue un altro ragazzo indifeso?
Innanzi tutto, per capire come un singolo possa apprendere ad agire violenza, dobbiamo tener
presente che i principi morali che tutti noi utilizziamo sono facilmente “malleabili”. Sono principi in qualche
modo fragili a livello psicologico, e possono essere agevolmente distorti. Anche quei sani principi che tutti
noi lodiamo, e senza i quali sarebbe impossibile vivere in una comunità. Inoltre, la mente umana è abile nel
destreggiarsi tra i diversi principi, magari applicandoli in modo selettivo. Pensiamo ai fatti recenti di Lucca.
Ho letto sui quotidiani locali le intercettazioni telefoniche dei ragazzi lucchesi coinvolti in queste vicende di
violenza. Forse qualcuno di voi l’avrà già notato: tra di loro risultano essere estremamente solidali…e la
solidarietà è in sé un valore. Chi può affermare che la solidarietà sia di per sé negativa? E’ però evidente che
anche valori fondamentali possono essere manipolati, usati come strategia di sostegno per offendere e far del
male. E non è certamente un caso che tutti i membri del siano legati dall’essere solidali nella colpa: tutti
fanno qualcosa di negativo, tutti si sporcano le mani, tutti sono coinvolti, e per sempre.
Dall’altro versante, è importante riflettere come, seppure pubblicamente biasimata, la violenza –
ovviamente ben camuffata – possa comunque essere socializzata, e venire addirittura considerata una norma
regolatrice della società. Pensiamo ad esempio alle cosiddette culture dell’onore, dove il torto subito viene
ricambiato con una vendetta subitanea. Quando diciamo a un ragazzo che ha subito un torto “Fatti valere e
ripaga con la stessa moneta”, non facciamo altro che utilizzare la norma implicita secondo cui a un danno
subito deve corrispondere una ritorsione della stessa natura dell’offesa patita. Inoltre, in molte culture e subculture, picchiare le donne è considerato normale, soprattutto all’interno dei rapporti di coppia. Questo ci
inorridisce, ma è una realtà sociale con cui dobbiamo fare i conti. E per chi vive all’interno di queste realtà,
la violenza agita è spesso un segno distintivo dell’appartenenza a un particolare gruppo di riferimento. Ad
esempio, nei paesi latini, per gli uomini, fare sfoggio di aggressività nei confronti delle donne è considerato
un indicatore di mascolinità. E si tratta di un attributo desiderato dai singoli maschi e socialmente
riconosciuto.
Vi sono inoltre processi psicologici che lavorano per non sentire la sofferenza dell’altro, la
sofferenza di chi subisce la violenza. Vi siete mai chiesti perché coloro che fanno per “mestiere” quello di
uccidere vengono sottoposti a un particolare training formativo? Il soldato non deve credere di uccidere un
uomo, piuttosto deve credere di uccidere un nemico. I soldati vengono addestrati a pensare alla vittima come
a qualcuno – talvolta anche come a “qualcosa” – distante moralmente e psicologicamente da se stessi, e
comunque come qualcuno portatore di negatività o di minaccia. Così certe emozioni ingombranti – come la
compassione – non verranno provate. Qualcosa di analogo lo possiamo rintracciare nelle violenze di Lucca.
Le vittime sono state squalificate facendo ricorso a un’identità sociale negativa. In questi casi non è
importante che a subire la violenza sia Paolo, Elisa e Mario, singole e ben identificate persone. Piuttosto
deve essere un membro di una determinata categoria. L’identità sociale diventa così centrale per chi agisce
violenza, non tanto per chi la subisce. E’ evidente che in questi frangenti la vittima non può fare nulla,
perché sono altri che decidono la sua sorte. Chi mette in atto la violenza manipola in negativo l’identità di
chi la subisce, e questo in qualche modo giustifica la violenza e conferma la bontà dell’azione. Pensiamo a
certe forme di violenza pseudo-politica – utilizzo questo termine perché spesso la politica diventa una
maschera dietro cui si nasconde il fallimento dell’incontro con la diversità – e vedremo facilmente come la
stessa si nutra di un linguaggio da pulizia etnica: “Facciamo pulizia”, “Bonifichiamo il nostro paese da
questa cancrena”, e così via. Squalificare la vittima significa altresì elevare il proprio gruppo al rango più
alto, ammantarlo di onore e gloria. E non è certo un caso che chi fa ricorso alla violenza squalificando gli
altri, dal punto di vista psicologico è un insicuro e fragile. E più la persona è contraddistinta da un “io
piccolo”, più sentirà il bisogno di gonfiarlo, dotandosi di “stampelle” esterne – l’appartenenza a un gruppo
ritenuto importante e forte – che lo sorregga. Per questo la violenza non la pratica chi è forte, ma chi è
debole; talmente debole da avere paura della propria paura, così da esportare la sua debolezza annichilendo
l’altro. Attenzione: con questo non voglio dire che un simile “io piccolo” abbia bisogno di una terapia.
Piuttosto si tratta di comprendere quali fragilità e incertezze incrinano la sua presenza nel mondo. Pensiamo
a un adolescente che vive nello stadio di sospensione tra il ragazzo che è stato e l’adulto che ancora non è. Si
tratta di un periodo della vita che genera molta insicurezza; ebbene, in questo contesto la violenza
organizzata può essere fonte di sicurezza e di sostegno, perché diventa una guida che orienta su come stare
nel mondo, informando inoltre sulle strategie più semplici e rapide per rafforzare la propria identità.
Leggendo le cronache, anche locali, possiamo vedere quante volte la violenza venga praticata in gruppo.
Senza voler demonizzare i gruppi – fondamentali per la vita individuale e collettiva –, è però evidente che
nel nostro caso diventano la maschera per nascondere la fragilità dei singoli. Fragilità che viene esorcizzata
attraverso un rito aggressivo. Fragilità che viene sedata ad ogni atto violento. Ma essendo la violenza un
surrogato, non il vero alimento che può saturare tale fragilità, ecco che la stessa continua a tornare a galla,
riaffiora continuamente. L’escalation della violenza può essere vista come una medicina sbagliata che punta
– vanamente – a sanare questa fragilità, che sempre irrompe nella mente dei singoli.
Detta così, passando attraverso la violenza, la questione dell’identità pare decisamente scottante.
Eppure è impossibile fare a meno dell’identità, sia personale che collettiva, perché tutti gli esseri umani si
nutrono di riconoscimento, il cibo indispensabile per la nostra psiche. Da un lato abbiamo un’identità
individuale, dall’altro c’è l’identità collettiva. Questi due elementi fondano la mia persona e permettono a me
stesso di dare un senso alla mia presenza nel mondo. Gli psicologi hanno evidenziato che se prendiamo un
gruppo di ragazzi, li dividiamo in due gruppi – sulla base di un criterio minimo, come un giudizio estetico in
merito a chi ama un pittore piuttosto che un altro –, li mettiamo a svolgere un compito senza neppure che gli
stessi debbano interagire, tra i membri nasce facilmente un comportamento a favore del gruppo di
appartenenza e una certa ostilità verso l’altro gruppo. Pur essendo una divisione banale, direi insignificante,
la distinzione in due categorie risulta essere importante per la psicologia del “noi” e “loro”. Questo è quello
che accade, ad esempio, nei comportamenti degli ultras: non c’è il “me” Luigi contro il “te” Paolo, c’è il noi
“lucchesi” contro il “voi” pisani. In tale contesto non c’è più spazio per la soggettività, non c’è più spazio per
le singole persone; il sentimento dell’appartenenza diventa decisivo. Non picchio l’altro perché è una
determinata persona, ma come membro del gruppo avversario. Ecco perché questo tipo di violenza non
incontra mai la sua vittima. Non è, ad esempio, la violenza di due ragazzi che si picchiano perché si
contendono la fidanzata. Non c’è mai un confronto a livello personale.
Questo tipo di violenza genera inoltre spaesamento nella vittima, perché essa comprende che è
insignificante quello che fa o non fa per l’aggressore. L’io non conta quasi nulla, perché la vittima viene
aggredita non tanto per quello che fa ma soprattutto per quello che rappresenta agli occhi del violento; se
questo è vero, come fa la vittima a difendersi? Cosa deve cambiare? Cosa può fare? Ben poco, perché sono
gli altri che l’hanno individuata come bersaglio. Si comprende quindi che una persona che subisce questo
tipo di violenza va fortemente sostenuta, va portata fuori dall’isolamento, perché rischia di soccombere a una
vera e propria tirannia. Fatte le dovute proporzioni, si tratta della stessa tirannia che veniva messa in atto nei
campi di sterminio, dove era indifferente quello che una persona faceva, era l’aguzzino a decidere cosa fare.
Tu prigioniero, ridi? Allora ti bastono. Piangi? Ti bastono. Lavori con impegno? Ti bastono. Non ti impegni
nel lavoro? Ti bastono. Davanti a un simile arbitrio, il prigioniero diventa preda di un senso di impotenza, e
come singolo soccombe. Leggendo le recenti cronache di Lucca, mi sembra che si possa rintracciare un
clima analogo: ci sono – o ci sono state – persone in balia di una violenza apparentemente insensata, ma per
le vittime che l’hanno subita; mentre per gli aggressori aveva un preciso significato.
Per concludere vorrei spendere ancora qualche parola su emozioni e violenza. “Io non devo provare
certe emozioni verso di loro”, questo potrebbe essere il motto dei membri di gruppi che praticano violenza
contro membri di altri gruppi sociali. Chi agisce la violenza non solo costruisce una precisa cornice
cognitiva, ma modula anche le emozioni in una certa maniera. Oggi, nell’incontro che ho avuto con gli
insegnanti, uno di loro mi ha raccontato un episodio molto bello accaduto nella sua classe: un ragazzo di
estrema destra si è innamorato di una ragazza di colore. Lascio a voi immaginare le conseguenze. Questo
episodio segnala con forza come le persone che aderiscono a un certo tipo di violenza debbano sottoporsi a
uno specifico apprendimento emozionale. Perché, nel momento in cui un singolo individuo si innamora di
una persona che fa parte del gruppo delle “scimmie”, stigmatizzato e biasimato, va in confusione, non
capisce più niente e la cornice di senso che si era costruito va in frantumi. Questo ragazzo all’inizio era
disorientato, confuso, senza segnaletica, come chiunque di noi perso nella nebbia. Un simile
disorientamento, una specie di “devianza emozionale” rispetto al canone fissato dal gruppo di appartenenza,
al di là del travaglio personale, segnala a tutti noi i vincoli emozionali associati alla violenza. Spesso i
ragazzi che fanno parte di gruppi violenti sono sottoposti a prove per essere sensibilizzati a “non sentire”, per
apprendere a non provare emozioni nei confronti degli altri, quegli altri giudicati inferiori. Questo accenno
finale alle emozioni mi serve per evidenziare ancora una volta come la violenza di cui abbiamo parlato
richiede sistema, impegno, ordine; in altre parole, una certa disciplina della mente e delle emozioni. E credo
che solo comprendendo questi processi, possiamo capire fino in fondo la violenza.
Solo se cogliamo le radici del problema possiamo pensare non semplicemente a una risposta che isoli
la mela marcia, ma a una risposta che consideri questa stessa mela marcia come un frutto del nostro cesto. La
sfida che si pone di fronte a questi episodi impone una presa di coscienza ben precisa, ossia la capacità di
guardare nello specchio noi stessi, non il mostro. Solo attraverso questa modalità potremo evitare che simili
episodi si diffondano, che si radichino, che si facciano sistema. Cosa possiamo fare? Dobbiamo sicuramente
stare vicini alle vittime, rompere l’isolamento che può indebolirle, e dobbiamo assolutamente evitare la
passività sociale. Dobbiamo agire, come stiamo facendo questa sera. C’è una bellissima metafora di Primo
Levi: egli raccontava che il prigioniero in un campo di sterminio non riusciva a farsi un’idea del sistema
oppressivo che gli gravava addosso, perché era legato con lo sguardo al suolo dai bisogni di tutti i giorni.
Ecco, credo che davanti a questi episodi di violenza, il primo compito che ci compete è quello di alzare lo
sguardo dal suolo, perché se lo teniamo inchiodato a terra – per paura, per opportunismo o per disinteresse –
non avremo mai una chiara rappresentazione di cosa ci sta ferendo. E se non abbiamo una chiara
rappresentazione, le nostre azioni rischiano di essere inefficaci.
Domande del pubblico
Alessandra Vecoli
Ringrazio il relatore che ci ha dato strumenti di riflessione molto importanti. Vorrei riprendere alcuni
ragionamenti di Zamperini. Credo che il sistema, la cornice e la rappresentazione siano elementi
fondamentali per comprendere il fenomeno che ci troviamo di fronte.
Sono tornata a Lucca da pochi anni e mi sono sorpresa, passeggiando per le strade della mia città, di vedere
bancarelle di Forza Nuova con giovani che raccoglievano firme nell’indifferenza generale. Questo mi stupì,
perché era un fatto inconsueto, perché mai in passato avevo visto scenari del genere. L’indifferenza mi stupì
e mi estraneò dalla realtà della mia città. Inoltre come genitore e come cittadina ho vissuto una progressiva
riduzione degli spazi sociali di aggregazione, fatto questo che ha inciso negativamente sulla realtà cittadina.
Il relatore ha esposto in maniera davvero chiara la difficoltà della relazione, che va coltivata, come va
coltivato un sistema culturale che riesca a garantire la pacifica convivenza tra persone diverse. A Lucca si
vedono molti manifesti di Forza Nuova che contengono slogan molto semplici ma efficaci del tipo
“L’immigrato ruba la casa”, “L’immigrato ruba il lavoro”. Affermazioni queste molto banali e false, ma che
riescono a parlare alla pancia delle persone, canalizzando verso l’estrema destra un disagio sociale diffuso.
Tutto questo si fa sistema, soprattutto in realtà come Lucca dove si sono rafforzati nel corso degli anni gruppi
di estrema destra molto forti, e anche radicati nel tessuto della città. E questo processo è avvenuto anche con
la connivenza delle istituzioni: esemplare è il caso del 25 aprile 2001, quando il Comune di Lucca concesse a
Forza Nuova l’utilizzo di una casermetta per un convegno su un gerarca fascista, e purtroppo non fu nè il
solo nè l'ultimo episodio del genere. Credo che tutto questo abbia portato ad una situazione molto grave,
situazione che sembra oggi aver preso forse un indirizzo positivo. Ovviamente le iniziative di tipo giudiziario
sono da valutare positivamente, ma sono secondo me anche i segni di una sconfitta, perché sono piuttosto
tardive. E soprattutto perchè una modifica reale di questa situazione si può ottenere su altri piani, politico e
sociale. Parallelamente C'è da rilevare a questo proposito come a Lucca manchino addirittura gli spazi per
iniziative di confronto, soprattutto per i giovani. A questo proposito c’è da sottolineare che
l’Amministrazione Comunale avrebbe concesso lo spazio per il mercatino dei libri usati ad una associazione
culturale non ben conosciuta, ma sicuramente vicina ad ambiente di estrema destra. Fatto molto grave
questo, visto che da molti anni il tradizionale mercatino dei libri usati è andato avanti tra mille difficoltà,
senza alcun sostegno da parte del comune. In questo contesto mi sembra difficile riuscire a coltivare la
relazione.
Federica Di Spilimbergo
Nella situazione che si è verificata a Lucca abbiamo notato che un gruppo ristretto di persone ha
avuto il sopravvento su un grande numero di persone. Ho partecipato a numerose assemblee scolastiche a cui
erano presenti molti ragazzi spaventati che chiedevano addirittura l’anonimato.
Come può un gruppo ristretto avere il sopravvento su un gruppo grande?
Intervento n°3
La situazione è veramente molto pesante. Oggi essere di estrema destra è “di moda”, fa “identità”.
Davanti alle scuole molto spesso i ci sono ragazzi che cercano di fare proselitismo, anche con metodi
violenti. E non si tratta purtroppo di piccoli gruppi, ma di bande che spesso raggiungono un buon numero.
Dico questo per non rischiare di sottovalutare il fenomeno, quantomeno dal punto di vista numerico.
Lucio Ciccone
Il gruppo ristretto per poter prevaricare si deve impegnare. Allora cosa può fare il resto della società
per non essere prevaricata?
Emanuela Benvenuti
Penso che le famiglie abbiano un ruolo molto fondamentale nella formazione dei ragazzi. Non si può
pensare che i ragazzi diventino aggressivi solo ed unicamente per gli incontri che fanno. Ci sono anche le
famiglie, e vi assicuro che ce ne sono molte che trasmettono messaggi non positivi verso il diverso, verso chi
è immigrato. Percepisco tra i miei studenti questa intolleranza trasmessa dalle famiglie. Dobbiamo
considerare anche questo aspetto che forse questa sera non è stato sufficientemente trattato.
Io – in quanto insegnante – come faccio a “guardare” dentro il violento? Come posso parlarci? Come
comunicare con loro?
Ilaria Vietina
Ci può essere un collegamento tra le forme di violenza locali e le dinamiche di relazione a livello
globale? Da molti anni sappiamo che la parola chiave della relazione tra gli stati è “competizione”; questo è
senza influenza sulle relazioni? L’aggressività che aumenta a tutti i livelli – dal micro al macro – ha forme di
ricadute sul territorio?
Risposte di Adriano Zamperini
Senza entrare troppo nello specifico, provo a spiegare gli effetti del sistema sulla singola mente. E’
provato che se creo una condizione di frustrazione in una persona e la costringo a eseguire una serie di
attività, in una stanza dove è presente un’arma, la probabilità che la persona faccia ricorso a una condotta
aggressiva aumenta in modo vertiginoso. Perché? Perché l’arma è un indizio ambientale che segnala una
sorta di appropriatezza del comportamento aggressivo. E’ evidente che gli esseri umani si muovono nel
mondo con una segnaletica simbolica: quindi se un ambiente mi comunica che un certo tipo di azione è
pertinente, il soggetto sarà influenzato da questo messaggio. Dobbiamo comprendere che la nostra mente per
poter diventare tale ha bisogno degli altri, per essere uno dobbiamo essere almeno in due. Abbiamo dei
sistemi cerebrali – i neuroni specchio – che regolano le risposte emotive rispetto agli altri. E le emozioni
sono sempre plasmate a livello sociale e legate alla geografia sociale: quindi, rispetto ad alcune categorie di
persone proviamo certe emozioni, mentre rispetto ad altre persone che appartengono a un’altra categoria –
sempre colpite dalla medesima situazione – noi proviamo altre emozioni. Con questo voglio dire che le
emozioni non sono un fatto privato, ma pubblico. Le nostre emozioni sono legate alla cornice culturale. La
devianza emozionale è quella condizione in cui si provano emozioni che non andrebbero provate, perché non
previste in certi ambienti. E noi avvertiamo di essere “fuori ruolo”, non all’altezza della situazione, proprio
in funzione delle norme entro cui siamo socializzati. Tutto questo per dire brevemente quanto l’ambiente,
fisico e umano, abbia grande influenza sulla nostra mente e sulla nostra condotta. Legittimando alcuni atti,
piuttosto di altri.
Rispondo alla seconda domanda. Il fenomeno è ben noto, nel senso che il gruppo ristretto è un
gruppo particolarmente coeso, che stringe fortissimi legami al proprio interno. Questa coesione crea una
mente di gruppo, una sorta di soggettività collettiva che stringe le maglie del gruppo. Una simile
compattezza riesce a mettere in difficoltà un gruppo più grande di persone, le quali non sono legate in modo
così ferreo. Si tratta in sostanza di un’affiliazione esclusiva che crea scompenso a una collettività di individui
che si muovono principalmente come singoli. Per questo motivo ho più volte affermato che le vittime di
queste violenze non vanno lasciate sole. Serve una grande risposta della comunità che sappia far valere un
legame ancora più forte rispetto a quello che lega tra loro gli offensori: il legame del rispetto e del
riconoscimento. Inoltre, c’è da aggiungere che è molto più facile destabilizzare con piccoli gruppi, piuttosto
che con grandi gruppi. L’insicurezza crea un contagio emotivo, e sorge la domanda: “Ma chi ci protegge?” E
poiché la protezione non è tanto legata a ciò che uno può fare, perché è decisivo come si appare agli occhi
dell’aggressore, i ragazzi non sanno cosa fare concretamente. E il senso di impotenza che gli esseri umani
provano verso la violenza indiscriminata è devastante. Questa è la forma più subdola di dominio di un essere
umano su un altro essere umano, ovvero fare in modo che sia eterodiretto: “Quello che fai nel mondo
dipende da me, non da te”, questo è il messaggio. Questa condizione è veramente gravosa e crea un clima di
angoscia diffusa che spesso non riesce a coagularsi in ribellione, come se gli esseri umani si guardassero
smarriti e impotenti. Per questi motivi non è infrequente che gruppi ristretti riescano a tenere testa, almeno
entro certi limiti, a gruppi più ampi ma meno coesi di persone. E questi ultimi devono organizzarsi. Non è un
caso che anche a Lucca siano nate assemblee tra studenti; una forma di aggregazione che indica come i
singoli, non sapendo cosa fare individualmente, abbiano avuto bisogno del momento collettivo come
tentativo per parlarsi, per socializzare, per raccontarsi le storie di violenza, per esorcizzarle, e per uscire
dall’isolamento.
Per quanto riguarda il numero di ragazzi coinvolti in questi gruppi violenti, non è tanto importante la
numerosità, quanto la legittimazione che gli stessi sentono di avere. In questo senso emerge la già
menzionata coesione del gruppo, come si evince dalla intercettazioni telefoniche in cui i ragazzi parlano del
metodo seguito per acquisire l’egemonia della curva allo stadio. Emerge l’azione diretta a fare pulizia in
funzione di un dominio. Qui si nota la grande coesione interna che trova sponda in una sorta di
legittimazione radicata nell’indifferenza totale da parte della società calcistica, della cittadinanza, delle
istituzioni.
Cosa fa la maggioranza di fronte a un gruppo violento ristretto? Credo che dovremmo rovesciare la
domanda, ovvero: come agisce il gruppo ristretto? Esso punta alla sopravvivenza di se stesso e non del
singolo membro, questo significa che è disposto a sacrificare anche un membro in funzione della
permanenza del gruppo. Anche noi dovremmo ragionare in questa logica: passare dalla tutela del sé – spesso
interessata e assai meschina – alla tutela dell’intera nostra comunità. In questo modo la maggioranza può
reagire, sennò rischia di disgregarsi. Finché penso solo a me come singolo, la comunità resterà sempre ferita
e non potrà rispondere adeguatamente. Se riduciamo tutto a un semplice problema individuale, del tipo: “Mio
figlio non è stato coinvolto, quindi non m’interessa”, oppure si invoca di punire la famose mele marce,
rischiamo di limitarci all’aspetto giuridico del problema, a fronte di un fenomeno che va ben oltre il
giuridico. Serve quindi una contrapposizione sullo stesso piano – ovvero collettivo –, rivisto però in una
logica positiva: di una comunità che si prende cura di se stessa e dei suoi membri.
C’è un ambiente che “alleva” un certo modo di pensare e di sentire? E’ vero, la nostra cultura
trasforma le emozioni in arma, e anche la paura è un’arma che viene usata, basta ascoltare un qualsiasi TG
che esaspera il problema della sicurezza. Anche le famiglie hanno una grande responsabilità, è vero. E tutto
questo viene esportato nella scuola, dove l’insegnante trova condensati questi problemi nel gruppo classe. E,
oggettivamente, per l’insegnante è molto difficile entrare in comunicazione con gli studenti violenti. Credo
che questo problema richieda uno sguardo molto più attento alle singole realtà scolastiche. C’è da dire che il
fantomatico nemico che quotidianamente i mass media ci propinano, non è mai all’altezza delle nostre paure,
e quindi dobbiamo costruire sempre nuovi nemici che siano all’altezza delle nostre paure. Troviamo sempre
nuovi bersagli, nuovi capri espiatori, che magari stanno ai margini della società, e quindi sono più
vulnerabili. Fare l’insegnante all’interno di una simile e diffusa cultura non è certo facile, comprendo
benissimo. Vivo in Veneto, una regione dove spesso si pensa che il “diverso” dovrebbe essere
“impacchettato” e spedito altrove, una realtà molto pesante che va contrastata ad ogni livello, con la
consapevolezza che non serve una battaglia alla Don Chisciotte, ma che dobbiamo utilizzare l’esistente,
quello che c’è già. Viviamo in un mondo in cui il giudizio precede il processo; noi dobbiamo tornare
indietro, pensando prima al processo, senza stereotipi. Oggi ci sono nel mondo tantissimi “imprenditori della
paura”, che si impossessano dei nostri timori per costruire a tavolino l’immagine del nemico. Gli esempi
sono moltissimi ed è una pratica diffusissima. Basti pensare al fatto che oggi le città non sono più progettate
dagli urbanisti ma dai poliziotti. La città non è più vista come il luogo della vivibilità, ma come luogo della
sicurezza. Città come caserme, come prigione, e noi rischiamo di diventare gli ostaggi di questo mondo,
ostaggi di noi stessi e delle nostre paure. Non si può garantire la sicurezza solo e unicamente con la presenza
di forze dell’ordine; dobbiamo creare vita civile, luoghi di incontro. Invece sono molte le città a doppia
faccia: tranquille e vissute di giorno, pericolose e deserte di notte. Questo fenomeno avviene perché la vita
civile è sempre più di transito, si muove prevalentemente nella sfera privata, anziché in quella pubblica. Da
qui la diminuita partecipazione alla vita collettiva. Credo che questa tendenza vada contrastata a tutti i livelli:
da quello scolastico a quello urbanistico.
Passo all’ultima domanda. Forse è eccessivo parlare di aggressività a livello globale, perché
rischiamo di dare troppa importanza a certi fenomeni. Nei ragazzi entrano in gioco aspetti legati al ciclo di
vita, agli smarrimenti, agli ideali. Le forme aggressive possono essere forme transitorie, e quindi poi
evolvere in un cambiamento positivo nel ciclo di vita. L’aggressività a livello internazionale, che dovremmo
chiamare propriamente guerra di aggressione, direi che va letta secondo la lente degli interessi geopolitici ed
economici. Tutto il resto altro non è che una grande maschera dietro cui si cela l’interesse economico e la
volontà di dominio. Credo che nessuno possa ancora credere alle guerre etniche, men che meno a quelle
umanitarie. Più che parlare di aggressività a livello internazionale, parlerei quindi di una sovraeconomia che
determina i comportamenti degli stati. Credo che la guerra moderna si sia, come dire, “impoverita”, abbia
perso quella “nobiltà” – almeno presunta – che poteva avere nel passato, ridotta anch’essa a un blando
commercio. Le tante guerre contemporanee mi sembrano altrettante messe in scena per occultare gli evidenti
interessi economici delle multinazionali, le vere “guide” dei singoli stati. Il resto altro non è che una
“comparsata” – purtroppo pagata con il sangue di molti innocenti –, con la funzione di gettare fumo negli
occhi e celare la vera realtà.