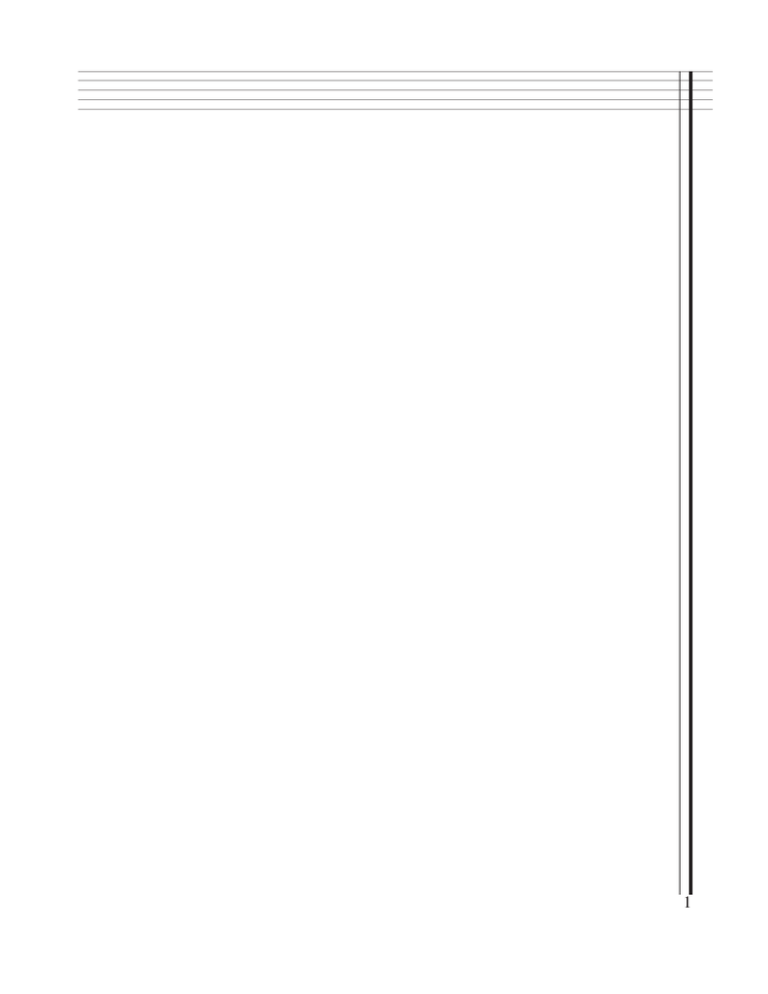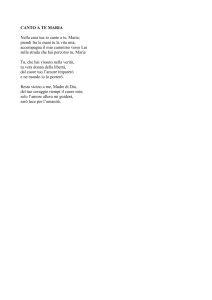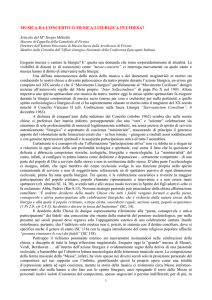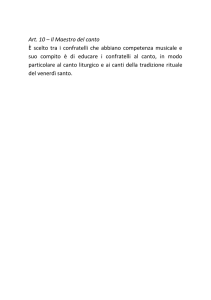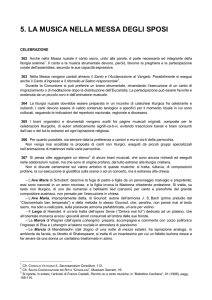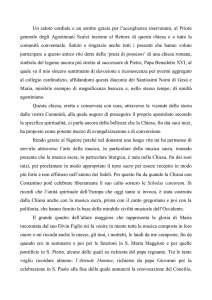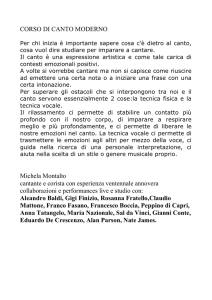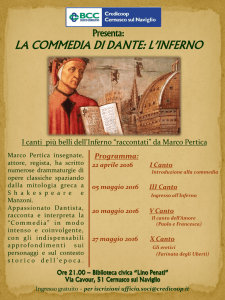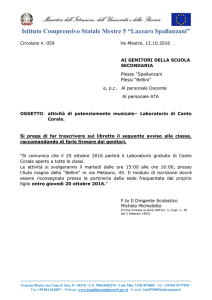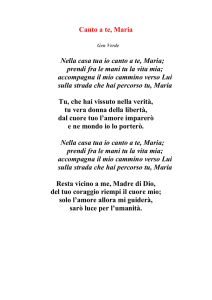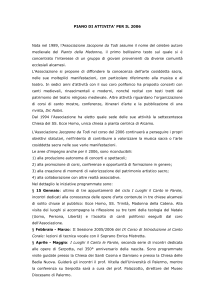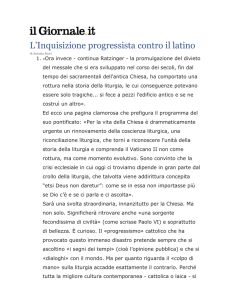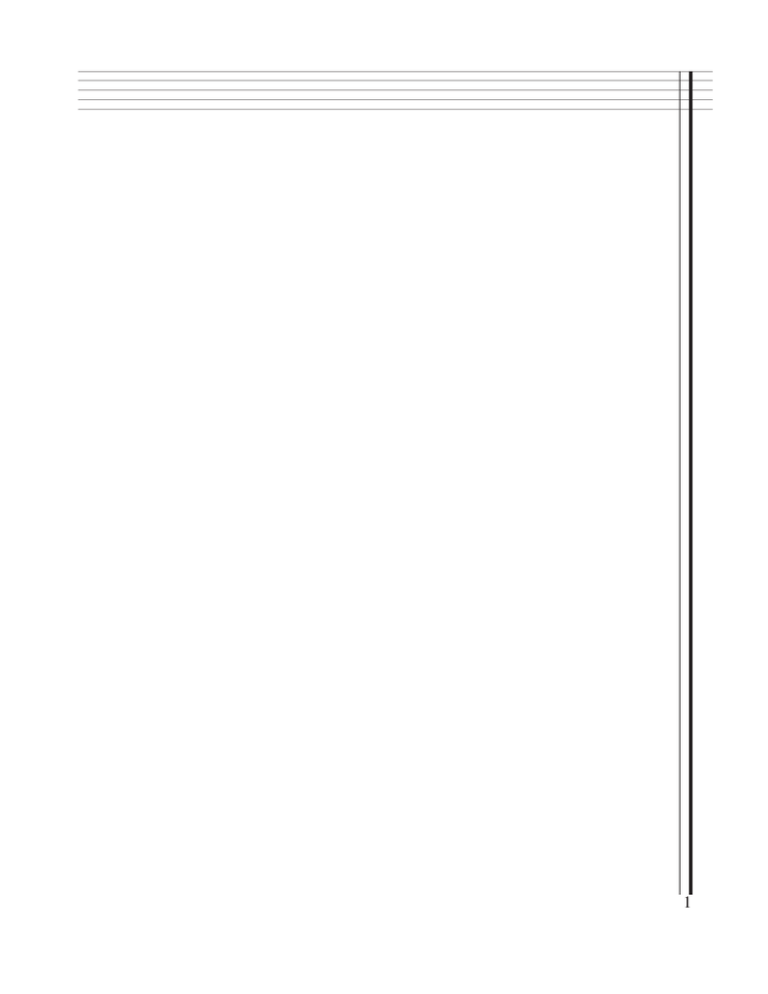
1
REDAZIONE:
COMMISSIONE DIOCESANA DI MUSICA SACRA
CASELLA POSTALE 26
6903 LUGANO
TEL.: 091/967.43.60
FAX: 091/966.13.02
e-mail: [email protected]
Gruppo redazionale:
Antonio Bonvicini
Franco Caccia
Peppino Manzoni
Felice Rainoldi
Michele Tamagni
Incontrarsi n. 23
dicembre 2003
Editoriale ............................................................. 4
Notiziario
Corali centenarie ..........................................................5
"Giovani in festa" ..........................................................6
s
"Cantate Domino" .........................................................7
o
La pagina dell'organista
m
Recensioni
Basta saper suonare? ..................................................8
m
Repertorio
Un canto per il Natale ...................................................9
a
Riflessioni
r
"Il centenario del motu proprio di Pio X" ..................... 11
i
Dossier
o
Questione di nomi? (Parte seconda) ..........................21
Proposte per un programma ...............................26
Accogliamo con gioia il nuovo Pastore
Queste sono le prime righe dell’editoriale della redazione, già in stampa,
che abbiamo bloccato e modificato: "Assieme al Natale arriva anche un
nuovo numero di Incontrarsi. Giunge in ritardo rispetto alle previsioni, perché si attendeva la nomina del nuovo Vescovo. Non abbiamo però voluto
che si chiudesse l'anno senza…incontrarci".
e d i t o r i a l e
Accogliamo con gioia la nomina a vescovo di don Mino Grampa. Ci sembra
bello riportare qui le sue prime impressioni: «Eccomi per quello che posso
essere utile, per spendere gli anni che mi restano al servizio del Vangelo
di Cristo per la speranza del mondo e per la crescita della nostra Chiesa
ticinese. Saluto tutti i diocesani, il Vescovo in carica, monsignor Giuseppe
Torti, che ha retto con sofferta dedizione la nostra Chiesa in questi anni;
l’emerito monsignor Ernesto Togni, che mi fu maestro e guida nei primi
anni del mio servizio presbiterale. I confratelli nel sacerdozio, che operano con impegno pastorale generoso e senza i quali il Vescovo non sarebbe
in grado di svolgere la propria missione, perchè nella Chiesa, con il principio della sussidiarietà, vale soprattutto quello della Comunione.
Saluto tutti i religiosi e le religiose, che impreziosiscono la vita cristiana
con la loro testimonianza, con la loro preghiera e la loro azione. Tutti i
fedeli, le famiglie, gli anziani, i malati, i giovani, i bambini: per loro spenderò senza risparmio gli anni che il Signore vorrà ancora donarmi.
Saluto i cristiani delle altre confessioni, che operano in mezzo a noi, affinchè prevalga ciò che ci unisce e diventiamo assieme segno di speranza e
di pace per il nostro mondo.
Saluto tutti gli uomini amati da Dio, con i quali mi propongo di collaborare in un dialogo franco, aperto, rispettoso, onesto e veritiero per la
risoluzione dei problemi comuni della nostra società. [...]
Invoco la Benedizione del Signore e la protezione della Madonna della
Misericordia ed auguro a tutti di poter godere dei frutti del Natale cristiano. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli uomini che Dio ama».
Porgiamo i più cordiali auguri a don Mino e a tutti i nostri lettori.
4
La redazione
Corali... centenarie!
Nel 2004 due corali che regolarmente prestano servizio per le Messe diffuse settimanalmente alla TSI ed RSI festeggeranno i cento
anni di attività: si tratta della corale "S. Cecilia" di Lugano e della
corale "S. Maria dei Miracoli" di Morbio Inferiore.
È un traguardo veramente notevole e che le rispettive corali giustamente festeggiano. Su questo numero vogliamo rendere brevemente omaggio alla corale di Morbio, sul prossimo ci occuperemo
della "S. Cecilia".
n o t i z i a r i o
La corale "Santa Maria dei Miracoli" è stata fondata l'8 dicembre
1904 da mons. Alfredo Noseda, che fu parroco di Morbio per 60
anni. In questi 100 anni della sua storia essa ha accompagnato la
vita della comunità di Morbio, che ha conosciuto lungo gli anni un
forte incremento demografico, passando dal piccolo villaggio contadino di allora al borgo residenziale di oggi.
Compito principale della Corale è sempre stato quello di animare,
attraverso il canto liturgico, le celebrazioni in parrocchia, sia nella
Basilica-Santuario di Santa Maria dei Miracoli (dalla quale prende il
nome), sia nell'antica chiesa di S. Giorigio.
Con il tempo, a questo compito si sono via via aggiunti altri impegni: la collaborazione con il Centro Cattolico Radio TV della diocesi,
servizi presso altre comunità in occasione di particolari ricorrenze,
concerti...
Dal 1979 la Corale promuove il biennale Convegno delle corali liturgiche, giunto lo scorso giugno alla sua XIII edizione.
Tappa significativa lungo la strada di questo secolo è stato l'anno
1950, quando, con il maestro Sergio Tettamanti, il gruppo ha conosciuto una globale ristrutturazione, intensificando via via la preparazione e gli impegni.
Sergio Tettamanti è stato direttore fino al settembre 1993, anno
della sua prematura morte. Lo ha sostituito il maestro Franco Caccia, cha la dirige attualmente, con la collaborazione all'organo del
maestro Giordano Montanelli.
Oggi la corale di Morbio è formata da una quarantina di elementi:
adolescenti, giovani, adulti, qualcuno pure sulla soglia della terza 5
età. Già vi sono genitori e figli, fra non molto vi saranno sicuramente anche nonni e nipoti.
Per festeggiare i 100 anni sono già in programma alcuni appuntamenti musicali alle seguenti date:
- sabato 7 febbraio 2004 con il coro "B. Marcello" in S. Giorgio
- sabato 29 maggio 2004 concerto della Corale a Viganello
n o t i z i a r i o
- 8 dicembre 2004, data del compleanno, concerto della Corale e
presentazione del nuovo compact-disc del centenario.
6
Giovani in festa
La maestra del "coro giovani di Agra", formazione
che collabora alle messe
diffuse dalla TSI ed RSI,
ha pubblicato una raccolta
di canti da lei composti
dedicata specialmente ai
cori giovanili. Si tratta di
12 composizioni orginali,
per i vari momenti della
celebrazione in cui è previsto il canto (inizio, atto
penitenziale,
Gloria...).
L'accompagnamento prevede sia l'utilizzo della
tastiera che la chitarra.
Gli interessati possono rivolgersi direttamente alla
maestra del coro Viviana
Vassalli, 6927 Agra (tel.
091-9947166).
"Cantate Domino"
r e c e n s i o n i
"Cosa sarebbe il Natale senza musica? Attraverso l'interpretazione di
antifone, mottetti e cantate, dal gregoriano ai nostri giorni, Domenico Pezzini
(sacerdote, professore universitario e
pubblicista, studioso di letteratura inglese medievale) propone un percorso
di riflessione dall'Avvento all'Epifania.
Ne risulta una lectio divina fra pentagrammi e chiavi di violino per un lettore
che desidera meditare in modo originale sul Mistero della Parola che si fa
carne. Anzi, musica!"
Ecco l'elenco dei brani che l'autore
tratta:
- "Rorate coeli" (gregoriano)
- Antifone "O" (Charpentier)
- Tre cantate per l'Avvento (J. S. Bach)
- "Cantata per il SS. Natale" (Scarlatti)
- Oratorio "Messiah", prima parte (G. F. Haendel)
- Oratorio di Natale (J. S. Bach)
- "L'infanzia di Cristo" (H. Berlioz)
- "A ceremony of Carols" (B. Britten)
- "Hodie, a Christmas cantata" (V. Williams)
- "Sie werden aus saba alle kommen" (J. S. Bach)
- "Christus" (F. Mendelssohn)
- "Il viaggio dei Magi" (B. Britten)
- "Liebster Immanuel" (J. S. Bach)
- Quattro mottetti per il tempo di Natale (F. Poulenc)
Domenico Pezzini, "Cantate Domino", meditazioni musicali sul mistero del
Natale, edizioni Ancora 2003, 169 pagine, € 11.
7
l a p a g i n a d e l l'o r g a n i s t a
"Basta saper suonare?"
8
Ci è capitato sotto gli occhi il bando per l’assunzione di un organista presso
una delle basiliche più importanti dell’Italia settentrionale. Leggendo attentamente le prove previste, una domanda è nata spontaneamente:
“Basta saper suonare per fare l’organista di una chiesa?” Infatti ciò che in
termini musicali è richiesto ai concorrenti è notevole: esecuzione di brani
impegnativi di Bach, Mendelsshon, Franck, Listz; improvvisazione su tema
dato e armonizzazione di una melodia. La giuria è composta di organisti
di fama mondiale.
Non compare mai, nel bando, una parola: “liturgia”. Se anche ci si assicura il
miglior esecutore esistente, perché non verificare anche le sue conoscenze
liturgiche? Dopotutto in primis si parla di “prestare servizio alle Messe
celebrate”, e solo dopo di eventuali concerti. Ci sembra questa una notevole
mancanza, in quanto anche il miglior organista-esecutore potrebbe essere
carente in materia liturgica, e la passacaglia di Bach o i corali di Franck certo
non sono adatti ad essere eseguiti durante la celebrazione eucaristica. Già
nel n. 21 di “Incontrarsi” avevamo pubblicato un lungo articolo sull’organo
e la figura dell’organista nella liturgia rinnovata del Concilio Vaticano II.
Ne riportiamo un paragrafo: “Oltre che possedere una adeguata perizia
nell’usare lo strumento, deve conoscere e penetrare intimamente lo spirito
della liturgia, con una preparazione spirituale e una ricchezza interiore”.
Ci auguriamo quindi che la scelta cada su un organista anche con queste
competenze. Ciò che però ci preoccupa maggiormente è che la committenza non le auspichi per il proprio futuro organista.
Diocesi di Milano: IV giornata diocesana organisti
Sabato 13 marzo 2004
9.30 Relazione l´organista custode del proprio strumento. Cenni di
organaria e di restauro Leonardo Trotta, Maurizio Mancino
11.00 Il restauro conservativo, Norme e orientamenti Matteo Galli
12.00 Comunicazioni del Servizio per la Pastorale Liturgica.
12.30 Pausa pranzo.
14.00 Laboratorio Introduzione all´organaria
16.00 Conclusioni.
Al mattino la relazione si svolgerà presso il salone della curia Arcivescovile di Milano in P.za Fontana 2.
Il laboratorio si svolgerà presso la Basilica dei Santi apostoli e Nazaro
Maggiore, P.za S. Nazaro, 5 - Milano.
Quota d'Iscrizione: € 15, da versare in loco.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 11 marzo alla Segreteria
del Servizio per la Pastorale Liturgica P.zza Fontana 2 - 20122 Milano
Tel 028556.345 Fax 028556.302 E-mail [email protected]
Un canto per il Natale
"In excelsis gloria"
Testo: Franco Gomiero
Musica: A. H. Brown (1830-1924)
La musica
Nella tonalità di Sol maggiore, che sottolinea la grandiosità dell’evento della
nascita di Gesù così misteriosa e gloriosa, troviamo il canto “In excelsis
gloria” scritto in forma di Corale a quattro parti dispari con accompagnamento dell’organo che raddoppia tutte le voci ed al quale è affidata una
breve introduzione di quattro battute che anticipano quella che sarà la
melodia affidata al coro.
Si articola in quattro strofe e relativi ritornelli nei quali l’assemblea è invitata
ad aggiungersi e la scrittura che proprio nel ritornello prevede le prime
due battute all’unisono ne facilita l’ingresso. Nelle seguenti sei battute,
poi, l’assemblea canterà la melodia della linea dei soprani. Da notare che
le strofe 1 e 3 iniziano in levare (cioè sull’ultimo quarto dell’ultima battuta
dell’organo che precede il loro inizio), mentre per le strofe 2 e 4 l’attacco
è in battere e anche l’intonazione melodica per contralti tenori e bassi è
diversa rispetto alla prima nota delle strofe 1 e 3.
Non presenta difficoltà ritmiche e melodiche, l’estensione è di una ottava
nel ritornello per quanto riguarda la linea del soprano che sarà la stessa per
l’assemblea, quindi di esecuzione immediata e senza forzature vocali.
r e p e r t o r i o
Il testo
“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1). La prima lettura nella
Messa della notte di Natale descrive la condizione spirituale dell’umanità
salvata da Gesù luce del mondo.
Il canto come lode, il canto manifestazione di gioia, il canto che accomuna
uomini ed angeli nella stessa azione: glorificare Dio, lodarlo, ringraziarlo
perché si è fatto uomo in Cristo Gesù per salvarci. Cantano gli angeli
la gloria del Signore nei cieli e qui sulla terra contemplano, cantando la
sua grandezza, un bimbo appena nato e già capace di illuminare la via
ai pastori che lo potranno adorare e con loro cantare al prodigio che si è
compiuto.
Nelle quattro semplici e brevi strofe che compongono questo canto è
riassunto il grande dono che Dio ha fatto agli uomini e tutta la gioia degli
uomini che finalmente vedono compiere la promessa di eterna alleanza
e la salvezza giungere.
9
r e p e r t o r i o
Da sottolineare la chiarezza di scrittura quando, nelle strofe, le voci che
paiono avere andamento omoritmico producono in modo più evidente una
esecuzione ritardata delle sillabe che rendono interessante e più viva la
partitura, come per esempio alla battuta 11 dove il soprano ritarda la penultima sillaba della battuta rispetto alle altre tre voci.
Nell’eseguire le strofe si faccia attenzione a definire il fraseggio in modo
preciso affinché il testo sia rispettato dal punto di vista letterario e, di conseguenza, più facilmente comprensibile.
Pertanto si raccomanda di collocare i fiati seguendo la punteggiatura,
notando, in particolare: nella seconda strofa è fondamentale unire in un
unico fiato secondo e terzo verso; nelle restanti strofe sono invece da unire i primi due versi. L’aspetto narrativo del testo è reso perfettamente dal
tempo binario e la pulsazione metronomica rende l’esecuzione morbida
ma solenne.
Quando eseguirlo
Un inno per il tempo di Natale. Non è da confondersi con il Gloria a Dio
previsto dalla Messa da cui si differenzia per il testo. Oltre che all’inizio e,
ancor meglio, alla Comunione, si potrebbe eseguire questo corale al termine
del Vangelo prolungando, così, il canto degli angeli. Potrà essere opportuno
che chi legge il Vangelo elimini l’acclamazione Parola del Signore in modo
da evitare che l’assemblea si sieda come d’abitudine in quel momento,
in questo modo questo canto diventerà un inno di lode e adorazione al
mistero dell’Incarnazione.
E. Marangoni
1.
Rit.
2.
3.
4.
Nel buio della notte una luce sfolgorò.
Voci di gioia cantano: in excelsis gloria!
In excelsis gloria! In excelsis gloria!
A Betlemme è nato Gesù:
una schiera d’angeli canta al Figlio di Dio: in excelsis gloria!
Accorrono i pastori a veder la novità.
Cantano lieti con stupor: in excelsis gloria!
Il prodigio si compie per noi: Dio ci salva in Cristo Gesù.
Tutti insieme cantiamo: in excelsis gloria!
10 (da Musica e Assemblea n. 2, 1999)
Il centenario del "Motu proprio" di Pio X
CHIROGRAFO DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II
PER IL CENTENARIO DEL MOTU PROPRIO
"TRA LE SOLLECITUDINI” SULLA MUSICA SACRA
2. Questa impostazione è stata ripresa dal Concilio Ecumenico Vaticano
II nel capitolo VI della Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra
Liturgia, dove si richiama con chiarezza la funzione ecclesiale della musica
sacra: “La tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un patrimonio
di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrale della liturgia solenne”. II Concilio ricorda, inoltre, che “il
canto sacro è stato lodato sia dalla Sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai
Romani Pontefici che recentemente, a cominciare da san Pio X, hanno
sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel
servizio divino”.
Continuando, infatti, l’antica tradizione biblica, a cui lo stesso Signore e gli
Apostoli si sono attenuti (cfr Mt 26,30; Ef 5,19; Col 3,16), la Chiesa lungo
r i f l e s i o n i
1. Mosso dal vivo desiderio “di mantenere e di promuovere il decoro della
Casa di Dio”, il mio Predecessore san Pio X emanava, cento anni fa, il
Motu proprio “Tra le sollecitudini”, che aveva come oggetto il rinnovamento
della musica sacra nelle funzioni del culto. Con esso egli intendeva offrire alla Chiesa concrete indicazioni in quel vitale settore della Liturgia,
presentandole “quasi a codice giuridico della musica sacra”. Anche tale
intervento rientrava nel programma del suo pontificato, che egli aveva
sintetizzato nel motto “Instaurare omnia in Cristo”.
La ricorrenza centenaria del documento mi offre l’occasione di richiamare
l’importante funzione della musica sacra, che san Pio X presenta sia come
mezzo di elevazione dello spirito a Dio, sia come prezioso aiuto per i fedeli
nella “partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica
e solenne della Chiesa".
La speciale attenzione che è doveroso riservare alla musica sacra, ricorda
il santo Pontefice, deriva dal fatto che essa, “come parte integrante della
solenne Liturgia, ne partecipa il fine generale, che è la gloria di Dio e la
santificazione ed edificazione dei fedeli”. Interpretando ed esprimendo il
senso profondo del sacro testo a cui è intimamente legata, essa è capace
di “aggiungere maggiore efficacia al testo medesimo, affinché i fedeli [...]
meglio si dispongano ad accogliere in sé i frutti della grazia, che sono
propri della celebrazione dei sacrosanti misteri”.
11
r i f l e s s i o n i
tutta la sua storia ha favorito il canto nelle celebrazioni liturgiche, fornendo
secondo la creatività di ogni cultura stupendi esempi di commento melodico
dei testi sacri nei riti tanto dell’Occidente quanto dell’Oriente.
Costante, poi, è stata l’attenzione dei miei Predecessori a questo delicato
settore, per il quale hanno richiamato i principi fondamentali che devono
animare la produzione di musica sacra, specie se destinata alla Liturgia.
Oltre al Papa san Pio X, sono da ricordare, tra gli altri, i Papi Benedetto
XIV con l’Enciclica Annus qui (19 febbraio 1749), Pio XII con le Encicliche
Mediator Dei (20 novembre 1947) e Musicae sacrae disciplina (25 dicembre
1955), ed infine Paolo VI con i luminosi pronunciamenti che ha disseminato
in molteplici interventi.
I Padri del Concilio Vaticano II non hanno mancato di ribadire tali principi,
in vista di una loro applicazione alle mutate condizioni dei tempi. Lo hanno
fatto in uno specifico capitolo, il sesto, della Costituzione Sacrosanctum
Concilium. Papa Paolo VI provvide poi alla traduzione in norme concrete
di quei principi, soprattutto per mezzo dell’Istruzione Musicam sacram,
emanata, con la sua approvazione, il 5 marzo 1967 dall’allora Sacra
Congregazione dei Riti. A quei principi di ispirazione conciliare occorre
costantemente rifarsi per promuovere, in conformità alle esigenze della
riforma liturgica, uno sviluppo che sia, anche in questo campo, all’altezza
della tradizione liturgico-musicale della Chiesa. Il testo della Costituzione
Sacrosanctum Concilium in cui si afferma che la Chiesa “approva ed ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, dotate delle dovute
qualità”, trova gli adeguati criteri di applicazione nei nn. 50-53 dell’Istruzione
Musicam sacram ora menzionata.
3. In varie occasioni anch’io ho richiamato la preziosa funzione e la grande
importanza della musica e del canto per una partecipazione più attiva e
intensa alle celebrazioni liturgiche, ed ho sottolineato la necessità di “purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione,
da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell’atto che
si celebra”, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica.
In tale prospettiva, alla luce del magistero di san Pio X e degli altri miei
Predecessori e tenendo conto in particolare dei pronunciamenti del Concilio
Vaticano II, desidero riproporre alcuni principi fondamentali per questo importante settore della vita della Chiesa, nell’intento di far sì che la musica
liturgica risponda sempre più alla sua specifica funzione.
12
r i f l e s i o n i
4. Sulla scia degli insegnamenti di san Pio X e del Concilio Vaticano II, occorre innanzitutto sottolineare che la musica destinata ai sacri riti deve
avere come punto di riferimento la santità: essa di fatto, “sarà tanto più
santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica”. Proprio
per questo, “non indistintamente tutto ciò che sta fuori dal tempio
(profanum) è atto a superarne la soglia”, affermava saggiamente il mio
venerato Predecessore Paolo VI, commentando un decreto del Concilio
di Trento e precisava che “se non possiede ad un tempo il senso della
preghiera, della dignità e della bellezza, la musica - strumentale e
vocale - si preclude da sé l’ingresso nella sfera del sacro e del religioso”. D’altra parte la stessa categoria di “musica sacra” oggi ha subito
un allargamento di significato tale da includere repertori i quali non possono entrare nella celebrazione senza violare lo spirito e le norme della
Liturgia stessa.
La riforma operata da san Pio X mirava specificamente a purificare la musica di chiesa dalla contaminazione della musica profana teatrale, che in
molti Paesi aveva inquinato il repertorio e la prassi musicale liturgica. Anche
ai tempi nostri è da considerare attentamente, come ho messo in evidenza
nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, che non tutte le espressioni delle
arti figurative e della musica sono capaci “di esprimere adeguatamente il
Mistero colto nella pienezza di fede della Chiesa”. Di conseguenza, non
tutte le forme musicali possono essere ritenute adatte per le celebrazioni
liturgiche.
5. Un altro principio enunciato da san Pio X nel Motu proprio Tra le sollecitudini, principio peraltro intimamente connesso con il precedente, è
quello della bontà delle forme. Non vi può essere musica destinata alla
celebrazione dei sacri riti che non sia prima “vera arte”, capace di avere
quell’efficacia “che la Chiesa intende ottenere accogliendo nella sua liturgia
l’arte dei suoni”. E tuttavia tale qualità da sola non basta. La musica liturgica
deve infatti rispondere a suoi specifici requisiti: la piena aderenza ai testi
che presenta, la consonanza con il tempo e il momento liturgico a cui
è destinata, l’adeguata corrispondenza ai gesti che il rito propone. I
vari momenti liturgici esigono, infatti, una propria espressione musicale,
atta di volta in volta a far emergere la natura propria di un determinato
rito, ora proclamando le meraviglie di Dio, ora manifestando sentimenti di
lode, di supplica o anche di mestizia per l’esperienza dell’umano dolore,
un’esperienza tuttavia che la fede apre alla prospettiva della speranza
13
cristiana.
r i f l e s s i o n i
6. Canto e musica richiesti dalla riforma liturgica - è bene sottolinearlo
- devono rispondere anche a legittime esigenze di adattamento e di
inculturazione. È chiaro, tuttavia, che ogni innovazione in questa delicata
materia deve rispettare peculiari criteri, quali la ricerca di espressioni musicali che rispondano al necessario coinvolgimento dell’intera assemblea
nella celebrazione e che evitino, allo stesso tempo, qualsiasi cedimento alla
leggerezza e alla superficialità. Sono altresì da evitare, in linea di massima,
quelle forme di “inculturazione” di segno elitario, che introducono nella
Liturgia composizioni antiche o contemporanee che sono forse di valore
artistico, ma che indulgono ad un linguaggio ai più incomprensibile.
In questo senso san Pio X indicava - usando il termine universalità - un
ulteriore requisito della musica destinata al culto: “…pur concedendosi ad
ogni nazione - egli annotava - di ammettere nelle composizioni chiesastiche quelle forme particolari che costituiscono in certo modo il carattere
specifico della musica loro propria, queste però devono essere in tal maniera subordinate ai caratteri generali della musica sacra, che nessuno
di altra nazione nell’udirle debba provarne impressione non buona”. In
altri termini, il sacro ambito della celebrazione liturgica non deve mai
diventare laboratorio di sperimentazioni o di pratiche compositive ed
esecutive introdotte senza un’attenta verifica.
7. Tra le espressioni musicali che maggiormente rispondono alle qualità
richieste dalla nozione di musica sacra, specie di quella liturgica, un posto
particolare occupa il canto gregoriano. Il Concilio Vaticano II lo riconosce
come “canto proprio della liturgia romana” a cui occorre riservare a
parità di condizioni il primo posto nelle azioni liturgiche in canto celebrate
in lingua latina. San Pio X rilevava come la Chiesa lo ha “ereditato dagli
antichi padri”, lo ha ”custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici
liturgici” e tuttora lo propone ai fedeli” come suo, considerandolo “come il
supremo modello della musica sacra”. Il canto gregoriano pertanto continua
ad essere anche oggi elemento di unità nella liturgia romana.
Come già san Pio X, anche il Concilio Vaticano II riconosce che “gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non vanno
esclusi affatto dalla celebrazione dei divini uffici”. Occorre, pertanto,
vagliare con attenta cura i nuovi linguaggi musicali, per esperire la possibilità di esprimere anche con essi le inesauribili ricchezze del Mistero
riproposto nella Liturgia e favorire così la partecipazione attiva dei fedeli
14 alle celebrazioni.
r i f l e s s i o n i
8. L’importanza di conservare e di incrementare il secolare patrimonio
della Chiesa induce a prendere in particolare considerazione una specifica
esortazione della Costituzione Sacrosanctum Concilium: “Si promuovano
con impegno le scholae cantorum specialmente presso le chiese
cattedrali”. A sua volta l’Istruzione Musicam sacram precisa il compito
ministeriale della schola: “E’ degno di particolare attenzione, per il servizio
liturgico che svolge, il coro o cappella musicale o schola cantorum. In
seguito alle norme conciliari riguardanti la riforma liturgica, il suo compito
è divenuto di ancor maggiore rilievo e importanza: deve, infatti, attendere
all’esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti,
e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Pertanto [...] si abbia e si promuova con cura specialmente nelle cattedrali e altre chiese
maggiori, nei seminari e negli studentati religiosi, un coro o una cappella
musicale o una schola cantorum”. Il compito della schola non è venuto
meno: essa infatti svolge nell’assemblea il ruolo di guida e di sostegno e,
in certi momenti della Liturgia, ha un proprio ruolo specifico.
Dal buon coordinamento di tutti - il sacerdote celebrante e il diacono, gli
accoliti, i ministranti, i lettori, il salmista, la schola cantorum, i musicisti, il
cantore, l’assemblea - scaturisce quel giusto clima spirituale che rende il
momento liturgico veramente intenso, partecipato e fruttuoso. L’aspetto
musicale delle celebrazioni liturgiche, quindi, non può essere lasciato
né all’improvvisazione, né all’arbitrio dei singoli, ma deve essere affidato ad una bene concertata direzione nel rispetto delle norme e
delle competenze, quale significativo frutto di un’adeguata formazione
liturgica.
9. Anche in questo campo, pertanto, si evidenzia l’urgenza di promuovere una solida formazione sia dei pastori che dei fedeli laici. San
Pio X insisteva particolarmente sulla formazione musicale dei chierici. Un
richiamo in tal senso è stato ribadito anche dal Concilio Vaticano II: “Si
curino la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati
dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri
istituti e scuole cattoliche”. L’indicazione attende di essere pienamente
realizzata. Ritengo pertanto opportuno richiamarla, affinché i futuri pastori
possano acquisire una adeguata sensibilità anche in questo campo.
In tale opera formativa un ruolo speciale viene svolto dalle scuole di musica sacra, che san Pio X esortava a sostenere e a promuovere, e che il
Concilio Vaticano II raccomanda di costituire ove possibile. Frutto concreto 15
r i f l e s s i o n i
della riforma di san Pio X fu l’erezione in Roma, nel 1911, otto anni dopo il
Motu proprio, della “Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra”, divenuta
in seguito “Pontificio Istituto di Musica Sacra”. Accanto a questa istituzione
accademica ormai quasi centenaria, che ha reso e rende un qualificato servizio alla Chiesa, vi sono tante altre Scuole istituite nelle Chiese particolari,
che meritano di essere sostenute e potenziate per una sempre migliore
conoscenza ed esecuzione di buona musica liturgica.
10. Avendo la Chiesa sempre riconosciuto e favorito il progresso delle
arti, non deve stupire che, oltre al canto gregoriano e alla polifonia, essa
ammetta nelle celebrazioni anche la musica più moderna, purché rispettosa sia dello spirito liturgico che dei veri valori dell’arte. È perciò
consentito alle Chiese nelle varie Nazioni di valorizzare, nelle composizioni
finalizzate al culto, “quelle forme particolari che costituiscono in certo modo
il carattere specifico della musica loro propria”. Nella linea del mio santo
Predecessore e di quanto stabilito più di recente dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium, anch’io, nell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, ho inteso
fare spazio ai nuovi apporti musicali menzionando, accanto alle ispirate
melodie gregoriane, “i tanti e spesso grandi autori che si sono cimentati
con i testi liturgici della Santa Messa”.
11. Il secolo scorso, con il rinnovamento operato dal Concilio Vaticano II,
ha conosciuto uno speciale sviluppo del canto popolare religioso, del quale
la Sacrosanctum Concilium dice: “Si promuova con impegno il canto
popolare religioso, in modo che nei pii e sacri esercizi, come pure
nelle stesse azioni liturgiche, [...] possano risuonare le voci dei fedeli”.
Tale canto si presenta particolarmente adatto alla partecipazione dei fedeli
non solo alle pratiche devozionali, “secondo le norme e le disposizioni delle
rubriche”, ma anche alla stessa Liturgia. Il canto popolare, infatti, costituisce “un vincolo di unità e un’espressione gioiosa della comunità orante,
promuove la proclamazione dell’unica fede e dona alle grandi assemblee
liturgiche una incomparabile e raccolta solennità”.
12. A riguardo delle composizioni musicali liturgiche faccio mia la “legge
generale”, che san Pio X formulava in questi termini: “Tanto una composizione per chiesa è più sacra e liturgica, quanto più nell’andamento,
nella ispirazione e nel sapore si accosta alla melodia gregoriana, e
tanto meno è degna del tempio, quanto più da quel supremo modello
16 si riconosce difforme”. Non si tratta evidentemente di copiare il canto
13. Da ultimo, vorrei ancora ricordare ciò che san Pio X disponeva sul piano
operativo, al fine di favorire l’effettiva applicazione delle indicazioni date nel
Motu proprio. Rivolgendosi ai Vescovi, egli prescriveva che istituissero
nelle loro diocesi “una commissione speciale di persone veramente
competenti in cose di musica sacra”. Là dove la disposizione pontificia
fu messa in pratica i frutti non sono mancati. Attualmente sono numerose
le Commissioni nazionali, diocesane ed interdiocesane che offrono il loro
prezioso apporto nella preparazione dei repertori locali, cercando di operare
un discernimento che tenga conto della qualità dei testi e delle musiche.
Auspico che i Vescovi continuino ad assecondare l’impegno di queste
Commissioni, favorendone l’efficacia nell’ambito pastorale.
Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, per meglio assicurare
l’adempimento dell’importante compito di regolamentare e promuovere
la sacra Liturgia, chiedo alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti di intensificare l’attenzione, secondo le sue finalità
r i f l e s s i o n i
gregoriano, ma piuttosto di far sì che le nuove composizioni siano pervase
dallo stesso spirito che suscitò e via via modellò quel canto. Solo un artista
profondamente compreso del sensus Ecclesiae può tentare di percepire
e tradurre in melodia la verità del Mistero che si celebra nella Liturgia. In
questa prospettiva, nella Lettera agli Artisti scrivevo: “Quante composizioni
sacre sono state elaborate nel corso dei secoli da persone profondamente
imbevute del senso del mistero! Innumerevoli credenti hanno alimentato la
loro fede alle melodie sbocciate dal cuore di altri credenti e divenute parte
della Liturgia o almeno aiuto validissimo al suo decoroso svolgimento.
Nel canto la fede si sperimenta come esuberanza di gioia, di amore, di
fiduciosa attesa dell’intervento salvifico di Dio”.
È dunque necessaria una rinnovata e più approfondita considerazione dei
principi che devono essere alla base della formazione e della diffusione di
un repertorio di qualità. Solo così si potrà consentire all’espressione musicale di servire in maniera appropriata al suo fine ultimo che “è la gloria
di Dio e la santificazione dei fedeli”.
So bene che anche oggi non mancano compositori capaci di offrire, in
questo spirito, il loro indispensabile apporto e la loro competente collaborazione per incrementare il patrimonio della musica a servizio di una
Liturgia sempre più intensamente vissuta. Ad essi va l’espressione della
mia fiducia, unita all’esortazione più cordiale perché pongano ogni impegno
nell’accrescere il repertorio di composizioni che siano degne dell’altezza
dei misteri celebrati e, al tempo stesso, adatte alla sensibilità odierna.
17
r i f l e s s i o n i
istituzionali, al settore della musica sacra liturgica, avvalendosi delle competenze delle diverse Commissioni ed Istituzioni specializzate in questo
campo, come anche dell’apporto del Pontificio Istituto di Musica Sacra. È
importante, infatti, che le composizioni musicali utilizzate nelle celebrazioni
liturgiche rispondano ai criteri opportunamente enunciati da san Pio X e
sapientemente sviluppati sia dal Concilio Vaticano II che dal successivo
Magistero della Chiesa. In tale prospettiva, confido che anche le Conferenze episcopali compiano accuratamente l’esame dei testi destinati al
canto liturgico, e prestino speciale attenzione nel valutare e promuovere
melodie che siano veramente adatte all’uso sacro.
18
14. Sempre sul piano pratico, il Motu proprio di cui ricorre il centesimo anniversario affronta anche la questione degli strumenti musicali da utilizzare
nella Liturgia latina. Tra essi riconosce senza esitazione la prevalenza
dell’organo a canne, circa il cui uso stabilisce opportune norme. Il Concilio
Vaticano II ha recepito pienamente l’orientamento del mio santo Predecessore stabilendo: “Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l’organo a
canne, strumento tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della Chiesa, e di elevare potentemente gli
animi a Dio e alle cose celesti”. Si deve tuttavia prendere atto del fatto che
le composizioni attuali utilizzano spesso moduli musicali diversificati che
non mancano d’una loro dignità. Nella misura in cui sono di aiuto alla
preghiera della Chiesa, possono rivelarsi un arricchimento prezioso.
Occorre tuttavia vigilare perché gli strumenti siano adatti all’uso sacro, convengano alla dignità del tempio, siano in grado di sostenere
il canto dei fedeli e ne favoriscano l’edificazione.
15. Auspico che la commemorazione centenaria del Motu proprio Tra le
sollecitudini, per intercessione del suo santo Autore, unitamente a quella di
santa Cecilia, patrona della musica sacra, sia di incoraggiamento e stimolo
per quanti si occupano di questo importante aspetto delle celebrazioni
liturgiche. I cultori della musica sacra, dedicandosi con rinnovato slancio
ad un settore di così vitale rilievo, contribuiranno alla maturazione della vita
spirituale del Popolo di Dio. I fedeli, per parte loro, esprimendo in modo
armonico e solenne la propria fede col canto, ne sperimenteranno sempre
più a fondo la ricchezza e si conformeranno nell’impegno di tradurne gli
impulsi nei comportamenti della vita quotidiana. Si potrà così raggiungere,
grazie al concorde impegno di pastori d’anime, musicisti e fedeli, quello
che la Costituzione Sacrosanctum Concilium qualifica come vero “fine della
musica sacra”, cioè “la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli”. [...]
Roma, 22 novembre 2003
GIOVANNI PAOLO II
20
r e p e r t o r i o
Questione di nomi? (seconda parte)
La “nuova pratica”
Per i membri delle Cappelle musicali, che non canteranno soltanto
“a cappella” ma prevalentemente accompagnati dalle più smaglianti
sonorità, si comincio’ a scrivere statuti e a stipulare contratti. Si
istituirono fonti di reddito, si richiesero garanzie di assunzione, si
indissero severe prove di concorso. I musici di cappella dovevano
essere chierici o assomigliare ai chierici, almeno per l’abito di cerimonia. Fu pertanto tassativa l’esclusione di donne (tanto le poterono
supplire i castrati).
d o s s i e r
La si intende qui, in senso liturgico, - non musicologico - e ci si limita
ad osservare la situazione dei paesi cattolici.
L’alleanza nuziale tra Barocco e Controriforma fu uno dei fattori
determinanti per un generale travaso dell’istituto corale in vigore (la
Cappella) dalla sfera “privata” a quella. “pubblica”: un “ritorno” dalle
cappelle alle cattedrali (o ad altre chiese importanti). Il nome restò il
medesimo, ormai in uso; come, del resto, non mutarono i compiti ed
i ruoli. Al massimo emerse una motivazione insita, la quale, stavolta,
interessava tutti i partecipanti ai riti. Si faceva musica per rapire tutti
i cuori. La loro commozione misteriosa andava a braccetto con la
certezza di glorificare Dio, mentre si manifesta vano pure - per non
dire “si ostentavano” - il fasto della Chiesa.
La musica era sostanza oratoria; o addirittura “struttura portante”,
considerata di pari dignità - se non maggiore - delle altre componenti
della celebrazione. Nessun limite cronologico verrà prefissato per
il contenimento di una vera e propria “ritualità musicale”, affiancata
a quella liturgica.
Nelle chiese i membri delle Cappelle musicali ebbero luoghi propri:
balconate e tribune, comode per la buona resa esecutiva e/o per
una drammatica ostentazione, non solo vocale. Non vi fu preclusione per nessuna delle risorse espressive, timbriche, dinamiche,
ritmiche... In certe circostanze venivano convocati ed assoldati dei 21
solisti di “grido” o dei coristi di “ripiego”, non mancava, allora, anche
la presenza di “strumentisti da cappella”. Si mirava prodigamente
ad un incremento di solennità, esaltata con più corposa vocalità ed
un gioco di forme concertanti.
d o s s i e r
Nessuna remora nei confronti delle evoluzioni stilistiche, ma solo
una ritornellante denuncia di biasimevoli intermperanze.
Le cappelle rispecchiarono piuttosto pacificamente (sebbene si
levavano alcune voci di dissenso) la concezione sociologica della
musica, nell’evolversi dei tempi e dei gusti.
Il declino delle Cappelle e il diffondersi dei gruppi corali
Non si può parlare di “declino” se ci si riferisce ai “modelli” o ai tipi
di “pratiche” descritte, come oramai recepite e stabilizzate.
Quello che si verifica, dalla fine del sec. XVIII è soprattutto un venir
meno (anche in seguito a confische di beni ecclesiastici) di fondi
economici per garantire l’istituto. Molte delle chiese che godevano di
questo servizio, gravoso ma anche comodo, dovettero per necessità
rinunciarvi. Nel sec. XIX tale processo diminutivo o riduttivo continuerà. E però si affacciava una sorte di alternativa: era la nascita dei
gruppi corali liberi, sorretti da volontariato ed organizzati o in forma
accademica o come aggregazioni di dilettanti musicali.
La pastorale-liturgica potrà avvantaggiarsi di questo fenomeno, anche culturale, per il servizio cultuale, sia avvalendosi di prestazioni
dei gruppi civici già costituiti, sia organizzando localmente dei “cori
amatoriali” con personale legato al territorio ecclesiastico. Da ciò
poteva derivare un vantaggio; il sottofondo culturale “romantico”
che in genere ispirava ed animava questi gruppi, contribuiva alla
riproposta di un “sacro musicale”, coraggioso nel rifarsi alla polifonia ed al canto gregoriano, sia in opposizione sia al diffuso gusto
teatrale sia in alternativa al gigantismo di forme sinfonico-corali
22 sommergenti i riti.
Nei confronti di quanto avveniva nelle Cappelle barocche e Settecentesche i nuovi cori modificarono un poco lo stile musicale, ma
assai meno lo spirito che guidava le esecuzioni. Un senso di “distacco” dal resto del popolo che era in chiesa e la pretesa (anche se
inconfessata) di una superiorità di gruppo, invece che la prospettiva
di servizio, restarono dei condizionamenti; né era pensabile che
potessero scomparire dalla mentalità dei neo-coristi.
d o s s i e r
Lo svantaggio, di notevole peso, era l’aleatorietà del ripiego; il
volontariato, per quanto generoso, non riesce ad uscire da uno
statuto precario, per mille condizionamenti che possono intervenire.
Particolarmente quando esso impegna a presenze attive molto
responsabili e non sempre gratificanti. Lo si constata anche oggi ,
con diffusa preoccupazione.
Cosi eccezion fatta di quelle poche situazioni locali in cui gli Enti
ecclesiastici hanno potuto mantenere e rinnovare le loro Cappelle,
i “cori” o “gruppi corali”, favoriti altresì dallo zelo del Cecilianesimo
ante e posto il Motu proprio di Pio X, subentrarono nei servizi religiosi.
Le loro prestazioni assumevano modalità e forme più o meno
continue; comunque il servizio restava sempre necessariamente
limitato.
Nel contempo - dopo i primi tentativi “illuministici” - con il “movimnto ceciliano” e poi per gli impulsi del “movimento liturgico”
ottenne graduale stima ed incremento la prospettiva del canto
popolare/assembleare. Ma poiché era generalmente eseguito in
lingua parlata, esso, fino al concilio Vaticano II, non poteva essere
riconosciuto come “liturgico”.
La scelta dei documenti conciliari del Vaticano II
A questo punto l’intervento non si occupa di documentare e di commentare il corpus normativo che la recente riforma liturgica ha fissato in materia di cori e cantori Soltanto, nella prospettiva adottata
23
di una breve rivisitazione storica, ha il dovere di metter in luce la
precisa scelta semantica operata in seguito alle istanze conciliari.
d o s s i e r
La costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium - assai sobriamente
- e la Istruzione Musicam sacram - molto diffusamente rimettono
in onore il nome “Schola cantorum”. Nella Istruzione esso ricorre
quasi venti volte.
Se a prima vista, il paragrafo 19 di MS sembra omologare il significato dei molti termini qui passati in rassegna - recita infatti: È degno
di particolare attenzione, per il servizio liturgico che svolge, il “coro”
o “cappella musicale” o “schola cantorum” - in realtà la sua intenzione è altra. Il documento di uso comune ed invalso, e però, di fatto,
in tutto il suo dettato, oltre a privilegiare coerentemente il termine
Schola mira ad attribuirne le funzioni e i compiti che furono propri a
tale istituzione antica a tutte le realtà corali che oggi operano nelle
chiese: siano essere le cappelle sopravvissute, siano “cori” siano
gruppi minori di cantori e, persino un singolo cantore, quando in un
luogo non si potesse disporre di più.
Risulta chiaro che se da un lato non è questione di nomi, dall’altro
lato anche ad essi è riconosciuto un peso culturale, che fa mentalità. Volere o no, in ogni campo ciascun nome connota una qualche
situazione che si intende promuovere o superare.
Ciò significa che, pur senza rinnegare alcuni valori della pratica di
modelli celebrativi emersi persino in età di decadenza liturgica, oggi il
ricentramento liturgico del canto deve essere preciso e deciso. Ogni
forma di canto/musica, tanto a livello compositivo che esecutivo,
deve rinunciare a qualsiasi tipo di affermazione autonoma.
Nella logica della riforma liturgica la riaffermazione del primato del
Chorus Dei, nella prospettiva dei Padri della Chiesa, è nettissima.
Forme di plenario canto assembleare (e la Schola stessa è una
porzione della Assemblea), prima e più che un dovere etico da
inculcare, sono un diritto da esercitare da parte del Popolo di Dio,
24 tutto sacerdotale. Per questo la Schola interviene come stimolatrice
e sostenitrice. Il suo servizio non può prescindere da una prospettiva teologico-sacramentale e teologale.
Ogni attuale esecuzione liturgica di un gruppo corale deve pertanto
assumere lo spirito della Schola: chiamata a servire un archetipo di
ritualità che oggi e come oggi viene riproposto dalla Chiesa (attori,
forme e ritmi). Inoltre è importante che sia presente un sano concetto
di “cultura”, intesa come esperienza vivente e creatrice; capace si
di testualizzare il passato, ma non a modo di esibizione.
d o s s i e r
E tuttavia, come avveniva in tempi antichi - e fu una delle ragioni per
cui la Schola nacque - non si dovrà pretendere che tutti cantino
tutto e sempre, quasi a spegnere la possibilità di ascolto interiore e
di contemplazione, e impiantando un attivismo ovviamente esposto
ad assumere qualità mediocri.
Nel confronto del riuso di repertori passati - anche semplicemente
proposti all’ascolto - si impongono discernimento e vigilanza.
Molti di tali repertori sono rispecchiamento di un’enfasi del musicale
che si affermò secondo modelli e pratiche oggi non più accettabili.
Vi sono pertanto delle negoziazioni da operare e delle nette rinunce
da fare, lasciando magari protestare qualche esteta incallito. La
correttezza dell’opus liturgicum ha il potere e il dovere di prevalere
su un puro opus musicorum.
Felice Rainoldi
(articolo tratto da "Choraliter", n. 7, gennaio-aprile 2002)
25
canti per la celebrazione eucaristica
Proposte per un programma
26
a. canto d’inizio
b. salmo responsoriale
c. acclamazione al Vangelo
d. canto d’offertorio
e. canto di comunione
f. canto finale
18 gennaio 2004
II domenica ordinaria “C”
NELLA NUOVA FEDE NASCE LA NUOVA COMUNITA’
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Un solo Signore ..................................................... LD 827
“Hai fatto nuove, Signore, tutte le cose” ............... LD 186,5
Alleluia................................................................... LD 205
È frutto della terra .................................................. LD 219
La mensa del Signore............................................. LD 259
Tutta la terra canti a Dio ........................................ LD 823
25 gennaio 2004
UNA COMUNITÀ DI ASCOLTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Tutta la terra canti a Dio ........................................ LD 823
“Le tue parole, Signore sono spirito e vita”........... LD 179,6
Alleluia................................................................... LD 205
Irrompe la luce del giorno...................................... LD 282
Lo Spirito del Signore............................................ LD 789
Da ogni luogo o Dio............................................... LD 772
1 febbraio 2004
UNA COMUNITÀ DI PROFETI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
III domenica ordinaria “C”
IV domenica ordinaria “C”
Lodate Dio ............................................................. LD 782
“la mia bocca annunzierà la tua giustizia”............. LD 178,14
Alleluia................................................................... LD 205
Canto il tuo amore.................................................. LD 740
Dove regna la carità ............................................... LD 775
Chiesa di Dio ......................................................... LD 759
8 febbraio 2004
UNA COMUNITÀ DI INVIATI
Noi canteremo gloria a Te...................................... LD 780,2
“Cantiamo al Signore davanti ai suoi angeli”........ LD 185,3
Alleluia................................................................... LD 205
Annunziate tra i popoli .......................................... LD 680
Grazie ti voglio rendere ......................................... LD 267
Andate in tutto il mondo ........................................ LD 755
15 febbraio 2004
VI domenica ordinaria “C”
UN ANNUNCIO CHE TRASFORMA IL MONDO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Da ogni luogo, o Dio.............................................. LD 782
“Beato chi pone la speranza” ................................. LD 181,2
Alleluia................................................................... LD 205
Venite a me voi tutti ............................................... LD 828
Nel tuo regno + Beatitudini ................................... LD 756
Andate in tutto il mondo ........................................ LD 755
22 febbraio 2004
VII domenica ordinaria “C”
UNA COMUNITÀ RIVOLUZIONATA DALL'AMORE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Chiesa di fratelli..................................................... LD 760
“Il Signore è buono” .............................................. LD 189,6
Alleluia................................................................... LD 205
Nel nome di Cristo uniti......................................... LD 221
Quant'è soave ......................................................... LD 806
Il cielo narra ........................................................... LD 782
canti per la celebrazione eucaristica
a.
b.
c.
d.
e.
f.
V domenica ordinaria “C”
27
FRANCESCO
CASTEGNARO
Fabbrica d’Organi da Chiesa
Via Brunelleschi, 59
TREZZANO sul NAVIGLIO (MI)
Tel e Fax: (+39) 02/44.55.693 - ab. 02/45.85.240
Artigiano specializzato nella costruzione di tutte le parti
dell’organo a canne, a trasmissione meccanica ed elettrica,
e nel restauro di organi a trasmissione pneumatica-tubolare.
Restauro, modifiche, pulitura, manutenzione ed accordatura
di strumenti già esistenti.
Attrezzato laboratorio per il restauro di Harmonium.
Sopralluoghi, consulenze, preventivi a richiesta e senza impegno.