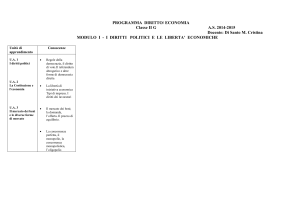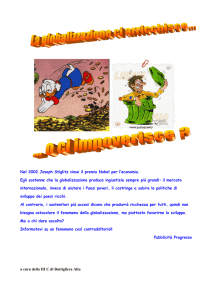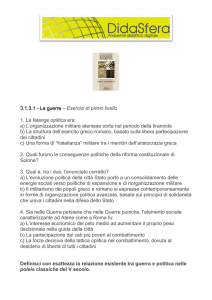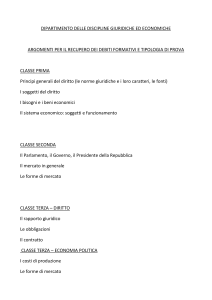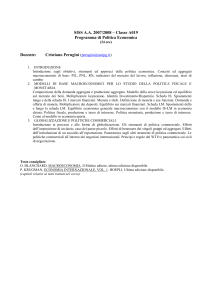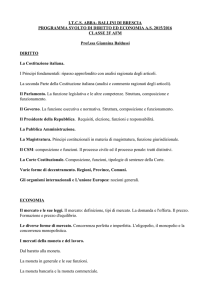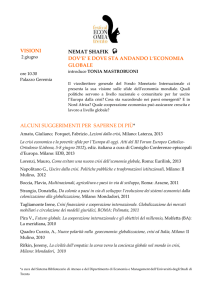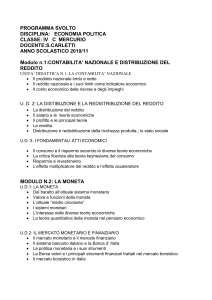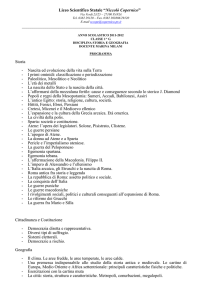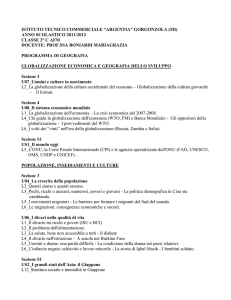Economia, finanza e geopolitica
di Carlo Jean (Geopolitica del mondo contemporaneo – capitolo VII)
1. Economia e politica
Secondo gli economisti classici, da Adam Smith a David Ricardo, l’economia va
sempre collegata con la politica, dato che entrambe determinano il benessere delle
nazioni. Di fatto, le loro relazioni non sono costanti, ma cicliche. In talune circostanze,
l’economia è più indipendente dalla politica; in altre, ne viene dominata, fino ad
esserne gestita. Talvolta domina il mercato; alle volte esso non è solo regolato, ma
dominato dalla politica. Con le riforme liberiste di Margaret Thatcher in Gran
Bretagna e di Ronald Reagan negli USA, l’economia si è emancipata dalla politica e
dalle regole da essa imposte. La fine della guerra fredda, eliminando la divisione
anche economica del mondo in due blocchi contrapposti, ha dato impulso ad una
nuova globalizzazione dell’economia, trainata dalla finanziarizzazione, dalla
deregolamentazione e dallo sviluppo delle ICT. Dal canto suo, la finanza si è resa
indipendente dall’economia reale. Da strumento di scambio, la moneta si è trasformata
in una commodity. Lo slogan “meno Stato e più mercato” ha dominato il mondo, come
pure i fondamentalisti del mercato – quelli che il prof. Giulio Tremonti chiama
“mercatisti” - secondo i quali la cosiddetta “mano invisibile” di quest’ultimo sarebbe
più efficiente della discrezionalità della politica, la quale provocherebbe consistenti
distorsioni nell’economia, imponendole enormi costi e rallentando la crescita. Tale
concetto si è esteso all’eliminazione delle regole e dei controlli, peraltro indispensabili
all’efficienza del mercato, come ci si è accorti quando è scoppiata la crisi del 2008.
Negli anni Novanta, la deregolamentazione e la finanziarizzazione dell’economia
hanno prodotto una crescita tumultuosa, stimolata dall’ampia liquidità anche in nuove
forme (come i contratti derivati), dai bassi tassi d’interesse e dalla ridotta percezione
dei rischi, che si pensava potessero essere eliminati da sofisticati meccanismi. Il
settore finanziario, per le sue caratteristiche intrinseche, possiede sempre un elevato
potenziale d’instabilità. La finanza è sostanzialmente uno scambio di promesse che si
fonda sulle aspettative e sulla fiducia. Se quest’ultima viene meno, i prestiti non
vengono rinnovati: all’euforia segue il panico; alla crescita la crisi. È quanto è
avvenuto nel 2007-08, per effetto del crollo dei subprime americani prima e della
Lehman Brothers, poi. È crollato, infatti, il castello di carta dei mutui immobiliari, che
1
si basava sul presupposto che i prezzi delle case avrebbero sempre continuato ad
aumentare o, almeno, sarebbero rimasti stabili. La crisi si è amplificata,
trasformandosi da finanziaria in economica e, subito dopo, in politica. L’incertezza
dei mercati finanziari ha prodotto un rallentamento nella circolazione della liquidità,
provocato dalla minore propensione delle banche a concedere prestiti sia tra loro che
a terzi. Le banche centrali hanno allora creato più moneta e gli Stati sono intervenuti
per sostenere il sistema bancario, vero responsabile della crisi, e attenuarne i costi
sociali, cercando di salvaguardare l’economia reale. Lo hanno fatto (almeno, così
hanno affermato) per contenere le ricadute negative del deleveraging, socializzando
le perdite delle banche. Con ciò hanno accresciuto i debiti pubblici, determinando
inefficienze economiche nel più lungo periodo e creando un nuovo potenziale di
instabilità, derivante dalla minore sostenibilità dei debiti sovrani. Non sono stati
invece corretti gli squilibri di fondo del sistema economico mondiale tra gli Stati
debitori, in particolare gli USA, e quelli creditori che, con i loro fondi sovrani e le loro
riserve, finanziano il debito dei primi e ne consentono elevati livelli di benessere e di
consumo. Beninteso, non lo fanno per generosità, ma per il loro interesse, cioè per
evitare crisi nelle loro economie, che sono export-led. Nonostante le iniziative del G20 (e, in Europa, dell’Ecofin e della BCE), la prossima crisi globale è quella dei debiti
sovrani, già scoppiata in Grecia, Irlanda e Portogallo, ma estesasi rapidamente agli
altri paesi europei, soprattutto per le indecisioni ed i ritardi con cui sono stati effettuati
gli interventi dell’Eurogruppo. Mentre la politica con i suoi interventi aveva evitato
che la crisi finanziaria del 2008 provocasse una depressione economica mondiale, nel
2011 la crisi dell’area euro e quella provocata dalla diminuzione del rating del debito
sovrano americano sono state provocate dalla politica.
La reazione internazionale contro l’“effetto domino” della crisi del 2007-08 è stata
senz’altro efficace, evitando un collasso analogo a quello del 1929. Il mercato è
rimasto globale, senza frammentarsi in sistemi nazionali o regionali protetti, come
invece richiedeva il populismo, sempre più diffuso, nelle opinioni pubbliche. Si è
contenuta la crisi a breve termine, ma si è accresciuto il potenziale di crisi a più lungo
termine. Inoltre, in Eurolandia, si è dovuto superare un duplice fronte di resistenza:
quello all’interno degli “Stati-formica”, i cui governi hanno difficoltà a persuadere gli
elettori/contribuenti a usare i propri risparmi per concedere crediti agli “Stati-cicala”;
e quello all’interno degli “Stati-cicala”, perché le misure di austerità imposte per
ottenere prestiti a livello internazionale o regionale, trovano precisi limiti di
sostenibilità sociale, provocando agitazioni e, addirittura, rivolte.
È ciò che era successo per la rigida applicazione del Washington Consensus nella
concessione di prestito dell’FMI, in occasione della crisi asiatica del 1997-98.
La crisi e le misure per contenerla hanno colpito, soprattutto, l’Occidente,
accelerando lo spostamento già in corso del baricentro geoeconomico e, quindi,
geopolitico del mondo dall’Atlantico al Pacifico, indebolendo i paesi occidentali
rispetto a quelli emergenti e agli Stati produttori di materie prime. Entrambi hanno
bilance commerciali largamente positive, e consistenti fondi sovrani che stanno
2
producendo una “colonizzazione alla rovescia”, acquistando i “gioielli tecnologici e
industriali” dell’Europa e degli USA. Le privatizzazioni, spesso selvagge come nel
caso della Grecia, consentiranno un’accelerazione della penetrazione dei BRIC e dei
“petrostati” nelle economie occidentali. Anche ciò potrebbe modificare il panorama
geopolitico del mondo.
Il processo di convergenza economica dei paesi emergenti con quelli avanzati è
stato facilitato dalla globalizzazione, dalla diffusione delle imprese multinazionali e
dall’informatizzazione, che hanno stimolato il transfer tecnologico e culturale,
vanificando la “teoria del ciclo prodotto” che aveva prodotto la superiorità
dell’Occidente nel mondo, unitamente alla sua preminenza in campo navale. Emerge,
in modo sempre più evidente, la tendenza al ritorno alla distribuzione della ricchezza
mondiale esistente in passato. Essa è descritta magistralmente negli studi di Angus
Maddison, pubblicati dall’OCSE: i giganti del Terzo mondo, non solo Cina, India e
Brasile, ma anche Indonesia e Turchia, hanno un’importanza crescente anche per la
governance economica globale e, di conseguenza, pretendono sempre maggior peso
nelle Istituzioni Finanziarie Internazionali create a Bretton Woods. Lo dimostra il
passaggio dal G-7 al G-20, nuovo direttorio dell’economia mondiale. Tuttavia, la
disomogeneità di quest’ultimo e le divergenze di interessi al suo interno fanno sì che
il livello di governance globale, un tempo garantito dall’assoluta superiorità degli
USA e della loro leadership, sia diminuito. Da un sistema economico-finanziario
sostanzialmente gerarchico, si è passati ad uno basato sul coordinamento fra i poli
regionali per cercare di colmare i vuoti di governabilità che si sono determinati. Il G20 è un foro in cui pragmaticamente si cerca di contrastare la recessione e salvare sia
la crescita che la globalizzazione. Contrastando le tendenze al nazionalismo
economico e al neo-protezionismo, che rischiano di frammentare il mercato
globalizzato, si cerca di evitare guerre commerciali e monetarie che sarebbero
disastrose per tutti, per i creditori come per i debitori. Il G-20 non è però in grado di
correggere gli squilibri che sono le cause profonde di una crisi tanto ampia. La
governance non consiste in un governo mondiale. Si limita a suggerire le linee di
coordinamento delle decisioni nazionali. La situazione è particolarmente grave in
Eurolandia. La moneta unica, invece di promuovere una convergenza non solo
economica, ma anche politica fra gli Stati membri, sta accentuandone le differenze, a
vantaggio degli Stati più efficienti e forti. Gli Stati deboli non possono più correggere
gli squilibri con svalutazioni competitive. Quelli forti approfittano della necessità dei
primi di ricevere crediti, per imporre misure di austerità e provvedimenti a loro
favorevoli. Lo fanno non per generosità, ma per il loro interesse. La Germania
subirebbe gravi perdite con la crisi dell’euro. Pur tamponando la situazione a breve
termine, si rischia di aumentare la crisi nel più lungo periodo.
Dal XVI secolo in poi, i rapporti di potenza economica e di ricchezza si erano
modificati a favore dell’Europa, prima a seguito della globalizzazione geografica
derivata dalle grandi scoperte, e dalla superiorità tecnologica delle marine europee e,
poi, della rivoluzione industriale e commerciale. L’Europa conquistò all’epoca quasi
3
tutto il mondo, facendo finanziare le sue conquiste dai popoli colonizzati e mettendo
ovunque fuori mercato le industrie locali concorrenti: basti pensare all’industria
tessile indiana, sacrificata agli interessi di quella britannica. La quota dell’Europa nel
PIL mondiale aumentò notevolmente. A partire dal XX secolo, l’economia e la
potenza militare degli USA acquistarono sempre maggiore peso relativo. Il baricentro
del mondo rimase l’Atlantico, anche se si spostò da Est ad Ovest. Con le due guerre
mondiali, che furono in sostanza guerre civili europee, l’Europa perse primato e
colonie e venne spiazzata, come potenza economica e militare, da due potenze esterne:
gli USA e l’URSS. La divisione dell’Europa fu aggravata da quella tra i suoi vecchi
Stati nazionali e dal ridotto livello d’integrazione politica, fiscale e sociale delle
istituzioni europee. Il pendolo del potere e della ricchezza mondiale ha così oscillato
a netto svantaggio dell’Europa, anche se essa si è ripresa dalle distruzioni del secondo
conflitto mondiale grazie ai legami transatlantici e agli aiuti degli USA. Essi furono i
veri integratori degli Stati europei, poiché Washington aveva interesse a un’Europa
forte, alleata degli USA nel loro confronto con Mosca. Con la fine della guerra fredda
e quando la Germania ha assorbito i costi dell’unificazione, gli equilibri in Europa si
sono modificati, causando divisioni non solo economiche (soprattutto tra il Nord e il
Sud), ma anche politiche, specie fra gli Stati della “vecchia” e quelli della “nuova”
Europa. Nell’Unione è in atto una rinazionalizzazione, fenomeno che si riteneva
definitivamente superato con il Trattato di Maastricht e l’euro. La geoeconomia
determinerà la futura geopolitica europea più della geostrategia, cioè delle diverse
esigenze e percezioni di sicurezza nei confronti della rinascente potenza della Russia,
determinate dalla collocazione geografica e dalla storia.
2.
La potenza economica nella geopolitica del XXI secolo
Le due guerre mondiali, la divisione dell’Europa, la sua dipendenza dagli USA per
la sicurezza e la perdita delle colonie hanno marcato l’inizio del declino europeo nel
mondo. Negli ultimi trent’anni, esso è stato accelerato dalla crisi demografica e, in
senso relativo, dalla crescita dei paesi emergenti. Negli anni Ottanta, i paesi del G-7
detenevano oltre due terzi della ricchezza mondiale; oggi ne possiedono meno del
50%. Pertanto, tale gruppo ristretto non è più in grado di garantire la governabilità
dell’economia mondiale, né di imporre le proprie decisioni al resto del mondo. Il suo
ruolo è così passato al G-20 e, nell’ambito di quest’ultimo, al cosiddetto G-2 o
“Chimerica”, cioè alla cooperazione fra gli USA e la Cina. Anche se taluni ritengono
quest’ultima troppo ristretta, esclusiva ed indebolita dalle ricorrenti tensioni fra
Washington e Pechino, il G-20 resta troppo numeroso e disomogeneo. E’ formato da
Stati con interessi troppo divergenti per poter pervenire a compromessi accettabili da
tutti sulle questioni di fondo, quali l’eliminazione degli squilibri commerciali esistenti
fra le grandi potenze ed le diverse aree geoeconomiche. Gli USA e la Cina, per contro,
dispongono di meccanismi bilaterali di coordinamento (S&ED, Strategic and
4
Economic Dialogues) e, soprattutto, hanno interessi esistenziali comuni. In campo
economico-finanziario hanno un rapporto per molti versi simile alla MAD (Mutual
Assured Destruction) che esisteva fra gli USA e l’URSS durante la guerra fredda. Una
guerra commerciale o valutaria tra di loro li distruggerebbe entrambi.
Globalizzazione, liberalizzazione, informatizzazione (con la diffusione tecnologica
e il conseguente superamento dei meccanismi del cosiddetto “ciclo prodotto”, che
prima dominavano i rapporti fra i livelli tecnologici degli Stati avanzati rispetto a
quelli meno sviluppati, hanno stimolato un’impetuosa crescita dei paesi emergenti
dall’ASEAN alla Cina fino all’India, a cui si sono aggiunti il Brasile, l’Indonesia e la
Turchia. Dal 2000, la Russia è in fase di ripresa dal disastroso declino che l’aveva
colpita negli anni Novanta, ma soffre di gravi difficoltà demografiche e di
un’eccessiva dipendenza dall’export delle materie prime. Ciò rischia di ridurla a
“petrostato”. L’eccessiva centralizzazione (“democrazia sovrana” e “verticale del
potere”) e lo scontro al Cremlino tra le due contrapposte fazioni dei civiliki e dei
siloviki, rischiano di frenare la modernizzazione della Russia, insieme alla crisi
demografica e allo spopolamento della Siberia. Ne accentuano però le tendenze
all’europeizzazione, promosse soprattutto dal presidente Dmitri Medvedev e dal
Ministro delle finanze Alexei Kudrin. Anche a Mosca, quindi, sarà l’economia a
determinare le scelte geopolitiche, come sta avvenendo con l’impulso dato
all’innovazione tecnologica (Skolkovo, la Silicon Valley russa) e l’enorme piano di
privatizzazioni aperto agli investimenti stranieri, per attirare in Russia centinaia di
miliardi di dollari, tecnologie avanzate e capacità manageriali d’avanguardia.
L’aumento dell’importanza politica dell’economia è derivato anche dalla fine
(relativa) dell’ordine militare, che aveva dominato il mondo dall’antichità – in
particolare, dalla pace di Westfalia - fino alla guerra fredda. Lo spazio politico non è
più dominato dalla forza militare. È diminuito il valore economico dei territori, che
era stato alla base delle guerre tradizionali e dell’espansione coloniale europea,
avvenuta per procacciarsi materie prime e garantirsi spazi esclusivi di mercato. Oggi,
nessuno ricerca più le colonie; anzi, tutti le rifiutano o le accettano solo a condizioni
molto onerose per chi vuol essere colonizzato, come è apparso evidente per l’adesione
all’UE dell’Est europeo e, attualmente, per i Balcani Occidentali e la Turchia. La
stessa tendenza emerge dal divario fra la domanda d’integrazione in Europa dei paesi
della sponda Sud del Mediterraneo e l’offerta d’integrazione proveniente da
Bruxelles.
Le ragioni della fine dell’ordine militare – in cui la forza militare produceva
cambiamenti geopolitici - non consistono nel mutamento di valori e di principi delle
relazioni internazionali, né nel fatto che la cooperazione abbia sostituito la
competizione fra gli Stati o che gli uomini siano divenuti più civili. Non sono di natura
etico-politica, bensì tecnologica, economica e finanziaria. Le guerre fra Stati forti
sono divenute troppo pericolose, anche per effetto delle armi nucleari, e in ogni caso
costano molto più di quanto rendano. Le commodities si comprano, non si
conquistano. Le speculazioni finanziarie su di esse sono più convenienti del controllo
5
diretto, sempre più costoso. Lo dimostra il caso del petrolio iracheno, dopo
l’occupazione dell’Iraq da parte americana. Lo dimostra anche l’effetto ultimo
dell’interventismo franco-britannico in Libia, che indebolirà l’UE e la NATO, e di cui
verosimilmente approfitteranno Cina, Russia e Turchia. Gli eserciti ipertecnologici
dell’Occidente non dispongono degli effettivi necessari per il controllo dei territori. A
differenza di quanto avveniva nel XIX secolo, gli Stati avanzati non hanno più due
eserciti: uno metropolitano, destinato ai conflitti ad alta intensità tecnologica e
operativa in Europa, e uno coloniale, in gran parte reclutato sul posto e finanziato con
i proventi delle colonie. Essi cercano di sopperire alla carenza di effettivi delle loro
forze armate regolari con il ricorso a società militari private ed a contractors, che
presentano il vantaggio di essere pagati solo quando vengono effettivamente impiegati
e non anche quando non lo sono, come avviene per i soldati. Ma si tratta di un rimedio
marginale, anche se in Iraq il numero del personale civile a contratto ha superato
quello dei militari.
Gli Stati non controllano più l’economia come un tempo. La liberalizzazione ha
sostituito parte dei loro poteri sovrani con quelli del mercato, della finanza
internazionale e di altri attori non statali, come le tre potenti agenzie di rating. Le
frontiere sono divenute porose. Nel valore dei prodotti finali, il contenuto fisico
rappresenta una quota sempre più ridotta del costo totale, nonostante l’aumento del
prezzo delle commodities e la maggiore efficienza energetica. Il valore dei prodotti,
compresi quelli manifatturieri, dipende soprattutto da componenti immateriali. La
globalizzazione ha deterritorializzato le produzioni e smaterializzato la ricchezza.
L’integrazione verticale dei campioni nazionali della prima rivoluzione industriale è
stata sostituita da una struttura a rete, che caratterizza l’attuale sistema oligopolistico
mondiale delle grandi corporations settoriali multinazionali. Componenti e
sottoassiemi vengono prodotti dove esistono le migliori condizioni di produttività, per
poi essere trasferiti ai luoghi di assemblaggio finale. Il commercio all’interno delle
imprese multinazionali ha superato quello dei prodotti finiti, grazie soprattutto alla
riduzione dei costi dei trasporti e delle telecomunicazioni. Per inciso, l’impatto
economico più negativo del terrorismo internazionale consiste nel fatto che i controlli
di sicurezza stanno mettendo in crisi il sistema just in time su cui si basa l’economia
globalizzata. Per sopperire all’incertezza sui tempi, le imprese produttrici dei prodotti
finiti sono costrette ad aumentare gli stocks di componenti, immobilizzando
consistenti capitali. Il valore centrale assunto dalle innovazioni di prodotto, di
processo e organizzative ha indotto le imprese più competitive a internazionalizzarsi:
infatti, solo le grandi dimensioni consentono di ammortare i costi sempre maggiori
dell’innovazione.
Tuttavia, la competizione tra gli Stati continua anche con la globalizzazione e la
creazione di istituzioni internazionali permanenti (dall’ONU alle IFI), con la
differenza che, più che con le armi, essa è condotta con gli strumenti dell’economia,
della finanza e della tecnologia, nonché con lo sforzo di aumentare la propria
competitività con il miglioramento delle “dotazioni di ambiente”. A parte l’esistenza
6
delle armi nucleari, la totale superiorità degli USA rende poi impraticabili, o almeno
irragionevoli, nuove guerre mondiali nelle loro tradizionali forme “simmetriche”,
ossia di scontro diretto fra forze armate regolari. Alle guerre asimmetriche low-tech,
che sono sempre esistite e che hanno caratterizzato le campagne di colonizzazione e
di decolonizzazione, si sono aggiunte quelle asimmetriche high-tech, ad esempio da
parte della Cina. Quest’ultima non è in grado di contrastare la potenza dei gruppi
portaerei e anfibi americani, né di proteggere le proprie essenziali vie di
comunicazione marittime. Per fare fronte a tale svantaggio, Pechino sta sviluppando
capacità antisatellite e di cyberwar e missili balistici antinave a gittata intermedia, che
dovrebbero consentirle di proteggere le sue coste orientali e impedire che gli USA
impieghino con troppa disinvoltura la loro potenza navale nei Mari Cinesi
Meridionale ed Orientale e nello stretto di Taiwan. La superiorità dell’U.S. Navy
continua a rappresentare uno dei pilastri della globalizzazione, garantendo la libertà
di navigazione nelle acque internazionali.
Nel mondo sviluppato, la forza militare viene oggi impiegata essenzialmente in
modo virtuale, per la dissuasione e per il mantenimento della stabilità necessaria
all’economia globalizzata. Le guerre scoppiano fra gli Stati deboli oppure, più spesso,
al loro interno. Talvolta gli Stati avanzati sono indotti a intervenire, per prevenire o
risolvere le crisi, dai loro principi e interessi (che tendono a coincidere fra di loro). Lo
fanno soprattutto ricorrendo ai mezzi aerei, nonostante i loro enormi costi e la loro
incapacità di conseguire vittorie militari che possano essere trasformate in politiche,
ma solo per contenere le perdite e dimostrare alle opinioni pubbliche che si sta facendo
qualcosa. Se le perdite superassero un certo limite, infatti, il consenso delle opinioni
pubbliche alla continuazione degli interventi si eroderebbe rapidamente. L’inefficacia
degli interventi occidentali deriva quindi da ragioni che esulano dall’ambito tecnicomilitare. L’asimmetria degli interventi ha anche una ragione etico-politica: poiché
occorre evitare il più possibile vittime anche civili, non si può impiegare il livello di
violenza che sarebbe necessario per far cessare il sostegno della popolazione a
guerriglieri, terroristi ed insorti; per conquistare cioè “il terreno umano” oltre che
quello fisico. In questo modo, la durata dei conflitti aumenta e, con essa, i loro costi.
Ad esempio, il costo di un soldato americano in Afghanistan si aggira sul milione di
dollari all’anno. La guerra in Iraq è costata oltre un trilione di dollari. Considerato il
pagamento dei debiti contratti per finanziare i conflitti in Iraq e in Afghanistan, e le
pensioni e gli indennizzi ai feriti, il costo totale di tali due interventi si aggirerà per gli
USA sui 4.000 miliardi di dollari.
Oggi, gran parte di quelle che in passato erano funzioni della forza militare sono
assolte dall’economia, non sotto le forme tradizionali dei “tesori di guerra”, la cui
importanza è descritta dalle teorie bullioniste, né di sanzioni, embarghi o blocchi
navali o aerei, bensì sotto forma di concorrenza fra le competitività dei sistemi-paese
sia nel campo economico (dotazioni d’ambiente), sia in quelli finanziario e monetario
(guerra delle monete), sia in quello comunicativo (utilizzazione dell’“economia della
7
paura” per destabilizzare il concorrente con la comunicazione – social network,
neuroscienze, ecc.).
3.
Stato, territorio e ricchezza: “sistema-paese” e competitività
In passato, in economia dominava la difensiva, che era propria del mercantilismo,
del protezionismo e dell’autarchia. Il territorio dello Stato e le dimensioni del mercato
erano per lo più coincidenti. Con la globalizzazione, invece, le frontiere sono divenute
porose e il mercato è diventato globale, almeno sul versante dell’offerta. La domanda
è ancora influenzata dalle peculiarità nazionali, ma la globalizzazione
dell’informazione sta producendo una crescente convergenza delle aspettative e delle
preferenze a livello mondiale, quindi una omogeneizzazione della domanda.
Gli Stati hanno mantenuto la loro funzione di garantire la stabilità sociale, non solo
mediante il monopolio della forza legittima, ma anche attraverso la ridistribuzione
della ricchezza dagli individui e dalle regioni più ricchi a quelli più poveri. Gli Stati
sono rimasti territoriali, mentre il segmento più ricco della popolazione, quello che un
tempo aveva costituito l’ossatura degli Stati nazione moderni, è diventato nomade.
Ciò contribuisce ad indebolire gli Stati e la democrazia rappresentativa. La massa dei
poveri, dei giovani e degli anziani è rimasta invece stanziale. Per procurarsi le risorse
necessarie ad assolvere i suoi compiti, lo Stato deve attirare sul proprio territorio i
flussi globali di ricchezza ed evitare di perdere quelli che già esistono su di esso. La
competitività, cioè la produttività relativa del “sistema paese”, sta diventando una
componente strutturale del nuovo contratto politico e sociale fra ogni Stato e i suoi
cittadini, tanto che andrebbe aggiunta alla “formula” di “libertà, eguaglianza e
fraternità”, introdotta dalla Rivoluzione francese. Nel mondo globalizzato, la
competitività costituisce quasi una premessa per gli altri tre principi-base della
coesione nazionale. Per essere attuati, essi richiedono risorse ingenti, che crescono
con l’invecchiamento della popolazione. Per disporne, gli Stati stimolano la crescita
migliorando e rendendo più competitive ed attraenti le loro “dotazioni di ambiente”:
dalle infrastrutture ai servizi, dalla formazione professionale alla ricerca e sviluppo,
dalla correttezza e trasparenza (o accountability) della pubblica amministrazione,
all’efficienza anche in termini temporali della giustizia civile; dall’intelligence
economica, al basso costo dell’energia, e così via. Le “dotazioni di ambiente”
costituiscono economie esterne alle imprese. Sono l’ossatura della competitività del
“sistema paese”. Attirano i flussi di ricchezza sui territori degli Stati più competitivi,
consentendo a quelli industrializzati di fronteggiare la concorrenza di quelli
emergenti, che li insidiano non solo grazie ai salari più bassi e alle minori tutele sociali
ed ecologiche, ma ormai anche dal punto di vista tecnologico.
Come si è prima accennato, la globalizzazione, con l’informatizzazione, ha
vanificato la teoria del “ciclo-prodotto”. Secondo essa, le produzioni a media ed alta
tecnologia e ad elevato valore aggiunto erano concentrate nei paesi avanzati e
8
passavano ai paesi in via di sviluppo solo quando venivano sostituite da tecnologie e
da meccanismi di produzione più avanzati. Oggi, l’innovazione tecnologica si
diffonde rapidamente. Per far fronte alla concorrenza globale propria del
“turbocapitalismo” e dell’“ipercompetizione”, per usare i termini di Edward Luttwak,
e per fugare il “fantasma della povertà”, espressione tanto cara al professore Giulio
Tremonti, gli Stati avanzati sono obbligati all’innovazione continua. In economia, il
“fattore tempo” ha assunto un’importanza sconosciuta in passato, e contribuisce ad
accrescere i divari sia all’interno degli Stati, fra le fasce più ricche e quelle più povere,
sia fra i vari sistemi paese. La globalizzazione crea vincitori e vinti: ogni Stato ha
quindi il compito di fare in modo che le sue imprese e i suoi cittadini siano tra i
vincitori della globalizzazione, poiché se si invece si attestassero fra i vinti entrerebbe
in crisi il patto sociale che garantisce la coesione interna. Ciò è tanto più vero in quanto
gli Stati avanzati conoscono una grave crisi demografica che si ripercuote
pesantemente sul “rapporto di sostegno”, tra la fascia attiva della popolazione e i
pensionati. Tale rapporto sta diventando determinante per il potenziale di crescita. La
demografia, oggi più che nel passato, sta diventando l’elemento fondamentale dei
rapporti di potenza fra gli Stati, Influisce sull’economia nello stesso modo con cui la
tecnologia determina la potenza militare.
4.
La crisi mondiale del 2008 e le sue conseguenze geopolitiche
La crisi finanziaria del 2008-09, con le sue pesanti ripercussioni sull’economia
reale e sull’entità dei debiti sovrani, ha posto fine all’euforia del progresso senza fine,
creati dalla deregolamentazione, dal credito facile e dall’esaltazione delle virtù della
“mano invisibile” del mercato.
In quasi tutti i paesi, il superamento della crisi ha registrato un poderoso ritorno
dello Stato nell’economia, prima a sostegno del sistema finanziario, poi con aiuti
diretti alle imprese ed ai consumi. Sorgono così gravi interrogativi sulla futura
sostenibilità dei debiti sovrani e sulla possibilità di mantenere l’autonomia nazionale
da parte degli Stati con maggiori debiti, esposti all’“aggressione” degli “avvoltoi del
debito” e a quella dei fondi sovrani dei paesi emergenti e dei produttori di
commodities, che dispongono di crescenti riserve. La futura competizione economica
mondiale sarà caratterizzata dal confronto fra gli “Stati-formica” e gli “Stati-cicala”.
Finora i primi hanno finanziato i debiti dei secondi, in particolare degli USA, ma non
è detto che continuino a farlo in futuro, anche per ragioni di competizione nel settore
della potenza internazionale. La superiorità strategica globale americana resta
comunque, nonostante i suoi costi, uno dei pilastri della forza del dollaro, anche se
quest’ultima è stata intaccata dal rischio di default USA, causato dai contrasti
verificatisi nel luglio 2011 nel Congresso americano sull’elevazione del “tetto” del
debito.
9
Nell’elaborare scenari sul futuro geopolitico del mondo è essenziale, innanzitutto,
capire come la potenza economica si trasformi in potere politico. La crisi del 2007-08
non ha avuto solo conseguenze economico-finanziarie, ma anche notevoli impatti
geopolitici a livello mondiale, anche a causa della perdita di prestigio subita dagli
USA e dal Washington Consensus, che fino a quel momento erano indiscutibili e oggi,
invece, sono sempre più sfidati dal “modello cinese”. In Eurolandia, tali impatti hanno
avuto particolare gravità. Al trasferimento di gran parte della sovranità monetaria a
livello BCE non ha fatto riscontro l’omogeneizzazione delle politiche sociali e fiscali
e della produttività degli Stati membri: infatti, l’euro è una moneta senza Stato. Si è
determinato un divario fra il Nord e il Sud dell’Europa non più sanabile con la
svalutazione delle monete nazionali. La Germania, che ha una bilancia commerciale
molto positiva e un’economia export-led, è divenuta “la Cina dell’Europa”. Le sue
banche hanno concesso finanziamenti in euro molto generosi, che sono stati usati
spensieratamente, specie dai paesi dell’Europa meridionale, anche per mantenere alto
il contingente consenso nei confronti dei governi in carica. La Germania, invece, ha
stimolato in misura insufficiente i consumi interni, come testimonia un persistente
avanzo della sua bilancia commerciale con l’estero, derivato anche dal fatto che non
ha aperto il suo mercato alle importazioni dagli altri paesi. Anche se di fatto i bailout
ai paesi in crisi hanno salvaguardato il sistema bancario tedesco, sovraesposto per il
finanziamento dei debiti di molti paesi, Berlino se ne è servita per imporre le proprie
scelte al resto dell’Europa. Ha continuato a trarre vantaggi sia sul mercato mondiale,
dove la presenza dei PIGS ha contribuito a contenere l’apprezzamento dell’euro, che
all’interno di Eurolandia, mantenendone aperti i mercati. Da strumento per
europeizzare la Germania, l’euro si è così trasformato in strumento per germanizzare
l’Europa, evitando al contempo a Berlino di doversi assumere gli oneri e le
responsabilità che sarebbero inevitabili se dovesse assumere la leadership politica e
strategica dell’UE. Si sono così però determinati alcuni squilibri, potenzialmente
distruttivi anche per l’integrazione politica realizzata nel continente a partire dal Piano
Marshall e dal programma ERP.
I pesanti interventi degli Stati nell’economia, pur avendo consentito di attenuare
nel breve termine gli effetti negativi della crisi, evitando ripercussioni analoghe a
quelle del 1929, a più lungo termine determinano difficoltà per il riassorbimento del
debito e fanno aumentare il nazionalismo economico ed il protezionismo. La nuova
governance mondiale del G-20 non ha consentito di sanare gli squilibri di fondo: ad
esempio, quelli fra i paesi che hanno forti riserve, fondi sovrani, basso livello
d’indebitamento e un consistente attivo della bilancia commerciale, e quelli che si
trovano in condizioni opposte. Sono stati questi squilibri, ben più degli errori della
politica finanziaria statunitense, la ragione principale di una crisi tanto grave.
Ad essi si aggiungono le profonde differenze fra le politiche adottate per uscire
dalla crisi: quella della consolidation, prevalente in Europa, e quella della stimulation,
adottata dagli USA e dalla Cina, per quest’ultima anche per lo sforzo di Pechino di
ridurre la vulnerabilità della sua economia, dovuta a un’eccessiva dipendenza dalle
10
esportazioni. La ristrutturazione dell’economia cinese allo scopo di dare maggior
spazio ai consumi interni, come previsto dall’XI e dal XII Piano Quinquennale, è già
in corso; tuttavia, essa sta accrescendo l’inflazione e frenando le esportazioni, tanto
che la bilancia commerciale del 1° trimestre 2011 è risultata addirittura negativa. Su
quanto accadrà in futuro prevale una notevole incertezza, nonostante le ottime
capacità dimostrate dai dirigenti politici ed economici cinesi nell’assumere decisioni
efficaci e tempestive. Una riduzione del livello di crescita dell’economia cinese al di
sotto del 7% annuale provocherebbe gravi rivolte, rendendo necessaria una politica
più aggressiva all’esterno, allo scopo di usare il nazionalismo come strumento per il
mantenimento del potere del Partito Comunista cinese, finora legittimato dalla crescita
dell’economia e del benessere. In un certo senso, paradossalmente, un ristagno della
crescita cinese è molto più pericoloso per la stabilità mondiale della prosecuzione di
un livello di crescita elevato, come quello realizzato negli ultimi trent’anni, a partire
dalle riforme modernizzanti e liberalizzanti di Deng Xiaoping. Date le
interconnessioni e l’interdipendenza esistenti, il problema dell’inflazione in Cina non
è un problema solo cinese bensì mondiale.
5.
La geofinanza
Negli anni Settanta, prima dell’“esplosione” del processo di liberalizzazione e di
deregolamentazione dell’economia, iniziato nel Regno Unito e negli USA, esisteva
un forte collegamento fra la finanza e l’economia reale. La moneta era uno strumento
di scambio e di riserva. La liquidità complessiva, che in precedenza si aggirava intorno
alla metà del PIL mondiale, è rapidamente cresciuta negli ultimi trent’anni. Nel 1980,
era circa pari al PIL mondiale; nel 2000 era il doppio; e nel 2010 quattro o cinque
volte tanto. Tenendo conto dei derivati e dei futures ed assimilabili, le attività
finanziarie complessive sono pari a 12-15 volte il PIL mondiale. Tali attività sono
soprattutto in mani private e non sono né influenzabili, né controllabili dai governi e
dalle banche centrali. Queste ultime dispongono di riserve valutarie e in oro pari a 78.000 miliardi di dollari, cioè da un sesto ad un settimo del PIL mondiale. Pertanto,
non sono in grado di resistere a massicci attacchi speculativi se non con iniziative
concordate a livello globale.
La finanza si è dissociata dall’economia. Capitali apolidi ed irresponsabili, anche
creati con i derivati, hanno alimentato un mercato virtuale che non ha niente a che fare
con l’economia reale ed è svincolato dalla politica e dal controllo degli Stati. Tali
caratteristiche di virtualità e immaterialità hanno determinato un notevole potenziale
d’instabilità, dovuto al rapido alternarsi di cicli di euforia e di panico, e hanno anche
permesso massicci fenomeni speculativi anche sui debiti sovrani. Questi ultimi non
appartengono più ai singoli cittadini che, con il patriottico acquisto dei titoli di Stato,
avevano finanziato le due guerre mondiali e si erano impoveriti. Gli operatori dei
mercati odierni sono molto più scaltri e meno patriottici. Si è accresciuta l’importanza
11
della conoscenza dei meccanismi complessi e spesso opachi che regolano il mercato,
sempre più condizionato dalla manipolazione dell’informazione. Non si tratta di
fenomeni nuovi: basti pensare che la banca Rothschild di Londra guadagnò il suo
primo milione di sterline diffondendo la falsa notizia che gli eserciti della coalizione
antinapoleonica erano stati sconfitti a Waterloo. Ciò fece crollare i titoli, che la banca
acquistò a prezzi molto più bassi per poi rivenderli con ampi guadagni.
Nel settore delle commodities, le transazioni finanziarie superano di almeno dieci
volte il valore di quelle reali. Ciò determina una forte instabilità, che ha impatti
negativi sulla stabilità geopolitica di intere regioni. Ogni giorno, si scambiano sulle
piazze finanziarie mondiali oltre 3.000 miliardi di dollari. La dematerializzazione e la
virtualità dei futures hanno contribuito alla deterritorializzazione della ricchezza e,
quindi, all’erosione della centralità degli Stati e del primato della politica. Inoltre,
hanno anche determinato l’idea che la finanza sia più importante e remunerativa delle
attività produttive. Ciò ha avuto conseguenze negative soprattutto nel mondo
industrializzato, trasformando molti operatori industriali in investitori-speculatori
finanziari.
Gli effetti geopolitici della geofinanza sono meno conosciuti di quelli della
geoeconomia che, come ricordato, sono meno prevedibili di quelli della geostrategia.
Tutti erano consapevoli della centralità che gli accordi di Bretton Woods hanno
attribuito al dollaro e ai vantaggi che tale privilegio determinava (e tuttora determina)
a favore degli USA. Tale fenomeno si accentuò dopo il 1971, quando fu abolita la
convertibilità del dollaro in oro, e gli USA ebbero la possibilità di finanziare i loro
debiti commerciali e di bilancio stampando moneta e titoli di Stato. Il benessere della
popolazione degli USA si è accresciuto grazie ai bassi salari giapponesi del Sud Est
asiatico prima, e della Cina e dell’India oggi. Ha consentito importazioni di beni di
consumo a basso prezzo da un lato, e il loro pagamento con l’acquisto di moneta e di
titoli di Stato americani da parte dei paesi esportatori, dall’altro. Tale privilegio è stato
messo in evidenza dal Plaza Accord del G-5 (G-7 meno Italia e Canada) del 1985.
All’epoca, tale situazione era giustificata per l’Occidente: in pratica, si trattava di un
finanziamento indiretto del “bene pubblico” della sicurezza fornito dagli USA.
Inoltre, era giustificato anche dal fatto che gli USA, con i loro livelli di consumo,
erano l’unica, o almeno la principale locomotiva dell’economia mondiale, i
consumatori di ultimo ricorso. Non ci si poneva praticamente l’interrogativo sulla
possibilità che una “grande potenza” potesse essere “a deficit”. Negli USA
predominava la visione espressa dallo slogan “il dollaro è la nostra moneta, ma è il
vostro problema”. A dire il vero, nemmeno nel 2011 Washington si pone grandi
interrogativi al riguardo. La possibilità di ripagare il debito federale, che sta superando
il 100% del PIL USA, è addirittura risibile, come dimostra il fatto che, tra le varie
“voci” del bilancio federale, quella relativa al Pentagono è la meno ridotta. Il CBO
(Congressional Budget Office) ne prevede anzi l’aumento, almeno fino al 2016-2020.
Preoccupate soprattutto del consenso interno, le amministrazioni Clinton e Bush jr.
avevano continuato la politica introdotta da Paul Volcker alla FED, con cui il regime
12
monetario veniva centrato sull’offerta di moneta anziché sulla più tradizionale
manovra dei tassi d’interesse. Tale scelta ha contribuito a trasformare la virtualità
finanziaria in realtà economica. Con la fine della guerra fredda, la ricchezza si è
sempre più finanziarizzata. La centralità degli USA non solo perdura, ma viene ancora
considerata indispensabile. Tutti hanno interesse a sostenere gli USA e il “Redollaro”. La liberalizzazione delle economie propria del Washington Consensus, a cui
si ispirano gli interventi del Fondo Monetario Internazionale, nonché
l’informatizzazione (i cui impatti sulla velocità delle transazioni sono stati paragonati
a quelli del passaggio dalla posta al computer o dal treno all’aereo) hanno contribuito
ad erodere il potere degli Stati sulla finanza e sull’economia. Si è spezzata la catena
tra Stato, territorio e ricchezza che esisteva non solo nelle società agrarie, ma anche
in quelle della prima rivoluzione industriale.
Dal punto di vista economico-finanziario, gli Stati si sono a poco a poco ridotti ad
espressione geografica e a presidio locale dell’economia globalizzata. I loro poteri
sono stati erosi: dall’alto, dalle istituzioni internazionali; dai lati, dal mercato
globalizzato; e dal basso, dalla crescita delle multinazionali industriali e bancarie
(oltre che dalla sempre più potente criminalità organizzata transnazionale). Per
conservare il loro potere, essi non possono più contare sulle tradizionali strategie
difensive, quali i controlli delle dogane o gli strumenti giuridici nazionali di
regolazione. Un regime di regole internazionali è però reso difficile dalla
disomogeneità e dalla contrapposizione di interessi degli Stati membri del G-20. Gli
Stati devono quindi adottare strategie offensive, consistenti nell’aumento della
competitività del proprio territorio rispetto a quelli concorrenti. La guerra delle
monete, l’impiego aggressivo dei fondi sovrani, le speculazioni sui debiti pubblici, il
controllo delle agenzie di rating, la manipolazione dell’informazione e così via sono
aspetti caratteristici della “geopolitica della geofinanza”. Essa si muove in una
situazione simile a quella che Hobbes aveva denominato “anarchia internazionale”: si
avvale di strumenti monetari, finanziari, legali e fiscali per attirare sul proprio
territorio i flussi globali di ricchezza, sottraendoli così ad altri Stati. La competizione
per il potere mondiale si è così spostata al campo finanziario. La geofinanza sta
caratterizzando la geopolitica del XXI secolo, anche nel dopo-crisi. Essa determina la
potenza e ricchezza delle nazioni o, viceversa, ne decreta il declino. Ciò spiega anche
la priorità che gli Stati hanno dato al salvataggio delle banche, che non è stata di certo
dovuta solo alla volontà di garantire la necessaria liquidità all’economia reale né di
socializzare le perdite per tutelare i profitti delle banche.
Non è realistico pensare che tale situazione di “guerra di tutti contro tutti” possa
essere contenuta, se non marginalmente, dalla cooperazione internazionale. Agli
squilibri macroeconomici e finanziari esistenti sono collegati potenti interessi anche
politici. Le possibili intese non rispecchieranno principi razionali di equilibrio e di
equità, bensì i rapporti di forza esistenti fra gli Stati, la loro volontà di potenza o il
timore di ritorsioni.
13
Il prestigio degli USA e della loro politica monetaria e finanziaria è stato messo a
dura prova dalla crisi, ma Washington continua ad essere garante dell’equilibrio del
sistema monetario internazionale. Non esiste una valuta di riferimento alternativa al
dollaro, né un prestatore di ultima istanza alternativo agli USA.
Si è invece indebolita la posizione degli Stati europei nelle Istituzioni Finanziarie
Internazionali. Tale problema è di natura strutturale e dipende dalla difficoltà (politica
e sociale, prima che finanziaria ed economica) di trasporre in ambito nazionale le
politiche macroeconomiche decise a livello internazionale, ad esempio quelle per lo
stimolo alla crescita o per l’assorbimento del debito e la stabilizzazione della moneta.
È difficile raggiungere compromessi da tutti politicamente accettabili. Basti pensare
alle rivolte provocate dalle politiche di austerità o ai danni che subisce la competitività
internazionale di un paese a seguito dell’apprezzamento della sua moneta; o ancora a
quanto è difficile determinare in modo oggettivo sia la sua capacità di finanziare il
debito (e, quindi, di contenere l’aumento dello spread dei suoi titoli di Stato), sia il
valore reale della sua moneta e gli effetti della modifica del suo tasso di cambio.
Gli interventi sono difficili e molto contestati, perché esiste un risentimento diffuso
nei confronti dei responsabili del sistema finanziario, cui viene attribuita la colpa della
crisi. Esso è accresciuto dal fatto che le banche sono riuscite a far socializzare le loro
perdite, mantenendo utili elevati e ingiustificati livelli retributivi per i loro dirigenti,
oltre a opporsi a ogni forma di regolamentazione, anche con ritorsioni quali la
contrazione del credito alle imprese e alle famiglie, che i governi non riescono a
neutralizzare.
Un analogo risentimento esiste anche nei confronti della Germania da parte degli
Stati europei meno efficienti. La maggiore competitività di tale paese viene vista da
alcuni come una specie di complotto per accrescere il suo peso anche politico in
Europa, se non per dominarla, come già aveva tentato invano di fare nelle due guerre
mondiali. Tali percezioni emotive vengono sfruttate anche nella lotta politica interna.
Il populismo, che da sempre si associa con il nazionalismo, può anche produrre
reazioni avventate come quella della Francia e della Gran Bretagna nei confronti della
Libia, che peraltro è stata anche un tentativo di tali due paesi (e, soprattutto, della
Francia) di sottolineare il loro primato politico e strategico nonostante la loro
economia disastrata nei confronti di quella della Germania. Dal canto suo Berlino, di
fronte all’ostilità di parte degli europei, è sempre più portata a resistere ad ogni
compromesso, che necessariamente comporta la subordinazione di alcuni suoi
interessi nazionali a quelli dell’Europa. Come si è accennato, Berlino ha ogni interesse
a salvare l’euro e l’Europa, ma cerca di farlo alle condizioni più favorevoli. Ha però
comunque una via di scampo, almeno parziale: quella di accrescere i propri legami
con i BRIC, in particolare con Mosca. Infatti, è impegnata a fondo nella
modernizzazione dell’economia russa.
Insomma, la crisi economico-finanziaria del 2008-09 ha comportato un vero e
proprio terremoto geopolitico a livello sia mondiale, sia europeo. Ciò impone un
riesame del significato del potere economico e dei meccanismi con cui esso agisce
14
sulla geopolitica del XXI secolo, anche perché il mondo non potrà più contare come
prima su una completa leadership degli USA che, bene o male, garantiva un certo
ordine all’intero sistema.
6.
Cos’è il potere economico e come influisce sulla geopolitica?
Mentre esiste un consenso generale sul fatto che è aumentata l’importanza
geopolitica dell’economia e della finanza, le opinioni divergono sul come esse operino
a livello mondiale e regionale, e su quali siano le loro conseguenze, potenzialità e
limiti. Dare una risposta a tali interrogativi è essenziale, soprattutto a fronte dei
mutamenti nella distribuzione mondiale della ricchezza e dei divari, anche geografici,
esistenti nella distribuzione della potenza economica e di quella militare.
L’importanza della questione è accresciuta dall’estrema volatilità conseguente alla
globalizzazione e dalla possibilità di cambiamenti radicali e rapidi nella distribuzione
mondiale della potenza. Senz’altro, la globalizzazione ha avuto, e ha ancora, impatti
globalmente positivi, poiché accresce la specializzazione, la serializzazione delle
produzioni e determina una divisione internazionale del lavoro più corrispondente alle
potenzialità e specificità di ciascuno Stato e regione geopolitica. Come ricordato,
però, ha anche fatto aumentare il potenziale d’instabilità, anche a causa del
moltiplicarsi di attori diversi dagli Stati, dell’accumulo di enormi riserve finanziarie
da parte di taluni paesi e gruppi privati e del fatto che, con la crisi finanziaria e i suoi
costi anche politici, il capitalismo liberale ed il Washington Consensus (che dà per
scontato il nesso tra benessere e democratizzazione, teorizzato da Fukuyama con la
“fine della storia”) ha subito una perdita di credibilità e di prestigio. Si è così erosa la
capacità degli USA di dominare il mondo con il loro soft power, cioè con il loro potere
di attrazione e di persuasione. Il mondo che un tempo era unipolare non è diventato
multipolare, ma “apolare”. L’hard power militare e anche economico degli USA è
rimasto pressoché inalterato, ma sono diminuite le possibilità di utilizzarlo per
conseguire obiettivi politici. Mentre le capacità di dissuasione degli USA sono rimaste
estremamente elevate, le loro capacità di costrizione (compellence) - cioè di imporre
la leadership di Washington grazie all’appeal americano - si sono molto ridotte. In un
certo senso, si è verificato un fenomeno analogo a quello avvenuto per le armi
nucleari, la cui utilità per imporre la propria volontà politica è stata sempre ridotta,
tanto che Mao Zedong le aveva giustamente chiamate “tigri di carta”.
L’interdipendenza economico-finanziaria ha fatto sì che molti nuovi Stati abbiano
visto aumentare le loro capacità di dissuasione e abbiano acquisito una capacità di
veto. Ciò rende difficilissimo ogni coordinamento della finanzia e dell’economia
mondiale. Si sono determinati nuovi moral hazards, impossibili da contrastare con i
tradizionali strumenti, come ad esempio quelli anti-protezionistici. La crisi di un
piccolo paese come la Grecia può espandersi rapidamente a livello non solo regionale
15
ma anche globale, come avvenuto per i “terremoti” provocati dalla crisi dei subprime
o del fallimento della Lehman Brothers.
Si è quindi prodotto un effetto per molti versi paradossale: la globalizzazione
dell’economia e della finanza rende una governance globale più necessaria ma, al
tempo stesso, più difficile se non impraticabile. È finito il periodo in cui la superiorità
americana consentiva una “dissuasione estesa” a favore dei piccoli paesi. Questi
ultimi sono più esposti di prima alle pressioni delle maggiori potenze regionali, anche
se possono recare loro gravi danni, come avverrebbe ad esempio, in caso di default di
uno Stato anche minore di Eurolandia.
Sul piano globale, il Washington Consensus è messo in crescenti difficoltà dal
Beijing Consensus. Esso dissocia i rapporti economici dalle condizionalità politiche,
quali la democratizzaione, la tutela dei diritti umani o la liberalizzazione
dell’economia. Il “modello cinese” si fonda sulla compatibilità tra liberalismo
economico e autoritarismo politico, dimostrata già dal Cile di Pinochet e teorizzata
dal suo consigliere Milton Friedman. Tale approccio facilita la penetrazione cinese in
Africa, America Latina, Asia Centrale e Medio Oriente, ma erode la politica
occidentale di stabilizzazione democratica di quelle regioni. È probabile che tale
modello risulti vincitore anche nella “primavera araba”.
La perdita di prestigio e d’influenza americana è stata aggravata e, forse anche,
accelerata dalla crisi dell’Europa, naturale alleata degli USA, dalla crescente
convinzione di Washington di non poter contare su di essa, dall’allargamento del G7 al G-20 e dalle politiche divergenti (stimulation e consolidation) adottate dalle due
sponde dell’Atlantico per uscire dalla crisi. In Europa, le misure di austerità per
contenere i deficit e rendere più sostenibili i debiti sovrani frenano consumi e crescita.
Per molti Stati, la crescita dell’economia dipende da quella delle esportazioni. Ciò
aumenta la conflittualità fra i “sistemi paese” e la “guerra fra le monete”. In Europa
fa aumentare il divario fra gli Stati “formica” e quelli “cicala”.
Ma cos’è il potere economico, e come agisce sulla geopolitica? È possibile
misurarlo in modo analogo a quello praticato dagli esperti di strategia cinesi, con i
loro complessi calcoli della miriade di fattori considerati nel valutare la “potenza
militare nazionale” e i suoi rapporti con quelle degli altri Stati?
In passato, la potenza economico-finanziaria era strettamente associata a quella
militare. Permetteva di sostenere un determinato livello di armamenti e di finanziare
le operazioni belliche con il “tesoro di guerra”, e con la “mobilitazione industriale e
demografica”, al tempo delle guerre totali del XX secolo. Il primato della politica
estera su quella interna comportava anche quello della politica tout court
sull’economia, di cui sono state tipiche espressioni il bullionismo e l’autarchia.
Dopo la fine guerra fredda, il potere economico ha accentuato la propria autonomia
da quello politico. Ha elaborato strategie più complesse, sia difensive che offensive.
Soprattutto nel periodo dell’espansione coloniale europea, tra mercanti e guerrieri era
esistita una stretta simbiosi: i mercanti finanziavano i guerrieri, che a loro volta
aprivano nuovi sbocchi al commercio e allo sfruttamento dei territori conquistati.
16
L’impiego della potenza economico-finanziaria per conseguire fini politici è vecchia
come il mondo. Basti pensare all’efficacia che la minaccia di Washington di non
rifinanziare il debito britannico ebbe sul ritiro del Regno Unito da Suez nel 1956.
Gli impatti geopolitici della potenza economica sono molto diversi: vanno dalla
sicurezza energetica alla capacità di evitare acquisizioni ostili di propri assets
industriali strategici, a quella di condizionare le decisioni politiche di altri Stati, sia
alleati che avversari, con pressioni, embarghi, sanzioni o incentivi. Gli Stati, del resto,
non hanno mai alleati o nemici permanenti, ma interessi che ne determinano la
cooperazione o la competizione. Di fronte al denaro, cessa l’amicizia. La prevalenza
del mercato sulla politica ha prodotto un mondo forse più ingiusto, ma senz’altro più
pacifico, poiché nel secondo dopoguerra è prevalsa l’affermazione di Adam Smith
secondo cui “se il tuo vicino diventa più ricco, aumenterà anche la tua ricchezza”. Ma
quando il “mondo piatto” della globalizzazione ha sostituito quello “rotondo”, la
competizione fra “sistemi paese” è divenuta più feroce.
La crisi finanziaria mondiale ha determinato il ritorno dello Stato nell’economia,
ha accentuato la conflittualità economica e ha messo in crisi gli assetti garantiti dal
primato degli USA. L’importanza assunta dai bailouts pubblici per stimolare consumi,
crescita ed esportazioni è aumentata. Sono cresciute inoltre le tendenze al
nazionalismo economico e le tentazioni del populismo e del protezionismo. Ai tempi
della sua indiscussa superiorità, pur tutelando i propri interessi, Washington garantiva
anche quelli del resto del mondo, svolgendo una funzione da arbitro che oggi è venuta
a mancare. Non si sa come potrà essere ripristinata in futuro.
7.
Considerazioni conclusive
La crisi finanziaria ha modificato i precedenti equilibri ed eroso la stabilità, anche
perché l’Europa non solo cresce poco, ma si è anche divisa: al suo interno si sono
prodotti squilibri strutturali incolmabili, e altri ne stanno sorgendo. La Germania,
come si è visto nella riunione del G-20 di Seul e nella crisi libica, tende a differenziare
la propria politica sia da quella degli USA che dagli altri paesi europei, rafforzando i
legami con i BRIC anche a discapito di quelli europei ed atlantici. Fanno quasi
tenerezza i francesi quando affermano che il mancato intervento della Germania in
Libia dimostrerebbe che tale paese è rimasto un “nano politico” e non è quindi
legittimato ad entrare a far parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. C’è da
augurarsi che il loro risveglio da tali fantasie megalomani non sia troppo brusco,
perché ne andrebbero di mezzo non solo la Francia, ma anche l’UE e la NATO, e
pertanto anche l’Italia. Il “risveglio arabo” rischia di aggravare le divisioni
dell’Europa, che diventeranno esplosive quando la Germania, che si è
costituzionalmente impegnata a non superare dal 2016 un livello di deficit pari allo
0,3% del PIL, non finanzierà più il bailout per i paesi in crisi. Gli spread rispetto al
Bund tedesco aumenteranno, sottoponendo i paesi in crisi a insostenibili oneri
17
aggiuntivi per finanziare il loro debito. Anziché avviare un “circolo virtuoso” della
convergenza delle economie deboli verso quelle forti, si rischia la penalizzazione delle
prime che, entrando in un ciclo deflattivo, saranno sempre più soffocate dai loro debiti.
Tale situazione verrà aggravata per tutti dall’invecchiamento della popolazione.
Rimarranno i rischi di deflazione, di default e dell’adozione di misure protezionistiche
per proteggere le economie più deboli dall’aggressione di quelle più forti. Si
verificherà anche il rischio di una “ri-colonizzazione” alla rovescia, con i paesi
emergenti che acquisteranno assets strategici dell’economia occidentale. Permane
anche l’incertezza su come la Cina, ma anche gli Stati produttori di petrolio e la
Russia, impiegheranno i loro fondi sovrani. Come minimo, tali paesi dovranno avere
maggiore peso nelle Istituzioni Finanziarie Internazionali. Perdura anche l’incertezza
sui prezzi delle commodities, sia minerarie che agricole. Il loro aumento - stimolato
da una speculazione incontrollabile e da talune discutibili decisioni politiche, quali gli
incentivi ai biocarburanti o i divieti di esportazione dei prodotti agricoli per
contenerne l’aumento dei prezzi interni - potrebbe accrescere l’instabilità politicosociale nei paesi più poveri. Altri interrogativi derivano dal potenziale intrinseco
d’instabilità proprio di tutti gli Stati autoritari, che diverrebbe reale in caso di crisi
economica. Lo dimostrano non solo la “primavera araba”, ma anche l’espansione delle
rivolte sociali in Cina e il panico che coglie l’oligarchia russa di fronte ad ogni
dimostrazione di piazza. Tale potenziale di instabilità è accresciuto dalle nuove ICT:
dopo la rivolta di “piazza” di Belgrado, provocata contro Milosevic dall’OTPOR
serbo, tali nuove tecnologie si sono dimostrate molto efficaci per mobilitare la piazza,
anche se, alla fine, le rivoluzioni vengono fatte dai fucili, non dalle ICT. Di fronte a
questi fenomeni, i regimi democratici sono più resilienti di quelli autoritari, in quanto
riescono meglio a prevenire ed assorbire il dissenso popolare. Tuttavia, non è detto
che non possono esserne travolti in caso di grave crisi economica. In altre parole,
anche se non è detto che il “modello cinese” alternativo al liberalismo democratico
del Washington Consensus debba prevalere, il capitalismo democratico e liberale è
meno solido che in passato anche in Occidente. Rimane, quindi, aperto l’interrogativo
su come l’economia e la finanza possano influenzare il nuovo ordine e disordine sia
mondiale che all’interno degli Stati. La risposta che si dà ad esso è determinante per
ogni ipotesi di futuro ordine mondiale.
18