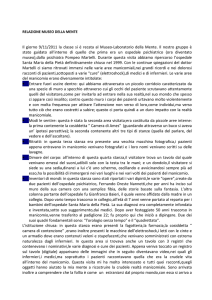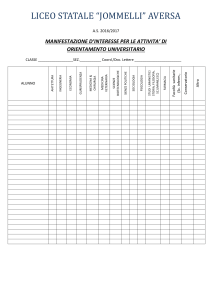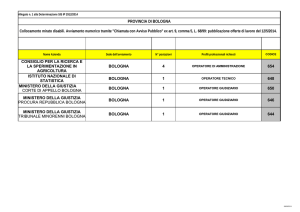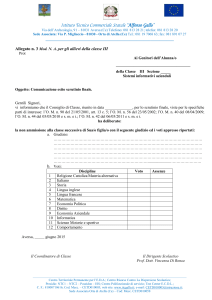La misura del pericolo.
Donne recluse nel manicomio giudiziario
di Aversa (1931-50)
di Laura Schettini
La storia dei manicomi, delle persone che hanno attraversato quei luoghi, delle
loro famiglie, dei medici e del personale che ne regolavano il funzionamento,
della cultura scientifica che li sostenne, ha conosciuto negli ultimi anni
riconoscimento accademico e fortuna bibliografica. A consolidare una
tradizione storiografica iniziata tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento,
sono arrivati recentemente, per citare solo alcuni dei lavori più rilevanti, Matti,
indemoniate e vagabondi di Vinzia Fiorino, II governo della follia di Lisa
Roscioni, il numero monografico dal titolo Manie della rivista "Genesis", Nati
per il crimine di Mary Gibson e, infine, i panel che hanno visitato il tema,
presentati tanto al convegno della Società italiana per lo studio della società
contemporanea che a quello della Società italiana delle Storiche del 2003'.
La storiografia dedicata alla psichiatria, alle istituzioni manicomiali, agli
uomini e alle donne internate sembra, quindi, aver raggiunto un alto grado di
maturità anche grazie alla complessità degli studi che la compongono; una
complessità data non solo dalla varietà delle fonti utilizzate (la letteratura
scientifica, le cartelle cliniche, la documentazione amministrativa), ma anche
dai diversi fuochi di interesse che, negli ultimi quarantanni, si sono avvicendati
al centro delle ricerche: prima l'istituzione, il sapere psichiatrico, le dinamiche
di controllo sociale, poi, finalmente, gli uomini e le donne internati, le reti di
relazioni sociali coinvolte dalle dinamiche di internamento, l'interazione tra
sapere scientifico e cultura popolare ecc.
Eppure, nonostante la ricchezza del panorama storiografico, ad oggi, in
Italia, mancano quasi del tutto studi e ricerche dedicati ai manicomi giudiziari;
un'assenza che colpisce ancora di più l'attenzione se si pensa che questi sono gli
unici istituti manicomiali funzionanti e operanti ancora oggi e che essi non furono
"chiusi" dalla cosiddetta legge 180.
Ma lo studio dei manicomi giudiziari, del loro funzionamento, degli uomini
e delle donne per cui furono pensati e da cui sono stati vissuti, può risultare
"utile" e significativo non solo per supplire a questa evidente
Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 2/2004
mancanza. Guardare a queste istituzioni - che si collocarono al confine tra
manicomi e istituti di pena, tra sapere psichiatrico e antropologia criminale può aggiungere qualcosa di inedito e suggerire nuove domande; può,
soprattutto, costituire un nuovo terreno su cui misurare anche le più recenti
acquisizioni della storia della psichiatria e della criminologia.
Durante il 1876, nell'edificio dell'ex convento di San Francesco ad Aversa, allora
casa di pena per invalidi, in assenza di una legislazione specifica ma per atto
amministrativo dell'alierà direttore generale delle carceri Martino Beltrani Scalia,
fu inaugurata la prima sezione per «maniaci» della penisola.
La storia dei manicomi giudiziari1 italiani iniziò, così, con l'invio di 19
detenuti, prevalentemente "impazziti" durante la detenzione, nella nuova sezione
aperta ad Aversa e affidata alla direzione di Gaspare Virgilio, noto alienista
seguace di Cesare Lombroso.
A lungo il manicomio giudiziario ha conservato questi caratteri
originari: di essere, cioè, nato come "un'appendice" del carcere, utile a
contenere quei detenuti che compromettevano il funzionamento degli istituti
di pena ordinari e, allo stesso tempo, di essere nato senza una definizione
giuridica precisa che ne stabilisse le funzioni, l'organizzazione interna, i criteri
d'ammissione3.
Soltanto nel 1891 il Regolamento generale delle carceri4 - voluto
nuovamente dal direttore generale delle carceri Martino Beltrani Scalia stabiliva le figure per cui era stato pensato il manicomio criminale: i
detenuti impazziti dopo la condanna con una pena superiore ad un anno, i
prosciolti per totale infermità di mente, i giudicabili inviati in osservazione
dall'autorità giudiziaria5.
Durante i quindici anni che intercorsero tra queste due date i manicomi
giudiziari (a quello di Aversa si aggiunse nel 1886 quello di Mon-telupo
Fiorentino e nel 1892 quello di Reggio Emilia) hanno funzionato
essenzialmente come sezioni speciali delle carceri. In base agli studi e alla
documentazione oggi disponibile6 sembra che inizialmente questi istituti
abbiano assolto una funzione specifica essenzialmente nell'ambito delle varie
forme di carcerazione - facendosi carico dei soggetti che compromettevano la
gestione dell'ordine negli altri istituti di pena - e non abbiano ricoperto,
invece, una funzione specifica nella gestione dei conflitti, delle contraddizioni
all'interno dell'intero corpo sociale.
Come ha già sostenuto Renzo Villa, i manicomi civili, le carceri, i
postriboli, gli istituti assistenziali e di ricovero, i riformatori, costituivano già
una rete estesa e differenziata di istituzioni in grado di assolvere ai compiti di
disciplinamento, assistenza, controllo dell'Italia del periodo. Nella divisione
dei compiti e delle competenze tra le diverse istituzioni i manicomi criminali
non sembravano avere un loro ruolo specifico tanto
296
che, per molti decenni, essi si collocarono nell'intersezione tra l'universo
carcerario e quello manicomiale, mutuando da essi tanto la popolazione quanto
l'organizzazione interna.
Proprio guardando a questa apparente assenza di significato e di ruolo
precipuo dei manicomi criminali al loro nascere e alle dinamiche altre, quindi,
che ne determinarono l'istituzione è possibile, a mio avviso, avvicinarsi ad una
prima questione molto significativa.
Per la cultura positivista di quel periodo i manicomi criminali che,
contrariamente a quanto accadeva in Italia, già da metà Ottocento erano stati
istituiti in alcuni paesi europei7, rappresentavano uno dei più agognati esiti
istituzionali delle teorie criminologiche, un campo di sperimentazione e
concretizzazione delle teorie lombrosiane senza precedenti8.
L'antropologia criminale aveva elaborato e diffuso un nuovo modello di
criminale, composto anche di individui che non erano responsabili delle loro
azioni ma il cui comportamento delittuoso era determinato da fattori innati;
persone che portavano scritti sui corpi i segni della loro degenerazione9.
Uomini e donne che quindi - come chiedevano gli antropologi criminali in
quegli anni - bisognava sottrarre all'ordinario sistema punitivo (anche perché
ne turbavano il funzionamento) per essere, invece, affidati ad un nuovo tipo
di istituti di custodia e cura: i manicomi criminali.
L'istituzione dei manicomi criminali, quindi, era fortemente voluta dai seguaci
dell'antropologia criminale anche perché avrebbe di fatto contribuito a
confermare l'esistenza di quella nuova tipologia di delinquenti, i «delinquentinati», inventati da quella disciplina; avrebbe reso valido quel corpus di
conoscenze che era alla base della criminologia positivista e che tanta
opposizione stava trovando tra i seguaci della scuola penale classica italiana10.
I cardini della criminologia positivista implicavano grossi spostamenti
all'interno della cultura giuridica, e non solo, italiana. In primo luogo il
riconoscimento della non responsabilità del folle per il reato commesso
comportava, di fatto, una messa in discussione dei dispositivi di sicurezza penale
di cui la società si era dotata fino a quel momento. L'antropologia criminale
offriva come alternativa al carcere una forma particolare di manicomio; alla
pena determinata e proporzionata al reato, fino ad allora fondamento del codice
penale, intendeva sostituire un trattamento dalla durata indeterminata,
indipendente da un codice scritto, e vincolato fortemente al giudizio
psichiatrico.
L'apertura, di fatto e non per diritto, della sezione per «maniaci» ad Aversa
nel 1876 inaugurò non solo la storia dei manicomi giudiziari in Italia, ma anche
un certo sbilanciamento della cultura giuridica verso i canoni della
criminologia positivista.
297
La nascita dei manicomi giudiziali, poco formalizzata, e il lento iter che portò
alla loro piena istituzione giuridica che si concluse solo con la legge Giolitti
del 1904, ci permettono, quindi, di inoltrarci all'interno di una questione molto
discussa dalla storiografia: in che misura la criminologia positivista è stata
egemone in ambito culturale, ma anche e soprattutto quanto e attraverso quali
percorsi essa ha effettivamente pervaso leggi, istituzioni, dinamiche sociali?
Ciò che la storia dei manicomi giudiziari italiani sembra indicare è che,
come già sostenuto recentemente da Mary Gibson in riferimento ad altri
ambiti istituzionali - quali la giustizia minorile e la polizia scientifica del tempo
-, «le idee di Lombroso ebbero un impatto profondo e , duraturo sul sistema di
giustizia penale italiano»". Un impatto che risulta "evidente soprattutto se si
guarda ai percorsi di istituzionalizzazione, anche informali, della criminologia
positivista, e non solo all'ambito legislativo. I manicomi giudiziari, infatti,
istituzione di certo non irrilevante all'interno del panorama giuridico italiano,
nacquero e funzionarono ben prima dell'approvazione di una legge che li
istituisse, grazie all'iniziativa di uomini che in virtù della loro funzione
pubblica agirono anche al di fuori dei meccanismi della vita parlamentare
italiana.
Dietro le vicende che portarono all'apertura dei manicomi criminali, è
noto, ci furono le pressioni degli esponenti di punta dell'antropologia
criminale: Cesare Lombroso, Gaspare Virgilio, Saverio Biffi, Augusto
Tamburini. Ma anche un altro nome, si è visto, fu legato, forse in modo anche
più efficace, ai passaggi che resero possibile la nascita di questa istituzione:
quello di Martino Beltrani Scalia11.
Profondamente impegnato nelle vicende risorgimentali, avvocato di
formazione e acuto studioso, per passione, del sistema penitenziario di alcuni
paesi europei13, all'indomani dell'Unità, nel 1864, Beltrani Scalia fu chiamato a
ricoprire in virtù delle sue competenze la carica di ispettore generale delle
carceri.
Dalla sua nascita, nel 1870, diresse la "Rivista di discipline carcerarie" che
oltre ad essere il bollettino ufficiale della Direzione generale delle carceri,
rappresentò uno dei luoghi di punta della discussione sulla riforma
penitenziaria italiana. La rivista pubblicò per prima articoli e studi di
antropologia criminale quando ancora non era nato il celebre "Archivio di
psichiatria, antropologia criminale e scienze penali"14, ospitò numerosi contributi
di Lombroso, Tamburini e altri esponenti eccellenti della nuova disciplina,
incoraggiò la discussione sulla necessità di riformare il sistema carcerario
italiano; di fatto aderì alle teorie criminologiche lombrosiane e contribuì alla
loro diffusione.
A metà anni Settanta dell'Ottocento, ancora una volta in qualità di
ispettore generale delle carceri, Martino Beltrani Scalia diede impulso alla
298
prima raccolta italiana di oggetti penitenziari, reperti anatomici, modelli di istituti
penitenziari e mezzi di contenzione organizzata a Roma nell'ambito della Scuola
degli allievi agenti di custodia e istituita presso il carcere delle Mantellate. Fu,
quello, il nucleo originario del Museo criminale di Roma che, insieme al Museo
di antropologia criminale ideato da Cesare Lombroso a Torino, ebbe tanta
parte nell'opera di rappresentazione concreta e divulgazione dell'antropologia
criminale15.
Come già detto, nel 1876 Martino Beltrani Scalia, divenuto in quello stesso
anno direttore generale delle carceri, con un semplice atto amministrativo
istituì la prima sezione per "maniaci" italiana ad Aversa. Nel 1884, ancora
sotto la sua direzione, la Direzione generale delle carceri presentò un disegno
di legge per l'istituzione dei manicomi criminali. Infine, come già si è avuto
modo di dire, ancora in qualità di direttore generale delle carceri, nel 1891
promosse il Regolamento generale delle carceri che sancì i criteri di
ammissione nei manicomi criminali.
L'insieme di queste iniziative, che contribuirono non poco alla diffusione
ma anche alla sperimentazione dell'antropologia criminale, ebbero quindi come
regista un uomo che aveva aderito alle teorie lombrosiane fin dal loro nascere,
quando già ricopriva un ruolo significativo nella vita istituzionale del paese.
Questi elementi possono offrire spunti interessanti per riflettere sulle
modalità di trasmissione e traduzione concreta di saperi e teorie: essi
rafforzano la lettura offerta da Mary Gibson dei percorsi tortuosi attraverso
cui la criminologia positivista è penetrata non solo nella vita culturale italiana,
ma anche in quella istituzionale e sociale. Una perva-sività che non può essere
misurata solo in base al grado di accoglienza ricevuta dalle teorie lombrosiane
nei codici penali ma che può essere verificata anche nella nascita in quegli
anni di nuove istituzioni o nella capacità dei seguaci dell'antropologia
criminale di agire in modo ben organizzato e coeso.
Soprattutto, però, a me sembra che sia proprio a partire dalle ricerche
negli archivi manicomiali che diventa possibile accedere a dati, informazioni,
suggestioni in grado di dirci in che misura saperi e teorie hanno conosciuto
esiti concreti, di che portata questi siano stati, quanto abbiano modificato e
orientato la vita quotidiana di uomini e donne, in quali dinamiche sociali
fossero collocati e così via16.
Il manicomio criminale di Aversa, oggi Ospedale psichiatrico giudiziario
"Filippo Saporito", è situato all'interno della città e attualmente ospita circa
150 uomini. Al suo interno una sala è stata adibita a museo storico dell'istituto
e vi sono esposti reperti anatomici, mezzi di contenzione, manufatti dei reclusi,
alcune lettere e fotografie. Un'altra stanza è utilizzata per conservare l'archivio
storico del manicomio, vale a dire le
299
cartelle cllniche degli internati dal 1900 fino ad anni recenti. L'archivio non è
stato ancora né ordinato né inventariato17.
Ad oggi sono rare le ricerche svolte sulle cartelle cliniche di un manicomio
criminale. I pochi studi dedicati a queste istituzioni si sono prevalentemente
riferiti al periodo a cavallo tra Otto e Novecento e hanno utilizzato come fonte la
documentazione amministrativa, la letteratura scientifica coeva, gli atti
parlamentari. Di qui, la scelta di fecalizzare il lavoro di ricerca di chi scrive
presso l'archivio storico del manicomio criminale di Aversa sugli internamenti
femminili fra gli anni Trenta e la fine degli anni Quaranta del Novecento. Le
ragioni di ciò sono molteplici e in parte legate tra loro.
Nel 1931 l'istituto campano divenne il primo manicomio giudiziario anche
femminile della penisola e resterà il solo per più di due decenni. vJPrima di
allora, ma anche successivamente per quelle che non potevano essere trasferite
ad Aversa, le «pazze-criminali» erano recluse in sezioni speciali delle carceri o
dei manicomi civili. Lo stesso anno, inoltre, entrò in vigore il nuovo Codice
penale, il cosiddetto Codice Rocco, che nonostante mantenesse nel suo impianto
principi generali ispirati sia alla scuola classica che alla scuola positiva,
risultandone di fatto un compromesso, fu salutato dagli antropologi criminali
come un grande successo18, soprattutto perché accoglieva al suo interno le
misure di sicurezza detentive e la categoria della pericolosità sodale19.
I manicomi giudiziari, le case di lavoro o le colonie agricole, i riformatori
giudiziari e le case di custodia e cura diventarono i luoghi preposti
all'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva; di periodi, cioè,
d'internamento cui sottoporre i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, i
delinquenti abituali, quelli per professione e quelli per tendenza, sia
successivamente all'espiazione della detenzione ordinaria, sia - in caso di
incapacità di intendere e di volere - in sostituzione della pena medesima10.
Le misure amministrative di sicurezza, che potevano essere applicate anche a
persone incensurate, introdussero nel codice penale un principio di
indeterminatezza della pena, peraltro già all'opera nelle procedure di reclusione
nei manicomi criminali dell'Italia liberale. Esse, infatti, recita l'articolo 207,
«non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno
cessato di essere socialmente pericolose»". Decorso il periodo di assegnazione
alla misura di sicurezza, era il giudice a riprendere in esame le condizioni della
persona che vi era stata sottoposta per valutare se fosse cessata la pericolosità
sociale; in caso negativo era fissato un nuovo termine per un ulteriore esame, e
così via22.
L'analisi del materiale relativo agli anni Trenta e Quaranta conservato
nell'archivio storico del manicomio giudiziario di Aversa mi è sembrato
300
un terreno fertile sul quale, quindi, misurare alcune questioni. In primo luogo
ero interessata a indagare in che misura e secondo quali modalità il modello di
criminalità femminile, elaborato per la prima volta dalla criminologia a fine
Ottocento e accolto dal fascismo, fosse stato messo all'opera, quali traduzioni
concrete avesse conosciuto nelle pratiche di reclusione, chi fossero le donne
giudicate «pazze-criminali» o considerate socialmente pericolose. In Italia non
sono mancati negli ultimi anni importanti studi che si sono dedicati al modello
positivista di delinquenza femminile, svelandone, grazie ad un'accurata analisi dei
testi che circolarono a partire dagli anni Novanta dell'Ottocento, i limiti, le
contraddizioni interne,le debolezze, l'artificiosità23. Mi è sembrato utile, dal
canto mio, sollecitare il tema anche a partire dallo studio dei luoghi che forse
sono stati tra i più adeguati alla messa in opera dei principi della criminologia
positivista e privilegiando le vicende concrete di quante furono recluse in
questo tipo particolare di istituzione.
In secondo luogo ero interessata a "toccare con Mano" il funzionamento
delle misure di sicurezza, per quanto uno studio centrato su un solo istituto
possa offrire solo indicazioni parziali. Di nuovo, volevo inoltrarmi nelle
vicende delle donne sottoposte a misure di sicurezza e vedere a quali donne
erano applicate, quando era ritenuta cessata la pericolosità sociale e quando
no, in che modo questo strumento così discrezionale era usato nell'Italia
fascista e quali dinamiche produsse all'interno della vita e delle famiglie dei
soggetti reclusi.
Il 1931, anno di nascita del manicomio giudiziario femminile e di
battesimo delle misure di sicurezza è stato quindi, per la mia ricerca, una data
d'inizio quasi obbligata24.
Durante gli anni Trenta e Quaranta del Novecento circa 1.2.00 donne furono
ecluse nel manicomio giudiziario di Aversa. Il primo anno, il 1931, furono
ammesse 23 donne, ma già l'anno successivo le donne condotte ad Aversa furono
il triplo e continuarono ad aumentare per tutto il periodo, fino ad arrivare, tra la
fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta, a più di 350 donne presenti
nell'istituto ogni anno25. Ad oggi non esiste un censimento delle donne recluse ad
Aversa che raccolga notizie circa lo stato civile, la condizione sociale, il reato e i
motivi per cui erano state condotte nell'istituto. Lo spoglio delle cartelle clini-che
consente, tuttavia, di ricostruire questo quadro in modo abbastanza significativo.
Nel corso della mia ricerca ho lavorato su un campione di trecento cartelle
cliniche, selezionando circa un quarto delle cartelle cliniche relative ad ogni anno
del periodo preso in esame26.
In generale non si notano dati particolarmente rilevanti per quanto riguarda lo
stato civile e la condizione sociale: le maritate concorrono
301
in misura maggiore sul totale della popolazione femminile reclusa, ma questo
sembra rispettare un andamento generale già registrato negli istituti manicomiali (i
dati precisi da me raccolti sono: 149 donne maritate, 108 nubili, 43 vedove); allo
stesso modo - in armonia con quanto succedeva negli altri istituti di pena e
manicomiali della penisola - la quasi totalità delle recluse di cui ho raccolto i
dati apparteneva alle classi povere: 75 contadine, 138 casalinghe, 26 sarte e
ricamatrici, 28 nullatenenti, 18 do-mestiche27.
Alcune riflessioni, invece, meritano i dati relativi ai reati imputati alle donne
recluse ad Aversa. Le imputazioni che ricorrono più frequentemente sono quelle
relative ad atti di violenza (lesioni gravi, tentato omicidio, omicidio) compiute
dalle donne nei confronti di membri della famiglia: \ 74 delle donne da me
studiate erano imputate per tali reati. Tranne sporadici casi in cui oggetto di tali
violenze erano i genitori, i figli o i fratelli 'è le sorelle, si trattava quasi sempre
di atti compiuti ai danni del marito o del fidanzato della donna" Segue, in
ordine di importanza tra i reati imputati, il furto (61 casi raccolti)28.
Sulla base dello spoglio delle cartelle cliniche è anche possibile dire
qualcosa sulla durata della reclusione. Più di un terzo delle donne (107) rimase
nell'istituto per un tempo superiore ai cinque anni. Un numero simile (104),
invece, vi rimase per meno di un anno. Tra questi due estremi si collocano 41
donne rimaste ad Aversa tra i due e i quattro anni, e 48 donne che invece
furono recluse tra uno e due anni. Può essere utile, per leggere questi dati,
tenere conto che molte delle donne che rimasero ad Aversa per meno di un
anno (69 su 104) erano state trasferite lì da altri istituti di pena della penisola
solo temporaneamente, al fine di sottoporle ad un periodo di osservazione e a
perizia psichiatrica. Dopo questo periodo furono trasferite nuovamente nelle
carceri da cui provenivano.
Delle donne assegnate tramite una sentenza del tribunale penale al
manicomio giudiziario di Aversa, due terzi furono dimesse allo scadere del
termine della misura; per quelle (76) a cui le misure furono rinnovate si è
trattato per la maggior parte di proroghe andate avanti per anni. Di queste 76
donne, 65 erano nubili o vedove oppure era espressamente indicato che non
avevano familiari a cui riferirsi.
Ovviamente questi dati non hanno assolutamente la pretesa di contribuire ad
un'analisi quantitativa quanto, piuttosto, credo possano essere utili a
suggerire un andamento e a porre alcune domande.
In primo luogo, in riferimento alle tipologie di reati commessi da queste
donne, sulla scia di un'ipotesi già avanzata da alcune studiose19, anche queste
prime informazioni sembrano confermare l'idea che, al contrario di quanto è
stato ipotizzato per gli uomini, i legami familiari producevano, piuttosto che
prevenire, la spinta al crimine tra le donne.
302
Allo stesso tempo, così come avveniva ed era avvenuto in altri istituti di ricovero e
di assistenza, le dimissioni erano regolate seguendo questa strada a ritroso: le
donne recluse riuscivano spesso a riconquistare la loro libertà solo se una rete
familiare era pronta ad accoglierle, a prendersene "cura", a proteggerle, a
contenerle. In secondo luogo, l'insieme dei dati raccolti contribuisce a disegnare
alcuni tratti della tipologia di donna che più frequentemente incorreva nel
manicomio giudiziario piuttosto che nella reclusione in un istituto di pena
ordinario. Ad essere considerati espressione di un carattere "degenerato",
patologico, erano, si è visto, prima di tutto gli atti di violenza contro le persone
della famiglia. Sembra aleggiare nei criteri che regolavano l'assegnazione ad un
manicomio giudiziario proprio quel paradigma scientifico che attribuiva alla
donna normale una naturale propensione alla pietas, al sacrificio di sé, alla
funzione di madre e sposa. Così come recitavano i principi della criminologia
positivista, le donne che usavano violenza verso i loro mariti, figli, madri, padri
non erano semplicemente delle criminali: erano piuttosto delle «degenerate»,
delle «pazze-criminali» che oltre ad essere punite dovevano anche essere
curate.
Ma di questa geografia dei crimini, delle strade attraverso cui si arrivava
nel manicomio di Aversa, di cosa rendeva una donna socialmente pericolosa
credo parlino molto meglio i documenti conservati nelle cartelle cliniche.
Carmela Z.3° fu condotta nel manicomio giudiziario di Aversa, per essere
sottoposta a perizia psichiatrica, nell'aprile del 1938. Era una donna sposata di 45
anni, insegnante, e viveva con la figlia in provincia di Belluno, città dove era
nata. Era imputata di tentato omicidio a danno del marito, un medico russo
naturalizzato italiano. Dalla perizia psichiatrica «risultò la sua totale infermità di
mente al momento del fatto, nonché la sua peri-colosità sociale»3'. Il tribunale di
Belluno dichiarò quindi di non doversi procedere contro la donna perché non
imputabile e ne ordinò il ricovero in manicomio giudiziario per due anni. In realtà
la donna rimase ad Aversa per quattro anni, fino a quando fu dichiarata cessata la
sua pericolosità sociale. Quando giunse in manicomio, come era d'obbligo, venne
redatta una relazione di ammissione che risassumeva le notizie relative alla sua
storia e, in particolare, alle vicende che l'avevano condotta nell'istituto:
Sposò nel 1932 un medico Russo naturalizzato in Italia di 24 anni più vecchio di
lei. Dopo un periodo di forte amore, si iniziarono i contrasti. Egli ringiovanito
"mercé" le cure ch'ella le aveva prestato, incominciò a ripudiarla e ad avere
relazioni con donne. Ella ne divenne gelosissima. Da ciò liti frequenti e gravi con
percosse, spinte etc. Ella si orientò verso la religione, egli, invece, avrebbe voluto
che si trovasse un amante. È da notarsi, incidentalmente, ch'egli la sposò
303
quando già aveva una figlia di 19 anni, avuta da rapporti con un tedesco durante la
invasione austro-tedesca della nostra provincia. Al reato la giudicabile giunse dopo
una sequela di oltraggi, spinte ed altre cose del genere quando già era iniziato il
procedimento di separazione. Il mattino del 22 dicembre 1937 erano i coniugi
convenuti presso il Tribunale di Belluno alla presenza del Presidente dopo breve
schermaglia di parole, ella estrasse un pugnale e somministrò un colpo al marito
davanti al detto magistrato e nell'ufficio. Afferma di essere stata trascinata all'atto
stesso dalla ipocrisia del marito che sapeva ben dissimulare le sue pessime qualità di
fronte a tutti.
Trascorsi tre anni di reclusione, la direzione dell'istituto interpellò il dottor B. per
verificare se l'uomo, in caso di dimissione della moglie, se ne sareb-Xbe fatto
carico. Evidentemente in un primo momento l'uomo rispose negativamente: non
solo perché alla donna fu prorogata la misura di sicurezza per un altro anno, ma
anche per la risposta che ella stessa scrisse al marito:
•
Mi dite che non intendete di prendervi la responsabilità di me per vari motivi. Ecco
quali sono: I avete paura di me e ciò vuoi dire che siete colpevole. Chi è innocente non
teme nulla perché ha la coscienza tranquilla. II Non intendete di mantenermi e non
volete spendere per me. Ili Agite con la volontà di quella miserabile degenerata
donnaccia, che si presta alle vostre oscenità, sobillandovi contro di me e consigliandovi
a commettere il più infame delitto morale che non vi lascerà pace, né riposo. [...] E non
solo prolungate il mio soggiorno qui, ma cercate ancora di farmi passare per pazza
mentre sapete che non lo sono e non lo sarò mai, dato che la pazzia è ereditaria. Io non
sono né pazza né delinquente; sono soltanto una povera donna malata di nervi e
bisognosa di cure, di compatimento, di attenzioni e di molto affetto... [...] Il giorno del
nostro matrimonio giurai di essere vostra, soltanto vostra, lo giurai poi sulla salma di
mia madre; mantenni la promessa nonostante la differenza d'età (24 anni) e vi amai
con ardore, con fedeltà, con lealtà. Chiesi di essere da voi ricambiata con la stessa
misura e quando mi accorsi che mi tradivate con femmina da trivio soffersi tanto da
desiderare la morte. Vi volevo tutto per me, onesto, leale, retto: fu per colpa del vostro
tradimento, del vostro ripudio che ammalai di nervi da perdere quasi la ragione. Sapete
tutto e perché non volete ridarmi la mia libertà?3*
Credo sia utile sottolineare la dimestichezza che la donna mostrò di avere sia con
alcune delle norme che regolavano la reclusione sia con alcune delle teorie
positiviste sulla natura della pazzia, quasi fossero entrate nel senso comune.
La donna mostrava una chiara consapevolezza che a prolungare il suo
soggiorno ad Aversa fosse l'atteggiamento del marito; poco dopo affermava di
non essere pazza perché la pazzia era ereditaria. Il rinnovo della misura di
sicurezza o la sua revoca sembravano dipendere da molti fattori: dalla natura del
crimine commesso, dalla possibilità di essere accolte da una rete familiare se
liberate, dall'intera biografia della
304
reclusa. In molti dei casi su cui ho lavorato la decisione di assegnare una donna a
un manicomio giudiziario piuttosto che a un istituto di pena ordinario era
legata non tanto al fatto che la donna fosse stata giudicata incapace di intendere e
di volere nel momento del compimento del delitto, quanto al fatto che l'intera
biografia dell'imputata parlava alle autorità di pericolosità sociale, di
marginalità, di "devianza". Proprio come prescriveva il codice penale del 1931,
in alcuni casi era la personalità, la storia della donna a essere oggetto di giudizio,
non i suoi atti.
Le biografie delle donne, spesso giovani, che così arrivavano ad Aversa
mostravano molti tratti comuni. Difficilmente, per esempio, l'esperienza di
reclusione nel manicomio giudiziario campano costituiva un evento
straordinario nel suo genere; al contr|irio, nel caso delle donne slegate dai
vincoli e dalle protezioni familiari, per scelta o per necessità, spesso si
sommavano esperienze di reclusione e ricovero in diversi istituti nell'arco di
una vita: istituti educativi, sanatori, manicomi civili, case di lavoro ecc.
Tra queste storie c'è anche quella di Ada G.33, una giovane donna in conflitto
con la sua famiglia che cercava una strada per la sua affermazione individuale. Il 4
agosto 1941 il tribunale di Ancona la prosciolse per vizio totale di mente,
imputata di violazione di domicilio (paterno) commesso con violenza, e ne
ordinò il ricovero in un manicomio giudiziario per un periodo non inferiore a
due anni. La donna fu ammessa ad Aversa nell'ottobre 1941. Lucida, corretta,
ordinata, orientata nel tempo, sul luogo e circa la sua posizione giuridica.
Spigliata, racconta con apparente serenità e indifferenza la sua vita. A suo dire
nulla deve alla famiglia perché tutti i suoi studi li ha potuti compiere solo
perché animata da grande volontà e da ardente amore allo studio; ha riportato
ottimi voti per cui ha potuto usufruire dalla dispensa delle tasse scolastiche.
Questo fatto l'ha messa in cattiva luce perché, a suo dire, nessun fratello è
riuscito ad andare avanti negli studi anche se poi nella vita sono riusciti a
ricoprire posti eminenti nella vita pubblica. Appena laureata contrasse una
pleurite a sinistra per cui fu inviata a San Remo e di lì in un sanatorio a Sondrio
dove rimase per circa quattro anni34.
Dalla relazione inviata dal sanatorio al manicomio giudiziario di Aversa
si apprende che dopo pochi mesi di ricovero in sanatorio, Ada G. era
praticamente guarita ma insisteva per essere trattenuta e non ritornare presso la
famiglia e, quindi, lì «rimase per vari anni come cliente abituale, anche se i suoi
disturbi non erano tali da rendere indispensabile la continuazione del
ricovero»". Quando le dimissioni sembravano diventate inevitabili, nel 1938,
si «manifestò quasi improwisamente un mutamento di carattere; [...] il carattere
divenne piuttosto allegro, comunicativo, mentre comparvero segni che
dimostravano un principio di alterazione
305
psichica: taglio raso dei capelli, abiti mascolineggianti, raccolta ed incetta in
camera di pubblicazioni numerosissime, d'ogni tipo, di veri magazzini di
vestiario, di oggetti svariati quali pentolarne ed altro»36. Nel 1939, al suo
ennesimo rifiuto di fare ritorno alla casa paterna
i due fratelli più anziani si recarono a Sondrio e lì l'avrebbero picchiata. Perciò lei
ruppe definitivamente le relazioni con il padre, per lei unico responsabile di tale stato di
fatto; ma per mancanza di mezzi fu costretta a tornare a Jesi, in casa paterna, dove trovò
tutti nemici che le negavano il conforto del focolare. Tentò di far pratica presso la
farmacia della Congrega di Carità per poi comprare per conto suo una farmacia37.
Ma - continua la ricostruzione del suo racconto riportata nel Diario del
ricovero - «la persecuzione paterna continuò implacabile perché oramai fra stata
decisa la sua distruzione. La vogliono liquidare perché lei non si rassegna ad
essere una nullità,»38. Durante questi primi tempi del suo ritorno a Jesi fu anche
condotta, per essere sottoposta a visita, nel manicomio civile di Ancona perché
«le sue manifestazioni andarono sempre aggravandosi, sempre prepotente, ostile,
litigiosa, metteva il disordine dove cercava di occuparsi. Il suo odio verso la
famiglia andava sempre crescendo, infine venne sottoposta a visita psichiatrica
che la riconobbe affetta da demenza precoce»™. Tornata nuovamente in famiglia i
comportamenti ostili verso il padre e i fratelli continuarono fino a che non fu
cacciata di casa.
Fu cacciata di casa, ma lei riuscì ad entrare scavalcando il muro di cinta del giardino ed
arrampicandosi poi su per un abbaino del quale ruppe i vetri. Ciò che ha determinato
l'attuale situazione giuridica40.
Ada G. rimase nel manicomio giudiziario di Aversa per tre anni. Allo scadere
della misura di sicurezza, infatti, il giudice di sorveglianza, su relazione
dell'istituto aversano, prolungò di un altro anno la misura stessa perché non era
cessata la pericolosità sociale della donna. Allo scadere di questo ulteriore
periodo le fu revocata l'assegnazione alla misura di sicurezza e fu trasferita nel
manicomio civile dello stesso comune. In una lettera del gennaio 1945 ai
familiari della donna, il direttore sanitario del manicomio giudiziario campano
così riassumeva la sua condizione:
Le condizioni mentali di vostra figlia Ada non hanno subito durante l'ulteriore degenza
favorevoli modificazioni, persistendo il suo particolare orientamento verso i familiari41.
Nella maggior parte dei casi il rinnovo della misura di sicurezza era ripetuto
per anni, a volte cessava solo con la morte della donna che vi era stata
sottoposta. Si tratta di casi in cui le protezioni familiari o comunitarie sono
306
completamente assenti o impossibilitate a intervenire nella vicenda, come nel
caso di Merien-bent Soleiman T.4* che fu reclusa nel manicomio giudiziario
di Aversa il io agosto 1933. La donna fu arrestata e incarcerata a Ben-gasi,
dalle autorità del governo coloniale italiano, perché nel febbraio 1933, Dopo
essere stata ricoverata per una notte in-casa della correligionaria Aiscia A., al
mattino si allontanava asportando alcuni ornamenti d'argento, oggetti da
mensa e da cucina, due paia di scarpe e tre baraccani. Gli oggetti furono trovati
poi a casa del marito della Meriem eccetto gli ornamenti, un baraccano di seta
e due paia di scarpe. La imputata è definita dal marito e dalla P. S. cleptomane
e deficiente ed è stata condannata un mese fa da questo Tribunale per altro
furto: confessò ai verbalizzanti e al pubblico Ministero, rispondeva cogli acuti
trilli abituali delle indigene e sollevava le vesti. Ritenuto che dalle prove
raccolte risulti avere l'imputata commesso il fatto ascrittogli. Ritenuto essere
evidente che la imputata ha commesso il fatto senza capacità di intendere in
seguito ad infermità psichica. Né occorre perizia per accertare la natura e la
designazione scientifica dell'infermità, tanto questa appare manifesta e totale
sia dalle informazioni assunte dall'autorità di P. S., sia dall'affermazione del
marito, sia - sovrattutto - dall'aspetto somatico e dal contegno dell'imputata,
non certo simulata. E tanto più pericolosa all'ordine sociale appare la donna, in
quanto attraverso l'oscuro disordine mentale sopravviene in essa il primordiale
istinto di rapacità che la spinge inconscia a rubare^. È da notare come il
tribunale di Bengasi fece propri alcuni discorsi della scuola positivista nel
trattare questo caso: l'origine etnica della donna equivaleva a uno stadio
primitivo di sviluppo umano che, paradigma della criminologia positivista, a
sua volta era insieme causa e manifestazione di una personalità delinquente.
Per lei non ci fu neanche bisogno di una perizia, ci dice la sentenza, perché la
sua infermità si manifestava in modo evidente nell'aspetto somatico. Non mi
soffermo in questa sede, perché già di recente discussa accuratamente in alcuni
lavori44, sulla questione di quanto sia proprio attraverso lo studio di casi come
questi che emergono con più forza alcune continuità tra scienza positiva e
scienza razzista elaborata dalla cultura fascista. Una continuità non solo
teorica, propria delle élites. culturali, ma anche tradotta praticamente in
dinamiche di esclusione e persecuzione dei soggetti considerati altri. In seguito
alla condanna la donna fu scortata da due agenti del governo coloniale e da
un'infermiera nel lungo viaggio da Bengasi ad Aversa, dove sarebbe dovuta
rimanere due anni. È annotato nel diario del ricovero:
Riferiscono costoro [i due agenti e l'infermiera di scorta] che durante il viaggio di
mare la internata è stata eccitata ed ha tentato la fuga malgrado fosse contenuta con
fascette. All'ammissione è in uno stato di eccitamento. [...] è provvista di
minuscoli buchi alle orecchie e tatuaggi. Si tenga isolata45,
307
Dopo qualche mese, l'ultima annotazione che la riguarda:
È apatica. Dorme la notte ravvolta solo nella coperta. Alla sera ripete monotonamente
parole in lingua araba come una cantilena46.
Era la fine del 1933. Da quel momento in poi non venne annotato altro nella
sua cartella clinica; solo che le fu prorogata per cinque volte l'assegnazione alla
misura di sicurezza e che il 7 novembre 1944, undici anni dopo, morì, ancora
reclusa nel manicomio giudiziario di Aversa, in seguito ad «arresto cardiaco».
Paradossalmente sono proprio le vicende di reclusione più lunghe quelle
che hanno lasciato meno tracce, che sono state registrate da anno-- tazioni scarne,
da silenzi lunghi anni. Come quella di Maria G.47 ammessa nel manicomio
giudiziario di Aversa nell'ottobre del 1935 in seguito all'assegnazione alla
misura di sicurezza per due anni per aver commesso atti osceni in luogo
pubblico. La donna proveniva dalla provincia di Como, era nubile e riguardo
alla sua condizione sociale il frontespizio della sua cartella clinica recitava:
«contadina nullatenente». Era stata accusata di aver avuto rapporti sessuali con
un uomo in un luogo esposto al pubblico; cosa che lei, come è scritto nel diario
del ricovero, ammise aggiungendo di essere convinta che «il fatto non fosse poi
così grave da essere condannata per questo»48. Il Tribunale penale di Como
stabilì che proprio in base alla sua mancanza di senso morale la donna non fosse
in grado di intendere e di volere durante il compimento dell'atto e quindi la
prosciolse e la assegnò a due anni di misure di sicurezza. Misure che anche nel
suo caso furono prorogate di anno in anno fino alla sua morte, avvenuta
nell'agosto del 1944, nove anni dopo. Totalmente assenti nella sua cartella
clinica tracce di corrispondenza con familiari o amici o anche annotazioni sul
diario del ricovero riguardanti il suo stato o eventuali terapie a cui fu
sottoposta. Storie di questo genere sono numerose.
Domenica C.49 entrò nell'istituto aversano il 2 febbraio 1938 all'età di 63
anni. La donna era vedova e proveniva dalla Sardegna dove faceva la
contadina. Processata per il «furto di un parapioggia» era stata prosciolta e
assegnata a una misura di sicurezza della durata di due anni da scontarsi in
manicomio giudiziario. Nel suo caso sul frontespizio della cartella clinica i
sanitari dell'istituto non si diedero neanche la pena di annotare le proroghe a
cui la donna fu sottoposta. Semplicemente una nota del luglio del 1947
segnalava la morte della donna dopo nove anni di reclusione.
Anche Evelina F.5° giunse ad Aversa, nel giugno 1933, per scontare due anni
di assegnazione alla misura di sicurezza. La donna, che viveva separata dal
marito in provincia di Chieti, era imputata di ubriachezza
308
abituale. Rimase, grazie a numerose proroghe, nel manicomio giudiziario di
Aversa per sedici anni. Fu dimessa nell'aprile del 1949 per essere trasferita nel
manicomio civile de l'Aquila.
Ancora: Luigia D.51, processata per oltraggio a pubblico ufficiale e
contravvenzione al divieto di mendicare, fu prosciolta e assegnata a due anni di
misura di sicurezza. Dalla cartella clinica è possibile sapere solo che viveva
vicino Cagliari, era nubile, aveva circa sessant'anni e mendicava per vivere. Morì
nel manicomio giudiziario di Aversa otto anni dopo esservi entrata, nel 1942.
Anna Maria B.51 arrivò ad Aversa nel giugno del 1938 in seguito all'imputazione
di aver provocato «lesioni personali in danno del seduttore». Assegnata anche
lei a due anni di misure di sicurezza, ne scontò nove. Anche lei era nubile,
contadina, nullatenente.
Ebbero tutt'altro esito le vicende delle donne che avevano una "funzione
sociale" più marcata, una rete parentale o comunitaria che sapeva esercitare
pressioni fin dentro il manicomio giudiziario. In un gioco di andata e ritorno la
famiglia sembra in queste vicende la causa e insieme la soluzione della
reclusione, sicuramente un soggetto in grado di dialogare e giocare con le
istituzioni. Una famiglia differenziata al suo interno, i cui membri assumevano
posizioni tra loro diverse.
Rosa E53 fu reclusa nel manicomio giudiziario di Aversa perché aveva tentato
di uccidere il marito. Arrestata nel gennaio del 1943 e condotta nelle carceri
giudiziarie di Grosseto, da lì, un mese dopo, fu trasferita ad Aversa dove rimase
per sei anni.
Coniugata da molti anni ha avuto 14 gravidanze e tre aborti. Sette figli sono deceduti per
malattie imprecisate dell'infanzia. Il marito da anni ha una relazione con altra donna
con la quale spende tutto il ricavato del proprio lavoro. A lei dava solo io lire
giornaliere ciò che non era sufficiente a tirare avanti la famiglia. Dovette subito mettere a
lavoro i figli per non farli morire di fame e tollerò per anni la tresca ma il marito invece
di esserle riconoscente la maltrattava spesso. In questi ultimi mesi la situazione si era fatta
più critica anche perché due figli, di cui uno militare, dovettero essere ricoverati in
sanatorio per T.b.c. Non ricorda nulla di come fece a ferire il marito e se abbia avuto lite
con lui. Dopo le hanno raccontato che quella mattina prese il rasoio che il marito aveva
poggiato su un tavolo e lo colpì. Non sa dire dove lo abbia colpito. In carcere i figli
l'hanno sempre seguita, confortata, visitata. Il marito al quale lei ha scritto, non si è mai
fatto vivo54.
La preoccupazione per la sopravvivenza dei figli sembra essere il tema intorno a
cui ha ruotato la vicenda della donna, ma proprio loro, con le lettere e i solleciti
presso la direzione dell'istituto, conservati nella cartella clinica, furono
straordinariamente presenti nell'esperienza di reclusione della madre. Il marito
in questo caso scomparve dalla scena sin dopo
309
l'arresto e di lui non si conservano tracce. Quando si trattò di dimettere Rosa F.
i sanitari la inviarono presso un figlio, in provincia di Arezzo.
In molte delle vicende su cui ho lavorato questo schema di posizionamento
dei figli rispetto ai padri e di entrambi rispetto alla reclusione della donna è
frequente: il marito, spesso oggetto della violenza della donna, diventava una
figura sbiadita e i figli assumevano una forte centralità nella vicenda che iniziava
con la reclusione della madre.
Carmela L." viveva a Sennino (in provincia di Roma) con il marito e quattro
figli. In seguito ai continui litigi con il marito - recita la sua cartella clinica cominciò a bere e «tale vizio l'ha condotta alla miseria e al furto, e ciò per potersi
procurare i mezzi per alimentare il vizio del bere»'6. Nel 19*54 fu processata per
avere ripetutamente sottratto a diverse persone, intf oducendosi nelle loro
abitazioni, biancheria, oggetti di cucina, cibarie. La d^nna fu prosciolta e
assegnata alla misura di sicurezza della durata di due anni da scontare in
manicomio giudiziario. Dall'interno dell'istituto la donna cercò da subito di
mettersi in contatto con il marito per avere informazioni sulle condizioni dei
figli ma l'uomo non le rispose mai, al punto che altri compaesani della donna
si risolsero a scriverle e darle informazioni. Numerose lettere, conservate
nella sua cartella clinica, testimoniano la forte rete di solidarietà che si attivò
intorno alla donna, e di cui quella che segue è una testimonianza significativa e
utile anche a illuminare alcuni aspetti della vicenda:
Ill.mo Sig. Direttore
è la seconda volta che la ricoverata in codesto manicomio, L. Carmela, si rivolge
a me per avere notizie sui figli e sul marito.
Alla prima lettera risposi direttamente perché le notizie, benché cattive,
lasciavano un filo di speranza che potessero migliorare; ma a questa seconda non ho il
coraggio di rispondere direttamente all'interessata, ed ho pensato di rivolgermi a Lei. Il
marito, sul quale io avevo qualche ascendente, convive con altra donna dalla quale, in
questi giorni, ha avuto anche un figlio, e della moglie non vuoi sentir parlare. [...] Dei
figli Antonio trovasi a Roma presso una Zia che gli ha procurato lavoro; Giuseppina è
col padre, ed Emilie l'ho in casa mia dove presta qualche piccolo servizio, ed è
provvisto di tutto. Lo mando anche a scuola che egli frequenta con amore, e spero di far
di lui un uomo onesto, utile a sé e agli altri57.
Con il passare dei mesi le condizioni di vita dei figli di Carmela L. subirono
notevoli peggioramenti. A questo punto la donna decise di scrivere di nuovo al
marito:
Signor Augusto
In questi giorni o' ricevuto una lettera di una persona, e con grande dispiacere o'
appreso quanto appresso. La mia figlia Giuseppina, è stata levata
310
dalla S. Annetta ed è stata portata in un altra casa, come donna di servizio, poi Emilio
che è stato levato dal S. Maestro e si trova in casa tua con la tua nuova moglie. Dunque,
non è che io scriva a te per ragione d'affetto, perché per te puoi immaginarti quanto sia
grande l'odio, dopo che ti ho saputo in braccio ad altra donna, tu puoi fare il tuo
comodo, ti lascio libero di dare il tuo affetto falso a chi vuoi perché di me non sei più
degno. Però quello che o' di rimproverarti è il modo in cui tratti i tuoi figli. [...] La
Giuseppina stava benone dove si trovava, e tu l'ai levata di là per mandarla a rovinarsi
in un altra casa, schiava a dieci anni, costretta a guadagnarsi un pezzo di pane, con le
piccole braccia, ti auguro solo che il sudore che scorrerà su quella fronte possa un
giorno convenirsi in sangue sulla tua di padre snaturato. Il piccolo Emilio si trovava
dal maestro, e stava bene tu te lo sei preso in casa con te senza mandarlo a scuola,
sotto la sorveglianza di una seconda moglie, forse privo di sfamarsi e per di più non l'ai
mandato nemmeno alla prima Comunione. [...] Mio figlio Antonio è partito per la Libia,
anche questo è causa tua esso si vergognava di avere un padre simile a te, preferiva
andare lontano forse per dimenticare le tempeste e le pene che sempre sono nella
nostra famiglia. [...] Ti ringrazio di tutte le lettere che mi ai scritto, nemmeno un rigo,
ma non me ne importa'8.
Negli ultimi tempi della reclusione di Carmela L. riappare il figlio Antonio,
evidentemente tornato dalla Libia.
Ill.mo Sig, Direttore
ho saputo che mia madre L. Carmela è guarita e che desidererebbe tornare a Sennino.
Io Sig. Direttore ho gran desiderio di averla con me, così si ricostituisce la famiglia,
almeno in parte perché su nostro padre non c'è più da far conto, e io vivo insieme con
un altro fratellino di dodici anni. Il lavoro non mi manca, e mi auguro che anche mia
madre possa fare qualche cosa, ma se anche non lo potesse ci sarò sempre io per
mantenerla. Ci basta di trovare la casa aperta e una persona che con la sola sua presenza ci
faccia trovare lieto il lavoro, perché quello lavoro servirà pure per mantenerla. Nella
speranza di una risposta favorevole La ossequio profondamente
M. Antonio di Augusto'9.
Un mese dopo, allo scadere della durata della misura di sicurezza cui era stata
assegnata, Carmela L. fu dimessa. Si recò a Sennino da suo figlio Antonio.
A provocare la revoca della misura di sicurezza piuttosto che la sua proroga
poteva concorrere anche il riconoscimento della funzione familiare e sociale
della donna reclusa.
Ida L.6° fu condotta nel manicomio giudiziario di Aversa nel novembre del
1934. Era una donna di 36 anni, viveva a Perugia con il marito e i tre figli, e
faceva la sarta. Era imputata di tentata estorsione. Il processo si concluse nel
settembre del 1934 con il proscioglimento per vizio totale di mente e
l'assegnazione di Ida L. a un manicomio giudiziario per non
311
meno di due anni. Dal manicomio civile di Perugia, luogo dove la donna transitò
prima di essere trasferita ad Aversa, provengono i documenti che raccontano la
sua storia:
Sappiamo che la Paziente fu arrestata perché autrice di lettere minatorie scritte ed inviate
con sistemi puerili. La Paziente richiedeva somme di denaro che dovevano essere depositate
in luoghi prossimi alla sua abitazione, minacciando i destinatari (parenti e conoscenti), di
gravi rappresaglie. Quasi mai si recò a ritirare le somme. Fu scoperta facilmente per il
puerile sistema adottato. [...] All'ingresso in questo Ospedale si presentava tranquilla,
lucida, un po' triste, ma ben orientata. Rispose bene a tutte le domande, mostrandosi
molto addolorata del mal fatto. [...] Le notizie anamnestiche sono fornite dalla Paziente
stessa. [...] La Paziente Sposò a 23 anni con uomo sano, dal quale ebbe tre gravidanze a
termine. I figli s'tanno bene; l'ultimo però è molto nervoso. [...] La Paziente ci riferisce
che dal giorno che ha sposato non è stata più bene di testa: le contrarietà della famiglia
al matrimonio, le gravidanze laboriose e dolorose, il marito disoccupato e ubriacone
[particolare esatto, N.d.R.] avevano tentato la sua abituale tranquillità: la Paziente si
sentiva spesso colpita da tristezza e sconforto incolmabile che male compensava col
grande affetto verso la famiglia. Più volte ha sentito che la testa non le voleva stare più a
posto. Da qualche settimana le venne la paura che la famiglia sarebbe presto morta di
fame per mancanza di mezzi; ossessionata da questa idea, il pensiero dei figli, del
marito, dello sfacelo di tutto, la spinse a tentare di procurarsi il denaro in un modo
poco onesto ma che riteneva quasi certo; scrisse lettere minatorie a persone conoscenti
invitandole a depositare i soldi al Pincio, una sola volta si recò al posto sopra indicato*1.
Ida L. era evidentemente la figura intorno a cui ruotava l'economia
familiare, con tutto il suo carico di responsabilità e preoccupazioni. Dalle
lettere conservate nella sua cartella clinica si deduce che questa
centralità rimase intatta anche mentre era reclusa:
Ill.mo Sig. Comm.re
Direttore Manicomio Giudiziario - Aversa
Io sottoscritto V. Domenico padre di tre figli con i genitori avanzati di età oltre 80
anni, mi trovo in condizioni meschinissime, privo della cara e adorata moglie Ida L. in
V., trovansi costà per scontare questa poca pena; raccomando gentilmente alla S. V.
Ill.ma affinchè si compiaccia farmi sapere il termine della sua permanenza costà, ed il
motivo perché non mi scrive, tanto che per l'amore dei figli e dei miei cari genitori. Vorrà
perdonare ma è circa un anno che soffriamo della sua lontananza, ed i miei figli 3 piccini
non fanno che piangere e chiamare la loro cara mamma61.
A Ida L. fu revocata la misura di sicurezza meno di un anno dopo essere stata
internata ad Aversa e, quindi, con un anno di anticipo rispetto al termine
fissato. Evidentemente il fatto che la donna fosse indispensabile alla sua
famiglia ne determinò la scarcerazione anticipata.
312
Sono molto numerosi i casi che potrei citare in cui la misura di sicurezza
fu revocata al suo scadere con un riferimento esplicito alla possibilità della
donna di essere accolta dalla famiglia o alle pressioni esercitate dai congiunti
sulla direzione del manicomio.
Ida R.63 aveva 34 anni quando fu trasferita dalle carceri giudiziarie di Venezia al
manicomio giudiziario di Aversa, nel gennaio del 1934, per scontare due anni di
assegnazione alle misure di sicurezza per aver sparato due colpi di rivoltella
contro il suo fidanzato che aveva voluto interrompere la relazione. La donna
era originaria di Palermo ma viveva da molti anni con il fratello a Venezia, dove
faceva l'impiegata. È da notare che l'esiguità della pena cui fu sottoposta la-donna
era in origine motivata dal fatto che la Corte riconobbe che la donna aveva
sparato per difendere il suo onore, dal momento che si era "concessa" al suo
fidanzato solo a fronte di una promessa di matrimonio che poi non fu rispettata.
Durante la sua permanenza ad Aversa, che durò quasi due anni, Ida R. ebbe
corrispondenze continue con le amiche e i familiari. Di lei ci ritorna
l'immagine di una donna inserita in una fitta rete di relazioni che si conservò e
la sostenne anche durante l'esperienza della reclusione. In particolare affiora un
forte legame con il fratello e con una sorella, che probabilmente viveva a Napoli, e
che si fece carico di andarla a trovare tutte le settimane portandole cibi e
vestiario. Il fratello, evidentemente consapevole di quali erano le vie per evitare il
rinnovo della misura di sicurezza, una volta scaduto il termine minimo
assegnato dal tribunale si preoccupò di scrivere per tempo alla direzione del
manicomio di Aversa:
Quale unico fratello che possa interessarsi della sorte di questa sventurata sorella, mi
viene spontaneo il domandare se tale provvedimento è di competenza di tale
onorevole Istituto e se ha carattere a tempo indeterminato, acciocché io possa
intercedere, qualora fosse possibile l'estinzione di detta misura di sicurezza che a lungo
andare potrebbe portare nuocimento all'avvenire stesso di mia sorella64.
La donna fu liberata addirittura qualche mese prima che scadesse il termine
della misura di sicurezza a cui era stata assegnata.
Come lei Maggiorina C.6', prosciolta dall'imputazione di lesioni
personali aggravate e assegnata per tre anni al manicomio giudiziario di
Aversa. Allo scadere della misura la donna fu dimessa e mandata dalla sorella
ad Alessandria; e così Adelia P.6fi, anche lei imputata di lesioni gravi e assegnata a
due anni di misura di sicurezza, che ben prima del termine della misura fu
dimessa e condotta a Cremona dalla famiglia.
In conclusione di questo lavoro vorrei fare alcune considerazioni e alcune
precisazioni. Il materiale documentario conservato nel manicomio giudiziario di
Aversa, proprio per la sua ricchezza e per la quasi assenza di studi su di esso,
credo si presti a molteplici letture e utilizzi. Come ho
313
già anticipato, mi ha interessato in primo luogo indagare i modi in cui le
misure di sicurezza, che hanno rappresentato forse la continuità più forte tra
cultura positivista e fascismo in campo giuridico, siano state concretamente
messe in atto. In particolare volevo capire come ha agito, all'interno della
giustizia penale, quel criterio di discrezionalità sancito di diritto per la prima
volta dal Codice penale del 1931. Volevo inoltre affrontare la questione di
quanta rispondenza ci fosse tra il modello teorico di donna criminale elaborato
dalla criminologia positivista e le dinamiche concrete di reclusione. Credo che
le vicende in parte riportate e i dati raccolti riassumano meglio di quanto io
stessa possa fare alcune risposte a questi interrogativi; mi sembra opportuno,
tuttavia, sottolineare alcuni elementi.
II fatto che ad essere recluse fossero soprattutto donne appartenenti alle
classi più povere della società o che le ammissioni e dimissioni fossero
fòrtemente connesse alla presenza o assenza di reti familiari non è una novità
del manicomio giudiziario. Le stesse dinamiche di internamento o ricovero
hanno regolato sia in età moderna che in età contemporanea altri istituti
assistenziali o di reclusione: le case di correzione, i collegi, i manicomi civili,
gli ospizi, i conservatori ecc. La novità introdotta dai manicomi criminali e
poi dalle misure di sicurezza è, a mio avviso, quella di aver immesso
all'interno della giustizia penale la possibilità di ampliare una pena a
dismisura o di contenerla basandosi non più sull'entità del reato commesso ma
sulla personalità della donna e dell'uomo criminale.
Uno degli elementi più significativi che è emerso da questo lavoro di
ricerca è il fatto che se si guarda al rapporto tra reato e pena la disarticolazione tra questi due elementi, la discrezionalità, è evidente sia in una
direzione che nell'altra: molte donne furono recluse per anni e anni ad Aversa
solo per aver, in origine, commesso un furto; altre donne scontarono appena
due anni di reclusione dopo aver sparato colpi di arma da fuoco contro il loro
"fidanzato". In entrambi i casi stiamo parlando di donne provenienti dalle
classi più povere della società. Chi era socialmente pericolosa e chi no?
Da quanto è emerso sembra che le donne che vennero ritenute pericolose
fossero quelle non integrate in un contesto familiare o comunitario forte e quelle
che commisero crimini che le resero distanti dal modello di femminilità
condiviso dalla cultura positivista e fascista. A questo proposito vale la pena
sottolineare che a fronte delle giovani donne, come abbiamo visto, che
avevano sparato contro il proprio seduttore per difendere l'onore e che
scontarono due anni di assegnazione alla misura di sicurezza, c'erano donne
che, processate per procurato aborto, come Maria M/7, o per aver tentato di
uccidere la figlia, come Cosima P.68, scontarono nel manicomio giudiziario di
Aversa la prima sette e la
314
seconda dodici anni di reclusione. Vorrei sottolineare che i casi che si
potrebbero citare per l'una e per l'altra voce sono numerosi e, inoltre, che a
tutte e tre le donne furono assegnati in prima battuta due anni di
misura di sicurezza.
A me sembra, quindi, che le variabili da tenere in considerazione per
comprendere i criteri di applicazione delle misure di sicurezza siano tante: la
condizione economica, quella sociale e familiare, la tipologia di ,, reato
commesso in relazione ai valori condivisi dalla società.
Quelli qui presentati sono solo alcuni spunti maturati nell'ambito di
una ricerca che non ha la pretesa di essere esaustiva. Molte questioni e
possibili domande rimangono aperte. Il materiale documentario conservato
nelle cartelle cliniche potrebbe essere una fonte per ricerche che partendo
dall'interno delle mura manicomiali sappiano interrogarsi sulla realtà sociale
di quegli anni: ci dicono molto, ad esempio, della vita quotidiana di uomini e
donne, delle dinamiche interne a una comunità, delle modificazioni prodotte
dal fascismo e dalla guerra nel tessuto sociale e nelle dinamiche familiari.
Accedere a un archivio e a un argomento poco esplorato mi ha messo di
fronte a un terreno sconfinato di domande, suggestioni, spunti. Ho scelto di
concentrare l'elaborazione dei dati e delle informazioni raccolti su una
questione, quella del funzionamento delle misure di sicurezza in relazione
alle esperienze femminili di reclusione, perché mi è sembrato il terreno più
fertile per mettere alla prova il modello teorico della criminologia positivista
nella sua relazione con la gestione della giustizia penale.
Note
1.1 riferimenti bibliografici dei lavori sopra citati sono: V. Fiorino, Matti, indemoniate e
vagabondi. Dinamiche ài internamento manicomiale tra Otto e Novecento, Marsilio, Venezia
2002; L. Roscioni, II governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell'età moderna, Bruno
Mondadori, Milano 2003; M. Gibson, Naft per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della
criminologia biologica, Bruno Mondadori, Milano 2004; "Genesis. Rivista della Società
Italiana delle Storiche", n. 2, 2003. Per quanto riguarda i panel mi riferisco in particolare a:
Scienze sociali e costruzione dello spazio pubblico italiano tra le due guerre mondiali, coordinato
da Francesco Cassata, all'interno di "Cantieri di Storia. Secondo incontro Sissco sulla
storiografia contemporanea italiana" (Lecce, 25-27 settembre 2003); e a quello La costruzione
delle allenta. Matti, travestiti, neri e meridionali (secoli XIX e xx), coordinato da Vinzia Fiorino,
all'interno del terzo "Congresso della Società Italiana delle Storiche" (Firenze, 14-16 novembre
2003).
2. La stessa istituzione ha assunto nel corso della sua storia nomi diversi: alle origini, «sezioni
per maniaci»; con il Regolamento generale delle carceri del 1891, «manicomi criminali»; con
la legge Giolitti del 1904, «manicomi giudiziari»; oggi, «ospedali psichia trici giudiziari». In
questo lavoro ho prevalentemente optato per i termini «manicomio criminale» prima e
«manicomio giudiziario» poi, perché erano quelli adottati nei periodi a cui mi riferisco.
3. In Italia sono pochi gli studi dedicati alla storia dei manicomi giudiziari. Alcuni
315
lavori che trattano più o meno approfonditamente il tema sono: R. Villa, "Pazzi e criminali":
strutture istituzionali e pratica psichiatrica nei manicomi criminali italiani, (1876-1915), in
"Movimento operaio e socialista", 1981; F. Stock, La formazione della psichiatrìa, II Pensiero
Scientifico, Roma 1981; R. Canosa, Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi, Feltrinelli,
Milano 1979.
4. Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi approvato
con R.D. n. 260 il i° febbraio 1891.
5. Solo con la legge Giolitti del 1904 l'esistenza dei manicomi criminali fu sanzionata di
diritto: la direzione degli istituti fu affidata ai medici e il mantenimento dei prosciolti fu messo a
carico delle province.
6. Ad oggi l'unico studio analitico dedicato ai primi decenni di funzionamento dei
manicomi criminali è ancora Villa, "Pazzi" e "criminali", cit.
7. I manicomi giudiziari furono istituiti tra il 1850 ed il 1870 in Inghilterra, Irlanda,
Germania, Francia; il primo manicomio giudiziario degli Stati Uniti, quello di Auburn,
, fu aperto nel 1855.
8. Cfr., a titolo di esempio, G. Virgilio, Sulla istituzione dei manicomi criminali in Italia, in
"Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali", 1877; C.
Lombroso, Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia, in "Rendiconti del Reale Istituto Lombardo
di Sciente, Lettere e Arti", 1872; A. Tamburini, I manicomi criminali, in "Rivista di Discipline
Carcerarie", 1873.
9. Non mi soffermo qui, per motivi di spazio, sulle caratteristiche dell'uomo e della donna
delinquenti tratteggiate dall'antropologia criminale, su cui esiste una nutrita bibliografia.
10. Per quanto riguarda il dibattito tra alienisti e giuristi alla fine dell'Ottocento cfr. C. Livi, I
periti alienisti nel foro (lettera alProf. Comm. F. Carrara), in "Rivista sperimentale di Freniatria e di
Medicina legale in relazione con l'Antropologia e le Scienze giuridiche", 1875; F. Carrara, I periti
alienisti nel foro. (Risposta alla lettera delprof. C. Livi), in "Rivista sperimentale di Freniatria e di
Medicina legale in relazione con l'Antropologia e le Scienze giuridiche", 1875; G. Ziino, Sulle cause
che escludono e diminuiscono l'imputabilità secondo l'ultimo progetto di Codice penale, Napoli 1874;
A. Tamassia, // nuovo codice penale italiano e la pazzia parziale, in "Rivista sperimentale di Freniatria
e di Medicina legale in relazione con l'Antropologia e le Scienze giuridiche", 1876. Per
un'accurata ricostruzione storica di questi temi e per una ricca bibliografia cfr. V. P. Babini, La
responsabilità nelle malattie
mentali, in V. P. Babini, M. Coletti, F. Minuz, A. Tagliavini, Tra sapere e potere. La psichiatrìa italiana
nella seconda metà dell'Ottocento, II Mulino, Bologna 1982, pp. 135-98.
n. Gibson, Nati per il crimine, cit., p. 180.
12. Per alcune note biografiche riguardanti Martino Beltrani Scalia cfr. Dizionario
biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1966, voi. vili, pp 80-2 e A. Boria,
Martino Beltrani Scalia, in "Rivista di discipline carcerarie", 1909, pp. 90-4.
13. Cfr. M. Beltrani Scalia, II sistema penitenziario d'Inghilterra e d'irlanda, Roma 1868.
14. "Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo studio
dell'uomo alienato e delinquente", fondato nel 1880 da Cesare Lombroso.
15. A proposito del ruolo svolto dai musei criminali, di polizia scientifica, di antropologia
criminale, dalle esposizioni, dalle gallerie fotografiche, dalle mostre come efficaci strumenti di
diffusione della criminologia positivista, cfr. G. Colombo, La scienza infelice. Il Museo di
antropologia criminale di Cesare Lombroso, Bollati Boringhieri, Torino 2000; A. Borzacchiello
(a cura di), Museo crìminologico, Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Roma 2003; U.
Levra (a cura di), La scienza e la colpa. Crìmini, criminali criminologi: un volto dell'Ottocento,
Electa, Milano 1985; A. Gilardi, Wanted! Storia, tecnica ed estetica della fotografia criminale,
segnaletica e giudiziaria, Bruno Mondadori, Milano 2003.
16. In riferimento all'importanza ricoperta dalle ricerche in archivio, dall'interesse
316
storiografico per l'internamento e non più solo per l'istituzione, anche come elementi che hanno
contribuito a riorientare le letture storiografiche «dell'età del positivismo», cfr. Fiorino, Matti,
indemoniate e vagabondi, cit., pp. 7-23 e l'Introduzione, a cura di Giovanna Fiume, al numero
monografico Manie della rivista "Genesis", cit., pp. 5-16.
17. Le cartelle cliniche precedenti al 1900 sono andate probabilmente perse in seguito al
terremoto del 23 novembre 1980. Le cartelle sono prevalentemente accatastate su alcuni scaffali
e ordinate, ma non tutte, per anno di dimissione o morte della persona reclusa. Per accedere
all'archivio bisogna ottenere un apposito permesso dal Ministero della giustizia.
18.È parere condiviso a livello storiografico che il Codice Rocco sia ispirato in alcune sue parti
al principio, di origine illuminista, della proporzione tra pena e reato e in altre sia invece ispirato
al principio, di origine positivista, della difesa sociale e quindi saldi la pena al reo.
19. Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. La pericolosità sociale è definita
dagli articoli 102,103,105, 108, 133, 203. Vale la pena rileggere alcuni passaggi, l'art. 203 così
recita: «Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile
o non punibile, [...] quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati»
(corsivo mio). Nell'articolo 133, dopo che nell'articolo precedente era stato fissato il potere
discrezionale del giudice - nei limiti della legge – per quel che riguardava l'applicazione della pena,
si dice che nell'esercitare questa discrezionalità il giudice deve tenere conto «della capacità a
delinquere del colpevole, desunta: i) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai
precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
[...] 4) dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo».
20. Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, titolo vili, Delle misure
amministrative di sicurezza, artt. 199-240.
21. Ivi, art. 207.
22. Ivi, art. 208.
23. A titolo di esempio cfr. Babini, II lato femminile della criminalità, cit.
24. Per quanto riguarda l'altro estremo della periodizzazione scelta, mi sono spinta fino agli
anni dopo la seconda guerra mondiale e non oltre per motivi "deontologici", non potendo e non
volendo accedere a informazioni molto riservate di donne probabilmente ancora viventi. Vale la
pena ricordare, per inciso, che il manicomio giudiziario era "aperto" anche ai e alle minori di anni
quattordici.
25. Gli indici degli internamenti nel manicomio giudiziario di Aversa, come di tutti i
manicomi italiani, sono stati pubblicati dalla "Rivista Sperimentale di Freniatria" per gli anni fino
al 1942; gli indici degli anni successivi furono, invece, pubblicati dalla rivista "II lavoro
neuropsichiatrico".
26. In concreto: le cartelle cliniche conservate nell'archivio storico del manicomio
giudiziario di Aversa sono ordinate per anno di dimissione o morte della detenuta. Ho visionato
un numero maggiore di cartelle cliniche, ma quelle trascritte sono, come ho detto, 300, vale a dire
un quarto di quelle relative al periodo preso in esame.
27. Riguardo questi dati bisogna fare due precisazioni: in primo luogo che la distinzione
tra contadine e casalinghe è spesso casuale, dal momento che la maggior parte delle donne dedite
ai lavori campestri si occupava anche dell'andamento della casa; in
secondo luogo sono molto rari i casi in cui la voce casalinga o contadina non sia associata a quella
«nullatenente». In questa sede ho riportato però la voce specifica «nullatenente» riferendomi alle
donne a cui era attribuita solo questa dicitura.
28. Altri reati degni di nota per la loro rilevanza sono: oltraggio a P. U., contravvenzione al
Regolamento di P. S., atti osceni in luogo pubblico, infanticidio.
29. In particolare mi riferisco a M. Gibson, Le carceri femminili nell'Italia liberale, in
"Storica", 2000; T. Pitch (a cura di), Diritto e rovescio. Studi sulle donne e il controllo sociale,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987.
317
Archivio storico del Manicomio giudiziario di Aversa (da qui in poi asmga). La data di uscita di
Carmela Z. è 19.8.1942.
30. Estratto della sentenza nel procedimento penale del Tribunale civile e penale di
Belluno contro Z. Carmela, p. 2, conservata nella sua cartella clinica.
31. Lettera del 6 marzo 1941, conservata nella cartella clinica di Carmela Z.
32. ASMGA, trasferita all'ospedale psichiatrico civile di Aversa il 5.10.1944.
33. Diario del ricovero, 2.10.1941.
34. Relazione della casa di cura "Abetina", 18.10.1941.
35. Ibid.
36. Diario del ricovero, 2.10.1941.
37. Ibid.
38. Relazione manicomio civile di Ancona, 30.9.1941.
39. Diario del ricovero, 2.10.1941.
40. Lettera, 18.1.1945.
41. asmga, deceduta il 7.11.1944.
42. Sentenza del tribunale di Bengasi, 27.2.1933. Corsivo mio.
43.
44. In particolare cfr. G. Israel, P. Nastasi, Scienza e razza nell'Italia fascista, II Mulino,
Bologna 1998 e A. Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia, II
Mulino, Bologna 2000.
„
45. Dal Diario del 20.8.1933.
46. Dal Diario del 20.12.1933.
47. ASMGA, deceduta il 28.8.1944.
48. Dal Diario del ricovero del 6.10.1935.
49. asmga, deceduta il 3.7.1947.
50. asmga, dimessa il 5.4.1949.
51. asmga, deceduta il 27.3.1942.
52. asmga, dimessa il 19.7.1947.
53. asmga, dimessa il 13.6.1949.
54. Dal Diario del ricovero, 9.2.1943.
55. ASMGA, dimessa I'i.6.i935.
56. Questionario inviato alla stazione dei R.R .C.C. di Sennino il 14.6.1933.
57. Lettera del 24.11.1933.
58. Lettera senza data.
59. Lettera del 18.9.1934.
60.
61. asmga, dimessa il 19.10.1935.
62. Relazione-medica, ospedale psichiatrico interprovinciale dell'Umbria, 23.3.1935.
63. Lettera del 19.5.1935.
64. asmga, dimessa il 16.10.1935.
65. 64.
Lettera ricevuta dalla Direzione del Manicomio giudiziario di Aversa il
21.101935.
66. asmga, dimessa il 21.3.1935.
67. asmga, dimessa il 3.11.1938.
68. asmga, dimessa il 7.9.1946.
69.asmga, deceduta il 22.1.1943.
318