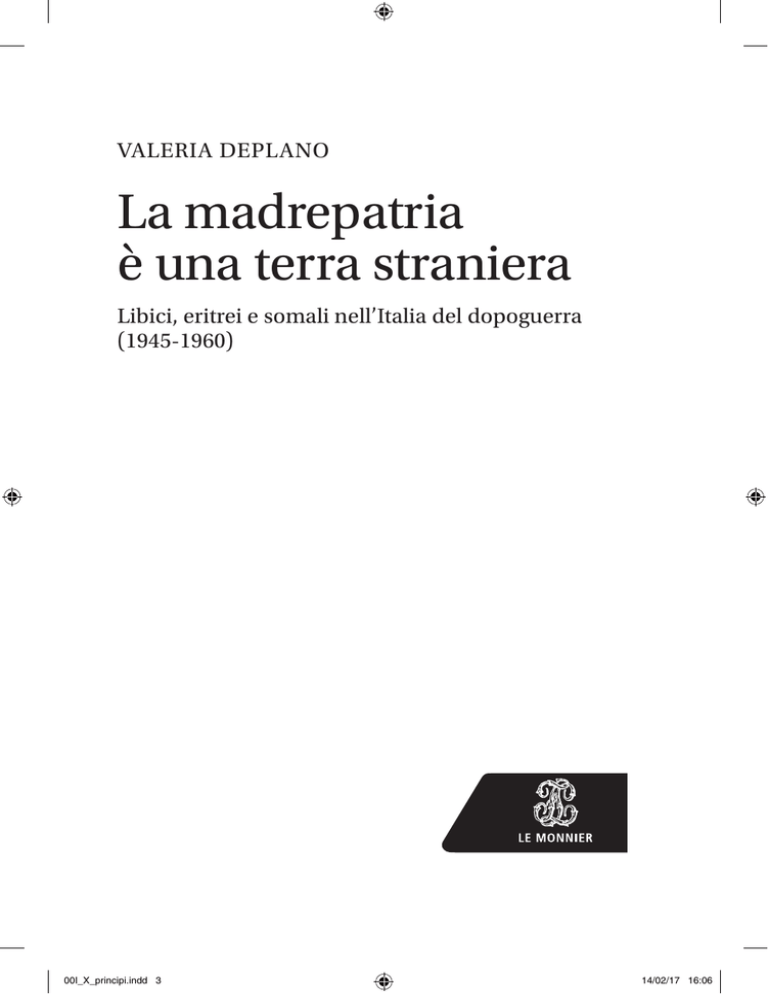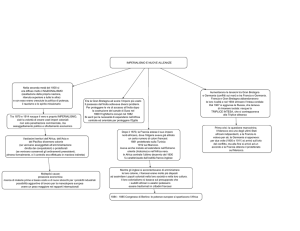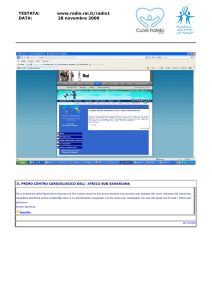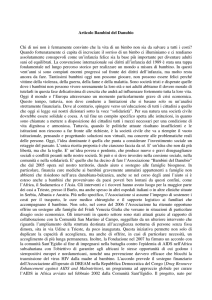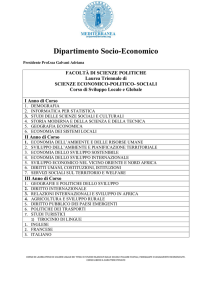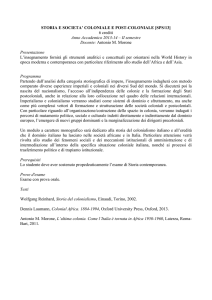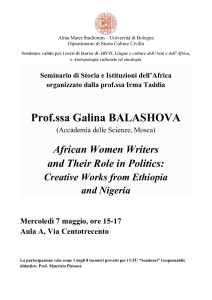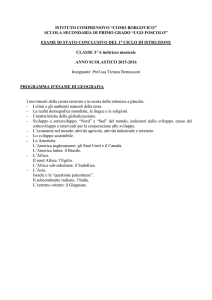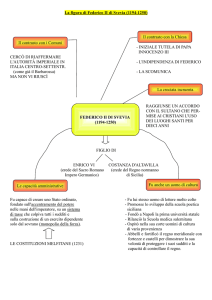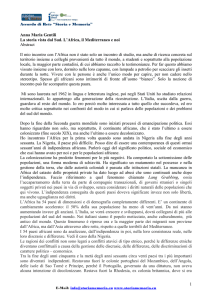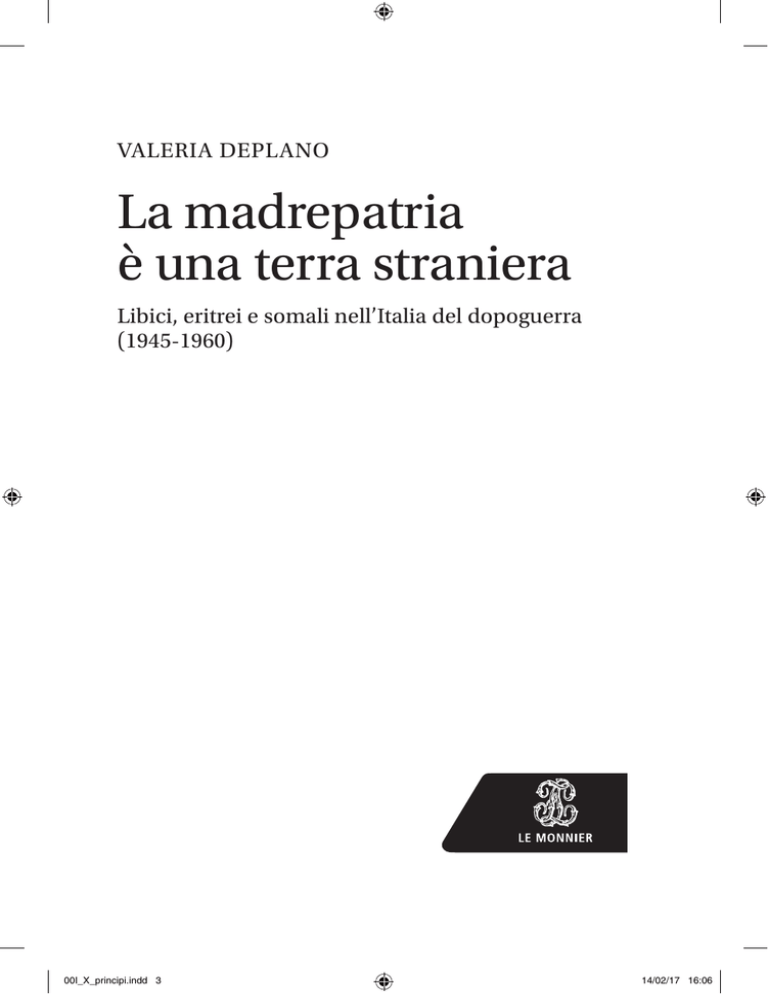
VALERIA DEPLANO
La madrepatria
è una terra straniera
Libici, eritrei e somali nell’Italia del dopoguerra
(1945-1960)
00I_X_principi.indd 3
14/02/17 16:06
1
(Ex) sudditi.
Libici, eritrei, somali
ed etiopici in Italia
Nel corpo bianco della nazione. Sudditi coloniali
nel Regno d’Italia
Incontri coloniali
Il colonialismo implica sempre, necessariamente, il contatto tra persone, storie, società, e ha come esito la loro contaminazione. Questo
fatto lo rende un fenomeno fortemente contraddittorio: esso, infatti, si
fonda su una netta contrapposizione tra colonizzatori e colonizzati e
sull’imposizione dei primi sui secondi; all’interno della società coloniale i rapporti sono concepiti in maniera gerarchica, in termini di oppressione, di disuguaglianza e di differenza incommensurabile.
D’altra parte, in ogni sua manifestazione l’espansionismo coloniale si è reso responsabile della produzione di realtà nuove, diverse e in
fondo incompatibili con l’idea di identità forte e monolitica sulla base
della quale, dalla fine dell’Ottocento, gli europei avevano legittimato
le aggressioni militari e le occupazioni di territori altrui. Tale attitudine è particolarmente evidente se si guarda agli incontri privati e intimi
tra colonizzatori e colonizzati: frutto di questo genere di unioni, il più
delle volte anch’esse diseguali e violente, sono persone che portano sul
proprio corpo e nelle proprie vite la prova evidente della capacità trasformatrice degli incontri coloniali. Allo stesso modo l’innesto di popolazioni bianche ed europee nelle società africane ha determinato ibridazioni culturali, linguistiche e sociali1.
Tra tutti gli incontri, quello che i colonizzatori temevano maggiormente, la contaminazione che cercarono di evitare il più possibile, fu
quella che poteva modificare dall’interno le loro, di società, attraverso
l’ingresso di persone provenienti dai territori colonizzati. Anche in questo caso le resistenze si dimostrarono inutili. L’imperialismo fu responsabile della creazione di un nuovo spazio di mobilità reale e immagi23
023_086_cap_1.indd 23
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
nato, destinato a sopravvivere al crollo degli imperi, che facilitò i flussi
migratori dall’Asia e dall’Africa verso il vecchio Continente2.
Fu solo dopo il 1945 che le migrazioni coloniali portarono in Europa gruppi consistenti di persone, che penetrarono in maniera evidente i
confini territoriali e le barriere identitarie degli ormai ex colonizzatori.
Ma fin dalla prima metà del Novecento la possibilità di percorrere i corridoi creati dal colonialismo in senso inverso, dalla supposta periferia
verso il centro coloniale, aveva consentito l’insediamento sul territorio
europeo delle prime comunità di colonizzati. Fu allora che si manifestarono per la prima volta le difficoltà di alcune società del vecchio Continente a fare i conti con «l’altro» in casa propria. Sopratutto nei casi inglese e francese la marginalizzazione dei migranti è come un fenomeno
di lunga durata, ben radicato nella storia novecentesca.
In Francia ad esempio, durante la prima guerra mondiale, gli uomini impiegati nel conflitto furono in parte sostituiti con lavoratori provenienti dal Maghreb, tra cui circa 119.000 algerini sbarcati nel Paese
nel 1919. Il numero dei migranti crebbe tra le due guerre; oltre al Nord
Africa gli spostamenti iniziarono a coinvolgere anche gli altri possedimenti, al punto che nel 1946 risultavano sul suolo francese circa tredicimila persone provenienti dall’Africa subsahariana, senza contare i
numerosi «clandestini» che negli anni avevano potuto raggiungere la
madrepatria in maniera non ufficiale senza troppe difficoltà. Da subito
queste comunità dovettero fronteggiare una diffusa ostilità da parte delle popolazione e delle autorità francesi3. Anche in Gran Bretagna, dove
negli anni Ottanta dell’Ottocento era stato eletto il primo indiano alla Camera dei Comuni4, tra le due guerre mondiali si erano formate le
prime comunità di marinai di origine africana e orientale, insediate in
alcune zone portuali. In queste aree nel 1919 si verificarono attacchi e
sollevazioni di natura razzista, che ebbero come vittime i migranti accusati di essere una minaccia per l’occupazione dei locali5.
Invece in Italia, nel periodo tra i due conflitti mondiali, mancavano
consistenti comunità di migranti coloniali. Se guardato con gli occhi di
uno dei suoi colonizzati, alla vigilia dell’entrata in guerra del 1940 il
Paese appariva anzi come una fortezza quasi impenetrabile: steccati giuridici e culturali erano stati innalzati negli anni, prima dai governi liberali e poi da quello fascista, rendendo il territorio italiano progressivamente impermeabile alle popolazioni sottoposte al dominio coloniale.
La presenza degli africani, già rara già nei primi trent’anni del secolo,
divenne assolutamente eccezionale dopo la proclamazione dell’Impero,
nel 1936, quando il pregiudizio razzista fu assunto come base della le24
023_086_cap_1.indd 24
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
gislazione nazionale. A quel punto per il regime diventò fondamentale
preservare una omogeneità interna, che era presentata come un tratto
distintivo della comunità nazionale: nell’idea di Mussolini tanto il corpo della nazione quanto il suo territorio erano e dovevano restare bianchi. Vedremo nel prossimo capitolo come, mentre affinava gli strumenti
giuridici per evitare definitivamente che africani e degli italo-africani ottenessero la cittadinanza italiana, allo stesso tempo il regime scoraggiava l’accesso nel Paese di persone provenienti dalle colonie.
La negazione ai sudditi del suolo italiano colpì anche i militari nativi delle colonie: gli ascari, che pure avevano combattuto tutte le guerre condotte dall’Italia dall’occupazione della Libia in poi, non furono
mai utilizzati sulla Penisola e la loro presenza nel territorio della madrepatria – a parte alcuni casi eccezionali – fu limitata alle cerimonie e
ai cambi della guardia.
Il tentativo di mantenere il territorio «bianco e omogeneo» non impedì, tuttavia, che anche in Italia e anche sotto il regime fascista alcune
decine di sudditi coloniali giungessero nel Paese, per forza o per scelta,
di passaggio o per restarvi. È nel corso di questi primi incontri coloniali
che alcuni italiani, al pari del governo, dovettero fare i conti con «l’impero che tornava indietro», misurando sia le proprie reazioni sia le possibilità di coesistenza, situazioni e problemi che sarebbero stati affrontati, in maniera più ampia, dopo il 1945.
La visita del 1912 a Roma e Napoli del V battaglione ascari, reduce
dalla guerra di Libia, rappresenta forse il primo e il più eclatante incontro degli italiani con i sudditi coloniali. La visita, organizzata dal governo italiano, era stata pensata non solo per celebrare la vittoria libica,
ma anche per contribuire al processo di nazionalizzazione degli italiani,
suscitando in loro, attraverso la celebrazione delle conquiste coloniali,
un senso di orgoglio patriottico. In questo caso l’intento del governo
non era di creare una identità ‘per contrasto’, che esaltasse l’italianità
contrapponendola all’«alterità» degli ascari. L’obiettivo era invece quello di insistere sui punti di contatto tra la nazione e quei valorosi e ‘civilizzati’ soldati eritrei6. Gli ascari furono sovraesposti mediaticamente, e
l’ondata di simpatia sollecitata nei loro confronti trascinò nelle strade,
ad accoglierli, una folla effettivamente entusiasta.
Negli stessi anni approdarono in Italia, in maniera ovviamente molto più silenziosa e triste, i primi deportati coloniali. Si trattava degli oltre tremila libici che furono confinati nel Paese durante e dopo la guerra
di occupazione del territorio nordafricano7. La pratica di rendere permeabili i confini della nazione ai sudditi in stato di prigionia, di depor25
023_086_cap_1.indd 25
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
tarli in Italia cioè, proseguì anche col fascismo. In quel caso colpì circa
duecento etiopici appartenenti alle famiglie più in vista dell’ex impero
di Haile Selassie, compreso un cugino dell’imperatore. Ritenuti da Rodolfo Graziani e da Mussolini responsabili delle cospirazioni che avevano portato all’attentato contro il viceré ad Addis Abeba, nel febbraio
del 1937, furono deportati in Italia e confinati per due anni nei pressi
di Roma, all’Asinara, a Ponza, a Mercogliano, a Longobucco, a Torre
del Greco, a Palermo e a Torino8. Solo nel 1939 ad una parte di loro fu
concesso il rimpatrio dal nuovo viceré Amedeo d’Aosta, mentre gli altri
furono trattenuti in Italia sino al crollo del regime.
La vicenda dei deportati, che si trovavano in Italia per costrizione governativa e in un regime di prigionia, risulta evidentemente eccentrica
rispetto alla storia delle migrazioni tra Africa e Europa, e a quelle delle
comunità di migranti che abbiamo visto crearsi in Francia e Gran Bretagna. Essa ebbe, ovviamente, anche un impatto limitato dal punto di vista
sociale e praticamente nullo da quello mediatico. Ciò premesso, durante
il periodo di permanenza forzata in Italia anche i confinati e i deportati
sperimentarono con le popolazioni residenti nelle aree in cui erano costretti una quotidianità che era nuova sia per loro, sia per gli italiani. È
esemplare in questo senso ciò che racconta nella sua biografia romanzata Martha Nasibù, che insieme alla sua famiglia trascorse in Italia otto
anni di confino, tra il 1936 e il 19449. I Nasibù, parenti del deggiac a
capo delle truppe di Haile Selassie nel conflitto del 1935-1936, fuggirono dall’Etiopia prima della deportazione ordinata da Graziani, ma sino
alla liberazione di Roma restarono in balia del controllo e delle volontà
del generale e delle autorità italiane. Nel loro peregrinare obbligato vissero tra Tripoli, Rodi, Napoli, le Dolomiti, Firenze e Roma. Martha e i
suoi fratelli, allora bambini, sperimentarono sulla propria pelle sia l’empatia di una parte degli italiani sia il razzismo presente nella società e
negli ordinamenti. Accanto ad atteggiamenti accoglienti – ad esempio
nei collegi che ospitarono lei e la sorella – a causa del colore della pelle
durante il loro soggiorno Nasibù e la sua famiglia dovettero subire delle «consuete, snervanti, aggressioni verbali, seguite in genere da sguaiate
risate e da coloriti apprezzamenti dei giovani simpatizzanti del regime».
Il varo della legislazione razziale comportò per loro un peggioramento
della situazione: l’ossessione per la bianchezza rese problematica per il
regime, infatti, la presenza di «quei neri abissini» in Italia, e per questo
motivo nel 1939 la famiglia fu trasferita in Libia. Una volta tornati in
Italia, nel 1940, la madre dovette registrare diversi rifiuti, di natura evidentemente razzista, alla richiesta di iscrivere i propri figli a scuola e a
26
023_086_cap_1.indd 26
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
quella di poter sostenere gli esami di riparazione. Il loro particolare status di appartenenti ad una famiglia di notabili etiopici offrì comunque ai
Nasibù alcune scappatoie: godendo dell’appoggio del Pontificio Collegio Etiopico, pur di fronte ad un regime che negava l’istruzione ai neri i
figli del deggiac poterono contare sugli spazi di manovra e di relativa libertà di cui godevano gli istituti ecclesiastici. Fu così che riuscirono non
solo a sopravvivere ma anche a studiare in un Paese fascista e razzista.
Un caso senza dubbio eccezionale quello della famiglia Nasibù, sia
per le ragioni della loro presenza in Italia sia per la condizione sociale dei protagonisti della vicenda. Allo stesso tempo si tratta di un caso
esemplare, capace di mettere in luce la crudeltà e le contraddizioni di un
progetto, come quello fascista, che imponeva di considerare la bianchezza come un segno e uno strumento di difesa dell’italianità.
Questa linea ma anche le contraddizioni si rivelarono in maniera prograssivamente più netta ed evidente nel corso del Ventennio, come emerge
dalle storie degli altri sudditi, né esuli né deportati, che vivevano in Italia.
Si trattava di persone giunte nella Penisola per scelta e in una condizione
riconducibile a quella dei migranti, intendendo questo termine nella sua
accezione più ampia: chi, cioè, soggiorna per un periodo ragionevolmente
lungo in un Paese di cui non è cittadino. Se non esistevano comunità strutturate e circoscritte, le fonti registrano la presenza in Italia di un centinaio
di persone provenienti dai territori coloniali: un primo censimento fatto
dal governo nel 1938 riuscì a contare settantadue persone, cui se ne aggiungevano delle altre che riuscirono a sfuggire alla ricerca condotta dalle autorità10. Il censimento preludeva infatti alla loro espulsione e al rimpatrio, in osservanza di un ordine di Mussolini, ormai deciso a difendere
da contaminazioni razziali il corpo della nazione. La ricognizione fatta in
quell’occasione dal ministero dell’Interno e da quello dell’Africa Italiana
descrive già con sufficiente chiarezza una piccola comunità, composta in
gran maggioranza da uomini che erano partiti dai territori colonizzati e
avevano raggiunto la «madrepatria», alcuni fin dal primo dopoguerra, ma
la maggior parte durante gli anni Venti e la metà degli anni Trenta. L’ordine di espulsione fece emergere diverse contaminazioni che il colonialismo
portava con sé, nonostante l’impegno del governo ad evitare ogni commistione tra colonizzatori e colonizzati. Contaminazioni di tipo ideologico,
innanzitutto. Nel 1939, ad esempio, il regime dovette fare i conti con tre
eritrei, arrivati in Italia tra il 1915 e il 1923, e due libici bengasini, giunti
nella Penisola rispettivamente nel 1922 e nel 1937. Erano tutti lavoratori,
e tutti iscritti al Partito nazionale fascista da cui, secondo le leggi razziali entrate ormai in vigore, dovevano però essere espulsi11. Il partito tentò
27
023_086_cap_1.indd 27
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
dapprima di controbilanciare l’espulsione invitandoli ad iscriversi all’Associazione musulmana del Littorio, istituita quello stesso anno, ma tale
soluzione risultò praticabile soltanto per Mohamed Sala, meccanico residente a Chieti. Gli eritrei erano infatti di fede copta e l’altro libico, Giovanni Maria Gasseri, si era convertito pochi anni prima al cattolicesimo.
Proprio la storia di Gasseri, mentre mette in luce gli spazi di mobilità di cui i sudditi libici potevano godere sotto il regime fascista, rivela allo stesso tempo il carattere di eccezionalità degli spostamenti dalle
colonie verso la madrepatria. Nato a Barce nel 1916, e rimasto orfano
a dieci anni, Gasseri fu raccolto da un reparto di truppe italiane e poi
assegnato ai Fratelli delle scuole Cristiane di Bengasi che lo spinsero a
compiere gli studi elementari e a seguire un primo corso di avviamento
professionale. Convertitosi al cattolicesimo prese il nome di Giovanni
Maria, mentre la versione italianizzata del suo paese di nascita (Gasr el
Lebia) ne divenne il cognome. Dopo aver ottenuto il diploma di avviamento professionale a Tripoli, sempre con l’appoggio del tenente del reparto che l’aveva preso in cura nel 1937, si trasferì a Roma, dove trovò
lavoro come ascensorista e fattorino d’albergo. Servì per tutta la durata
della guerra mondiale nella difesa costiera, e nel 1945 tornò a Roma
dove, dopo qualche tempo, sposò una donna italiana12.
La possibilità di sposare una italiana, certo facilitata dal crollo del regime, era osteggiata ma non totalmente preclusa anche negli anni precedenti, in particolar modo ai libici. Un’altra contaminazione rilevata dal
censimento del 1938 era infatti l’esistenza di alcuni matrimoni «interrazziali», che riguardavano cinque libici sposati con donne italiane, contro
un solo eritreo e una donna eritrea13. Che anche in questo caso probabilmente al regime sfuggisse qualcosa è dimostrato dalla storia di Hanna Gonnicé, donna eritrea, e Ugo Bolsi, italiano. Tornati dall’Eritrea,
i due riuscirono dopo il 1937 a tenere nascosto al governo il proprio
matrimonio per evitare il provvedimento di rimpatrio14. Dopo il 1938
era infatti questo il destino che spettava ai colonizzati in Italia, anche se
sposati. Riuscì a sfuggire al provvedimento e a restare nel Paese anche
Ali el Gariani, nato a Bengasi nel 1913 e trasferitosi in Italia nel 1927.
Nel 1933 l’uomo si era arruolato nella Milizia Volontaria di Sicurezza
Nazionale e nel 1940 si era fatto battezzare. La conversione, pure frequente tra i libici che si trasferivano in Italia, non gli evitò, due anni dopo, di essere radiato dal corpo a causa delle disposizioni che vietavano
«l’appartenenza di gente di colore dell’Impero e delle Colonie ai Corpi Armati metropolitani». Nel 1935, l’anno dell’inizio della guerra d’Etiopia, El Gariani aveva sposato una donna italiana, Laura Petrignani,
28
023_086_cap_1.indd 28
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
da cui aveva avuto due figli: quando l’uomo fu espulso dalla milizia la
prima ipotesi presa in considerazione dalle autorità fu quella di inviare
l’intera famiglia nella colonia nordafricana. «Di fronte ad altre situazioni similari, si è preferito allogare in Libia le famiglie formatesi in seguito a matrimoni misti, che attualmente contrastano con i postulati della nostra etica razzista», spiegava il ministro dell’Africa Italiana Attilio
Teruzzi. Il ministero poi diede ordine di rimpatriare il solo Gariani, ma
alla fine anche a lui fu concesso di rimanere in Italia come civile insieme alla moglie e ai figli15. Vantava una lunga permanenza in Italia e un
matrimonio «misto» anche Mohamed Taurghi, giunto a Roma nel 1921
al servizio della principessa di Villafranca, che dalla moglie Rosalia Rocaforte ebbe anche una bambina, Maria.
Le singole vicende personali rivelano uno scenario in cui esistevano
spazi e modi attraverso cui una minoranza di individui provenienti dalle colonie poteva riuscire a costruirsi una vita nella «madrepatria». Se
pure qualche eritreo giunse nelle penisola a ridosso o durante il primo
conflitto mondiale, il trasferimento era decisamente più semplice per i
libici, che costituivano la quasi totalità degli «immigrati coloniali». Sino
alla proclamazione dell’impero e alla promulgazione delle leggi razziali
gli abitanti della colonia nordafricana avevano maggiori possibilità di
porre le basi per una normale vita familiare: il colore della pelle, e anche lo status giuridico di cittadini (per quanto «speciali», e dunque limitati nei loro diritti pubblici16) consentivano loro uno spazio di mobilità
e una possibilità di integrazione nella società italiana inconcepibile per
gli africani provenienti dal Corno d’Africa.
Studiare in Italia. Libici, eritrei ed etiopici tra politica dei capi
e contestazione
L’assunzione del pregiudizio razzista da parte del diritto italiano della
fine degli anni Trenta rese più complicati sia l’arrivo, sia l’integrazione di
quei pochi migranti coloniali che riuscivano ad arrivare nella madrepatria. Anche in questo caso, però, a dimostrazione delle tante contraddizioni che segnano la storia in generale e che in particolare caratterizzarono quella del fascismo, in questi stessi anni per i nordafricani si aprirono
altri canali di ingresso nella Penisola. Nello specifico, negli ultimi anni
Trenta, per la prima volta fu istituzionalizzata l’ammissione di studenti libici negli istituti italiani di istruzione superiore e universitaria. Si trattava
di numeri irrisori, non sufficienti per sovvertire la ratio generale della po29
023_086_cap_1.indd 29
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
litica educativa italiana nei confronti dei colonizzati, ma rappresentava
comunque un cedimento nella politica di separazione voluta dal regime.
Anche prima dell’arrivo al governo di Mussolini la politica coloniale
italiana non aveva mai investito nell’educazione di nuove élite africane né
sulla formazione di mediatori da utilizzare per meglio imporre il proprio
dominio sulle società dei colonizzati. Tra l’indirect rule britannico o il modello assimilazionista francese l’Italia scelse una strada propria, che ebbe
come suo tratto distintivo proprio il rifiuto di avvicinare a sé, in qualunque prospettiva, le popolazioni colonizzate. Per radicarsi nei territori occupati l’amministrazione italiana cercò l’appoggio delle élite tradizionali,
quindi di capi che potevano mettere a disposizione degli occupanti relazioni di potere già consolidate. Per i sudditi di tutti i territori coloniali fu
concepito un sistema di istruzione che prevedeva una frequenza scolastica estremamente limitata nel tempo, ridotta alla sola scuola elementare, e
finalizzata ad una formazione pratica dei giovani libici, eritrei e somali17.
Nonostante l’enfasi retorica sulla «elevazione» degli africani il regime
fascista non modificò, ma anzi rese più rigido questo approccio. Il risultato fu che, diversamente da ciò che accadeva negli Imperi francese e britannico, al momento dello scoppio della seconda guerra mondiale nei
territori del Corno d’Africa sottoposti alla dominazione coloniale italiana non era presente neanche un laureato tra la popolazione locale. Una
situazione, questa, che avrebbe influito in maniera tutt’altro che secondaria sugli eventi successivi alla fondazione dei nuovi Stati indipendenti.
Ancora una volta diverso il caso della Libia, in cui capitava che le famiglie più in vista del notabilato spingessero i propri giovani verso l’università. Anche in questo caso si trattava però di casi eccezionali e numericamente limitatissimi; inoltre, i pochissimi libici che si iscrivevano all’università sceglievano perlopiù di recarsi in Egitto piuttosto che in Italia18.
Gli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale videro però, per la prima volta, la concessione di speciali facilitazioni governative ad alcuni studenti provenienti dalla colonia nordafricana, che furono così iscritti a spese dello Stato italiano in istituti di istruzione superiore
ed universitaria della Penisola. Come detto non è certo il dato numerico
– risicatissimo – a modificare il quadro d’insieme, bensì il principio che
si scorge dietro questo fatto nuovo. «Fin dagli anni precedenti il recente
conflitto», scriveva Martino Mario Moreno, arabista, etiopista e funzionario ministeriale dagli anni Dieci sino alla Repubblica19, «questo Ministero
– per ovvi motivi di opportunità politica – provvedeva ad incoraggiare e
favorire per quanto possibile l’ingresso di giovani libici anche nelle scuole
italiane metropolitane, avviandoli nelle scuole superiori». Moreno esplici30
023_086_cap_1.indd 30
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
tava un fatto di per sé evidente, guardando i nomi e la provenienza degli
studenti in questione: la decisione di accettarne la presenza in Italia non
nasceva da un ripensamento nell’organizzazione dell’istruzione in colonia,
quanto piuttosto era il risultato di una particolare contingenza politica20.
Nel 1940 erano cinque gli studenti libici ospitati dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II a Roma. Il primo ad arrivare era stato Shifau
Cherbish, figlio di quel Yusuf Cherbish, capo berbero, che per venti anni
era stato un fedelissimo sostenitore degli italiani. Nel marzo del 1937, durante la cerimonia allestita da Balbo in occasione della visita di Mussolini
a Tripoli per consacrare la «politica filoaraba» del regime, era stato Yussuf a consegnare al capo del fascismo la celeberrima «spada dell’Islam»21.
La possibilità data a Shifau, allora non ancora ventenne e non ancora diplomato, e al più giovane fratello Ahmed che lo seguì a Roma due anni
dopo, rientrava probabilmente in quella serie di privilegi che i mediatori acquisivano e contrattavano in virtù della loro posizione di tramite tra
colonizzatori e colonizzati22. Sembrano confermare questa ipotesi i nomi
degli altri ospiti libici dello stesso convitto romano, tutti in vario modo
collegati a famiglie appartenenti al notabilato libico. Tra coloro che si trovano a Roma o comunque in Italia prima della guerra, in qualità di studenti assistiti dal governo italiano c’erano sia Abdullatif Kikhia, del clan
bengasino dei Kikhia, che nel dopoguerra avrebbe dato il primo ministro
al governo del re Idris I; sia Taufik el-Seqizli, il figlio del suo successore,
Mohamed el-Seqizli, ex scrivano pubblico. A Roma si trovava poi Mohamed Khaled, figlio del capitano libico Kalefa Khaled, ufficiale decorato
con quattro medaglie al valor militare per aver combattuto al fianco degli
italiani fin dai tempi della «riconquista» fascista della Libia.
Se il privilegio dei figli nasceva dalla posizione dei genitori, la presenza degli studenti in Italia dipendeva anche dalla particolare congiuntura politica, nello specifico dalla già citata «svolta filoaraba» del regime.
Per quanto si trattasse in gran parte di una mossa propagandistica, da
parte di Mussolini esisteva una effettiva volontà di presentarsi a tutte
le popolazioni arabe con un volto nuovo. Senza elaborare davvero un
nuovo sistema di gestione del potere in colonia, dunque, il regime nella seconda metà degli anni Trenta prese iniziative isolate che volevano
suggerire una nuova considerazione nei confronti dei musulmani in generale e più in particolare dei notabili libici. Per questo, e anche per le
pressioni del governatore della Libia Italo Balbo, alla fine di quel decennio era stata introdotta una nuova cittadinanza libica speciale, che in
teoria avrebbe dovuto consentire a chi la possedeva l’accesso agli uffici
amministrativi in Tripolitania e Cirenaica23. L’apertura nei confronti dei
31
023_086_cap_1.indd 31
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
rampolli di alcune famiglie libiche costituiva dunque un ulteriore strumento di avvicinamento al regime di quella parte della società colonizzata: la riconoscenza che questi provvedimenti avrebbero portato al regime consolidava infatti il rapporto con famiglie considerate strategiche
o comunque utili per il controllo della colonia.
L’istruzione dei giovani notabili libici in Italia poteva poi risultare
vantaggiosa per il governo anche da un altro punto di vista: attraverso
il sovvenzionamento dell’istruzione si coltivavano nuove generazioni,
sempre legate alle vecchie élite, sulla cui fedeltà e sui cui sentimenti filoitaliani si sperava di poter contare anche in futuro.
Detto questo, il governo italiano dimostrò però un certo imbarazzo
nel gestire la presenza nel Paese degli studenti libici. La loro condizione
sociale avrebbe dovuto garantire loro uno status di privilegio, mentre
quella ‘razziale’ li poneva in uno stato di inferiorità, rispetto agli italiani ma anche agli altri stranieri. Indicativa di queste contraddizioni è la
reazione del ministero dell’Africa Italiana alla richiesta fatta nel novembre del 1939 da un gruppo di studenti musulmani (egiziani, libanesi,
siriani e palestinesi) residenti a Roma, che chiedevano alle autorità italiane di poter costituire un’associazione culturale. In considerazione della politica filoaraba il ministero inizialmente diede un parere positivo,
dal momento che «ai fini della nostra azione e penetrazione politica nei
Paesi arabi più progrediti una tale associazione potrebbe, non è dubbio,
svolgere un’opera proficua»24. Si escludeva, però, che all’associazione
potessero aderire anche gli studenti libici: «il solo fatto che essi non siano cittadini», recitava il documento, escludeva che essi potessero partecipare «ad una società formata, come è detto nella proposta, ‘su basi di
egualità tra europei e arabi’». L’ultima parola spettò al ministro Teruzzi,
che proprio in virtù della presenza nella Penisola degli studenti sudditi
italiani decise di sconsigliare del tutto la costituzione del sodalizio. «Ove
l’associazione fosse costituita, non si reputerebbe opportuno autorizzare a farne parte i libici ed i nostri sudditi di religione musulmana che
vivono nel Regno e che dovessero chiedere di iscriversi ad essa. […] È
d’altra parte evidente – proseguiva – che non sarebbe gradito agli stessi
nostri sudditi il dover constatare l’esistenza del Regno di una associazione islamica a carattere religioso culturale dalla quale essi sarebbero
per principio esclusi, mentre vi dovrebbero poter essere ammessi i loro
correligionari purché sudditi di altri stati»25.
Ancora più problematica era la presenza in Italia dei sudditi del Corno d’Africa, per i quali la madrepatria restava una terra straniera. Tra le
pochissime eccezioni erano gli etiopici ammessi a studiare nelle struttu32
023_086_cap_1.indd 32
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
re delle Santa Sede, in primo luogo nel Pontificio Collegio Etiopico26. Il
collegio nel 1919 era stato trasformato in modo da accogliere non più
pellegrini, come accadeva in passato, ma appunto studenti provenienti
dal Corno d’Africa. Dopo l’occupazione dell’Etiopia da parte dell’Italia la presenza di questi giovani a Roma, seppure al riparo delle mura
vaticane, fu la causa di alcuni contrasti tra il regime e lo Stato Pontificio: per legge, infatti, quest’ultimo concedeva la cittadinanza vaticana a
chiunque si stabilisse, per un periodo più o meno lungo, a vivere nel suo
territorio. La cittadinanza valeva per tutta la durata del soggiorno, ma i
Patti Lateranensi a loro volta stabilivano che, uno volta che il cittadino
vaticano avesse spostato la propria residenza dallo Stato Pontificio allo
Stato italiano, divenisse cittadino di quest’ultimo. Poco prima dell’inizio
della guerra il governo italiano presentò formali rimostranze alla Santa
Sede per la pratica di concedere la cittadinanza vaticana agli etiopi, nel
frattempo diventati sudditi italiani. Il governo temeva che, concluso il
periodo di studi e tornati in colonia, gli studenti avrebbero approfittato
dello status guadagnato in Vaticano per accedere alla cittadinanza italiana. Eludendo in questo modo, scriveva Teruzzi, la «integrale applicazione dei principi generali del nostro diritto in materia di razza»27.
Come se non bastasse, sul breve periodo il ministero dell’Africa
Italiana paventava un altro rischio. Uscendo dalle mura dello Stato
Pontificio per brevi vacanze, i giovani etiopici avrebbero potuto girare per Roma protetti dalla loro cittadinanza vaticana. Si trattava di
uno scenario particolarmente sgradito alle autorità fasciste, in primo
luogo perché rendeva permeabile la barriera innalzata per mantenere le popolazioni sottoposte al dominio italiano lontane dal territorio nazionale. L’eventualità di avere gli studenti etiopici in giro per la
capitale, tutelati dalla cittadinanza straniera, rappresentava inoltre un
rischio politico. L’OVRA, la polizia segreta fascista, aveva infatti segnalato già da tempo al ministero degli Interni e a quello dell’Africa
Italiana quanto fossero diffusi, fra gli studenti del Collegio Etiopico in
Vaticano «i soliti sentimenti antitaliani». Tra i trentadue collegiali ospitati dalla struttura nel dicembre 1940 furono segnalati due diciassettenni, Tesfaghiorghis Tigiar e Uolde Johannes Habtemariam, prossimi
a conseguire la laurea e a rientrare in Africa Orientale per iniziare il
ministero di sacerdoti. «In linea fiduciaria risulta effettivamente che i
predetti non tralasciano occasione per criticare ogni provvedimento
del nostro Governo e in particolare del regime, svolgendo tra gli altri
seminaristi una dannosa propaganda antitaliana», scriveva il ministro
Teruzzi, disponendo nei confronti loro e dei loro compagni un serra33
023_086_cap_1.indd 33
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
to controllo e la censura della corrispondenza. «Tra l’altro» aggiungeva «essi dimostrano di rimpiangere la ‘libertà di un tempo della loro
terra’, auspicandone il ritorno»28.
Già dagli ultimi anni del regime, insomma, si trovava in Italia uno
sparuto ma articolato nucleo di persone provenienti dalle colonie, che
nutrivano sentimenti e avevano posizioni decisamente differenti verso la
società italiana e il governo di Roma. Quest’ultimo, a sua volta, aveva
nei loro confronti atteggiamenti diversi, che andavano dalla tolleranza al
controllo sociale, e comprendevano un sostegno anche finanziario. Nello stesso modo il governo gestì un altro gruppo di sudditi coloniali: uomini e donne che dall’Africa Orientale erano giunti in Italia, immediatamente prima dell’ingresso del Paese nella seconda guerra mondiale, per
partecipare come figuranti alla Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare.
Prigionieri in madrepatria. Gli africani della Mostra Triennale
delle Terre d’Oltremare
L’idea di una esposizione che fosse la vetrina della civiltà italiana e
della sua potenza imperiale era nata nel 1937, appena dopo la proclamazione dell’impero29. La Triennale era l’ultima delle iniziative pensate
e realizzate nel Paese fin dall’Ottocento, sulla scia delle grandi esibizioni coloniali allestite in tutta Europa che mostravano territori, prodotti e,
soprattutto, le popolazioni delle colonie, allo scopo di consolidare non
soltanto un immaginario e una «coscienza coloniale», ma come strumento anche per la creazione di specifiche identità culturali collettive e
nazionali30. In particolare la pratica di portare in madrepatria «esemplari umani» provenienti dai territori coloniali era diffusa in Italia dal XIX
secolo, e anche il fascismo vi aveva già fatto ricorso in più occasioni:
la più famosa era stata l’Esposizione coloniale organizzata a Torino nel
1928, che vide la ricostruzione di tre villaggi africani – cirenaico, somalo ed eritreo – e per il quale le suore missionarie avevano portato in
Italia trenta bambini provenienti dalle colonie31.
Per realizzare la Mostra Triennale, tra il 1938 e il 1940 il regime
aveva provveduto a sgomberare ed edificare un’enorme area nelle vicinanze di Napoli, individuata anche per la sua posizione nel Mediterraneo come espressione della attitudine espansionista della nazione. Nei
progetti dello stesso Mussolini il capoluogo campano avrebbe dovuto
ospitare permanentemente, nell’area della mostra, manifestazioni ed iniziative finalizzate ad esaltare il ruolo dell’Italia in Africa e nell’Oriente.
34
023_086_cap_1.indd 34
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
L’esposizione, con i suoi trentasei padiglioni, fu inaugurata alla presenza del re Vittorio Emanuele III in occasione del quarto anniversario della proclamazione dell’impero, il 9 maggio del 1940, ma fu costretta a
chiudere i battenti dopo appena un mese a causa dell’ingresso dell’Italia
nella guerra mondiale. Gli eritrei, i somali e gli etiopici che erano stati
trasportati fin là per animare il cosiddetto «villaggio indigeno», attraverso cui i visitatori della mostra si sarebbero dovuti fare un’idea della vita
nel Corno d’Africa, rimasero bloccati nella penisola32.
Si trattava di cinquantasette persone, soprattutto artigiani e operai, in
larga maggioranza uomini ma anche diciassette donne e sette bambini, appartenenti a diverse religioni (copti e musulmani) e gruppi etnici (eritrei,
somali, amara, scioiani, galla, hararini, uolama e sidama). Erano stati scelti
e ingaggiati dal governo dell’Africa Orientale – «quasi a titolo di premio»,
scriverà il ministro dell’Africa italiana Teruzzi – per dare nel corso della
mostra dimostrazione dell’esercizio dei rispettivi mestieri, e per mettere
in scena ad uso e consumo dei visitatori la vita di un villaggio dell’Africa
orientale. Con le stesse finalità l’Ente mostra aveva deciso la creazione anche di un padiglione libico, sempre con figuranti provenienti dalla colonia:
il destino dei libici, però, sarebbe stato molto diverso, e decisamente meno
sfortunato di quello dei sudditi provenienti dal Corno d’Africa.
Rispetto alle precedenti esibizioni che prevedevano la presenza di
esseri umani, la legislazione razzista in vigore nel 1940 aveva posto dei
problemi del tutto nuovi. Per la preoccupazione di difendere la «razza
italica» dal contagio delle «razze inferiori», era stata perfino messa in
discussione l’opportunità stessa di portare nel territorio nazionale dei
sudditi coloniali neri. Si temeva che la prolungata permanenza nella penisola degli eritrei, dei somali e degli etiopici (mentre nulla si ritrova a
proposito dei libici) comportasse il «pericolo di gravi inconvenienti nel
campo razzistico»33. Fu alla fine lo stesso Teruzzi ad annunciare a Mussolini di aver autorizzato la permanenza temporanea degli africani del
Corno destinati al villaggio indigeno: a patto, questo, che li si mantenesse sotto stretto controllo, in modo da evitare qualunque contatto con
gli italiani. A questo scopo fu creata una apposita stazione della Polizia
dell’Africa italiana, che avrebbe accolto un gruppo di militari – sia italiani sia africani – specificamente preposti alla sorveglianza del personale
coloniale34. Anche la presenza di ascari della PAI sul territorio nazionale
era una novità: per la mostra ne furono inviati in tutto 55, la maggior
parte dei quali era destinata al servizio d’onore. Alla chiusura dell’esposizione il loro destino corse parallelo a quello dei «figuranti» del villaggio, del cui inquadramento e controllo sarebbero stati incaricati35.
35
023_086_cap_1.indd 35
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
Gli africani, divisi sulla base del gruppo etnico di appartenenza, furono
sistemati in un campo speciale costruito nella zona della Triennale, in alloggiamenti di legno che erano stati in precedenza utilizzati dai bersaglieri.
Ad ognuno di loro era destinata una paga giornaliera, fissata tra le venticinque e le trenta lire per gli uomini, dodici per le donne e sei per i bambini.
La situazione della piccolissima comunità iniziò a complicarsi dopo
la chiusura della mostra. Già ora la posizione dei libici si rivelò più semplice, poiché qualche giorno prima dell’inizio delle ostilità si riuscì ad
imbarcarli per la vicina «quarta sponda»36. Il contesto bellico rendeva invece impossibile il rimpatrio verso il Corno d’Africa, cosicché eritrei, somali ed etiopici rimasero bloccati in Italia. Il rapido crollo delle truppe
italiane nei territori dell’impero li costrinse poi ad un esilio dalla durata
indefinita, senza che il rigido controllo imposto su di loro si allentasse
in alcun modo. Anzi, come ha scritto Abbattista, «il controllo temporaneo dei loro corpi fisici in quanto oggetti da esposizione, destinati però a tornare in patria nel volgere di sei mesi, si era rapidamente mutato […] in un vero e proprio disciplinamento poliziesco permanente»37.
I sudditi coloniali – il cui numero nel frattempo cresceva: tra il
1940 e il 1943 nacquero cinque bambini – continuarono ad essere costretti in uno spazio angusto, con la consegna di allontanarsi al
massimo due volte alla settimana e soltanto dietro accompagnamento di un poliziotto. La limitazione dei movimenti era esplicitamente
giustificata come una profilassi per preservare la nazione da un contatto ritenuto pericoloso con le cosiddette «razze inferiori»: per questo
motivo il comando generale respingeva ogni richiesta che, anche per
periodi limitati, e anche dietro controllo delle forze Polizia dell’Africa
Italiana, comportasse una qualsiasi interazione tra africani e italiani
all’esterno del campo. Trovandosi a valutare la richiesta di due somali,
Islao Omar e Aden Scirè, di trascorrere alcuni giorni ospiti di un connazionale momentaneamente a Roma, il direttore generale del corpo
PAI, Matteo Gallimberti giustificò il proprio rifiuto affermando che: «I
detti somali, seppure opportunamente accompagnati durante la loro
permanenza in Roma – non mancherebbero, con ogni probabilità, a
compenso del lungo periodo di limitata libertà in cui sono stati e sono tuttora costretti – di rendersi causa di riprovevoli azioni con conseguenti spiacevoli incidenti»38.
Per lo stesso motivo, nonostante le pressanti richieste non fu consentito che i sudditi coloniali lavorassero al di fuori del campo. Fu rigettata
anche la domanda presentata dalla Banca d’Italia, tre dipendenti della
quale erano stati inviati dal Corno d’Africa a Napoli per lavorare al pa36
023_086_cap_1.indd 36
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
diglione dell’Istituto. A causa del richiamo di molti impiegati alle armi,
la filiale di Napoli si era trovata con il personale drasticamente ridotto,
per cui chiese di poter usufruire dell’aiuto dei suoi tre dipendenti africani alloggiati nel campo. Anche in questo caso il comandante ritenne
opportuno negare il proprio consenso per non contravvenire alle stringenti norme relative ai sudditi inviati per la mostra. Fecero eccezione i
permessi accordati ai tre sudditi trasferiti a Roma nel 1941 per contribuire alle radiotrasmissioni di propaganda in lingua tigrina e amarica,
realizzate per il Corno d’Africa dal ministero dell’Africa Italiana insieme
a quello della Cultura Popolare. Tra questi era una donna eritrea, Abeba Bisset, scelta poiché in grado di leggere e scrivere anche l’italiano39.
Il controllo cui erano sottoposti gli africani della Mostra d’Oltremare avvicinava sempre di più il loro stato a quello dei confinati politici, e
rese il clima interno al campo sempre più teso.
Oltre alle complesse dinamiche che si creano normalmente all’interno dei gruppi umani costretti alla convivenza per lungo tempo (gelosie,
creazione di gruppi antagonisti, intemperanze) e ai problemi dati dal dover affrontare il clima invernale in baracche non adeguatamente riscaldate, il malcontento si diresse verso il comando italiano del campo e in
qualche caso contro l’Italia in generale. L’insofferenza emerse in alcune
occasioni: ad esempio, rischiò un provvedimento giudiziario un etiope,
Hailù Uoldejesus che, dopo un’uscita a Bagnoli, fu denunciato per offese all’Italia e agli italiani. Contro di lui la testimonianza di un oste, che
sosteneva di essere stato aggredito verbalmente dall’uomo. «Avete paura che non paghiamo?», avrebbe urlato questi. «Noi etiopi siamo ricchi
e potremmo pagare anche in oro. Voi italiani stare meschini e miserabili ma gli inglesi vi strozzeranno e vi metteranno un chiodo nel cuore»40.
Più spesso le lamentele venivano espresse per iscritto alla dirigenza
del campo e riguardavano le razioni alimentari, considerate non adeguate, o le paghe, considerate insufficienti e troppo irregolari per mantenere un livello di vita dignitoso. A queste si aggiunsero le denunce di
violenze e soprusi commessi da alcune guardie. Il sistema imposto dal
controllo del campo imponeva una rigida gerarchia, con i capi di ogni
gruppo a controllare gli altri e i poliziotti dell’Africa Italiana a capo di
tutti. Un poliziotto italiano fu allontanato e rispedito in Etiopia perché
riconosciuto come inadatto al lavoro di sorveglianza a causa dei suoi
modi «brutali e a volte anche violenti» nei confronti degli africani41. In
altri casi i contrasti tra guardie e coscritti si risolvevano con la punizione di questi ultimi, ma alla direzione generale degli Affari Politici giungevano diverse segnalazioni a proposito di violenze perpetuate dai capi
37
023_086_cap_1.indd 37
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
africani e coperte dai responsabili italiani della PAI con minacce e arresti. «Al solo titolo di informazione diciamo che dal giorno in cui siamo
giunti in Italia non abbiamo trovato che dei soprusi e dei mali per noi
nocivi, cosa che da noi in patria non succedeva», scrivevano i due etiopici Scifarrà Aba Dico e Aba-Bulgur Aba Garic.
I dirigenti del ministero dell’Africa Italiana guardavano con una certa attenzione ai disagi lamentati dagli ospiti del campo. Moreno, allora
a capo della direzione Affari Politici, consigliò di soddisfare le loro richieste, sia per evitare disordini sia perché, con una certa lungimiranza,
riteneva che quelle persone sarebbero state utili dopo la fine del conflitto per ristabilire l’ordine nei territori coloniali attraversati dalla guerra42.
Diverso l’atteggiamento sia dei responsabili dell’organizzazione della
mostra, sia dei vertici del comando della PAI, che consideravano esagerati i problemi denunciati degli africani, frutto di una tendenza naturale
(dovuta alla «attitudine razziale» delle popolazioni africane, si diceva) alla lamentela. Una evidente interiorizzazione del discorso razzista emergeva in una lettera spedita nel gennaio del 1943 dalla direzione Servizi
di guerra. Secondo l’autore:
ozio volontario, costrizione in accampamento – resa necessaria da avvenute intemperanze – la coabitazione di nuclei differenti per razza e religione, la nostalgia dell’Africa, la difficoltà di acclimatazione e quelle
derivanti dalla situazione di guerra, aggiunte ai tipici difetti della razza,
hanno fatto di questi nativi degli elementi insofferenti, litigiosi, ipercritici, neghittosi, incontinenti, in costante sollecitudine dei miglioramenti
più disparati, scontenti di tutto, privi di ogni comprensione per le non
comuni provvidenze adottate dagli organi governativi nei loro confronti, pronti ad avanzare ogni giorno con petulanza tipicamente orientale
reclami e pretese, la cui inconsistenza e falsità è bene nota a chiunque
abbia esperienza delle genti d’Africa43.
Il disinteresse per le condizioni di vita degli africani da parte degli
amministratori desiderosi di liberarsi di «quei neri» il prima possibile
crebbe nel corso degli anni, traducendosi in un sempre meno celato
razzismo e in una crescente incuria per il benessere degli assistiti. Alla
fine del 1942 il ministero scoprì anche che i dirigenti del campo avevano arbitrariamente ridotto le razioni alimentari destinate ai sudditi. Per
questi motivi, e perché i continui bombardamenti costringevano sempre
più spesso gli africani e le loro guardie a trovare riparo in un rifugio poco distante dal campo, alla fine del gennaio 1943 si iniziò a valutare la
possibilità di trasferire degli africani in un luogo più sicuro.
38
023_086_cap_1.indd 38
14/02/17 16:07
(Ex) sudditi. Libici, eritrei, somali ed etiopici in Italia
La ricerca durò qualche mese e portò poi alla scelta di villa Spada, di
proprietà della famiglia Vannuttelli, che si trovava a Treia, in provincia di
Macerata. Villa Spada era stata precedentemente utilizzata come campo
di concentramento per cittadine straniere e poi chiusa nel gennaio del
1942 per inagibilità dell’edificio44. Inizialmente la villa era stata scartata proprio perché considerata inadatta ad ospitare gli africani, sia per le
sue condizioni, sia per la sua collocazione in uno dei luoghi più freddi
della zona. Ciononostante la direzione generale del ministero decise di
assumersi l’onere di alcune migliorie e tra l’8 e il 9 aprile trasportò comunque là i sudditi della mostra. Furono spostati da Napoli cinquantatré africani45, e con loro anche il comando di polizia della PAI, di cui
però non è dato conoscere l’esatta consistenza.
Anche qua, come già nel campo, non tardò a manifestarsi una certa
tensione tra le guardie africane e italiane della PAI e quelli che erano,
ormai a tutti gli effetti, dei confinati. Rispetto al periodo precedente gli
incidenti assunsero ben presto un carattere politico: una relazione del
comando PAI riporta ad esempio di uno scontro, causato da un ritardo, tra uno degli etiopici della mostra, Abdissà Agà, e uno sciumbascì
eritreo di guardia. «Zitto tu, schiavo figlio di schiavi», pare avesse detto
l’etiopico. «Tu sei eritreo ed io scioano, per cui tu sei un venduto e quando io tornerò alla mia terra sarò come bandiera, a casa mia e tu invece
sarai un ruffiano che si fa fottere come una donna».
Quello che a prima vista può apparire come un semplice scontro,
forse anche dovuto alla diversa provenienza – e quindi alla diversa storia – dei due sudditi, assume un diverso significato alla luce degli eventi
che sconvolsero la vita della villa pochi mesi dopo, quando il 6 di ottobre tre degli africani della mostra, Scifarrà Abbadicà, Ambagirù Abbuagi, Mahamud Abbascimbò, fuggirono dal campo, seguiti il 25 dallo stesso Abdissà Agà. Tre giorni dopo, il 28, la villa fu attaccata da un
gruppo di partigiani: era infatti quella la zona di operazione di alcune
bande, tra cui la «banda Mario» della brigata Garibaldi, che erano state
informate della villa proprio dai fuggitivi. L’operazione aveva l’obiettivo
di fare incetta delle armi automatiche là custodite e di liberare gli africani46. Circa trenta uomini tra slavi, inglesi e italiani fecero irruzione a
villa Spada e, dopo aver ferito il proprietario e altre due persone, oltre
alle armi si «portarono via alcuni indigeni». La prima relazione inviata al
ministero parlava di dieci persone mancanti, mentre l’elenco stilato dal
comando generale del PAI a gennaio ne indicava solo otto, tra cui una
donna, tutti membri non del gruppo degli ascari PAI, bensì del nucleo
di africani inizialmente giunti a Napoli per dare vita al villaggio indige39
023_086_cap_1.indd 39
14/02/17 16:07
La madrepatria è una terra straniera
no47. Tra questi erano Nurù Tahar, Aden Scirè e Abbabuglù Abbamegal,
che si unirono, con altri, alla guerra partigiana nella zona48.
Dopo l’assalto la direzione generale degli Affari Politici manifestò le
proprie, crescenti preoccupazioni per la sicurezza della zona, tanto che
Enrico Cerulli nel novembre di quell’anno arrivò a pianificare un nuovo
trasferimento a Roma. L’ordine però non fu mai realizzato e di lì a poco la villa venne a trovarsi nell’area liberata dagli Alleati sfuggendo così
al controllo delle autorità fasciste. Furono gli Alleati, nel luglio 1944, a
trasportare nel campo di Carbonara a Bari gli africani ancora presenti,
e a disporne il rimpatrio dopo quattro anni dalla partenza dalle loro case49. Presumibilmente per la maggior parte degli «africani della Mostra
d’oltremare» la vicenda italiana si concluse in quel momento. Almeno
uno di loro però, Gheresellassè Maconnen, capo del gruppo eritreo a
Treia, non fu rimpatriato subito ma nel 1946 si trovava ancora in Italia ospite del campo di Aversa, dopo essere passato per quello di Santa
Maria di Leuca. Da qua scrisse più volte al ministero dell’Africa Italiana
per ottenere aiuti economici e materiali in modo da affrontare meglio
le avversità della permanenza in Italia prima dell’atteso rimpatrio per
l’Eritrea50. La sua richiesta, che faceva leva sul proprio comportamento sempre corretto nei confronti dell’Italia, e sui diritti accumulati nei
confronti del Paese durante gli anni precedenti, rende immediatamente
evidente come la fine della guerra e quella (all’epoca non ancora accettata dai governi italiani) dell’impero non potevano chiudere, da sole, la
questione coloniale. Ai governi postfascisti e alla Repubblica spettava
ora farsi carico non solo delle questioni di mantenimento materiale, ma
anche delle responsabilità morali nei confronti di persone il cui destino
per decenni era stato segnato dal rapporto coloniale con l’Italia.
Ritorno in madrepatria. Africani nell’Italia del dopoguerra
Assisterli e rimpatriarli. Gli ex sudditi civili dopo il 1945
Alla fine della guerra i governi di Francia, Gran Bretagna, Olanda e
Belgio, oltre a gestire materialmente l’afflusso degli ex sudditi coloniali
nei loro Paesi, dovettero fronteggiare le ricadute sociali della presenza
dei migranti coloniali. La loro accettazione non era semplice, all’interno di società da secoli educate a percepirsi come incommensurabilmente superiori alle popolazioni africane e asiatiche. L’Italia invece, primo
tra tutti gli stati imperialisti a dover gestire la fine del colonialismo,
40
023_086_cap_1.indd 40
14/02/17 16:07