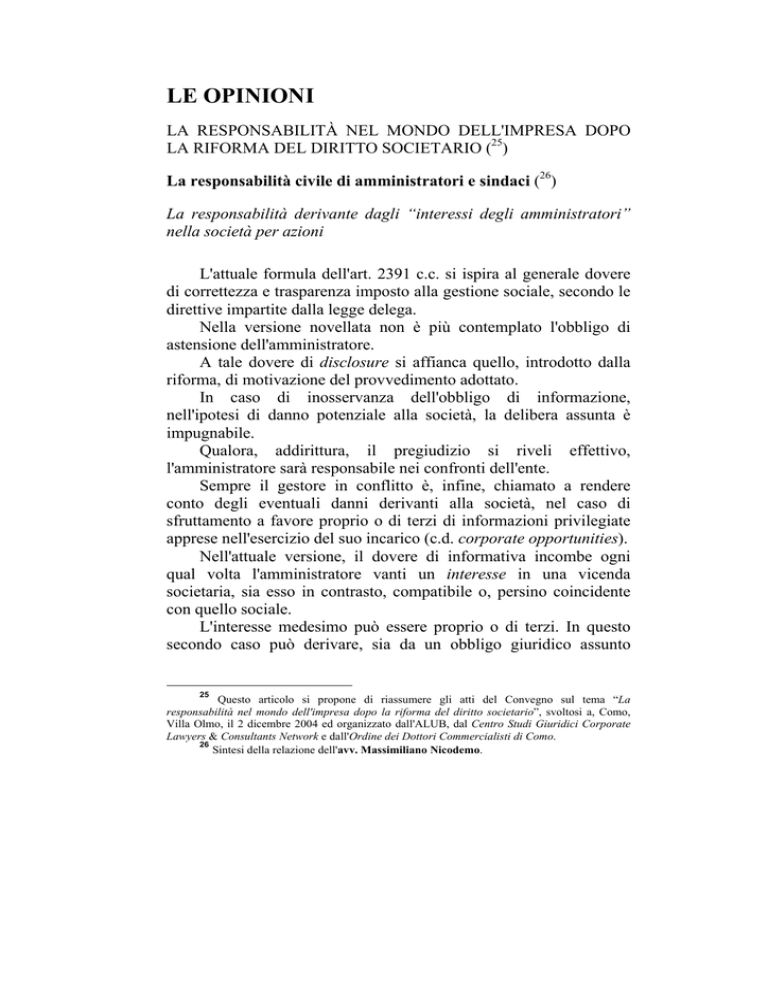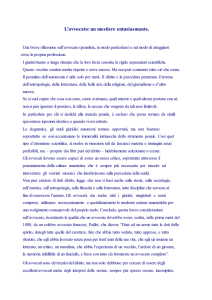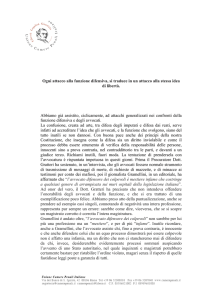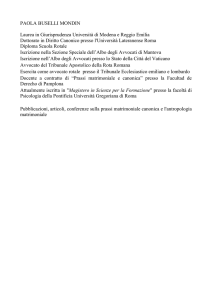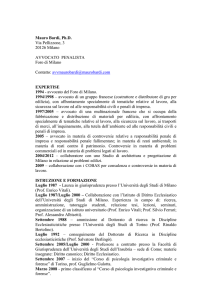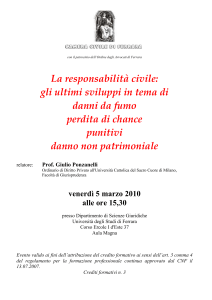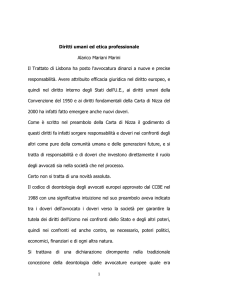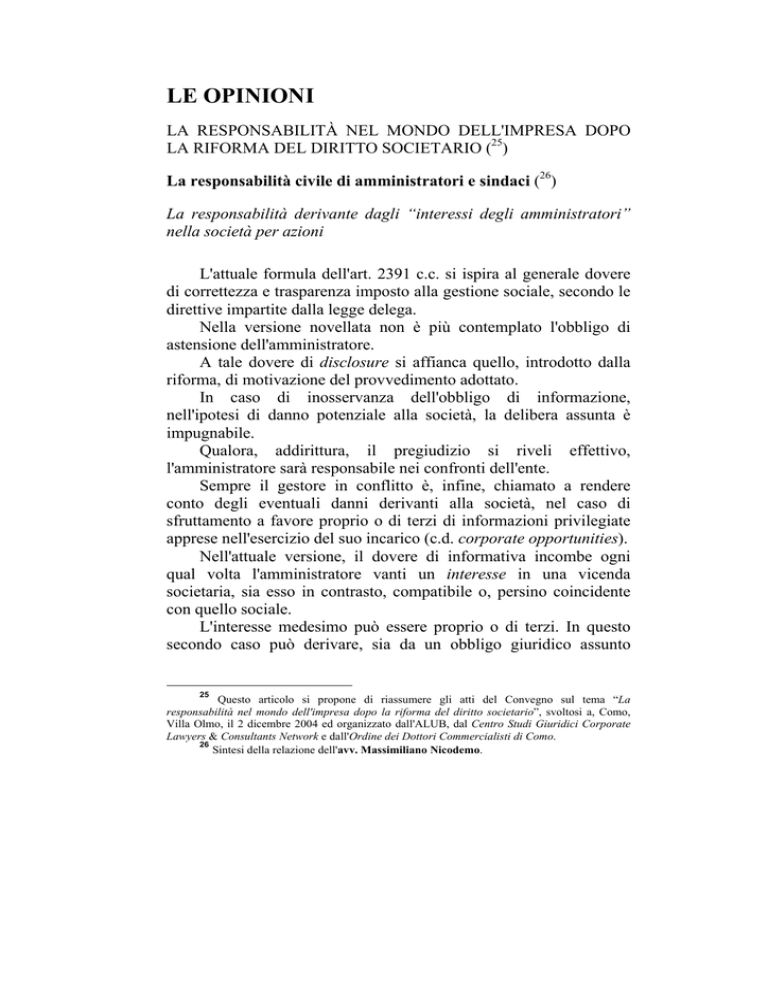
LE OPINIONI
LA RESPONSABILITÀ NEL MONDO DELL'IMPRESA DOPO
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (25)
La responsabilità civile di amministratori e sindaci (26)
La responsabilità derivante dagli “interessi degli amministratori”
nella società per azioni
L'attuale formula dell'art. 2391 c.c. si ispira al generale dovere
di correttezza e trasparenza imposto alla gestione sociale, secondo le
direttive impartite dalla legge delega.
Nella versione novellata non è più contemplato l'obbligo di
astensione dell'amministratore.
A tale dovere di disclosure si affianca quello, introdotto dalla
riforma, di motivazione del provvedimento adottato.
In caso di inosservanza dell'obbligo di informazione,
nell'ipotesi di danno potenziale alla società, la delibera assunta è
impugnabile.
Qualora, addirittura, il pregiudizio si riveli effettivo,
l'amministratore sarà responsabile nei confronti dell'ente.
Sempre il gestore in conflitto è, infine, chiamato a rendere
conto degli eventuali danni derivanti alla società, nel caso di
sfruttamento a favore proprio o di terzi di informazioni privilegiate
apprese nell'esercizio del suo incarico (c.d. corporate opportunities).
Nell'attuale versione, il dovere di informativa incombe ogni
qual volta l'amministratore vanti un interesse in una vicenda
societaria, sia esso in contrasto, compatibile o, persino coincidente
con quello sociale.
L'interesse medesimo può essere proprio o di terzi. In questo
secondo caso può derivare, sia da un obbligo giuridico assunto
25
Questo articolo si propone di riassumere gli atti del Convegno sul tema “La
responsabilità nel mondo dell'impresa dopo la riforma del diritto societario”, svoltosi a, Como,
Villa Olmo, il 2 dicembre 2004 ed organizzato dall'ALUB, dal Centro Studi Giuridici Corporate
Lawyers & Consultants Network e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.
26
Sintesi della relazione dell'avv. Massimiliano Nicodemo.
dall'organo di gestione, sia da un suo legame connesso a rapporti
societari o personali.
Può, altresì, essere patrimoniale o non e, per far scattare il
relativo dovere di disclosure, deve superare una soglia minima di
rilevanza quantitativa e qualitativa, tale da perturbare il giudizio
dell'amministratore.
Il soggetto, nella circostanza, investito deve comunicare
l'esistenza del proprio interesse a tutti i componenti del consiglio di
cui fa parte ed all'organo di controllo.
La nuova norma definisce il contenuto dell'informazione:
devono essere specificati natura, termini, origine e portata
dell'interesse, assicurando, dunque il full disclosure.
Non è richiesta una forma solenne di comunicazione, né una a
fini probatori; deve, comunque, essere garantita la completa
conoscenza a tutti i destinatari.
Ciò rileva ai fini del requisito di legittimazione
all'impugnazione ai sensi del terzo comma dell'art. 2391 c.c..
Recepita l'informativa, il consiglio deve “motivare le ragioni e
la convenienza per la società dell'operazione”.
La motivazione deve essere esaustiva e logica, idonea a chiarire
tutti gli interessi in gioco ed a specificare la ragione che determini al
compimento o non della data operazione.
Devono, nella stessa, essere, altresì, segnalati i vantaggi per
l'ente, nonché spiegato il perché l'interesse dell'amministratore non
abbia interferito sulla deliberazione.
Quest'ultima, se assunta con voto determinate del soggetto
interessato, è annullabile qualora risulti potenzialmente dannosa per
la società, sia se l'operazione venga disposta, sia in caso contrario.
Inoltre, il membro del consiglio che non si astenga ed esprima
un voto contrario all'interesse sociale è revocabile dall'assemblea e
passibile di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c..
L'inosservanza del dovere di informativa di cui al primo comma
dell'art. 2391 c.c. rende la delibera, se suscettibile di provocare un
danno alla società, impugnabile dagli amministratori o dal collegio
sindacale entro novanta giorni dalla sua data, indipendentemente
dalla partecipazione o non all'adozione della stessa da parte
dell'interessato (art. 2391, terzo comma, c.c.).
Il difetto di informazione non permette agli aventi causa di
conoscere la situazione di interferenza, dunque, il requisito del
danno è in re ipsa.
Anche il mancato rispetto dell'obbligo di motivazione da parte
del consiglio rende annullabile la delibera.
Non è, comunque, ammessa l'impugnazione del membro
consenziente del consiglio, una volta che gli obblighi informativi
siano stati adempiuti.
Il membro dell'organo gestorio cointeressato, qualora la sua
posizione prevalga su quella della società con conseguente danno a
carico di quest'ultima, può votare, a condizione che il suo voto non
sia determinante per la delibera, pena l'invalidità della stessa.
Ai fini dell'impugnazione della delibera, il terzo comma dell'art.
2391 c.c. richiede il configurarsi di un danno per la società.
L'esistenza di un interesse extrasociale in capo
all'amministratore genera di per sé un danno potenziale.
In questo caso, a differenza che per l'esperimento dell'azione di
responsabilità nei confronti del membro coinvolto, non occorre la
prova concreta del pregiudizio, ma è sufficiente la sua ragionevole
evidenza.
Legittimati all'impugnativa della delibera sono, in presenza di
violazione dell'obbligo di disclosure, tutti gli amministratori, a
prescindere dalla loro partecipazione alla procedura di assunzione
della delibera ed al voto.
È, pertanto, legittimato pure il soggetto interessato, anche
laddove abbia votato a favore dell'operazione, nel caso in cui,
successivamente, reputi la stessa potenzialmente nociva per la
società o, comunque, voglia limitare la sua responsabilità.
Qualora, invece, egli abbia assolto l'obbligo di informativa,
possono impugnare il provvedimento solo i membri del consiglio
assenti, dissenzienti o astenuti.
Legittimato è, anche, il collegio sindacale.
La delibera può, infine, essere attaccata dai soci, se lesiva dei
loro diritti alla luce del disposto dell'art. 2388, quarto comma, c.c.,
introdotto dalla riforma.
Data esecuzione alla decisione, l'amministratore interessato
risponde nei confronti della società, qualora si sia verificato un
danno effettivo a carico di quest'ultima a causa della sua azione od
omissione.
Si configura, pertanto, un'ipotesi riconducibile alla generale
fattispecie di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c., che non diverge, nella
sostanza, da quella precedentemente prevista, secondo la quale
l'amministratore rispondeva “delle perdite che siano derivate alla
società dal compimento dell'operazione”.
L'organo gestorio deve rendere conto del suo operato anche se
non ha preso parte all'iter che ha condotto all'adozione della delibera,
non ha dato esecuzione direttamente all'attività decisa o non si è
trovato in una condizione di conflitto di interessi.
Nel caso il comportamento imputabile al membro del consiglio
coinvolto sia omissivo, deve essere dimostrato il nesso di causalità
tra detta inerzia ed il danno arrecato. Ciò al fine di scongiurare la
responsabilità oggettiva.
L'ultimo comma della norma in commento prevede che il
soggetto interessato sia, altresì, chiamato a rispondere dei danni
derivati all'ente di appartenenza dalla utilizzazione a vantaggio
proprio o di terzi di opportunità di affari apprese nell'esercizio delle
sue funzioni.
La disposizione deve essere coordinata con la lettera dell'art.
2391 c.c..
In quest'ottica, l'amministratore che venga a conoscenza di una
corporate opportunity potenzialmente sfruttabile per fini extrasociali
deve comunicarlo agli altri che decideranno se sia la società a
doverne o meno approfittare. In questo secondo caso, il membro
interessato del consiglio può liberamente cogliere l'opportunità
sottesa all'affare.
La responsabilità derivante dal conflitto di interessi
dell'amministratore di s.r.l. e la figura dell' “amministratore di
fatto”
La nuova disciplina (art. 2475-ter c.c.) è fondata sul diritto,
accordato alla società, di invocare l'annullamento di contratti
conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi con la stessa,
per conto proprio o di terzi, per scongiurare il danno eventualmente
derivante dall'esecuzione dei negozi in parola.
È, comunque, richiesta la condizione per cui tale situazione sia
nota o, per lo meno, conoscibile dal terzo (art. 2475-ter, primo
comma, c.c.) all'atto della stipula.
Il disposto dell'articolo in esame conferisce, altresì, ai singoli
membri del CdA e — ove nominato — al collegio sindacale, la
legittimazione ad impugnare, entro il termine di decadenza di
novanta giorni, le decisioni adottate dal consiglio con voto
determinante del componente in conflitto di interessi, qualora le
delibere medesime possano cagionare un danno patrimoniale alla
società (art. 2475-ter, secondo comma, c.c.).
Il rimedio non è esperibile ove siano stati scelti modelli di
governance che non prevedano l'istituzione dell'organo gestorio
tradizionale.
Il legislatore richiede, comunque, quale presupposto di ogni
iniziativa ammessa, la configurabilità di un danno effettivo e non
meramente potenziale.
In ogni caso, sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai
terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Nella s.r.l. l'organo gestorio risponde per “i danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri (…) imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società” (art. 2476, primo
comma, c.c.).
Manca, a differenza di quanto prescritto per la S.p.A, il
riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalla
specifica competenza posseduta.
In ogni caso, in assenza di una previsione espressa, può
ritenersi operante, per le s.r.l., il dovere sotteso alle regole generali
imposte in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176, primo
comma, c.c.).
La responsabilità degli amministratori si configura sempre in
presenza di un fatto personale e non deriva mai dalla sola carica
rivestita.
È, inoltre, necessario che chi sia chiamato a dare conto del suo
comportamento abbia personalmente partecipato al compimento
dell'atto cagione del danno, o, in mancanza, che non possa
dimostrare di essere esente da colpa e non abbia manifestato il
proprio dissenso, pur essendo a conoscenza dell'operazione (art.
2476, primo comma, c.c.).
Qualora il gestore sia a conoscenza dell'atto pregiudizievole, se
non vuole incorrere in responsabilità, ha l'onere di manifestare il
proprio dissenso, che dovrebbe, in ogni caso, risultare dal libro delle
decisioni degli amministratori.
La legittimazione ad esperire l'azione spetta innanzitutto ai soci,
indipendentemente dalla qualifica o meno di amministratori (art.
2476, terzo comma, c.c.).
Il socio la esercita in nome proprio e per conto dell'ente.
Ciascun membro della compagine è legittimato ad agire,
qualunque sia la sua partecipazione al capitale sociale.
L'entità della quota detenuta rileva, invece, per quanto riguarda
la rinuncia o la transazione dell'azione (art. 2476, quinto comma,
c.c.).
Il socio che promuove l'azione può, altresì, chiedere, in
presenza di gravi irregolarità gestorie, la revoca dell'amministratore
a cui le stesse sono ascritte.
Il provvedimento cautelare presuppone, comunque, che un
danno si sia già verificato.
Legittimata attiva è, anche, la società. Quest'ultima può, inoltre,
rinunciare o transigere l'azione.
In assenza di un'apposita previsione, il termine di prescrizione è
quello dettato dall'art. 2949, primo comma, c.c..
È di cinque anni ed inizia a decorrere dal momento della
produzione del danno a carico della società.
La norma di cui all'art. 2476, settimo comma, c.c. prevede
un'estensione della responsabilità ai “soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi
per la società, i soci o i terzi ”.
La previsione di una responsabilità a carico di chi eserciti
effettivamente il potere di governance, pur in assenza di una
qualifica formale, è tesa ad evitare che tale potere sia oggetto di
abusi.
La responsabilità ha natura contrattuale, discendendo dal
contratto sociale e dal complesso di diritti ed obblighi che ne
conseguono.
Primo requisito è il concorso della stessa con quella degli
amministratori ufficialmente investiti. Secondo è l'intenzionalità del
comportamento.
Sul significato da attribuire a tale ultimo termine impiegato dal
legislatore, gli interpreti non sono concordi.
La nozione sembra debba correlarsi all'evento cagionato dalla
condotta e rappresentato dal danno per la società.
Aderendo a tale interpretazione, non sarebbe sufficiente, ai fini
della configurazione della responsabilità a carico del membro della
compagine che non rivesta cariche gestorie formali, il fatto che egli
abbia agito con colpa grave, ma si richiederebbe l'intento di arrecare
un danno all'ente o addirittura l'animus nocendi.
La tesi espressa pare quella più aderente allo spirito della
previsione normativa.
La responsabilità amministrativa delle società (27)
Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la « responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società, nonché delle
associazioni prive di personalità giuridica » quale conseguenza di
determinati fatti-reato compiuti dai legali rappresentanti a beneficio
dell'ente.
La norma è scollegata dal sistema nel suo impianto strutturale
e, inoltre, non segue una logica sistematica degli illeciti conforme
con quella del sistema stesso.
Infatti, la responsabilità dell'ente è prevista, dagli artt. 24 e 25
del decreto, solo per i reati di corruzione, concussione,
malversazione, truffa aggravata e frode informatica in danno dello
Stato o di altri enti pubblici, reati questi, quasi tutti sì di
formulazione postcodicistica, ma inseriti in Capi differenti del
Codice.
Definire la responsabilità degli enti come responsabilità
amministrativa tout court, dando luogo di fatto ad una figura atipica
di responsabilità, quasi un tertium genus, più vicina a quella penale
che non a quella amministrativa tipica, di certo non aiuta a
perseguire quelle finalità di chiarezza e determinatezza della
fattispecie cui ogni ordinamento liberal-democratico dovrebbe
mirare.
La recente produzione normativa in argomento è permeata da
un vizio di fondo: l'incapacità del legislatore di orientarsi verso una
27
Sintesi della relazione del prof. avv. Fabio Foglia Manzillo.
scelta decisa a favore o meno della responsabilità penale della
persona giuridica con il risultato di creare un ibrido normativo quale
la sanzione all'ente definita sì amministrativa, ma comminata dal
giudice penale in forza di regole sostanziali e processuali proprie del
diritto e della procedura penale.
L'art. 2 dispone che la responsabilità dell'ente e le relative
sanzioni debbono osservare il principio di stretta legalità.
La disciplina dell'art. 3 è un logico corollario di quanto sancito
dalla norma appena citata. Infatti, se l'irretroattività della legge
penale è una delle necessarie conseguenze del principio di legalità,
ovviamente non potrà sopravvivere la responsabilità dell'ente, una
volta che la legge sia abrogata.
Ulteriore corollario della legalità è il divieto di ultrattività della
legge penale, con il conseguente divieto di ultrattività della sanzione
amministrativa in ipotesi di abrogazione della norma incriminatrice e
di quella contenente la sanzione nei confronti dell'ente stesso.
Il principio di legalità, in ogni caso, diviene garanzia
imprescindibile di libertà per il soggetto al quale sono imputabili
fatti illeciti, e nei confronti del quale sono applicabili sanzioni
restrittive della libertà personale e patrimoniale. Infatti, il sacrificio
di tali libertà insopprimibili dell'individuo può essere giustificato
unicamente in forza di precise e predeterminate scelte legislative.
È da notare che, invece, l'appiattimento sulla disciplina
penalistica è del tutto evidente nell'art. 4, che richiama gli artt. 7, 8,
9 e 10 del codice penale riguardo la perseguibilità dei reati
commessi all'estero.
Poiché l'intera disciplina della perseguibilità dei reati commessi
all'estero è strutturata sull'illecito penale, non vi sono altre ragioni
che consigliano l'uniformità di trattamento se non la chiara volontà
di rendere il più possibile omogenee le modalità di applicazione
delle sanzioni all'ente con quelle dell'illecito penale presupposto
della responsabilità della persona giuridica.
L'art. 4 prevede che l'ente che abbia la sede in Italia risponde
anche dei reati commessi all'estero. A tal riguardo, è da evidenziare
che la disciplina dovrà confrontarsi con il noto fenomeno della
globalizzazione dell'economia e, conseguentemente, con la presenza
di una pluralità di sedi di una società commerciale localizzate in più
nazioni, nonché con l'operatività della stessa in differenti parti del
globo.
Organo competente a giudicare il reato commesso dal soggetto
che agisce nell'interesse dell'ente è il giudice penale, secondo le
modalità previste dal relativo Codice di rito; l'art. 38 dispone
l'obbligatoria riunione dei procedimenti, aventi ad oggetto le due
ipotesi di responsabilità, avvenuta la quale, il processo per
l'accertamento della “responsabilità amministrativa” perde la sua
autonomia.
La riunione dei procedimenti, ai sensi del citato art. 38 è
obbligatoria e il giudice penale deve compiere un duplice
accertamento riguardo la responsabilità dell'agente persona fisica e
dell'agente persona giuridica, nonché comminare la relativa sanzione
alla persona giuridica.
Altro evidente segnale di “penalizzazione” delle modalità di
accertamento processuale è rappresentato dall'art. 40 che statuisce
l'obbligatorietà della nomina del difensore di ufficio. Infatti, l'istituto
in esame non trova alcun riscontro nel diritto amministrativo e nella
relativa procedura.
Senza meno la difesa di ufficio ha la propria genesi nel
processo penale, quale strumento per garantire il diritto di difesa
all'imputato, diritto, questo, sancito costituzionalmente dall'art. 24.
La necessità di garantire in ogni caso il diritto di difesa
all'imputato ha reso tale istituto tipico del processo penale, con
riferimento alle posizioni processuali proprie dell'accusato. È da
segnalare che l'esigenza di rendere effettiva l'applicazione del
menzionato diritto, ha motivato il legislatore ad emanare la legge n.
60/2001 sulla difesa di ufficio.
Altro evidente segnale di adeguamento degli strumenti di
accertamento della responsabilità dell'ente alla responsabilità penale,
per il relativo illecito commesso, è la previsione dell'incompatibilità
dell'ufficio di testimone sia per l'agente del reato-base, sia per la
persona fisica che rappresenta l'ente in giudizio.
La veste di testimone è incompatibile con quella di imputato,
alla pari diviene incompatibile con l'autore dell'illecito dal quale si
genera la responsabilità dell'ente, e con chi rappresenta lo stesso
nella fase del suo accertamento.
Il parallelismo diviene ancor più stringente allorquando il
capoverso dell'art. 44 dispone la possibile audizione del
rappresentante della persona giuridica nelle forme e nei modi
previsti dal Codice di procedura penale per l'imputato di reato
connesso.
Rilevante è anche l'estensione della disciplina dell'art. 513
c.p.p. con riguardo alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini o dell'udienza preliminare.
Peraltro, appare abbastanza singolare che tale eventualità non
sia prevista esplicitamente per l'autore dell'illecito penale, per il
quale è stabilita, invece, la stessa incompatibilità sancita per il legale
rappresentante della persona giuridica, a meno di non voler ritenere
che la responsabilità dell'ente non sia del tutto appiattita sull'illecito
penale commesso dalla persona fisica.
Quest'ultima condizione è ancora più macroscopica se si
analizzano le prescrizioni contemplate nelle sezioni del decreto, che
attengono alle misure cautelari, alle indagini preliminari ed ai
procedimenti speciali.
La misura cautelare è sì uno strumento utilizzato anche nei
procedimenti tesi ad accertare la responsabilità amministrativa o
civile, ma la disciplina degli artt. 45, 46, 47, del decreto è
evidentemente ispirata a quella penale.
I criteri di scelta delle misure, previsti dall'art. 45, sciolgono
ogni residuo dubbio in argomento riguardo l'uniformità della
disciplina a quella processual-penalistica; il giudice, infatti, deve
tener presente tre criteri:
— la proporzionalità della misura al fatto compiuto e alla
prevedibile sanzione che sarà applicata;
— la specifica idoneità della misura alle esigenze di
prevenzione;
— la residualità della misura più grave dell'interdizione
dall'attività per l'ente, rispetto le altre misure più gradate.
I mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti applicativi
delle ordinanze custodiali sono, altresì, indubbiamente riferibili al
sistema processuale penale, nel quale sono previsti specifici
strumenti di garanzia per il cittadino imputato o indagato, che
subisce pressanti restrizioni alla sua libertà personale o patrimoniale.
L'art. 52 individua l'appello al Tribunale del riesame e il
conseguente ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del
Tribunale.
Sempre in termini di garanzia per l'ente indagato, devono essere
affrontati gli istituti delle indagini preliminari sia per quanto attiene
l'invio dell'informazione di garanzia all'ente (art. 57), sia per i
termini di durata delle indagini stesse (art. 56) equivalenti a quelli
penalistici, il superamento dei quali, evidentemente, comporterà
l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza
degli stessi, infine, per la disciplina che prevede l'obbligatorietà, la
precisione e la determinatezza della contestazione dell'illecito (art.
59).
La Sezione VI introduce, inoltre, i riti alternativi propri del
codice di procedura penale anche nei procedimenti a carico della
persona giuridica. In particolare, l'art. 63 prevede l'applicazione della
pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
Il c.d. patteggiamento introdotto dal Codice del 1989, consiste
nell'applicazione, ad opera del giudice della pena concordata tra le
parti, pertanto non si comprende come si possa, poi, identificare la
sanzione dell'ente come amministrativa, lì dove l'istituto in
discussione ha quale oggetto tipico quella penale.
È da notare, altresì, che la norma in esame presenta lacune,
poiché non menziona eventuali limiti massimi di pena per
l'applicabilità del patteggiamento, così come disposto dall'art. 444
c.p.p., che prevede che l'accordo tra le parti processuali riguardo la
sanzione irrogata non superi i due anni.
Dal breve esame di alcuni punti qualificanti del D.Lgs. n.
231/2001, emerge come la definizione legislativa di responsabilità
dell'ente quale amministrativa tout court possa suscitare perplessità,
tenendo presente i risvolti che la qualificazione di tale modello in un
senso o nell'altro presenta nell'applicazione della norma. Sarebbe
auspicabile, pertanto, una rimeditazione della scelta, alla quale segua
l'armonizzazione della materia con il sistema sanzionatorio nel suo
complesso. Purtroppo è da notare che i successivi passi del
legislatore, anche se de iure condendo, si muovono in senso opposto.
Silvia Petruzzino
avvocato in Como
AVVOCATI, NOTAI, CARROZZIERI: LA RITENZIONE
1. Il Far-West forense
150.000 avvocati: un numero enorme, destinato ad aumentare a
ritmi vertiginosi, e divenuto incontrollabile anche per la statistica,
visto che la stessa avvocatura non è in grado di contare i propri
componenti su tutto il territorio nazionale se non a distanza di mesi,
ed ancora con qualche approssimazione.
Tutto ciò, come era stato ampiamente previsto e denunciato da
molti anni e da tutta l'avvocatura, ha comportato uno scadimento
della qualità deontologica che si riflette nei comportamenti segnalati
ai Consigli dell'Ordine per l'esercizio della funzione disciplinare.
Spesso i colleghi si lamentano del comportamento dei loro pari
con le classiche frasi di rito, una delle quali dà il titolo a questo
paragrafo.
Il diffuso malumore per i comportamenti che diventano sempre
più ricorrenti ci dà l'occasione per sviluppare alcuni aspetti relativi
ad un tema tipico del Far-West forense: l'accaparramento del cliente
sottratto, in corso di causa, al precedente difensore.
La questione, come vedremo, è descritta con toni più misurati
nel nostro codice deontologico; ma l'esame dei casi pratici e
l'approfondimento delle norme applicabili riservano alcune sorprese.
2. Diritto di ritenzione e divieto di ritenzione
Il paragone tra avvocati e carrozzieri che affrontiamo in questo
paragrafo sembra paradossale, ed in effetti nasconde una
provocazione.
Chi ha la ventura di frequentare le sale d'attesa degli ispettorati
sinistri delle compagnie di assicurazione sa bene che quei luoghi
consentono di incontrare una umanità assai varia: c'è il danneggiato
che tratta il sinistro da solo, ci sono i professionisti (avvocati,
praticanti, periti, geometri ed altri) che trattano le pratiche per i
clienti, e ci sono i carrozzieri che talvolta ricevono il mandato di
trattare la liquidazione del sinistro e qualche altra volta sono più
abili e veloci dei professionisti sopra citati.
Il paragone con i carrozzieri è particolarmente suggestivo
perché questi prestatori d'opera godono del diritto di ritenzione sui
beni loro affidati, e probabilmente il conferimento dell'incarico per
la trattazione del sinistro rinviene le radici proprio in questo
privilegio.
In particolare, la norma di riferimento è l'art. 2756 cod. civ. che
prevede: “I crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio
sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le
prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio
dei terzi che hanno diritto sulla cosa, qualora chi ha fatto le
prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può
ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del
suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la
vendita del pegno”.
Si tratta di una ritenzione privilegiata (28) la cui giustificazione
è da ricercare nel vincolo di inerenza economica che induce a far
prevalere il creditore sul proprietario della cosa e persino sui terzi, a
condizione che si provi la buona fede (29).
Oltre che ai carrozzieri, e agli artigiani in genere, in dottrina si
ritiene che il diritto di ritenzione spetti anche allo spedizioniere
doganale (30) nonché al vettore, al mandatario, al depositario e al
sequestratario, ex art. 2761 cod. civ.
Al contrario il prestatore d'opera intellettuale (pur essendo
spesso, come nel caso degli avvocati, un mandatario particolarmente
qualificato) subisce il trattamento opposto, tant'è che l'art. 2235 cod.
civ. prevede l'esplicito divieto di ritenzione: “Il prestatore d'opera
non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi
professionali”.
La distinzione tra il trattamento che il codice riserva ai due
prestatori d'opera, manuale ed intellettuale, è tradizionalmente
giustificata con la maggiore nobiltà della professione intellettuale,
che nelle intenzioni del legislatore comporta anche un certo distacco
dal vile denaro.
28
29
30
Così P. CENDON, Commentario al cod. civ., sub art. 2756.
V. ANDRIOLI, Commentario al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, sub art. 2756..
P. RESCIGNO, Commentario al cod. civ., sub art. 1740.
Infatti, per quanto riguarda gli avvocati, la norma codicistica è
integrata dall'art. 66 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (31), che
espressamente fa divieto di ritenere gli atti della causa e le scritture
ricevute dai clienti per il mancato pagamento degli onorari e dei
diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi
anticipate.
Anzi, proprio l'anteriorità della legge professionale rispetto al
codice ha fatto affermare in dottrina (32) che il legislatore, con il
codice civile, avrebbe esteso alle altre professioni il principio già
fissato per gli avvocati fin dal 1933 con l'art. 66 della legge
professionale.
3. Avvocati e Notai
Fino ad oggi la disparità di trattamento tra avvocati e
carrozzieri è stata serenamente accettata proprio in nome dei
supremi principi ai quali abbiamo accennato.
Tali principi subiscono però un duro colpo quando
paragoniamo la disciplina dettata per gli avvocati a quella prevista
per una categoria di professionisti molto vicina, e certamente non
meno nobile: stiamo parlando dei Notai.
Per questi professionisti il divieto di ritenzione per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti è inteso come un
riconoscimento alla ritenzione stessa con una funzione cautelare, che
non confligge con il carattere eccezionale dell'autotutela privata.
Secondo una recente dottrina (33) la tutela dei diritti a cui fa
riferimento l'art. 2235 è quella relativa al compenso del
professionista, mentre il riferimento codicistico alle singole leggi
professionali serve soltanto per verificare l'entità dei compensi
suddetti, senza altre limitazioni.
Lo stesso Autore afferma che la ritenzione, per il Notaio, è
pienamente legittima fino al momento del pagamento, e che solo in
tale momento sorge l'obbligo immediato di consegnare i documenti.
31
È la legge professionale forense che, peraltro, è cronologicamente anteriore rispetto al
codice civile.
32
L. RIVA-SANSEVERINO, Commentario al cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, sub art.
2235.
33
G. PETRELLI, Tutela del diritto del Notaio a compensi e rimborsi e diritto di ritenzione di
atti e documenti, in www.federnotizie.org
L'Autore conclude affermando che il più rigoroso divieto di
ritenzione previsto per gli avvocati costituisce una parziale deroga al
disposto dell'art. 2235, e tale deroga, trattandosi di norma speciale,
non è estensibile ad altre fattispecie nè ad altre professioni.
Se così è, la nostra indagine non può fermarsi a ragioni etiche o
di decoro, che dovrebbero essere valide ed uniformi per tutti i
professionisti; evidentemente l'art. 66 della legge professionale deve
essere riletto alla luce delle norme costituzionali e comunitarie, per
verificare se la sua disciplina, così come fino ad oggi unanimemente
interpretata, sia ancora accettabile.
4. L'art. 66 della legge professionale forense e il codice
deontologico
Come è noto, il codice deontologico costituisce
l'esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti (così
espressamente recita l'art. 60) ed ha una natura regolamentare
integrativa della legge professionale (34).
L'art. 66 più volte citato vieta agli avvocati di trattenere gli atti
della causa e le scritture ricevute dai clienti per il mancato
pagamento degli onorari e delle spese; prevede la possibilità di una
composizione amichevole, con eventuale verbale di conciliazione, e
stabilisce che gli atti e le scritture debbano essere depositati presso il
consiglio dell'Ordine e non possano essere ritirati prima che il
Consiglio stesso abbia accertato le spese e liquidato gli onorari.
Il quinto comma, nel prevedere uno specifico potere del
Presidente del Consiglio dell'Ordine di adottare provvedimenti per i
casi di urgenza, manifesta l'ipotesi di contrasto tra diritti opposti,
indicando la necessità di conciliare i legittimi interessi dell'avvocato
con quelli del cliente.
Il regolamento di attuazione (35), all'art. 73, prevede che in casi
urgenti il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture
depositati nella sua sede siano ritirati contro il rilascio di una
ricevuta particolareggiata del nuovo avvocato, il quale assume
impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena ne sia
richiesto.
34
35
Cass., sez. unite, 6 giugno 2002 n. 8225; Cass., sez. unite, 12 febbraio 2004, n. 5776.
R.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
Le norme indicate ci mostrano il clima idilliaco di quegli anni,
nei quali non era ipotizzabile un contrasto tra avvocato revocato e
avvocato subentrante, ma anzi era prevista la piena collaborazione
tra entrambi e con il Consiglio dell'Ordine.
Nel 1933 non esistevano le fotocopiatrici, e trattenere atti e
documenti serviva all'avvocato per dare la prova della prestazione
effettuata.
Nei giorni nostri il problema della dimostrazione dell'attività
svolta dal professionista non si pone, poiché è possibile realizzare
fotocopie degli atti con costi assai ridotti.
Per questa ragione l'art. 42 del codice deontologico, dopo aver
ribadito l'obbligo di restituzione alla parte assistita della
documentazione, prevede che l'avvocato possa trattenerne soltanto la
copia e solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini della
liquidazione del compenso, e non oltre l'avvenuto pagamento.
Qui occorre precisare che, qualora vi sia sostituzione
nell'attività difensiva a processo in corso, la disposizione può
riguardare soltanto alcuni documenti che l'avvocato detenga in
originale nel proprio studio; per quanto riguarda gli atti processuali,
invece, è sufficiente che l'avvocato revocato non ritiri il fascicolo di
parte depositato in tribunale, giacché l'art. 76 disp. att. cod. proc. civ.
stabilisce che gli atti e i documenti inseriti nei fascicoli possono
essere esaminati dalle parti o dai loro difensori muniti di procura.
Con la revoca del mandato cessa ogni potere del difensore
revocato sul fascicolo, e quindi basterà comunicare al cliente le
indicazioni necessarie per individuarlo, in modo da garantire la
prosecuzione dell'attività difensiva.
Il divieto di ritenzione per gli avvocati è confermato dalla
unanime giurisprudenza disciplinare, che considera la sua violazione
come illecito (36).
L'ipotesi di conflitto tra avvocato revocato e avvocato
subentrante in corso di causa è invece regolata indirettamente
dall'art. 33 del Codice Deontologico che prevede la necessità di un
36
Consiglio dell'Ordine di Milano, 4 aprile 1968; Consiglio dell'Ordine di Roma, 11 ottobre
1988, n. 35; CNF 7 marzo 1959; CNF 27 maggio 1978; CNF 7 ottobre 1992 n. 103; Consiglio
dell'Ordine di Bergamo, 6 giugno 1995; CNF 28 aprile 1998 n. 32; CNF 23 ottobre 2000 n. 125;
CNF 11 settembre 2001 n. 168; tutti casi riferiti da R. DANOVI, Commentario del Codice
Deontologico Forense, sub art. 42.
contatto tra i due avvocati ed una leale cooperazione del nuovo
avvocato affinché siano pagate le prestazioni svolte dal precedente
difensore.
La giurisprudenza disciplinare ha visto in questi ultimi anni un
mutamento di indirizzo; infatti in precedenza era considerato
obbligatorio, prima di accettare l'incarico, un contatto con il collega
per conoscere se vi fossero motivi contrari all'assunzione del
mandato (37).
Anzi, dobbiamo qui rilevare che probabilmente la regola
deontologica insita nella coscienza degli avvocati è diversa da quella
oggi dettata dall'art. 33, poiché fino a qualche anno fa si riteneva
obbligatorio non solo contattare il precedente difensore, ma anche
assicurarsi che egli fosse stato saldato.
Il pagamento dei compensi al precedente difensore era quindi
una condizione per poter assumere l'incarico, mentre oggi esso può
essere assunto immediatamente e l'avvocato subentrante, secondo
l'art. 33, deve soltanto adoperarsi affinché siano soddisfatte le
legittime richieste del collega.
Come dicevamo, in passato il CNF ha sanzionato chi ha
accettato l'incarico senza il consenso del collega (38); chi lo ha
accettato prima che il cliente saldasse la parcella dell'avvocato
sostituito (39); in altre ipotesi, invece, è stato ritenuto sufficiente
l'invito rivolto al cliente a definire la pendenza (40) con il
predecessore.
L'evoluzione del Codice Deontologico e della giurisprudenza
disciplinare è confermata anche dal Codice Deontologico Europeo,
che fino al dicembre 2002 prevedeva l'obbligo per l'avvocato che
subentrasse nel mandato di assicurarsi dell'avvenuto pagamento del
predecessore o quantomeno che quest'ultimo avesse accettato un
regolamento delle spese e degli onorari a lui dovuti.
L'articolo in questione è stato però abrogato dal C.C.B.E. nella
data sopra indicata (41).
37
38
39
op. cit.
40
41
CNF 2 dicembre 1991 n. 116; CNF 13 luglio 2001 n. 149.
CNF 23 maggio 1985.
CNF 11 febbraio 1987 n. 13; parere Consiglio dell'Ordine di Milano, 1980, in R. DANOVI,
CNF 28 ottobre 1999 n. 186.
Cfr. R. DANOVI, op. cit., 492.
La suddetta abrogazione è stata probabilmente dettata dalla
necessità di evitare canoni deontologici di natura corporativa.
Un accordo tra avvocati che prevede l'impossibilità per il
cliente di cambiare difensore se prima non salda il precedente
potrebbe portare ad abusi e certamente potrebbe essere inteso, per
usare un'espressione mutuata dal diritto comunitario, come un
accordo di cartello tra imprese.
5. La concorrenza tra avvocati e il diritto comunitario
La modifica delle regole deontologiche che abbiamo appena
indicato è da ritenersi senz'altro in linea con la normativa
comunitaria, nonché con l'art. 24 della nostra Costituzione che
garantisce la difesa come diritto inviolabile e che non consente
accordi tra professionisti che possano in qualunque modo limitarne
l'effettivo esercizio.
A questo punto però dobbiamo chiederci, anche alla luce delle
stesse norme comunitarie, se ciò possa legittimare il Far-West
forense.
Dobbiamo, in altri termini, accertare se sia legittimo il
comportamento di un avvocato che subentri nella difesa di un altro,
che è costretto a restituire i documenti senza indugio, mentre il
subentrante ha soltanto un generico e indefinibile dovere di
“adoperarsi” per le spettanze del suo predecessore.
La questione assume una particolare rilevanza nell'ipotesi in cui
il predecessore abbia condotto brillantemente un giudizio, ottenendo
una sentenza esecutiva, ed il cliente si rivolga ad un altro avvocato
per l'esecuzione del titolo senza pagare colui che, con il proprio
lavoro, ha reso possibile tale esecuzione.
Nella nozione di atti e documenti per i quali vige il divieto di
ritenzione è infatti compresa anche la sentenza esecutiva, che in caso
di richiesta deve essere consegnata al cliente senza alcuna
condizione (42).
Non è questa la sede per affrontare in modo compiuto la
questione dell'assimilazione dell'avvocato all'imprenditore.
Basterà solo accennare che, secondo la giurisprudenza delle
Corti Europee, i professionisti sono equiparati alle imprese
42
Consiglio dell'Ordine di Roma, 11 ottobre 1988, n. 35; CNF 27 giugno 1985.
soprattutto per quanto riguarda la tutela della concorrenza, con
regole che però sono adattate alle peculiari caratteristiche delle
singole professioni.
La nozione di impresa abbraccia infatti qualsiasi entità che
eserciti un'attività economica, e quest'ultima è qualsiasi attività
consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (43).
Una lettura dell'art. 81 (ex art. 85) del trattato sulla comunità
europea ci chiarisce la ragione per cui, come dicevamo, una regola
deontologica che consenta ad un avvocato di assumere la difesa del
cliente solo dopo il saldo del predecessore sarebbe illegittima: “sono
incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra
imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che... abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza...”.
In questo senso, e solo in questo senso, l'avvocato può essere
visto come un'impresa e il CNF, che detta le regole disciplinari,
come un'associazione d'imprese; e se quindi è da salutare con favore
la modifica deontologica che elimina ogni restrizione corporativa ai
diritti del cliente, è certamente da rivedere, per le medesime ragioni
di tutela della concorrenza, il testo dell'art. 33 del Codice
Deontologico.
Tra le circostanze e le normative astrattamente lesive della
libera concorrenza rientrano, infatti, anche le condizioni poste alle
forme di esercizio dell'attività stessa (44); e tra tali condizioni
rientrano senz'altro le norme di comportamento concernenti il
subentro nella difesa.
Il comportamento di un professionista che subentra nella difesa
di un cliente dopo che il predecessore ha ottenuto un titolo esecutivo
e prima che le spettanze di quest'ultimo vengano pagate, o almeno
garantite, compie un atto di concorrenza sleale, a meno che
sussistano validi e particolari motivi che abbiano incrinato il
rapporto fiduciario tra la parte e il difensore.
Infatti, in queste ipotesi il cliente non ha nulla da rimproverare
al proprio difensore, che anzi ha ottenuto un risultato favorevole
43
Corte di giustizia UE, causa C-309/99, Wouters; UE e concorrenza nelle libre
professioni, in La previdenza forense, n. 2/2004.
44
Cfr. R. DANOVI, La giustizia in parcheggio, 1996, 233.
grazie al proprio impegno professionale; e spesso l'unica ragione di
contrasto è economica, nel senso che il cliente ingrato preferisce
cambiare avvocato e non pagare il precedente, piuttosto che fare il
proprio dovere e lasciar completare l'opera a chi l'ha iniziata.
Nella pratica, assistiamo anche a situazioni nelle quali il
subentrante, lungi dall'adoperarsi per far conseguire al revocato le
proprie spettanze, addirittura difende il cliente nella causa di
opposizione a decreto ingiuntivo!
L'ipotesi appena indicata manifesta la debolezza, sul punto
specifico, delle attuali norme deontologiche e soprattutto della loro
più autorevole interpretazione.
Secondo la Commissione Pareri del CNF, infatti, la causa di
opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da un collega non rientra
nelle “azioni giudiziarie penali e civili” per le quali gli avvocati, a
norma dell'art. 22 del codice deontologico, sono obbligati ad
effettuare una preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine,
affinché quest'ultimo possa tentare la conciliazione (45).
Questa interpretazione appare in contrasto con il testo dell'art.
22, che al canone II fa espresso riferimento al caso in cui l'avvocato
ritenga infondata la pretesa del collega; questa dicitura sembra
volersi riferire proprio all'ipotesi di compensi richiesti in misura
eccessiva, e quindi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Insomma, seguendo la tesi che emerge dal parere, si
giungerebbe al paradosso per cui l'avvocato deve informare il
Consiglio dell'Ordine delle iniziative da assumere contro un collega
per questioni attinenti alla vita privata (ad esempio: sfratto per
morosità), ma non deve farlo per questioni attinenti all'attività
professionale, che invece sono proprio quelle nelle quali il Consiglio
può meglio esplicare la sua funzione conciliativa.
Sembra quindi che, mentre la Corte di Cassazione amplia la
nozione di concorrenza sleale, estendendola (46) a quei
comportamenti non previsti dalla legge, ma “connotati dallo stesso
disvalore di quelli espressamente regolati”, i custodi della nostra
disciplina non valutino che la concorrenza tra avvocati deve essere
oggetto di regolamentazione proprio in ossequio a quella stessa
45
46
Parere n. 2, 11 luglio 2001, in Attualità forensi n. 3/2001.
Cass., sez. I, 27 aprile 2004 n. 8012.
disciplina comunitaria che tutela il diritto del cittadino all'immediata
restituzione dei documenti.
Ed allora ben venga “l'Europa che bussa, invade e mescola”,
ma “non possiamo ridurci a pedine/oggetto di un mercato sempre
più senza regole” (47).
È vero che l'avvocato revocato ha a disposizione i mezzi di
tutela individuati dal codice di procedura civile; ma è anche vero che
una efficace tutela della concorrenza si dispiega attraverso misure
preventive, e che il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere, se
possibile, evitato.
Occorre quindi modificare l'art. 33 del Codice deontologico al
fine di evitare i comportamenti più clamorosi, esplicitando il divieto
di assistere il cliente nella causa che ha per oggetto i compensi del
precedente difensore; ed inoltre occorre rileggere l'art. 66 della legge
professionale forense alla luce dei principi che abbiamo appena
ricordato, e riempire di nuovo contenuto quel potere del presidente
del Consiglio dell'Ordine di adottare tutti i provvedimenti che
valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato con quelli del
cliente.
Il Consiglio dell'Ordine potrebbe quindi valutare, secondo
l'ipotesi qui sostenuta, le ragioni della revoca del mandato, e cioè se
esse dipendano effettivamente dalla fine del rapporto fiduciario o da
semplici e vili questioni economiche; potrebbe valutare se le
richieste dell'avvocato revocato siano conformi all'attività prestata, o
se siano esagerate; potrebbe valutare se le condizioni economiche
del cliente siano disagiate o meno; potrebbe infine valutare se
l'atteggiamento dell'avvocato subentrante sia quello di chi soccorre
un inerme cittadino indifeso o quello di chi addenta una grossa torta
senza curarsi dei diritti del pasticciere.
A proposito: ma il pasticciere avrà un diritto di ritenzione? (48)
Antonino Ciavola
avvocato in Catania
47
Sono parole di E.N. BUCCICO, Editoriale di Attualità Forensi, n. 3/2001.
Questo articolo non sarebbe stato scritto senza il fondamentale apporto dei miei colleghi:
A. BONACCORSI, G. CALTABIANO, L. CANNIZZARO, A. CASTRO, S. CHIARENZA, N. D'ALESSANDRO,
R. MENZA, G. SCUTO, S.A. SPINA, V. VITELLO, che ringrazio.
48
TAMPOCO
Credo che in nessuna professione si usi negli scritti un fritto
misto di anticaglie linguistiche come quello diffuso nelle professioni
legali (avvocati, notai, ma anche giudici).
Noi parliamo più o meno normalmente e di solito la gente ci
capisce, ma quando ci mettiamo a scrivere invecchiamo di alcuni
secoli, ci trasformiamo in personaggi del '600 e una pulsione
incontenibile ci induce ad usare un lessico desueto, ridondante,
ermetico e brutto.
In un atto che ho letto recentemente ho trovato, tra le altre,
queste espressioni: tampoco, conclamato, al contempo, del pari,
prodromico, prefato.
In un mio atto ho scoperto: declaranda, attoreo, onde, inficiato,
pretensivo.
In una sentenza compaiono: eziologicamente, giocoforza,
suddetto, delibanda, pregnanza.
Per non parlare del latino, del quale basterà ricordare i
diffusissimi salvis juribus e contrariis rejectis.
Io mi domando perché se parlo con un giudice gli chiedo
qualcosa, ma se gli scrivo rivolgo rispettosa istanza? Perché dico a
mia moglie quanto ho pagato una cosa, ma in giudizio mi riferisco
all'ingente esborso?. Io non ripeto: reitero, non verifico: appuro. Io
menziono, denego, acclaro, tengo indenne o manlevo, opino e
confuto.
Poi c'è il malvezzo (malvezzo!) di enfatizzare tutto: dalla
ostentata considerazione verso l'illustrissimo Tribunale (che non
trova alcun riscontro nei giudizi poi espressi nell'atto d'appello che
contro di esso rivolgiamo alla eccellentissima Corte), alla
ineccepibile condotta del nostro assistito, cui si contrappone la
pretensiva e assurda richiesta di controparte, affidata a suggestive
quanto irrilevanti rappresentazioni e a tesi giuridiche inaudite,
audaci, di macroscopica infondatezza.
Non so se siamo indotti a questi eccessi da un istinto mimetico
e conformistico o dalla irrazionale fiducia che un linguaggio
esoterico e aulico ci nobiliti e ci renda degni di rispetto, oppure se
stemperiamo in questa rassicurante verbosità la depressione che ci
induce la banalità di troppe questioni.
Il fatto è che, dopo un po' , anche volendo non si riesce a
scrollarsi di dosso il “legalese” ed è persino difficile esprimere gli
stessi concetti o raccontare gli stessi fatti senza utilizzarlo.
L'unica consolazione è la consapevolezza di padroneggiare un
linguaggio che sarebbe ben compreso da un redivivo don Ferrante
(Azzeccagarbugli mi pareva poco rispettoso).
« ... è quindi giocoforza rapportare eziologicamente i prefati
assunti onde trarne il pregnante convincimento che una siffatta
conclusione consegue, prima facie, dalle suddette allegazioni, e
tampoco varrebbe ad inficiarne l'ineccepibile consequenzialità la
risibile asserzione afferente l'opinabilità del nesso, smentita
causalmente dal perdurante riscontro fattuale ».
E valga il vero!
Guido Salvadori del Prato
avvocato in Milano