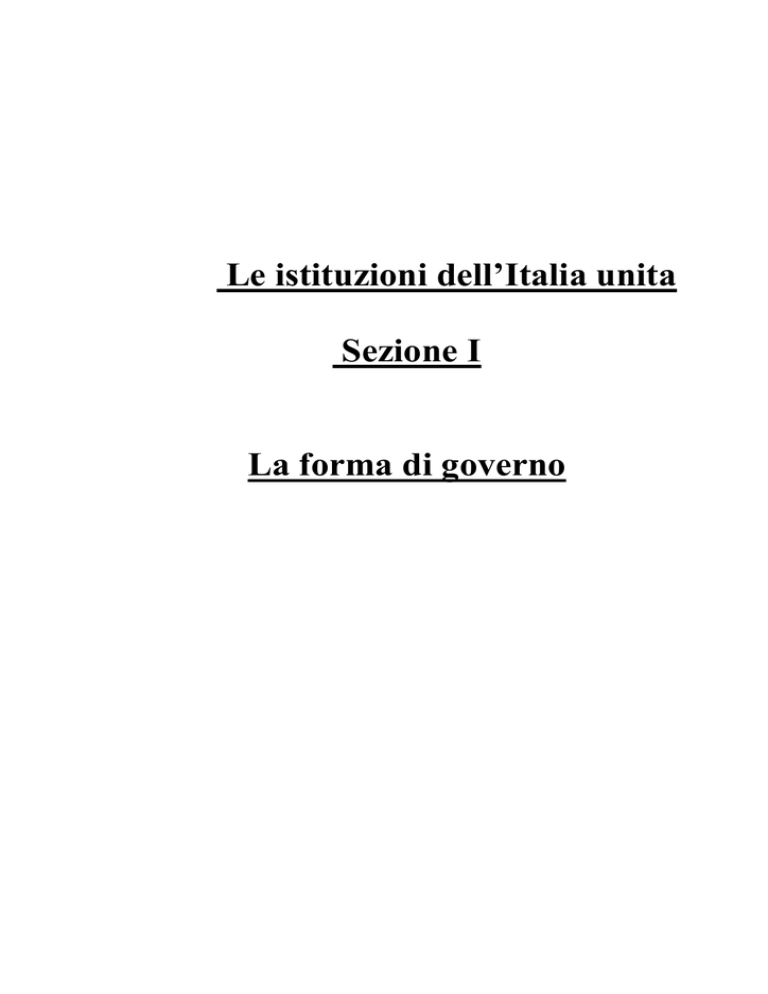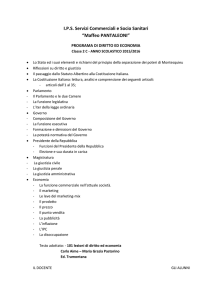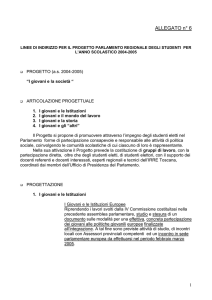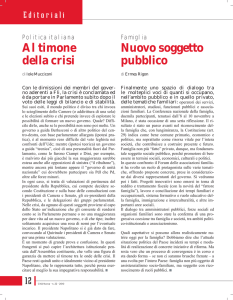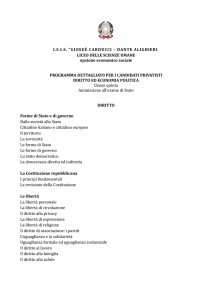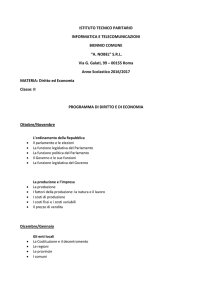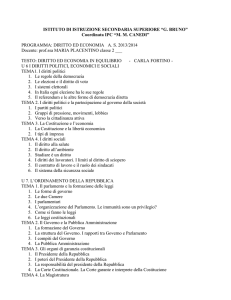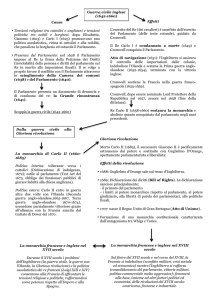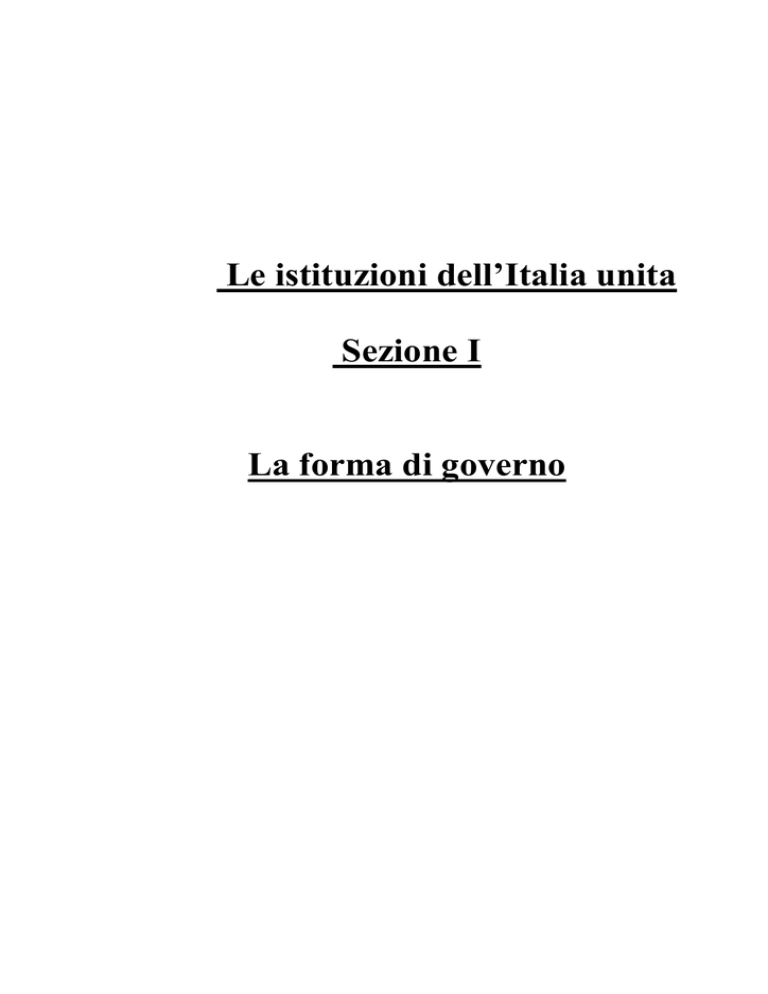
Le istituzioni dell’Italia unita
Sezione I
La forma di governo
A. Il periodo liberale, i suoi prodromi, il suo complesso lascito
Il giurista Umberto Allegretti sintetizza il bilancio complessivo dell’esperienza liberale in Italia
come quello della prevalenza dell’autorità sulla libertà e dunque sulle garanzie.
E’ una pesante eredità storica che si è ripercossa lungo tutto il percorso delle nostre istituzioni.
1.La particolare piegatura, accentuatamente conservatrice, assunta in Italia dalla teoria del
governo rappresentativo
La teoria del governo rappresentativo, cuore della restaurazione liberale, ebbe in Italia importanti
declinazioni aggiuntive rispetto a quelle che quella teoria rivestiva nel resto d’Europa.
Da noi, la teoria del governo rappresentativo fu utilizzata da intellettuali, politici e giuristi per
contrastare, durante il Risorgimento, le tesi che immaginavano per l’Italia indipendente una forma
repubblicana e/o federale, e diventò così la formula di governo naturalmente abbinata alla
politica di unificazione sotto il Piemonte Sabaudo e quella che sembrava imposta dalla
necessità di ‘adeguare’ l’Italia all’Europa.
Lo Statuto albertino, infatti, adottava la monarchia costituzionale pura, la forma di governo
corrispondente alle teorie del governo rappresentativo.
L’unificazione aveva rappresentato il trionfo della ‘modernità giuspubblicistica’ sulle tradizioni
nazionali, alcune delle quali ancora riccamente ispirate all’ordine antico.
1.1.La storia costituzionale d’Italia: unificazione nel segno della ‘modernità’1
Da un punto di vista gius-pubblicistico, possiamo guardare alla unificazione dell’Italia come a un
processo che ha visto la ‘vittoria’ o ‘affermazione’ di una esperienza statale ‘moderna’ (quella di
cui era portatrice lo Stato Sabaduo) su una esperienza rimasta molto più vicina all’ordine antico (il
Regno delle due Sicilie).
In generale, in Italia, il passaggio dall’ordine antico al moderno è avvenuto con tempi e modi diversi a
seconda delle diverse aree della penisola, ciascuna portatrice di una sua storia politico-istituzionale.
Nel Nord e nel centro-Nord, cioè nell’area facente parte del Sacro Romano impero d’Occidente, questo
passaggio si delinea anche prima che in Francia, e secondo due itinerari diversi tra loro: da una parte la
precoce individualizzazione di almeno una piccola monarchia di tipo assoluto, lo Stato sabaudo. La
formazione politica intorno alla quale sarebbe avvenuta l’unificazione italiana appare, confrontata con le
altre esperienze della penisola, quella più in linea coi tempi, allineata alle concezioni ‘moderne’ del potere.
Nel Centro e nel resto del Nord Italia, anche per effetto della lontananza dei poteri imperiali e di quelli
papali, e come risposta ai problemi e alle opportunità aperte in questa situazione, si è svolta invece
l’esperienza comunale, con la successiva trasformazione dei comuni in signorie e principati, esperienza
che, nel suo insieme, è la vera e propria sperimentazione della sovranità in senso moderno, modello e fonte
di ispirazione dei monarchi assolutisti francesi, ma adotterà in un secondo tempo, sotto l’influsso austriaco, i
modi di un ‘assolutismo illuminato’.
Salvo che sia diversamente indicato, questo paragrafo riassume parti dell’opera Storia del diritto pubblico italiano. Principii e
istituti di governo in Italia dalla metà del secolo IX alla metà del XIX secolo, Istituto Cisalpino, Milano-vaese, 1956, dello storico del
diritto sardo Antonio Marongiu (1902-1989).
1
Il Sud e la Sicilia compongono invece un percorso che, pur con differenze al suo interno2, è reso in qualche
modo unitario intanto dalla comunanza di sorte politica di queste aree, condizione istituitasi già nel
primissimo Medio Evo per essere questa zona del paese parte, prima, dell’Impero romano d’oriente, poi del
Regno normanno-svevo, anticipatore di forme statuali avanzate, poi nel suo complesso angioina, quindi
aragonese, quindi borbonica. Alcune caratterizzazioni del percorso di questa area, che la differenziano dal
Nord e Centro, sono in particolare il fatto che qui non avviene mai una completa messa da parte delle
concezioni miste e giurisdizionalistiche del potere proprie dell’ordine antico, e questo particolarmente in
Sicilia, il cui Parlamento dei Bracci (questo il nome, Parlamento, preso in Italia dalle assemblee dei
ceti, o stati) sarà l’ultimo ancora funzionante in Europa continentale in piena età napoleonica, di
tanto che l’Isola potrà rivendicare l’analogia tra la propria costituzione e quella inglese; il fatto che,
anche laddove l’assolutismo si instaura con più vigore a danno delle istituzioni antiche, e cioè nella parte
continentale del Regno di Sicilia, a Napoli, si tratterà sempre di un assolutismo meno interventista,
dinamico e trasformatore di quello di marca francese e settentrionale. La relativa ‘povertà’ di quest’area
corrispondeva anche, del resto, a un bassissimo livello di imposizione fiscale e a una diffusa accettazione
popolare della feudalità (o delle altre forme di strutturazione cetuale della società, come la presenza del
Clero quale ceto).
Altra caratteristica importante, anzi decisiva, della storia costituzionale e politica italiana, ma che non
potremo qui approfondire nel modo dovuto è la esistenza dello Stato della Chiesa; per l’influenza che il
papato ha sulle vicende politiche del territorio; per la persistenza, nello stato della Chiesa, di una
costituzione al tempo stesso antica, signorile e feudale, ma anche precocemente centralizzata intorno
all’amministrazione ecclesiastica; e anche per la tipica e del tutto eccezionale condizione di cosmopolitismo
che viene impressa a Roma dalla presenza del papato.
Le singolari a-sincronie della storia costituzionale della penisola emergono anche se si pensa alla
particolarissima costituzione del Friuli, dove un ordinamento di tipo antico fu mantenuto fino a che
Venezia, di cui era provincia, viene assorbita dall’Austria nel periodo napoleonico.
Quanto Domìni Sabaudi, ‘motore’ dell’unificazione nazionale, in questi territori già nella prima metà del
‘500, si era delineato uno stato ‘assolutista’.
Durante gli sconvolgimenti della prima metà del 1500 i duchi di Savoia persero i loro possedimenti finché
Emanuele Filiberto, dopo avere riconquistato in armi la Savoia, si vide restituiti i suoi possessi nel 1559 con
la pace di Cateau-Cambresis.
E’ appunto con Emanuele Filiberto che avviene nello stato sabaudo la svolta assolutista, e questo significò la
fine, per il ‘parlamento dei tre stati’, l’organo rappresentativo dei ceti, la fine del percorso che lo aveva visto
acquistare crescente potere e influenza e capacità di limitare le pretese dei duchi. Ancora nel 1442, di fronte
alla richiesta ducale di un donativo, ‘ i tre stati’ avevano mandato a consultare il collegio dei dottori
dell’Università di Pavia per sapere se il duca avesse o no il diritto di pretenderlo (Marongiu, p. 225); dopo la
svolta assolutista di Emanuele Filiberto,ispirata a una concezione del potere sovrano quale superiorem non
recognoscens, e svincolato all’interno dal rispetto dell’ordine tradizionale.
La rottura degli ordinamenti antichi, che Emanuele Filiberto realizzò, si giustificava col fatto che egli aveva
riconquistato il Regno militarmente, dunque non era obbligato a tenere in vigore il vecchio ordinamento;
non era tenuto ad alcuna gratitudine verso i sudditi, perché essi avevano tradito i loro sovrani accettando di
collaborare con la Francia; la sua svolta assolutista fu resa possibile anche dal fatto che guerre ed epidemie
avevano decimato la vecchia classe dirigente.
Emanuele Filiberto convocò gli stati l’ultima volta nel 1560, non giurò di rispettare gli antichi privilegi, ed
pretese comunque il pagamento delle contribuzioni: impegnato nell’espansione politica e militare dello
stato, nonché in una rigida persecuzione di Valdesi ed Ebrei, Emanuele Filiberto aveva bisogno di risorse,
ricorreva continuamente all’aumento delle imposte, e non vedeva di buon occhio i feudali attaccati ai loro
secolari privilegi, in specie a quello di concedere o negare i donativi.
Un percorso al quale si lega anche la Sardegna della dominazione aragonese, in cui l’Isola condividerà con Napoli e con la Sicilia il
rango di Vicereame del regno d’Aragona, per poi confluire, nel 1720, nello Stato sabaudo.
2
Eliminati gli stati, il re rimase l’unico potere costituzionale del paese, con esercizio esclusivo del potere
legislativo.
Mano a mano la monarchia sabauda andò rafforzandosi, essa diventò sempre più insofferente di freni e di
ostacoli: il Parlamento rimase in piedi, ma senza più rappresentare una autentica istanza dialettica nei
confronti del sovrano. Anzi, già con Carlo Emanuele III, nel sec. XVIII, fu escogitato l’espediente di
chiamare a parte delle decisioni del Sovrano, oltre al Gran Cancelliere, i presidenti dei due Senati (i
parlamenti di Torino e Chambery). In questo modo il Sovrano si rendeva sicuro a priori del pacifico
accoglimento dei suoi provvedimenti e le rappresentanze territoriali e cetuali venivano esautorate, a
vantaggio delle élite apicali (Marongiu, p. 327). Intanto, il potere di interinazione dei Senati (o Grandi
Tribunali) fu molto indebolito, posto che gli organi erano ormai una emanazione del sovrano e che lo
statuto prevedeva che ciascun Senato dovesse interinare l’atto a cui aveva fatto obiezione se per tre volte il
Sovrano lo ripresentava, e cioè dopo tre “giussoni” ( iussones, ordini, disposizioni del sovrano). La funzione
legislativa si concentrò nel sovrano, e dal Consiglio che lo affiancava, che diventerà il Consiglio di Stato. Le
province furono amministrate sotto il controllo dei prefetti.
Ricorreva tutto il corredo delle misure politico fiscali tipiche dell’assolutismo: sull’esempio delle pratiche
scorrette dei sovrani francesi, i Savoia per raccogliere denaro non mancarono per esempio di abolire, e
quindi riacquisire, i feudi non nobiliari, per poi rivenderli a più caro prezzo sempre a non nobili. I Savoia
“tassano tutto ciò che è tassabile rompendo le resistenze locali degli ultimi nuclei più o meno parzialmente
autonomi (feudali, laici ed ecclesiastici, comunità) e sono portatori di uno ‘uno sfrenato assolutismo’.
Sicilia, Napoli e Sardegna
Prima normanno-svevo, poi angioino, poi vicereame aragonese e infine regno borbonico, il territorio delle
Due Sicilie, nonostante i cambi di dominazione, si presenta nel suo complesso unitario e caratterizzato da
una certa conservazione delle concezioni di, che in effetti si mantiene in quest’area, e particolarmente in
Sicilia, in modo assai cospicuo. In Sicilia, fino all’età napoleonica si mantiene una costituzione feudale
medievale, legata a, e generatrice di, una tradizione autonomistica molto spiccata. Viceversa il Regno
di Napoli conosce una evoluzione in stile più assolutistico, dove però sopravvivono i privilegi di
autogoverno della città di Napoli, e dove lo stile di governo rimase assai meno interventista e
modernizzatore che non nelle aree del Nord e Centro.
In particolare, caratteristica distintiva della Sicilia fu di avere mantenuto una propria autonomia
costituzionale, incentrata sulle forme del governo misto, pur non essendo politicamente indipendente.
Storicamente, la particolare autonomia costituzionale della Sicilia si spiega coi modi in cui essa ‘si dette’
agli aragonesi3.
A differenza dei metodi che gli aragonesi avrebbero adoperato in Napoli e in Sardegna, il regno aragonese
adottò in Sicilia forme monarchico-parlamentari. Era un chiaro riconoscimento dello spessore dei poteri
ecclesiastici e feudali coi quali il sovrano si trova a confrontarsi in Sicilia. Il re rimetteva ai sudditi le
collette e le esazioni (manteneva cioè il modello della autoamministrazione) e anche in tema di tributi
governa d’accordo col paese.
Strumento dell’autonomia del Regno di Sicilia di fronte a quello di Aragona, di cui pure la Sicilia era parte,
fu l’istituzione parlamentare, vero organo centrale e direttivo della vita del paese insieme al sovrano.
Questo assetto venne sanzionato sin dalla riunione del parlamento del 1296, regnante Federico II
3
Morto Federico II nel 1250, si aprì in Europa la grande mobilitazione militare e politica che avrebbe visto la Francia dichiararsi
indipendente all’impero nel 1313, l’Inghilterra nel 1320, la Castiglia nel 1329; quanto all’Italia fu la Sicilia l’unica area per la quale
si parlò di una acquisita posizione di indipendenza dall’Impero. Qui, durante gli scontri tra angioini e svevi, aveva trovato la morte
Corradino di Svevia (1268). Egli venne giustiziato in seguito a una accusa di lesa maestà e in questa pronuncia fu vista “la
clamorosa sanzione della piena sovranità e indipendenza del Regno dall’Impero. Marino da Caramaico o altri giuristi del tempo
avrebbero ribadito il principio in termini assoluti dicendo che il re di Sicilia era re Libero, a nessuno soggetto, ossia che tutte le cose
del regno appartenevano a lui come all’imperatore appartenevano le cose dell’Impero”. (Marongiu, p. 165). Re di Sicilia fu
inizialmente Carlo d’Angiò. Dopo gli Svevi, infatti, la Sicilia fu occupata dagli Angioini, sostenuti dal papa, ma la dominazione
angioina venne mal sopportata e fu rovesciata per effetto dei Vespri siciliani (1282): innescata da una ribellione nobiliare contro i
francesi a Palermo, la rivolta si trasformò in una guerra che interessò tutta la Sicilia e, dato che gli angioini erano alleati del papa,
assunse un significato antipapale e nazionalistico che ne fece anche la causa di modifiche dell’intero scacchiere del potere su scala
europea. Di fatto, i Siciliani poterono rivendicare in seguito di avere scelto il proprio re, perché i Vespri si conclusero con la salita
al trono di Sicilia di Pietro III d’Aragona chiamato dai Siciliani, autori così del passaggio della Corona dagli angioini agli
aragonesi (il nuovo Re, inoltre, era siciliano per parte di madre).
d’Aragona, le cui conclusioni contennero l’obbligo del sovrano di convocare annuali sessioni della curia (o
parlamento); precisarono che del parlamento facevano parte conti, baroni, e sindaci idonei e sufficienti
forniti di mandato delle comunità territoriali di cui erano espressione; e definirono la competenza del
parlamento, in quella, illimitata, di procurare il bene e la felicità del re e del paese e l’obbligatorietà, anche
per il re, delle sue decisioni “essendo più che giusto che il sovrano dovesse per primo rispettare gli ordini
da sé medesimo impartiti”. Sul modello aragonese, alla fine del 1300 il parlamento venne costituito in tre
Bracci (clero, feudali, rappresentanti delle città demaniali, ossia non dipendenti da alcun feudale), e la sua
attività legislativa prese la forma di petizioni, da sottoporre al placet del sovrano, e di risposte di
quest’ultimo (leges pactionatae).
Si realizzava di lì in poi anche il sistema commutativo dei rapporti tra Sovrano e assemblea tipico del
governo misto: il sistema delle leggi pattuite (leges pactionatae), cioè sanzionate dal re in cambio del
corrispettivo del voto e della concessione, da parte dei Bracci parlamentari, di più o meno cospicui, e, di
fatto, periodici contributi finanziari, a carico degli abitanti del paese.
Con la salita al trono d’Aragona di Alfonso il Magnanimo la Sicilia si trasforma in Vicereame (attorno al
1420). Nel momento in cui il potere sovrano si allontanava dal territorio, il parlamento conobbe una
trasformazione: i Siciliani continuarono ad avere un parlamento, ma le leges pactionatae accentuarono
sempre di più una logica di ‘do ut des’ (dare una cosa per ottenerne un’altra in cambio), strumentale al
mantenimento di contingenti interessi più che del ‘bene’ del paese (coi donativi i ceti rappresentati in
parlamento danno contribuzioni al re in cambio della sanzione di leggi a loro convenienti).
I sovrani, sollecitando e accettando i donativi o sussidi finanziari, si impegnavano a loro volta a dare e a
conservare forza di legge alle proposte dei Bracci, le quali erano esaudite e sanzionate come “contratti o
leggi pattuite e convenute, irrevocabili in perpetuo, garantite da giuramento”.
Ferdinando il Cattolico eliminò il giuramento del re di osservare le leggi sanzionate a iniziativa del
parlamento di volta in volta che una legge veniva approvata. Da allora in poi, il sovrano giurava di osservare
le leggi del regno una volta per sempre: all’atto di presa di possesso del trono. Ma la sanzione parlamentare
sulle richieste del sovrano restava pur sempre il prezzo che quest’ultimo pagava in cambio del donativo, e il
voto di questo era e rimase lo strumento, o l’argomento, più efficace dei Bracci per realizzare la loro
funzione rappresentativa. Votare il donativo, d’altronde, significava anche esaminare e discutere l’impiego
delle somme concesse nelle sessioni precedenti e discutere la politica del governo viceregio. Durante il
primo periodo del regime vicereale, il parlamento apparve ancora non solo rivestito di un’alta autorità, ma
anche un organo rappresentativo perfettamente idoneo ai suoi compiti. Anche nella sua fase più tarda, il
Vicereame aragonese siciliano si caratterizza comunque come un governo assoluto ma nei limiti della
“legge del paese”, dove l’antica costituzione, rappresentata dal parlamento e dai suoi poteri di
sanzione, non si era mai spenta (Marongiu, p. 371).
D’altro canto, proprio perché il parlamento siciliano rimaneva la potente espressione dei Bracci, la necessità
di aggirarlo fece nascere prassi distorsive, come
l’uso di convocarlo solo dopo avere conquistato
l’appoggio, anche sulle più banali decisioni, dei parlamentari eminenti, o come l’uso per cui, per dare la
sanzione alle richieste del re, bastava il voto di soli due Bracci, con costi, alla lunga, non indifferenti: il
Parlamento usa il suo potere per barattare privilegi e favori, e lucrarne, mentre a sua volta il Viceré si
delegittima.
Con tutto ciò, però, va comunque segnalato il fatto che in Sicilia fino a tutto il ‘700 rimase il principio
del necessario coordinamento tra Re e Regno, del quale il Parlamento era l’espressione e la
rappresentanza, e la necessità di reagire al decrescente rispetto delle antiche leggi e consuetudini, nelle quali
si facevano consistere le garanzie dell’autonomia del Regno e del suo Parlamento, fu sentita ben più che
quella di abbandonare quel modello antico. Secondo gli storici, “il Parlamento siciliano fu quasi sempre
all’altezza dei suoi compiti istituzionali e della sua funzione rappresentativa” e in tal modo, anche grazie
agli studi storici e giuridici degli scrittori siciliani “venne a svilupparsi e a fare da freno all’indirizzo
autoritario dei viceré una specie di diritto parlamentare che determinava le funzioni del parlamento e
stabiliva i rapporti con la Corona”. (Margoniu).
Assolutismo ‘illuminato’
Nel Nord e nel Centro Italia il primo Settecento aveva segnato il passaggio dalla preponderanza spagnola a
quella austriaca: il Ducato di Milano è austriaco dal 1714, egualmente il Granducato di Toscana, dove i
Lorena mettono in cantiere una Costituzione illuminata, ossia contenente principi limitatori
dell’assolutismo, prima che Pietro Leopoldo lasci il Granducato per salire al soglio imperiale. In queste
aree, il ‘700 è il periodo delle riforme dei principi, e lo scenario intellettuale e politico si orienta all’idea
che sia necessario modificare la società sotto la guida dei governanti e in armonia con essi, intorno a nuovi
principi favorevoli agli scambi e al buon governo della cosa pubblica.
Si trattava di un’area che stava esperendo l’assolutismo illuminato di marca germanica.
Nel Regno delle due Sicilie, con Carlo III di Borbone re delle due Sicilie (1734-59) si era d’altro canto,
sotto l’impulso della stessa mentalità ‘illuminata’ un risveglio intellettuale di straordinaria portata:
intellettuali come Genovese, Filangieri, Mario Pagano, Vincenzo Cuoco propugnano la liberalizzazione
dell’economia, l’abolizione dei privilegi. Sotto il dominio borbonico, la Sicilia feudale e parlamentare
rimane attaccata alle tradizioni anche nel timore di essere assorbita in uno stato unitario accentrato e
napoletano; ciononostante si abolisce anche qui però la feudalità, nel 1812, e già nel 1799 è la prima
cattedra di diritto pubblico a Palermo, a segno di una diffusione significativa di una concezione
modernizzata della cosa pubblica (Marongiu, p. 431).
Dappertutto, altrove, gli antichi stati o bracci sono segnati a residui di assolutismo e mera espressione di
privilegio (Marongiu, p. 435).
Guerre Napoleoniche, Repubbliche rivoluzionarie, ‘francesizzazione’
Scoppiata la Rivoluzione, si innescano in Italia numerose seppure brevi o brevissime, e spesso tragiche,
esperienze costituzionali rivoluzionarie 4 che aprono all’ingresso della dittatura napoleonica, la quale
significherà per l’Italia trasformazioni forti e rapidissime.
Lo sguardo di uno storico come Marongiu è però disincantato: i francesi venivano a fare lezioni teoriche di
democrazia, ma, a quell’epoca, gli italiani ne avevano avute abbastanza e da istruttori nazionali.
I Lombardi già conoscevano il livellamento delle classi e il principio dell'eguaglianza nei diritti (pochi) e
nei doveri (molti) di tutti i sudditi. Più di un italiano stentò ad entusiasmarsi per la democrazia, come veniva
imposta e attuata manu militari (=con la forza delle armi) dal vincitore.
I primi effetti dell’arrivo di Napoleone sono rappresentati dal fiorire delle Costituzioni rivoluzionarie: è del
1796 la Costituzione della repubblica bolognese, del 1797 la Costituzione delle Repubblica cisalpina, che
viene redatta a imitazione della costituzione dell'anno III (1795). Il modello ‘imitativo’ non era condiviso
dai giuristi e intellettuali italiani: Melchiorre Gioia dedicò una lunghissima prolusione a sostenere la tesi che
le istituzioni giuste dovevano venirci dalla nostra storia, non essere copiate da altri paesi (p. 455).
Ma la forma di governo adottata dalle Costituzioni rivoluzionari fu appunto, spesso, copiata dalla Francia, in
cui due Consigli esercitano il potere legislativo e il potere esecutivo è affidato a un direttorio di 5 membri.
Dalla Francia si prese anche il calendario, e soprattutto delle Costituzioni francesi si seguì l’esito politico,
che vide la Costituzione del 1795 presto sostituita da una molto meno democratica, quella consolare. Nel
1802 Napoleone è Primo console e poi Re d'Italia; nel 1805 modella gli ordinamenti del Regno sulla sua
concezione centralizzante e cesaropapista.
L'eguaglianza è dei soli cittadini attivi e che avessero un certo censo, e più che di fronte alla legge, osserva
Marongiu, era una eguaglianza sotto la legge, cioè sotto il vigile controllo di uno Stato non meno
autoritario e sospettoso di quanto fosse stato quello austriaco. Ripristinata l'eguaglianza era venuta meno la
libertà, per esempio di circolazione, di stampa.
A rafforzarsi è solo il potere e il prestigio dei capi e funzionari dell'amministrazione (Margoniu: p. 467).
La Repubblica Cisalpina, Repubblica ‘sorella’ di quella francese rivoluzionaria ed estesa alla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
e Toscana, poi Repubblica italiana (1802-1815) quindi Regno d’Italia (1805-1815), sempre sulla scia delle trasformazioni
attraversate dalla Francia; altra Repubblica ‘sorella’ fu la Repubblica romana, proclamata il 15 febbraio 1798, caduta nel 1789 con
ripristino dello Stato pontificio.
4
Sul modello francese, gli enti locali sono privati delle proprie magistrature e posti sotto tutela, e il
procedere alla soppressione del 'mostro' della feudalità dà occasione di sostituire l’antica con una nuova
nobiltà in realtà burocratico- funzionariale, consonante col nuovo regime (p. 468). Mentre i libri scolastici
sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa, viene introdotto nelle introduzione nelle università lo
studio del diritto costituzionale, che funge da propalatore delle nuove concezioni del diritto, della polemica
contro l’antico, della svalutazione della cultura e delle tradizioni dei diversi territori.
Uno dei primi atti dei regimi rivoluzionari fu l’introduzione nel 1797 a Bologna, Pavia, Ferrara e altre
sedi, del diritto costituzionale, indirizzato al fine di assicurare ‘ nella più alta maniera l’insegnamento e
la diffusione delle sublimi teorie sopra le quali sono fondati i diritti dell’uomo e del cittadino, la
sovranità del popolo, il riparto dei poteri nella sovranità compresi, l’analisi dei bisogni della società e gli
offici dei magistrati”. Tale cattedra sostituì quelle di diritto romano, di diritto canonico, e di notariato,
col pretesto che queste fossero ‘inconcludenti e del tutto estranee allo spirito di una costituzione
repubblicana’. Le proteste dei dirigenti universitari contro tale soppressione apparvero alle autorità
“insidiosi maneggi controrivoluzionari” (Margoniu, p. 473).
Nel Regno napoletano il primo effetto delle guerre napoleoniche è la rivoluzione e la dichiarazione della
breve e tragica Repubblica napoletana (1799 ); dopo un temporaneo ritorno dei Borbone, il Regno di Napoli
è dato a Giuseppe Bonaparte, che procede alla soppressione della feudalità, che, peraltro, “nessuno odiava”
(p. 476) e alla riorganizzazione centralistica dello Stato, secondo principi formalizzati nello statuto del 1808
e mantenuti con l’avvento di Murat nominato da Napoleone re di Napoli e di Sicilia.
“Il governo del Regno, così sotto Giuseppe, come sotto Giacchino, era composto dal Re, dai Ministri e
da un Consiglio di stato di nomina regia, del quale facevano parte anche i Ministri, e che aveva il potere
di formulare ‘pareri’ che, con la sanzione del sovrano, diventano legge. Lo stato fu centralizzato come
non mai e organizzato su basi gerarchiche. L’amministrazione locale fu costituita sulla base di province
aventi a capo degli intendenti corrispondenti presso a poco ai presidi borbonici e ai prefetti napoleonici,
che curavano l’esecuzione delle leggi, soprintendevano alle forze di polizia, trasmettevano al governo le
notizie interessanti l’ordine e la pubblica utilità, dirigevano il personale degli uffici dipendenti,
vigilavano sull’attività dei comuni” (p. 477).
I prodromi della nostra storia costituzionale
Durante la presenza francese a Napoli, i Borboni si trasferirono in Sicilia, dove continuava a operare il
Parlamento, l'unico rimasto attivo, ormai, in tutta l'Europa continentale. I rapporti tra i Borbone e la Sicilia
non erano mai stati facili, perché il pur pigro disegno assolutista dei Borbone era considerato, dai Baroni e
dalla Chiesa siciliani, un rischio per i loro privilegi. Perciò, arrivato in Sicilia a chiedere i cospicui aiuti
necessari a tornare sul Trono di Napoli, Ferdinando I scelse una retorica d’occasione, ma comunque
rivelatrice della posizione goduta dalle istituzioni dell’Isola:
Prevedendo la probabile opposizione del braccio militare, ma sicuro di poter influire sugli altri due
bracci, il 15 febbraio 1810 Ferdinando domandava personalmente aiuti adeguati alla eccezionalità del
momento, sia per la difesa dell'Isola sia per la salvaguardia della costituzione del Regno e dei suoi
'pregi e vantaggi i quali non hanno più seggio se non in due isole, l'Inghilterra e la nostra Sicilia".
Per superare le resistenze dell’Isola alle richieste del sovrano apparve opportuno rivederne l’ordinamento,
fare una ‘riforma’: si iniziò così a lavorare per dare una costituzione alla Sicilia, discutendo se dovesse
assumere a modello la Costituzione tradizionale inglese o la costituzione di Cadice, del 1812, emanata dalle
Cortes (il Parlamento) spagnolo e che prevedeva una monarchia affiancata da un organo legislativo, sul
modello antico.
E’ a questo punto necessario ricordare che l’evoluzione costituzionale della Gran Bretagna, dopo la guerra
civile degli ani 1628-1659 e la ‘Gloriosa rivoluzione’ del 1688-89 aveva visto l’affermazione, in contrasto
con i tentativi assolutistici della monarchia, di un modello ‘parlamentare’ fondato sull’impegno della
Monarchia al rispetto del Bill of Rights.
Questo documento, riprendendo i principi della Magna Charta del 1215 garantiva al Parlamento (istituzione
di ordine antico risalente al secolo XIII e articolata in una camera alta (o dei lord) di nomina regia, formata
da nobiltà e clero, e in una camera bassa, dei comuni, a base territoriale, comprendente cavalieri e cittadini),
libertà di parola e discussione, vietava al re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del
parlamento, di tenere un esercito fisso in tempo di pace senza il consenso del parlamento, di perseguitare i
sudditi per motivi religiosi e prevedeva che il parlamento fosse elettivo.
Ne era risultato un sistema fondato sul principio secondo cui il Parlamento controlla la monarchia, e in
particolare ne controlla le spese, e il gabinetto (l’insieme dei ministri) e il primo ministro rappresentano gli
anelli di congiunzione tra Parlamento e Corona, in quanto responsabili per gli atti del Monarca.
Gli storici spiegano il successo della formula di governo inglese – la monarchia parlamentare – con la sua
efficienza sul piano sia politico, sia economico.
Una volta assunto il controllo delle spese, e in particolare, una volta ottenuto che la Corona ‘non fosse in
grado di fare le sue spese senza una convocazione annuale del Parlamento, i comuni spesso ci facevano un
affare, ed esigevano in cambio dei crediti un quid pro quo. Denaro non se ne votava finché il re non aveva
fatto anche lui qualche concessione, o rinunciato a opporsi a provvedimenti o indirizzi politici che gli
dispiacevano. Questo processo, ormai annuale, rese i comuni padroni della vita e della politica della corona e
condusse in breve tempo a un risultato che nessuno nel 1689 avrebbe previsto: la scelta dei ministri del re sul
nuovo principio che dovessero appartenere al partito che avesse la maggioranza nella Camera.’ (I partiti
tradizionali inglesi erano i whigs, l’aristocrazia fondiaria e il clero, e i tories, la borghesia commerciale ).
(Sebbene la Monarchia abbia lungamente tentato di governare per mezzo di ministeri misti, formati da whigs
e tories, tolto presto apparve necessario formare i ministeri di un solo partito, quello che disponeva della
maggioranza nella Camera dei Comuni, ciò che rafforzava moltissimo quest’ultima (L. Trevelyan, La
Rivoluzione inglese del 1688-89).
Avendo il potere di controllare le spese, oltre che in generale di condizionare il Governo, il Parlamento le
votava più volentieri, e questo permise di sviluppare una politica di prestiti governativi su garanzia
parlamentare e di debito pubblico che, insieme all’operato della Banca d’Inghilterra, fondata nel 1694,
consentirono all’Inghilterra uno sviluppo economico poderosissimo. Infatti “’gli uomini di denaro’ erano
congiunti da simpatia politica ai governi che nacquero dopo la rivoluzione; i magnati della City, molti dei
quali erano stati dissidenti [ai tempi della Monarchia Stuart ‘assolutista], spalancarono le borse a un sicuro
investimento nel debito pubblico garantito dal parlamento per appoggiare i governi nei quali hanno
fiducia”.(Trevelyan, cit.)
Così era avvenuto che il sistema politico e finanziario inglese si era arricchito e rafforzato enormemente
negli stessi secoli in cui invece ‘la finanza e la monarchia francese cadevano sempre più in basso, sino al
crollo del 1789’. (Trevelyan, cit.).
La monarchia parlamentare inglese era dunque la forma di governo nella quale istituzioni e principi di ordine
antico erano stati riorganizzati in modo funzionale alle esigenze del nuovo assetto, capitalistico, del mondo
produttivo. Pensare di ‘copiarla’ in un contesto economico e sociale totalmente diverso quale la Sicilia
borbonica era certamente una notevole ingenuità, ma rappresentava comunque una risposta molto chiara, in
termini negativi, al recepimento della formula opposta, quella della preminenza del nucleo rappresentato dal
Sovrano/Governo/Potere esecutivo sul Parlamento, verso cui si era orientata la parabola della forme di
governo in Francia.
Studiata dai Bracci, la nuova costituzione siciliana, che fu in vigore nel 1812-13, proponeva infatti un
modello ispirato all’ordine antico: prevedeva un forte parlamento composto da due Camere (dei Pari e dei
Comuni), che affiancava il Re. La funzione legislativa funzionava su proposta delle Camere, il Re poteva
solo o approvare o respingerne le proposte.
Se si fa il confronto con lo spostamento totale del potere legislativo sul Re e il suo Consiglio, e cioè sul
potere esecutivo, che nel frattempo si era compiuto (e che si era instaurarsi nel Regno murattiano di Napoli,
sul modello acquisito in Francia con la Costituzione consolare e, poi imperiale, napoleonica), si percepisce
piuttosto chiaramente il carattere del tutto asimmetrico della proposta costituzionale siciliana rispetto alle
tendenze allora dominanti in materia di conformazione del potere pubblico sul contnente. Poco dopo
l’entrata in vigore della Costituzione Ferdinando I lasciò l'isola per ritornare sul trono di Napoli e sciolse il
Parlamento, assicurando che ne avrebbe convocato un altro, ma poco dopo intervenne la Restaurazione
(1815), che chiuse questa esperienza costituzionale.
Le Restaurazioni
In tutta Italia la Restaurazione fu piena e fortissima, ma dovunque in Italia, si registrarono anche molti
elementi che segnalano che il periodo napoleonico si era innestato nel tessuto culturale e istituzionale come
fattore capace di produrre cambiamenti durevoli. Nel Lombardo Veneto, per esempio, abrogato il codice
napoleonico per l’Italia se ne adotta però uno nuovo nel 1811; anche nel Regno delle due Sicilie si adotta un
‘corpo completo di diritto patrio’ (il codice ferdinandeo 1819, di ispirazione napoleonica); nel 1837 Carlo
Alberto adotta il codice civile sabaudo.
La codificazione del diritto in Italia avviene nella piccola scala delle singole realtà politico-costituzionali
storiche: sarà soltanto il codice del Regno d’Italia del 1865 (sostanziale ‘esportazione’ del codice albertino)
a realizzare la ‘nazionalizzazione’ del diritto.
Dopo i fermenti del 1820, e in particolare lo scoppio di una rivoluzione liberale che in Sicilia ha toni
separatisti, il 1848 segna nuovi sconvolgimenti costituzionali, in cui si giova la partita che avrebbe da lì a
poco assegnato al Piemonte il ruolo di protagonista dell’unificazione nazionale, e al Regno delle Due Sicilie
il ruolo recessivo.
Due Costituzioni per l’Italia unita, due diversi modelli storici e politico-costituzionali
La prima Costituzione che nasce dai rivolgimenti del 1848 è quella siciliana, dopo che la Sicilia insorta
dichiara che non poserà le armi e non sospenderà le ostilità se non quando la Sicilia “riunita in generale
parlamento in Palermo o adatterà ai tempi quella sua Costituzione che, giurata dal Re, riconosciuta da tutte
le potenze, non si è mai osato di togliere apertamente a quest'isola”. La Costituzione siciliana del 1848 è
costituzione non donata, non concessa dai sovrani, ma redatta da rappresentanti del paese. Per redigerla,
bastò adattare la Costituzione del 1812-13, ma poi non la si seppe difendere davanti alla reazione borbonica,
e, soprattutto, ai timori che il cambiamento di governo aveva provocato nei ceti dirigenti, che pure
inizialmente lo avevano favorito, e anzi determinato: il nuovo regime resse sedici mesi 5. Ma le cause della
recessività del modello costituzionale siciliano non sono solo legate a questi fattori, bensì alla sua
intonazione, che guardava a un modello costituzionale di tipo antico, misto, parlamentarista, fortemente
contenitivo dei poteri del monarca/esecutivo. Una intonazione che appariva nell’Europa continentale, dopo
la Rivoluzione e il suo taglio col passato, recessiva e disfunzionale, o pericolosamente sorda ai tentativi di
ricostituzione dell’ordine istituzionale operati dalla Restaurazione.
La Rivoluzione siciliana si era compiuta nel nome della libertà. Per sottrarsi ai Borboni, i quali
avevano mancata fede all’Isola, che loro aveva dato infinite prove di fedeltà negli anni burrascosi, dal
1799 al 1815, e per rompere ogni vincolo di dipendenza con Napoli, la Sicilia die’ nel 1848 un
esempio di virtù politica, che da principio si impose al mondo. Insorse unanime, a giorno fisso, e
conquistò l’indipendenza: creò un governo di uomini virtuosi e una diplomazia, la quale non si perse
d’animo nei momenti di maggiore sconforto. Il Parlamento non proclamò la Repubblica, ma, volendo
conciliare repubblicani e monarchici, modificò stranamente, dopo una discussione di due mesi, la
“Sbolliti i primi ardori, i nobili e gli ecclesiastici cominciarono a temere per i loro privilegi: si videro minacciati negli averi, offesi
nelle credenze religiose, ed esposti a violenze rivoluzionarie e reazionarie. Quei vincoli di gerarchia sociale, fortissimi nell’Isola per
tradizione di secoli, si andavano via via rallentando. Il prestito forzoso, la tassa sulle rendite del clero, l’incameramento dei tesori
delle chiese e dei beni dei gesuiti non potevano trovare sinceri ammiratori nella nobiltà e nel clero: e quando la fortuna delle armi, e le
mutate condizioni d’Italia e di Europa non favorirono più la causa della Sicilia, i nobili, il clero e i benestanti più grossi si persuasero,
via via, che solo la restaurazione borbonica poteva reintegrare nelle plebi cittadine e campagnole l’ordine e la tranquillità. Appena
Catania fu occupata dalle truppe regie, la guardia nazionale e il Senato di Palermo, persuasi essere inutile ogni altro conato di
resistenza, fecero partire per Caltanissetta una deputazione, implorando la clemenza e dichiarando che Palermo si sottometteva alla
autorità del Re.” R. De Cesare, La fine di un Regno.
5
Costituzione del 1812, e creò un Re da parata, con una Camera di Pari, elettivi e temporanei!
(Marongiu)
Dichiarò decaduto non solo Ferdinando II, ma la dinastia sua, rendendo inconciliabile il dissidio coi
Borboni; non ottenne che il Duca di Genova6 accettasse la corona, e si ebbe una repubblica effettiva,
benché Ruggiero Settimo7 fosse presidente del Regno di Sicilia”8
Dietro la Costituzione siciliana, riviveva il governo misto di ordine antico, e si agitava lo spettro che più di
tutti spaventava i governi dell’epoca, quello repubblicano.
Marongiu è assai chiaro al riguardo:
“Se solo la Costituzione del Piemonte sopravvisse era perché le altre erano incompatibili con l’ordine
interno come lo intendevano, e riuscirono a imporlo, i governi della reazione.
1.3. La forma di governo disegnata dallo Statuto albertino: una monarchia costituzionale
pura e fortemente sbilanciata a favore del potere esecutivo
Lo Statuto albertino fu concesso nel 1848 da Carlo Alberto di Savoia al Regno di Sardegna e con
l’unificazione divenne la legge fondamentale del Regno.
Esso adottava, come forma di governo, la monarchia costituzionale pura, articolandola sui seguenti
principi:
6
-
Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo.
-
Il Re, la cui persona è detta ‘sacra e inviolabile’, detiene in esclusiva il potere esecutivo, che
esercita per potere proprio (prerogativa regia) insieme al proprio gabinetto, ministri e
collaboratori che nomina autonomamente e che rispondono solo a lui. (Recitava lo Statuto
albertino: Al re solo appartiene il potere esecutivo. Il Re nomina e revoca i suoi ministri. I
ministri sono responsabili). Egli è il Capo Supremo dello Stato, dispone delle forze armate e
del potere estero (dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri,
dandone notizia alle camere ove l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, cioè
senza esservi obbligato) e del potere di scioglimento delle Camere.
-
Affiancano il Re due Camere, di cui una nominata dal re (Senato regio, i cui membri sono
nominati a vita) e una (Camera dei deputati) elettiva (da un corpo elettorale inizialmente pari
al 2% della popolazione) e di durata quinquennale.
-
Mentre la funzione esecutiva è prerogativa del Monarca, la funzione legislativa spetta
insieme al Re e al Parlamento. Le leggi, deliberate dalle Camere, possono assumere vigore
solo se ricevono la sanzione regia, un atto di approvazione non formale ma sostanziale, nel
quale si esprimeva appunto la piena con-titolarità da parte del re della funzione legislativa.
Affermava lo statuto: Il potere legislativo sarà esercitato collettivamente dal Re e da due
Camere. Il Senato e quella dei Deputati. La proposizione delle leggi apparterrà al Re e a
ciascuna delle due Camere. Ogni proposta di legge, discussa ed approvata da una Camera,
sarà trasmessa all’altra per la discussione e l’approvazione, e poi presentata alla sanzione
Che era Ferdinando di Savoia, figlio di Carlo Alberto.
Un importante uomo politico e convinto liberale e separatista siciliano.
8 R. De Cesare, La fine di un Regno.
7
del Re. Se un progetto di legge è rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà più
essere ripresentato nella medesima sessione.
-
Secondo gli auspici della teoria del governo rappresentativo, le Camere non avevano alcun
potere di influire sul governo (Monarca+Ministri), che esisteva e seguiva il proprio progetto
politico indipendentemente dal bisogno della approvazione del Parlamento e
indipendentemente dagli orientamenti di questo rispetto alla sua politica.
-
Anche la funzione giurisdizionale ‘emana dal Re’.
Va altresì notato che il Re disponeva di un potere di emanare regolamenti, norme subordinate alla
legge e destinate alla sua applicazione, integrazione, esecuzione. In linea di principio, il potere
regolamentare del Re-Governo era dunque subordinato alla legge. Tuttavia, la subordinazione dei
poteri dell’esecutivo e del re al legislativo non si estendeva alla sfera di prerogativa regia, nella
quale il sovrano poteva prendere decisioni ed emanare atti senza il consenso delle Camere. Siccome
si estendeva a tutto ciò che aveva a che fare con l’interesse e la sicurezza dello stato, questa sfera
era molto ampia e dai confini elastici.
Dati gli ampi poteri riservati al monarca, è d’uso definire la forma di governo disegnata dallo
statuto albertino come una monarchia limitata ‘fortemente sbilanciata a favore del monarca’.
Poiché il monarca era il capo del potere esecutivo, e cioè del governo e dell’amministrazione, si può
altrettanto bene dire che si trattava di una forma di governo fortemente sbilanciata a favore del
potere esecutivo.
Le “modificazioni tacite” dello statuto albertino: verso la forma di governo parlamentare?
Secondo ciò che lo Statuto albertino testualmente prevedeva, le Camere non avevano il potere di
influire sul Governo, di determinarne la vita o di condizionarne le scelte, di influenzarne l’indirizzo
politico9.
Tuttavia, nella prassi ( e cioè senza un cambiamento delle regole formali, delle norme scritte, ma
sul piano dei comportamenti concreti di fatto) questo modello diventò, con l’unità d’Italia e
segnatamente verso la fine dell’ ’800, molto più articolato, e la forma di governo, da monarchico
costituzionale che era, si trasformò, sia pure con un processo discontinuo, in una forma di governo
che funzionava secondo principi diversi.
Per comprendere queste trasformazioni bisogna tener presente che nell’Italia unita la vita politica
diventò ben presto molto più complessa che nel Piemonte sabaudo e anche nella piccola e
omogenea (dal punto di vista degli interessi e delle mentalità che vi erano rappresentati) Camera dei
deputati dell’epoca cominciavano a prospettarsi visioni diverse, a contrapporsi visioni differenti del
modo in cui la nazione avrebbe dovuto essere condotta. Questo consigliò al monarca di tenere
distinti la propria persona e il proprio ruolo da quelli di coloro che componevano il governo, dai
ministri.
Il Monarca cessò di andare nelle Camere fisicamente, perché là il Governo poteva ricevere critiche,
che erano inadatte alla posizione del Monarca, in quanto ne avrebbero sminuito l’autorità, ma che al
9
Nel Parlamento Statutario quando si apriva la legislatura il Re rivolgeva un discorso alle Camere, nel quale raffigurava la sua
visione degli obiettivi cui la legislatura si sarebbe dovuta orientare. Le Camere rispondevano con un ‘indirizzo di risposta’ cioè una
mozione che accettava il discorso del Re. Questa è l’origine storica dell’espressione ‘indirizzo politico’, con la quale nel nostro
paese si descrive un’attività che è propria del Governo e del Parlamento: dare indirizzi al Paese.
Monarca sarebbero inevitabilmente risalite dato che esso era, secondo lo Statuto, indistinguibile dal
Governo.
Pur non perdendo alcuno dei suoi poteri formali, il Re uscì dalle dirette dinamiche politiche e
questo fece sì che cominciò a succedere che il governo (i ministri del re) oltre a organizzarsi
intorno a una figura preminente (il capo del governo) che ne riassumeva le caratteristiche e gli
orientamenti, tendesse a dare le dimissioni quando diventava evidente che non disponeva di un
sufficiente consenso nelle Camere, e in specie in quella elettiva.
Il governo formalmente non era tenuto a far questo, perché secondo lo Statuto esso rispondeva solo
al re; ma nei fatti si affermarono atteggiamenti che corrispondevano all’idea che il governo dovesse
rispondere anche al Parlamento, nel senso che se i suoi atti non erano condivisi dal parlamento, e in
particolare dalla Camera elettiva, il governo non poteva rimanere in carica.
Nasceva così l’idea di un nesso che legava il governo al parlamento, un nesso che viene definito di
responsabilità politica, in base al quale il progetto politico che il governo vuole realizzare deve
avere una condivisione anche nelle Camere, e quando quel progetto o non viene perseguito
come promesso o si dimostra sbagliato, o inopportuno, il governo ne risponde con le sue
dimissioni.
Il nesso di responsabilità politica che lega il Governo alle Camere Parlamento prende il nome di
rapporto fiduciario: il governo sta in carica in quanto il parlamento gli dimostra fiducia e
fintantoché questa fiducia rimane.
La forma di governo nella quale il monarca continua a influire sul governo (perché lo nomina) e
sulla legislazione (perché dà la sanzione alle leggi) ma dove comincia ad esistere anche un nesso
fiduciario tra governo e parlamento è quello che viene detta monarchia (o governo) parlamentare.
Il processo che vide il trasformarsi della forma di governo da monarchico pura a monarchico
parlamentare non fu lineare, non segnò un cambiamento da un giorno all’altro definitivo e
chiaro.
“Al contrario (…) fino almeno al trasferimento della Capitale a Roma (1871) non
mancarono casi in cui il Re esercitava del tutto autonomamente il proprio potere di revoca
delle compagini ministeriali che non gli fossero gradite, indipendentemente dal rapporto tra
queste e le Camere; il re mantenne sempre inoltre il comando effettivo dell’esercito e la scelta
del ministro della guerra.10”
Si trattò però di un sistema parlamentare che si mantenne ‘dualista’ perché – stando ad analisi
importanti, come quella dello studioso di diritto amministrativo e storico del diritto pubblico
Umberto Allegretti - il ruolo sociale e politico della monarchia non venne mai meno.
Il Re continuò a influire sulla politica, da una parte, tramite l’esercizio delle prerogative regie, cioè
dei poteri che il sovrano esercitava senza necessità del consenso, e talvolta
neppure
dell’informazione delle Camere: nell’uso delle prerogative regie si segnalò in particolare il potere di
ingerenza sulla politica estera e militare; dall’altra parte, il Re influiva sulla politica tramite i
contatti diretti che sempre intrattenne con uomini politici e di governo, i quali componevano un
autentico “partito di corte”, composto di rappresentanti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia.
10
Livio Paladin, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, p. 78.
Alla base di ciò, vi erano molte ragioni che non è difficile individuare.
Le trasformazioni della forma di governo nell’Italia liberale: riflesso delle contraddizioni del
periodo statutario, annuncio delle problematiche che si ripresenteranno in età repubblicana
(1) Per effetto del carattere molto ristretto del suffragio, la classe al potere rimase una ristretta
oligarchia, della quale le Camere erano l’espressione. Il fatto che il Parlamento (e tanto meno il
Governo) non divenne mai l’espressione di interessi sociali diversi o autonomi da quelli
dell’oligarchia dominante, e rimase anzi, per composizione, estrazione e cultura in larga parte assai
affine al Monarca, spiega perché i principi del parlamentarismo non si affermarono mai
definitivamente nel senso di precludere al Monarca di addivenire alla nomina o revoca del governo
sulla base di determinazioni proprie, non nascenti dal rapporto fiduciario tra governo e Camere.
Specialmente in situazioni di necessità, quando ragioni di ordine bellico o di ordine pubblico si
facevano avanti, era facilmente accettato il “ministero regio”. Così la forma di governo rimase
ancorata alla sua radice dualistica, e il governo finì per appoggiarsi sia sulla fiducia
parlamentare sia su quella regia, alternativamente, a seconda del contesto politico del
momento.
Le prerogative delle singole istituzioni (Parlamento, Governo, Re) non si stabilizzarono mai
in consuetudini capaci di garantire certezza del loro ruolo e limiti reciproci, ma risposero
sempre a un principio di convenienza politica, secondo un tratto che torneremo a osservare
nell’esperienza repubblicana, e che potremmo definire come tendenza, da parte degli
attori politici, a modellare le istituzioni secondo le loro convenienze o necessità.
(2) Il carattere oligarchico, quantomeno ristretto ed elitario, della classe politica statutaria, e le
regole, trasformistiche, che ne caratterizzarono il funzionamento, ci dice anche che l’evoluzione in
senso parlamentare della forma di governo non rispondeva se non in parte alla intenzione,
delle forze politiche presenti in Parlamento, di dare al Paese una organizzazione istituzionale
più rappresentativa della società, ma rispondeva anche, e forse piuttosto, al tentativo di quelle
forze di conquistare per sé un maggiore potere di influenza.
In teoria, infatti, il fatto che il Parlamento condizioni la vita del Governo significa, siccome il
Parlamento è, almeno in parte, elettivo, che gli eletti, ossia i rappresentanti della Nazione,
acquistano un peso importante nei confronti dell’Esecutivo.
Dunque, a condizione che la base elettorale da cui il Parlamento è eletto si allarghi, il maggiore
potere acquistato dal Parlamento può significare un maggior potere della società, degli elettori.
Sempre in teoria, quindi, evoluzione in senso parlamentare può significare ‘evoluzione
in senso democratico’ della forma di governo. Ma le esigenze dalle quali nasceva l’acquisto
di maggior peso del Parlamento non erano queste, o non erano soprattutto queste.
In realtà, la parlamentarizzazione della forma di governo fu una conseguenza del trasformismo
cui
due
soggetti politici dell’età statutaria, ossia la Destra e la Sinistra cd. ‘storiche’ improntaro
no i loro comportamenti in Parlamento.
Destra e Sinistra erano due schieramenti in cui si dividevano in parlamento gli eletti, che, come
poco sopra ricordato, provenivano però tutti dallo stesso ceto ed erano molto omogenei tra loro, pur
ispirandosi, nelle grandi linee, a diverse letture della storia risorgimentale e di quelli che avrebbero
dovuto essere i suoi esiti e, in questo senso, idealmente differenziandosi. Ora divenne subito un
tratto caratteristico del funzionamento della Camera elettiva che deputati che sedevano a Sinistra
poi votassero a favore di provvedimenti di un Governo composto dalla Destra, e viceversa
(trasformismo), per effetto di: tensioni interne allo schieramento; risentimento e inimicizia verso il
Primo Ministro di turno; previsioni o calcoli di convenienza circa chi sarebbe stato al Governo nel
periodo immediatamente successivo. In un quadro di questo genere, in cui cioè gli schieramenti
parlamentari, Destra e Sinistra, non erano coesi e stabili, un Presidente del Consiglio che
apparteneva a uno dei due schieramenti
sapeva di poter controbilanciare le
lacerazioni interne al suo partito appoggiandosi in parlamento al voto dell’altro. Oppu
re, i deputati del partito cui il Presidente del Consiglio apparteneva sapevano che potevano
controbilanciarne
il
potere,
persino farlo cadere, semplicemente votando con l’altro schieramento. In una parola:
il peso che la Camera acquista sul Governo è direttamente proporzionale all’interesse che gli
schieramenti politici avevano di condizionare quest’ultimo; e anche al Governo conveniva che le
Camere avessero influenza perché, nel quadro trasformistico, poteva trovare ora sull’uno ora
sull’altro schieramento appoggio per i suoi provvedimenti.
L’“evoluzione in senso parlamentare” della forma di governo statutaria risponde cioè non ad alti
obiettivi di democratizzazione della direzione politica del Paese, ma, in larga parte, alla ‘tattica’
delle forze politiche di cercare di influenzarsi reciprocamente, tenendosi l’un l’altra sotto scacco11.
Le pratiche trasformistiche, che incidono negativamente sulla stabilità della forma di
governo perché determinano una relazione instabile e sleale tra il Governo e la maggioranza,
sono una costante che si ripresenterà in età repubblicana: esse consistono in un
comportamento degli ‘eletti’ che tiene conto delle dinamiche e convenienze politico
parlamentari sacrificando ad esse gli ideali e gli impegni assunti davanti agli elettori.
Certamente, d’altronde, a spingere verso modificazioni del funzionamento della forma di governo
rispetto al modo in cui lo statuto la disegnava c’era anche un altro dato. Lo Statuto concesso ai
Piemontesi da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 era concepito in tutto e per tutto nella luce delle
esperienze istituzionali del Piemonte Sabaudo. Quest’ultimo, come ricordavamo poco sopra, era
uno stato precocemente assolutista, dove un Parlamento era sempre esistito, ma aveva ben presto
cessato di essere la espressione vitale degli interessi dei ceti e il luogo in cui, su un piano paritetico,
re e ceti individuavano accordi. Nel XVIII secolo in Piemonte esistevano due ‘Camere’ (chiamate
in realtà Senati, di Chambery e Torino) che condividevano col re il potere legislativo ma l’usanza
consolidatissima era che il Sovrano, per rendersi sicuro che i suoi provvedimenti fossero approvati,
prima e fuori dalla riunione dei Senati si incontrava coi loro Presidenti e si metteva d’accordo, poi i
Presidenti provvedevano a garantire che i Senati votassero come voleva il Re, esautorando le
rappresentanze dei ceti. Il modello cui guardava lo Statuto era, insomma, quello di un sovrano
legislatore che non era abituato a incontrare contrappesi: quando Carlo Alberto approvò lo
Statuto non poteva nemmeno concepire che le Camere potessero esprimere una reale dialettica
sulle proposte del Governo, cioè del Re, perché questo in Piemonte non si era visto né sentito da
secoli.
Inevitabilmente, il modello istituzionale statutario, tutto concepito con gli occhi del passato, non
poteva funzionare, come tale, applicato a un paese grande, impegnato nel processo
11
Destra e Sinistra, pur contrapposte, condivisero prassi di (mal)governo e interessi. Allegretti, nel suo Profilo di storia
costituzionale italiana, Il Mulino, Bologna, suggerisce che la Sinistra fece peggio della Destra perché, arrivata finalmente al potere
nel 1876, trovò in tutte le ‘magagne’ dello stato, dalla magistratura asservita alle finanze in crisi, comodi sistemi per regolare i suoi
conti con la destra e installarsi al potere saldamente.
Osservando anche che le tante critiche alzate da uomini della Destra contro la Sinistra sottacevano ‘quasi sempre le decis
ive colpe del proprio periodo di amministrazione’ (p. 494) Allegretti
suggerisce che si trattasse, già allora, dell’uso dei principi strumentale alla lotta politica (si rimprovera ad altri di non
rispettare questa o quella regola o criterio, quando a nostra volta non li si è rispettati e non si intende rispettarli).
straordinariamente complesso di riforma economica, sociale, giuridica e istituzionale che l’unità ha
rappresentato, dove le Camere, per quanto omogenee e frutto di un suffragio ristretto, erano
comunque la sede di dinamiche politiche ben più articolate di quanto potesse accadere nei Senati
sabaudi. D’altro canto, quel modello non poteva evolversi fino al punto di accettare la naturale
conseguenza della evoluzione in senso parlamentare. Quale è questa conseguenza? E’ presto detto:
se il governo per vivere ha bisogno della fiducia delle Camere, è razionale che, quando lo si
nomina, si cerchi di formare un Governo che avrà la fiducia delle Camere. In una forma di governo
parlamentare, infatti, sebbene le camere non necessariamente nominino il Governo (vi sono state
esperienze in cui ciò è stato, peraltro, tentato), tuttavia ne influenzano la scelta: se nella Camera la
maggioranza è di Destra, è naturale fare un Governo di Destra. L’indirizzo politico si concentra tra
parlamento e governo e il Monarca o capo dello stato assume un ruolo imparziale di garanzia del
corretto gioco delle parti, ma non di diretta decisione politica. Seguire questa evoluzione non era
possibile, però, senza contraddire il pilastro della forma di governo statutaria, cioè il principio per
cui il capo dell’esecutivo è comunque il re, e il governo è il governo del re.
L’’evoluzione’ verso la forma parlamentare era possibile, dunque, solo fino a quel certo punto in
cui non mettesse in discussione la titolarità nel solo monarca del potere esecutivo. Una riprova del
fatto che, nonostante il delinearsi di una specie di rapporto fiduciario tra parlamento e governo, la
forma di governo rimase sempre sostanzialmente dualistica, è anche data dal fatto che in quasi
nessuna occasione il Governo che era in carica all’atto della convocazione dei comizi elettorali si
sia dimesso davanti alle nuove Camere, quelle risultanti dall’elezione, benché i risultati elettorali
avessero dato origine, in Parlamento, a una maggioranza diversa da quella precedente.
La difficoltà a concepire che il ruolo di una istituzione (il Parlamento) sia naturalmente
quello di porsi in dialettica, costruttiva ma attiva, col Governo e controllarlo, ha
attraversato tutta l’esperienza repubblicana, che ha teso piuttosto alla perpetua
confusione dei ruoli delle due istituzioni.
Il periodo statutario fu dunque segnato da un andamento contraddittorio, che spingeva verso la
parlamentarizzazione ma anche contrastava gli esiti ‘naturali’ di quest’ultima; i limiti del modello
statutario, insieme alle prassi e alle mentalità delle classi dirigenti e della Monarchia, spiegano
come mai quel modello non seppe e non volle reggere, in particolare, davanti alla più grande sfida
che il presente portava con sé, cioè al sorgere di una forma di partito politico del tutto diversa da
quella dei partiti parlamentari d’epoca risorgimentale.
Il problema dell’estensione del suffragio e la nascita dei partiti politici di massa
La “parlamentarizzazione” della forma di governo si accompagnò anche ad un timido ma continuo
allargamento della base elettorale (fino al riconoscimento del suffragio universale maschile,
applicato nelle elezioni del 1921) e questo si accompagnò a sua volta alla formazione di partiti
politici di massa (il partito popolare, di ispirazione cattolica, il partito socialista) che si affermavano
come rappresentanti dei diversi interessi di cui le diverse parti della società erano portatrici.
Secondo i principi del governo rappresentativo, l’esperienza del Regno d’Italia ha contemplato fin
dall’inizio l’elezione dei deputati della Camera elettiva, ma questo non significa che esistessero sin
dall’inizio partiti politici di massa nel senso contemporaneo, la cui nascita data in Italia, e in altri
paesi europei, soltanto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Sino ad allora, gli eletti
alla Camera erano personalità eminenti sul piano locale, nobiluomini, professionisti, intellettuali,
che si candidavano in un collegio, a titolo individuale, e che poi, una volta eletti, si raggruppavano
alla Camera (orientavano cioè le proprie scelte di voto e le proprie iniziative) secondo accordi che si
formavano dentro la Camera medesima. Si parlava perciò di partiti parlamentari, cioè il partito era
un gruppo di deputati che procedevano d’intesa in relazione ai provvedimenti che erano via via in
approvazione o in generale alla politica del Governo di volta in volta attuale. Pertanto erano anche
frequenti i cambi di schieramento. Questa natura ebbe lo schieramento liberale nel Parlamento del
Regno d’Italia.
Il partito politico iniziò a cambiare configurazione quando a richiedere di avere influenza sulla vita
pubblica furono ceti o soggetti diversi dalla nobiltà e alta borghesia economica o intellettuale che
avevano seduto in parlamento sin dall’inizio del Regno. Queste ultime, portatrici di una estrazione
sociale, formazione e visione del mondo assai omogenea, si erano attirate sin troppo facilmente
l’accusa di concepire l’interesse generale sullo stampo del proprio punto di vista di élite dominante.
I nuovi soggetti cui i partiti politici di massa davano voce erano il proletariato, le classi subalterne
dei lavoratori salariati, organizzati nel partito socialista (fondato nel 1892), e i cattolici, che
immediatamente dopo la revoca del Non expedit, la bolla papale con cui Pio IX nel 1868 aveva
dichiarato la estraneità dei cattolici alla vita pubblica del Regno, dettero vita al partito popolare
(1919).
Tuttavia, il ricambio o almeno una piena reciproca legittimazione tra antichi partiti parlamentari
in cui si esprimeva il nucleo di interessi e di poteri fondativi dello stato liberale (la Destra e la
Sinistra Storiche) e i nuovi partiti di massa non avvenne mai, e alla resistenza dei primi, e del
blocco di mentalità, interessi e prassi che ad essi corrispondeva, nei confronti dei secondi, si deve
l’avvento del regime fascista.
Il fenomeno dei partiti politici di massa riflette un dato, che consiste nella esistenza di differenze di
fatto, ossia di condizioni economiche e sociali, che intercorre, nella società, tra le sue componenti,
nonostante l’uguaglianza giuridica tra i cittadini. Dopo l’abbattimento dei ceti, come sappiamo,
grazie all’affermarsi dell’eguaglianza di status, chiunque può salire (o scendere) nella scala sociale,
con lo studio, il lavoro, ecc., indipendentemente dalla propria estrazione familiare.
Tuttavia, per effetto della diversa distribuzione della ricchezza, si determinano ‘naturalmente’
gruppi sociali tra loro differenziati: coloro che vivono vendendo la propria forza-lavoro
(proletariato); coloro che possiedono i capitali e i mezzi di produzione (capitalisti), e un ceto
intermedio impiegatizio. Sono queste le ‘classi sociali’: che non sono ‘ceti’, perché l’appartenenza
ad esse non è determinata da uno status che si acquista con la nascita e che accompagna la persona
per tutta la vita, ma che rappresentano gruppi sociali portatori, per effetto delle loro diverse
condizioni materiali di esistenza, di condizioni di vita, valori e visioni del mondo tra loro
differenziate.
Il partito socialista prima (da cui si scisse, nel 1921, il partito comunista), poi quello popolare, non
nacquero, dunque, in parlamento come articolazioni interne a uno stesso blocco di interessi sociali,
come era avvenuto per la Destra e la Sinistra storiche, ma nacquero nella società, come associazioni
che si proponevano di rappresentare gli interessi di gruppi sociali diversi da quello espresso dai
partiti tradizionali; essi iniziarono a presentare alle elezioni propri candidati, cioè candidati che si
impegnavano a proteggere, nel loro lavoro in parlamento, le questioni care al loro elettorato, e a
contrastare iniziative che potevano danneggiarlo, a svolgere propaganda, stampare giornali e libri,
organizzare comizi e conferenze.
I partiti di massa premevano naturalmente per un allargamento del suffragio; nel nostro paese, la
lentezza e limitatezza delle estensioni del suffragio elettorale nascevano proprio dal timore che esso
avrebbe portato al ripetersi di quanto si era visto in Francia dopo la prima elezione a suffragio
universale maschile, nel 1848, allorché quando, come scrisse nel 1862, il liberale italiano Carlo
Cattaneo: “Per la prima volta si vide in Francia un operaio chiamato a sedere tra i governanti, il
miglioramento del destino degli operati fu posto tra i doveri della società e dello stato; e fu
riconosciuto, in quanti cittadini avessero anni ventuno, il diritto di influire al pari sulla cosa
pubblica”. Da liberale progressista o riformista moderato, Cattaneo sostiene che non si deve avere
paura della rappresentanza politica delle classi escluse, che erano viste dalle classi aristocratica e
borghese, alternativamente, o come ‘sovversive’ o come ‘incapaci’ di assumere responsabilità di
governo per difetto della necessaria esperienza e cultura. Ma molti non la pensavano affatto come
lui, e provavano preoccupazione, angoscia e scandalo davanti all’avanzata delle classi subalterne e
alla loro pretesa di condizionare l’azione delle istituzioni. Alcuni sinceramente pensavano che se
l’idea democratica avesse preso piede questo non avrebbe potuto che significare la fine dell’unità
dello stato, la fine dello stato stesso, perché gli interessi competitivi e confliggenti della società non
avrebbero mai potuto esprimere indirizzi unitari, garantire la stabilità e la pace.
In effetti, la nascita dei partiti di massa travolgeva l’idea, che aveva improntato di sé i regimi
della Restaurazione, che gli interessi dello stato, cioè dei gruppi dominanti, potessero valere
come interessi generali; metteva in dubbio la radice stessa dei regimi rappresentativi, che
ammettevano la rappresentanza degli interessi della società, ma solo in presenza del postulato che
interessi unitari dello Stato esistessero come tali, prevalessero sugli altri, e avessero organi specifici,
come il Re, a dar loro espressione e tutela. Con la loro stessa esistenza i partiti politici di massa
‘attentavano’ al principio-cardine dello stato liberale, ‘meno società nello stato’, perché quello cui i
partiti politici di massa tendevano era che la società contasse nella direzione dello Stato.
Perciò i partiti politici di massa furono visti dallo Stato liberale, e in specie da uno conservatore,
involuto, quale era il nostro, come una minaccia alla sua stessa esistenza.
Le idee cardine del regime ‘rappresentativo’ iniziarono nel corso dell’’800 e ancora più fortemente
ai primi del ‘900 a essere fortemente contestate da coloro che erano stati esclusi dalla possibilità di
far valere le proprie esigenze, bisogni, punti di vista, e di influire sulla vita pubblica. La borghesia
liberale, e lo Stato che ne era l’espressione, videro con grande timore l’emergere di una piccola
borghesia scontenta, e di un proletariato organizzato che, reclamando il diritto di votare e di dar vita
a proprie organizzazioni politiche (i partiti, appunto), intendeva arrivare a governare lo Stato in
modo più sensibile ai propri interessi, se non in nome di essi; ugualmente temuta era la pressione
delle forze cattoliche, tradizionalmente ostili allo stato ‘laico’ (il Regno si era pur sempre unificato
con la presa militare dello Stato della Chiesa), che chiedevano anch’esse una voce sulla direzione
politica del Paese. Preoccupavano le dottrine marxiste, che denunciavano lo Stato come apparato
funzionale al dominio di una classe sull’altra.
Non solo nel nostro Paese, questi timori si tradussero nella “crisi del parlamentarismo”, nel
risorgere di grosse diffidenze verso specialmente la Camera elettiva, che iniziava a rappresentare in
qualche misura il popolo. In Italia:
“Verso la fine del Regno di Umberto I fu rimesso in discussione lo stesso sistema
parlamentare già affermatosi in via di prassi, dal momento che si registrò una notevole spinta
verso un ‘ritorno’ alla monarchia costituzionale. Ma non era tanto lo Statuto che preoccupava:
ciò cui i conservatori, la destra, mirava in quegli anni era un governo ‘forte’, poco importa se
guidato dal Re stesso o da un Primo Ministro che fosse in grado di bloccare il naturale
sviluppo del sistema in senso democratico e sociale, specialmente per mezzo di leggi
restrittive delle libertà (come quella di stampa). Sulla legge limitativa della libertà di stampa
che il Governo intendeva introdurre si svolse un enorme contrasto tra Governo e Parlamento,
e il tentativo di scavalcamento del Parlamento in questo caso fallì: gli schieramenti
parlamentari della “sinistra” si opposero con l’ostruzionismo all’approvazione delle misure
restrittive della libertà di stampa; e i decreti legge coi i quali il Governo sperava di scavalcare
l’ostruzionismo parlamentare furono dichiarati inapplicabili dalla Corte di Cassazione.
“Questa prima crisi della forma di governo parlamentare si avviò a una rapida composizione e
nelle elezioni del 1900 la Sinistra si rafforzò, e ne seguirono i governi Zanardelli e Giolitti,
accomunati da una comune politica riformista, con l’adozione di misure di diritto del lavoro e
di intervento statale a sostegno dell’economia. La riforma più notevole fu quella che investì la
base elettorale, con una progressiva estensione del suffragio a tutti i maschi adulti
maggiorenni; gli aventi diritto a partecipare alle elezioni del 1913 furono il 23% dei cittadini
residenti del Regno contro il 7,5% delle elezioni del 1904 e il 6,9% delle elezioni del 1900.
Le elezioni del 1913 sembrarono dunque completare il processo di perfezionamento interno di
una evoluzione verso forme più democratiche dello Stato, ma in realtà segnarono l’inizio della
fine dell’ordinamento statutario, le cui strutture non si dimostrarono idonee ad assorbire le
spinte antitetiche e difficilmente componibili dei partiti di massa che si affacciavano sulla
scena politica, profittando del suffragio universale. Se nel 1913 i conservatori ancora ressero e
ottennero la maggioranza dei seggi, nel ’19, anche grazie a un cambiamento del sistema
elettorale (da maggioritario a proporzionale), essi subirono un vero e proprio tracollo, a
vantaggio di partiti relativamente nuovi come i socialisti e i popolari (cattolici).
Gli schieramenti politici tradizionali ne rimasero sconvolti a tal punto che in un breve torno di
anni si determina una nuova crisi, questa volta irreversibile. Per quanto la presidenza del
consiglio continui ad essere affidata ad esponenti della vecchia classe politica (Nitti, Giolitti,
Bonomi, Facta) la Camera e il corpo elettorale sono sempre meno inclini ad appoggiarla. Fra
il 1919 e il 1922 si succedono cinque governi, tutti incapaci di far fronte alla crisi istituzionale
e al dissesto dell’economia, seguito alla guerra in egual misura per i vinti come per i vincitori
e in questo vuoto di potere si inserisce il fascismo12”.
La nascita dei partiti, dei sindacati, le lotte popolari ed operaie, cui non erano estranee componenti
insurrezionali, rivoluzionarie, o accusate di essere tali sfociarono nel biennio 1898-99 in una crisi di
particolare gravità (che si ricorda come “crisi di fine secolo”) che ci ha lasciato, tra le tante
testimonianze di un conflitto sociale crescente e drammatico, il ricordo delle cannonate sparate
contro i manifestanti operai a Milano durante le quattro giornate del 1898 su ordine del Generale
Bava Beccaris, poi in premio di ciò insignito dal Re dei più alti onori militari. Il numero dei morti
rimase ignoto, ma fu certo superiore a cento persone; Milano e la sua provincia furono poste in stato
d’assedio, con la sospensione di tutte le libertà costituzionali e la devoluzione della giustizia ai
Tribunali di Guerra, secondo un rimedio che il governo statutario adottava regolarmente durante i
‘disordini’; furono arrestati numerosi esponenti politici, sciolte le relative organizzazioni.
Nonostante nell’immediato si sia dispiegata in seguito la politica distensiva e conciliatrice di
Giolitti, molte analisi vedono nei fatti del 1898-99 la premessa dell’onda lunga di reazione che
avrebbe portato il paese alla dittatura fascista.
12
Livio Paladin, Diritto Costituzionale, cit., p. 83.
L’ambiguo lascito di una ‘parlamentarizzazione’ della forma di governo che condusse
effettivamente al rafforzamento dell’Esecutivo e alla delegittimazione del Parlamento
Vi è stata allora davvero una trasformazione in senso parlamentare della forma di governo durante il
periodo statutario? E quale è stato il lascito dell’oscillazione tra governi regi e governi parlamentari
in questo lungo periodo? Il Parlamento si rafforzò veramente? E quanto? L’apparato esecutivo Re e
Governo, perse o acquistò poteri?
Per rispondere a queste domande bisogna ripartire dalla considerazione che le trasformazioni che
portarono verso una forma di governo di tipo parlamentare erano avvenute senza modificare
formalmente lo statuto, che rimase come era: esse avvennero cioè in via di prassi, furono modifiche
tacite. Queste modificazioni furono e furono viste come una crescita del potere di influenza del
parlamento, che nei fatti poteva condizionare l’esistenza in carica del governo. A sua volta, la
crescita di potere del parlamento corrispondeva a uno sforzo, sia pure modesto e titubante, di
aggiornare il disegno dello statuto alle esigenze di un paese divenuto più articolato, consapevole di
essere composto di soggettività e appartenenze diverse. La crescita dei poteri del parlamento, in cui
le modifiche della forma di governo si traducevano, veniva associata, e di fatto in parte almeno si
associava, all’affermarsi delle tendenze ‘democratiche’ che a giudizio dei conservatori mettevano a
rischio l’ordine costituito. Il fatto che le modifiche dello statuto fossero solo tacite rese allora facile
il diffondersi di opinioni che ne disconoscevano la doverosità, e soprattutto la legittimità. Di queste
opinioni fu il simbolo lo scritto di Sidney Sonnino, uomo politico della Destra storica, apparso nel
1897 e intitolato Torniamo allo Statuto, e che fu la punta di una letteratura ferocemente
antiparlamentare, che fiorì in Italia in quegli anni, rivelando le ansie che la trasformazione della vita
pubblica italiana sollevava nell’opinione conservatrice dominante. “Torniamo allo Statuto” voleva
dire: ricordiamoci che non esiste alcuna norma che imponga al governo di avere la fiducia delle
Camere. Se alle Camere ci sono maggioranze troppo progressiste, troppo democratiche, non
pensino di poter condizionare il Governo. Il Governo lo nomina e lo revoca il Re.
La critica del parlamento, che prendeva anche le forme di una ridicolizzazione della lunghezza e
dell’inutilità dei dibattiti, di una caricaturizzazione dei comportamenti degli uomini politici, sempre
raffigurati come bassi e meschini affaristi di second’ordine, serviva a diffondere la convinzione che
fosse assolutamente necessario restaurare il potere del sovrano. L’immagine sovente ripetuta
secondo la quale il governo era troppo debole per colpa delle pretese delle ‘consorterie
parlamentari’ in parte rifletteva le verità di un sistema politico involuto su se stesso e fragile, in
altra parte intendeva squalificare l’importanza e la dignità dei nascenti partiti, e la loro pretesa di
influire sulla politica nazionale. La polemica antiparlamentarista e antipartitica che segna il tardo
periodo statutario (e prepara il consenso verso un ‘governo forte’ che il fascismo offrirà)
conteneva dunque una grossa ed esplicita carica polemica anche, e forse soprattutto, contro l’altro
grande fenomeno che stava accompagnando la trasformazione del sistema di governo e della forma
di stato, vale a dire la spinta verso la democratizzazione.
E’ una polemica, quella antiparlamentare, che, pur non priva di basi nella realtà dei
comportamenti delle classi politiche, si ripresenta in Italia ogni qual volta si intende
giustificare una restrizione dei poteri dell’organo rappresentativo, il Parlamento, davanti al
Governo.
Considerate le osservazioni che precedono, si può dire che nell’Italia monarchica una vera e
propria conquista di centralità del parlamento nelle dinamiche della forma di governo, intesa come
legittimazione dell’organo in nome della funzione che esprime, la rappresentanza politica, non si
sia instaurata mai con forza. La crescita di ruolo del parlamento fu un evento assistito da
scarsissima legittimazione: lo si poteva raffigurare come una violazione dello Statuto, come una
scelta inopportuna, rischiosa per gli interessi dello Stato. Così, il Parlamento cresceva di ruolo, ma
anche restava debole.
Dall’altro lato, che cosa accadeva al Governo? La formazione di una forma di governo di tipo
parlamentare aveva risposto all’esigenza di rendere il governo un organo distinto dal Re, il quale
non poteva essere chiamato a rispondere alle Camere. Di fatto, l’esistere del Governo come un
collegio composto da un primo ministro e dai ministri, portò a un sicuro rafforzamento dei poteri
dell’esecutivo. Il “modellino” dello Statuto, pensato per la dimensione proto-ottocentesca del
piccolo stato sardo, era adatto a funzionare con un parlamento che insieme al Re fa le poche leggi
che servono al governo dello stato. Ma l’Italia unitaria dovette affrontare le esigenze di governo di
un paese grande, attraversato da disuguaglianze profonde, sempre sottoposto a enormi sforzi per
non “perdere” nella concorrenza economica, politica, militare e diplomatica con le grandi nazioni,
percorso da problemi sociali, economici e di ordine molto molto grandi. Nei fatti, il ruolo del
governo cambiò moltissimo rispetto a quello che lo Statuto attribuiva al “Gabinetto” del re, ma nel
senso che crebbe enormemente, approfondendo quella posizione di maggior forza rispetto a ogni
altro potere, che già lo Statuto attribuiva al potere esecutivo.
Il rafforzamento del governo si tradusse, da una parte, nell’allargarsi delle ipotesi in cui il governo
emanava regolamenti anche senza l’esistenza di una previa norma di legge che lo autorizzasse;
dall’altra parte, nell’acquisto di poteri normativi nuovi.
Durante il periodo liberale ebbe infatti inizio una prassi per cui il Governo, quando aveva necessità
urgente di emanare un provvedimento con forza di legge, o quando voleva evitare la discussione
parlamentare per non misurarsi col dissenso e la critica, anziché ricorrere al procedimento
legislativo ordinario adottava un atto d’urgenza (decreto legge) o si faceva dare una delega, una
autorizzazione, dal parlamento, per poi deliberare, con ampia libertà di scelta dei contenuti, un
decreto (decreto delegato). In questa forma furono adottati provvedimenti importantissimi, le leggi
di unificazione amministrativa, il codice civile del Regno.
La tendenza del Governo ad aggirare i limiti costituzionali del suo ruolo esercitando
poteri normativi che formalmente non detiene, o esercitandoli oltre i limiti consentiti,
si ripresenterà in modo accentuato nell’Italia repubblicana, dove, negli anni a noi più
vicini, è tornata come vedremo decisamente ad assumere il senso di evitare la discussione e
il dissenso parlamentare.
Possiamo dunque dire che sviluppo della “monarchia parlamentare” in Italia vede sì l’affermarsi di
un nesso tra Parlamento e Governo che vede crescere il ruolo del primo, ma testimonia anche:
a) debolezza dell’immagine, del consenso intorno al parlamento;
b) rafforzamento dei poteri dell’esecutivo, specialmente normativi (e in particolare: sviluppo di
atti normativi del Governo capaci di abrogare le leggi);
c) perdurante convinzione che il governo, almeno in caso di necessità, e cioè in mancanza del
consenso del parlamento, o al preciso scopo di evitare di chiedere questo consenso, per non
dare espressione a forze politiche sgradite, potesse sempre contare sulla fiducia del solo
Monarca.
Sono tratti che si ripresenteranno nell’esperienza repubblicana, non senza le ‘stimmate’ lasciate dal
periodo fascista.
B. La forma di governo durante il Fascimo
1.L’avvento del fascismo in Italia: continuità col regime liberale
Secondo il giuspubblicista Allegretti “la monarchia sabauda e una classe dirigente oligarchica
dominante sul piano politico, economico e culturale durarono fino al momento in cui, sotto la paura
del socialismo, passano alla diversa forma dello stato fascista”. In altri termini: l’avvento del
fascismo al potere segna in Italia sì un cambio di regime, ma non un cambio di classe dominante,
ed anzi è voluto dalle classi dominanti per non perdere la loro egemonia.
La nomina di Mussolini a capo del Governo, nel 1922, fu un esempio di ricorso del re alla propria
prerogativa di nominare il Governo senza tenere in considerazione gli orientamenti delle Camere e
gli schieramenti in esse presenti 13 . L’insediamento del regime fascista avviene cioè grazie alla
debolissima instaurazione in Italia di una forma di governo parlamentare, che esige che il Governo
sia l’espressione della maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento.
In effetti, la piegatura autoritaria di molti regimi europei tra le due guerre si spiega probabilmente
proprio con il timore delle classi che erano state egemoni di condividere il potere, o vederselo portar
via, dalle classi emergenti. Di fatto, e certamente non a caso, la dittatura fascista e quella nazista
hanno compiuto ben presto cosa l’azzeramento delle elezioni e la messa al bando dei partiti politici.
L’identificazione col capo e col partito unico, i bagni di folla, le esibizioni ginniche, le parole
d’ordine, il mito della razza, la sostituzione di appartenenze corporative alle appartenenze
ideologiche e partitiche, furono le pratiche e le teorie “narcotizzanti” che presero piede nel nostro
Paese, come nella Germania nazista. Questi furono i modi con cui le dittature europee della prima
metà del Novecento intesero ricostruire un senso di identificazione tra il popolo e lo Stato, sapendo
che le persone non credevano più nelle ideologie liberali dell’ “armonia” e volendo evitare che, al
posto di quelle ideologie, prendessero piede altri modi di appartenenza, quelli pluralistici che fanno
capo al partito, al sindacato, agli interessi comuni di diversi gruppi sociali.
2. Fascismo ‘movimento’ e fascismo ‘regime’
Si deve certamente distinguere un fascismo ‘movimento’ da un fascismo ‘regime’. Il fascismo
‘movimento’ fu uno dei molteplici fenomeni di contestazione e di crisi dello stato liberale, della sua
politica di ingiustizia sociale, privilegio e immobilismo, che segnarono gli inizi del Novecento e gli
anni tra le due guerre. Il fascismo fu vicino al sindacalismo rivoluzionario e anarchico, a movimenti
artistici d’avanguardia; espresse un’ansia di rinnovamento, di trasformazione e anche una
rivendicazione di originalità nazionale: denunciando i limiti e i fallimenti dello stato liberale, lo
contestava anche come copia modestissima di forme politiche che avevano la loro origine nella
storia di altri paesi, da cui le avevamo importate. Opposto al comunismo, esso aveva però un
messaggio sociale analogamente forte, che si rivolgeva, più che agli operai, ai contadini, agli
sradicati, ai reduci della guerra, ai piccoli imprenditori rovinati dalla speculazione economica: a
tutti coloro che soffrivano ingiustizie e non le razionalizzavano nelle concezioni marxiste del
conflitto di classe, ma non per questo le sentivano meno profondamente e drammaticamente. Il
fascismo ‘regime’ fu altra cosa, il frutto di un accordo tra un blocco conservatore decisissimo a
evitare la rivoluzione socialista e Mussolini, che si era ben presto rivelato disponibile a mettere le
sue squadre armate a servizio degli interessi conservatori.
Circa l’avvento del fascismo, occorre tener presente che nel 1919 si erano svolte le elezioni politiche, con metodo proporzionale,
che avevano dato la maggioranza ai popolari (cattolici) e ai socialisti. Tuttavia, nonostante il loro schieramento parlamentare fosse
minoritario, il Re aveva dato l’incarico di nuovo ai liberali (Giolitti). Nel 1920 scoppiò in tutta Italia una serie clamorosa di scioperi,
innescati dallo ‘sciopero delle lancette’ con cui gli operai della Fiat di Torino si erano ribellati al rifiuto della direzione della fabbrica
di modificare l’orario di ingresso degli operai dopo l’entrata in vigore dell’ora legale. I socialisti e i maggiori sindacati detterò però
agli scioperanti un appoggio molto debole, temendo altrimenti di perdere le proprie già deboli chances di essere considerati forza
politica idonea a esprimere il governo. Di qui, nel 1921, la scissione all’interno del partito socialista, da cui nacque il Partito
comunista (tra i cui fondatori Antonio Gramsci). Tra le gravi agitazioni del paese e la situazione di paralisi in cui il governo, che era
in minoranza, si trovava, vennero sciolte le Camere e indette nuove elezioni: erano le prime elezioni a suffragio universale maschile, e
le prime cui partecipavano i fascisti. Il partito che li esprimeva, ossia i Blocchi nazionali fascisti, ottenne 105 seggi contro i 123 dei
socialisti e i 108 dei popolari. Venne di nuovo nominato un nuovo governo liberale (Bonomi), nonostante il partito liberale fosse stato
sconfitto alle elezioni. Mussolini decretò la marcia su Roma. Il Ministro dell’Interno, Facta, presentò al Re un decreto per porre Roma
in stato d’assedio, onde isolare e respingere i drappelli fascisti. Il Re rifiutò di firmare e dette l’incarico a Mussolini. Il re ricorrerà alla
prerogativa regia una seconda volta: quando il 25 luglio del 1943 convocherà al Quirinale Mussolini ‘sfiduciato’ dal Gran Consiglio
del Fascismo, per revocarlo (all’uscita dal palazzo Mussolini sarà arrestato), verosimilmente nell’intento di affermare l’autonomia
delle sorti della Monarchia da quelle del Fascismo, in quel momento ormai travolte dal declino, e in vista delle scelte future
sull’assetto istituzionale del Paese.
13
4. La forma di governo durante il fascismo
I provvedimenti che, in Italia, la dittatura fascista adottò circa la forma di governo sono tutti
leggibili come risposte, in chiave autoritaria, ai problemi che avevano agitato la nostra società tra la
fine dell’800 e l’inizio dell’800. Essi sono altrettante reazioni contrarie sia alla
“parlamentarizzazione” del governo sia alla democratizzazione della vita pubblica che stava
seguendo la via della nascita e diffusione dei partiti e dei sindacati.
5. Accentramento nel Governo, espressione del partito nazionale fascista, dei poteri normativi
e di indirizzo
Si deve ricordare in particolar modo la legge n. 100 del 1926, la quale trasformò il Primo Ministro
in “Capo del Governo”, eliminando ogni forma di rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e
rafforzò il potere normativo del governo consentendo a quest’ultimo l’adozione, in sostanza priva
di limiti, di atti normativi con forza di legge (decreti legge e decreti delegati) e di una ampia
gamma di poteri regolamentari che potevano essere adottati in mancanza di previa legge.
Il Parlamento veniva così escluso sostanzialmente dalla funzione normativa.
Come sappiamo, lo Statuto rendeva il Re parte del potere legislativo, ma gli negava il potere di
“dispensare dalle leggi o sospenderne l’osservanza”. Il Monarca, o meglio l’Esecutivo, non aveva il
potere di porre nel nulla, con propri provvedimenti o atti normativi, i deliberati parlamentari. Nella
prassi, specialmente tra la fine dell’Ottocento e i primi due decenni del Novecento, in Italia come
altrove, erano però invalsi i decreti legge, provvedimenti emanati d’urgenza dal Governo e capaci di
sospendere l’efficacia delle leggi, sia pure sottoposti alla conversione in legge come condizione per
divenire definitivi, e altresì era invalsa la prassi che vedeva la Camera delegare al Governo
l’esercizio di poteri legislativi su singole materie. Il fascismo si appropria di questi strumenti, e,
avendo eliminato la natura rappresentativa della Camera e il rapporto fiduciario tra essa e il
Governo, fa di quest’ultimo, e dunque di se stesso, il centro normativo del sistema. La legge n. 100
del 1926 prevede che il Governo possa emanare decreti con forza di legge destinati a una vigenza
provvisoria di due anni e rinnovabili; prevede inoltre che la Camera possa delegare poteri
legislativi al Governo “in bianco” cioè senza bisogno di definire l’oggetto, i tempi e modi in cui il
Governo eserciterà questa prerogativa.
In più, la legge n. 100 del 1926 disciplinò i poteri normativi secondari, o regolamentari, del
Governo. La legge n. 100 autorizzò il Governo a emanare regolamenti, oltre che per dare
esecuzione alle leggi (e cioè, ormai, agli atti normativi che esso stesso emanava: regolamenti
esecutivi), per regolare materie per le quali non esistesse ancora una disciplina legislativa
(regolamenti indipendenti), nonché per disciplinare l’organizzazione amministrativa, quand’anche
già regolata con legge, in modo nuovo, cioè difforme dalle leggi previgenti (regolamenti delegati).
Questa tipologia dei regolamenti del Governo, che li distingue in esecutivi, indipendenti e delegati,
sarebbe rimasta vigente in Italia fino al 1988, anno in cui la legge n. 400 ha riordinato le
attribuzioni regolamentari del Governo (nei modi che vedremo).
Con una legge del 1925 il fascismo revisionò la struttura del Governo. La legge istituì la figura del
Capo del Governo, Duce del Fascismo: si voleva evitare che, come era accaduto nel periodo
precedente (nonostante le contrarie previsioni dello Statuto) il Governo fosse attirato nell’orbita del
Parlamento, cioè condizionato da quest’ultimo. La legge del 1925 volle evitare questa eventualità
che il Governo ha una sua identità e un suo capo; la fiducia parlamentare, cui per prassi i governi
statutari ogni tanto guardavano, venne abolita. Il Governo è l’espressione di una sola parte, che è
poi l’unico partito legittimo. I Ministri sono ancora nominati dal Re, come vuole lo Statuto, ma la
proposta è riservata al Capo del Governo, che sarà anche Segretario del Partito nazionale fascista: il
tratto totalitario del partito unico che occupa lo stato è qui manifesto.
Con questi interventi il fascismo costruisce il Governo come istituzione forte, ben contornata di
poteri utili a garantire l’efficacia e l’effettività della realizzazione del suo disegno, verso il quale
può procedere autonoma, cioè senza venire influenzata dal basso, dalle opinioni, dai bisogni, dagli
interessi nascenti nella società. Agli italiani era stato ripetuto talmente tante volte che i problemi
della Nazione nascevano dal fatto che il Governo era ‘debole’ (non dotato di sufficienti poteri) e in
mano alle ‘consorterie parlamentari’, ‘vittima’ delle pressioni dei partiti, che essi accettarono
facilmente una dittatura la quale, mentre aboliva le elezioni e criminalizzava il dissenso, diceva di
agire nel bene della Nazione e per le sue sorti trionfanti e ‘progressive’.
6.Trasformazione in senso plebiscitario del sistema elettorale
Nel 1928 il sistema elettorale fu trasformato in senso plebiscitario: la lista dei candidati alle elezioni
era unica, e veniva formata da un organo del Partito nazionale fascista, il Gran Consiglio del
Fascismo, che fu trasformato nel 1928 nell’organo di coordinamento e integrazione di tutte le
attività del fascismo. Il Gran Consiglio, presieduto dal Capo del Governo, sceglieva i candidati sulla
base delle indicazioni delle associazioni fasciste. Al corpo elettorale non restava che suffragare in
blocco la lista (elezioni del 1929 e del 1934).
7.Trasformazione in senso corporativo della rappresentanza
Nel 1939, con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, venne a cessare ogni parvenza di
rappresentatività del Corpo elettorale nel Parlamento: mentre il Senato rimaneva composto di
membri nominati e non eletti (e nominati sulla base di scelte del regime), la Camera non era più
elettiva, ma veniva composta, oltre che dal Duce del Fascismo, dai componenti dei Consigli
nazionali del Partito nazionale fascista e delle Corporazioni, organismi espressivi dei datori di
lavoro e dei lavoratori, controllati dal Governo e dal PNF.