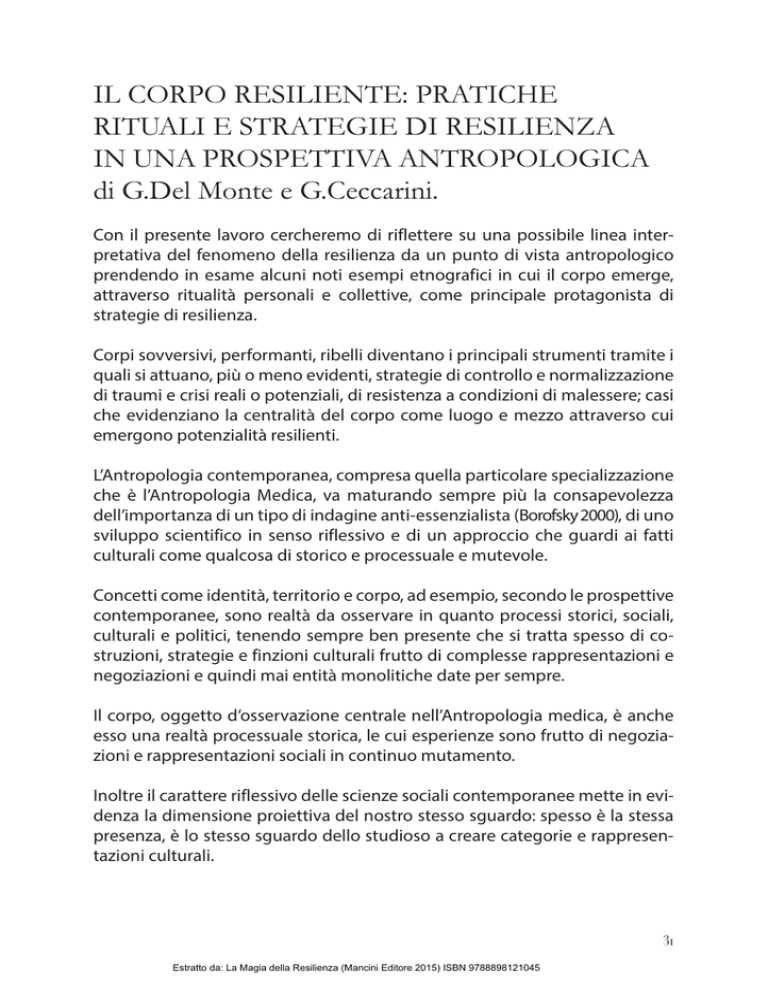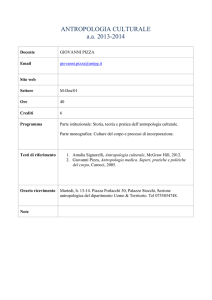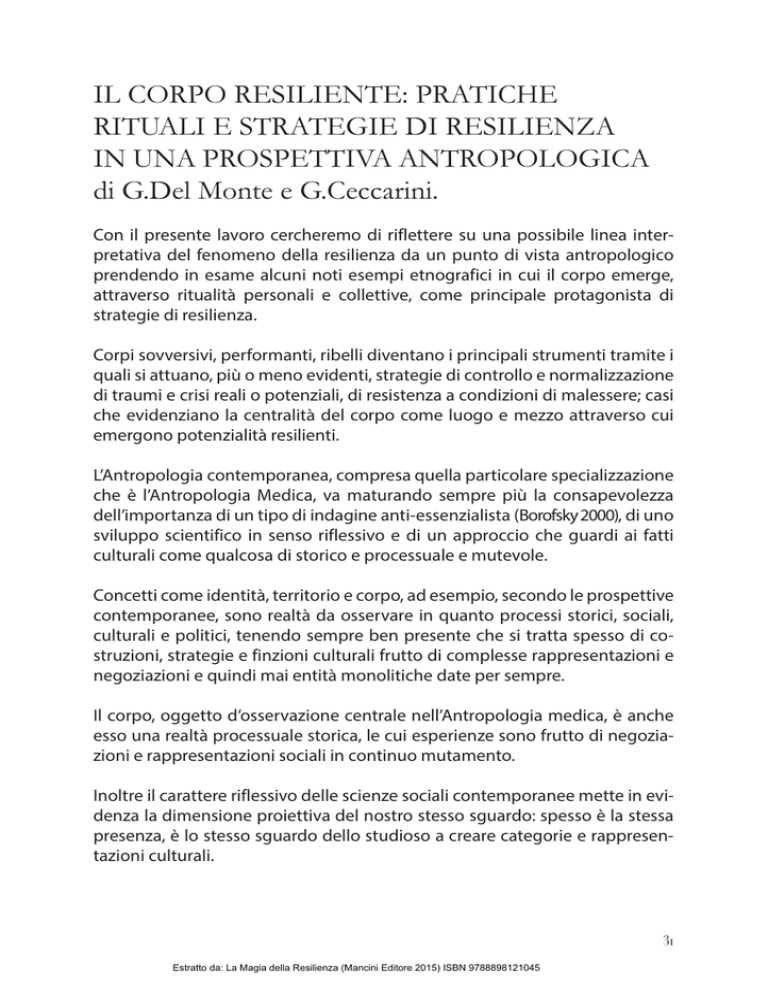
IL CORPO RESILIENTE: PRATICHE
RITUALI E STRATEGIE DI RESILIENZA
IN UNA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA
di G.Del Monte e G.Ceccarini.
Con il presente lavoro cercheremo di riflettere su una possibile linea interpretativa del fenomeno della resilienza da un punto di vista antropologico
prendendo in esame alcuni noti esempi etnografici in cui il corpo emerge,
attraverso ritualità personali e collettive, come principale protagonista di
strategie di resilienza.
Corpi sovversivi, performanti, ribelli diventano i principali strumenti tramite i
quali si attuano, più o meno evidenti, strategie di controllo e normalizzazione
di traumi e crisi reali o potenziali, di resistenza a condizioni di malessere; casi
che evidenziano la centralità del corpo come luogo e mezzo attraverso cui
emergono potenzialità resilienti.
L’Antropologia contemporanea, compresa quella particolare specializzazione
che è l’Antropologia Medica, va maturando sempre più la consapevolezza
dell’importanza di un tipo di indagine anti-essenzialista (Borofsky 2000), di uno
sviluppo scientifico in senso riflessivo e di un approccio che guardi ai fatti
culturali come qualcosa di storico e processuale e mutevole.
Concetti come identità, territorio e corpo, ad esempio, secondo le prospettive
contemporanee, sono realtà da osservare in quanto processi storici, sociali,
culturali e politici, tenendo sempre ben presente che si tratta spesso di costruzioni, strategie e finzioni culturali frutto di complesse rappresentazioni e
negoziazioni e quindi mai entità monolitiche date per sempre.
Il corpo, oggetto d’osservazione centrale nell’Antropologia medica, è anche
esso una realtà processuale storica, le cui esperienze sono frutto di negoziazioni e rappresentazioni sociali in continuo mutamento.
Inoltre il carattere riflessivo delle scienze sociali contemporanee mette in evidenza la dimensione proiettiva del nostro stesso sguardo: spesso è la stessa
presenza, è lo stesso sguardo dello studioso a creare categorie e rappresentazioni culturali.
31
Estratto da: La Magia della Resilienza (Mancini Editore 2015) ISBN 9788898121045
‹‹In tal modo l’antropologia medica è portata a riflettere su se stessa, consapevole che anche l’antropologo è dotato di un corpo che non è possibile estromettere
dalla scena conoscitiva.›› (Pizza G. 2005: 15).
Il merito dell’Antropologia Medica è stato quello di svelare il carattere storico-culturale della Biomedicina1 denaturalizzando l’ideologia scientifica
attraverso il metodo della comparazione e svelandone dunque il carattere
dominante rispetto ad altre pratiche “non ufficiali” di cura e rappresentazioni
della malattia.
Ciò ha permesso di superare il riduzionismo biologico della Biomedicina
indagando i rapporti di forza e di potere che sono alla base dei processi di
istituzionalizzazione del ruolo del malato e del medico e di porne in evidenza
la dimensione egemonica dei saperi a causa della quale la Biomedicina scrive
nei corpi le modalità del vivere la malattia, occultandone di conseguenza la
dimensione simbolica, sociale e politica.
Affrontare le problematiche della malattia, del corpo e le pratiche della cura
con questa consapevolezza riflessiva significa dunque considerare la Biomedicina un “sistema culturale” tra tanti, esplorandone i modi in cui essa è socialmente, culturalmente e storicamente costruita e le modalità con cui influenza
la vita dei pazienti, dei medici stessi e degli individui.
Il contributo antropologico alla medicina è stato inoltre alla base di un percorso di liberazione della nozione di “corporeità” da un’esclusiva concettualizzazione biologica, arrivando quindi a denaturalizzare realtà e concetti spesso
percepiti come “naturali” come il corpo, la salute e la malattia ma che in realtà
ci appaiono come fenomeni, oltre che naturali, anche storico-culturali.
Almeno fino agli anni Settanta l’Antropologia Culturale aveva analizzato saperi e pratiche dei sistemi medici di culture “altre” senza problematizzare il
sistema medico occidentale.
La Biomedicina come nuovo oggetto di studio e ricerca, e quindi l’Antropologia Medica come specializzazione disciplinare autonoma, nascono nel
momento in cui l’osservazione etnografica si sposta anche sulle società complesse.
1 Il termine-concetto di Biomedica in uso in Antropologia Medica definisce il sistema medico occidentale distinguendolo da altri
sistemi medici, saperi e pratiche di cura.
32
Gli antropologi della Harvard Medical School, tra cui Arthur Kleinman, psichiatra e antropologo, e Byron J. Good, docente di Antropologia Medica, sono
i primi protagonisti di questa nuova prospettiva centrata sull’analisi della dimensione culturale e storica dei saperi e delle categorie della Biomedicina.
La scuola di Harvard sperimenta una metodologia di studio dialogico e interpretativo delle forme narrative, dei racconti prodotti dai pazienti (narratives)
i quali comunicano la propria percezione soggettiva della malattia (illness).
Tale approccio innovativo ha avuto il merito di ‹‹sottrarre la definizione della
malattia ad un codice biologico “oggettivo e “naturale”, ponendo al centro dell’attenzione analitica dell’antropologia la dimensione culturale dell’esperienza del
malessere›› (Pizza G. 2005: 85) ma, contemporaneamente, l’accento posto alla
dimensione dialogica e narrativa, ha perso di vista la contestualizzazione dei
resoconti e delle storie personali nella realtà sociale, storica e socio-politica.
Il limite, infatti, di questo approccio è proprio il ruolo marginale attribuito alle
dinamiche sociali, economiche e di potere; limite che negli anni Ottanta è
stato discusso e analizzato da vari autori.
A. Zempléni, antropologo francese, ad esempio rivolge una critica diretta alla
suddivisione della malattia nei tre concetti di disease, illness e sickness2 sottolineando come tale tripartizione rischi di non evidenziare la reale interazione
fra i tre ordini della malattia e altri innumerevoli ordini possibili.
Antropologi come Ronald Frankenberg e Allan Young sottolineano come
l’approccio antropologico alla illness si limiti a privilegiare la percezione soggettiva del malessere del paziente e di come quindi sia sostanzialmente un
approccio clinico privo di prospettive di analisi dei processi di costruzione
storica delle categorie biomediche di malattia.
Nel caso in cui la socializzazione del malessere diventi oggetto di conflitti sociali e politici, gli approcci narrativisti, concentrandosi sulla illness, rischiano
di ignorare la dimensione sociopolitica particolarmente evidente nei casi di
malattie derivanti dalle condizioni di lavoro.
2 In inglese esistono tre diverse parole per definire la malattia: illness, disease e sickness. Tutti e tre i termini sono stati assunti dall’antropologia medica
anglosassone per indicare tre dimensioni della malattia talmente diverse da essere osservate come realtà distinte: illness è l’esperienza soggettiva del
malessere, il vissuto del disagio, lo stato di sofferenza così come è percepito dal sofferente stesso; disease è invece la definizione biomedica di malattia,
la condizione patologica oggettivata come alterazione dell’organismo e denominata in un etichetta nosologica nei saperi della medicina occidentale in
base a segni e sintomi interpretati da un punto di vista esterno al corpo del sofferente (lo sguardo diagnostico del medico); sickness è il significato sociale
dello star male, (Pizza G. 2005:83-84)“il ruolo sociale del malato, formalizzato all’atto della diagnosi”(Pandolfi, 1986).
33
Barbara Smith in un saggio del 1981 analizza la produzione sociale della malattia facendo riferimento alle storie del “polmone nero”, la silicosi, tra i minatori di carbone in Virginia negli Stati Uniti evidenziando come la malattia colpisca gli operai nelle miniere e non i proprietari delle compagnie minerarie.
Il corpo mediante la malattia traduce e traspone quindi i conflitti insiti nelle
relazioni sociali, incorpora le ineguaglianze. ‹‹Le relazioni sociali dunque producono non solo la malattia del minatore, la sua illness, ma determinano anche la categoria biomedica, la disease, che non è quindi “oggettiva”, ma riflette
anch’essa i rapporti di forza e di potere dentro i quali le diagnosi sono prese››
(Pizza G. 2005: 87-88).
La silicosi non riguarda in egual modo tutti i lavoratori delle miniere ma si
differenzia in base alle varie condizioni di lavoro come ad esempio la quantità
delle polveri e la ventilazione degli ambienti.
Per determinare gli indennizzi destinati ai minatori malati, la biomedicina, e
in questo caso, i medici scelti come periti dalla compagnia mineraria, hanno
elaborato un sistema che è spesso oggetto di discussione.
I noduli che si formano nei polmoni in seguito alla respirazione delle polveri
si presentano agli esami con una certa opacità misurata in millimetri: i medici
hanno così stabilito un limite “oggettivo” di visibilità del nodulo entro il quale viene stabilito l’indennizzo, offuscando così completamente quella che è
la sofferenza individuale di ogni caso, impossibile da misurare in centimetri
quadrati.
La messa in opera del “dato oggettivo” fa scaturire la protesta: i minatori pretendono di essere risarciti in base alla loro “personale” sofferenza. In questa
prospettiva la malattia appare come un’incorporazione delle ineguaglianze
messa in evidenza dall’analisi delle dinamiche di potere che regolano i processi di salute e malattia e dall’esplorazione delle interazioni tra benessere
fisico e economia politica.
Molti dei dibattiti sulle relazioni umane e sulla vita sociale affrontati in antropologia, afferma Nancy Scheper-Hughes, si lasciano dietro un progetto
fallimentare, perché ignorano l’esperienza vissuta del body-self, del corpo
individuale.
34
Nelle analisi dell’antropologia sociale il corpo è sempre stato descritto come
uno strumento per l’iscrizione sociale, privo di soggettività: il corpo come
pelle sociale, sagoma, palcoscenico simbolico su cui il dramma della socializzazione è messo in scena (Turner T.); il corpo come incorporazione o somatizzazione della cultura (Bourdieu P.); corpo passivo, medicalizzato e violato,
privo di soggettività (Foucault M.).
Sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso Nancy Scheper-Hughes e
Margaret Lock, come fa notare Giovanni Pizza, affrontano il problema della
riconfigurazione unitaria del corpo ‹‹inteso dalle due antropologhe, come “un
modello culturale” occidentale di lunghissima durata, radicato nella filosofia di
Aristotele, nella medicina di Ippocrate e sancito da Cartesio nel Seicento›› (Pizza
G. 2005: 54).
Lo scopo delle osservazioni delle due studiose era di spingere l’antropologia
medica fuori dal paradigma dicotomico, separazione mente/corpo, pensato
come un prodotto, una costruzione storico-culturale e quindi senza nessun
fondamento di naturalità e di universalità.
La separazione cartesiana mente-corpo ha dominato ideologicamente i saperi occidentali divenendo un principio ontologico universale e indiscutibile
che ha dato legittimità alla costruzione di rigide dicotomie come natura-cultura, irrazionale-razionale.
Il superamento delle dicotomie è dunque possibile se pensiamo al corpo
come qualcosa di fisico e simbolico, naturale e culturale, il corpo come un
complesso processo culturale e storico legato al contesto in cui vive.
Quello a cui arrivano Nancy Sheper-Hughes e Margaret Lock è la configurazione di un “corpo multiplo”, capace di ricomporre la frattura cartesiana,
costituito dalla sovrapposizione di tre dimensioni della corporalità: “il corpo
individuale” vissuto nell’esperienza, nella produzione del proprio sé; il “corpo
sociale” e il “corpo politico” riferito ai poteri e alle forze che esercitano una
sorveglianza normativa sui corpi attraverso il controllo della sessualità, della
malattia, del lavoro, del tempo libero ecc.
Si rivela quindi un’ulteriore dimensione del corpo: un corpo che è sociale,
politico ma anche naturalmente sovversivo, dove ‹‹le verità sociali vengono
forgiate e le contraddizioni messe in scena, così come anche il luogo di resistenza
personale, di creatività e di lotta›› (Scheper Hughes 2000: 284).
35
Un mindful body, quindi, un corpo cosciente, dotato di mente, che rompe
il dominio concettuale del dualismo cartesiano e che mostra potenzialità di
resilienza.
Anche il concetto di embodiment, utilizzato da Thomas Csordas per descrivere il corpo nella sua dimensione processuale di apprendimento di codici,
divieti, atteggiamenti, prescrizioni, rivela potenzialità individuali e creative di
libertà e di resistenza (Csordas 1994.).
L’embodiment o incorporazione è, come sostiene Giovanni Pizza, ‹‹la condizione esistenziale dell’uomo: stare al mondo abitandolo con il proprio corpo e
abituarsi ad esso. La nozione di “incorporazione”, quindi, definisce le modalità
attraverso le quali gli esseri umani vivono l’esperienza del corpo nel mondo e ne
producono la rappresentazione. [...] Il soggetto e l’oggetto della rappresentazione e dell’esperienza del corpo sono inscindibili: è il corpo a vivere l’esperienza nel
mondo e a conoscere il mondo producendone rappresentazioni. In questo senso potremmo dire che la stessa storia dell’uomo è fondata sulla “presenza” del
corpo nel mondo e sulla presenza del mondo nei corpi, poichè noi incorporiamo
costantemente le forze esterne e le esperienze passate e al tempo stesso, in un
processo vitale in continuo divenire, agiamo creativamente nel mondo trasformandolo con la nostra presenza›› (Pizza 2005: 37).
In questa prospettiva le manifestazioni di sofferenza umana come il dolore o
la disabilità rappresentano espressioni corporee culturalmente condizionate
e fortemente connesse alle relazioni sociali.
La malattia come processo originale e creativo, forma di prassi del corpo, di
azione corporea.
E’ proprio in questo senso che Scheper-Hughes parla di “saggezza del corpo”,
della ‹‹sua intenzionalità e significatività nel produrre ribelli e caotici sintomi che
aprono continue brecce nei confini tra mente e corpo, natura e cultura, corpo inviduale e sociale. Il corpo è “naturalmente sovversivo”, si rifiuta di conformarsi ad
epistemologie che trafficano tra opposizione e dualismi, tra materialismi riduzionisti e radicali›› (Scheper Hughes 2000:285.).
Il corpo può, dunque, essere utilizzato per esprimere sensi di appartenenza
e di affermazione e per esprimere sentimenti negativi e conflittuali, (disagio,
alienazione, frustrazione, rabbia ecc.) e la malattia ne rappresenta il mezzo
principale di espressione.
36
Attraverso questa prospettiva, la dimensione sovversiva del corpo, manifestazione e strategia di resilienza, sembra emergere oltre quella sociale, omologante e tendenzialmente passiva spesso descritta dalle varie scienze sociali.
Il mindful body, il corpo individuale pieno di mente, resiliente, è, dunque,
capace di esprimere attraverso varie pratiche e strategie, tra cui anche la
malattia, una volontà di riscatto, di resistenza e creatività, contro le logiche
del potere, contro drammi improvvisi altrimenti incontrollabili, contro derive
esistenziali contemporanee.
Un corpo resiliente è quello affetto da ataque de nervos dei tagliatori di canna da zucchero nel nord-est del Brasile osservati da Nancy Scheper-Hughes.
Corpi resilienti sono anche quelli delle tarantate osservate da Ernesto De Martino, quelli soggetti a trance, possessione e stregoneria testimoniati in vari
contesti etnografici, quelli che attraverso messe in scena fantastiche e rituali
di travestimento gestiscono il conflitto delle relazioni sociali come nella cerimonia dei Naven della Nuova Guinea descritta da Gregory Bateson; i corpi
della cybercultura o quelli su cui, nelle culture metropolitane contemporanee, si attuano pratiche di body marking.
Tra il 1935 e il 1936 Gregory Bateson compie uno studio etnografico presso gli
Iatmul della Nuova Guinea (Bateson, 1988) osservando il rito Naven, termine
che presso queste popolazioni significa “mostrarsi”, “dare a vedere” e che indica una complessa cerimonia di travestimento.
Durante il rito si innesca un meccanismo di confronto esasperato fra le diverse “tecniche del corpo” tra uomini e donne.
Le donne imitano in maniera caricaturale ed esagerata la gestualità dei guerrieri ridicolizzandoli e contemporaneamente gli uomini imitano ed esagerano i comportamenti femminili.
Dopo una prima fase di eccitazione crescente che accompagna la reciproca
derisione, improvvisamente i toni cambiano e domina il silenzio, la serietà e
il pianto, le emozioni esplodono quando il rito raggiunge il culmine dell’intensità fisica.
Il rito viene attuato in momenti particolari della vita degli individui, spesso
legati al passaggio alla condizione di adulto.
37
Nel sistema di parentela Iatmul è lo zio materno, lo wau, ad avere autorità
paterna sul figlio della sorella, il laua.
Il rito permette allo wau di esprimere atteggiamenti affettuosi nei confronti
del giovane altrimenti negati agli uomini perchè considerati “femminili” e contemporanemante permette alle donne, alle madri, di mostrarsi fiere del figlio,
atteggiamento maschile normalmente negato fuori dalla cerimonia.
Con questo lavoro Bateson evidenzia le dinamiche reciproche di adattamento e reazione che innescano processi di reazione e progressiva differenziazione del comportamento, definendo tali meccanismi come “schismogenesi”,
nascita nella separazione, “processo di differenziazione nelle norme del comportamento individuale” (Bateson 1988: 166-7).
Il Naven, secondo l’etnologo inglese, ha la finalità di produrre un equilibrio
dinamico che tenga sotto controllo i processi di diversificazione evitando così
l’esplosione potenziale di contrasti e crisi all’interno delle relazioni sociali.
In questo senso i corpi protagonisti possono essere considerati corpi resilienti, impegnati in azioni rituali finalizzate a controllare e superare potenziali crisi
individuali e sociali.
Attraverso l’analisi del rito Naven, anche nella sua versione più recente, appare evidente quanto la dimensione corporea sia centrale, il rito offre agli
uomini e alle donne ‹‹la possibilità di uscire dall’habitus per poi rientrarvi modificando, nel proprio corpo, le tecniche acquisite, riposizionandosi sulla scena
sociale dopo aver incorporato nuove possibilità espressive delle emozioni, nuove
gestualità per manifestare i propri sentimenti›› (Pizza G. 2005: 54).
Corpi resilienti sono anche quelli delle donne morse dalla taranta, protagoniste del complesso rito del Tarantismo descritto e analizzato dall’antropologo
italiano Ernesto De Martino sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso
in Lucania (De Martino E. 1996.).
Il morso della taranta è un morso simbolico, mitologico e per liberarsi della possessione del ragno e quindi del malessere che ne comporta, la donna
deve ballare per giorni in stato di trance e chiedere la grazia a San Paolo protettore delle tarantate.
Il corpo femminile è quindi protagonista di un complesso rituale individuale e
sociale, un evento straordinario che permette alla donna, povera e contadina,
38
di esprimere socialmente con forza il proprio malessere e di normalizzarlo
grazie alla performance rituale, fenomeno di resilienza attuato come strategia
per dare senso e superare cicliche e potenziali derive esistenziali dovute dalla propria condizione sociale (donna, povera, costretta a lavorare nei campi
ecc.).
Fenomeni simili sono stati rintracciati in molti casi etnografici simili in cui risultano protagonisti i corpi, la trance e la musica: in molti casi spesso appare
evidente come tali pratiche siano finalizzate alla risoluzione di stati reali o
potenziali di crisi individuale e sociale, ritualità che secondo De Martino nascono come riscatto culturale dal rischio di non esserci, come strategia contro
il rischio di perdita della presenza.
I corpi delle tarantate sono corpi sovversivi e resilienti, che esprimono forme di resistenza, come quelli dei tagliatori sottopagati di canna da zucchero
nel nord-est del Brasile osservati da Nancy Scheper-Hughes affetti da ataque
de nervos: tremore, svenimento, crisi, pianto isterico, paralisi e perdita di coscienza sono alcuni dei sintomi più diffusi.
Sintomi ribelli e sovversivi, metafore codificate attraverso cui, secondo la studiosa americana, i lavoratori ‹‹esprimono la loro precaria e inaccettabile condizione di malnutrizione cronica e di bisogno, e in parte rappresentano atti di sfida
e di dissenso che registrano graficamente il rifiuto di sopportare ciò che è, nella
realtà, insopportabile e la loro protesta contro la loro disponibilità allo sfruttamento fisico e all’abuso›› (Scheper-Hughes N. 2000).
Tra le donne chi soffre di “attacchi di nervi” normalmente ha affrontato una
recente tragedia, particolarmente violenta: vedove o madri di figli sequestrati
o violentemente spariti. I nervosos lanciano un segnale di allarme, l’epidemia
di nervos tra le madri e le mogli vedove rappresenta una ‹‹forma di resistenza,
al tempo stesso efficace e sicura. Da un lato infatti rende pubblico il pericolo,
la paura, l’anormalità del normale, dall’altro, non espone chi soffre ad ulteriori
rappresaglie politiche›› (ibidem pag. 290)
Corpi resilienti sono anche quelli soggetti alle pratiche contemporanee di
body marking. Nell’uso metropolitano contemporaneo di tali pratiche come
piercing, tatuaggi, scarificazioni, ecc., si attuano individualizzazioni rituali,
semi-ritualità autonome finalizzate alla costruzione del proprio rituale di passaggio; gli individui diventano bricoleurs inventivi e instancabili del proprio
corpo.
39
‹‹[...] Il corpo appare come unico ancoramento possibile, sogno di liberazione e
libertà, “luogo” dove progettare e investire su e per sé. É l’espressione di una volontà, la spinta di un desiderio, la ricerca di un’identità “rifatta”›› (Fusaschi 2008:9).
Quello del corpo è un linguaggio alternativo e il ricorso al corpo può nascondere inadeguatezza della parola e del pensiero. Il corpo rivela un’incompletezza, un’insufficienza: delusione, sconforto e desiderio di cambiare pelle,
volontà di “mettersi al mondo da soli”.
I corpi tatuati, tagliati, incisi, feriti volontariamente, parlano di malesseri e
rifiuti altrimenti incomunicabili, manifestazione del desiderio smarrito di esistere, ai limiti della condizione umana (Le Breton 2005.).
Per molti l’esperienza simbolica di segnarsi il corpo è connessa a cambiamenti
reali sul piano personale ed emotivo e in questo senso le pratiche di body
marking si configurano come riti di passaggio personali e i tatuaggi, i piercing
come protesi identitarie.
Riferisce Le Breton che molti giovani raccontano di essersi sentiti più forti,
addirittura di sentirsi meglio nella propria pelle dopo essersi sottoposti a pratiche di body marking in cui ad esempio risulta molto importante, dal punto
di vista simbolico, la sfera legata al dolore: il dolore come conferma e senso
dell’importanza del rito a cui si sottopongono.
I corpi tatuati e forati, sono corpi resilienti, corpi che raccontano crisi e malesseri altrimenti inesprimibili, crisi e malesseri controllati e superati grazie a
tali pratiche dal profondo valore simbolico, pratiche di de-ri-costruzione del
corpo, forme di resistenza o ribellione alle norme sociali (Fusaschi 2008.).
I corpi contemporanei offrono nuovi orizzonti della corporeità, ci appaiono
come corpi ‹‹sovversivi, capaci di costruire personali e dislocanti dinamiche
identitarie, di tracciare nuovi confini e contemporaneamente di gridare il proprio
disagio, la propria alienazione. Sono corpi in fuga, corpi rifugio: body-escapes.
Perché se è vero che il corpo, come ha ampiamente testimoniato l’antropologia,
è spazio privilegiato per esprimere sensi di appartenenza collettivi, è anche vero
che lo stesso corpo può diventare un mezzo di resistenza ed esprimere sensi di
disagio, negazione, alienazione, ribellione›› (Ceccarini G. 2014.).
I casi fin qui analizzati descrivono quello che Scheper-Hughes e M. Lock definiscono come mindful body, un corpo pieno di mente, strumento e luogo di
strategie di resistenza e, secondo il nostro punto di vista, quindi di resilienza.
40
Questa modalità di osservazione, oltre ad aprire nuovi scenari interpretativi
dei più noti casi etnografici relativi alle culture tradizionali, si pone come un
interessante strumento di analisi dei fenomeni legati alla sfera corporale nella
modernità in una prospettiva che vede il corpo come parametro essenziale
del contemporaneo (Cipolletta G. 2014).
BIBLIOGRAFIA
Borofsky, R. 2000. (a cura di) L’Antropologia culturale oggi. Roma: Meltemi.
Canevacci, M. 2004. Sincretismi. Esplorazioni diasporiche sulle ibridazioni culturali. Milano: Costa&Nolan.
Ceccarini, G. 2014. “Dal landscape al bodyscape. Confini e prospettive identitarie nella
surmodernità”. In Rivista di scienze sociali n. 10 Limen. Bodyscape tra gentrification,
anomie e culture, www.rivistadiscienzesociali.it.
Cipolletta, G. 2014. Passages metrocorporei. Macerata: EUM.
Csordas Thomas, J. 1994. Embodiment and Experience: The existential ground of culture
and self. Cambridge: Cambridge University Press.
Di Lauro, D. 2012. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità
della vita. Milano: Xenia Edizioni.
De Martino, E. 1996. La terra del rimorso. Milano: Est.
Fusaschi, M. 2008. Corporalmente corretto. Roma: Meltemi.
Le Breton, D. 2007. Antropologia del dolore. Meltemi Editore.
--- 2007, Antropologia del corpo e modernità. Milano: Giuffrè.
---2005. La pelle e la traccia. Le ferite del sé. Meltemi Editore.
---2002. Signes d’identité. Metailié.
41
Pizza, G. 2005. Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo. Roma: Carocci
Editore.
Scheper-Hughes, N. 2000. “Il sapere incorporato”. In R.Borofsky (a cura di) L’Antropologia culturale oggi. Roma: Meltemi.
Short, D., C.Casula. 2004. Speranza e resilienza. Franco Angeli Edizioni.
Dotti, M. 2002. Segni d’identità. L’alterazione del corpo, intervista con David Le Breton (6
settembre 2002) a cura di Marco Dotti, http://idr.seieditrice.com.
Trabucchi, P. 2007. Resisto dunque sono. Corbaccio.
42