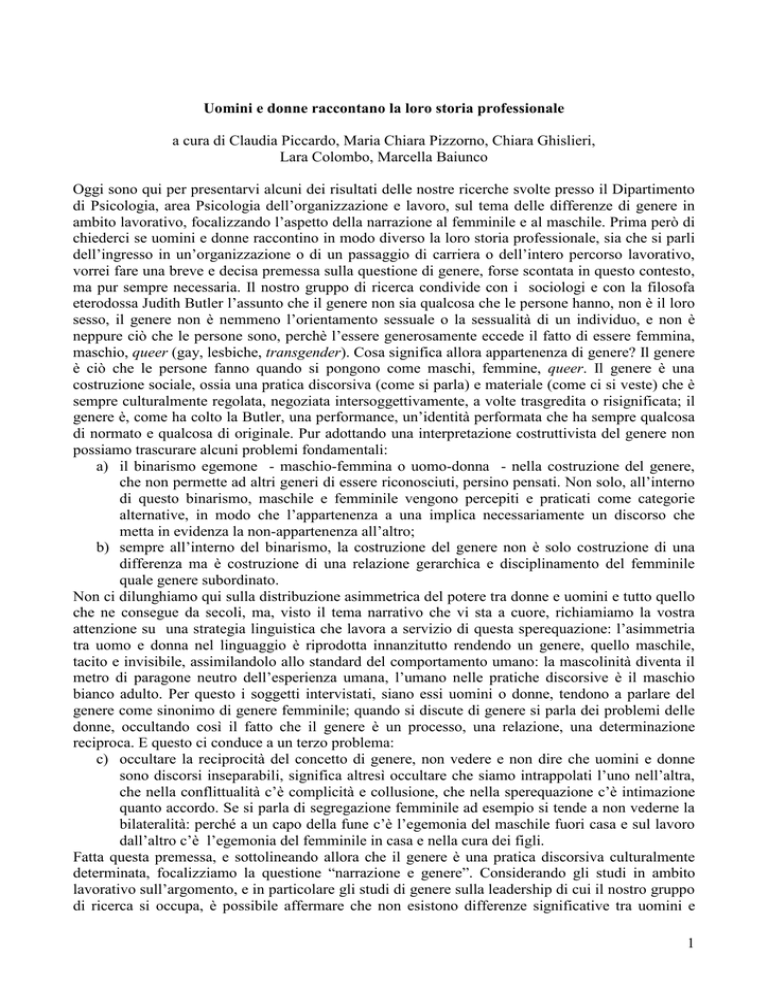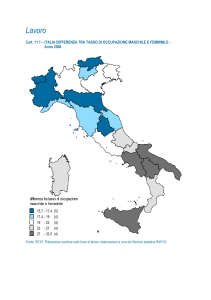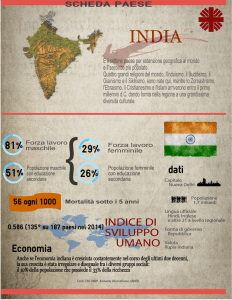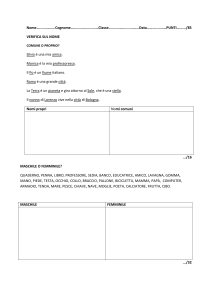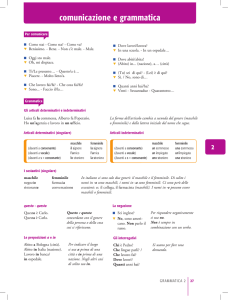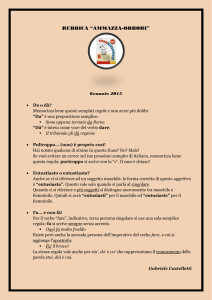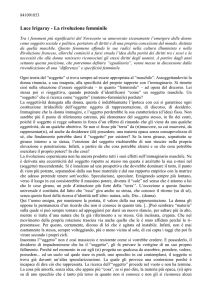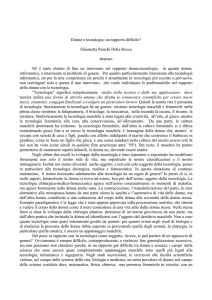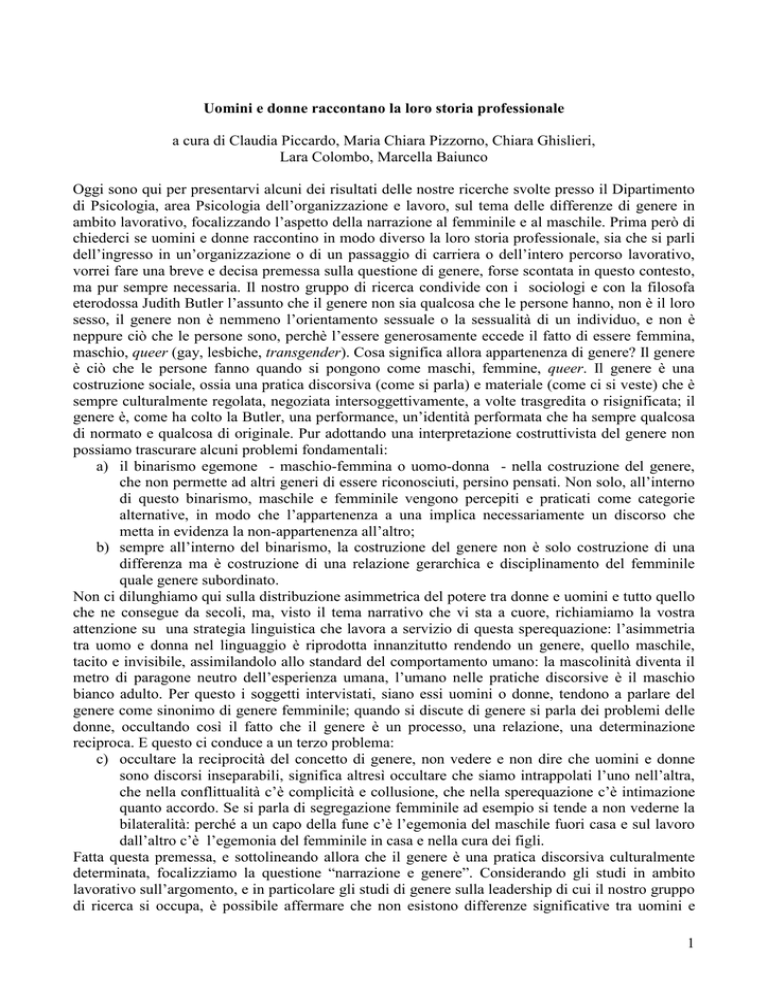
Uomini e donne raccontano la loro storia professionale
a cura di Claudia Piccardo, Maria Chiara Pizzorno, Chiara Ghislieri,
Lara Colombo, Marcella Baiunco
Oggi sono qui per presentarvi alcuni dei risultati delle nostre ricerche svolte presso il Dipartimento
di Psicologia, area Psicologia dell’organizzazione e lavoro, sul tema delle differenze di genere in
ambito lavorativo, focalizzando l’aspetto della narrazione al femminile e al maschile. Prima però di
chiederci se uomini e donne raccontino in modo diverso la loro storia professionale, sia che si parli
dell’ingresso in un’organizzazione o di un passaggio di carriera o dell’intero percorso lavorativo,
vorrei fare una breve e decisa premessa sulla questione di genere, forse scontata in questo contesto,
ma pur sempre necessaria. Il nostro gruppo di ricerca condivide con i sociologi e con la filosofa
eterodossa Judith Butler l’assunto che il genere non sia qualcosa che le persone hanno, non è il loro
sesso, il genere non è nemmeno l’orientamento sessuale o la sessualità di un individuo, e non è
neppure ciò che le persone sono, perchè l’essere generosamente eccede il fatto di essere femmina,
maschio, queer (gay, lesbiche, transgender). Cosa significa allora appartenenza di genere? Il genere
è ciò che le persone fanno quando si pongono come maschi, femmine, queer. Il genere è una
costruzione sociale, ossia una pratica discorsiva (come si parla) e materiale (come ci si veste) che è
sempre culturalmente regolata, negoziata intersoggettivamente, a volte trasgredita o risignificata; il
genere è, come ha colto la Butler, una performance, un’identità performata che ha sempre qualcosa
di normato e qualcosa di originale. Pur adottando una interpretazione costruttivista del genere non
possiamo trascurare alcuni problemi fondamentali:
a) il binarismo egemone - maschio-femmina o uomo-donna - nella costruzione del genere,
che non permette ad altri generi di essere riconosciuti, persino pensati. Non solo, all’interno
di questo binarismo, maschile e femminile vengono percepiti e praticati come categorie
alternative, in modo che l’appartenenza a una implica necessariamente un discorso che
metta in evidenza la non-appartenenza all’altro;
b) sempre all’interno del binarismo, la costruzione del genere non è solo costruzione di una
differenza ma è costruzione di una relazione gerarchica e disciplinamento del femminile
quale genere subordinato.
Non ci dilunghiamo qui sulla distribuzione asimmetrica del potere tra donne e uomini e tutto quello
che ne consegue da secoli, ma, visto il tema narrativo che vi sta a cuore, richiamiamo la vostra
attenzione su una strategia linguistica che lavora a servizio di questa sperequazione: l’asimmetria
tra uomo e donna nel linguaggio è riprodotta innanzitutto rendendo un genere, quello maschile,
tacito e invisibile, assimilandolo allo standard del comportamento umano: la mascolinità diventa il
metro di paragone neutro dell’esperienza umana, l’umano nelle pratiche discorsive è il maschio
bianco adulto. Per questo i soggetti intervistati, siano essi uomini o donne, tendono a parlare del
genere come sinonimo di genere femminile; quando si discute di genere si parla dei problemi delle
donne, occultando così il fatto che il genere è un processo, una relazione, una determinazione
reciproca. E questo ci conduce a un terzo problema:
c) occultare la reciprocità del concetto di genere, non vedere e non dire che uomini e donne
sono discorsi inseparabili, significa altresì occultare che siamo intrappolati l’uno nell’altra,
che nella conflittualità c’è complicità e collusione, che nella sperequazione c’è intimazione
quanto accordo. Se si parla di segregazione femminile ad esempio si tende a non vederne la
bilateralità: perché a un capo della fune c’è l’egemonia del maschile fuori casa e sul lavoro
dall’altro c’è l’egemonia del femminile in casa e nella cura dei figli.
Fatta questa premessa, e sottolineando allora che il genere è una pratica discorsiva culturalmente
determinata, focalizziamo la questione “narrazione e genere”. Considerando gli studi in ambito
lavorativo sull’argomento, e in particolare gli studi di genere sulla leadership di cui il nostro gruppo
di ricerca si occupa, è possibile affermare che non esistono differenze significative tra uomini e
1
donne nei comportamenti organizzativi e, quando si riscontrino delle differenze, esse risultano
stereotipiche e si spiegano in funzione di distinti percorsi di socializzazione. Quello che qui ci
importa sottolineare è che la stereotipia dei generi trapela innanzitutto nel modo in cui uomini e
donne rappresentano se stessi, si raccontano e posizionano nel racconto il proprio genere in
relazione all’altro. Uomini e donne, pur comportandosi in modo analogo, raccontano la propria
esperienza professionale diversamente, producendo storie istituzionali in accordo alle caratteristiche
culturalmente associate alla mascolinità e alla femminilità. Ad esempio, quando si parla di
leadership, i soggetti intervistati si qualificano secondo caratteristiche associate al genere che sono
state classificate come attributi agentici e communali. Caratteristiche agentiche, molto spesso
associate più agli uomini che alle donne, sono descritte in termini di assertività, tendenza al
controllo e fiducia in sé. Comportamenti agentici possono essere individuati nel parlare in modo
assertivo, nell’influenzare gli altri, nel competere per ottenere attenzione e considerazione. Le
caratteristiche communali, maggiormente associate alle donne, si riferiscono in primo luogo
all’attenzione per il benessere altrui e si esprimono attraverso poca attenzione per sé, desiderio di
sostenere e supportare gli altri, parlare lasciando spazio all’altro. Il fatto che uomini e donne
rappresentino diversamente la propria leadership ha però un impatto molto concreto sulla possibilità
di far carriera. Le regole relative a come si fa carriera, ossia il modello di leadership premiante in un
dato contesto organizzativo, non è un modello neutro al genere: nelle organizzazioni il modello
vincente è quello che presenta caratteristiche agentiche, non communali, quindi il modello
promosso e premiato è quello maschile. Cosa fanno e dicono allora le donne per fare carriera?
Possono rappresentare un’identità più vicina allo stereotipo maschile, presentandosi come “donne
con le palle” e allora verranno valutate positivamente. Tuttavia se le donne eccedono nell’assumere
questi stili di comunicazione e di azione mascolini, se l’assertività diventa aggressività, le donne
non sono più valute positivamente perché assumono comportamenti e stili di comunicazione che
vengono percepiti come incoerenti con lo stereotipo femminile che ad esempio prevede l’elusione
del conflitto. Gli uomini infatti dicono di apprezzare le donne “concilianti” che investono nelle
relazioni, che valorizzano gli altri, le donne cioè che sono in linea con lo stereotipo di genere, ma se
le donne adottano pratiche discorsive e materiali in linea con le qualità communali
stereotipicamente femminili, non sono considerate leader efficaci. Quindi nelle organizzazioni ci
sono delle regole implicite relative alle relazioni di genere, ma queste norme sono ambigue e il
soggetto non può performarle senza sperimentare una certa ambivalenza: da un lato la norma invita
le donne ad assumere dei comportamenti maschili se vogliono adempiere al proprio ruolo, dall’altro
sanziona comportamenti che non siano tipicamente femminili. Se impersoni solo lo stereotipo
femminile soccombi, se impersoni quello maschile vieni censurata. Questa ambivalenza trapela nei
racconti delle donne, ad esempio attraverso la metafora della donna “con l’armatura”, per altro
rintracciabile in diversi miti, fiabe, film (Fanta-ghirò di Calvino, Cantando dietro i paraventi di
Olmi): la donna, per andare in guerra, deve rinunciare alla propria appartenenza di genere, indossare
un’armatura e, dopo aver superato la prova, aver dimostrato di essere all’altezza del compito, torna
a indossare i panni della principessa. Si potrebbe dire che la donna, per “farcela”, deve praticare
un’identità “trans-gender” e poi rioccupare il posto assegnatole nel binarismo uomo-donna. In
queste narrazioni è esclusa la possibilità di smarcarsi dallo stereotipo di genere e accedere a una
identità originale e polimorfa. Quello che ci preme rimarcare a questo punto è che uomini e donne
non comunicano in modo diverso perché sono uomini e donne, ma attraverso diverse modalità di
comunicazione costruiscono il genere maschile e femminile, e le donne, raccontandosi
prevalentemente secondo caratteristiche communali (“concilianti” e “carine”) contribuiscono a
consolidare lo stereotipo di genere di cui poi pagano lo scotto. Scendiamo nel dettaglio e vediamo
ad esempio, attraverso i risultati di una ricerca svolta da Gherardi e Poggio (2003), come molte
donne raccontino di essere entrate in un contesto organizzativo per “il caso” e “le coincidenza”,
mentre “la volizione” e “la scelta” sono al centro del racconto degli uomini. Gherardi e Poggio
hanno analizzato le narrazioni di 33 casi di donne pioniere all’interno di organizzazioni
tradizionalmente maschili e in posizione di responsabilità, e di 33 uomini delle stesse
2
organizzazioni. A tutti i soggetti è stato chiesto di raccontare la propria storia professionale e in
particolare il percorso nell’attuale organizzazione di appartenenza; agli uomini inoltre è stato
chiesto di raccontare come la loro collega è entrata nell’organizzazione a cui entrambi
appartengono. Dall’analisi degli incipit delle storie professionali narrate risulta che:
• gli uomini (o le donne giovani) rappresentano un sé volitivo (mediante frasi quali “io ho
fatto”, “ho deciso”) e un sé storico-processusale, per cui si pongono come protagonisti di
una storia che ha un avvio e una sequenza molto lineare, pur risentendo delle condizioni e
degli eventi all’intorno;
• le donne presentano invece un sé evenziale: il racconto si apre su una condizione sospesa, si
parla di circostanze casuali entro le quali la donna si posiziona in maniera defilata. Il
protagonista a volte è qualcun altro (qualcuno che l’ha selezionata, ad esempio) e la donna si
muove in una cornice temporale discontinua, scandita da eventi e ostacoli che spezzano la
linearità, intessendo percorsi interrotti e poi ripresi.
Analizzando poi la trama, lo sviluppo narrativo conferma che:
• gli uomini adottano una struttura narrativa standardizzata, lineare e sequenziale, per cui le
fasi del racconto sono funzionali al raggiungimento dell’attuale traguardo (la posizione
organizzativa), inoltre l’identità costruita nel racconto è prevalentemente quella
professionale;
• le donne invece tessono trame complesse, intrecci che possono dirsi “a ragnatela”, inoltre i
loro racconti sono multidimensionali e l’identità lavorativa si intreccia con quella familiare e
personale.
Se guardiamo alle trame narrative delle donne occorre però fare un distinguo:
• ci sono storie di donne, specie le donne giovani, che sono storie di scelta, in cui emerge una
dimensione intenzionale e progettuale riguardo alle decisioni da prendere di fronte alle
diverse opzioni disponibili. Le scelte sono spesso tra carriera e famiglia e si collocano
all’inizio della storia o a metà (la scelta di avere un figlio);
• poi ci sono storie di fortuna - “mi sono trovata lì per caso” - che non tengono conto delle
strategie aziendali per cui l’assunzione di tali soggetti non è aleatoria, ma soprattutto e
amaramente non tengono conto delle capacità dimostrate dalla stessa autrice del racconto: le
donne raccontano di essere “fortunate” se hanno vinto un concorso, non prendendo in
considerazione la loro bravura. In tutte le storie poi c’è una traccia di fortuna intesa come la
fortuna di aver incontrato figure maschili che hanno saputo valorizzarle.
Secondo Gherardi e Poggio, nelle storie di “fortuna”, le donne selezionano espedienti narrativi e
stili retorici che consentano loro di costruire un’identità coerente con lo stereotipo di genere, ossia
agency1 esterna e “modestia” nel positioning2. Perché lo fanno? Perché minimizzando la propria
agency così come minimizzano i propri successi, cercano di farsi perdonare l’entrata in un
organizzazione maschile ed evitano di essere percepite come una minaccia dagli uomini.
Analizzando invece le trame maschili esse si presentano come:
• o percorsi segnati cioè racconti segnati dalla Necessità per cui il percorso professionale è
una traccia assegnata loro dalla società, un iter automatico progressivo e tradizionale;
• o percorsi disegnati dal protagonista: si tratta di uomini che raccontano di essere artefici del
proprio destino, averlo indirizzato, forgiato.
1
Agency (agentività, capacità di agire) = essere agente del proprio comportamento (François e Langelier, 2000).
Concetto fondamentale della teoria di Bandura, l’agency è “la facoltà di far accadere le cose, di intervenire sulla realtà,
di esercitare un potere causale” (Bandura, 2000a, p. 17).
2
Positioning: “processo discorsivo per mezzo del quale i sé sono collocati all’interno di conversazioni, in quanto
partecipanti osservabilmente e soggettivamente coerenti lungo linee di storia prodotte congiuntamente” (Davies e Harrè,
1990, p. 48); concetto che supera la staticità del concetto di “ruolo”, in quanto ogni soggetto si posiziona diversamente a
seconda del discorso a cui partecipa e del contesto in cui agisce.
3
Che il percorso sia segnato o disegnato, che la meta sia scelta o prescritta, il timone viene
comunque tenuto saldamente dal protagonista.
In generale emerge da questa ricerca come gli uomini non si raccontino, o raccontino poco, con
pochi fatti personali, scarsa affettività, un vocabolario dell’azione piuttosto che della riflessività. Le
donne invece tessano trame ricche e complesse. La trama scarna e lineare maschile e la ragnatela
femminile si spiegano in base alla funzione ordinante della narrazione. La funzione sociale della
narrazione è quella di rendere comprensibile lo straordinario, riconducendolo preferibilmente
all’ordinario. Se consideriamo che la storia professionale di un uomo difficilmente è una storia di
rottura, piuttosto è ordinaria amministrazione, comprendiamo perché gli uomini fatichino a
raccontare storie e quando lo fanno come esse siano standardizzate. La storia professionale di una
donna, specie in ambiti maschili, invece è un evento vissuto nella sua eccezionalità, per cui la
narrazione serve a ricomporre il disordine prodotto dalle proprie scelte o dagli accadimenti. Come a
dire che le donne hanno bisogno di raccontarsi perché si sperimentano diverse, perché si
percepiscono come l’eccezione in un ambiente maschiocentrico, perché il mondo non è stato
pensato per loro e pur tuttavia vogliono rientrarvi. Nel momento in cui i percorsi professionali di
uomini e donne diventeranno più simili, allora anche le narrazioni si uniformeranno: anzi già adesso
è possibile riscontrare delle affinità tra le storie maschili e quelle delle giovani donne.
Tornando alle storie raccontate da donne che entrano in contesti di lavoro tradizionalmente
maschili, come le donne ingegnere, Gherardi e Poggio evidenziano nelle loro trame una duplice
sfida: “non essere uomini” e, allo stesso tempo, “non essere come le altre donne”. La prima sfida non essere un uomo in un contesto maschile - viene raccontata in modi diversi e diversamente
trattata dagli uomini quando raccontano l’arrivo delle loro colleghe donne, vediamo come:
• se la donna racconta la vicenda di non essere un uomo in mezzo ad altri uomini dicendo che
già solo il fatto di esserci è una sfida, per cui non occorre accentuare ulteriormente la
differenza, la rappresentazione maschile di questa collega è di una donna “discreta”, che
viene pertanto apprezzata: c’è un atteggiamento di accondiscendenza;
• se la donna racconta la sfida come lotta, come assunzione consapevole e intenzionale di
modelli maschili di lotta, intesa come “durezza”, “grinta”, “capacità di imporsi” e
“contrapporsi”, allora la reazione maschile è di squalifica; gli uomini non lesinano parole di
disapprovazione per l’accentuazione di comportamenti maschili da parte delle donne, cioè
valutano negativamente i comportamenti incoerenti con lo stereotipo di genere;
• se la sfida è invece raccontata come un’avventura, costellata di prove iniziatiche, ostacoli,
ma soprattutto animata da grande “passione” per il mestiere, mentre il rapporto con gli
uomini si qualifica come confronto anziché competizione, la reazione maschile è
ambivalente: da un lato gli uomini riconoscono alla professionista le capacità, ma non le
riconoscono la vocazione, leggendola come un fatto privato, e sostenendo che le donne non
riusciranno a realizzarsi perché quella professione è maschile,
• se la sfida viene raccontata come affermazione di sé, ricerca di uno spazio, come impegno
al superamento delle differenze di genere, proponendo una visione assessuata del mercato
del lavoro e del profilo professionale, la reazione degli uomini varia dall’ammirazione per
l’investimento nel lavoro e per l’eccezionalità della donna, all’insofferenza per lo “strafare”
e l’ostentazione della propria bravura.
C’è poi una seconda sfida che le donne drammatizzano nei loro racconti professionali: esse infatti si
rappresentano come diverse non solo dagli uomini, ma anche dalle “altre donne”, per intenderci
dalle donne che nell’organizzazione occupano ruoli tipicamente femminili, come le segretarie, e
dalle donne che non lavorano, cioè le mogli dei colleghi. Perciò le lavoratrici/professioniste nei loro
racconti accentuano da un lato la differenza rispetto ai colleghi uomini, dall’altro sottolineano le
affinità che le accomunano a loro, per distinguersi dalle “altre” che diventano così un gruppo di
riferimento negativo. Raccontandosi come diverse dalle altre, per poter appartenere alla cultura
maschile e per non essere vittime di in uno stereotipo di genere, paradossalmente queste donne
4
professioniste contribuiscono a consolidarlo, peggio a stigmatizzare il proprio genere. Così facendo
inoltre esse corrono il rischio psicologico di un disprezzo latente per se stesse in quanto donne.
Tornando alle narrazioni degli uomini, quando viene loro chiesto di raccontare come una collega è
entrata nel suo contesto di lavoro (“ci racconti come è arrivata?”), i rispondenti si affrettano a
negare ci sia “un problema di genere”, affermando che la donna è stata accettata nel contesto
maschile perché competente, nonostante il lavoro sia maschile e benché lei sia donna. È probabile
che negli intervistati maschi scatti il riferimento implicito al dibattito sulle pari opportunità quindi
l’impulso a difendersi; è interessante notare una certa familiarità e padronanza linguistica degli
uomini sulle tematiche di genere, eppur tuttavia trapela dalle interviste la difficoltà degli uomini a
riflettere sulla propria esperienza di genere. Gli uomini non sembrano aver elaborato un
vocabolario, un’abitudine a parlare di sé in relazione alla propria mascolinità che si costruisce in
rapporto al femminile; non hanno sviluppato una riflessività sul proprio genere in relazione all’altro.
Questo dato non va letto come una costante di genere, come a dire “gli uomini non parlano di sè”, al
contrario, non parlando di sé fanno gli uomini. Il fatto di non parlare di sé, di non raccontarsi mai in
termini di mascolinità, conferma e consolida lo stereotipo di genere maschile per cui gli uomini
sono educati a non rivelarsi se non nell’intimità. Gli uomini performano la loro identità di genere
non parlandone: non possedere un vocabolario della relazionalità fa parte della costruzione sociale
del maschio. Inoltre, come dicevamo in precedenza, rendere invisibile la mascolinità è una strategia
linguistica per renderla il metro di paragone neutro dell’esperienza umana, è una strategia di potere.
In questo breve intervento ho cercato soprattutto di evidenziare come sia le donne sia gli uomini
producono narrazioni che contribuiscono a consolidare le differenze di genere stereotipiche, ma
soprattutto contribuiscono a consolidare le asimmetrie di genere culturalmente prescritte, anche
dalle culture organizzative. Vi faccio un ultimo esempio: una retorica ricorrente nei discorsi delle
donne e degli uomini che lavorano è quella del face time: far vedere che stai al lavoro fino a tardi,
che sei disponibile è quello che ti fa fare carriera, indipendentemente dalle capacità e dalla
produttività. Uomini e donne, dunque, assumono e danno per scontata una sovraesposizione
temporale degli individui nelle organizzazioni, così facendo, però, entrambi consolidano le
attribuzioni e le asimmetrie tradizionali di genere che pretendono l’uomo impegnato nel lavoro e la
donna nella famiglia. Mi spiego meglio: l’asimmetria lavoro-famiglia, che colloca in una posizione
subordinata la famiglia rispetto al lavoro, replica l’asimmetria uomo-donna perché quest’ultima ha
per tradizione la famiglia come priorità. Quindi, pur di essere accettate nelle organizzazioni, le
donne ne sposano le norme fino a ribadire il mito della inconciliabilità tra lavoro e famiglia,
accettando la rinuncia che comporta, o a una vita familiare/maternità o alla carriera. Ricordiamo che
una quota rilevante di donne dirigenti sono single.
Concludo dicendo che nel momento in cui riproduciamo una norma, possiamo anche indebolirla,
possiamo risignificarla ed è quello che sta succedendo con la negoziazione dei ruoli e degli impegni
all’interno della coppia e della famiglia, che ha poi una ricaduta positiva nella vita lavorativa. Un
dato incoraggiante della ricerca di Gherardi e Poggio non è solo aver registrato come le giovani
donne si considerino “artefici del loro destino” e non attrici passive baciate dalla fortuna, ma aver
riscontrato che gli uomini in situazioni di coppia dual career (con entrambi i partner in carriera),
non solo non stigmatizzano le professioniste, ma essi stessi non si rappresentano in modo
paternalistico come i mentori delle medesime, offrendo invece racconti di stima reciproca, di parità,
di scambio, aprendosi alla riflessione anche sulla propria identità di genere.
Come gruppo di ricerca annunciamo di essere in fase di avvio di un progetto intitolato “transizioni
di carriera e conciliazione” che ha l’obiettivo di cogliere il significato del passaggio di carriera in
ambito lavorativo, il significato dell’intreccio tra la carriera lavorativa e la carriera di vita
(personale e familiare) e le eventuali differenze di genere nella narrazione delle transizioni di
carriera e dell’intreccio carriera lavorativa-carriera di vita. La ricerca prenderà in esame due
popolazioni appartenenti a due organizzazioni diverse: una con una cultura family friendly e l’altra
priva di politiche a riguardo. Questo per capire come una cultura organizzativa impegnata sul fronte
della conciliazione possa o meno incidere sul modo di vivere la propria carriera professionale e di
5
vita delle donne e degli uomini. Speriamo di avere tra un anno modo di presentarvi i dati di questa
ricerca e di ricevere da voi ulteriori stimoli all’approfondimento.
Grazie
(Intervento in occasione della presentazione del volume “Parole di donne. Una riflessione
sull'essere donna a Torino, oggi” a cura della Scuola Holden e di EmilyTorino, Torino, aprile 2007.)
6