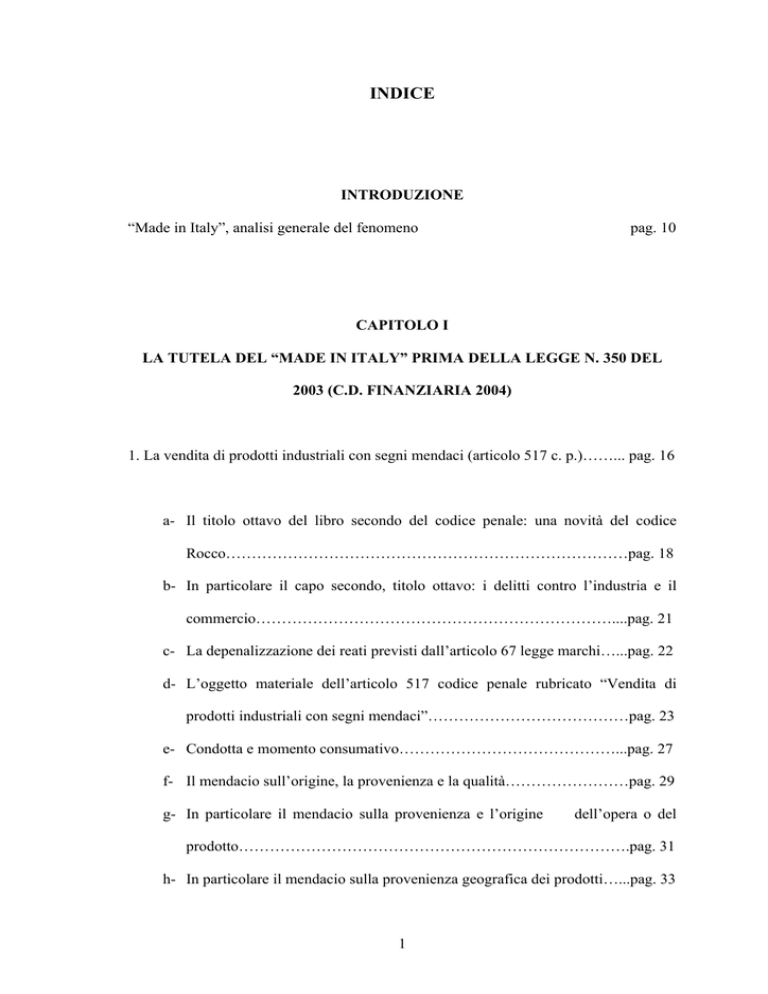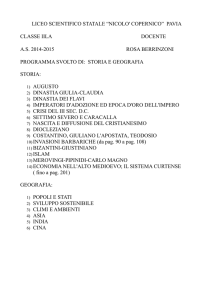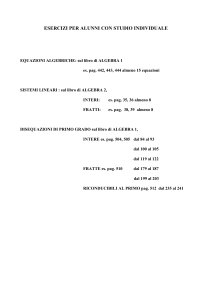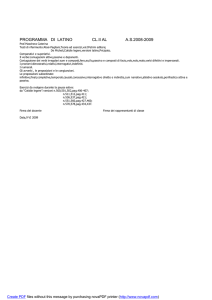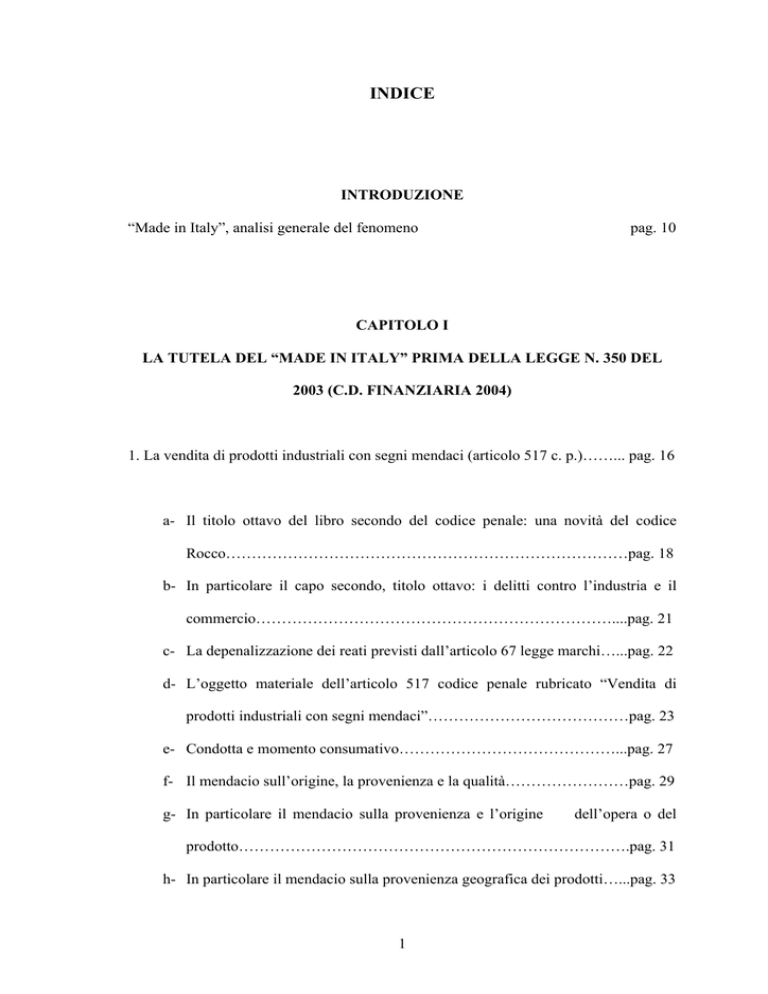
INDICE
INTRODUZIONE
“Made in Italy”, analisi generale del fenomeno
pag. 10
CAPITOLO I
LA TUTELA DEL “MADE IN ITALY” PRIMA DELLA LEGGE N. 350 DEL
2003 (C.D. FINANZIARIA 2004)
1. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 c. p.)……... pag. 16
a- Il titolo ottavo del libro secondo del codice penale: una novità del codice
Rocco……………………………………………………………………pag. 18
b- In particolare il capo secondo, titolo ottavo: i delitti contro l’industria e il
commercio……………………………………………………………....pag. 21
c- La depenalizzazione dei reati previsti dall’articolo 67 legge marchi…...pag. 22
d- L’oggetto materiale dell’articolo 517 codice penale rubricato “Vendita di
prodotti industriali con segni mendaci”…………………………………pag. 23
e- Condotta e momento consumativo……………………………………...pag. 27
f- Il mendacio sull’origine, la provenienza e la qualità……………………pag. 29
g- In particolare il mendacio sulla provenienza e l’origine
dell’opera o del
prodotto………………………………………………………………….pag. 31
h- In particolare il mendacio sulla provenienza geografica dei prodotti…...pag. 33
1
i- In particolare il mendacio sulla qualità………………………………….pag. 35
j- Lo sviluppo della giurisprudenza e della dottrina relativamenente al mendacio
sulla provenienza e l’origine dell’opera e del prodotto…………………pag. 36
j. 1 Anni Sessanta………………………………………………….pag. 38
j. 2 Anni Settanta…………………………………………………..pag. 39
j. 3 Anni Ottanta…………………………………………………...pag. 40
j. 4 Anni Novanta, Sentenza Thun (Cassazione, sez. III penale, 7 luglio
1999, n. 2500)……………………………………………………...pag. 43
k- Considerazioni conclusive……………………………………………....pag. 46
2. L’Arrangement di Madrid del 1981 applicato al “made in Italy”………………pag. 48
3. Accenni alla disciplina civilistica in tema di “made in Italy”…………………..pag. 54
CAPITOLO II
PROFILI PENALISTICI DEL “MADE IN ITALY”: SVILUPPO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
1. Le norme a tutela del “made
in Italy” contenute nella legge 350/2003 (c.d.
finanziaria 2004)………………………………………………………………pag. 56
a- L’interpretazione “innovatimene colpevolista” propria dell’Agenzia delle
Dogane………………………………………………………………...pag. 65
2
b- L’interpretazione prevalente fatta propria dalle prime pronunce della
Suprema Corte di Cassazione…………………………………………pag. 71
c- La riforma del 1992 sul trasferimento del marchio…………………...pag. 75
d- La difficile definizione del concetto di “fallace indicazione”………...pag. 77
e- Tutela del “made in Italy”, ma non di altre indicazioni di provenienza..pag.
80
f- Il regolamento delegato previsto dal comma 63 dell’articolo 4 legge n. 350
del 2003 (c.d. finanziaria 2004)……………………………………….pag. 81
g- La determinazione del momento consumativo: superamento del contrasto
giurisprudenziale………………………………………………………pag. 83
h- L’”origine doganale” nel codice doganale comunitario (Regolamento n.
2913/92)……………………………………………………………….pag. 85
2. I primi interventi interpretativi della Suprema Corte di Cassazione relativamente al
comma 49 dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004)..pag. 88
a- Sentenza Fro n. 3352/2005: la prima pronuncia della Suprema Corte
di Cassazione sull’origine dei prodotti dopo la legge n. 350 del 2003
(c.d. finanziaria 2004): conformità all’orientamento consolidato circa
la
prevalenza
dell’origine
imprenditoriale
sulla
provenienza
geografica……………………………………………………...pag. 90
b- Sentenza Legea n. 13712/2005: consolidamento dell’interpretazione
assunta dalla Suprema Corte di Cassazione: prevalenza dell’origine
da un produttore che controlla il processo rispetto all’origine
geografica…………………………………………………...…pag. 98
3
c- Sentenza Igam n. 34103/2005: prima pronuncia sulla dicitura “made
in Italy”: prevalenza della provenienza geografica in assenza
dell’indicazione del produttore………………………………pag. 106
3. Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 14 Marzo 2005, n. 35 (c. d.
decreto competitività), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80………….pag. 110
a- In
particolare
il
punto
7:
l’incauto
acquisto
di
prodotti
contraffatti……………………………………………………pag. 114
b- In particolare il punto 9: le indicazioni di provenienza e quella di
origine nella prospettiva della tutela penale del “made in
Italy”…………………………………………………………pag. 119
4. Fermo della merce in dogana come momento essenziale per l’accertamento della
loro provenienza……………………………………………………………..pag. 124
5. Le novità introdotte dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206)………………………………………………………………………..pag. 126
6. Sentenza Giordani n. 2648/2006: il ripensamento giurisprudenziale sulla “non
neutralità” dell’origine geografica di alcuni prodotti..……………………....pag. 129
7. Ordinanza del Tribunale di Genova: 21 marzo 2006………………………...pag. 138
4
8. Sentenza Huang Suwen n. 3669/2006: riaffermazione della prevalenza dell’origine
imprenditoriale sulla provenienza geografica, in presenza in capo al produttore della
responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo in capo al
produttore…………………………………………………………………….pag. 140
9. Sentenza Danzi n. 21797/2006: diciture quali “concepiti” o “ideati” costituiscono
fattispecie diverse da “made in..” …………………………………………...pag. 142
10. Sentenza Dolce & Gabbana n. 157/2006: prevalenza dell’Accordo di Madrid sulla
disciplina penale……………………………………………………………..pag. 144
11. I cambiamenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (così detta finanziaria 2007):
il riferimento alle pratiche commerciali ingannevoli………………………...pag. 148
12. Sentenza n. 8684/2007: l’ultima pronuncia in tema di “made in Italy”: legittimità
della dicitura “Italian design” su prodotti fabbricati all’estero………………pag. 154
CAPITOLO III
PROFILI PENALISTICI DEL “MADE IN ITALY”
1. La controversia sulla natura giuridica del segno distintivo “made in italy” in attesa
del regolamento governativo istitutivo del marchio “made in Italy”: opinioni
contrastanti…………………………………………………………………pag. 160
5
a- Origine doganale……………...……………………………...pag. 162
b- Marchio d’origine: categoria priva di riconoscimento normativo da
parte del legislatore italiano………………………….………pag. 165
c- Il sistema americano: obbligo di indicare sui prodotti importati la
loro origine………………………….......................................pag. 168
d- La normativa sull’origine della merce in Cina: obbligo di indicare
l’origine sia sui prodotti importati, sia su quelli esportati…...pag. 170
e- La nozione di marchio……………………………………….pag. 172
f- Le indicazioni di provenienza, in particolare le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine…………………...pag. 175
g- I marchi collettivi…………………………………………….pag. 179
h- Considerazioni conclusione: gli aspetti caratterizzanti il “made in
Italy” dal punto di vista della natura giuridica……………….pag. 180
2. Ancora sulla natura giuridica: considerazioni sull’istituendo marchio “made in
Italy”……………………………………………………………………….pag. 185
3. Individuazione del bene tutelato dalle norme sul “made in Italy”: opinioni
contrastanti………………………………………………………………....pag. 189
a- Il consumatore: soggetto non più passivo che compra prodotti
standardizzati………………………………………………...pag. 191
b- La tutela del “made in Italy” nel mercato globalizzato: la
salvaguardia del sistema produttivo nazionale………………pag. 195
6
c- Le imprese italiane: i soggetti maggiormente interessati alle norme
sull’origine imprenditoriale e geografica dei prodotti……….pag. 199
d- L’”italianità” dei prodotti quale interesse tutelato dalle norme sul
“made in Italy”……………………………………………….pag. 202
4. Fonti normative della tutela del “made in Italy”. La condotta incriminata..pag. 204
a- Il coordinamento tra l’articolo 517 codice penale e l’articolo 4,
comma 49, legge n. 350/2003 (c.d. finanziaria 2004)……….pag. 210
b- Profili critici della formulazione dell’articolo 4, comma 49, legge n.
350/2003 (c.d. finanziaria 2004)…………………………….pag. 211
c- Il coordinamento tra la nuova disciplina della legge n. 350 del 2003
(finanziaria 2004) e l’Accordo di Madrid del 1891………….pag. 214
d- Confronto tra l’Accordo di Madrid e il codice del consumo (decreto
legislativo n. 206/2005)……………………………………...pag. 215
5. L’individuazione del momento consumativo: superamento di un contrasto
giurisprudenziale…………………………………………………………..pag. 216
CAPITOLO IV
PROPOSTE DE IURE CONDENDO
1. Le proposte di legge a livello nazionale…………………………………pag. 219
7
a- Il sistema rigoroso: “made in Italy” consentito solo su prodotti
fabbricati interamente in Italia…………………………….…...pag. 222
b- Il sistema aperto: “made in Italy” consentito anche per la produzione
parzialmente effettuata all’estero nel rispetto di alcuni standards
qualitativi……………………………………............................pag. 229
c- La soluzione intermedia: compromesso tra sistema “aperto” e sistema
“rigoroso” quale maggiormente rispondente alle esigenze dei soggetti
interessati alle norme del “made in Italy”……………………...pag. 231
2. Le proposte di istituzione del marchio d’origine “made in EU”…………….pag. 233
3. Il rapporto tra il diritto comunitario e il diritto penale interno...…………….pag. 240
a- L’impostazione tradizionale: il diritto penale non rientra tra le
competenze della comunità europea………………………….. pag. 241
b- La tutela dei beni giuridici comunitari………………………... pag. 244
c- La configurazione di sanzioni da parte della normativa comunitaria
pag. 246
d- Il ricorso ai sistemi sanzionatori degli Stati membri…………. pag. 248
e- Le prospettive di armonizzazione per la tutela dei beni giuridici
comunitari…………………………………………………….. pag. 250
f- L’efficacia “riflessa” del diritto comunitario sul diritto penale pag. 251
1. L’interpretazione del giudice nazionale conforme al
diritto comunitario…………………………...…. pag. 252
8
2. La normativa comunitaria integra il precetto penale pag.
252
3. La configurazione di cause di giustificazione…... pag. 254
4. La disapplicazione da parte del giudice nazionale di
norme incompatibili con il diritto comunitario…..pag. 255
g- La cooperazione giudiziaria in materia penale nel Trattato sull’Unione
Europea………………………………………………………...pag. 256
h- Le previsioni della Costituzione europea……………………....pag. 259
i- Il Trattato di Lisbona pag. 260
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………….pag. 263
GIURISPRUDENZA………………………………………………………….. pag. 277
FONTI NORMATE…………………………………………………………… pag. 283
9
INTRODUZIONE
“MADE IN ITALY”, ANALISI GENERALE DEL FENOMENO
L’indicazione “made in Italy”, inizialmente utilizzata dai produttori nazionali per
indicare l’origine geografica dei propri prodotti, è, nel corso degli anni, diventata
emblema di valori estetici e di qualità, grazie agli ingenti investimenti effettuati
dall’intero sistema imprenditoriale italiano ed alla continua cura posta dagli operatori
del settore nella ricerca di sempre più elevati standard qualitativi.
Il “made in Italy” veicola un messaggio di eccellenza e qualità riconosciuto in tutto il
mondo, a differenza di analoghe indicazioni di altri paesi, e questo genera un potere
attrattivo per i prodotti cui è apposto.
In considerazione di tale potere attrattivo è sempre più avvertita l’esigenza di
individuare quando un prodotto possa essere considerato realmente italiano e dunque
quando sia legittimo apporvi una dicitura che lo ricolleghi all’Italia.
Tale problematica si è posta, in particolare, in questi ultimi vent’anni, in considerazione
dello sviluppo di un’economia globalizzata, in cui le imprese sono sempre meno legate
al territorio, grazie all’introduzione di nuove tecnologie di comunicazione e di trasporto,
che permettono agli operatori economici, localizzati in punti diversi e lontani, di
scambiare ordini e informazioni in tempo reale, come in tempo reale avvengono le
transazioni commerciali per cui i prodotti arrivano a destinazione in tempi sempre più
rapidi. In un’economia di questo tipo si rileva lo scontro tra interessi diversi: da una
parte quelli degli operatori economici nazionali, che si sentono danneggiati
10
dall’indiscriminata importazione di prodotti di cui non si conosce l’effettiva
provenienza e dall’altra quelli delle società multinazionali che, de-localizzando i propri
processi produttivi in paesi in via di sviluppo, sono interessati a non palesare l’origine
geografica dei prodotti che rivendono con elevati margini di guadagno, avendo
sostenuto costi fortemente competitivi.
In questo scenario assume più che mai rilevanza la questione dell’origine dei prodotti.
Se fino a vent’anni fa la produzione di un’azienda italiana avveniva completamente
entro i confini nazionali, per cui non vi erano problemi di distinzione tra origine
imprenditoriale e provenienza geografica, questi oggi emergono, perchè molte aziende
hanno de-localizzato la produzione. Si pensi che la Romania è considerata la nona
provincia veneta.
Si è sentita la necessità di un intervento del legislatore volto a chiarire cosa sia italiano e
cosa non lo sia. Vi è stata l’esigenza di individuare strumenti che siano in grado di
aumentare le difese del mercato dalla diffusione di prodotti che recano illegittimamente
le diciture “made in Italy” o “Italy”, ma anche di garantire la libertà imprenditoriale e di
salvaguardare principi che si stanno sempre più radicando nel nostro sistema giuridico,
quali la corretta informazione e la protezione del consumatore.
Il nostro legislatore, recependo tali esigenze, è intervenuto emanando una normativa
nazionale che specificatamente disciplini l’apposizione “made in Italy” sui prodotti, con
l’intento di trasmettere un forte segnale da parte dello Stato e per tentare di risolvere le
problematiche che hanno messo in crisi diversi settori dell’industria nazionale.
Le regole relative all’uso del “made in Italy” o di altre indicazioni che richiamano
l’origine italiana dei prodotti (come Italy o i colori della bandiera italiana o comunque
qualsiasi altra indicazione denominativa o figurativa che colleghi il prodotto all’Italia)
sono, però, in continua evoluzione.
11
Nell’ordinamento italiano si è registrata, infatti, negli ultimi anni una vivace quanto
disorganica successione di norme, che ha fatto da contraltare a decenni di scarsa
attenzione per la materia, generando difficoltà interpretative e una copiosa produzione
giurisprudenziale.
L’intervento normativo più rilevante è costituito dalla legge finanziaria 2004 (legge n.
350 del 2003) e sue successive modifiche, che ha introdotto per la prima volta nel
nostro ordinamento giuridico alcune regole per l’uso legittimo del “made in Italy”.
Con la citata legge finanziaria 2004 ha preso il via un più vasto progetto di riforma a
tutela della produzione italiana. E’ stato avviato, ad opera del Ministero delle attività
Produttive e del Ministero delle Finanze, il così detto Progetto Leonardo “per la
realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a
favore del “made in Italy””. Tale progetto prevede la regolamentazione dell’indicazione
di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente
prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di
origine, nonché il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico,
rivolte alla diffusione del “made in Italy” nei mercati mediterranei, dell’Europa
continentale e orientale (articolo 61 legge finanziaria 2004). E’ previsto, tra l’altro, la
creazione del fondo per la promozione straordinaria del “made in Italy”, nonché la
creazione del Comitato nazionale anti-contraffazione.
Inoltre, non limitandosi a stabilire, in chiave programmatica, misure per tutelare e
promuovere il “made in Italy” con interventi legislativi di attuazione e risorse da
destinare al sistema produttivo, la legge finanziaria 2004, articolo 4 comma 49, è
intervenuta direttamente nel campo penale, introducendo una parziale modifica
all’articolo 517 del codice rubricato “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
per estendere le condotte rilevanti, descrivere un oggetto giuridico più ampio rispetto
12
alla previsione codicistica e anticipare il momento consumativo del reato già alla
presentazione della merce in dogana.
Le recenti novità normative hanno avuto un impatto immediato sul mondo
imprenditoriale italiano, che si è trovato all’improvviso a fronteggiare una serie di
disposizioni di difficile e complessa interpretazione letterale e sistematica.
L’interpretazione estremamente aggressiva datane dalle autorità doganali ha provocato
una copiosa produzione giurisprudenziale, nel 2005 e 2006, non solo da parte dei
giudici di merito, ma anche da parte della terza sezione penale della Corte di
Cassazione.
Le sentenze analizzate vertono per lo più su casi di “produzione su commissione”: ossia
si riferiscono a quella diffusa prassi industriale per la quale l’imprenditore nazionale,
invece di produrre direttamente in Italia determinati beni, affida la loro realizzazione (o
di loro parti) ad un commissionario estero, dettando a quest’ultimo le procedure di
fabbricazione e riservandosi normalmente la facoltà del riscontro qualitativo sul
prodotto finito. Tale pratiche, come detto, sono la ragione dello stesso intervento del
legislatore.
Chiamata a valutare la rilevanza penale di tale pratica alla luce della norma codicistica e
delle nuove norme extra codicem, la Corte di Cassazione si è pronunciata, nella
maggioranza delle sentenze, in senso negativo, affermando che la garanzia fornita al
consumatore riguarderebbe l’origine e la provenienza del prodotto non già da un
determinato luogo, bensì da un determinato imprenditore, che si assume la
responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; solo nei casi di
prodotti agro-alimentari il concetto di origine indicherebbe, invece, la provenienza da
un determinato luogo geografico. Dall’analisi delle sentenze emerge, però, come le
pronunce più recenti della Corte, quale ad esempio la sentenza Giordani n. 2648/2006,
13
abbiano cercato anche interpretazioni alternative nell’applicare il comma 49 articolo 4
legge 350 del 2003, nell’intento di recuperare al delitto de quo una maggiore operatività
rispetto a quella emergente dalla formulazione dell’articolo 517 codice penale.
Le numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia e gli interventi del
legislatore stimolano l’attenzione in una duplice direzione. Da un lato, si pone il
problema, affrontato ex professo dalla Suprema Corte, di individuare il contenuto
precettivo della nuova norma incriminatrice, perimetrandone l’ambito applicativo
rispetto all’area di tipicità propria dell’articolo 517 codice penale; dall’altro si cerca di
individuare l’interesse protetto, procedendo alla collocazione della fattispecie
nell’attuale momento storico, segnato dalla così detta “globalizzazione” dei mercati,
cercando di cogliere i valori culturali che il delitto in parola sembra voler esprimere.
Tutto ciò con una doverosa premessa: l’ordinamento italiano non impone, in positivo,
un obbligo di indicare l’origine e la provenienza dei prodotti industriali messi in
commercio, quanto, in negativo, vieta e intende reprimere la condotta ingannatoria di
chi faccia uso di nomi, marchi e segni distintivi mendaci.
Sulla base dell’individuazione del bene protetto dalla norma, sul quale dottrina e
giurisprudenza non sembrano trovare accordo, sarà possibile formulare pareri
sull’opportunità di eventuali riforme del legislatore.
Un discorso sulla tutela della provenienza geografica e aziendale dei prodotti industriali
deve necessariamente fare i conti con le dinamiche complesse della moderna realtà
economica, caratterizzata da aspetti fisiologici e patologici strettamente interconnessi e
con istanze ed esigenze tra loro spesso contrapposte e apparentemente inconciliabili.
In questo contesto un intervento riformatore inteso a colpire la patologia, individuata
nell’inarrestabile diffusione sul mercato nazionale di prodotti contraffatti, provenienti
da mercati stranieri specie in via di sviluppo, deve tener conto delle conseguenze che
14
potrebbe avere rispetto ad altre dinamiche ed altre esigenze parimenti meritevoli di
tutela. Ci si riferisce, in particolare, al fisiologico decentramento dell’attività industriale
attraverso l’esternalizzazione della produzione a terzi sub-fornitori, spesso operanti
proprio su mercati in via di sviluppo, dove è possibile avvantaggiarsi del basso costo del
lavoro e/o di agevolazioni finanziarie e all’esigenza degli imprenditori nazionali, che
hanno, in tutto o in parte, decentrato il ciclo di produzione, di caratterizzare comunque i
propri prodotti in maniera uniforme, per origine, provenienza e qualità al fine di
conservare, indipendentemente dal luogo di fabbricazione dei prodotti stessi,
l’immagine unitaria del gruppo, del marchio e del prodotto.
Inoltre, si deve osservare, che gli interventi del legislatore non possono prescindere dal
contesto internazionale e comunitario. Ogni riforma in materia di “made in Italy” potrà
godere di un reale grado di effettività soltanto nel momento in cui venga condivisa
quantomeno a livello europeo. Alcune perplessità sorgono, dunque, in merito
all’opportunità di una riforma esclusivamente nazionale, specie in considerazione
dell’acceso dibattito che si sta svolgendo, in sede europea, per una regolamentazione
comune della materia che, a breve, potrebbe portare alla creazione di un marchio “made
in UE”.
15
CAPITOLO I
LA TUTELA DEL “MADE IN ITALY” PRIMA DELLA LEGGE N.
350 DEL 2003 (C. D. FINANZIARIA 2004)
SOMMARIO: 1. La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517
codice penale): a) il titolo ottavo del libro secondo del codice penale: una novità del
codice Rocco; b) in particolare il capo secondo, titolo ottavo: i delitti contro l’industria e
il commercio; c) la depenalizzazione dei reati previsti dall’articolo 67 legge marchi; d)
L’oggetto materiale del reato previsto dall’articolo 517 codice penale, rubricato
“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”; e) condotta e momento
consumativo; f) il mendacio sull’origine, la provenienza e la qualità; g) in particolare il
mendacio su origine e provenienza dell’opera o del prodotto; h) in particolare il
mendacio sulla provenienza geografica dei prodotti; i) in particolare il mendacio sulla
qualità; j) lo sviluppo della giurisprudenza e della dottrina relativamente al mendacio
sulla provenienza e l’origine dell’opera e del prodotto: 1- anni Sessanta; 2- anni
Settanta; 3- anni Ottanta; 4- anni Novanta: sentenza thun (Cassaione, sez. III, 7 luglio
1999, n. 2500); k) considerazioni conclusive. – 2. L’Arrangement di Madrid del 1981
applicato al “made in Italy”. – 3. Accenni alla disciplina civilistica in tema di “made in
italy”.
Le disposizioni legislative precedenti alla legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004)
con le quali si sanzionava (e si sanziona ancora oggi) l’uso illecito del “made in Italy” o
di altre indicazioni di origine e provenienza, sono l’articolo 517 codice penale e
l’articolo 1 dell’Arrangement di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la repressione
delle indicazioni di provenienza false o fallaci, che è stato ratificato con legge 4 luglio
16
1967, n. 676 ed integrato dalle norme per la sua applicazione contenute nel d. P. R. 26
febbraio 1968, n. 656.
L’attenzione dei giudici di legittimità, dell’amministrazione e prassi doganale e della
dottrina non è, però, stata in passato elevata come, invece, lo è oggi. Il problema del
“made in Italy” è relativamente attuale, se ne parla da circa una quindicina anni1.
I casi vagliati dalla Suprema Corte di Cassazione hanno finora riguardato ipotesi di
produzione su commissione. È stato solo dal 2003 che l’attenzione si è direttamente
incentrata sul “made in Italy” e la sua apposizione legittima. Questo è dovuto al fatto
che solo negli ultimi quindici anni lo svilupparsi dell’economia globalizzata e del
fenomeno dei gruppi societari ha acquisito importanza e le importazioni dai mercati
stranieri, soprattutto dal Far East, hanno assunto dimensioni considerevoli.
1
Cfr. Supra, Introduzione: “made in Italy”, analisi generale del fenomeno, pag. 10-11;
17
1. LA VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
(ARTICOLO 517 CODICE PENALE)
a- Il titolo ottavo del libro secondo del codice penale: una novità del codice Rocco
Il codice penale del 1930 protegge la provenienza aziendale e geografica dei prodotti
industriali nel titolo ottavo del libro secondo, collocando tra i reati contro “l’economia
pubblica, l’industria e il commercio” due figure tipiche di reato: la frode nell’esercizio
del commercio (articolo 515 codice penale) e la vendita di prodotti industriali con segni
mendaci (articolo 517 codice penale)2.
L’intero titolo ottavo del codice Rocco rappresenta una novità rispetto al liberale codice
Zanardelli del 1889. Quest’ultimo infatti, in coerenza con i postulati ideologico - politici
tipici del liberismo economico, non aveva apprestato alcuna tutela penale dei fatti
economici in sé, ma si era limitato a disciplinare l’aggiotaggio, la frode in commercio e
la vendita di sostanze alimentari non genuine tra i delitti contro la fede pubblica e lo
sciopero tra i delitti contro la libertà.
Tale innovazione si spiega con lo sviluppo di una moderna economia industriale, in cui
si assiste al passaggio dal principio del liberismo economico all’intervento dello Stato
2
G. Fornasari, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, Padova, Giuffrè, 1994, pag. 42 e ss.
18
nel settore dell’economia e l’affermarsi di esigenze di tutela degli interessi collettivi
rispetto a quelli individuali3 4.
Il Guardasigilli spiega che “le disposizioni di questo titolo hanno stretto riferimento alle
nuove concezioni politiche e sociali della dottrina fascista, dappoichè esse intendono
apprestare un’efficace e specifica difesa degli istituti e dei presupposti fondamentali
dello Stato corporativo, quale fu creato e si viene organizzando sulla scorta dei principi
fissati nella Carta del lavoro. L’opportunità di una più rigorosa tutela della produzione
nazionale è, infatti, in diretto rapporto con il fine supremo che alla produzione stessa è
assegnato: l’affermazione, lo sviluppo della potenza economica”.
Il titolo ottavo non è esente da critiche. Già nei primi anni successivi alla sua entrata in
vigore è stata evidenziata l’improprietà della contrapposizione tra economia pubblica ed
industria e commercio, posto che si tratta di un rapporto tra il tutto (l’economia) e le
singole parti (l’industria e il commercio).
Inoltre si è registrata, in tempi più recenti, una quasi totale disapplicazione e di
conseguenza inefficacia di gran parte delle fattispecie del titolo ottavo ed in particolare
di quelle del capo primo, relative all’economia pubblica. Le cause di ciò sono da
rinvenire nel criterio ispiratore delle diverse fattispecie: la tutela della produzione
nazionale, intesa come insieme delle attività produttive che danno vita ad un vero e
proprio sistema. Tale evento, richiesto dalle norme incriminatici per la loro
configurazione, è di dimensioni gigantesche, è un “mega-evento”, il che ha comportato,
come conseguenza inevitabile, la quasi impossibile verificabilità empirica di un evento
3
C. Pedrazzi, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Enciclopedia del
Diritto, volume XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pag. 278-282 evidenzia come l’autonomo rilievo dato
all’economia dal legislatore sia espressione dell’importanza che lo Stato attribuisce a questo tema.
4
Alcuni codici preunitari raggruppavano i delitti relativi “al commercio, alle manifatture ed arti” in un
capitolo autonomo: così come il codice sardo (articolo 391-405), parmense (articoli 472-489) e delle Due
Sicilie (articoli 320-325); ma in tale sistematica, più che un’anticipazione dei criteri informatori
dell’attuale titolo VIII, si avverte l’eco della legislazione dell’ancien regime. In tal senso C. Pedrazzi,
voce Economia,…., cit., pag. 278;
19
di tali proporzioni e, in ogni caso, insuperabili difficoltà di accertarlo in sede
processuale. Questo connotato di gigantismo della fattispecie rappresenta la diretta
conseguenza di discutibili scelte ideologiche peraltro non adeguatemente mediate e
filtrate attraverso un sapiente uso della tecnica normativa.
Il titolo ottavo si suddivide in tre capi: il primo relativo ai delitti contro l’economia
pubblica, il secondo concerne i delitti contro l’industria e il commercio e il terzo
contiene una disposizione comune ai precedenti.
Quello che a noi interessa maggiormente è il capo secondo in cui è collocato l’articolo
517 codice penale che rileva per l’analisi del “made in Italy”.
20
b- In particolare il capo secondo: i delitti contro l’industria e il commercio
Nei delitti contro l’industria e il commercio, la tutela dell’economia pubblica viene in
rilievo sotto un angolatura particolare. Il legislatore non ha penalizzato fatti che
aggrediscono direttamente gli interessi globali del sistema economico, ma
comportamenti che arrecano pregiudizio al corretto esercizio di attività industriali o
commerciali e, di conseguenza, colpiscono gli interessi di una pluralità indistinta di
persone. Comunque la tutela dell’economia pubblica costituisce sempre la ragione
giustificatrice della disciplina codicistica, non assumono rilevanza gli interessi
patrimoniali di natura individuale coinvolti nelle diverse fattispecie.5 Non sempre, però,
l’intenzione del legislatore si è tradotta in adeguate formulazioni normative: ad esempio
nel delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio, l’interesse individuale si
proietta sullo schermo della fattispecie che è appunto punibile a querela dell’offeso.
Nelle frodi commerciali, invece, la tutela della buona fede degli scambi non lascia
spazio agli interessi individuali: la frode in commercio è integrata anche da un
comportamento che arreca un vantaggio patrimoniale all’acquirente.6 7
5
Cfr. G. Marinucci, voce Frode in commercio, in Enciclopedia del diritto, volume XVIII, Milano,
Giuffrè, 1969, pag. 137.
6
Cfr. C. Pedrazzi, voce Economia pubblica, cit., pag. 281.
7
Cfr. G. Fornasari, Il concetto …, cit.; L. Conti, voce Economia pubblica, industria e commercio, in
Digesto delle discipline penalistiche, volume IV, Torino, Utet, 1990, pag. 198; C. Paterniti, voce
Economia pubblica (delitti contro la), in Enciclopedia giuridica, volume XII, Treccani, Roma, 1989.
21
c- La depenalizzazione dei reati previsti dall’articolo 67 legge marchi
E’, invece, definitivamente consegnato al campo dell’illecito amministrativo l’articolo
67 della legge sui marchi (r.d. 21-6-1941, n. 929), in cui erano descritte due distinte
ipotesi contravvenzionali, già depenalizzate dalla legge n. 706 del 1975 per poi essere
ulteriormente ridimensionate nel contenuto precettivo dal decreto legge n. 480 del 1992,
in conseguenza dell’avvenuta abrogazione dell’ipotesi di “usurpazione” contenuta nel
vecchio articolo 14 della legge sui marchi, che era richiamata in chiave sanzionatoria8.
Ora il nuovo articolo 67 della legge marchi commina la sanzione amministrativa per
“chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero,
tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,oppure
tendenti a far credere che l’oggetto contraddistinto sia brevettato”.
Nel secondo comma è ora prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di
violazione degli articoli 10 (rubricato “impiego di un marchio la cui registrazione sia
stata dichiarata nulla per causa che comporta l’illiceità dell’uso”) e 12 (rubricato
“soppressione del marchio altrui”).9
8
Di “ragionevole” abrogazione parla A. Vanzetti, La nuova legge marchi, Milano, 1993, pag. 60 che
ricorda “l’infelicissima, arcaica e spesso poco comprensibile formulazione” dell’articolo 14 legge marchi;
9
Per un approfondimento si veda Marchetti-Umbertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza,
Padova, Cedam, 1997, pag. 1138;
22
d- Oggetto materiale del reato previsto dall’articolo 517 codice penale, rubricato
“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”
La condotta penale tipica descritta dagli articoli 515 e 517 del codice penale è una
condotta commissiva e non omissiva, per cui integra la fattispecie di reato chi ponga in
essere una condotta ingannatoria facendo uso di nomi, marchi e segni distintivi mendaci
e non invece chi semplicemente ometta di dichiarare l’origine e la provenienza dei
prodotti industriali posti in circolazione.
La disposizione normativa utilizzata prima della legge n. 350/2003 (c.d. finanziaria
2004), che ha introdotto un’apposita disposizione a tutela della provenienza dei
prodotti10, per punire l’uso illecito del “made in Italy” era l’articolo 517 codice penale
rubricato “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.
Tale norma incrimina: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o
esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto”.
La giurisprudenza risalente, come si vedrà, tendeva, tuttavia, a limitare la portata di
questa norma, nel senso di restringerla per lo più alle ipotesi di contraffazione del
“marchio”, lasciando a margine la tutela dell’origine geografica del prodotto.
Pacificamente si ritiene che l’interesse tutelato dalla previsione codicistica dell’articolo
517 codice penale sia l’ordine economico e che in ciò stia il discriminen con la
fattispecie di cui all’articolo 474 codice penale che, sottoponendo a pena la
10
Cfr. Infra capitolo II, § 1, pag. 59 e ss.
23
contraffazione (materiale) dei soli marchi registrati, è invece posto a presidio della
pubblica fede.11
Nel tentativo di specificare il contenuto dell’evanescente formula “ordine economico”,
autorevole dottrina12 ha sottolineato come, accanto all’interesse dei consumatori a non
venir ingannati circa determinate caratteristiche del prodotto (origine, provenienza,
qualità), sia rinvenibile l’ulteriore esigenza di tutelare produttori e commercianti dalla
sleale concorrenza che il mendacio rivolto al consumatore concreterebbe, ovvero
nell’aspettativa del produttore a che non vengano compromesse la stima e la
considerazione di cui gode il prodotto e la conseguente diffusione.
In questa prospettiva si sottolinea come l’articolo 517 codice penale, configurando un
reato di pericolo, perché anticipa la punibilità ad una fase antecedente la traditio della
res, essendo il destinatario della condotta non ancora determinato, costituisca un
esempio di frode in incertam personam e si traduca in una tutela avanzata della buona
fede negli scambi commerciali.13
La qualificazione della fattispecie come reato di pericolo non esime, comunque,
l’interprete da verificare, in concreto, l’idoneità percettiva del mendacio, valutata alla
stregua di un parametro empirico: l’attenzione che il consumatore medio dedica
all’esame del prodotto. 14
11
Per tutti, G. Neppi Modona, Interesse alla produzione e interesse del consumo nell’articolo 517 codice
penale, in Rivista italiana diritto e processo penale, Milano, 1964, pag. 804.
12
In tal senso C. Pedrazzi, voce Economia pubblica), cit., pag. 281; G. Neppi Modona, Interesse…, cit. ,
pag. 801; G. Fiandaca- E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, volume I,
quarta edizione, Bologna, Zanichelli, 2007, pag. 651; G. Ebner, sub articolo 517, in AA. VV., Codice
penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di G. Lattanzi- E. Lupo, IX, Milano, 2000, pag.
646; C.F. Grosso, Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni
mendaci, in Rivista italiana diritto e processo penale, Milano, 1989, pag. 1265; M. Locatelli, Dell’esame
comparativo tra il marchio contraffatto e quello originale e dell’uso del nome geografico come marchio,
in Rivista trimestrale diritto penale dell’economia, 1992, pag. 231.
In giurisprudenza si veda Cassazione, Sez. III penale, 29 gennaio 2003, Piscitelli, in Rivista Penale, 2003,
pag. 381; Cassazione, Sez. III penale, 9 dicembre 1998, Tombola, in Cassazione penale, 2000, pag. 1285;
13
In tal senso G. Marinucci, voce Frode in commercio, in Enciclopedia del diritto, Volume XVIII,
Milano, Giuffrè, 1969, pag. 136.
14
Per tutti, A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Digesto delle discipline penalistiche,
volume XIV, Torino, Utet, 1999, pag. 456; C. Pedrazzi, voce Economia pubblica…, cit., pag. 281; C.F.
24
L’articolo 517 codice penale configura, dunque, un reato di pericolo concreto, che non
intende offrire una tutela diretta alla veridicità dei segni o alla verità del messaggio, ma
alla affidabilità che il pubblico viene a riporre in essi.
La categoria di “mezzi” che fanno da veicolo alle informazioni su cui il pubblico ripone
il suo affidamento deve essere contenuta nelle tipologie espressamente indicate dal
legislatore. Saranno rilevanti, dunque, i nomi, ad esempio quello proprio del produttore,
che sono denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere;
i marchi registrati e non, quindi anche di fatto, perché l’articolo 517 codice penale a
differenza dell’articolo 473 non richiede la previa osservanza delle norme sulla
proprietà industriale ed i segni distintivi. Segno distintivo è un termine generico che
indica la ragione o la denominazione sociale, la ditta, l’insegna ed inoltre sembrerebbe
che la norma si riferisca anche quelli di genere, ad esempio le indicazioni di
provenienza.15 In tale prospettiva il problema del “made in Italy” viene rincodotto
all’articolo 517.
I marchi, registrati e non (marchi di fatto), si affiancano, all’interno della figura in
esame, a tutti gli altri segni espressivi di messaggi in grado di suscitare rappresentazioni
circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto. La punibilità scatta qualora si
accerti che le informazioni suggerite dai segni possono generare una falsa
rappresentazione di quelle caratteristiche nei consumatori-destinatari.
Analogamente non è necessario che vi sia stata una vera e propria contraffazione o
alterazione degli stessi: è sufficiente che vi sia stato l’utilizzo di nomi, marchi o segni
distintivi che risultano idonei ad indurre in errore l’eventuale compratore “medio” in
Grosso, Condotta e momento consumativo…, cit., pag. 1265. Pur individuando la stessa oggettività
giuridica G. Neppi Modona, Interesse della produzione …, cit., pag. 801, sostiene che l’articolo 517
codice penale desume una lesione oggettiva dell’interesse del produttore.
15
In tal senso si è espressa la Cassazione , Sez. III penale, 25 Settembre 1980, in Giustizia Penale, fasc. n.
81, II, pag. 130;
Parte della dottrina, peraltro, non condivide tale estensione della formula legale, pur ammettendo che nel
concetto di segno distintivo rientrano certamente la ragione o la denominazione sociale, la ditta, l’insegna,
l’indicazioni di provenienza e gli altri segni di genere;
25
ordine all’origine, provenienza o qualità del prodotto, come si desume sia dalla
descrizione del tipo legale sia dalla finalità di tutela rivolta al pubblico degli
indifferenziati, potenziali clienti.
26
e- Condotta e momento consumativo
La condotta tipica dell’illecito represso dall’articolo 517 codice penale è data dalla
“messa in vendita” o “messa in circolazione” del prodotto coperto dai segni mendaci.
Il reato si consuma con il primo atto di messa in circolazione o in vendita, atto che,
secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, si lega al “passaggio dal
fabbricante al consumatore o ad un intermediario e può proseguire fino al momento
della destinazione al consumatore finale”.16
La messa in circolazione può, in particolare, realizzarsi con qualsiasi attività attraverso
la quale la merce esce dalla sfera di disponibilità del fabbricante, ora con la vendita
(“che è in definitiva una forma di messa in circolazione”), ora con la donazione e lo
scambio, ora con il deposito dei prodotti.
Quest’ultima attività, aggiunge la Corte, è penalmente irrilevante solo quando rimanga
nella sfera di disponibilità del fabbricante, mentre configura il reato ogniqualvolta, per
le modalità e il luogo del deposito, risulta finalizzata alla commercializzazione e si
qualificandosi così come prodromica alla vendita. 17
Nel caso di specie per la Suprema Corte doveva, quindi, ritenersi consumato il reato
poiché, per un verso, la merce era già stata ceduta dal fabbricante al distributore e, per
altro verso, essendo stata depositata presso un centro commerciale, luogo cioè deputato
alla commercializzazione, la condotta non poteva qualificarsi come mera detenzione.
Donde è stato ravvisato il concorso del ricorrente con il fabbricante o un suo
intermediario “nella perpetrazione del reato nel momento in cui ha ricevuto la merce”,
16
Cassazione, Sez. III penale, 20 aprile 2005, n. 14644, Tarantino, in Foro italiano, 2005, fasc. 12, pag.
646-647, nonché in Guida al diritto, 2005, n. 43, pag. 92.
17
Cassazione, sez. III penale, 24 Marzo 2003, P., con nota di A. Madeo, L’offerta di cibi congelati come
atto univocamente diretto alla frode in commercio, in Rivista diritto penale e processo, 2004, pag. 218.
27
atteso che “l’attività di immagazzinamento finalizzata alla distribuzione configura
astrattamente l’ipotesi criminosa ipotizzata”.
Il risultato cui perviene la pronuncia citata si uniforma ad autorevole dottrina 18 nonché
al costante orientamento della Suprema Corte che, sottolineando la differenza tra la
condotta di “mettere altrimenti in circolazione” e quella di “mettere altrimenti in
commercio” di cui all’articolo 516 codice penale, ha sempre riconosciuto alla previsione
dell’articolo 517 codice penale una portata ben più ampia, tale da ricomprendere ogni
attività diretta a far uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del detentore.
Controversa, invece, è la rilevanza penale dell’attività di presentazione della merce alla
dogana: mentre alcune pronunce ritengono che il blocco alla frontiera dei prodotti possa
configurare il delitto nella forma tentata19, altre negano la configurabilità del tentativo
rispetto ad un reato di pericolo quale l’articolo 517 codice penale, sostenendo così
l’irrilevanza penale della condotta di presentazione della merce alla dogana. 20
La questione può dirsi superata grazie all’intervento della Finanziaria 2004 ai sensi
della quale “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di
origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 codice penale”21.
18
Cfr. A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi…, cit., pag. 466; G. Ebner, sub. articolo 517
codice penale, cit., pag. 650. Sostiene invece che la condotta di messa in circolazione non possa “trovare
una collocazione anticipata rispetto alla messa in vendita” e conclude quindi per l’irrilevanza penale
dell’attività di immagazzinamento della merce C.F. Grosso, in Condotta e momento consumativo.., cit.,
pag. 1265.
19
Così Cassazione, Sez. III penale, 13 Ottobre 1999, n. 11671, Delaser, in Rivista penale, 2000, pag. 41 e
Cassazione, Sez. III penale, 11 Dicembre 1995, n. 4374, Dubini, in Rivista trimestrale di diritto penale
dell’economia, 1996, pag. 1399.
20
Cfr. Cassazione, Sez. III penale, 26 aprile 2001, n. 26754, Andolfo, in Cassazione Penale, 2002, pag.
2124.
21
Cfr. Infra capitolo 3, § 5, pag. 216.
28
f- Il mendacio sull’origine, la provenienza e la qualità
L’attitudine ingannatoria dei segni distintivi deve riguardare “l’origine, la provenienza
o la qualità del prodotto”. Il mendacio è tipico solo se diretto a caratteristiche rilevanti e
significative del prodotto, che assumono, cioè, importanza nella formazione delle scelte
dei consumatori.
Si rileva, peraltro, l’incertezza mostrata dalla dottrina nel definire i concetti di origine e
di provenienza, spesso usati alla stregua di una mera endiadi.
Parte della dottrina, supportata da una certa giurisprudenza, si spinge persino a negare
qualsiasi autonomia ai due concetti di “origine” e “provenienza”, qualificandoli quali
elementi funzionali al terzo, cioè la qualità, che in realtà sarebbe il solo fondamentale,
posto che il luogo e lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato sono indifferenti
alla qualità del prodotto stesso. In quest’ ottica, origine e provenienza dovrebbero
intendersi esclusivamente come indicatori della provenienza giuridica, ossia del
produttore cui attribuire la responsabilità per la qualità, appunto, del prodotto.
La dottrina che riconosce un significato autonomo ai due concetti ricollega, invece,
l’”origine” alla provenienza geografica “da un determinato luogo specifico” e la
“provenienza” alla provenienza aziendale “da un determinato produttore specifico” dei
prodotti messi in circolazione.
La legge penale si propone di reagire, con tale norma, fondamentalmente a due ordini di
fatti illeciti: alla contraffazione (compresa l’alterazione) del segno legittimamente
adottato da altri ed all’impiego di marchi mendaci: di marchi cioè che, senza essere la
copia o l’imitazione di un marchio registrato altrui (o il frutto di modifiche portate
29
direttamente sul marchio registrato genuino), sono però idonei per il loro contenuto, o
per il rapporto in cui si trovano con il prodotto marcato, a trarre in inganno il pubblico
dei consumatori sull’origine, la provenienza o la qualità del prodotto stesso. “Marchi
falsi e marchi non veri” secondo la definizione risalente al Binding.22
Il mendacio ingannevole può tuttavia incorporarsi, oltre che nel marchio, anche nell’
Ausstattung del prodotto o dell’opera: cioè in quel complesso di segni, forme, colori,
immagini, diciture, emblemi, fregi, ecc.., che in aggiunta al marchio e a volte con un
peso o un’efficacia superiore inducono il consumatore a istituire un collegamento tra la
merce sulla quale sono apposti e una determinata provenienza aziendale, o una data
origine geografica, o una data qualità. Ecco perché la legge punisce “chiunque pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto”. 23
Sarà pertanto tutta l’apparenza esteriore dell’opera o del prodotto che dovrà insinuare
nell’acquirente le impressioni fallaci sulle sue caratteristiche: a comporre il quadro della
presentazione fraudolenta giocherà anche il particolare ingannevole.
22
In tal senso K. Binding, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, vol. II,
Leipzig, 1904, pag. 350 e ss.
23
Cfr. C. Pedrazzi, voce Economia pubblica…, cit., pag. 281.
30
g- In particolare il mendacio sulla provenienza aziendale e l’origine dell’opera o
del prodotto
Il mendacio sulla provenienza aziendale può scaturire, essenzialmente, da due
situazioni: dal fatto cioè che il marchio genuino (o altro segno che indichi la
provenienza aziendale) si trovi apposto su un prodotto (o su un involucro del prodotto)
diverso da quello originario oppure dal fatto che il marchio genuino (o altro indicatore
di provenienza) contrassegni un prodotto che origina solo in parte dall’azienda che
dovrebbe stare a “indicare”.
La prima ipotesi viene designata in dottrina24 con il nome – mutuato dalla pratica
francese - di “délit de remplissage”. Il caso concreto più frequente è, infatti, quello del
commerciante o del produttore che in possesso di recipienti, bottiglie, sacchi, ecc..,
recanti un marchio autentico o altro segno distintivo della provenienza da una data
azienda, li riempia di un prodotto in tutto o in parte diverso da quello originario.
L’ipotesi in esame è però comprensiva anche della situazione opposta, cioè del fatto che
il produttore o il commerciante appongano i propri contrassegni su un prodotto altrui. 25
In entrambi i casi la ragione dell’illiceità risiede nel fatto, che al contrassegno genuino
viene fatta esplicare fallacemente la sua funzione tipica di indicatore di provenienza, in
relazione a un prodotto che, in realtà, non origina dall’azienda che dovrebbe stare a
indicare.
La seconda ipotesi di mendacio sulla provenienza aziendale, a cui oggi si dà maggiore
rilevanza, quando ci si riferisce al mendacio relativo alla provenienza aziendale, è
legata invece a un fenomeno economico: cioè alla tendenza dei produttori di
24
25
In tal senso G. Neppi - Modona, Interesse alla produzione…, cit., pag. 799-780.
In tal senso G. Neppi - Modona, Interesse alla produzione…, cit., pag. 781.
31
commissionare la fabbricazione della loro merce, o di parte di essa, ad altre aziende
economicamente e giuridicamente indipendenti. E in tale seconda ipotesi delittuosa,
come si vedrà, si inserisce la tematica del “made in Italy”.
32
h- In particolare il mendacio sulla provenienza geografica dei prodotti
Il mendacio ingannevole sulla “origine geografica” del prodotto può incorporarsi
soltanto nei marchi e nei segni distintivi genuini: con una parola, un’espressione
composta, un simbolo grafico, un’immagine, o più spesso, con un complesso di
elementi emblematici, denominativi, grafici, ecc.., si possano evocare, fallacemente, il
nome di una città, di una regione, di uno Stato, che sono famosi nei traffici per la bontà
della merce che vi si produce, bontà e fama che riposano ora sulla natura intrinseca dei
prodotti, ora sulla rinomata tecnica di fabbricazione propria di certi ambiti geografici
(come gli orologi svizzeri, i profumi francesi, ecc…), ora, infine, sulla notorietà della
“ricetta” che assicura ai prodotti alimentari di certe zone una certa qualità26.
Il valore di queste indicazioni geografiche fallaci vale, soprattutto, quando richiamino
un luogo di origine extra nazionale: a torto o a ragione vi sono infatti dei prodotti che
ripetono bontà e notorietà dalla loro origine straniera. E poca importa che si tratti di
bontà e notorietà usurpate: poco conta che il convincimento dei consumatori si fondi
magari su un preconcetto. Se nella concezione del mercato una data indicazione
geografica viene a influenzare il giudizio dei consumatori, questo è sufficiente perché
l’indicazione geografica fallace riesca a trarre in inganno i consumatori su un elemento
decisivo ai fini della loro scelta.27
È alla psicologia del consumatore medio che bisogna, dunque, far capo per misurare
l’attitudine di un prodotto ad essere riconosciuto per la sua determinata origine
geografica. Quanto ad essa, occorre aggiungere che non basta – ad evitare l’effetto
d’inganno- che il produttore abbia voluto assumere un contrassegno “geografico” come
26
Sulle varie forme di mendacio sull’origine geografica cfr. G. Marinucci, Il diritto penale dei marchi,
Milano, Giuffrè, 1962, pag. 143 e ss.
27
Cfr. V. Manzini, Trattato di diritto penale, volume VII, Utet, 1986, pag. 456.
33
denominazione fantastica di un prodotto, perché è necessario che la clientela media,
sprovvista com’è di particolari dati di attenzione, riconosca e si avveda dell’assunzione
fantastica del contrassegno geografico. 28
Può accadere però che il fenomeno della “volgarizzazione” nel linguaggio dei
consumatori incida anche sulle denominazioni geografiche: un nome che agli inizi
indicava la provenienza del prodotto da una regione celebrata per doti di natura, o per
operosità di uomini, può diventare in seguito, per le vicende più diverse, la
denominazione necessaria di un genere merceologico, oppure l’indice di una qualità del
prodotto. Qualche esempio: acqua di Colonia, cappello di Panama, sigari dell’Avana,
ecc… Quando ciò accada, evidentemente non si potrà più parlare di false o veraci
indicazioni d’origine, perché si tratta di indicazioni che agli occhi dei consumatori
significano tutt’altra cosa: o il nome generico di un prodotto o l’indice di una sua
qualità.
Perché il fenomeno della volgarizzazione rilevi occorre, però, che si sia compiuto in
modo rilevante nel linguaggio dei consumatori.
28
Cfr. R. Panzarini, Marchio e nome geografico, in Rivista di diritto industriale, 1953, fasc. 11, pag. 231
e ss.
34
i-
In particolare il mendacio sulla qualità
L’ultima ipotesi prevista dall’articolo 517 è quella del mendacio ingannevole sulla
“qualità” del prodotto.
Due sono le situazioni concrete più evidenti: il mendacio sulla composizione della
merce, e quello sui requisiti di gusto propri di un tipo merceologico.
Se nel marchio, o in un altro segno esteriore del prodotto, si dice al consumatore che
ogni esemplare è la risultante di una determinata quantità di dati elementi, il
consumatore non potrà non prendere in considerazione un’attestazione tanto seria. Il
mendacio sulla qualità del prodotto acquisterà, così, l’ingannevolezza necessaria per
divenire punibile ai sensi dell’art. 517 codice penale.
La seconda situazione si profila, invece, tutte le volte che il marchio, o gli altri segni
distintivi, vengono adottati in funzione “descrittiva-espressiva” di una peculiare qualità
del prodotto, quando in realtà la qualità evocata dal segno non è presente.
La giurisprudenza ha sempre dato una interpretazione limitata di tale norma,
applicandola alle ipotesi di contraffazione del “marchio” e non ponendo attenzione
all’ipotesi dell’inganno relativa all’origine geografica.
35
j- Lo sviluppo della giurisprudenza e della dottrina relativamente al mendacio
sull’origine e la provenienza dell’opera e del prodotto
Tradizionalmente si ritiene che il mendacio sull’origine possa consistere o nell’utilizzo
di un marchio genuino su un manufatto diverso da quello originario, utilizzando ad
esempio confezioni con segni distintivi non contraffatti per contenervi un prodotto altrui
(c.d. delit de remplissage), ovvero nell’apposizione del marchio su un prodotto
proveniente solo in parte dall’azienda titolare del segno.
A quest’ultima ipotesi va ricondotto il fenomeno della “de-localizzazione” del processo
produttivo, cioè la frequente prassi di commissionare a terzi la fabbricazione o parte di
essa, per motivi di organizzazione aziendale o per risparmiare sui costi di produzione.
In simili ipotesi ci si chiede se l’indicazione fornita dal marchio, attestante una
determinata fonte produttiva, possa assumere natura decettiva; la questione risulta
influenzata sia dal contesto socio- economico, sia dalle esigenze informative dei
consumatori.
In tale prospettiva, è da sottolineare come la sensibilità del consumatore medio si sia
acuita notevolmente negli ultimi decenni, fino a ritenere l’origine del prodotto come un
elemento tutt’altro che indifferente nella scelta di acquisto. Si pensi al nuovo
commercio “equo e solidale”, in cui un fattore decisivo nella scelta del prodotto è la
provenienza geografica dello stesso, al fine di contribuire allo sviluppo dei così detti
paesi sottosviluppati. Si pensi, ancora, ai ricorrenti scandali suscitati dalla scoperta che
negli stabilimenti di alcune grandi industrie internazionali viene sfruttato il lavoro
minorile di Paesi del terzo mondo e alle conseguenti iniziative di boicottaggio di quei
prodotti.
36
Si deve fin d’ora sottolineare che proprio queste nuove esigenze informative, così come
quelle ulteriori e strettamente connesse alla difesa dei prodotti nazionali, sono di
problematica tutela ai sensi dell’art. 517 codice penale e della previsione di cui
all’articolo 4 comma 49 della Finanziaria 2004: ed, anzi, un orientamento
giurisprudenziale consolidato sembra non lasciare spiragli ad un simile ampliamento di
tutela.
L’influenza esercitata dal contesto socio-economico e dalle esigenze informative dei
consumatori sulla problematica in esame emerge, comunque, dall’evoluzione
giurisprudenziale e normativa.
37
J. 1
Anni Sessanta
Negli anni Sessanta, autorevoli voci dottrinali sottolineavano la necessità di distinguere
a seconda che la produzione fosse totalmente delegata ai terzi ovvero solo parte del
processo produttivo venisse svolto al di fuori degli stabilimenti del titolare del
marchio.29 Nel primo caso sarebbe stato infatti certamente integrato il reato di cui
all’art. 517 codice penale. Nel secondo caso l’apposizione del marchio si sarebbe
configurata come mendace, per cui punibile ex articolo 517 codice penale, solo ove
potesse ravvisarsi un inganno in quanti tra i consumatori acquistavano un prodotto
confidando nell’alto standard qualitativo dell’azienda fallacemente indicata dal marchio,
quando in realtà una frazione del processo produttivo “qualificante”, relativa cioè a parti
essenziali del prodotto, era stata delegata a terzi.30
A ben vedere, tale orientamento risentiva di un contesto socio-economico ancor legato a
un’immagine della fabbrica come centro unico dell’intera produzione e assai lontano
dalla realtà degli odierni gruppi societari e della de-localizzazione produttiva.
29
In giurisprudenza, Cassazione, Sez. IV penale, 30 Marzo 1967, in Rivista Penale, 1968, vol. II, pag.
952, relativa a un produttore che aveva apposto su radio a transistor fabbricate in Italia il marchio di una
ditta giapponese, volendo far credere agli acquirenti che si trattasse di apparecchi ben più pregiati di
quello che erano.
30
In tal senso, G. Marinucci, voce Falsità in segni distintivi…, cit., pag. 662; G. Neppi Modona,
Interesse alla produzione…, cit., pag. 808;
38
j. 2 Anni Settanta
Bisogna attendere fino alla fine degli anni Settanta per la prima decisione
giurisprudenziale in materia, che attiene però alla peculiare disciplina dei prodotti
alimentari31. Nel caso di specie l’imputato veniva condannato ai sensi dell’art. 517
codice penale per aver omesso di indicare sulle confezioni della merce (panettoni),
accanto al proprio marchio, anche il diverso luogo dello stabilimento produttivo. A
prescindere dall’epilogo del singolo caso, in cui la condanna trovava giustificazione nel
fatto che, vertendosi in materia di sostanze alimentari, sussisteva in capo
all’imprenditore uno specifico obbligo di indicare il luogo di produzione, ciò che rileva
è l’affermazione di principio della suprema Corte, secondo cui il titolare di un marchio,
pur de-localizzando il processo produttivo o commissionando a terzi la fabbricazione
del prodotto, ha il diritto di apporre il proprio segno distintivo sulla merce, salvo
adempiere agli ulteriori obblighi informativi che la peculiare disciplina dei prodotti
alimentari richiede.
31
Sent. Cassazione, sez. IV penale, 29 Gennaio 1979, Vitaloni, in Foro italiano, 1981, II, pag. 252.
39
j. 3 Anni Ottanta
Ma negli anni Ottanta questa ultima affermazione di principio viene sviluppata per
abbandonare la visione “penalcentrica” e abbracciare invece una prospettiva in grado di
integrare la disciplina civilistica.
E’ con il noto “caso Fiat”, infatti, che si porta all’attenzione dei giudici la complessa
dinamica dei rapporti commerciali in una realtà non più atomistica, ma di gruppi
societari.32
Nella fattispecie, il Presidente e l’amministratore delegato della casa automobilistica
torinese venivano condannati dal Pretore di Torino ai sensi dell’articolo 517 codice
penale per aver posto in vendita sul mercato italiano vetture recanti il solo marchio Fiat,
ma in realtà prodotte dalla Seat, società iberica controllata dal gruppo. La sentenza
veniva riformata dal Tribunale, secondo il quale il giudizio sulla rilevanza penale della
condotta va collegato alla funzione e alla disciplina dei marchi. In particolare, il
Tribunale sottolineava che il marchio è uno “strumento di identificazione per il
consumatore, (….) che gli consente di distinguere e scegliere tra prodotti dello stesso
genere offerti dal mercato”. La funzione distintiva del marchio, quindi, sarebbe di
indicare la provenienza di quel manufatto da un certo nucleo imprenditoriale e di
garantire così la costanza qualitativa del prodotto recante quel medesimo segno
distintivo.
Del resto, è fuor di dubbio che il marchio identifica non già il singolo manufatto, ma la
fonte produttiva, dovendosi altrimenti affermare la necessità di creare marchi diversi per
i differenti prodotti offerti dalla stessa società.
32
Tribunale Torino, 12 Ottobre 1984, Agnelli ed altri, in Foro italiano, 1985, II, pag. 230 con nota di G.
Fornasari, Appunti sull’applicabilità dell’articolo 517 codice penale alle ipotesi di produzione su
commissione.
40
Se dunque – aggiungeva il Tribunale – la funzione distintiva del marchio è connessa
alla “paternità imprenditoriale”, allora la nozione di provenienza ex articolo 517 codice
penale, va intesa come “provenienza aziendale”. A sua volta, quest’ultima nozione
veniva interpretata alla luce della disciplina sui marchi per verificare se, e a quali
condizioni, potesse essere considerato come proveniente dalla società titolare del
marchio anche la merce fabbricata altrove. In questo senso si sottolineava come, se in
sede civile è consentito cedere il marchio unitamente al diritto di fabbricare ovvero di
stipulare contratti di licenza del marchio, purchè il licenziatario si attenga alle regole
tecniche dettate dal concedente, occorre allora estendere il concetto di provenienza
aziendale “fino a ricomprendere i prodotti provenienti da più imprese collegate tra loro
ovvero quelli fabbricati su licenza del committente allorché sia assicurato un identico
standard qualitativo dei prodotti fabbricati da unità diverse” .
Donde l’assenza di attitudine decettiva, ai sensi dell’articolo 517 codice penale, nei casi
in cui venga apposto il marchio sul prodotto fabbricato dal così detto terzista, ma sia
garantita uniformità qualitativa, dovendosi altrimenti giungere alla paradossale
conclusione di punire in sede penale ciò che è lecito da un punto di vista civile.
Questa sentenza appare però criticabile fondandosi su un duplice equivoco: la
confusione tra marchio ed indicazione di provenienza ed il concetto di “provenienza del
prodotto”.
L’indicazione di provenienza manifesta il luogo ove materialmente si svolge l’attività di
fabbricazione del prodotto. Il marchio, invece, indica la provenienza imprenditoriale.
In applicazione di tali principi, il Tribunale di Torino, riformando totalmente la sentenza
del Pretore di Torino ed assolvendo gli imputati, ha deciso che “è lecita l’importazione
da Stati esteri di autovetture fabbricate in detti Paesi su ordine e sotto il controllo della
41
FIAT, anche se al momento dell’introduzione in Italia esse recavano il solo marchio
FIAT e non anche l’indicazione del Paese di provenienza”33.
Riassumendo: mentre l’indicazione di provenienza denota la provenienza geografica del
prodotto, il marchio denota una provenienza imprenditoriale in senso giuridico, vale a
dire la provenienza del prodotto da un nucleo aziendale che opera secondo direttive
tecniche impartite dal committente e sul quale il titolare del marchio esercita controlli
qualitativi, assumendo di fronte al consumatore la responsabilità del processo
produttivo.34 Ne consegue che l’apposizione sul prodotto di un marchio notoriamente
facente capo ad un’impresa avente sede e/o operante in Italia non significa di per sé che
il prodotto così contrassegnato sia stato materialmente fabbricato in Italia e non può
quindi di per sé integrare una condotta ingannevole circa l’indicazione del luogo di
fabbricazione.
33
34
Cfr. Tribunale di Torino, 12 ottobre 1984, Agnelli ed altri, cit., pag. 230.
G. Fornasari, Appunti sull’applicazione…,cit., pag. 253.
42
J. 4 Anni Novanta: Sentenza Thun (Cassazione, Sez. III, 7 Luglio 1999, n. 2500)
Gli argomenti utilizzati dai giudici piemontesi vengono recepiti e sviluppati quindici
anni più tardi dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in un giudizio a carico della
“Thun”, nota società altoatesina produttrice di oggetti di ceramica, originato dal
sequestro disposto su una partita di merce proveniente dalla Cina, priva di indicazione
della manifattura cinese e recante solo la dicitura “Thun Bolzano Italy”. 35
Tale sentenza fissa la posizione della Suprema Corte in relazione sia alla Convenzione
di Madrid sia all’articolo 517 codice penale.
Affermando che la predetta sintetica indicazione non può integrare la fattispecie
penalistica, la Suprema Corte si muove nel solco tracciato dai giudici torinesi, facendo
leva sulla funzione distintiva del marchio come segno che indica al consumatore
l’origine e la provenienza del prodotto, non già da un determinato luogo (ad eccezione
delle ipotesi espressamente previste dal legislatore), ma da un determinato imprenditore,
inteso come colui che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di
produzione.
In altri termini, poiché nel processo di scelta tra prodotti recanti marchi diversi
l’acquirente confida sull’esistenza di determinati requisiti qualitativi, nel mendacio
sull’origine, provenienza e qualità del prodotto i primi due elementi – secondo la Corte
– sono “funzionali al terzo, che in realtà è il solo fondamentale, atteso che il luogo o lo
stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto
stesso”. Donde, come ulteriore conseguenza, l’indifferenza, ai sensi della fattispecie
penalistica, della falsa indicazione del luogo di produzione, dovendosi ritenere pacifico
35
Cassazione, Sez. III penale, 26 Agosto 1999, Thun, in Rivista penale, 1999, fasc. n. 12, pag. 1107.
43
che l’origine e la provenienza del prodotto vanno intese “in senso esclusivamente
giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e
provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza
del produttore”.
La Corte riconosce dunque con questa pronuncia la possibilità di far produrre parte del
prodotto all’estero, in quanto la garanzia che pone la legge relativa all’ origine e alla
provenienza del prodotto non è una garanzia geografica, cioè garanzia della produzione
in un dato luogo, ma garanzia di produttività, cioè che il bene è stato prodotto da un
dato produttore.
L’orientamento si è reso famoso per l’ampiezza che ha concesso all’attività di
terziarizzazione, arrivando ad ammettere come lecita e legittima l’immissione in
commercio di prodotti contenenti in etichetta indicazioni “erronee o imprecise” purchè
il committente possa garantirne i contenuti intrinseci con il proprio Know-how
produttivo.
La Corte ha fatto propria questa argomentazione anche in base al rilievo che altrimenti
sarebbero inevitabilmente considerate illegittime tutte le forme di terziarizzazione della
produzione, in cui il produttore fa produrre parte del prodotto all’estero a soggetti terzi
in base a contratti di sub fornitura, concessione possibile per la legge positiva, ad
esempio in forza della legge n. 192 del 1998 che riconosce il contratto di sub fornitura
Questi argomenti trovano negli anni Novanta nuova forza nella disciplina introdotta a
tutela del consumatore e nell’intervenuta normativa comunitaria sull’origine doganale.
In tale prospettiva, l’articolo 1 lettera b della legge 10 Aprile 1991, n. 126, obbliga ad
indicare sui prodotti o le confezioni commercializzate in Italia, a tutela del consumatore,
il nome o la ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un imprenditore
44
stabilito nella Comunità economica europea. Di contro, non sussiste alcun obbligo di
menzionare il luogo di fabbricazione della merce, salvo che si tratti di prodotti di
origine alimentare, oggetto di disciplina ad hoc con il Regolamento CEE n. 2801/1992.
Donde l’espresso riconoscimento ex lege, in una disciplina dettata a tutela dei
consumatori, dell’irrilevanza del luogo (geografico) di produzione e, per contro,
dell’obbligo di menzionare solo la provenienza aziendale, intesa come la paternità del
prodotto da parte dell’imprenditore che ne assume la responsabilità con la
commercializzazione.
Inoltre, ancor prima che sul fronte della distribuzione, già in sede di produzione
l’imprenditore italiano, che commissioni a terzi la manifattura della merce, può
dichiarare l’italianità del prodotto. La normativa comunitaria sull’origine (Regolamento
CEE 12 Dicembre 1992, n. 2913, istitutivo del Codice Doganale Comunitario), nel
definire il concetto di origine ai fini doganali, contrappone i prodotti di natura
mineraria, vegetale, animale e derivati a tutti gli altri generi merceologici: mentre nei
casi indicati possono qualificarsi come originarie di un Paese solo le merci ivi
intermente ottenute, nelle altre ipotesi, se alla produzione abbiano partecipato due o più
paesi, deve intendersi come paese di origine quello in cui è avvenuta “l’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in
un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione”. Donde la possibilità per l’imprenditore italiano, che commissioni ad
un’impresa di un paese extracomunitario una parte del processo produttivo riservandosi,
ad esempio, l’assemblaggio o la finitura del prodotto, di indicare l’origine italiana dello
stesso.
45
k- Considerazioni conclusive
Sino ad ora la giurisprudenza e la normativa di fonte comunitaria relative all’articolo
517 codice penale non si aprivano ad interpretazioni evolutive in grado di offrire tutela
penale alle richieste informative dei consumatori.
Forse proprio in considerazione dei limiti suesposti e al fine di apprestare un presidio
più efficace alle nuove esigenze di tutela (avvertite sia dal mercato interno sia dai
consumatori), il legislatore allora è intervenuto con una norma diretta a sanzionare la
falsa o fallace indicazione di provenienza, la cui portata incriminatrice deve essere
oggetto di analisi.
Per vero, anche prima della Finanziaria 2004 i giudici italiani tutelavano il “made in
Italy” ed altre indicazioni di provenienza richiamanti l’Italia applicando l’articolo 517
codice penale: in particolare consideravano ingannevole, ai sensi di tale norma, l’uso di
segni quali “made in Italy” ed altri equivalenti, che hanno l’effetto di indurre in errore il
pubblico, facendogli ritenere che il prodotto, materialmente realizzato all’estero, sia
stato fabbricato in Italia36.
Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza della Cassazione, sezione III penale
del 23 Settembre 2003, n. 34103,secondo la quale l’uso illecito del “made in Italy”:
“integra indubbiamente già il reato di cui all’art. 517 codice penale a prescindere dalle
integrazioni apportate dall’art. 4 comma 49 della legge 24 Dicembre 2003 n. 350, il
quale si è limitato a dare indicazioni su quando un prodotto possa considerarsi non
fabbricato in Italia e su quando, pertanto, la stampigliatura “prodotto in Italia” o
36
Cfr. supra capitolo I, § 1, lettera g), pag. 31.
46
“made in Italy” apposta sullo stesso costituisca falsa indicazione sull’origine del
prodotto ed integri quindi il reato di cui all’art. 517 codice penale”37.
37
Cfr. per il commento alla sentenza infra capitolo 2, § 2, lettera c), pag. 106 e ss.
47
2. L’ARRAGEMENT DI MADRID DEL 1981 APPLICATO AL “MADE IN
ITALY”
L’Accordo di Madrid38 del 14 Aprile 189139 nasce nell’alveo dei diritti di proprietà
industriale (Convenzione di Parigi) ed ha la finalità di reprimere l’apposizione di false o
fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti, nonché il loro utilizzo su insegne,
documenti o materiale pubblicitario.
In particolare l’articolo 1, nel testo revisionato a Lisbona nel 1958, recita: “Tutti i
prodotti riportanti un’indicazione falsa o fallace per la quale uno dei Paesi ai quali si
applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di tali Paesi, sia direttamente o
indirettamente indicato come paese o luogo d’origine, saranno sequestrati all’atto
dell’importazione in ciascuno di detti Paesi”. La norma vieta l’apposizione di
indicazioni di provenienza ingannevoli: l’indicazione di provenienza non deve essere
falsa o fallace, non deve cioè indurre i consumatori a ritenere che il prodotto sia
fabbricato in un luogo diverso da quello di effettiva provenienza.
La violazione della norma comporta, sin dal momento dell’importazione delle merci, il
fermo da parte degli Uffici Doganali, allorché “vi sia fondato sospetto che rechino false
o fallaci indicazioni di provenienza”, oltre alle sanzioni ordinarie collegate alle condotte
di concorrenza sleale.40
38
L’accordo di Madrid è stato negoziato nell’ambito della convenzione di Parigi del 1881 (Convenzione
per la proprietà industriale) per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci sui prodotti.
I paesi firmatari hanno assunto l’impegno di consentire il sequestro all’atto d’importazione dei beni che
rechino un’indicazione falsa o fallace per la quale uno degli Stati aderenti sia direttamente o
indirettamente indicato come paese d’origine. Non tutti i paesi aderenti alla Convenzione di Parigi hanno
aderito all’Accordo di Madrid.
39
Riesaminato a Washington il 2 Giugno 1911, all’Aia il 6 Novembre 1925, a Londra il 2 Giugno 1934, a
Lisbona il 31 Ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 Settembre 1967.
48
Il problema è quello di individuare quali indicazioni di origine siano da considerare
false e fallaci e come tali consentono il sequestro.
Malgrado l’ampiezza dell’articolo 1, la previsione di cui al successivo articolo 4 induce
a ritenere che, nelle originarie intenzioni, destinatarie della tutela fossero le indicazioni
di origine che implicano un rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine
geografica: “i tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali denominazioni, in
virtù del loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo,
essendo inteso che le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli non
sono tuttavia comprese nella riserva di cui al presente articolo”.
Dunque, con la sola eccezione delle denominazioni regionali di provenienza dei prodotti
vinicoli,
le denominazioni aventi carattere “generico” sono escluse dalla tutela
dell’Accordo di Madrid.
L’Accordo, tuttavia, non fornisce alcun criterio per distinguere le denominazioni
generiche da quelle non generiche. Si potrebbe ritenere, per il tenore dell’articolo 4, che
la “denominazione generica” coincida con la “denominazione di origine geografica
semplice”, cioè un’indicazione che non implica alcun rapporto fra le caratteristiche del
prodotto e la sua origine geografica.
L'Italia ha dato applicazione all'Accordo di Madrid con il d. P. R. n. 656 del 26 febbraio
1968, ancora in vigore, provvedimento composto di soli due articoli, il primo dei quali
dispone: "Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace
indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel
territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno
immediatamente notizia all’autorità giudiziari e agli interessati".
49
L’articolo 2 prevede la restituzione delle merci qualora gli interessati “abbiano
provveduto alla regolarizzazione prevista dall’articolo 2 dell’Accordo di Madrid”, e
siano trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione all’autorità giudiziaria senza
che questa abbia disposto il sequestro delle stesse.
La ratio sottesa a tale disciplina è chiaramente quella di fornire ai consumatori
un’efficace tutela rispetto a false dichiarazioni in merito alla provenienza delle merci
importate nel nostro territorio, imponendo l’obbligo per i produttori di agire in buona
fede nei confronti del mercato e, nella misura in cui vogliano “dichiarare” qualcosa
circa l’origine dei loro prodotti, di dichiarare il vero.
Ben diverso sarebbe prevedere che tutte le merci commercializzate in Italia debbano
recare il marchio “made in..”, considerato che, come rilevato dalla Corte di Giustizia,
una tale previsione, ben lungi dal limitarsi a garantire il diritto dei consumatori a non
essere raggirati, potrebbe in realtà risolversi in una misura protezionistica volta a
scoraggiare le importazioni.
Tale rischio fu paventato anche all’epoca della conclusione dell’accordo di Madrid e la
soluzione di compromesso raggiunta allora fu quella di prevedere, da un lato, che “le
disposizioni contenute (nell’accordo stesso) non escludono che il venditore indichi il
proprio nome o indirizzo su prodotti che provengano da un paese diverso da quello in
cui ha luogo la vendita”, dall’altro, che “in tali casi, l’indirizzo o il nome del venditore
devono essere accompagnati dall’indicazione, precisa, e a caratteri chiari, del paese o
del luogo di fabbricazione o produzione o da altre indicazioni che valgano ad evitare
errori sulla vera provenienza delle merci” ( articolo 3 Accordo di Madrid).
Alla luce di tale disposizione,poteva apparire obbligata per il legislatore italiano la
scelta di non consentire all’operatore commerciale l’importazione in Italia di prodotti
50
contraddistinti con il proprio nome e indirizzo, senza che a tale indicazione fosse
associata quella relativa al luogo di origine dei prodotti stessi.
In realtà non solo il d. P. R. 656 del 1968 non ha recepito espressamente l’articolo 3
dell’Accordo di Madrid, ma, successivamente alla sua emanazione, il Ministero delle
Finanze41 ha precisato che, in presenza di prodotti importati con marchi di fabbricazione
legalmente utilizzati, non risultava necessaria l’evidenziazione del paese di origine degli
stessi in quanto “la diversificazione dei processi industriali porta alla necessità che più
imprese, ubicate anche in paesi differenti e facenti parte di un’unica organizzazione
imprenditoriale, concorrano alla produzione di merci sulle quali vengono apposti
marchi identificanti l’organizzazione stessa”. Secondo tale orientamento il semplice
marchio di fabbrica sarebbe già di per sé idoneo a consentire al consumatore di
identificare la provenienza del prodotto non tanto in termini di luogo, quanto in termini
di produttore.
Da quanto precede risulta, dunque, chiaro che il legislatore italiano, sin qui scarsamente
propenso ad imporre obblighi positivi di informazione in merito al luogo di produzione
delle merci importate, ha preferito lasciare alla libera scelta di ciascun produttore la
decisione riguardo a cosa indicare sulle proprie merci, benchè il nostro ordinamento non
rinuncia a vincolare gli operatori del mercato ad un obbligo di correttezza e verità nei
confronti dei consumatori.
Il decreto di applicazione dell’Accordo di Madrid, successivamente alla sua entrata in
vigore, è stato oggetto di numerose altre circolari emesse dal Ministero delle Finanze Direzione delle Dogane, che ne hanno orientato l’interpretazione, consolidando una
prassi applicativa secondo cui il carattere più o meno generico dell’indicazione non
41
Direzione Generale Dipartimento Dogane, Circolare 358/77.29/IV del 22 luglio 1989.
51
assume alcuna rilevanza; per cui l’indicazione “made in …” ha potuto essere compresa
nelle ipotesi coperte dalla misura del fermo in dogana ai sensi del provvedimento di
attuazione dell’Accordo di Madrid.
A prescindere da ogni analisi in merito alla coerenza dell’interpretazione invalsa
rispetto al dato normativo savranazionale, è importante sottolineare come il d.P.R.
656/68 sia stato utilizzato per bloccare l’ingresso nel nostro Paese di prodotti rispetto ai
quali vi era il sospetto che l’apposizione del marchio “made in Italy” fosse illegittima.
Ma il problema è stabilire quando l’indicazione dell’origine italiana apposta sul
prodotto può dirsi falsa o fallace.
Se la definizione di origine vera o falsa non pone problemi in caso di prodotti
interamente realizzati in un solo Paese, la situazione si complica in caso di beni
realizzati parzialmente in Paesi diversi.
Nel 1995 una circolare del Ministero delle Finanze42 stabilì che, a tale riguardo, si
dovessero osservare le disposizioni del Codice Doganale Comunitario relativamente alle
merci di origine non preferenziale, parzialmente ottenute in paesi diversi43. In altri
termini, è possibile apporre l’indicazione “made in Italy” sui prodotti realizzati in Italia
con materiali importati da un Paese straniero qualora, applicando le regole previste dal
Codice Doganale Comunitario, detta produzione sia considerata – ai fini doganali - di
origine italiana.
L’intervento del Ministero è conforme agli impegni assunti dal nostro Paese in sede
WTO: le regole concernenti l’identificazione dell’origine ai fini della marchiatura dei
prodotti rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo sulle Regole di Origine del
42
Direzione Generale Dipartimento Dogane, Circolare 275/D del 23 Ottobre 1995.
Il Codice doganale europeo prevede un duplice insieme di regole per definire l’origine doganale di un
prodotto: quella relative all’origine preferenziale, cioè nascenti da accordi di volta in volta negoziati tra la
Comunità Europea e un dato paese terzo e quelle relative all’origine non preferenziale emanate in via
autonome dall’Unione europea e incidono con i Paesi non legati ad essa da accordi specifici, come con
Canada, Stati Uniti e Giappone.
43
52
sistema multilaterale, e da ciò consegue la necessità di ricorrere, per l’identificazione
del Paese di origine, al criterio dell’origine non preferenziale44.
L’articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), anche
se con locuzione incerta, ha inteso certamente riaffermare il medesimo principio
laddove precisa che è falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e
merci non originari dall’Italia “ai sensi della normativa europea sull’origine”.
44
In base all’articolo 24 del Codice doganale europeo la merce si considera “originaria del Paese in cui è
avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale”.
53
3.
ACCENNI ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA IN TEMA DI “MADE IN
ITALY”
Quanto alla rilevanza civile, secondo il diritto italiano, dell’uso di false indicazioni di
provenienza, come “made in Italy”, può dirsi che esso va ritenuto illecito ai sensi
dell’articolo 30 codice proprietà industriale (che riprende l’articolo 31 commi 2 e 3,
decreto legislativo 1996, n. 198, a sua volta attuativo dell’articolo 22 degli accordi
GATT - TRIPs45 del 15 aprile 1994), secondo il quale è tra l’altro vietato “l’uso di
qualsiasi mezzo nella disegnazione o presentazione di un prodotto che indichino o
suggeriscano che il prodotto stesso è proveniente da una località diversa dal vero luogo
di origine…”.
Il codice della proprietà industriale nei suoi articoli 29 e 30 abrogando il decreto
legislativo n. 198 del 1996 ed incorporando la relativa disciplina ( articolo 31, decreto
legislativo n. 198 del 1996), ha di fatto rafforzato la tutela contro le false indicazioni di
provenienza, per cui possono essere richieste tutte le misure proprie dei titoli di
proprietà industriale.
Prima, invece, i mezzi di tutela erano quelli, più limitati, riconosciuti contro gli atti di
concorrenza sleale. Pare quindi che oggi, in forza degli articoli 29 e 30 codice proprietà
industriale, l’uso di indicazioni di provenienza false o fallaci sia sanzionato a
prescindere dalla configurazione di un atto di concorrenza sleale; le sanzioni ammesse
sono quindi tutte quelle contemplate dal codice della proprietà industriale. La
competenza è delle sezioni specializzate ( ex articolo 1 e 120 c.p.i.).
45
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade, accordo relativo agli scambi internazionali prima
della creazione del WTO (World Trade Organization).
54
Sempre dal punto di vista civile, l’apposizione di diciture di provenienza false o fallaci
sui prodotti o loro confezioni potrebbe avere una rilevanza ai sensi delle norme che
reprimono la pubblicità ingannevole, oggi oggetto del nuovo Codice del Consumo,
decreto legislativo n. 206 del 200546.
Occorre ricordare che lo stesso decreto legislativo 6 Settembre 2005, n. 206) obbliga il
produttore ad apporre sul prodotto venduto in Italia o sulla sua confezione la
denominazione sociale e la sede del produttore o dell’importatore; nonché l’indicazione
del Paese d’origine, se situato fuori dall’Unione Europea.
Oggi, quindi, oltre al divieto di indicazioni d’origine false o fallaci ed alle relative
sanzioni di cui all’Arrangement di Madrid, all’articolo 517 codice penale, al Codice
della proprietà industriale ed al divieto di pubblicità ingannevole, c’è un obbligo di
informazione “positivo” sancito dal Codice del Consumo.
46
Cfr. infra capitolo III, § 4, lettera d, pag. 215.
55
CAPITOLO II
PROFILI PENALISTICI DEL “MADE IN ITALY”: SVILUPPO
LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
SOMMARIO: 1- La novità normativa in tema di “made in italy” introdotta dalla legge
n. 350 del 2003 (così detta finanziaria 2004): a) l’interpretazione “innovativamente
colpevolista” dell’Agenzia delle Dogane; b) l’interpretazione prevalente fatta propria
dalle prime pronunce della Suprema Corte di Cassazione; c) la riforma del 1992 sul
trasferimento del marchio; d) la difficile definizione del concetto di “fallace
indicazione”; e) tutela del “made in Italy”, ma non di altre indicazioni di provenienza; f)
il regolamento delegato previsto dal comma 63 dell’articolo 4, legge n. 350 del 2003
(c.d. finanziaria 2004); g) la determinazione del momento consumativo: superamento
del contrasto giurisprudenziale; h) l’ “origine doganale” nel codice doganale
comunitario. 2- I primi interventi interpretativi della Suprema Corte di Cassazione
relativamente al comma 49, articolo 4, legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004): a)
sentenza Fro n. 3352/2005: la prima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
sull’origine dei prodotti dopo la legge n. 350/2003 (c.d. finanziaria 2004): conformità
all’orientamento consolidato circa la prevalenza dell’origine imprenditoriale sulla
provenienza
geografica;
b)
sentenza
Legea
n.
13712/2005:
consolidamento
dell’interpretazione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione: prevalenza dell’origine
da un produttore che controlla il processo rispetto all’origine geografica; c) sentenza
Ingam n. 34103/2005: prima pronuncia sulla dicitura “made in Italy”: prevalenza della
provenienza geografica in assenza dell’indicazione del produttore. 3- Le nuove
disposizioni introdotte dal decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 (c.d. decreto
competitività) convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80: a) in particolare il punto 7:
l’incauto acquisto di prodotti contraffatti; b) in particolare il punto 9: le indicazioni di
provenienza e quelle di origine nella prospettiva della tutela penale del “made in Italy”.
56
4- Fermo della merce in dogana come momento essenziale per l’accertamento della loro
provenienza. 5- Le novità introdotte dal codice del consumo (decreto legislativo 6
settembre 2005 n. 206). 6- Sentenza Giordani, n. 2648/2006: il ripensamento
giurisprudenziale sulla “non neutralità” dell’origine geografica di alcuni prodotti. 7Ordinanza del Tribunale di Genova 21 marzo 2006. 8- Sentenza Huang Suwen n.
3669/2006:
riaffermazione
della
prevalenza dell’origine
imprenditoriale
sulla
provenienza geografica, in presenza in capo al produttore della responsabilità giuridica,
economica e tecnica del processo produttivo. 9- Sentenza Danzi n. 21797/2006: diciture
quali “concepiti” o “ideati” costituiscono fattispecie diverse da “made in..”. 10Sentenza Dolce e Gabbana n. 157/2006: prevalenza dell’Accordo di Madrid sulla
disciplina penale. 11- I cambiamenti della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (così detta
finanziaria 2007): il riferimento alle pratiche commerciali ingannevoli. 12- Sentenza n.
8684/2007: l’ultima pronuncia della Suprema Corte in tema di “made in Italy”: la
legittimità della dicitura “Italian design” su prodotti fabbricati all’estero.
Nell’ordinamento italiano si è registrata negli ultimi anni una vivace quanto disorganica
produzione normativa in tema di provenienza geografica e imprenditoriale delle merci,
che ha fatto da contraltare a decenni di scarsa attenzione per la materia.
Il legislatore italiano ha ritenuto opportuno intervenire nel campo del “made in Italy”,
prima con la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), poi con il decreto legge
n. 35 del 2005 (il così detto decreto competitività), quindi con l’introduzione del codice
del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) e infine con la legge n. 296
del 2006 (così detta finanziaria 2007).
Esaminando tali importanti novità normative emerge che il legislatore ha voluto
attribuire rinnovato vigore a fattispecie di reato scarsamente applicate, in un periodo
storico in cui i prodotti italiani soffrono la crescente competitività di prodotti
provenienti da paesi in via di sviluppo (in primis Cina e India), cercando, in qualche
modo, di tutelare l’eccellente industria italiana con misure aventi quanto meno rilevanza
57
interna, in attesa di ben più incisivi interventi a livello comunitario, che possano porre
fine all’indiscriminata importazione di merci prodotte a prezzi notevolmente inferiori a
quelli europei, con standard di qualità e controlli di sicurezza tuttavia inadeguati rispetto
a quelli garantiti dall’industria nazionale.
Tali novità normative hanno dato luogo a una serie di disposizioni di difficile
interpretazione letterale e sistematica, che a loro volta hanno portato la Suprema Corte
a pronunciarsi più volte su questo tema, cercando di indirizzarne l’applicazione.
58
1.
LA NOVITA’ NORMATIVA IN TEMA DI “MADE IN ITALY”
INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 350 DEL 2003 (C.D. FINANZIARIA
2004)
Alla fine del 2003 è entrata in vigore la legge n. 350 del 2003, meglio conosciuta come
finanziaria 2004 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”)
47
, la quale dedica importanti disposizioni al tema del “made in Italy”,
precisamente l’articolo 4, commi 49, 51 e 61.
In particolare l’articolo 4, comma 49 stabilisce che “ l’importazione e l’esportazione ai
fini della commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517
codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su
prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie
sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti della merce in dogana per
l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace
indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione
a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a
ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine
o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo
47
Pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003.
59
attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made
in Italy””.
Nel dettaglio l’articolo 4, comma 49 legge n. 350 del 2003:
a- estende l’ambito di applicazione dell’articolo 517 codice penale alle condotte di
“importazione e esportazione ai fini della commercializzazione di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza”: infatti, l’articolo 517 codice penale non
specifica che la condotta punibile si estende all’importazione e alla esportazione dei
prodotti.
Vero è pure, tuttavia, che tali attività venivano già ricondotte da alcuni autori e da
parte della giurisprudenza nelle nozioni di “messa in vendita” e di “messa in
circolazione” dell’articolo 517 codice penale;
b- individua un oggetto materiale più ampio di quello specificato dall’articolo 517
codice penale. L’oggetto non è più limitato ai prodotti od opere “industriali”, ma
comprende anche i prodotti agricoli;
c- sottopone a pena non solo la “fallace”, ma anche la “falsa” indicazione di
provenienza;
d- specifica che integra una “falsa indicazione” l’apposizione della dicitura “made in
Italy” su prodotti o merci non originari dall’Italia; precisando che per stabilire se un
prodotto è originario dall’Italia si applica la normativa europea sull’origine48. La
48
Cfr, per un approfondimento sul rinvio del precetto penale interno alle norme comunitarie supra
capitolo IV, § 3, lettera g, pag. 246 e ss.
60
normativa comunitaria richiamata è identificabile principalmente nel Regolamento
CE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che ha istituito il codice doganale comunitario
ed ha definito negli articoli 22-26 l’origine delle merci ai fini doganali. La
fattispecie di reato ha forma necessariamente commissiva e non pare ammissibile
punire l’omessa indicazione dell’origine del prodotto49, considerando che ad oggi
non esistono né sono stati introdotti obblighi giuridici in capo ai produttori di
indicare l’origine dei loro prodotti.
e- precisa che integra una “indicazione fallace” di provenienza :
a. sia l’apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di
segni, figure o quanto altro tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
b. sia l’apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e
provenienza estera, di segni, figure e quanto altro, tali da
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia
di origine italiana;
f- determina, nel terzo periodo, quale sia il momento consumativo del reato: aspetto
considerato come la maggiore novità del comma 49 dell’articolo 4 legge n. 350 del
2003. Il reato, infatti, si intende consumato sin dalla presentazione della merce o dei
prodotti in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio.
Tale precisazione del legislatore si giustifica con la voluntas legis di risolvere il
contrasto giurisprudenziale, nato negli anni precedenti in seno alla terza sezione
49
Cfr. D. Sangiorgio, L’ultima sul “made in Italy”, nota a Cassazione penale 23 Settembre 2005, n.
34103, in Rivista il diritto industriale, 2006, fasc. n. 3, pag. 224 e ss.
61
della Suprema Corte di Cassazione, relativo al momento consumativo del reato
punito dall’articolo 517 codice penale. Tuttavia l’individuazione ex lege del
momento consumativo del reato di cui all’articolo 4 comma 49 della finanziaria
2004 non pare così pacificamente estendibile, nel silenzio della legge, all’originaria
previsione codicistica, a causa dell’autonomia delle due fattispecie.50
g- prevede nell’ultimo periodo la possibilità di sanatoria ai fini amministrativi, di cui
può usufruire il produttore, per la fallace e falsa indicazione sulla provenienza. La
fallace indicazione sulla provenienza può essere sanata sul piano amministrativo con
l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
La falsa indicazione può, altresì, essere sanata sempre ai fini amministrativi
attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura
“made in Italy”.
Resta ferma, in entrambi i casi, la procedibilità ai fini penali, nonostante il possibile
dissequestro dei prodotti in seguito alla rimozione delle false o fallaci indicazioni.
La nuova norma dà spazio ad alcune considerazioni critiche, in quanto è sicuramente
poco felice sotto il profilo della formulazione lessicale e la linearità sintattica51.
Lo stesso giudice di legittimità, nella prima pronuncia che lo ha impegnato
nell’interpretazione di tale disposizione, l’ha definita come una norma “redatta in
termini che effettivamente possono a prima vista apparire poco chiari”52.
50
Cfr. A. Sirotti Gaudenzi, Rafforzata la tutela del “made in Italy”, in Dossier mensile di Guida al diritto,
2004, n. 1, pag. 134 e ss.
51
Infra capitolo 3, § 4, lettera b, pag. 210 e ss.
52
Cfr. Cassazione, 21 ottobre 2004, n. 3352, Fro, in Foro italiano, 2005, II, pag. 203, per il commento
alla sentenza cfr. infra capitolo II, § 2, lettera a, pag. 90 e ss.
62
Dai primi interventi della Suprema Corte di Cassazione e dai primi commenti alla
norma di nuovo conio emergono subito due diversi orientamenti.
Un primo orientamento ritiene che le innovazioni apportate dalla legge n. 350 del 2003
(c.d. finanziaria 2004) non siano così rilevanti, avendo l’articolo 4 comma 49 carattere
solo declamatorio, in quanto non inciderebbe di fatto sulla portata della normativa
penale e avrebbe il solo pregio di aver specificato il momento consumativo del reato di
cui all’articolo 517 codice penale.
Un secondo orientamento, invece, ha letto il dettato normativo come un “superamento”
della vecchia distinzione giurisprudenziale fra “provenienza imprenditoriale” ed
“origine geografica”, per cui la finanziaria 2004 inciderebbe direttamente sulla
estensione della norma penale, ampliandone i confini al di là di quanto stabilito dalla
più recente giurisprudenza.
È fin d’ora da premettere che un tale ampliamento della norma penale non andrà certo a
colpire la condotta dell’imprenditore straniero che commercializzi in Italia beni
industriali prodotti all’estero e contrassegnati con false indicazioni di provenienza
aziendale e geografica, ossia con l’apposizione di marchi o altri segni distintivi in grado
di creare nel consumatore l’apparenza di un prodotto fabbricato in Italia e/o da soggetti
italiani, perchè, già oggi, la norma penale reprime senza riserve questa condotta.
Piuttosto la riforma andrà a colpire proprio l’imprenditore italiano che abbia delocalizzato la produzione, il quale potrebbe vedere frustrata l’esigenza di caratterizzare
con il proprio segno distintivo il proprio prodotto.
63
64
a- L’interpretazione “innovativamente colpevolista”dell’Agenzia delle Dogane
L’interpretazione di coloro che ritengono che la disposizione del comma 49 dell’articolo
4 della legge n. 350 del 2003 abbia innovato il sistema giuridico relativo alle indicazioni
di provenienza e di origine dei prodotti, è stata definita da alcuni “innovativamente
colpevolista”53.
Tale interpretazione è stata fatta propria dalle autorità doganali, con un conseguente
moltiplicarsi di provvedimenti di sequestro di merci con etichettature ritenute “fallaci”
in quanto evocative dell’Italia in prodotti di origine in realtà straniera.
Per i sostenitori di tale orientamento la nuova norma ha due caratteristiche:
1. precisa il momento consumativo del reato punito dall’articolo 517
codice penale, anticipandolo alla presentazione della merce in
dogana: assunto condiviso anche da coloro che ritengono che la
nuova norma non abbia apportato innovazioni incisive;
2. allarga la portata dell’articolo 517 codice penale, estendendola
all’ipotesi di ingannevolezza circa il luogo geografico di produzione
delle merci, superando la giurisprudenza del passato.
In altre parole, la nuova norma considererebbe ingannevole anche quel segno distintivo
che fa credere al consumatore che la fabbricazione del prodotto sia avvenuta in Italia,
quando, invece, è stata materialmente altrove. Con l’effetto che sarebbero assoggettate
alle sanzioni previste dall’articolo 517 codice penale le ipotesi in cui l’imprenditore
nazionale, senza indicare il luogo di produzione, apponga il proprio segno distintivo su
53
Cfr. M. Barbuto, La piena tutela del “made in Italy” aspetta il regolamento delegato, in Guida al
diritto, 2005, fasc. n. 12, pag. 81 e ss.
65
prodotti la cui materiale realizzazione viene commissionata ad un terzo sub-fornitore
estero.
Il legislatore, al fine di promuovere la produzione italiana, avrebbe voluto vietare agli
imprenditori nazionali la possibilità di apporre il proprio marchio su prodotti fabbricati
all’estero per proprio conto, omettendo ogni riferimento al luogo materiale della loro
fabbricazione.54
Emblematiche di tale interpretazione della norma di nuovo conio sono le circolari
dell’Agenzia delle Dogane.
In particolare si consideri la circolare n. 20 D del 13 maggio 2005, pubblicata nello
stesso mese, che fornisce alcune precisazioni (condivise da rappresentanti del Ministero
delle Attività Produttive, del Ministero della Giustizia e del Comando Generale della
Guardia di Finanza), volte ad uniformare l’interpretazione delle disposizioni relative
alle indicazioni fallaci.
Va notato che tale circolare, nonostante sia stata pubblicata nel maggio del 2005, è
relativa al testo dell’articolo 4, comma 49, precedente alla modifica introdotta dal
decreto legge sulla competitività del marzo 2005.
L’Agenzia delle Dogane è il primo soggetto (con i suoi uffici periferici) ad entrare in
contatto con la merce sospettata di violare le regole sull’uso della dicitura “made in
Italy” o analoghe55, per cui è anche il primo soggetto chiamato a interpretare le norme
in materia.
54
Cfr. G. Martiello, La tutela penale del “made in Italy” nel mercato glòbalizzato: tra difesa del
consumatore e salvaguardia del sistema produttivo nazionale, in Rivista trimestrale di diritto penale
dell’economia, 2005, fasc. n. 3, pag. 780.
55
Si vedano le decine di comunicati stampa dell’Agenzia delle Dogane, pubblicati sul sito web
www.dogane.it riguardanti fermi amministrativi effettuati dai funzionari delle dogane sparsi su tutto il
territorio nazionale, relativi a merce recante false o fallaci indicazioni d’origine. Tra questi ci sono
comunicati riguardanti i sequestri: come ad esempio, di prodotti di noti designer della moda, recanti
illegittimamente la dicitura “made in Italy”; di palloni da calcio, con indebita dicitura designed in Italy; di
abbigliamento e calzature fabbricati in Cina, ma con l’indicazione “made in Italy”; nonché di apparecchi
per l’aereosol; ecc…
66
La circolare individua due ipotesi:
a- la “falsa indicazione”, consistente nella stampigliatura “made in Italy” su prodotti e
merci che in realtà non abbiano un’origine italiana, dove per “origine italiana” si
intende quella stabilita dalle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine
non preferenziale;
b- la “fallace indicazione”, consistente:
1. nell’apposizione, sui prodotti privi di indicazione d’origine, di
segni, figure o quant’altro, tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;
2. nell’apposizione, sui prodotti su cui è indicata una origine e
provenienza estera, di segni, figure o quant’altro, tali da indurre il
consumatore a credere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi la circolare precisa che, nel caso di importazione
di prodotti sui quali sia indicata la loro esatta origine, il reato si configura solo se “la
fallace indicazione” (segni, figure o quant’altro) sia tale da oscurare, fisicamente o
simbolicamente, l’etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o non
riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto.
Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, è
considerata “fallace” l’indicazione che induce chi la legge ad attribuire al prodotto
un’origine errata (in particolare quella italiana). Ad esempio: i casi in cui il prodotto, in
mancanza di una qualsiasi indicazione d’origine, presenti un’etichetta riportante la
bandiera italiana, oppure la dicitura Italy, oppure il nome di una città italiana.
67
Nella circolare si precisa che non costituisce una “fallace indicazione” di origine
l’apposizione di diciture quali “bottled in Italy” o “packed in Italy”, integrate
dall’elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto
confezionato o imbottigliato o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio
nazionale. Per l’Agenzia delle Dogane in tali casi il reato non è integrato, data
l’inesistenza di un inganno per il consumatore, essendo da una parte il significato di
“packed” non assimilabile a quello di “made”, dall’altra essendo altresì precisata sulle
confezioni l’esatta provenienza della materia prima.
Quanto alla “falsa indicazione” la circolare ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma
49, legge n. 350 del 2003, tale fattispecie si verifica quando è apposta “la
stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della
normativa europea sull’origine”.
L’Agenzia delle Dogane offre altresì una propria interpretazione del concetto di origine,
ai sensi della normativa europea, precisando nella citata circolare 20D, che “ogni
riferimento all’origine deve essere inteso come riferito all’origine non preferenziale56
degli stessi, così come viene definita dagli articoli da 22 a 26 del codice doganale
comunitario”57.
56
Le diciture “origine preferenziale” e “origine non preferenziale” sono utilizzate in ambito doganale per
determinare l’origine doganale della merce scambiata a livello internazionale tra paesi dell’Unione
europea e paesi extra Unione europea. In altre parole, negli scambi internazionali dell’UE, il trattamento
daziario delle merci dipende dall’origine doganale. Le norme comunitarie prevedono un duplice insieme
di regole per definire l’origine doganale di una merce: la regola dell’origine preferenziale e quella
dell’origine non preferenziale.
La definizione dell’origine “preferenziale” nasce da accordi conclusi tra la Comunità ed un determinato
paese terzo in base ai quali le merci possono ottenere alcune agevolazioni (riduzioni o esenzioni dai dazi)
all’atto della loro importazione.
L’origine “non preferenziale” si ha in tutti gli altri casi e determina l’applicazione della tariffa esterna
comune e di altre misure non tariffarie (divieti di importazione, restrizioni quantitative, misure
antidumping) alle merci oggetto di scambio.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, i criteri dell’origine non preferenziale sono
quelli da utilizzare per attribuire l’origine italiana di un prodotto sul quale si può apporre la stampigliatura
“made in Italy”.
57
Cfr. per il concetto di origine nel diritto comunitario, infra, capitolo II, § 1, lettera h, pag. 85 e ss.
68
Nella stessa circolare viene sottolineato che “difficoltà applicative possono sorgere, in
particolare, nell’applicazione dell’articolo 24 di detto Codice nel quale viene precisato
che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi deve essere
considerata originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale”.
L’Agenzia delle Dogane aggiunge che il concetto di “trasformazione sostanziale” può
creare difficoltà interpretative alla luce delle diverse valutazioni che possono essere
attribuite alle operazioni cui i prodotti medesimi siano sottoposti. Al riguardo l’Agenzia
precisa che “gli allegati 10 e 11 del regolamento CE n. 2454/9358 riportano, per taluni
prodotti, la descrizione delle lavorazioni (c.d. “regole di lista”), che permettono al
prodotto finito (per la cui produzione sono usati materiali aventi origini diverse) di
acquisire l’origine del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione in questione,
trasformazione che viene in tal modo ad essere considerata sostanziale”.
Nella circolare si evidenzia, però, che tali elenchi comprendono solo alcune tipologie di
prodotti. Per gli altri non è indicato il procedimento che li rende originari di un Paese,
per cui per essi rimane il dubbio interpretativo.59
In sintesi, la posizione dell’Agenzia delle Dogane sulla “origine” di un prodotto può
essere così riassunta:
1. i beni completamente ottenuti in un singolo paese, ai sensi dell’articolo 23
del Regolamento CE 2913/92, si considerano originari di tale paese;
2. quando due o più paesi sono coinvolti nella produzione di un bene,
l’origine del bene deve essere determinata nel rispetto dell’articolo 24 del
Regolamento CE 2913/92;
58
E’ il regolamento che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento CE n. 2919/92 che
istituisce il codice doganale comunitario.
59
Per rimediare a tale dubbio interpretativo sono in corso a Ginevra presso l’Organizzazione Mondiale
del Commercio i negoziati relativi all’armonizzazione delle regole di origine non preferenziale.
69
3. per diversi prodotti sono stabilite le regole (dette “regole di lista”) per
individuare i tipi di lavorazioni o trasformazioni che attribuiscono l’origine
non preferenziale ad un prodotto. Per molti prodotti le regole di lista sono
elencate negli allegati 9-11 del Regolamento CE 2454/93, recanti le
disposizioni di applicazione del Regolamento CE 2913/92;
4. per i prodotti relativamente ai quali non c’è una “regola di lista”, l’origine
è determinata conformemente alla posizione presa dall’UE nelle
negoziazioni volte al programma di armonizzazione, che definiscono il
concetto di ultima lavorazione sostanziale. In tal caso si applicheranno i
principi generali in materia di origine non preferenziale.60
60
Principi generali pubblicati all’indirizzo internet:
http://europe.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/nonpreferential/article_1621_en.htm.
70
b- L’interpretazione prevalente fatta propria dalle prime pronunce della
Suprema Corte di Cassazione
I sostenitori dell’orientamento maggioritario ritengono che la legge n. 350 del 2003 (c.d.
finanziaria 2004) non avrebbe modificato in modo incisivo il sistema pre-vigente. Tali
autori superano la lettura “colpevolista” della norma con un ragionamento che è proprio
anche dei cultori del diritto industriale di impostazione civilistica. Tale tesi, come si
vedrà, è stata fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione nelle prime sentenze in
cui ha dato applicazione alla norma di nuovo conio.
In particolare, essi sostengono che se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di
estendere la portata del reato anche al luogo di produzione materiale, il legislatore
sarebbe intervenuto anche sulla disciplina generale del marchio e sulla “latitudine della
facoltà per il titolare di concedere in licenza il marchio”61: in definitiva sull’articolo 15
della legge marchi n. 929 del 1942 (come novellato nel 1992)62, recentemente trasfuso
nell’articolo 127 del codice della proprietà industriale.
Inoltre, come si vedrà nella sentenza Fro, la Corte di Cassazione ha rilevato che
l’interpretazione “colpevolista” parte da un duplice errore valutativo, ravvisato
nell’errata individuazione della ratio della norma medesima e nella sua non corretta
lettura da un punto di vista letterale e logico.
Per la Suprema Corte la ratio non è da individuare nella promozione della produzione
italiana, da esaltare sotto il profilo della sua materiale fabbricazione in Italia, ma nella
risoluzione del contrasto giurisprudenziale sul momento consumativo del reato e nella
61
Così nella motivazione della sentenza Cassazione, Fro, n. 3352/2005, cfr. infra capitolo II, § 2, lettera
a,pag. 90 e ss.
62
Si veda infra , capitolo 2, § 2, lettera c, pag. 75.
71
volontà di promuovere i prodotti italiani mediante la promozione del marchio “made in
Italy”, la cui disciplina viene demandata ad un apposito regolamento delegato.
La Corte inoltre rifiuta la lettura “colpevolista” sotto il profilo linguistico - lessicale.
Infatti con il termine “provenienza” si deve intendere ciò che si è sempre inteso in
giurisprudenza e in dottrina a proposito dei marchi: provenienza di un prodotto da un
determinato produttore che ne garantisce la qualità e non da uno specifico luogo di
fabbricazione63. Niente induce a ritenere che in questa occasione il legislatore abbia
voluto dire qualcosa in più o di diverso rispetto al sistema vigente. Qualunque
interpretazione estensiva (nel senso di includere anche il luogo geografico)
contrasterebbe con il principio di tassatività delle fattispecie penali.
Occorre tener conto, poi, che il legislatore, quando la legge ha voluto attribuire
rilevanza al luogo di produzione materiale/geografico del prodotto, lo ha sempre fatto in
modo espresso e con riferimento a quei casi in cui i fattori climatici o ambientali
possono avere una incidenza sulla qualità del prodotto: come ad esempio, a proposito
della normativa sulle denominazioni di origine protette e le etichettature di alcuni
prodotti agro-alimentari. Ed ancora, si osserva come tutte le volte in cui sono sorti dubbi
circa la possibilità che una norma potesse far riferimento non solo alla provenienza di
un dato prodotto da un determinato produttore, ma anche al luogo di materiale
produzione si è sempre trattato di norme che utilizzavano il termine “origine” del
prodotto e non quello di “provenienza”.
Pertanto, dal momento che l’articolo 4, comma 49 legge citata, si riferisce solo alle
“false o fallaci indicazioni di provenienza” e non anche alle “false o fallaci indicazioni
d’origine”, e che tale omissione non può ritenersi una dimenticanza, è evidente
63
In questo senso, con riferimento al concetto di provenienza di cui all’articolo 517 codice penale: cfr. F.
Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, volume II, 14esima edizione integrata e aggiornata a
cura di L. Conti, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 188; G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale…, cit., pag.
652; A. Alessandri, voce Tutela penale…, cit, pag. 461.
72
l’intenzione del legislatore di attribuire rilevanza alla provenienza da un dato produttore
e non anche alla provenienza da un determinato luogo di produzione.
In effetti, la Suprema Corte di Cassazione osserva che il termine “origine”, assente nel
primo periodo del comma 49 dell’articolo 4, compare nel secondo e nel quarto periodo
con riferimento a prodotti “non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine”, che individua nel luogo di produzione o di ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale dei prodotti il criterio per determinare l’origine stessa.
Sennonché, secondo la Corte, il secondo e il quarto periodo del comma 49 non si
riferiscono all’imprenditore che apponga i propri marchi o segni distintivi sui prodotti
materialmente fabbricati all’estero, bensì all’imprenditore che apponga il costituendo
marchio “made in Italy” su prodotti non originari dall’Italia ai sensi della normativa
europea sull’origine.
Per i sostenitori di tale tesi la fattispecie extra codicem avrebbe una ridotta utilità: esse
troverebbe applicazione soltanto grazie alla clausola di residualità contenuta
nell’articolo 517 codice penale, con esiti applicativi apprezzabili non tanto sul versante
sostanziale, bensì su quello procedurale, considerata la possibilità per il reo di
avvantaggiarsi della eventuale regolarizzazione della merce contemplata dalla
previsione extra codicem. L’ultimo periodo del comma 49 articolo 4 prevede, infatti,
che “la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con
l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul
piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della
stampigliatura “made in Italy””.
73
Per cui il reale contenuto dispositivo della norma si ridurrebbe alla sola previsione del
terzo periodo, cioè quella relativa al momento consumativo.
74
c- La riforma del 1992 sul trasferimento del marchio
I sostenitori della tesi sistematica fondano le loro considerazioni anche sulla riforma del
1992 sul trasferimento del marchio.
Fino al 1992 l’articolo 15 della legge marchi, conforme al vecchio testo dell’articolo
2573 del codice civile, non consentiva il trasferimento del marchio senza la contestuale
cessione dell’azienda o di un ramo di questa. Una norma molto severa che in Italia
rendeva problematiche alcune pratiche commerciali molto diffuse all’estero, quali il
merchandising e le licenze non esclusive.
La Cassazione civile ( sentenze n. 2688 del 1967; n. 665 del 1972; n. 3034 del 1993) ha
interpretato tale divieto in modo via via più blando, fino a giungere a soluzioni che la
dottrina ha definito come “processo di spiritualizzazione del ramo d’azienda”. La Corte
è arrivata a ritenere lecita una licenza di marchio, anche non esclusiva, mediante il
semplice trasferimento del know how o anche delle mere istruzioni per produrre il bene
marchiato.
La riforma del 1992, infine, abolendo l’originario divieto, ha modificato la disciplina
del trasferimento del marchio, dando il via libera al merchandising e alle licenze non
esclusive, con l’unico limite della non ingannevolezza dei “caratteri dei prodotti o
servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”. Si è così passati dal
regime di vincolo fra marchio e azienda (per cui non si poteva trasferire l’uno senza
trasferire, in tutto o in parte, l’altra) al regime del distacco fra marchio e impresa:
ovvero dal regime di “cedibilità del marchio vincolata all’azienda” a quello
dell’”indipendenza della trasferibilità”.64
64
Cfr. G. Sena, Il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario, IV edizione, Milano,
2007, pag. 54.
75
In sintesi: prima del 1992 la legge esigeva che un marchio fosse l’indicatore di
provenienza del prodotto da una certa impresa/azienda facente capo al titolare di quel
marchio; oggi la legge consente che il marchio possa essere usato da un soggetto
diverso dal titolare che lo abbia registrato (ovviamente col consenso di quest’ultimo) e
possa quindi provenire da un complesso aziendale diverso dall’azienda del titolare.
Con questa breve digressione in campo civilistico, si comprende meglio l’obiezione dei
sostenitori della tesi “non colpevolista”: l’articolo 4, comma 49 non può essere stato
esteso anche al luogo di produzione, perché sconvolgerebbe la portata del nuovo
articolo 15 della legge marchi.
La legge marchi, inoltre, non prevede alcun obbligo per il licenziatario di apporre
l’indicazione del luogo di fabbricazione di un prodotto contrassegnato, per esempio, da
un marchio celebre, ottenuto in licenza da un titolare con sede o stabilimento in altra
località. Per esempio: un produttore di “felpe Ferrari”, con licenza della casa di
Maranello, non ha l’obbligo di scrivere sul prodotto che l’indumento è fabbricato a
Firenze, perché il consumatore non confida sul confezionamento a Maranello di tutti i
prodotti con il marchio “Ferrari” immessi sul mercato dal titolare e dai licenziatari.
Diverso ovviamente è il caso del vino Chianti o Montepulciano, del prosciutto di Parma,
del formaggio Parmigiano-Reggiano e di tutti i prodotti del settore agro-alimentare in
cui vigono regole diverse.
76
d- La difficile definizione del concetto di “fallace indicazione”
Se la nozione di “falsa indicazione” non sembra dar luogo a dubbi interpretativi, lo
stesso non può dirsi per quella di “fallace indicazione”.
Si rileva, infatti, in giurisprudenza e dottrina un certo grado di problematicità nel
definire il concetto di “indicazione fallace”, che, attraverso l’impiego dell’espressione
“segni, figure o quant’altro possa risultare ingannevole”, lascia ampio spazio alla
fantasia degli interpreti chiamati ad applicarla.
Sul punto, bisogna distinguere l’ipotesi in cui l’indicazione fallace sia accompagnata
dall’indicazione dell’origine estera del prodotto, da quella in cui ciò non avvenga,
situazione quest’ultima che sarà ampiamente discussa nell’analisi delle pronunce della
Suprema Corte successive al 2004.
Innanzitutto sembrerebbe che la prima ipotesi sia illegittima ai sensi del diritto
internazionale. Sembrerebbe che la nuova norma dia maggiore peso ad elementi
meramente speculativi rispetto al dato oggettivo fornito da un legittimo marchio di
origine. Una tale fattispecie non sembra essere compatibile con il GATT, il cui articolo
IX, interpretato anche alla luce della Raccomandazione del 1958, consente l’adozione di
norme che prescrivano l’utilizzo di marchi d’origine, sempre che le difficoltà per il
commercio internazionale siano ridotte al minimo indispensabile.65 È invece evidente la
conseguenza sproporzionata che deriva dal nuovo regime, che prevede l’applicazione
della norma penale anche ai casi in cui il marchio di origine sia del tutto veritiero.
65
Cfr. F. Di Gianni, Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine: norme e giurisprudenza relative al made
in, in Rivista di diritto industriale, 2007, fasc. n. 1, pag. 45.
77
Il problema del significato attribuibile alla locuzione “uso di segni, figure o quant’altro
possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana” è tutt’altro che teorico.
Da recenti provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane66 emerge un indirizzo applicativo
che porterebbe a ritenere sussistenti gli estremi dell’indicazione fallace, ex articolo 4,
comma 49, legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004), anche quando sia
semplicemente apposto, sull’etichetta dei prodotti importati e pronti per la
commercializzazione, l’indirizzo dell’impresa importatrice. Nell’ambito di tale
posizione interpretativa è stata ritenuta “fallace”, pertanto, l’indicazione dell’identità del
concedente la licenza del marchio, apposta sui prodotti dal licenziatario italiano in
adempimento di un preciso obbligo contrattuale; in virtù del fatto che la ragione sociale
del licenziante, trattandosi di società anch’essa italiana, comprendeva il termine
“Italy”.67
In via di principio, un’applicazione come quella descritta potrebbe essere plausibile solo
ove si ritenesse che, in seguito all’introduzione della previsione di cui all’articolo 4,
comma 49, al fine di “non indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce
sia di origine italiana”, nel nostro paese sia attualmente fatto divieto a chiunque
commercializzi prodotti non fabbricati in Italia di apporre il proprio indirizzo sulla
confezione degli stessi. Tale divieto dovrebbe dunque valere per i prodotti provenienti
da qualunque paese, sia esso la Cina, l’India, la Francia o la Spagna.
Ma non si può avvallare una simile interpretazione, certamente lontana dalle intenzioni
del legislatore, anche perché la prassi applicativa sopra richiamata si pone in palese
contrasto con il principio di uguaglianza. Infatti, mentre coloro che importano prodotti
66
Si veda supra lettera a), pag. 65.
Nel caso di specie l’impresa italiana importatrice aveva appaltato ad un produttore cinese la
fabbricazione di una linea di prodotti da lei disegnata e realizzata e che venivano commercializzati con
l’ulteriore marchio consistente nel nome di una nota trasmissione televisiva, in virtù di un regolare
contratto di licenza concluso con il titolare dei relativi diritti.
67
78
integralmente fabbricati e confezionati all’estero sarebbero costretti ad omettere
nell’etichetta la loro ragione sociale, oppure marchi contenenti le parole “Italia” o
“Italy” (al fine di non incorrere nel blocco doganale al momento dell’importazione),
coloro che importano prodotti integralmente fabbricati all’estero, ma provvedono
all’apposizione delle etichette in Italia, non subiscono alcuna limitazione in merito.
A ciò si aggiunga che, qualora si tratti di prodotti destinati al consumatore, il termine
“Italia”
dovrà
comunque
figurare
sull’etichetta
degli
stessi
all’atto
della
commercializzazione, ex articolo 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante
norme per l’informazione del consumatore, nonché dell’articolo 1, comma 1 del relativo
regolamento di attuazione: il nome o ragione sociale, o marchio, così come la sede del
produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea, rientrano infatti tra le
informazioni
che
devono
figurare
sull’imballaggio
preconfezionato
oppure
sull’etichettatura fissata o legata al medesimo.
Da un punto di vista pratico è importante riflettere sul fatto che il consolidamento della
descritta prassi dalle autorità doganali si risolverebbe in uno svantaggio unicamente per
le imprese importatrici italiane: queste ultime dovrebbero sopportare l’aggravio di costi
derivante dalla necessità di procedere al confezionamento in Italia, per non incorrere nel
blocco doganale dei loro prodotti, mentre le imprese operanti negli altri paesi europei
sono esenti da un tale onere.
Sembrerebbe che la sola interpretazione plausibile della previsione relativa
all’indicazione fallace (vale a dire l’uso di segni, figure o quanto altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana) è che la stessa
sia diretta a reprimere situazioni quali l’utilizzo del tricolore italiano o di espressioni del
tipo “Italian style” o “Italian design” in relazione a prodotti relativamente ai quali tali
riferimenti non trovano giustificazione in alcuna situazione di fatto o di diritto.
79
e- Tutela del “made in Italy”, ma non di altre indicazioni di provenienza
Stando al dato letterale della disposizione di cui al comma 49 dell’articolo 4 legge n.
350 del 2003 sembrerebbe che il legislatore si sia disinteressato dei casi in cui un
prodotto rechi illegittimamente il marchio “made in Japan”, “made in France”, “made in
Ue” ecc.., in quanto si riferisce esclusivamente al “made in Italy”.
Tali etichettature poste su prodotti realizzati in paesi diversi dall’Italia e importati in
Italia, sembrerebbero sfuggire al divieto e per tale ragione si può sostenere che
l’obiettivo della tutela della buona fede del consumatore italiano, pur essendo per alcuni
versi comprensibile, in quanto risente dell’assenza di un’armonizzazione comunitaria,
non sembra dunque coerentemente perseguito.
Se, infatti, il bene tutelato in caso di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
“non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell’ordine economico, che
dev’essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori”68, sarebbe stato più
opportuno prendere in considerazione qualsiasi ipotesi di falsa indicazione dell’origine
e non limitarsi alla sola stampigliatura “made in Italy”.
68
Cfr. Cassazione, sez. VI penale, 5 luglio 1989, n. 9584.
80
f- Il regolamento delegato previsto dal comma 63 dell’articolo 4 legge n. 350 del
2003 (c.d. finanziaria 2004)
Il comma 61 dell’articolo 4 legge n. 350 del 2003 demanda ad un apposito regolamento
governativo, tutt’oggi non ancora emanato, “la regolamentazione dell’indicazione di
origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente
prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia
di origine”.
Ai sensi del successivo comma 63 “le modalità di regolamentazione delle indicazioni di
origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61” sono definite “con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri
dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e
per le politiche comunitarie”.
Finora tale marchio non è stato però istituito e regolamentato. Quindi il “marchio made
in Italy” non esiste ancora, dal punto di vista giuridico, pur essendo negli auspici della
finanziaria 2004.
In merito si può ricordare che già nel 1998 un provvedimento normativo, precisamente
l’articolo 7 del decreto legislativo n. 173, aveva introdotto la previsione di un marchio
“identificativo della produzione agro-alimentare nazionale” che, nelle intenzioni,
avrebbe dovuto consistere “in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio
della produzione agro-alimentare nazionale” ed essere “di proprietà del Ministero per
le politiche agricole”. La norma rimase senza attuazione a seguito della censura
81
espressa in una comunicazione della Commissione Europea, in quanto “limitandosi la
concessione del marchio in funzione della sola origine o provenienza geografica
sarebbe stato contrario all’articolo 30 del Trattato (…) e avrebbe configurato una
violazione delle norme in tema di concorrenza, in quanto il marchio e il segno di cui
trattasi possono favorire i prodotti nazionali a scapito dei prodotti provenienti da altri
Stati membri”.
82
g- La determinazione del momento consumativo: superamento del contrasto
giurisprudenziale
Per alcuni commentatori, ossia come visto per i sostenitori dell’orientamento
consolidato69, il periodo terzo del comma 49 dell’articolo 4 legge n. 350 del 2003 è
l’unica vera novità introdotta dalla novella.
Con tale disposizione è stato in effetti risolto un decennale contrasto giurisprudenziale,
nato in seno alla terza sezione della Corte di Cassazione, relativamente al momento
consumativo del reato previsto dall’articolo 517 codice penale.
Nel “caso Andolfo” (Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 2001, n. 26754)70
la Suprema Corte ha affermato che “la presentazione della merce in dogana per
l’operazione di sdoganamento non costituisce atto di circolazione dei prodotti”, con la
conseguenza che il reato non ancora esisterebbe oggettivamente.
Nel “caso Delaser” (Cassazione, sez. III penale, sentenza 13 ottobre 1999, n. 11671)71 la
Suprema Corte ha affermato il contrario, interpretando l’espressione “mette altrimenti in
circolazione” come alternativa all’atto di “porre in circolazione” e, quindi, comprensiva
della “mera presentazione alla dogana”, ipotesi peraltro configurata come tentativo del
delitto di cui all’articolo 517 del codice penale.
Con il comma 49 dell’articolo 4 il legislatore ha risolto ogni dubbio al riguardo72,
precisando che costituisce il reato punito dall’articolo 517 codice penale (come delitto
consumato) sia “la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di
69
Si veda supra capitolo 2, § 1, lettera b), pag. 70.
In Cassazione Penale, 2002, pag. 2124.
71
In Rivista penale, 2001, pag. 946.
72
Cfr. infra capitolo III, § 5, pag. 215 e ss.
70
83
provenienza” sia “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione” degli
stessi mediante presentazione in dogana73.
73
Si veda infra capitolo 3, § 5, pag. 215 e ss..
84
h- L’”origine doganale” nel codice doganale comunitario (Regolamento n. 2913/92)
Occorre precisare quale sia la normativa europea sull’origine a cui si riferisce il citato
comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004) e come essa
definisca la nozione stessa di “origine”.
Si tratta del regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992, che ha istituito il codice
doganale comunitario e ha definito negli articoli dal 22 al 26 l’origine delle merci ai fini
doganali.
Nell’articolo 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente ottenute in
detto paese, precisando che per tali devono intendersi:
a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese;
d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi
immatricolate o registrate in tale paese e battenti la sua bandiera;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f);
h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque
territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale
suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso,
sempre che siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie
prime;
85
j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro
derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
Com'è evidente, si tratta sempre di merci la cui qualità è in qualche modo identificabile
in relazione alla loro origine geografica, così come per i prodotti agricoli e alimentari di
cui al Regolamento CE n. 20817 del 1992.
Sembra logico dedurne, quindi, che il legislatore nazionale del 2003, nel riferirsi alla
nozione europea di origine, abbia richiamato la categoria di derivazione geografica
(solo) per quei prodotti di tipo agricolo, minerario o animale, le cui caratteristiche siano
in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale.
Rilievo assume, poi, l’articolo 24 dello stesso regolamento CE che riferendosi
genericamente “alla merce alla cui produzione contribuiscono due o più paesi”,
statuisce che essa s’intende “originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in
un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione”. Definizione che si fonda sulle esigenze del commercio internazionale,
per cui l'origine della merce deve essere sempre radicata in un solo paese.
A tale disposizione fa eco l’articolo 25 che, nel tentativo di impedire facili elusioni della
norma precedente, ritiene irrilevante quella trasformazione o lavorazione “per la quale è
accertato o per la quale i fatti constati giustificano la presunzione che sia stata
effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di
determinati paesi”.
Quindi, richiamando la nozione europea di origine l'articolo 4 comma 49 della legge n.
350 del 2003 non ha modificato l’ interpretazione che si deve dare della origine e
86
provenienza di un prodotto ai fini della tutela penale dell'ordine economico e/o della
fede pubblica. Posto che a tali fini origine e provenienza sono funzionali alla qualità del
prodotto, rileverà la derivazione territoriale o quella imprenditoriale, a seconda che la
qualità del prodotto dipenda dall'ambito geografico o dalla tecnica produttiva con cui la
merce nasce: perciò, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla
affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine
imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la
responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo; invece,
relativamente ai prodotti agricoli o alimentari, la cui qualità dipende essenzialmente
dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine
del prodotto deve intendersi propriamente la relativa origine geografica o territoriale,
che lo rende identificabile.
87
2. I PRIMI INTERVENTI INTERPRETATIVI DELLA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE RELATIVAMENTE AL COMMA 49 DELL’ARTICOLO 4
DELLA LEGGE 350 DEL 2003 (C.D. FINANZIARIA 2004)
La difficoltà di attribuire un senso giuridicamente coerente alla disposizione del comma
49 dell’articolo 4 legge 350/2003 (c.d. finanziaria 2004), nella parte dedicata alle
indicazioni di provenienza false o fallaci, emerge in tutta evidenza dalle prime pronunce
della Cassazione Penale rese in merito alla stessa.
La Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi sulla validità dell’interpretazione
propugnata da quanti ritenevano superato alla luce della legge n. 350 del 2003 il
“vecchio” orientamento in tema di estensione dell’articolo 517 codice penale.
Il giudice di legittimità, con due note sentenze, la sentenza n. 3352 del 2005 relativa al
caso “Fro” e la n. 13712 del 2005 relativa al caso “Legea”, ha, in una prima fase,
riportato la questione entro i ben noti binari della tradizione.
Ha, infatti, respinto la tesi che vedeva nell’articolo 4 della finanziaria 2004 il
superamento della vecchia impostazione giurisprudenziale sull’articolo 517 codice
penale per due ordini di ragioni: una strettamente letterale e una di coordinamento con
la disciplina civilistica.
In queste due sentenze è stato ritenuto del tutto arbitrario considerare l’intervento del
legislatore come una “svolta” nella tutela penale dell’origine delle merci, quasi si fosse
limitato solo a risolvere un contrasto giurisprudenziale sorto, in seno alla terza sezione
88
penale della Cassazione, in ordine al momento consumativo del reato, oggi
definitivamente individuato nella presentazione della merce in dogana.74
Le sentenze sull’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 precedenti alle modifiche
apportate dal decreto legge sulla competitività (decreto legge n. 35 del 2005, convertito
in legge n. 80 del 2005) sono complessivamente quattro, di cui l’ultima del 2006, pur se
pronunciata dopo il decreto, non ha avuto, comunque, modo di considerare detta
modifica.
Questo l’esito delle quattro decisioni: le prime due (Fro e Legea) escludono che integri
“fallace indicazione di provenienza” la apposizione di parole e segni che richiamino
l’Italia su prodotti realizzati all’estero su commissione di imprese italiane. La terza
sentenza (Ingam), invece, ritiene che costituisce “falsa indicazione di provenienza”,
l’apposizione “made in Italy” su prodotti commissionati e commercializzati da una
impresa italiana, ma realizzati all’estero con il know how italiano, senza che in Italia
avvenga l’ultimo processo di lavorazione sostanziale. La quarta (Giordani), senza
indicare se si tratta di falsa o fallace indicazione di provenienza, ritiene illecita
l’apposizione dellaformula “designed & produced by Tasci Rovereto, Italy” su capi di
abbigliamento fatti all’estero con design e materia prima italiani.
74
Il contrasto si riferisce alle sentenze della terza sezione penale della Corte di Cassazione numero
219216 del 26 aprile 2001 “Andolfo”in Cassazione penale, 2002, pag. 2124 e 215530 del 27 maggio 1999
Desaler, in Rivista penale, 2000, pag. 41. Si veda supra capitolo 2, § 1, lettera g, pag. 83 .
89
a. Sentenza FRO, n. 3352/2005: la prima pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione sull’origine dei prodotti dopo la legge n. 350 del 2003 (c.d.
finanziaria 2004): conformità all’orientamento consolidato circa la prevalenza
dell’origine imprenditoriale sulla provenienza geografica
La prima pronuncia che rileva è la sentenza n. 3352 del 2005, così detta sentenza
“FRO” 75.
La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte riguarda il sequestro probatorio
operato dalle autorità doganali di Padova su una partita di elettrodi per saldatura
fabbricati in Romania nello stabilimento della Ductil S.A. di Buzau (Romania),
controllata al 70% dalla Fro S.r.l.. Questi ultimi riportavano sulla confezione la dicitura
“Fro Via Torricelli 15/a Verona - Italy” senza alcun riferimento alla provenienza
rumena, trovandosi solo il nome, la ragione sociale e la sede del venditore stabilito nella
CE, seguito dal termine “Italy”.
Il pubblico ministero ha convalidato il sequestro, ipotizzando, per la presenza del
termine “Italy” nell’indirizzo dell’impresa importatrice, il reato di cui all’articolo 517
codice penale in relazione all’articolo 4, comma 49, della legge n. 350.
Il Tribunale del riesame, adito dalla difesa, aveva, confermato il provvedimento
ritenendo sussistenti gli indizi di commissione del reato ipotizzato.
Il Tribunale e il pubblico ministero hanno interpretato la disposizione della finanziaria
2004 come un superamento dei limiti della disciplina precedente, individuando la ratio
del comma 49 della legge n. 350 del 2003 nella promozione della produzione italiana e
75
Cassazione, sezione III penale, 21 ottobre 2004, n. 3352, Fro, in Foro italiano, 2005, II, pag. 203 con
osservazioni di Casaburi, in Guida al diritto, 2005, n. 12, pag. 75, con nota di Barbuto, nonché in Diritto
industriale, 2005, pag. 271, con nota di Casucci.
90
dei suoi prodotti di punta, da esaltare anche sotto il profilo della loro materiale
fabbricazione in Italia.
In tale ottica la finanziaria è stata interpretata come una sostanziale chiusura, da parte
del legislatore, ad ogni possibilità per gli imprenditori di indicare sui prodotti fabbricati
all’estero, per proprio conto, la propria ragione sociale o il proprio marchio, omettendo
riferimenti alla provenienza, nel senso di materiale fabbricazione, dei prodotti
medesimi.
Il caso in esame, oggetto della sentenza della Suprema Corte, si può definire di
“ordinaria amministrazione” nell’attuale pratica commerciale, caratterizzata da un
consistente ricorso alla sub-fornitura industriale da parte di imprese “de-localizzate”,
cioè collocate in paesi ad alta competitività sotto il profilo del costo del lavoro.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame,
consentendo così il dissequestro e la restituzione delle merci all’avente diritto Fro s.r.l.,
che ha pertanto potuto liberamente commercializzare gli elettrodi realizzati dalla propria
controllata rumena, rifiutando totalmente l’approccio interpretativo seguito dalla Corte
territoriale e mantenendosi peraltro nella linea giurisprudenziale già tracciata in epoca
antecedente all’introduzione del comma 49 dell’articolo 4 della legge finanziaria 2004.
Per la Corte di Cassazione “il reato prospettato dal pubblico ministero non è allo stato
nemmeno astrattamente configurabile”.
La Suprema Corte nella motivazione parte dalla ricognizione della giurisprudenza
preesistente sull’articolo 517 codice penale, con particolare riferimento ai concetti di
“origine” e di “provenienza” dei prodotti, dando conto della complessa discussione ad
essi sottesa in ambito civilistico, per poi passare all’interpretazione della normativa
introdotta dalla legge n. 350 del 2003.
91
La Corte di Cassazione inizia l’esposizione dei motivi della decisione soffermandosi
sulla portata, precedenti alla modifica, dell’articolo 517 codice penale, riaffermando
l’interpretazione fornita nella sentenza n. 2500 del 1999 (così detta sentenza Thun)76.
Come si visto, detta pronuncia giurisprudenziale ha espresso l’evolversi del pensiero
giuridico nel settore industriale, diretto ad interpretazioni della norma penale adeguate
allo sviluppo delle nuove prassi industriali e commerciali sempre più tese, nel corso
degli ultimi trent’anni, a scindere il processo “ideativo” del prodotto rispetto alla fase
della sua materiale realizzazione: scissione che ha portato, nel corso dei decenni, a
concentrare gli investimenti delle imprese dei paesi più avanzati nel settore della ricerca
e sviluppo, ed a procedere contemporaneamente a de-localizzare la produzione in aree
(della nazione, prima, del pianeta, poi) caratterizzate da costi (del lavoro) ridotti.77
Per la Corte di Cassazione si applica l’articolo 517 codice penale solo alle fattispecie in
cui il consumatore sia ingannato relativamente all’origine e provenienza della merce da
uno specifico produttore (identificabile da un marchio), non anche da un determinato
luogo geografico. Secondo la Corte l’elemento centrale della norma penale sarebbe la
tutela della fiducia dell’acquirente quanto alla riferibilità di una merce ad un produttore,
in conformità con la funzione che ha il marchio commerciale di contraddistinguere
determinate caratteristiche qualitative, in quanto risultato del processo produttivo di
un’impresa78. In tal senso, i termini provenienza e origine contenuti nella norma
76
Si veda supra capitolo 1, § 1, lettera j, pag. 43 e ss .
Cfr. M. Casucci, La tutela del “made in Italy” in sede penale, nota a Cassazione sez. III penale 2
febbraio 2005, n. 3352, in Il diritto industriale, fasc. n. 3, 2005, pag. 277.
78
L’articolo 23 del Codice della proprietà industriale del 10 febbraio 2005 ( ex articolo 15 R. D. 29
giugno 1942 n. 929, così detta legge marchi) che – in uno con l’articolo 2573 codice civile – ha esteso
notevolmente le facoltà di trasferimento del marchio da parte del titolare del relativo diritto, consentendo
anche la licenza così detta non esclusiva e la possibilità di licenza del marchio indipendentemente dalla
cessione dell’azienda o dal ramo d’azienda.
Proprio con l’introduzione della trasferibilità del marchio non vincolata dalla contestuale cessione
dell’azienda e di un suo ramo si è profondamente modificato il concetto di funzione distintiva del marchio
come indicazione della provenienza in senso letterale dei prodotti.
77
92
sarebbero “funzionali (al termine qualità) che in realtà è il solo fondamentale posto che
il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del
prodotto stesso”.
La Suprema Corte sulla scorta di tali argomentazioni ha ritenuto non fosse configurato il
reato de quo, escludendo la rilevanza penale della condotta descritta alla luce del fatto
che la merce in questione era stata prodotta all’estero con il Know how della società
italiana, che se ne assumeva la responsabilità, giuridica, economica e tecnica,
apponendo sulla merce la propria denominazione sociale ed il proprio marchio.
Indicazione, questa, corrispondente alla verità e non atta ad ingannare il consumatore
sulla provenienza e sulla qualità della merce. La Corte ha altresì sottolineato che era del
tutto irrilevante che non fosse indicato il luogo di fabbricazione materiale.
In seguito la Corte ha affrontato, per la prima volta, le implicazioni relative all’ambito
di applicazione dell’articolo 517 codice penale derivanti dal nuovo regime delineato
dall’articolo 4, comma 49, della legge n. 350 (prima della novella introdotta dal decreto
legge n. 35 del 2005). La Corte ha respinto la lettura della norma proposta dall’Agenzia
delle Dogane e dal Tribunale di Padova, diretta a sostenere che la legge n. 350 del 2003
avrebbe esteso la portata dell’articolo 517 codice penale alle indicazioni ingannevoli
relative al luogo geografico di produzione.79
Contro questa interpretazione, la Corte ha individuato sostanzialmente due argomenti.
La prima argomentazione, che poggia su considerazioni di ordine lessicale e
sistematico, sostiene che l’estensione dell’articolo 517 codice penale porterebbe a
contemplare una nuova fattispecie di reato per indicazione ingannevole dell’origine
Cfr. sull’argomento supra capitolo II, § 1, lettera c, pag. 75 e ss.
Sullo sviluppo normativo e giurisprudenziale del novellato articolo 15, F. Leonelli – P. Pederzini – P.L.
Costa – S. Corona, Commentario alla legge sui marchi d’impresa, Milano, 1995, pag. 46 e ss.
79
Cfr. supra capitolo II, § 1, lettera a, pag. 65 e ss.
93
geografica di un prodotto, così modificando anche la tutela tipica del marchio
commerciale, che è diretta a ricondurre un prodotto ad un produttore e non ad un luogo.
La seconda evidenzia come il testo dell’articolo 4, comma 49, si limiti a parlare di false
o fallaci indicazioni di provenienza80, per concludere che tali locuzioni si riferiscono
alla provenienza da un determinato produttore e non da un determinato luogo di
produzione, ipotesi, quest’ultima, ricompresa nel termine “origine”.
La Corte ha, quindi, concluso distinguendo due diverse ipotesi nell’oggetto della
disciplina stabilita dal comma 49 dell’articolo 4 della legge finanziaria 2004: “il comma
49 dell’articolo 4
in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si
riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazioni
di “provenienza” del prodotto e per i motivi indicati, deve ritenersi che si riferisca alla
provenienza come è sempre stata pacificamente intesa, ossia alla provenienza da un
produttore e non alla provenienza da un luogo determinato. Il secondo periodo
riguarda , invece, la tutela del marchio “made in Italy” (marchio la cui disciplina è
demandata ad un regolamento delegato) e dispone che costituisce falsa indicazione
l’apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi
della normativa europea sull’origine. Ne consegue che i criteri utilizzati dalla
normativa europea per stabilire l’origine di un prodotto sono richiamati e possono
essere usati solo in relazione alla apposizione del marchio “made in Italy” e non anche
per le false indicazioni di provenienza di cui al primo periodo e ciò sia perché il primo
periodo parla di “provenienza” e non di “origine” sia perché la prima parte del
secondo periodo limita chiaramente il richiamo alla normativa europea (dettata per la
80
La sentenza è prima della modifica apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, che ha aggiunto
nell’articolo 4, comma 49, la nozione di “origine”.
94
applicazione della tariffa doganale e per altri limitati effetti) alla sola falsa indicazione
della stampigliatura “made in Italy””.
Per cui secondo la Corte:
1- quando il comma 49 dell’articolo 4 legge n. 350 del 2003 parla di false o fallaci
indicazioni di provenienza, la parola provenienza “non può avere altro
significato che quello di rendere chiaro che la disposizione penale…si riferisce
solo alla provenienza da un determinato produttore e non a quella geografica”,
in caso contrario, a parere della Cassazione, potrebbero sorgere dubbi di
legittimità costituzionale sotto il profilo della manifesta irrazionalità e della
violazione del principio di offensività, non essendo corretto estendere la portata
delle norme in oggetto a fattispecie irrilevanti ai fini dell’interesse perseguito,
costituito dalla tutela del consumatore contro indicazioni o segni che potrebbero
trarre in inganno;
2- egualmente, nella seconda parte del secondo periodo del comma 49, quando la
norma parla di origine “non intende riferirsi al luogo di produzione…bensì
proprio al produttore che assume la responsabilità giuridica, economica e
tecnica della produzione”;
3- il termine “origine” deve essere interpretato come origine geografica di
produzione solo in caso di uso della dicitura “made in Italy”, dato che la norma
solo in tale caso richiama la normativa europea sull’origine: pertanto, laddove
fosse usata la frase “made in Italy” e venisse accertata una diversa origine
geografica dei prodotti, risulterebbe giustificata la maggiore tutela prevista dal
legislatore con la configurazione dell’illecito di cui all’articolo 517 codice
penale.
95
In definitiva, secondo la Corte, la sola conseguenza della novella del 2003 sarebbe stata
quella di specificare il momento consumativo del reato, che si perfezionerebbe non più
all’atto della vendita ma sin dalla presentazione della merce in dogana.
Questa interpretazione sarebbe eccessivamente dipendente dall’assenza del termine
“origine” nel primo periodo del comma 49, difetterebbe di scarsa coerenza e perderebbe
di vista gli obiettivi della riforma del 2003.
In conclusione, con questa prima pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha adottato
una interpretazione assai restrittiva della portata della nuova norma introdotta dalla
finanziaria 2004.
Può essere utile esemplificare le ipotesi in cui, secondo tale orientamento della Suprema
Corte, potranno trovare applicazione le nuove disposizioni legislative della finanziaria
2004:
1- saranno da considerare legittimamente immessi nel mercato i prodotti fabbricati
all’estero per conto di un produttore italiano che garantisca i processi produttivi
ed imponga o autorizzi l’utilizzo dei propri segni distintivi. Questo è il principio
applicato per risolvere il caso in questione, in cui la Fro s.r.l. risultava
controllante la società produttrice materiale degli elettrodi e curava anche gli
aspetti legati al controllo della produzione;
2- sarà rilevante, ai sensi del primo e del terzo periodo del comma 49, e perciò
punita con la sanzione di cui all’articolo 517 codice penale, la presentazione in
dogana di prodotti fabbricati all’estero riportanti marchi o altre indicazioni
contenenti l’indicazione di un produttore italiano o comunque di una origine
italiana, quando non esistano legami con il titolare del segno distintivo quale
soggetto garante del processo produttivo;
96
3- quanto alla norma relativa al “made in Italy” non appare possibile al momento
attuale nessuna applicazione in mancanza del regolamento previsto dal comma
63 del medesimo articolo 4 legge n. 350 del 2003. La Corte ipotizza la necessità
di una integrale fabbricazione sul territorio nazionale per l’utilizzo di tale
dizione, ma l’affermazione è tutt’altro che definitiva. Lo stesso giudice di
legittimità cita la normativa europea sull’origine, in base a cui non sembra
potersi escludere che il prodotto originario di una data nazione venga realizzato,
quantomeno in parte all’estero sulla base del know-how italiano.
La Corte di Cassazione, in conclusione, con questa prima pronuncia ha adottato una
interpretazione restrittiva della nuova norma introdotta dalla finanziaria 2004, senza
discostarsi dagli orientamenti precedenti al 2004 relativi all’articolo 517 codice penale,
che avevano escluso la rilevanza penale di condotte analoghe a quella in esame.
97
b- Sentenza Legea n. 13712/2005: consolidamento dell’interpretazione assunta
dalla Suprema Corte di Cassazione: prevalenza dell’origine da un produttore
che controlla il processo rispetto all’origine geografica
Con la sentenza LEGEA la Suprema Corte è tornata sull’argomento del “made in
Italy”81, offrendo nuovi spunti di riflessione sul tema.82
Questa sentenza, che conferma la linea segnata, solo un paio di mesi prima, dalla
pronuncia Fro, trae spunto dal ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli contro
il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la
restituzione di una partita di capi di abbigliamento alla società Legea s.r.l.. Tale società
aveva fatto produrre i suoi capi in Cina e li aveva successivamente importati in Italia,
apponendovi la dicitura “Legea – Italy” oppure solo “Legea”, con una striscia
sottostante con i colori della bandiera italiana e un riquadro con la dicitura “Italy”.
Rispetto alla sentenza FRO del 2 Febbraio 2005 deve rilevarsi innanzitutto che:
-
la
condotta
analizzata
in
entrambe
le
pronunce
consiste
nell’importazione di prodotti, in questo caso capi di abbigliamento
sportivo prodotti all’estero (in Cina);
-
non emergono in tale pronuncia, a differenza del caso degli elettrodi
per la saldatura, elementi che consentano di comprendere quale sia il
rapporto tra la merce (prodotta all’estero) e il titolare del marchio
(italiano) ivi esposto;
81
Cassazione, sez. III penale, 17 febbraio 2005, n. 13712, Legea, in Il diritto industriale, 2005, n. 4, pag.
372 e ss.
82
Cfr. M. Casucci, La tutela del Made in Italy…, cit., pag. 277 e ss;
98
-
difetta in questo caso un’indicazione completa della ditta italiana,
risultando riportato sui prodotti semplicemente il marchio (Lagea),
accompagnato dalla dicitura “Italy” e per alcuni capi anche da una
striscia riportante i colori della bandiera italiana.
Sottese alla decisione degli organi del Tribunale di Napoli vi erano due diverse
interpretazioni circa la portata del comma 49 dell’articolo 4: da una parte, secondo il
giudice per le indagini preliminari, il bene tutelato dalla norma sarebbe l’interesse del
consumatore a non essere ingannato sulla qualità e provenienza delle merci; dall’altra,
secondo il procuratore, il campo di applicazione della norma in questione sarebbe ben
più ampio di quello dell’articolo 517 codice penale, da essa richiamato solo ai fini della
determinazione della pena, in quanto l’incriminazione contemplerebbe il reato anche
l’utilizzo di segni che potrebbero fuorviare il consumatore quanto alla reale origine
(geografica) del prodotto.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore, rilevando che la qualità dei
prodotti dipende dall’identità del produttore e non dall’ambiente geografico di
fabbricazione. Il comportamento della Legea s.r.l. non ha integrato il reato di cui
all’articolo 4, comma 49, legge n. 350, poiché i prodotti tessili, così importati, non
recavano alcuna falsa o fallace indicazione sulla origine imprenditoriale, l’unica
rilevante per la qualità dei prodotti. Le etichette contenevano l’indicazione veritiera
sulla identità del produttore e sulla sua nazionalità italiana, a nulla rilevando che non
fosse indicato anche il luogo di fabbricazione (cinese), “giacchè i capi di abbigliamento
sportivo e in genere i prodotti tessili non sono identificabili in relazione alla origine
geografica, atteso che la loro qualità è assicurata dalla materia prima usata e dalla
99
tecnica produttiva e non certo dall’ambiente territoriale dove il processo produttivo si
svolge”.
Nel giungere a queste conclusioni la Suprema Corte ha in primo luogo ricordato che
l’oggetto giuridico dell’articolo 517 codice penale è la tutela dell’ordine economico,
comprensivo sia della libertà ed affidamento del consumatore, sia della protezione del
produttore dalla illecita concorrenza, per poi sottolineare che, in base alle sentenze n.
2500 del 1999 (Thun) e n. 1263 del 2005 (Fro), l’incriminazione garantisce l’origine e
la provenienza della merce, non già da un determinato luogo, ma da un determinato
produttore “il quale, coordinando giuridicamente, economicamente e tecnicamente il
processo produttivo, assicura la qualità del prodotto”. In tal senso “lo strumento che
rassicura il mercato sulla qualità del prodotto è il marchio, registrato o no, che si
configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di
una denominazione. Come è noto, la funzione tradizionale del marchio è triplice,
perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce
come richiamo per la clientela ovverosia come suggestione pubblicitaria”.
Nel caso dei prodotti industriali tale triplice funzione, assicurata dal marchio, non è
modificata neppure dalla de-localizzazione del processo produttivo, in cui le tecniche di
produzione sono imposte e controllate dall’impresa madre. Al contrario, per i prodotti
agro-alimentari la qualità è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel
quale sono coltivati, trasformati o elaborati. Per cui la Corte effettua una nuova
distinzione tra prodotti industriali tout court e prodotti industriali di natura alimentare,
affermando la necessità dell’indicazione di provenienza geografica per i secondi, a
differenza dei primi, per i quali ciò che conta è la provenienza imprenditoriale.
100
La Suprema Corte nella motivazione evidenzia i profili di novità sul tema “made in
Italy”, introdotti dalla legge finanziaria del 2004, individuando, oltre all’aspetto già
illustrato dalla sentenza FRO (estensione del momento consumativo del reato anche alla
semplice presentazione delle merce in dogana), altri due aspetti:
-
l’estensione della tutela penale anche ai prodotti agricoli, oltre che ai
prodotti industriali ed alle opere dell’ingegno, già indicate
nell’articolo 517 codice penale, dato che il comma 49 dell’articolo 4
non fa riferimento ai soli prodotti industriali;
-
l’estensione delle condotte rilevanti. Se la Corte ha individuato una
sostanziale similitudine fra la condotta tipica del reato di cui
all’articolo 517 codice penale e la “fallace indicazione” dell’origine o
provenienza di cui al comma 49, ha però evidenziato che la condotta
tipica del nuovo reato comprende anche la “falsa indicazione” della
provenienza (e non più solo la fallace), non contemplata dall’articolo
517 codice penale, benchè assimilabile a quella di cui all’articolo 474
codice penale: ferma la differenza che il delitto di cui al comma 49
non si perfeziona mediante contraffazione o alterazione del marchio.
I punti di collegamento individuati fra le due norme codicistiche
hanno portato la Corte ad attribuire al reato introdotto dalla legge n.
350 una duplice oggettività giuridica: tutela dell’ordine economico e
tutela della fede pubblica.
Sulla base di queste premesse la Corte ha delineato una ricostruzione sistematica degli
ambiti di tutela penale in materia di proprietà industriale, individuando tre fattispecie
penali, così distinte:
101
1- il reato di cui all’articolo 474 codice penale, che punisce le condotte di
commercializzazione di prodotti industriali (e opere dell’ingegno) con marchi o
segni distintivi “contraffatti o alterati”;
2- il reato di cui all’articolo 517 codice penale, che punisce le condotte di
commercializzazione di prodotti industriali (e opere dell’ingegno) con marchi e
segni distintivi “fallaci”, vale a dire atti a trarre in inganno sull’origine e la
provenienza o qualità del prodotto, a prescindere dalla registrazione o dal
riconoscimento giuridico degli stessi segni distintivi;
3- il reato di cui all’articolo 4 comma 49, legge n. 350 del 2003, che punisce le
condotte di commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di
origine o provenienza falsa, ovvero non corrispondente alla realtà, oppure fallace,
cioè atta a trarre in inganno sull’origine o sulla provenienza medesima (anche in
questo caso, a prescindere dalla registrazione o dal giuridico riconoscimento dei
segni distintivi), dovendosi ritenere questa nuova fattispecie di reato assorbente
rispetto al reato di cui all’articolo 517 codice penale – fattispecie residuale per
espresso dettato normativo: “se il fatto non è preveduto come reato da altre
disposizioni di legge” - ad eccezione della commercializzazione delle sole opere
dell’ingegno contraddistinte con marchi o segni distintivi fallaci.
Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte dopo l’analisi della norma introdotta dalla
legge n. 350 sono abbastanza sorprendenti. Secondo la Corte il richiamo contenuto nel
comma 49 dell’articolo 4 alle norme comunitarie sull’origine sarebbe limitato a quei
prodotti per i quali le caratteristiche siano collegate al territorio, e cioè ai prodotti
agricoli.
102
Questa lettura sembra forzata, in quanto prescinde da un’interpretazione obiettiva e
sistematica della norma, per essere utilizzata a sostegno dell’allora vigente
giurisprudenza, che aveva difficoltà a svincolare la nozione di origine rispetto a quella
di qualità. Altrettanto opinabile è il rilievo secondo cui le norme sull’origine avrebbero
una valenza solo ai fini delle regole doganali, in quanto non si comprenderebbe il
motivo del richiamo effettuato dal legislatore italiano83.
In una nota a commento della sentenza n. 13712, Sirotti Gaudenzi84 rileva che “nel caso
in cui si effettuino lavori su commissione il sub –produttore dovrà attenersi alle regole
tecniche impartite dal committente, giacchè l’attività del primo rappresenta una
operazione meramente esecutiva sulla base delle indicazioni che giungono da chi
commissiona il lavoro, il quale sarà ben legittimato a contraddistinguere il suo
prodotto con il suo segno distintivo”. Però, come evidenzia Casucci85, “non emergono
(…) dalla pronuncia di legittimità elementi che consentano di comprendere quale sia il
rapporto tra la merce prodotta all’estero ed il titolare del marchio italiano ivi
apposto…ciò che conta per questa pronuncia della Suprema Corte è l’assunzione di
responsabilità consistente nell’apposizione del proprio segno distintivo, piuttosto che
l’effettiva esistenza di un rapporto tra fabbricante estero e produttore italiano che
consenta a quest’ultimo di dirigere e/o controllare il processo produttivo”. Secondo
l’autore, questa caratteristica differenzia la sentenza n. 13712 dalla sentenza 1263, che
invece aveva sottolineato la necessità della ricorrenza di un rapporto di fatto fra
fabbricante estero ed impresa italiana.
83
Cfr. F. Di Gianni, Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine…, cit., pag. 24 e ss.
A. Sirotti Gaudenzi, in La nozione comunitaria di “origine”radica nel territorio solo piante e animali,
Notiziario giuridico telematico.
85
M. Casucci, L’ulteriore evoluzione interpretativa della Cassazione sul made in Italy, in Rivista il diritto
industriale, 2005, fasc. n. 4, pag. 377 e ss.
84
103
La Corte sembra dunque risolvere in modo schematico la questione relativa al caso
concreto da essa esaminato, sostenendo che la qualità dei prodotti in oggetto deriva
dall’affidabilità tecnica del produttore in senso giuridico e non dal territorio di
fabbricazione e che le etichette ed i cartellini dei capi in sequestro contenevano
l’indicazione veritiera sull’identità del produttore (la società LEGEA) e sulla nazionalità
del medesimo (italiana), a nulla rilevando la mancata indicazione del luogo di
fabbricazione (cinese).
Per la Corte, in mancanza dell’utilizzo del segno distintivo “made in Italy”, per la cui
disciplina concreta difetta il regolamento attuativo previsto dal legislatore del 2003,
sarebbe carente il fumus del reato ipotizzato.
Quanto alla irrilevanza dell’”indicazione del luogo di fabbricazione materiale” sul
prodotto importato, tale ultima pronuncia non si discosta dalla sentenza Fro.
Desta però qualche perplessità l’assenza, in motivazione, di una adeguata valutazione
della veridicità dell’indicazione del nome del produttore in senso giuridico. Nella
sentenza Fro, la Suprema Corte censura l’omessa valutazione da parte del Tribunale del
riesame degli elementi di fatto utili a considerare la veridicità dell’indicazione di
provenienza dal produttore, indicando come parametri di valutazione la ricorrenza di
una situazione di controllo di fatto o di diritto da parte della società italiana sulla società
straniera e l’effettiva ricorrenza di procedure di controllo del processo produttivo, al
fine di consentire una effettiva assunzione di responsabilità sotto il profilo della qualità
della merce su cui viene apposto il marchio.
Nel caso Legea, invece, la Corte pare quasi ritenere superflue queste verifiche,
limitandosi a citare la ricorrenza di “un qualche controllo sulla tecnica di
fabbricazione” da parte del produttore italiano e così implicitamente considerando,
104
quale unico elemento rilevante, l’assunzione di responsabilità fatta dal produttore con
l’apposizione della propria denominazione sociale o del proprio marchio: il che è come
sostenere che il reato non sussiste in ogni caso in cui il produttore italiano apponga il
proprio segno distintivo al prodotto fabbricato all’estero.
In altre parole ciò che conta per questa pronuncia della Suprema Corte è l’assunzione di
responsabilità consistente nell’apposizione del proprio segno distintivo, piuttosto che
l’effettiva esistenza di un rapporto tra fabbricante estero e produttore italiano che
consenta a quest’ultimo di dirigere e/o controllare il processo produttivo.
Mentre la sentenza Fro sembrava sottolineare la necessità di evitare l’utilizzazone
indiscriminata di segni che inducessero a ritenere una provenienza italiana del prodotto,
verificando la ricorrenza di un rapporto di fatto tra fabbricante estero ed impresa italiana
che consentisse di ritenere quest’ultima come produttrice in senso giuridico del bene, la
sentenza Legea pare ritenere superflui tali verifiche, considerando sufficiente la
rivendicazione delle merci sequestrate in dogana da parte di un’impresa titolare del
marchio che sia italiana.
Le due sentenze sembrano pertanto sposare due linee diverse, l’una più attenta alla
verifica della provenienza, anche se solo giuridica, delle merci (e dunque più in linea
con le motivazioni di fondo che hanno portato il legislatore all’introduzione della
novella contenuta nella finanziaria 2004), l’altra più legata al tradizionale canone
applicativo dell’articolo 517 codice penale, come norma che svincola completamente
l’uso del segno distintivo dalle verifiche in ordine alla veridicità della provenienza
dichiarata.
105
c- Sentenza Ingam n. 34103/2005: prima pronuncia sulla dicitura “made in Italy”:
prevalenza della provenienza geografica in assenza dell’indicazione del
produttore
La terza sentenza in ordine cronologico86 relativa all’articolo 4, comma 49, legge
finanziaria 2004 è la pronuncia del 23 settembre 2005 concernente l’illecita
commercializzazione di magliette recanti “made in Italy” provenienti dalla Romania e
dirette a una società italiana.
La motivazione di tale sentenza è particolarmente chiara e completa, in quanto tutti gli
aspetti legislativi e giurisprudenziali relativi all’origine dei prodotti sono stati esaminati
in una chiave definita, da alcuni commentatori alla sentenza, di stampo
“manualistico”87.
Tale sentenza risulta fondamentale nel panorama delle pronunce della Corte di
Cassazione relative al “made in Italy” poiché, per la prima volta, la Suprema Corte,
come essa stessa riconosce, affronta un caso in cui è apposta sui prodotti un’etichetta
“made in Italy” e non vi è stato il semplice uso di segni, figure o quanto altro possa
genericamente richiamare l’origine italiana dei prodotti (come Italy, o la bandiera
italiana, o il nome di una località italiana).
In tutti i casi precedenti la violazione contestata verteva, infatti, non sull’utilizzo di tale
esplicita locuzione, bensì sull’apposizione di scritte a vario titolo attinenti alla
provenienza o all’origine del prodotto: così in un caso la scritta richiamava il nome
dell’azienda (italiana) seguita dalla dicitura “Bolzano Italy”, in un altro il nome
86
Cassazione, sez. III penale, 19 aprile 2005, n. 34103, Ingam, in Il diritto industriale, 2006, n. 3, pag.
224 e ss.
87
In tal senso G. De Maio, Marchio d’origine, tutela della qualità: (nota a sentenza Cassazione, sez. II
penale, 19 aprile 2005, n. 34103) , in Diritto e Giustizia, 2005, fasc. n. 43, pag. 74 e ss.
106
dell’azienda era seguito dall’indirizzo e dalla dicitura “Verona Italy” ed in un terzo caso
l’indicazione “Italy” era posta accanto al nome dell’azienda, il quale era presente anche
su un cartellino separato con una striscia sottostante recante i colori della bandiera
italiana e un riquadro con la dicitura “Italy”.
Il caso in esame, quindi, riguarda l’uso di una falsa (non fallace) indicazione di
provenienza (“made in Italy”) ai sensi dell’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003
(c.d. finanziaria 2004).
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte verteva su un lotto di magliette prodotte in
Romania per conto e sotto stretto controllo della società italiana Ingam s.p.a. (di
Canosa, Puglia), recanti l’etichetta “made in Italy”.
In particolare la società Ingam aveva fornito alla società rumena Carriere s.r.l. i
macchinari e il know how per la lavorazione e la confezione delle magliette.
Nello stabilimento della Ingam in Puglia avveniva la creazione dei modelli, la
realizzazione degli stampi, la macchiettatura del filato, mentre (queste le parole della
Corte) “l’attività fondamentale rispetto alla quale tutte le altre sono propedeutiche,
ossia l’assemblaggio definitivo e la realizzazione del capo indossabile, veniva compiuto
in Romania”.
La Suprema Corte ha concluso che, nel caso di specie, l’apposizione della dicitura
“made in Italy” sulle magliette della Ingam è stata illecita. Ciò in quanto ai sensi
dell’articolo 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 la dicitura “made in Italy” può
essere usata solo se il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia è avvenuta
l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed
effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione
107
di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione, ai sensi del codice doganale comunitario (Regolamento CE 2913/92).
Per la Corte le magliette Ingam non sono state integralmente prodotte nel territorio
italiano né in Italia è avvenuta l’ultima trasformazione, conclusasi con la fabbricazione
di un prodotto nuovo.
Al riguardo è di particolare importanza l’inciso della Corte, con il quale individua la
lavorazione sostanziale sufficiente a far ritenere un prodotto di abbigliamento originario
di un Paese e cioè “l’assemblaggio definitivo e la realizzazione del capo indossabile”
che nel caso concreto erano stati eseguiti in Romania.
La Suprema Corte aggiunge che sarebbe invece stata lecita (conformemente alle prime
due sentenze sopra citate) l’apposizione sulle magliette Ingam di diciture tipo “Ingam Italy” o “Igam – Canosa”, dato che queste sarebbero state indicazioni indicanti soltanto
la veritiera origine imprenditoriale italiana del prodotto.
La Corte, in particolare, sottolinea come nel caso in esame non fosse stato inserito
soltanto il nome e la sede del produttore italiano, ma anche (o soltanto) la scritta
“prodotto in Italia” o “made in Italy”. Tale espressa dicitura assume un chiaro
significato comunicativo agli occhi del consumatore, cioè di un’indicazione attinente
all’origine del prodotto, da ritenersi fabbricato in Italia. Dinanzi a tale chiara
indicazione, la circostanza che il prodotto sia stato fabbricato all’estero per conto di un
produttore italiano e che assicuri la qualità propria di quel produttore sarebbe
irrilevante. Il consumatore, infatti, potrebbe essere indotto ad acquistare un prodotto
proprio e solo in quanto fabbricato (o non fabbricato) in un determinato luogo
geografico e quindi soltanto in quanto effettivamente “prodotto in Italia” ( o “non
prodotto in Italia”) o prodotto in qualche altra località e ciò in base alle più svariate
considerazioni soggettive, non necessariamente attinenti alla qualità del prodotto stesso.
108
Di fatto l’apposizione della scritta o dell’etichetta “prodotto in Italia o “made in italy”
su un prodotto fabbricato all’estero risulta di per sé idonea a trarre in inganno il
consumatore.
La Corte ha sottolineato, infine, come anche se tale sentenza sia stata pubblicata dopo
l’entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005 (così detto “decreto sulla
competitività”) che ha modificato l’articolo 4 comma 49 della legge finanziaria, tuttavia
non ne ha applicato le disposizioni, in quanto i fatti oggetto del giudizio erano
precedenti.
La pronuncia della Corte è apprezzabile per la chiarezza argomentativa, ma suscita
perplessità quanto al titolo di reato configurato, perchè la condanna è intervenuta ai
sensi non dell’articolo 4 comma 49 della Finanziaria 2004, ma dell’articolo 517 codice
penale. Siffatta conclusione, resa ancor più oscura dall’assenza di motivazione sul punto
non considera, infatti, né la clausola di sussidiarietà della previsione codicistica, né la
circostanza che l’indicazione “made in Italy” su prodotti interamente fabbricati
all’estero non sia tanto punibile ai sensi dell’articolo 517 codice penale, quanto piuttosto
“falsa” alla stregua dell’articolo 4 comma 49 della Finanziaria 2004.
Alla luce dei rilievi operati già nella sentenza Legea circa l’autonomia di quest’ultima
previsione rispetto a quella codicistica, con il connesso avanzamento di tutela, nel caso
di specie sarebbe stata più corretta la esplicita configurazione del reato quale previsto
dall’articolo 4 comma 49 della Finanziaria 2004. 88
88
Cfr. L. Mandelli, La problematica tutela del “made in Italy” tra diritto vigente e prospettive di riforme,
in Rivista diritto penale e processo, 2006, fasc. n. 5, pag. 605 e ss.
109
4- LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 14
MARZO
2005,
N.
35
(C.
D.
“DECRETO
COMPETITIVITA’”),
CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80
L’insistenza della Suprema Corte di Cassazione nella precedente linea applicativa non
ha riscosso il parere favorevole di quanti, animati dall’intenzione di proteggere il
mercato nazionale e l’italianità delle merci dall’invasione dei così detti “falsi”, avevano
ravvisati nell’intervento del legislatore del 2003 la possibilità di dare vita a un’incisiva
lotta alla contraffazione89.
A conferma di tale apprezzamento critico degli effetti della novella del 2003 il
legislatore è nuovamente intervenuto il 14 marzo 2005 con il decreto legge n. 35 del
2005 recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano d’azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale”90, convertito nella legge n. 80 del 14 maggio del
2005. Con tale decreto sono state previste alcune disposizioni dirette a potenziare il
sistema punitivo posto a tutela dei diritti di privativa industriale ed intellettuale e sono
state introdotte rilevando novità in materia di origine e provenienza dei prodotti.
L’articolo 1 del decreto, punto 7, ha introdotto, in capo all’acquirente, l’onere di
accertare la legittima provenienza dei beni che intende acquistare, qualora - sulla base
della qualità del prodotto oppure della condizione di chi lo offre in vendita oppure
dell’entità del prezzo - sia possibile ritenere “che siano state violate le norme in materia
d’origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale”.
89
Si veda supra capitolo 2, § 1, lettera a), pag. 65 e ss .
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62, 16 marzo 2005 e n. 111, 14 maggio 2005, Supplemento
ordinario.
90
110
La violazione dell’onere suddetto comporta la responsabilità amministrativa
dell’acquirente, qualora non ricorrano gli estremi della responsabilità penale ex articolo
712 codice penale ( rubricato “Acquisto di cose di sospetta provenienza”), comportando
una ammenda dell’importo massimo di 10 mila euro.
Si tratta di una disposizione fortemente penalizzante per il consumatore, al quale si
chiede di presumere, in base ad elementi quali la condizione di chi offre l’oggetto o
l’entità del prezzo, se siano state violate le norme in materia fra l’altro di marchi di
origine. È ovvio che a meno che non si voglia attribuire agli elementi presuntivi appena
indicati il valore di prova della violazione della normativa sui marchi di origine, il
consumatore dovrebbe avere cognizione di tale normativa ed in particolare della portata
delle indicazioni false o fallaci. È però evidente che tali cognizioni richiedono
valutazioni ed analisi, alla luce delle regole di origine non preferenziale, difficili anche
per esperti della materia.91
L’introduzione di un illecito amministrativo punitivo che sanziona espressamente il
cliente, che incautamente acquista prodotti contraffatti se, da un lato, può contribuire a
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’effettivo disvalore della contraffazione dei
prodotti industriali e dei segni distintivi, dall’altro lato non sembra possa costituire un
valido strumento di contrasto alla produzione e al traffico dei prodotti contraffatti,
sempre più al centro degli interessi della criminalità organizzata.92
Il punto 9 dell’articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 prevede, poi, che la
disposizione dell’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sia
91
Cfr. F. Di Gianni, Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine…, cit., pag. 50.
Cfr. F. Cingari, Misure punitive per il rilancio della competitività: tra repressioni dell’incauto acquisto
di prodotti “taroccati” e tutela del “made in Italy”, in Diritto penale e processo, 2005, fasc. n. 11, pag.
1342.
92
111
integrata con l’inserimento dopo le parole “fallaci indicazioni di provenienza”, delle
parole: “o di origine”93.
Il punto 10, inoltre, innalza in modo considerevole il limite edittale massimo della multa
prevista dall’articolo 517 codice penale dagli originali 1032 euro a ventimila euro.
Tali innovazioni sono un segnale importante della volontà del legislatore di rafforzare il
sistema punitivo diretto a contrastare il fenomeno della contraffazione dei prodotti
industriali e dei marchi. Tuttavia, occorre interrogarsi sulla adeguatezza delle
disposizioni poste in essere dal Governo e dal Parlamento rispetto alla portata e alle
caratteristiche che nel tempo ha assunto il fenomeno della contraffazione. In particolare
bisogna chiedersi se l’introduzione di un illecito amministrativo punitivo, che sanziona
espressamente il cliente che incautamente acquista prodotti “taroccati” e l’aumento del
tetto massimo della pena pecuniaria dell’articolo 517 codice penale possano costituire
un efficace strumento di controllo della produzione e del traffico di prodotti contraffatti,
sempre più al centro degli interessi della criminalità organizzata.
Infine, occorre chiedersi se con l’introduzione del punto 9 dell’articolo 1 della citata
legge il legislatore sia riuscito finalmente a superare le incertezze nascenti dalla
controversa disciplina relativa al “made in Italy” prevista dal comma 49 dell’articolo 4
legge n. 350/2003.
Sembrerebbe, infatti, a una prima analisi che l’entità della pena pecuniaria, nei limiti
dell’aumento introdotto, non sia decisivo al fine di scoraggiare l’importazione o il
commercio di prodotti contraffatti. La “sanzione” più rilevante a tal fine, scaturente dal
93
Nuovo testo comma 49 articolo 4 legge 350/03, in Guida al diritto, Dossier mensile, 2004, fasc. n. I,
pag. 7 e ss: “ l’importazione e l’esportazione a fini della commercializzazione ovvero della
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o provenienza costituisce
reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale (….)”;
112
procedimento penale, resta il sequestro e la successiva confisca della merce contraffatta,
permanendo sostanzialmente invariate le difficoltà relative all’esercizio dell’azione
penale nei confronti dei soggetti effettivi responsabili, ai livelli più elevati, del
fenomeno della contraffazione. 94
94
In tal senso M. Casucci, La tutela del “made in Italy”…, cit., pag. 280.
113
a- In particolare il punto 7: l’incauto acquisto di prodotti contraffatti
Tra le disposizioni dirette al rafforzamento della lotta alla contraffazione previste dal
“decreto competitività” emerge quella che introduce un illecito amministrativo diretto a
colpire l’incauto acquisto di prodotti contraffatti.
Per approfondire l’analisi del punto 7 è necessario in primo luogo chiedersi quando si
possano ritenere violate “le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti”.
Sembrerebbe che il Governo abbia voluto smentire l’interpretazione assunta dalla
Suprema Corte, nelle sue ultime sentenze, del concetto di “origine” delle merci.
Si ritiene, infatti, che si abbia violazione delle norme sull’origine in caso di mancato
rispetto dei criteri di attribuzione della stessa in base alla normativa sull’origine
doganale. Allo stato attuale della disciplina si può ritenere violata la normativa
sull’origine dei prodotti qualora il prodotto porti la dicitura “made in…” (o altra
equipollente) seguita dall’indicazione di un determinato paese, ma non sia avvenuta in
quello
stesso
Paese
“l’ultima
trasformazione
o
lavorazione
sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si
sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione” ex articolo 24 del codice doganale
comunitario.
Per quanto concerne il riferimento alla “provenienza”, contenuto nella stessa previsione
introdotta dal punto 7 possono essere attribuiti a questo termine tre differenti significati:
a. esso può riferirsi agli indicatori di provenienza ammessi a forme di tutela
dalla normativa vigente (DOP, IGP e simili);
114
b. esso può riferirsi alla provenienza del bene da un determinato produttore
(articolo 517 codice penale);
c. esso può riferirsi alla provenienza di un prodotto da un determinato paese;
in tal caso il termine sarebbe utilizzato quale sinonimo di “origine”, con la
conseguenza che la violazione andrebbe valutata alla stregua delle norme
di origine doganale.
Inoltre la presenza della clausola di riserva, estesa nei confronti di qualunque reato95, e
le analogie con la fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza (così detto
incauto acquisto) prevista dall’articolo 712 codice penale96, non rende agevole
l’individuazione della sfera di operatività dell’illecito amministrativo di nuovo conio.
A prima vista, si potrebbe ritenere che la nuova fattispecie si limiti a delineare
un’ipotesi speciale rispetto all’articolo 712 codice penale, dati i molti profili di
omogeneità tra le due figure. Le condotte descritte dalle due norme sono omogenee,
mentre diversi sono gli oggetti materiali: quello dell’articolo 712 codice penale è
costituito dalla provenienza da qualsiasi reato della “cosa”, mentre quello dell’illecito
amministrativo sembrerebbe limitato solo alla provenienza da alcuni reati, come, ad
esempio, quelli previsti dagli articoli 473, 474, 517 codice penale e quelli a tutela del
diritto d’autore, previsti dagli articoli 171 e ss della legge n. 633 del 1941.
Sennonché, la presenza della clausola di riserva non consentirebbe l’applicazione della
fattispecie amministrativa speciale di nuovo conio. Infatti, i casi da essa previsti
rientrerebbero per definizione anche nella fattispecie generale di cui all’articolo 712
95
Cfr. sulle clausole di riserva in generale A. Magliaro, voce Concorso di norme (diritto penale), in
Enciclopedia del diritto, 1961, pag. 547 e ss.; G. A. De Francesco, Lex specialis, Milano, 1980, pag. 140 e
ss.; G. A. De Francesco, voce Concorso apparente di norme, in Digesto delle discipline penalistiche, vol.
II, Torino, Utet, 1988, pag. 425 e ss.
96
Sulla contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza e sulla distinzione dal delitto di
ricettazione, cfr. nella manualistica F. Mantovani, cit., pag. 257 e ss.; G. Fiandaca – E. Musco, Diritto
penale…, cit., pag. 238 e ss.
115
codice penale e poiché la riserva impone l’applicazione della norma che configura
l’illecito penale, la norma speciale che configura l’illecito amministrativo sarebbe
destinata a rimanere lettera morta nella totalità dei casi ad essa riconducibili.97
In realtà la fattispecie descritta dal punto 7 non costituisce un’ipotesi speciale della
contravvenzione di incauto acquisto, ma un’ipotesi diversa dotata di un’autonoma sfera
di operatività, in quanto accanto ad elementi strutturali omogenei le due fattispecie
presentano alcune significative differenze sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
In primo luogo, l’oggetto materiale della contravvenzione prevista dall’articolo 712
codice penale è individuato in riferimento a “cose” pervenute attraverso un reato nella
titolarità o disponibilità di chi poi le cede attraverso un reato98. In sostanza, con
l’espressione “proveniente da reato” l’articolo 712 codice penale si riferisce ad un
illecito che abbia determinato il trasferimento della cosa da una sfera giuridica esterna a
quella di colui che poi effettua la vendita o comunque il trasferimento.
Nell’illecito amministrativo, invece, l’oggetto materiale è individuato in riferimento a
reati come quelli previsti dagli articoli 473, 474, 517 codice penale, che non possono
essere considerati capaci di far pervenire la cosa nella sfera giuridica di colui che poi la
cede. In effetti, i reati di questo tipo, se possono portare a considerare illecite le “cose”
alle quali si riferiscono, essendo offensivi della fede pubblica, dell’economia nazionale,
dei diritti di privativa industriale o intellettuale, non determinano tuttavia il
trasferimento di quelle “cose” da una determinata sfera giuridica a quella di coloro che
poi le mettono in vendita: e quindi non determinano la loro “provenienza” da un reato.
In secondo luogo, mentre la contravvenzione prevista dall’articolo 712 codice penale si
riferisce solo alle ipotesi di acquisto di cose la cui provenienza illecita è stata accertata
97
Per un approfondimento sul rapporto tra diritto amministrativo e diritto penale cfr. T. Padovani, Diritto
penale del lavoro. Profili generali, Milano, 1983, pag. 140-141.
98
Cfr. M. Papa, La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e
norme disciplinanti la circolazione di “cose illecite”, in Rivista italiana diritto e processo penale, 1985,
pag. 756 e ss.
116
dal giudice99, la fattispecie descritta dal punto 7, che fa riferimento a “cose che
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza
dei prodotti (…)”, sembrerebbe riferirsi a ipotesi in cui la provenienza illecita delle cose
acquistate è solamente oggettivamente sospetta. Più precisamente, mentre la
contravvenzione prevista dall’articolo 712 codice penale richiede la certezza oggettiva
della provenienza illecita della cosa ricevuta che, pur non dovendo essere stata accertata
con sentenza passata in giudicato, deve essere accertata dal giudice incidenter tantum, ai
fini della sussistenza dell’illecito amministrativo non occorre la certezza oggettiva della
illecita provenienza della cosa, essendo sufficiente l’oggettiva sospettabilità della loro
illiceità.
Sotto il profilo soggettivo, poi, va rilevato che mentre la fattispecie penale è imputabile
unicamente a titolo di colpa,100 la fattispecie in esame, ai sensi dell’articolo 3 legge n.
689 del 1981, è imputabile alternativamente a titolo di dolo o di colpa. Pertanto,
l’illecito amministrativo punitivo risulterà integrato sia nell’ipotesi in cui l’acquirente
sia consapevole della natura sospetta del prodotto che acquista sia nell’ipotesi in cui,
pur non essendone consapevole, egli avrebbe potuto rendersi conto del carattere
“sospetto” del prodotto.
Con l’introduzione di un illecito amministrativo, che sanziona espressamente l’incauto
acquisto di prodotti contraffatti, il legislatore sembra aver eliminato ogni dubbio circa
l’impossibilità di ricondurre tale ipotesi nell’ambito dell’articolo 712 codice penale. Del
resto, l’utilizzo della sanzione amministrativa per reprimere la condotta di chi
incautamente acquista prodotti contraffatti non solo appare più proporzionata di quella
99
Cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale…, cit. , pag. 431; F. Mantovani, Diritto penale..., cit. , pag.
257.
100
Cfr. F. Mantovani, Diritto penale…, cit., pag. 260.
117
criminale al reale disvalore del fatto101, ma sembra anche in grado di sensibilizzare
l’opinione pubblica rispetto alla pericolosità di un fenomeno in inarrestabile espansione
come quello della contraffazione dei prodotti industriali, senza peraltro contribuire ad
accrescere il già pesante carico di procedimenti penali.
La sanzione amministrativa pare destinata a svolgere, accanto alla tipica funzione di
prevenzione generale, anche una funzione lato sensu risarcitoria, considerato che il
comma 8 dell’articolo 1 del decreto stabilisce che le somme derivanti dall’applicazione
della sanzione vengano destinate dallo Stato alla lotta alla contraffazione.
101
Cfr. S. Fiore, voce Diritto d’autore (reati in materia di), in Digesto delle discipline penalistiche,
aggiornato, 2004, pag. 195.
118
b- In particolare il punto 9: le indicazioni di provenienza e quelle di origine nella
prospettiva della tutela penale del “made in Italy”
Altra significativa disposizione è contenuta nel punto 9 dell’articolo 1 del decreto legge
poi convertito nella legge n. 80 del 2005, con la quale il legislatore ha novellato
l’articolo 49 comma 4 della legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004), attribuendo
rilevanza - oltre alle “false o fallaci indicazioni di provenienza” delle merci - anche alle
“false o fallaci indicazioni di origine” delle stesse.
È tutt’altro che agevole ricostruire il significato dell’attribuzione di rilevanza accanto
alle “false o fallaci indicazioni di provenienza” delle merci, anche alle “false o fallaci
indicazioni di origine” delle stesse.
Nella Relazione governativa al così detto “decreto competitività”102 si legge che la
novella di cui al comma 9 dell’articolo 1 sarebbe stata introdotta tenendo conto anche
delle recenti sentenze della Corte di Cassazione103, che avevano individuato nel
mancato riferimento alla nozione di “origine”, nel primo periodo del comma 49
dell’articolo 4 della finanziaria 2004, un argomento a favore dell’inapplicabilità
dell’articolo 517 codice penale alle ipotesi di così detta produzione su commissione.
Sembrerebbe, dalla relazione, che il Governo abbia voluto tener conto delle sentenze
della Corte al fine di smentire l’interpretazione assunta: la Cassazione riteneva che il
mancato riferimento alla nozione di origine, nel primo periodo del comma 49,
102
Il testo della relazione, in Guida al diritto, 2005, fasc. n. 13, pag. 55 e ss., in relazione al comma 9
dell’articolo 1 recita: “Con il comma 9, tenendo conto anche della recente sentenza della corte di
Cassazione, si interviene sulla legge 350 del 2003 ai fini di poter tutelare il “made in Italy” sia tenendo
conto del luogo di produzione dei prodotti (concetto di origine) sia avendo presente il produttore
(concetto di provenienza) (…)”.
103
La Relazione evidentemente si riferisce a Cassazione, Sezione III penale, 2 febbraio 2005, Fro,
sentenza depositata poco più di un mese prima dell’emanazione del così detto “decreto competitività”,
cfr. supra capitolo II, § 2, lettera a, pag. 90 e ss.
119
comportasse l’attuale legittimità di condotte di importazione di merci, non
materialmente fabbricate in Italia, ma comunque riportanti indicazioni dalle quali trarre
una “paternità” italiana delle merci medesime.
Da questo punto di vista, la novella del 2005 finirebbe per estendere la sfera applicativa
dell’articolo 517 codice penale anche alle ipotesi in cui l’imprenditore nazionale, senza
indicare anche il luogo di materiale fabbricazione dei prodotti, indichi soltanto il proprio
marchio o segno distintivo sui prodotti fabbricati per suo conto all’estero da un terzo
sub-fornitore.
Dal punto di vista sistematico, a questa conclusione sembrerebbe poter condurre anche
il tenore dei commi 12 e 13 dell’articolo 1 della legge che, nella evidente prospettiva di
porre un freno al fenomeno della de-localizzazione della produzione industriale, per un
verso, escludono dalla possibilità di conseguire alcuni incentivi e benefici economici
quelle imprese italiane che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento nel
territorio nazionale di una parte sostanziale delle attività produttive; e, per un altro
verso, consentono di accedere a tali agevolazioni alle imprese italiane che, pur avendo
trasferito all’estero la propria attività, intendono reinvestire nel territorio nazionale.
Sennonché pare altrettanto plausibile ritenere che, con la novella, il legislatore si sia
voluto riferire esclusivamente al costituendo marchio “made in Italy” e abbia voluto
chiarire che l’articolo 517 codice penale si applica all’imprenditore nazionale che, non
avendo la titolarità del marchio in base alla disciplina che verrà dettata dal regolamento
di futura emanazione, lo apponga sui proprio prodotti “non originari dall’Italia ai sensi
della normativa europea sull’origine”.
Più precisamente, si potrebbe pensare che, con l’inserimento dell’espressione “o di
origine”, il legislatore abbia voluto semplicemente chiarire che le condotte di
120
importazione ed esportazione ai fini della commercializzazione assumano rilevanza
penale ai sensi dell’articolo 517 codice penale, anche se riguardino false o fallaci
indicazioni legate all’utilizzo del marchio “made in Italy”, di cui al secondo periodo
dell’articolo 4, comma 49 legge n. 350 del 2003.
In effetti, il comma 49 dell’articolo 4, mentre nel primo periodo attribuiva rilevanza alle
sole false o fallaci indicazioni di provenienza, nel secondo periodo, come ipotesi di falsa
o fallace indicazione, si riferiva alla stampigliatura “made in Italy” su prodotti non
originari dall’Italia secondo la normativa europea in tema di origine, costituente per
l’appunto una ipotesi di falsa o fallace indicazione di origine e non di provenienza.104
Da questo punto di vista, la funzione della novella sarebbe limitata a chiarire la portata
dell’oggetto materiale delle condotte incriminate nel primo periodo del comma 49
dell’articolo 4.
A sostegno di questa interpretazione si potrebbero addurre almeno due plausibili
ragioni. In primo luogo, la stessa Relazione governativa al decreto competitività, che
afferma come il comma 9 dell’articolo 1 interviene sulla finanziaria 2004 al fine di
tutelare il “made in Italy”, “sia tenendo conto del luogo di produzione dei prodotti
(concetto di origine) sia avendo presente il produttore (concetto di provenienza)”,
sembrerebbe mettere in relazione la novella con l’utilizzo del marchio “made in Italy”.
In secondo luogo, appare difficile ipotizzare che il legislatore, attraverso una novella dal
significato così ambiguo, abbia voluto modificare, in modo così incisivo, una disciplina
come quella in tema di trasferimento e cessione del marchio (articolo 15 R.D. n.
929/42), peraltro di attuazione di importanti direttive comunitarie105, senza procedere ad
un intervento più organico che coinvolga anche la disciplina civilistica.
104
105
Cfr. G. Martiello, La tutela del “made in Italy”…, cit., pag. 782.
Cfr. Direttiva CEE n. 104 del 1989, si veda supra capitolo 2, § 1, lettera c, pag. 75 e ss.
121
Ecco dunque che occorre verificare al di là delle intenzioni ermeticamente espresse
nella relazione governativa, quale sia l’interpretazione della norma, modificata sul piano
letterale e sistematico, più adeguata tenendo conto anche del diritto vivente e della
realtà socio economica del nostro paese.
A seconda della sua interpretazione, la novella può avere un impatto ben diverso nel
regime giuridico, perché se si assume che la portata effettiva della novella sia legata al
solo istituendo marchio “made in Italy”, poco o nulla pare cambiare rispetto al regime
precedente, anche se essa comporterà sicuramente ulteriori incertezze interpretative per
i soggetti preposti ai controlli dall’Agenzia delle Dogane, in primo luogo, ai pubblici
ministeri ed ai tribunali del riesame, in seconda battuta. Secondo una siffatta
interpretazione, dunque, al di fuori dell’ipotesi legata all’utilizzazione del marchio
“made in Italy”, dovrà ritenersi lecita l’indicazione o il riferimento all’origine
“imprenditoriale” italiana di prodotti materialmente realizzati all’estero, purchè sotto la
responsabilità giuridica, economica e tecnica del produttore italiano.
Molti operatori dei controlli pubblici, invece, hanno interpretato la modifica del punto 9
come espressione dell’intenzione del legislatore di colpire come fallaci o ingannevoli
tutte le ”etichettature” di merci che pur solo con il silenzio, inducano a ritenere “di
origine nazionale” un prodotto in realtà semilavorato all’estero.
Ciò anche alla luce del disposto dell’articolo 30 del codice della proprietà industriale106,
a norma del quale “salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni
internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona
fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni
geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il
106
Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 “Codice della proprietà industriale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, n. 52, 4 Marzo 2005, Supplemento Ordinario n. 28.
122
prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il
prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengano da una
località designata da una indicazione geografica”.
Da questa “variazione”, altrimenti poco spiegabile, data la scarsa differenza semantica
fra i concetti di “origine” e “provenienza”, che lo stesso legislatore ha più volte
mostrato di disconoscere, ma che la Corte di Cassazione vi ha dato peso, i sostenitori
dell’ampliamento della tutela del “made in Italy” hanno quindi tratto conforto per
l’inasprimento della lotta alla così detta “contraffazione” nella sua versione più
integralista. 107
Sennonché l’intervento del decreto competitività non pare adeguato a rafforzare in
modo significativo la lotta a un fenomeno criminale non solo in continua evoluzione ed
espansione, ma anche capace di offendere una pluralità di interessi: da quelli delle
industrie del settore, a quelli del consumatore finale, da quelli dei soggetti costretti a
lavorare senza coperture assicurative e contributive nell’industria della contraffazione, a
quelli dello Stato a combattere l’evasione dell’Iva e delle imposte sui redditi.
Una cosa è certa: il legislatore ha perso un’occasione per eliminare le ambiguità,
difficilmente compatibili con il canone della determinatezza, che caratterizzano anche
l’attuale formulazione del comma 49, articolo 4 della legge 350 del 2003 (c.d.
finanziaria 2004).
107
In tal senso avv. Vito Rubino, La tutela del “made in Italy” dopo la sentenza nr. 2648/2006 della
Corte di Cassazione: considerazioni generali e ricadute nell’ambito delle produzioni alimentari alla luce
delle norme e della giurisprudenza comunitaria, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica
pubblicata su internet.
123
5- FERMO DELLA MERCE IN DOGANA COME MOMENTO ESSENZIALE
PER L’ACCERTAMENTO DELLA LORO PROVENIENZA
Il primo soggetto chiamato ad applicare la normativa in vigore sulle indicazioni di
provenienza delle merci è l’Agenzia delle Dogane.
In caso di dubbio sulla legittimità delle indicazioni di provenienza delle merci si
procederà al fermo amministrativo, per valutare l’eventuale violazione dell’articolo 4,
comma 49 legge n. 350 del 2003 o dell’Accordo di Madrid relativo alla repressione
delle false o fallaci indicazioni nei casi di minore gravità.
I funzionari doganali dovranno far questo anche in casi in cui la merce venga importata
in Italia per la successiva commercializzazione da parte del produttore in senso
giuridico, cioè del titolare del know how produttivo e dei segni distintivi, che ha de –
localizzato all’estero i processi produttivi, pur controllandone i parametri di qualità e
sicurezza.
In questi casi sarà interesse immediato della stessa azienda dimostrare quanto prima
l’esistenza dei presupposti per qualificarsi come produttore delle merci, mediante
documentazione dell’eventuale rapporto di sub-fornitura o dell’avvenuta delocalizzazione produttiva, licenza d’uso dei segni distintivi, attivazione di procedure per
il controllo qualitativo della produzione, ecc..: cioè di tutti quegli elementi, valorizzati
dalla Corte di Cassazione nella sentenza Fro, che consentano di ritenere l’azienda
medesima quale produttore in senso giuridico delle merci presentate in dogana.
In caso di dubbio sull’effettiva sussistenza dei presupposti, l’autorità doganale
demanderà, comunque, il controllo in merito al pubblico ministero competente alla
convalida del sequestro, il quale si troverà di fronte a diverse opzioni:
124
1. convalidare il sequestro e procedere penalmente, nel caso in cui emerga
l’ingannevolezza dell’indicazione di provenienza per difetto o carenza dei
requisiti necessari per ritenere la giuridica provenienza delle merci dal
produttore italiano;
2. non convalidare il sequestro e restituire la merce al produttore/destinatario
italiano, in quanto merce di provenienza italiana, nonostante la materiale
fabbricazione all’estero, se non risultino sussistenti i presupposti di cui
sopra.
Appare pertanto di tutta evidenza che come il combinato disposto della normativa
penale (costituita dall’articolo 517 codice penale e dall’articolo 4, comma 49 legge n.
350 del 2003 come novellato dall’articolo 1 del c.d. decreto competitività n. 35 del
2005) e della regolamentazione in materia doganale, costituiscano innanzitutto un utile
scudo per le aziende italiane dai tentativi di introduzione in Italia di merci recanti
indicazioni di provenienza false o fallaci a danno del “made in Italy”.
Resta peraltro evidente lo scotto da pagare per la presenza di tale forma di difesa, cioè il
rischio di fermo in dogana anche di merci di legittima provenienza. Fermo che, tuttavia,
potrà essere superato con la veloce e completa attività di documentazione della legittima
provenienza delle merci, da proporre alla stessa autorità doganale o, in caso di avvenuto
sequestro, al pubblico ministero competente.
125
6- LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL CODICE DEL CONSUMO (DECRETO
LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206)
Se le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2004 e dal decreto legge 2005 hanno
complicato la normativa in tema di indicazione dell’origine geografica e/o
imprenditoriale dei prodotti, difficoltà ancora maggiori sono state causate da un’altra
recente innovazione, il codice del consumo, per via del contrasto tra questo, l’articolo
517 codice penale e l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli
indicazioni di provenienza.
Le difficoltà derivano dall’impossibilità, da parte delle industrie che hanno una
produzione de-localizzata all’estero, di rispettare contemporaneamente le tre norme
citate.
Con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è stato adottato il codice del
consumo (entrato in vigore il 23 ottobre 2005) che ha introdotto alla lettera c)
dell’articolo 6 l’obbligo di indicare, in modo chiaramente visibile e leggibile, sui
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul
territorio nazionale, le seguenti indicazioni:
1. denominazione legale o merceologica del prodotto;
2. nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell’Unione europea;
3. paese di origine se situato fuori dall’Unione Europea.
Gli obblighi di indicazione previsti dall’Accordo di Madrid e dal nuovo articolo 6
lettera c) del decreto legislativo n. 206/2005, cioè indicare il nome o il marchio o la
126
ragione sociale o la sede del produttore, sono impossibili da rispettare, nel caso di
prodotti fabbricati all’estero da imprese italiane, a fronte della contemporanea necessità
di non indicare l’origine per non violare l’articolo 517 codice penale.
Non si dovrebbe indicare l’origine, per rispettare la sospensione dell’obbligo di
indicazione “made in..” già previsto dall’articolo 6 lettera c) del codice del consumo,
ma rinviato dal decreto così detto “milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2005, n.
273/2005), il cui articolo 31-bis prevede che “l’efficacia della disposizione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c) del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice”.
Indicando solo la sede italiana (o il nome), ai sensi del codice del consumo, senza
specificare che il prodotto non è “made in Italy”, si potrebbe indurre il consumatore a
ritenere erroneamente che il prodotto sia di fabbricazione italiana, cioè fabbricato nel
nostro paese: conseguentemente chi lo produce potrebbe essere accusato di aver
commesso il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto
dall’articolo 517 codice penale.
Le questioni suscitate dal contrasto tra queste norme potrebbero essere superate dalla
prossima entrata in vigore dell’obbligo di indicazione dell’origine, previsto dall’articolo
6 lettera c) del codice del consumo. Tale obbligo si sarebbe dovuto applicare dal 1
gennaio 2007 per via dell’articolo 31-bis del così detto decreto “milleproroghe”, ma la
sua efficacia è sospesa fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione,
previsto dal comma 1 dell’articolo 10: e tale decreto ha scarsissime possibilità di essere
emanato, per via dell’iter complesso previsto dallo stesso codice e dei problemi di
coordinamento con la normativa comunitaria sul mercato interno.
127
Infatti la nuova disposizione del codice del consumo può creare problemi di
compatibilità con l’articolo 23 comma 2 Trattato CE, che statuisce che i divieti di
imporre dazi doganali o tasse di effetto equivalente e di adottare restrizioni quantitative
o misure di effetto equivalente nel commercio tra Stati membri “si applicano ai prodotti
originari dagli stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in
libera circolazione negli stati membri”.
Da questa disposizione si evince che l’Italia non potrebbe bloccare la vendita in Italia di
prodotti non recanti il paese di origine, se messi in libera pratica nella Comunità, in
quanto un tale obbligo violerebbe il disposto dell’articolo 28 del Trattato CE.108
108
Cfr. F. Di Gianni, Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine…, cit., pag. 33.
128
7- SENTENZA
GIORDANI
N.
2648/2006:
IL
RIPENSAMENTO
GIURISPRUDENZIALE SULLA “NON NEUTRALITA’” DELL’ORIGINE
GEOGRAFICA PER ALCUNI PRODOTTI
I principi enunciati dalla sentenza n. 34103/2005, lungi dall’aver trovato definitiva
consacrazione, sono stati, qualche mese dopo, contraddetti dalla pronuncia della terza
sezione della Suprema Corte di Cassazione n. 2648 del 9 novembre 2005, il meglio
conosciuto quale caso Giordani109.
La Corte, pur non disconoscendo quanto sino ad oggi elaborato in materia di estensione
della copertura penale offerta dall’articolo 517 codice penale, ha ritenuto necessario
apportare significative correzioni per tutti quei prodotti che devono, in misura più o
meno ampia, la propria notorietà commerciale al potere evocativo del “made in Italy”.
La sentenza riguarda il sequestro probatorio, confermato dal Tribunale di Trieste, di
alcuni capi di abbigliamento importati dalla Moldavia ad opera della Tasci s.r.l., nella
cui targhetta vi era la dicitura “designed and produced by Tasci srl Roverato Italy”, che
per il pubblico ministero era idonea a trarre in inganno il consumatore circa l’origine e
provenienza del prodotto.
In particolare la Tasci s.r.l. di Rovereto spediva campioni di capi di abbigliamento in
Moldavia per farli ivi produrre dalla società moldava CSM Uniform, con la materia
prima fornita dalla Tasci s.r.l.. In Italia non veniva però compiuta alcuna fase del
processo di produzione dei capi di abbigliamento sequestrati.
109
Cassazione, Sez. III penale, 20 gennaio 2006, n. 2648, Giordani, in Diritto penale e processo, 2006,
fasc. n. 5, pag. 605-613.
129
Il Tribunale di Trieste aveva sviluppato una serie di argomentazioni, per alcuni versi
innovative rispetto alla posizione assunta sin a quel momento dalla giurisprudenza.
Il Tribunale muove dalla considerazione che nella nozione di ordine economico
garantito dall’articolo 517 codice penale rientrerebbe, anche, la tutela dell’affidamento
del consumatore rispetto a segni o diciture mendaci di qualsiasi tipo apposte sul
prodotto.
Inoltre, osservava come non sempre il fenomeno della de-localizzazione della
produzione potesse considerarsi “neutro” rispetto alla qualità del prodotto e, quindi, alla
tutela della buona fede del consumatore garantita dall’articolo 517 codice penale.
Risulterebbe infatti notorio come, ad esempio nel campo dell’abbigliamento, oltre alla
qualità dei tessuti ed al design, larga parte del valore aggiunto del prodotto discenda
dalla professionalità della mano d’opera impiegata, che all’estero non potrebbe garantire
il medesimo livello di esperienza e specializzazione dell’Italia.110
Il Tribunale aveva, ancora, sottolineato che tutto ciò non è di ostacolo alla delocalizzazione di segmenti di produzione: basta indicare il luogo di produzione, se
differente da quello della sede dell’impresa responsabile del processo produttivo.
Infine, il Tribunale aveva posto l’accento sul richiamo operato dal comma 49
dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 alla normativa europea sull’origine ed in
particolare sull’articolo 24 del codice doganale comunitario, che stabilisce che la merce
è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale.
110
Peraltro, secondo la Corte, l’osservazione sarebbe contenuta in nuce già nella giurisprudenza
precedente ove questa ammetteva l’esistenza di eccezioni (come i prodotti DOP e IGP) alla generale
indifferenza della provenienza geografica del prodotto, sicchè l’interesse in gioco in questi casi “oltre che
legittimo e concreto, si colloca oltre la categoria degli interessi ispirati da ragioni meramente
ideologiche- quali la volontà di favorire l’impiego di manod’opera nazionale o il rifiuto di acquistare
prodotti provenienti da paesi ove non è sufficientemente tutelato il lavoro minorile- e la sua correttezza si
evince a contrariis in casi come questo ove il produttore fornisce maliziosamente al consumatore avare
se non addirittura fallaci indicazioni con l’intento taciuto ma evidente di conferire al prodotto una
maggiore affidabilità promuovendone in definitiva l’acquisto.
130
Il ricorrente aveva, invece, richiamato la consolidata giurisprudenza, che aveva
affermato che la qualità del prodotto non dipende dalla provenienza geografica, bensì
dalla riconducibilità ad un imprenditore responsabile del processo produttivo (il
ricorrente forniva la materia prima e i campioni cui i prodotti dovevano confermarsi) e
sollevato una serie di argomentazioni incentrate sul fatto che la lavorazione in una
fabbrica italiana non garantisce la presenza di operai particolarmente specializzati, né
tanto meno la presenza di soli operai italiani.
La Suprema Corte ha seguito l’impostazione avanzata dal Tribunale, secondo cui la
legge n. 350 del 2003 (c.d. finanziaria 2004) avrebbe riproposto il tema in termini nuovi
rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. In
particolare, la Suprema Corte si è soffermata a valutare le implicazioni derivanti dal
richiamo delle norme comunitarie sull’origine, che statuiscono che per luogo di origine
del prodotto deve intendersi quello dell’ultima trasformazione. Aprendo una breccia nel
muro che aveva in passato attribuito alle norme sull’origine valenza solo nell’ambito
doganale, la Corte ha fatto propri i suggerimenti del Tribunale, per sottolineare come in
alcuni settori particolari, come quello dell’abbigliamento, in cui l’Italia gode di
particolare prestigio, il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale, ai sensi delle
regole sull’origine non preferenziale, costituisce un’informazione in grado di incidere
sulle scelte del consumatore, come tale degna di tutela giuridica.
La Suprema Corte ha quindi considerato illecita la condotta della Trasci, in quanto
idonea ad ingannare il consumatore ex articolo 517 codice penale, data la natura
tipicamente italiana del prodotto trattato (abbigliamento). La Corte non ha precisato se
si tratta di falsa o fallace indicazione di provenienza. Il fatto che crea confusione e come
tale è considerato illecito deriverebbe per la Suprema Corte dalla natura del prodotto
131
trattato, l’abbigliamento, che farebbe sorgere in capo alla società venditrice italiana un
dovere di informazione circa la sua reale provenienza.
In particolare, la Corte ha ritenuto maggiore il rischio dell’inganno del consumatore
sulla origine del prodotto nel caso di prodotti tipici italiani (come l’abbigliamento), per
i quali, in presenza di una indicazione di provenienza (come il “made in Italy”), non
solo è necessario che siano fatti in Italia, ma è anche necessario l’uso di mano d’opera
italiana. Più in particolare, secondo la Corte, nel settore dell’abbigliamento l’Italia gode
di una leadership mondiale, dovuta alla particolare specializzazione delle maestranze
italiane impiegate nel settore dell’abbigliamento, viceversa non impiegate nel caso
specifico. Pertanto, per la Corte, è ragionevole credere che il consumatore di media
diligenza, leggendo l’indicazione di provenienza italiana “produced by Tasci, Roverato
Italy” sui capi di abbigliamento importati dalla Moldavia, abbia un legittimo interesse
ad acquistare un prodotto di abbigliamento che sia stato anche materialmente lavorato in
Italia, da maestranze italiane. L’etichetta di tali capi di abbigliamento lasciava intendere
che la produzione fosse avvenuta in Italia. Da questo quadro la Corte ha dedotto un
comportamento del produttore tendente a fornire “maliziosamente al consumatore avare
se non addirittura fallaci indicazioni con l’intento tacito ma evidente di conferire al
prodotto una maggiore affidabilità promuovendo in definitiva l’acquisto”.
Ne consegue che, in casi analoghi, cioè di prodotti tipici italiani, per evitare l’inganno
dell’acquirente nascerebbe in capo al committente italiano un dovere di informazione
volto a comunicare al consumatore la reale origine straniera della merce venduta.
A giustificazione del significativo cambio di rotta, la Corte ha ricordato che la
“normativa che disciplina la materia è indubbiamente in movimento alla ricerca di un
punto di equilibrio fra fenomeni diversi e virtualmente contrastanti” e che si scorgono
segnali in direzione della rilevanza del luogo della materiale produzione del bene.
132
Si sottolinea, peraltro, che non è previsto alcun dovere di informazione nella finanziaria
2004 al fine dell’uso lecito di “made in Italy” o di altre indicazioni di origine
richiamanti l’Italia, né c’è una distinzione di trattamento a seconda del prodotto trattato,
tanto meno è imposto l’uso di manodopera italiana. La Corte sembra quindi introdurre
un ulteriore elemento, che in futuro occorrerà tenere a mente prima di usare la dicitura
“made in Italy” o indicazioni analoghe: la tipologia del prodotto. Se si tratterà di
prodotto tipico italiano, è possibile che, quand’anche siano rispettate le regole per l’uso
legittimo del “made in italy” o di altre indicazioni di provenienza ai sensi della
finanziaria 2004, sarà comunque ritenuto sussistente il reato di cui all’articolo 517
codice penale, se non verrà informato il consumatore della reale origine geografica
estera del prodotto. 111
Colpiscono alcuni aspetti di questa sentenza.
Nelle precedenti pronunce si era affermata la linea secondo cui, al di fuori della
illegittima apposizione del “made in…” (sentenza Igam), l’indicazione del nome del
produttore, se veritiera quanto alla sua identità e nazionalità, non configurasse un reato
anche qualora non fosse stato indicato il luogo estero di fabbricazione e si trattasse di
prodotti tessili, in quanto “la loro qualità è assicurata dalla materia prima usata e dalla
tecnica produttiva e non certo dall’ambiente territoriale dove il processo produttivo si
svolge”112.
L’inversione di rotta lascia qualche perplessità e non può essere spiegata con la
cavillosa giustificazione avanzata, in base alla quale il Tribunale non avrebbe rinnegato
111
L’obbligo di indicazione del Paese di produzione del prodotto è stato introdotto dal codice del
consumo con riferimento ai prodotti importati da Paesi extra europei.
Quanto alla tipologia dei prodotti, in passato si dava rilevanza solo ai prodotti agro-alimentari, data la loro
qualità derivante più da un determinato luogo di produzione che dalla provenienza da un certo
imprenditore. Ne consegue che non è possibile per tali prodotti indicare, se provenienti territorialmente
dall’estero, solo indicazioni d’origine “imprenditoriale” italiana, pena la configurazione del reato ex
articolo 517 codice penale.
112
Cfr. sentenza Ingam, supra capitolo II, § 2, lettera c, pag. 106 e ss.
133
la precedente giurisprudenza, ma solo individuato un’eccezione per i tessili. La sentenza
Legea, resa non più di sette mesi prima, aveva affermato il contrario.
È anche sorprendente che il Tribunale prima e la Suprema Corte poi abbiano giustificato
quale eccezione, regole diverse solo per l’abbigliamento. L’industria italiana gode,
infatti, di elevata reputazione in tanti altri settori merceologici: si pensi alla pelletteria,
alla ceramica, alle calzature, ecc…
La sentenza n. 2648 della Suprema Corte di Cassazione si presta ad alcune
considerazioni critiche per l’inevitabile incertezza che genera nell’interpretazione ed
applicazione di disposizioni in sé estremamente generiche e, per certi aspetti, contrarie
alla disciplina comunitaria in materia.
Tale nuovo orientamento solleva altre incertezze (quali sono i prodotti tipicamente
italiani?) che suggeriscono di introdurre in tempi strettissimi una unica normativa che
regoli l’uso delle indicazioni di provenienza italiane.113 Sino ad allora è consigliabile
alle imprese che utilizzano indicazioni di provenienza italiane, di adottare una condotta
trasparente e prudente, volta ad indicare con chiarezza al consumatore il reale luogo di
produzione della merce venduta. Informazione questa, che non sembra pregiudicare il
commercio di capi di abbigliamento: si pensi,ad esempio, a quelli recanti marchi
stranoti (come NIKE), nei quali è indicato il luogo di produzione estero (tipo: “made in
china”, “made in corea”, ecc…).
Passando a considerare un altro argomento, la sentenza in esame, nel confermare
l’illiceità della condotta descritta, non indica esplicitamente se si tratti di una “falsa
indicazione di provenienza” (uso illecito di “made in Italy”), di una “fallace indicazione
di provenienza” (uso illecito di Italy o di altri nomi richiamanti l’Italia).
113
E’ auspicabile che l’uso del “made in Italy” e di indicazioni di provenienza analoghe sia disciplinato in
nuovi articoli dal codice proprietà industriale, al fine di non tornare alla moltiplicazione delle leggi
industrialistiche.
134
Infatti, come sopra visto, la condotta è stata considerata ingannevole, ai sensi
dell’articolo 517 codice penale, solo per la natura tipicamente italiana del prodotto
sequestrato.
Stupisce che la Corte non abbia indicato se la condotta costituisse una falsa ovvero una
fallace indicazione di provenienza, dato che, nella pur succinta motivazione, si leggono
molti riferimenti all’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 ed agli interessi sottesi
ad essa. Si richiamano, infatti, i significati di origine imprenditoriale e geografica già
citati, si richiama anche il Codice Doganale Comunitario al fine dell’indicazione delle
merci che possono essere fregiate dalla dicitura “made in Italy”. Vengono anche esposte
considerazioni circa l’opportunità di tutela del “made in Italy”: nella sentenza si
evidenzia infatti che la normativa sul “made in Italy”, oggi in evoluzione, tenta di
trovare il punto di equilibrio tra due interessi contrapposti: l’interesse di tutelare la
concorrenza e quindi la de-localizzazione della produzione da un lato e l’interesse a
tutelare il consumatore dall’altro. Consumatore che, dice la Corte, a sua volta ha
interesse a che certi prodotti tipici italiani (come quelli dell’abbigliamento), siano
materialmente realizzati in Italia: esigenza che porta a tutelare indirettamente anche
l’interesse all’impiego di mano d’opera nazionale ed a evitare lo sfruttamento del lavoro
clandestino degli stranieri.
Precisato questo, pare si possa concludere che la condotta contestata (uso della dicitura
“designed & produced by Tasci srl Roverato Italy” per prodotti realizzati
completamente all’estero) integri una falsa indicazione di provenienza. Invero,
“produced” è sinonimo di “made”. Essendo identico quindi il significato dei due verbi,
la dicitura contestata poteva essere usata solo in presenza delle condizioni richieste per
l’uso legittimo del “made in Italy” e cioè solo se in Italia fosse avvenuta almeno una
trasformazione sostanziale del prodotto (non avvenuta nel caso concreto). Invero
135
secondo la giurisprudenza e l’Agenzia delle Dogane, le regole sull’uso del “made in
Italy” dovrebbero applicarsi anche a diciture di significato analogo (come: fatto in Italia,
prodotto in Italia, scritti anche in lingua straniera es. produced in Italy).
Sempre sulla qualificazione della condotta, non sembra che quella analizzata dalla Corte
possa integrare una “fallace” indicazione di provenienza, dato che sussisteva l’origine
imprenditoriale italiana (la società committente era la Tasci s.r.l. di Rovereto); era
dunque lecito l’uso di diciture quali Italy, Rovereto e simili richiamanti l’Italia.
Tuttavia, come sopra detto, la dicitura contestata era composta anche dai verbi
“designed and produced” che l’hanno resa una “falsa” indicazione di provenienza.
Per ultimo, non pare condivisibile l’inciso finale della Corte secondo il quale, se fosse
stato indicato il reale luogo di fabbricazione della merce, si sarebbe evitato nel
consumatore l’inganno sulla origine nel consumatore e quindi non sarebbe stata
integrata la condotta antigiuridica di cui all’articolo 517 codice penale. Non si può
negare, infatti, che sia comunque idoneo ad ingannare il pubblico un prodotto che reca
accanto alla dicitura “designed and poduced by Trasci Rovereto, Italy”, la scritta “made
in Moldavia”: le due diciture si contraddicono. Forse la Corte, con il suo ultimo inciso,
voleva far riferimento all’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 4, comma 49,
legge n. 350 del 2003 per il quale “la falsa indicazione sulla origine o provenienza di
prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta
indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura “made in Italy””.
Tuttavia, occorre rilevare che l’aggiunta ex post del paese di origine comporta solo la
regolamentazione amministrativa della merce e non parrebbe quindi eliminare la
configurazione del reato ex articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003. Conclusione
confermata dalla stessa norma, nel punto in cui tratta delle fallaci indicazioni di
provenienza e precisa che, in assenza delle condizioni per l’utilizzo legittimo delle
136
indicazioni di provenienza italiane diverse dal “made in Italy” (in altre parole in assenza
dell’origine imprenditoriale italiana) il reato si configura anche se accanto alla
indicazione fallace (tipo Italy o la bandiera italiana), sia indicato il paese estero di
produzione della merce. A fortiori, quindi, la stessa conclusione dovrebbe trarsi nel caso
di uso illecito del “made in Italy”.
In primo luogo l’interpretazione dell’articolo 4 comma 49 della legge 350/2003
orientata ad estendere l’applicazione dell’articolo 517 codice penale ai prodotti recanti
in etichetta la parola ITALY, senza alcuna indicazione sulla reale origine del
semilavorato estero, deve essere ritenuta eccessiva, perché nulla nella nuova normativa
autorizza a ritenere superato il concetto di “origine imprenditoriale” elaborato dalla più
risalente giurisprudenza di legittimità.
La nuova differente impostazione, infatti, aprirebbe un insanabile contrasto logico e
giuridico fra rami diversi dello stesso ordinamento nazionale, posto che il diritto privato
permette di concludere contratti di sub-fornitura con aziende estere potendo comunque
apporre il proprio marchio.
La confusione che si è venuta a creare è forse conseguenza delle scarse conoscenze
tecniche nella materia. Nel commercio internazionale il produttore è colui che dispone
della proprietà della materia prima. La sua origine prescinde dal luogo di stabilimento
del produttore, in quanto è invece legata al luogo dell’ultima trasformazione sostanziale
della stessa materia prima. Pertanto è perfettamente accettabile, nel commercio
internazionale, che il produttore di una merce sia italiano anche se la merce abbia
origine straniera. L’obbligo di indicare il “made in..”, in base alle regole sull’origine
non – preferenziale,è previsto d’altronde solo dall’articolo 6 del codice sul consumo e
quando, sia indicato il nome del venditore, dall’articolo 3 della Convenzione di Madrid.
137
8- ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA: 21 MARZO 2006
In una recente ordinanza inedita del 21 marzo 2006 il giudice delle indagine preliminari
del Tribunale di Genova ha ritenuto che l’aggiunta delle parole “o di origine”
all’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 effettuato dal decreto competitività
abbia esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 4, comma 49 anche all’origine intesa
in senso geografico, la quale si applicherebbe anche alle fallaci indicazioni di
provenienza, contrariamente a quanto in precedenza detto dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione114.
Il caso esaminato dal giudice delle indagini preliminari riguarda il sequestro di tende
prodotte in Vietnam e commercializzate in Italia da società italiana con apposita dicitura
contenente la denominazione sociale della committente italiana, seguita da “…Premana
(LC) ITALY”. Si trattava, quindi, di uso di una indicazione di provenienza italiana non
qualificata (Italy, la bandiera italiana), affiancata da una reale provenienza
imprenditoriale italiana della merce, dato che le tende erano commissionate e
commercializzate dalla società italiana (che ha poi subito il sequestro). La difesa ha
ricordato le sentenze precedenti al 2005, che avevano ritenuto lecite condotte analoghe.
Il giudice delle indagini preliminari, ribadendo che l’articolo 4, comma 49 legge n. 350
del 2003 è stato ampliato con il decreto legge del 2005, ha ritenuto che anche in caso di
prodotti diversi da quelli agro-alimentari il consumatore può avere interesse a conoscere
il luogo di fabbricazione della merce, ad esempio per poter valutare la congruità del
prezzo rispetto al costo della manodopera del luogo di fabbricazione oppure per
orientarsi nell’acquisto “si pensi ai frequenti appelli di alcune associazioni umanitarie a
114
Cfr. sentenza Fro, supra capitolo II, § 2, lettera a, pag. 90 e ss.
138
non comprare prodotti fabbricati in paesi ove sia consentito il lavoro minorile.
Ponendosi in questa prospettiva l’obbligo di indicare in maniera veritiera o comunque
non ingannevole il luogo dell’origine geografica di un prodotto appare del tutto
coerente con lo scopo della fattispecie incriminatrice, che è quello di proteggere
ciascun commerciante e ciascun produttore dall’illecita concorrenza degli altri e di
tutelare la buona fede del consumatore e la sua libertà di scelta”.
In conclusione per il gip del Tribunale di Genova nel caso concreto l’indicazione di
provenienza (intesa in senso imprenditoriale), apporta sulle merci, non era falsa e
neppure fallace, dato che il committente era effettivamente un’impresa italiana. Era,
invece, fallace l’indicazione del luogo di origine del prodotto, cioè l’indicazione del
luogo in cui le tende erano state fabbricate, dato che il consumatore non era in
condizione di comprendere, esaminando le etichette, che si trattava di merci realizzate
in Vietnam e non in Italia.
Tale decisione, insieme a quella del gennaio del 2006 della Corte di Cassazione, sembra
confermare una tendenza sempre più forte ad una applicazione maggiormente rigorosa
dell’articolo 4, comma 49 legge n. 350 del 2003, sempre più a favore della tutela del
consumatore. Nel caso del giudice delle indagini preliminari di Genova è stata
considerata illecita anche una condotta meramente omissiva, quale la mancata
indicazione, sulle tende realizzate in Vietnam, della origine geografica del prodotto,
accanto alla indicazione di provenienza imprenditoriale italiana.
139
9- SENTENZA HUANG SUWEN, N. 3669/2006: RIAFFERMAZIONE DELLA
PREVALENZA
PROVENIENZA
DELL’ORIGINE
GEOGRAFICA,
IMPRENDITORIALE
IN
PRESENZA
IN
SULLA
CAPO
AL
PRODUTTORE DELLA RESPONSABILITA’ GIURIDICA, ECONOMICA E
TECNICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
La pronuncia verte su un sequestro probatorio di capi di abbigliamento di provenienza
cinese, recanti scritte “Italy” con bandiera italiana, “Moda Lisa Italy” o “Style Italy” 115.
Il sequestro fu disposto in relazione al reato di cui agli articoli 517 codice penale e
articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003,sul presupposto che le indicazioni
riportate fossero idonee ad indurre in errore il consumatore, facendogli ritenere che la
merce fosse di origine italiana.
Il Tribunale del riesame ha poi annullato il decreto di sequestro, in quanto ha ritenuto
che le etichette, non riportando il luogo di fabbricazione della merce, non fossero idonee
ad indurre in errore il consumatore. In particolare, il Tribunale ha interpretato l’articolo
4 della legge n. 350 limitatamente al divieto in esso contenuto di falsa indicazione di
provenienza, concludendo che nel caso di specie la norma non fosse stata violata poiché
le etichette non recavano la dicitura “made in Italy”. Contro tale ordinanza ha presentato
ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo un’errata interpretazione
dell’articolo 4 della legge n. 350 nella misura in cui il Tribunale aveva omesso di
considerare, in aggiunta al reato sulla falsa indicazione di origine, anche quello sulla
fallace indicazione d’origine.
115
Cassazione, sez. III penale, 24 novembre 2005, n. 3669, Huang Suwen.
140
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato
l’ordinanza del Tribunale. La Corte ha ravvisato l’errore del Tribunale nella parte in cui
aveva omesso di valutare se i segni e le figure costituissero fallace indicazione. Con
questo, la Corte sembra compiere un passo indietro rispetto alla sentenza Giordani, in
quanto è ritornata sul principio dell’origine imprenditoriale, affermato dalla sentenza
Legea, per concludere che, in mancanza di elementi comprovanti la provenienza
imprenditoriale italiana della merce, dovesse essere mantenuto il sequestro. Ne potrebbe
conseguire che, in presenza dei fatti in causa, se fosse stata fornita la prova che la merce
era stata fabbricata all’estero per conto e sotto il controllo di una ditta italiana, non si
sarebbe concretizzata la fattispecie di fallace indicazione.
Due aspetti della sentenza meritano di essere sottolineati: primo, essa riafferma la
prevalenza del principio dell’origine imprenditoriale su quello dell’origine geografica
nell’ambito dell’analisi dell’indicazione fallace; secondo, ed in qualche misura
collegato al primo, la nozione di origine imprenditoriale non coincide con la proprietà
del prodotto, ma richiede, ai sensi della giurisprudenza, il coinvolgimento di un
imprenditore che assuma la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo
produttivo.
141
10- SENTENZA DANZI, N. 21797/2006: DICITURE QUALI “CONCEPITI” O
“IDEATI” COSTITUISCONO FATTISPECIE DIVERSE DA “MADE IN..”
La controversia ha avuto ad oggetto il sequestro probatorio di un lotto di occhiali da
sole provenienti dalla Cina e recanti la dicitura “Conceived by Vidivici Italia” 116.
Il sequestro è stato disposto dalla dogana di Malpensa sul presupposto che gli occhiali
violassero l’articolo 4, comma 49, della legge n. 350, così come novellato dall’articolo
1, comma 9, del decreto legge n. 35 del 2005, che ha introdotto la nozione di origine nel
primo periodo del comma 49.
Tale sequestro è stato convalidato prima dal pubblico ministero e poi dal Tribunale del
riesame che, contestando la giurisprudenza Fro e Legea, ha interpretato la norma nel
senso che tuteli non solo i prodotti provenienti da un produttore italiano, ma anche la
merce di origine italiana.
Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza Legea, ha argomentato nel senso che nel
contemplare le nozioni di provenienza o origine, l’articolo 4, comma 49 intende riferirsi
non alla località territoriale in cui il prodotto è realizzato, bensì al produttore che
assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione, come
d’altronde è stato affermato da molte sentenze della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha condiviso la tesi del ricorrente, evidenziando che la dicitura
“conceived”, che corrisponde, in italiano, a “concepiti” o “ideati”, non indica “né la
provenienza, né l’origine italiana del prodotto, ma soltanto il modello e/o marchio
riconducibili alla Vidivici Italia, utilizzato nella realizzazione degli occhiali. Trattasi,
pertanto di dicitura né falsa, né fallace quanto alla provenienza ed all’origine italiana,
116
Cassazione, sez. III penale, 12 maggio 2006, n. 21797, Danzi.
142
né illegittima quanto al marchio Vidivici ivi indicato, posto che i prodotti erano
destinati alla ditta “Vidivici Italia” di cui il Danzi era il rappresentante legale”.
La posizione della Corte sembra dunque coerente con quella della precedente
giurisprudenza: ha chiarito che diciture come “concepiti” o “ideati”, sebbene
accompagnate dalla parola Italia, costituiscono locuzioni distinte rispetto a “made in ..”,
rilevante in rapporto alla fattispecie di falsa indicazione e/o “prodotto da”, di interesse
in collegamento alla nozione di fallace indicazione.
143
11- SENTENZA
DOLCE
E
GABBANA,
N.
157/2006:
PREVALENZA
DELL’ACCORDO DI MADRID SULLA DISCIPLINA PENALE
Tra le novità giurisprudenziali in tema di origine dei prodotti industriali si inserisce la
sentenza del Giudice amministrativo del Friuli Venezia Giulia117, appellata al Consiglio
di Stato.
E’ una pronuncia significativa, perché da essa è possibile ricavare spunti interpretativi
di grande rilievo nell’applicazione di una normativa in costante evoluzione.
La questione verte sul fermo amministrativo disposto dall’autorità doganale, ai sensi
dell’articolo 1 del d.P.R. n. 656 del 1968, decreto di recepimento dell’Accordo di
Madrid relativo alle indicazioni di provenienza false e fallaci, su un lotto di capi di
abbigliamento proveniente dalla Turchia contenente t-shirt con il marchio “Dolce e
Gabbana linea junior”, su cui erano apposte targhette con la dicitura “Dolce e Gabbana
spa Legnago, Milano (Italy)”.
La società Dolce e Gabbana ricorrente al Tar, si avvaleva di un’impresa turca
denominata “G.D.T.A.S.” per l’assemblaggio di t-shirt e slip da bambino, ma la stessa
controllava tutte le fasi della produzione, inviando anche le etichette e i cartellini. I capi
così realizzati venivano poi inviati alla ricorrente attraverso una ditta di spedizioni.
Secondo l’Autorità Doganale erano state violate le disposizioni di cui all’articolo 3 della
Convenzione di Madrid sulla repressione delle falsi o fallaci indicazioni di provenienza
delle merci, poiché i capi, di origine turca, recavano sull’involucro e sull’etichetta la
dicitura “Dolce & Gabbana Industria s.p.a. – Legnano, Milano (Italy)”.
117
Sentenza del Tar per il Friuli Venezia Giulia, 8 febbraio 2006, n. 157, Dolce e Gabbana.
144
La materia in questione non è ricaduta nella competenza del giudice penale in quanto il
pubblico ministero riteneva “documentalmente dimostrato” che la ditta ricorrente,
destinataria della merce sequestrata, fosse anche la committente di produzione della
ditta turca e avesse la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo
produttivo, tant’è che non poteva essere ritenuta fallace o fuorviante l’apposizione sui
prodotti dei dati identificativi della stessa ditta. Il pubblico ministero non riscontrava
perciò gli estremi per configurare il reato di cui all’articolo 4, comma 49 della legge n.
350 del 2003, non sussistendo gli elementi della falsa o fallace indicazione. Questa
conclusione sembra conforme alla giurisprudenza consolidata (Legea), che afferma la
sostanziale prevalenza dell’origine imprenditoriale rispetto a quella geografica: il
pubblico ministero vi è, infatti, giunto dopo aver riscontrato che l’etichetta era veritiera
quanto all’origine imprenditoriale.
L’Agenzia delle Dogane, però, nonostante il mancato sequestro penale entro il termine
di sessanta giorni, non ha disposto la restituzione della merce sottoposta a fermo
amministrativo e, di fronte alla specifica richiesta della ricorrente, ha negato la
restituzione, facendo presente che la merce “potrebbe essere rilasciata solo previa
rimozione delle indicazioni irregolari riscontrate (false o fallaci) a prescindere ed al di
là delle valutazioni dell’Autorità giudiziaria in merito alla configurabilità di una
fattispecie penalmente rilevante” e restano in attesa dell’istanza di regolarizzazione
suddetta.
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso e confermato la legittimità
del fermo delle merci.
Le motivazioni contenute nella sentenza rispecchiano l’orientamento recentemente
emerso nella giurisprudenza penale di legittimità, laddove è stata attribuita maggiore
importanza alla corretta indicazione dell’origine geografica dei prodotti, non limitando
145
quindi l’applicabilità del sistema sanzionatorio alle sole ipotesi di falsa o fallace
indicazione della provenienza “giuridica”.
Come detto il sequestro è stato disposto ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di
Madrid, che prevede che debba essere indicato il luogo di produzione o altra
indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore “sull’origine vera delle merci”.
La società Dolce & Gabbana ha fondato il suo ricorso su due profili:
1- che in seno alla normativa a tutela del “made in Italy” i concetti di origine e
provenienza dei prodotti fanno riferimento ad un determinato produttore e non
ad un determinato luogo;
2- che, comunque, l’articolo 3 dell’Accordo di Madrid sarebbe inapplicabile nella
fase dell’importazione, non riferendosi al caso del produttore che importa la
propria merce fatta materialmente realizzare altrove, ma solo al venditore. Infatti
quando quest’ultimo intenda apporre il proprio nome o indirizzo su prodotti
provenienti da un paese diverso da quello della vendita dovrà, ai sensi
dell’articolo 3, accompagnarlo con la precisa indicazione del paese o luogo di
fabbricazione o produzione o “da altra indicazione che valga ad evitare
qualsiasi errore sull’origine vera delle merci”.
Il Tribunale regionale, pur riscontrando che la nozione di origine imprenditoriale
dispiega effetti in relazione al campo di applicazione dell’articolo 517 codice penale e
dell’articolo 4, comma 49 della legge n. 350, ha statuito che essa perde valore in
rapporto all’articolo 3 della Convenzione di Madrid.
In tale contesto, l’origine geografica acquista una sua autonoma rilevanza in tutta la
gamma commerciale. Pertanto, allorché “il produttore importa il suo prodotto – fatto
realizzare all’estero – per venderlo alla distribuzione, dando così inizio alla catena di
146
vendite che finisce per offrire il prodotto al consumatore finale, la fabbricazione estera
del capo non può più dirsi priva di rilevanza”.
Il Tribunale regionale ha pertanto concluso nel senso della piena parificazione delle
figure del produttore/importatore e del venditore: entrambi gli operatori, allorché
indichino il loro nome sull’etichetta di un prodotto fabbricato all’estero, sono tenuti a
riportare al corretta origine geografica.
L’orientamento del giudice amministrativo rappresenta senza dubbi un importante
indirizzo interpretativo, che rafforza ulteriormente la tutela del “made in Italy”.
147
12- I CAMBIAMENTI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27 DICEMBRE 2006 (C. D.
FINANZIARIA
2007):
IL
RIFERIMENTO
ALLE
PRATICHE
COMMERCIALI INGANNEVOLI
L’ultimo intervento del legislatore in tema di “made in Italy” è contenuta nella legge
finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296).
Il comma 941 dell’articolo 1 di tale legge amplia il divieto di recare nei prodotti false o
fallaci indicazioni circa la loro esatta provenienza ed origine, divieto penalmente
sanzionato ai sensi dell’articolo 517 codice penale, prevedendo anche la punibilità nel
caso di uso “fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle
pratiche commerciali ingannevoli”.
In seguito a tale modifica l’attuale testo dell’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del
2003 così recita: “l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero
la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari
dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione,
anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,
l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Le fattispecie
sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per
l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace
148
indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione
a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quanto altro induca a
ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine
o sulla provenienza dei prodotti o delle merci può essere sanata sul piano
amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della
stampigliatura “made in Italy””.
La disposizione in questione è in vigore dal 1 gennaio 2007.
L’articolo 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 riconduce, come si è visto,
all’ipotesi di reato previsto dall’articolo 517 codice penale l’importazione e
l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti
recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine della merce.
Nella fattispecie il legislatore ha inteso individuare due distinte ipotesi:
-
quella relativa alla falsa indicazione, che si può concretizzare nell’apporre il
“made in Italy” su prodotti e merci che non abbiano un’origine italiana ai sensi
della normativa comunitaria in tema di origine doganale dei prodotti;
-
quella relativa alla fallace indicazione consistente nell’apporre, su prodotti sia
provvisti che privi di indicazioni di origine, segni, figure e quanto altro possa
indurre il consumatore a ritenere detti prodotti di origine italiana.
149
È dunque l’ipotesi riconducibile alla “fallace indicazione” che appare oggi ampliata dal
comma 941 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (c.d. finanziaria 2007), rispetto
alla formulazione originaria.
Tale legge ha, infatti, incluso “l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi
della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli” fra le condotte punibili ex
articolo 517 codice penale. L’integrazione contenuta nel comma 941 della finanziaria
2007 rappresenta l’ennesimo intervento del legislatore in tema di “made in Italy”, che
ne ha estesa la tutela a tutte le ipotesi in cui l’utilizzo dei marchi possa generare abusi ai
sensi della normativa comunitaria sulle pratiche commerciali ingannevoli.
I primi commenti alla disposizione della Finanziaria hanno evidenziato alcuni problemi
interpretativi per quanto concerne l’utilizzo dei termini “fallace” e “fuorviante”
accompagnati dal richiamo “alle pratiche commerciali sleali”. Nelle intenzioni del
legislatore, questo sembrerebbe riferito alla direttiva 2005/29/CE118 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali
tra imprese e consumatori nel mercato interno. 119
La direttiva ha lo scopo di reprimere le pratiche commerciali sleali attuate, in
particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli.
Secondo l’articolo 6 della direttiva, rubricato “azioni ingannevoli”, deve considerarsi
“ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto
non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o
possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta,
riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a
118
La direttiva 2005/29/CE ha modificato la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE,
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
119
Sul tema si è tenuto un Convegno a Padova presso ’Uniindustria il 13 Febbraio 2007 dal titolo: “Made
in Italy” come cambia la tutela dei prodotti con la finanziaria 2007.
150
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso: ...”.
Il legislatore comunitario ha inteso così contrastare quelle pratiche commerciali
ingannevoli, ottenute mediante la diffusione di informazioni false, capaci di ingannare il
consumatore medio e indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale (quindi
di acquistare o meno) che non avrebbe altrimenti preso.
Vengono quindi indicati una serie di elementi, fra i quali rientra l’origine geografica o
commerciale del prodotto che, pertanto, ai fini dell’analisi della disposizione in
commento, assume certamente rilevanza.
Inoltre sono individuate le pratiche commerciali ingannevoli realizzate omettendo di
fornire informazioni necessarie ai consumatori. L’articolo 7 della direttiva, infatti,
prevede in linea generale che sia considerata sleale la condotta dell’impresa che,
nell’immettere in commercio i propri prodotti, “ometta informazioni rilevanti di cui il
consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole
di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso”.
Il richiamo a tale normativa, nel comma 941 della legge n. 296 del 2006 (c.d. finanziaria
2007), in correlazione all’uso di marchi aziendali che possano ingenerare errori nei
consumatori, sembra finalizzato ad evitare l’apposizione su prodotti realizzati
prevalentemente all’estero di marchi (indifferentemente che siano registrati o meno) che
inducano, direttamente o indirettamente, gli acquirenti a ritenere che i beni in vendita
siano di origine italiana.
Tale misura, pur non escludendo per le imprese italiane la possibilità di apporre i propri
marchi su beni realizzati in paesi esteri, in seguito a scelte di de-localizzazione dei
151
processi produttivi, imporrà indirettamente l’obbligo di apporre anche l’indicazione di
origine “made in ..” sui prodotti medesimi.
Tuttavia, le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 si prestano ad essere
interpretate anche in modo differente. Il dubbio che emerge in seguito alla lettura del
comma 941 riguarda la mera apposizione del marchio di un’impresa italiana su prodotti
realizzati prevalentemente all’estero. In particolare, non è chiaro se tale condotta integri
ex se la fattispecie penalmente rilevante.120
In un certo senso, si potrebbe ravvisare un uso fallace o fuorviante del marchio
aziendale, tale da far ritenere che un prodotto sia stato realizzato in Italia, solo nei casi
in cui il marchio in sé contenga riferimenti diretti alle produzioni nazionali e non anche
per effetto della mera apposizione sul prodotto del marchio di un’impresa italiana.
Di contro, interpretando in modo estensivo il comma 941 dell’articolo 1 della legge n.
296 del 2006 (c.d. finanziaria 2007) si potrebbe intendere che l’apposizione su un
prodotto importato del proprio marchio da parte di un’impresa italiana possa risultare ex
se fuorviante per il consumatore, a meno che non venga indicata l’esatta origine del
medesimo, o quanto meno che si tratta di merce importata.
Appare evidente, tuttavia, che preferendo la seconda interpretazione, la normativa de
qua imporrebbe un onere ingiustificato alle imprese italiane rispetto alle aziende estere:
l’indicazione dell’esatta origine dei prodotti, ogni volta che sui prodotti venga apposto il
marchio dell’impresa italiana.
Un’impresa estera potrà, quindi, commercializzare liberamente i propri prodotti,
realizzati in paesi in via di sviluppo, a costi competitivi, apponendovi il proprio
marchio. L’impresa nazionale, apponendo il suo marchio aziendale al prodotto
realizzato all’estero, potrebbe invece violare la normativa a tutela del “made in Italy”.
120
Cfr. F. Antonacchio, Etichettatura dei prodotti – Tutela del “made in Italy”, sicurezza e contrasto alla
contraffazione del marchio, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 50-52.
152
Si attendono più precise indicazioni dalle istituzioni competenti (Ministero dello
Sviluppo Economico ed Agenzia delle Dogane in particolare), perchè, la norma
introdotta dalla finanziaria 2007, anche se diretta a rafforzare la tutela del marchio, in sé
risulta troppo generica e non capace di chiarire la complessa e a volta contraddittoria
disciplina in vigore sulla tutela del “made in Italy”. 121
121
La circolare n. 17 del 28 marzo 2007 emessa dall’Assonime (Associazione tra le società italiane per
azioni) chiarisce l’interpretazione dell’articolo 4 della legge 350/2003 modificata dalla legge finanziaria
del 2007 sulla tutela penale del “made in Italy”.
Per l’ Assonime grazie alla nuova legge finanziaria sono individuabili tre ipotesi di illecito:
1- la falsa o la fallace indicazione di origine o di provenienza
2- l’apposizione indebita sul prodotto dell’indicazione "made in Italy"
3- l’uso ingannevole di marchi, segni o figure.
La circolare precisa quanto segue.
Riguardo al primo caso, la fattispecie penale non si estende ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare
in stabilimenti esteri da un produttore o imprenditore italiano che assuma la piena responsabilità
giuridica, economica e tecnica del processo di produzione, se rechino solo il marchio o l’indicazione
dell’impresa italiana e non anche l’indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno
stabilimento estero.
Riguardo al secondo caso, l’apposizione può essere legittimamente apposta solo quando il prodotto sia
integralmente prodotto in Italia, ovvero possa qualificarsi di origine italiana ai sensi della normativa
europea sull’origine.
Riguardo al terzo caso, non si può ritenere di per sè ingannevole l’apposizione di un marchio di
un’impresa italiana che ha decentrato la produzione, ma ha la responsabilità giuridica, economica e
tecnica del processo di produzione, purchè siano indicate l’origine e la provenienza estera del prodotto
industriale. L’obiettivo sarebbe quello di sanzionare l’importazione, l’esportazione e la
commercializzazione di prodotti recanti indicazioni e segni che, per la loro ingannevolezza circa la
provenienza del prodotto stesso, siano atti a trarre in inganno l’acquirente;
Infine la circolare precisa che l’asportazione dei segni o delle figure illegittime, pur non estinguendo il
reato, è idonea a legittimare il dissequestro della merce regolarizzata.
153
13- SENTENZA N. 8684/2007: L’ULTIMA PRONUNCIA IN TEMA DI “MADE
IN ITALY”: LEGITTIMITA’ DELLA DICITURA “ITALIAN DESIGN” SU
PRODOTTI FABBRICATI ALL’ESTERO
La sentenza n. 8684 del 1 marzo 2007 della terza sezione della Cassazione Penale è
l’ultima pronuncia in tema di “made in Italy” ad oggi presente in repertorio.
Contro tale pronuncia si sono levate le voci critiche delle associazioni di categoria, le
quali sostengono che tale sentenza “scardina il concetto di “made in Italy”” e “sposa
quello molto vago di Italian design”.
La questione portata all’attenzione della Suprema Corte riguarda un produttore italiano,
nella specie la società “Alfa” con sede in Senigallia, che ha presentato in dogana per
l’importazione quasi duemila orologi da polso fabbricati, per suo conto, ad Hong Kong.
In particolare, tali orologi recano tutti incisa sul retro della cassa la dicitura “Officina
del Tempo – Italy”, nonché, la maggior parte di essi, la dicitura “Italian design”,
impressa sulla parte inferiore del quadrante.
Il Tribunale di Como, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto il produttore italiano sul
presupposto che, nel caso di specie, le diciture che gli orologi riportano si limitano ad
indicare che il produttore (inteso come soggetto giuridico) è italiano e che la
progettazione è opera di designers italiani. Per il Tribunale il fatto che la fabbricazione
sia de-localizzata all’estero non rileva ai fini della sussistenza del delitto di cui
all’articolo 517 codice penale.
Avverso tale sentenza il procuratore della Repubblica di Como ha proposto ricorso per
Cassazione ritenendo che tale orientamento non tenga conto della ratio su cui si fonda
154
la normativa a tutela del “made in Italy”, specie in seguito alle modifiche introdotte in
seno all’articolo 4 comma 49 legge 350/2003 dal decreto legge 35/2005, convertito in
legge 80 del 2005.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della
Repubblica di Como, confermando l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, già
pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare di Como.
I giudici della Suprema Corte osservano che “la garanzia che l’articolo 517 codice
penale ha inteso assicurare riguarda l’origine e la provenienza del prodotto, non già da
un determinato luogo (…), bensì da un determinato produttore (…)” per cui
l’imprenditore “ben può affidare a terzi sub fornitori l’incarico di produrre
materialmente un determinato bene e può imprimervi il proprio marchio con i suoi
segni distintivi”.
Questo ragionamento si basa sulla considerazione che l’articolo 517 codice penale è
volto a tutelare la fiducia dell’acquirente e che “a tal fine, la induzione in inganno di cui
all’articolo 517 codice penale riguarda l’origine, la provenienza o qualità dell’opera o
del prodotto. Ma, a ben vedere, i primi due elementi sono funzionali al terzo, che, in
realtà, è il solo fondamentale, giacchè, normalmente, il luogo o lo stabilimento in cui il
prodotto è confezionato è del tutto indifferente alla qualità del prodotto stesso”.
La Corte di Cassazione continua affermando che “del resto, la disciplina generale del
marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal
punto di vista giuridico, il marchio non garantisce la qualità del prodotto, ma
rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l’impresa, non nel senso
della materiale fabbricazione, ma della responsabilità del produttore (…)”.
155
Per la Cassazione, dunque, l’articolo 517 codice penale tutela il consumatore riguardo
all’origine e alla provenienza del prodotto, ma non in senso assoluto: l’inganno può
riguardare l’origine e la provenienza, ma solo in relazione alla qualità, elemento che in
realtà è considerato quello fondamentale.
Il fatto che la fabbricazione sia de-localizzata all’estero, per la Suprema Corte, non è
motivo sufficiente per considerare applicabile l’articolo 517 codice penale, qualora la
progettazione ed il disegno siano effettivamente italiani, benché l’assemblaggio del
prodotto avvenga all’estero.
Tale orientamento è contrario a quanto affermato dalla stessa Cassazione nella
precedente sentenza n. 2648 del 20 gennaio 2006, in cui era stata riconosciuta la
potenzialità ingannevole delle fallaci indicazioni di origine dei prodotti, atteso che il
nostro paese gode, specie in taluni settori, di una “riconosciuta leadership in campo
mondiale, dovuta anche alle particolari maestranze impiegate”122.
Nella sentenza n. 8684 del 1 marzo 2007 la Cassazione, invece, richiamando un
precedente pronunciamento, ha affermato che “anche una indicazione errata o
imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno
dei tassativi aspetti considerati dall’articolo 517 codice penale, in quanto deve ritenersi
pacifico che l’origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico,
non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza
sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal
produttore”.
Nella motivazione la Cassazione ha sostenuto che la volontà del legislatore,
introducendo una normativa specifica a tutela del “made in Italy”, modificata dal
122
Cfr. supra capitolo II, § 6, pag. 129 e ss.
156
decreto competitività, non sarebbe stata quella di “stravolgere” la costante
interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che riconduce il concetto di origine al
“produttore” e non al “luogo di produzione”.
Tuttavia, la Suprema Corte non si è soffermata su quanto espressamente indicato dalla
finanziaria 2004, in forza della quale per l’individuazione dell’origine dei prodotti il
legislatore non rimanda al concetto di origine giuridica dei prodotti (ossia dell’origine
da un determinato produttore) bensì alla normativa comunitaria in materia, che
disciplina, come osservato, l’origine geografica123.
La Suprema Corte ha così nuovamente evidenziato i limiti applicativi di una normativa
non chiara, che ha generato, nel tempo, profondi contrasti interpretativi.
Da parte delle associazioni di categoria si lamenta che tale sentenza avrebbe
“scardinato” il concetto di “made in Italy” “sposando” quello di “italian design”, in
quanto gli imprenditori potrebbero lecitamente apporre “italian design” senza subire
alcun limite, dicitura comunque molto forte e che ha un forte potere attrattivo per i
consumatori al pari del “made in Italy”.
Tale sentenza conferma, in realtà, il prevalente indirizzo seguito dalla giurisprudenza
della Suprema Corte in questi anni.
In conclusione l’interpretazione della Suprema Corte è parzialmente condivisibile
relativamente alla dicitura “italian design”, mentre è discutibile in relazione alle
affermazioni relative alla funzione dei vari elementi dell’articolo 517 codice penale,
secondo cui il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato sono del tutto
indifferenti alla qualità del prodotto stesso.
123
Cfr. infra capitolo IV, § 3, lettera c ,pag. 246 e ss.
157
È discutibile la tesi che nel caso di specie la dicitura “Officina del Tempo – Italy” si
limiti ad indicare che il produttore in questione era un soggetto giuridico italiano.
È parimenti discutibile affermare che il marchio non garantisce la qualità, subito dopo
aver sostenuto che la ratio dell’articolo 517 codice penale riguarda l’origine e la
provenienza del prodotto, non da un certo luogo bensì da un produttore “quale ne
garantisce la qualità”.
158
CAPITOLO III
PROFILI PENALISTICI DEL “MADE IN ITALY”
Sommario: 1. La controversia sulla natura del segno distintivo “made in Italy” in attesa
del regolamento governativo istitutivo del marchio “made in Italy”: a) origine doganale;
b) marchio d’origine: categoria priva di riferimenti normativi nella legislazione italiana;
c) il sistema americano: obbligo di indicare sui prodotti importati la loro origine; d) la
normativa sull’origine delle merci in Cina: obbligo di indicare l’origine sia su i prodotti
importati, sia su quelli esportati; e) la nozione di marchio; f) i marchi collettivi; g) le
indicazioni di provenienza, in particolare le indicazioni geografiche e le denominazioni
di origine; h) considerazioni conclusive: gli aspetti caratterizzanti il “made in Italy” dal
punto di vista della natura giuridica. 2. Ancora sulla natura giuridica: considerazioni
sull’istituendo marchio “made in Italy”. 3. Individuazione del bene tutelato sulla base
delle norme sul “made in Italy”: opinioni contrastanti: a) il consumatore non più
soggetto passivo che compra prodotti standardizzati; b) la tutela del “made in Italy” nel
mercato globalizzato e la salvaguardia del sistema produttivo nazionale; c) le imprese
italiane quali tra i soggetti maggiormente interessati alle norme sull’origine
imprenditoriale e geografica dei prodotti; d) l’”italianità” dei prodotti quale vero
interesse tutelato. 4. Fonti normative della tutela del “made in Italy”. La condotta
incriminata: a) il coordinamento tra l’articolo 517 codice penale e l’articolo 4, comma
49, legge n. 350/2003 ( così detta finanziaria 2004); b) critiche alla formulazione
dell’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004). 5. Individuazione
del momento consumativo: risoluzione di un contrasto giurisprudenziale.
159
1- LA CONTROVERSIA SULLA NATURA GIURIDICA DEL SEGNO
DISTINTIVO “MADE IN ITALY” IN ATTESA DEL REGOLAMENTO
GOVERNATIVO ISTITUTIVO DEL MARCHIO “MADE IN ITALY”:
OPINIONI CONTRASTANTI
Nella ricostruzione della prospettiva di tutela propria delle incriminazioni extra
codicem, poste a tutela del “made in Italy”, è necessario per individuare della natura
giuridica di tale segno distintivo, in attesa che venga emanato il regolamento
governativo istitutivo del marchio “made in Italy” previsto dal comma 61 dell’articolo 4
legge n. 350 del 2003.
In dottrina si manifestano diverse opinioni: alcuni lo ritengono un marchio124, altri
invece un marchio collettivo e altri ancora una mera indicazione di provenienza125.
Le differenze sono importanti, perché diverse sono le funzioni del marchio e
dell’indicazione di provenienza.
Nel cercare di individuare la natura giuridica del “made in Italy”, si avverte l’esigenza
di una preliminare ricognizione del corretto significato di espressioni quali: origine
124
In tal senso M. Casucci, La tutela del “made in Italy”…, cit., pag. 284; F. Cingari, Misure punitive
per il…, cit., pag. 1340-1345; F. Di Gianni, Il lungo viaggio…, cit., pag. 24.
In giurisprudenza si riferisce espressamente al marchio “made in Italy” la Corte di Cassazione nella
sentenza Ingam n. 34103/2005, in cui più volte fa impropriamente riferimento al “marchio made in Italy”
o, in termini interpretativi, alla disciplina generale del marchio.
125
In tal senso G. Martiello, La tutela penale del “made in Italy” nel mercato globalizzato…, cit., pag.
777 e 779; A. Sirotti- Gaudenzi, Rafforzata la tutela…, cit., pag. 135; S. Sandri, Marchi, indicazioni
geografiche, disegni, modelli nel capo II del nuovo codice, in Diritto Industriale, 2005, n. 22; D.
Sangiorgio, L’ultima sul “made in Italy”…, cit., pag. 224.
Di recente, ha ritenuto che la dicitura “made in Italy” dovesse intendersi come denominazione di origine
ai sensi della normativa europea, con conseguente applicazione della fattispecie de qua, Cassazione, sez.
III penale, 19 Aprile 2005, Tarantino, in Guida al diritto, 2005, n. 43, pag. 92.
160
doganale, origine commerciale, indicazione di provenienza, marchio commerciale e
marchio collettivo.
Dall’analisi di queste figure si osserverà come non sia possibile far rientrare il “made
in..” in alcuna di tali categorie, perché esso presenta caratteri suoi propri che attingono
solo in parte alle caratteristiche delle categorie sopra menzionate.
161
a) Origine doganale
Ogni paese (o gruppo regionale come l’Unione europea) è dotato di un insieme di
regole (leggi, regolamenti, norme amministrative) volte a definire, ai fini doganali, il
paese d’origine delle merci oggetto di transazioni internazionali.
Le regole doganali sull’origine delle merci rivestono grande importanza nel commercio
internazionale, in quanto è sulla base di esse che un determinato prodotto, proveniente
da un determinato paese, si vedrà applicare un regime daziario in luogo di un altro.
Uno degli accordi allegato al GATT è interamente dedicato al tema delle regole
d’origine (Agreement on Rules of Origin; AROO), con la dichiarata finalità di
promuoverne l’armonizazzione, evitando al contempo che le stesse costituiscano degli
ostacoli non necessari al commercio.
Per quanto concerne l’armonizzazione, l’Accordo prevede che il Comitato sulle regole
di origine in seno all’organizzazione mondiale del commercio, in collaborazione con il
comitato sulle regole di origine dell’organizzazione mondiale delle dogane, elabori un
documento che definisca le norme relative. L’attività di armonizzazione, che doveva
portare a un documento comune entro il 1998, non ha ancora raggiunto l’obiettivo, a
causa delle difficoltà di trovare l’accordo (in particolare tra i paesi ricchi di materie
prime e i paesi trasformatori) sull’individuazione delle fasi di produzione rilevanti per
l’attribuzione dell’origine.
La mancata armonizzazione lascia lo spazio, nel frattempo, all’elaborazione ed
applicazione di regole di origine valide nei singoli paesi o gruppi regionali, le quali non
potranno porsi in contrasto con i principi sanciti dall’Accordo, tra i quali il divieto di
utilizzare le regole d’origine quali “strumenti volti a favorire, direttamente o
162
indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale” e l’impiego a che
le regole d’origine non determino “effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione
del commercio internazionale” (articolo 2, b) e c)).
Per quanto riguarda l’Unione Europea la normativa di riferimento è il codice doganale
europeo, che prevede un duplice insieme di regole, per definire l’origine doganale di un
prodotto: quelle relative all’origine “preferenziale” e quelle relative all’origine “non
preferenziale”.
Quando un prodotto è interamente ottenuto in un unico paese, la determinazione
dell’origine non presenta particolari difficoltà, posto che il criterio è in ogni caso quello
di ritenere la merce originaria dal paese in cui è estratta o prodotta.
Per i prodotti parzialmente ottenuti in paesi diversi, il discorso dell’attribuzione
dell’origine doganale è invece più complesso. Qualora si tratti di paesi in regime di
origine non preferenziale, la merce si considera “originaria del paese in cui è avvenuta
l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale” (articolo 24 c.d.e.).
Quando i paesi in questione siano ammessi all’origine preferenziale, i criteri relativi
saranno da ricercare nei singoli accordi. In generale può dirsi che il principio di base di
tali accordi è che una merce è originaria del paese in cui ha subito una “trasformazione
sufficiente”. In ogni accordo vi è una lista delle operazioni ritenute sufficienti.
Questa digressione su cosa s’intenda per origine doganale e quali siano le regole da
applicare è molto importante quando si parla di “made in..”, perché, se le norme che
permettono l’apposizione del “made in..” non hanno rilevanza giuridica ai fini della
determinazione dell’origine doganale di un prodotto, di converso, vi è una spiccata
tendenza a ricorrere alle regole sull’origine doganale (non preferenziale) per valutare la
legittimità dei marchi di origine. Il legislatore italiano, come visto nella legge n.
163
350/2003 (c.d. finanziaria 2004) fa proprio riferimento alle regole comunitarie
sull’origine doganale per determinare l’origine di un prodotto, al pari di quello cinese e
statunitense. Il legame tra regole sull’attribuzione doganale e regole sul “made in..” è un
legame inscindibile, anche se i due ambiti non devono essere confusi. Le regole
sull’origine doganale sono, ad oggi, il solo parametro di riferimento per l’apposizione
del “made in..”.
164
b) Marchio d’origine: categoria priva di riconoscimento normativo da parte
del legislatore italiano
Alcuni autori126 hanno collocato il “made in Italy” all’interno della categoria del
marchio d’origine.
Il “marchio” d’origine consisterebbe nell’indicazione, apposta sul prodotto e/o sulla sua
confezione, delle diciture “made in..”, “product of…” o in espressioni ad esse
equivalenti (alle volte anche la sola indicazione di un paese, per esempio “Italia”) che
attribuiscono l’origine di un prodotto a un determinato Stato.
Con riferimento al tema del marchio di origine, nella prassi, a volte, si ricorrerebbe a
espressioni di significato equivalente all’espressione “origine commerciale” in
contrapposizione a “origine doganale”, nell’intento di evitare la facile confusione tra i
due ambiti.
Il marchio d’origine, per tali autori, assolverebbe essenzialmente ad una duplice
funzione: quella di fornire al consumatore un’informazione aggiuntiva sul prodotto che
intende acquistare e quella di prevenire pratiche fraudolente da parte dei produttori e di
importatori. Inoltre, qualora per certi produzioni i consumatori colleghino l’origine da
un determinato paese a caratteristiche generali di migliore qualità, il marchio di origine
può rappresentare altresì, per i relativi produttori, uno strumento indiretto di promozione
delle vendite.
Tali autori fondano la loro posizione sull’articolo IX del GATT, il quale, in termini
molto generali e senza, peraltro, darne una definizione, fa riferimento al marchio
d’origine. In tale articolo si fissa il principio secondo cui “Le parti contraenti
126
Cfr. N. Picchi, Paesi emergenti…, cit., pag. 46; G. De Maio, Marchio d’origine, tutela della qualità,(
nota a Cassazione penale, sez. III , 19 aprile 2005, Ingam), in Diritto e Giustizia, 2005, fasc. n. 43, pag.
74.
165
riconoscono che, nell’elaborazione e applicazione delle leggi o regolamenti relativi ai
marchi d’origine, converrà ridurre al minimo le difficoltà e gli inconvenienti che da tali
misure potrebbero derivare al commercio e alla produzione dei paesi esportatori,
tenendo in debito conto la necessità di proteggere i consumatori contro le indicazioni
fraudolente o di natura atte a indurre in errore”.
In realtà la maggior parte della dottrina italiana, in assenza di riferimenti del legislatore
sia nazionale, che comunitario, non riconosce un’autonomia di significato al “marchio
d’origine”. Difficilmente con la nozione di marchio esistente nel nostro ordinamento,
quale segno distintivo identificativo di un dato produttore, si può accogliere una sua
nuova sottocategoria di marchio.
In altri paesi esiste detta categoria e anche un’apposita disciplina. Nel momento in cui
un produttore commercializza i suoi prodotti in tali paesi, in base al principio di
territorialità, deve rispettare le norme colà vigenti.
Dove sono presenti, le regole sulla marcatura di origine possono prevedere che
l’apposizione del marchio sia condizione necessaria per l’immissione di un prodotto sul
mercato (marcatura obbligatoria); oppure, alternativamente, creare un quadro normativo
di riferimento per i produttori che, su base volontaria, decidono di apporre sul prodotto
il marchio che ne indica l’origine (marchiatura facoltativa). L’obbligo della marchiatura
può concernere indistintamente tanto i prodotti nazionali che quelli importati, ovvero
può sussistere unicamente per questi ultimi.
L’apposizione sui prodotti importati dell’indicazione del paese d’origine è
obbligatoriamente prevista dalle norme di molti paesi: Stati Uniti, Giappone, Cina,
Arabia Saudita, Brasile, Argentina, Australia, Canada, Cile, Croazia, Colombia, Corea
del Sud, Egitto, Emirati Arabi, Filippine, Grecia, Israele, Kuwait, Libano, Malesia,
166
Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Parguay, Polonia,, Russia, Turchia, Uruguay e
Venezuela.
Ove, invece, non sussiste uno specifico obbligo al riguardo, come il caso dell’Unione
Europea, apporre o meno l’indicazione d’origine delle merci è frutto di una libera scelta
di ciascun produttore.
167
c) Il sistema americano: obbligo di indicare sui prodotti importati la loro
origine
Le leggi doganali degli Stati Uniti richiedono, da molto tempo, precisamente dal
Trademark Act del 1946, che ogni prodotto importato, fabbricato all’estero, riporti in un
luogo visibile e in modo leggibile, indelebile e permanente il nome del paese di origine
del prodotto stesso espresso in lingua inglese. Solo alcuni prodotti, specificatamente
indicati, sono esentati da tale obbligo.
Questo allo scopo di indicare all’acquirente finale il nome del luogo ove il prodotto è
stato effettivamente costruito o prodotto.
Il criterio per l’attribuzione dell’origine è quello dell’origine non preferenziale.
La dicitura “made in..” o “product of..” non è in sé necessaria, essendo sufficiente il
singolo nome del paese d’origine, ma lo diventa nel caso in cui sul prodotto compare
anche il nome di una località diversa dal luogo d’origine e quindi possa profilarsi il
rischio di confusione per il consumatore finale. La dicitura “made in..” accompagnata
dal vero paese d’origine, in tal caso, deve essere apposta nelle immediate vicinanze
della prima indicazione d’origine e con caratteri e dimensioni simili.
A fronte di questo complesso di norme esiste un apparato sanzionatorio che le dogane
USA applicano con molto rigore: possono imporre un dazio aggiuntivo del 10% sul
valore della merce, rifiutare l’ingresso delle merci non marcate in modo appropriato,
obbligare l’importatore alla marcatura d’origine dei beni non marcati, o marcati in modo
improprio, e applicare sanzioni pecuniarie.
Si ricorda inoltre che la sezione 43 del Trademark Act proibisce l’immissione sul
territorio statunitense di prodotti recanti una falsa indicazione d’origine o l’alterazione
168
di una etichetta indicante l’origine, mentre la cancellazione o l’alterazione di una
etichetta indicante l’origine costituiscono un reato punibile con il carcere e con la multa.
Le norme USA in materia di origine sono disposizioni doganali e i controlli in ordine
all’origine
delle
merci
importate
costituiscono
un
ambito
di
competenza
prevalentemente riservato al dipartimento delle dogane, benché questo non sia l’unico
ente statale coinvolto. Si deve, infatti, ricordare che i prodotti importati, qualora non
conformi alle regole di origine, possono incorrere anche nelle misure sanzionatorie
previste dal Federal Trade Commission Act che, nella sezione due, classifica e
proibisce, come pratica sleale e ingannevole, la falsa indicazione d’origine geografica
dei prodotti venduti negli Stati Uniti.
169
d) La normativa sull’origine della merce in Cina: obbligo di indicare l’origine
dei prodotti sia sui prodotti importati, sia su quelli esportati
La normativa cinese, in materia di origine non preferenziale del prodotto, è molto
recente: risale, infatti, al settembre del 2004 il Regolamento della Repubblica Popolare
cinese sull’indicazione del luogo di origine dei prodotti destinati all’importazione e
all’esportazione. Esattamente, come le regole che presiedono alla determinazione
dell’origine del codice doganale comunitario (ex articolo 23 regolamento Ce, anche per
la Cina, i beni interamente ottenuti in un paese, saranno considerati originari di quel
paese, mentre i prodotti che hanno subito lavorazioni in due o più paesi, saranno
considerati originari del paese in cui è stata effettuata l’ultima lavorazione sostanziale
(articolo 3).
L’articolo 6 del regolamento cinese sull’origine non preferenziale dei prodotti specifica
che la determinazione della lavorazione sostanziale può essere fatta, basandosi sul
cambio di nomenclatura tariffaria. Qualora il cambio di nomenclatura non rifletta
l’effettiva lavorazione sostanziale, bisognerà basarsi sul criterio della percentuale di
lavorazione effettuata nei diversi paesi, per valutare quello di origine effettiva.
L’articolo 11 del regolamento in questione stabilisce che un importatore, quando
importa beni da paesi terzi, debba adempiere all’obbligo di dichiarare il paese di origine
dei prodotti medesimi, intendendo l’origine secondo il criterio sopra menzionato: “il
luogo geografico ove è avvenuta l’ultima lavorazione sostanziale”.
Attraverso un complesso procedimento, la dogana cinese competente stabilisce qual è
l’effettiva origine dei prodotti di cui è chiesta l’importazione. La medesima dogana o
altra autorità amministrativa cinese verifica poi che il luogo di origine, riportato sul
170
prodotto importato e sull’imballaggio del medesimo, corrispondano a quello stabilito
sulla base del regolamento in questione e, ove le autorità competenti riscontrino delle
discrepanze, possono imporre all’importatore di correggere, a sue spese, la menzione
riportata sul prodotto o sull’imballaggio, per renderla conforme a verità.
L’articolo 22 del regolamento stabilisce, infine, che chiunque dichiari un luogo di
origine falso in violazione della normativa cinese sull’origine sarà soggetto a sanzioni
amministrative e penali.
171
e) La nozione di marchio
Il marchio è il segno distintivo che gli imprenditori possono apporre e di regola
appongono sui prodotti che mettono in commercio (articolo 2569 codice civile), al fine
di consentire al consumatore di individuare il produttore di un bene, garantendone la
qualità, a prescindere dall’origine geografica del medesimo127.
L’amministrazione delle dogane ha provveduto a chiarire che nel nostro ordinamento
“le funzioni di tale indicazione (il marchio di fabbrica) è volta essenzialmente a
garantire al consumatore che il prodotto viene da una specifica organizzazione e,
quindi, che il prodotto stesso ha determinate caratteristiche qualitative e non anche a
certificare il luogo della sua effettiva produzione”.128
Il marchio, pertanto, è per i consumatori la garanzia che un prodotto proviene da una
medesima impresa o da un’impresa che presenti rilevanti elementi di continuità con
quella originaria o che abbia con questa rapporti di natura contrattuale o/e economica.129
Il richiamo alla stessa funzione di individuazione e di reperimento dei prodotti di una
determinata impresa è posto a fondamento delle decisioni della giurisprudenza
riguardanti i casi in cui sui prodotti vi era l’indicazione dell’impresa che ha fabbricato il
prodotto, ma non l’indicazione “made in Italy”.
Dall’analisi delle sentenze, effettuata nel capitolo precedente, emerge che la Suprema
Corte ha sempre sottolineato che il marchio è quel segno distintivo indicante che il
prodotto proviene da un dato produttore, quale garanzia di determinate caratteristiche
127
Cfr. G. Sena, Il diritto dei marchi – marchio nazionale e marchio comunitario-, op. cit. , 2007, pag. 55
e ss..
128
Cfr. Circolare n. 226 del 22 luglio 1989 dell’Agenzia delle Dogane, integrata dalla circolare 302/VI
del 20 ottobre 1989.
129
Cfr. A. Vanzetti, Natura e funzioni giuridiche del marchio, nel volume celebrativo del XXV anno
della Rivista di diritto industriale, Milano, 1977, pag. 1168.
172
qualitative, risultato di un processo di fabbricazione del quale il suddetto imprenditore,
titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti
e fattori nel processo produttivo.
Il marchio deve potersi effettivamente qualificare come tale, ossia deve essere registrato
e in regola con le norme che disciplinano i marchi stessi. Nella sostanza, al marchio
deve corrispondere una reale attività commerciale ed imprenditoriale, radicata in Italia,
per non incorrere nella violazione dell’articolo 517 codice penale.
La Cassazione ha voluto sanzionare coloro che improvvisano delle attività di
importazione in Italia, senza avere nel nostro paese alcun collegamento, serio e
conosciuto, con il mercato del prodotto in questione. Questi soggetti si presentano sul
mercato con una “mera etichetta italiana” senza quel collegamento tra marchio, impresa
e prodotto che permette all’acquirente di effettuare una corretta valutazione del rapporto
qualità-prezzo, imputando poi all’impresa titolare del marchio eventuali apprezzamenti
negativi e positivi.
Nel caso in cui non fosse possibile per il produttore apporre un marchio sul prodotto,
ma questi abbia comunque un know how come nel caso trattato dalla Cassazione
sentenza n. 21979/2006, in cui la ditta italiana aveva effettivamente disegnato i prodotti
in Italia, sarà possibile apporre menzioni atte a qualificare il prodotto come italiano,
purchè,
ovviamente, non vengano fatte affermazioni false che, se apposte,
ricaderebbero sotto la fattispecie di cui all’articolo 517 codice penale. Nel caso
specifico, ad esempio, sarebbe stato diverso se fosse stato scritto sugli occhiali, invece
che “Conceived in Italy”, “produced in Italy”, in quanto sarebbe stata un’affermazione
senz’altro falsa, integrante il reato di cui all’articolo 517 codice penale.
173
A livello comunitario nel 1996 è stato istituito e regolato il Marchio Comunitario.
L’Ufficio preposto alla raccolta delle domande di registrazione di Marchi Comunitari e
alla loro successiva registrazione è l’ U.A.M.I.. (Ufficio per l’Armonizzazione del
Mercato Interno) ed è ubicato ad Alicante, nel Sud-Est della Spagna.
Con questo nuovo istituto, si dà la possibilità ai titolari di un marchio, con un unico
deposito, di ottenere al protezione del proprio marchio in tutti i 15 Paesi dell’Unione
europea. Infatti, il marchio comunitario ha la caratteristica di produrre i suoi effetti
sull’intera Unione europea, in quanto diviene un unico titolo a valere per tutto il
territorio comunitario. I segni che possono costituire un marchio comunitario sono una
categoria piuttosto ampia: parole, cifre, lettere, ecc.. Detti segni possono essere protetti
purchè siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra
azienda. Per cui a livello comunitario si attribuisce al marchio la stessa funzione
distintiva che il nostro ordinamento riconosce al marchio nazionale. Per poter essere
registrato, al pari che nel nostro ordinamento, deve possedere carattere distintivo e non
potrà consistere esclusivamente in un’indicazione del luogo di provenienza del prodotto.
Tale ultima specificazione è importante per il tema del “made in Italy”. Il “made in
Italy” non potrà essere registrato come marchio comunitario. Inoltre il marchio
comunitario non potrà essere contrario all’ordine pubblico e indurre in errore i
consumatori. Il marchio comunitario conferisce un diritto forte: il titolare del marchio
ha il diritto di vietare a qualsiasi terzo l’uso di contrassegni identici al marchio
comunitario o che possano creare confusione nel
.
174
f) Le indicazioni di provenienza, in particolare le indicazioni geografiche e le
denominazioni di origine
Le “indicazioni di provenienza”, ammesse a forme di tutela nell’ambito della proprietà
industriale, perseguono lo scopo di fornire ai produttori tutela giuridica in relazione a
prodotti che posseggano qualità e caratteristiche direttamente collegate al luogo in cui la
merce è prodotta. Inoltre, sono volte ad evitare che i consumatori siano fuorviati circa
l’origine di specifici prodotti, allorché si ritenga che l’origine abbia un impatto diretto
sulle qualità e caratteristiche dei prodotti in questione.
La Corte di giustizia della CE ha chiaramente descritto, fin dal 1975, la portata delle
denominazioni di origine e indicazioni di provenienza: esse “devono, a prescindere
dagli elementi che possono più particolarmente caratterizzarle, possedere un requisito
minimo: (….) mettere in rilievo la provenienza del prodotto da una determinata zona
geografica. Nella misura in cui le predette denominazioni sono giuridicamente tutelate,
esse devono giustificare tale protezione, cioè apparire necessarie non solo per
difendere i produttori interessati dalla concorrenza sleale, ma altresì per impedire che i
consumatori siano tratti in inganno da indicazioni fallaci. La loro ragion d’essere
consiste precisamente nel disegnare un prodotto che possiede in effetti qualità e
caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza. Per quanto riguarda più
specificamente le indicazioni di provenienza, il collegamento con la zona geografica
d’origine deve poter evocare una qualità e caratteristiche tali da consentire una precisa
individuazione del prodotto”.130
130
Commissione della C.E. c. Germania, in Raccomandazione, 1975, 181 (punto 7);
175
Con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari ci si riferisce non alla generale
categoria delle indicazioni di provenienza, ma alle “indicazioni geografiche” e le
“denominazioni d’origine”
131
, disciplinate dal Regolamento Ce n. 2081/1992132 del
Consiglio. Queste regole stabiliscono un sistema di tutela giuridica uniforme, a livello
comunitario, delle “indicazioni geografiche protette – IGP” e “denominazioni di origine
protette – DOP”. 133134
Il presupposto della tutela riconosciuta alle indicazioni di provenienza è che vi sono
prodotti rispetto ai quali la provenienza da un determinato territorio ne determina i
caratteri e “garantisce l’invariabile presenza di alcune qualità”. Le caratteristiche che
tipizzano tali produzioni possono essere dovute esclusivamente a fattori ambientali
(suolo, sottosuolo, clima), ovvero essere condizionate anche dal fattore umano, in
particolare da”tecniche di lavorazione consolidate e tramandate nei costumi e nelle
consuetudini locali”.135
All’origine la tutela era organizzata solo a livello nazionale, tuttavia l’esigenza, da parte
di diversi stati, di proteggere le proprie produzioni tipiche negli scambi internazionali,
portò alla negoziazione di convenzioni che garantissero alle stesse una tutela reciproca
131
Per una apertura verso una rinnovata valorizzazione della “distinzione geografica dei prodotti”, la
quale riflette anche la distinzione tra i “sistemi- Paese” che stanno intorno alla società produttrice, “in
quanto complesso di cultura, tradizione, norme e garanzie che sono il retaggio industriale di un paese
(…)”, cfr. Kiflè-Perrotti, Made in Italy. Marchio di origine o di provenienza?, in Impresa, 2005, 1031.
132
Regolamento Ce del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, sulla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine sui prodotti agricoli ed alimentari (G.U.C.E. 1992 L208/1). Censure sulla
compatibilità di tale regolamento con i principi del WTO sono state avanzate dagli Stati Uniti e
dall’Australia, che hanno richiesto il 18 agosto 2003 la costituzione di un Panel. Secondo gli Stati Unii e
l’Australia il regolamento era contrario agli accordi TRIPs e GATT.
133
In dottrina sulle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche cfr. Franceschelli, Sui marchi
d’impresa, Milano, 1988, pag. 156 e ss; Sordelli, voce Denominazioni di origine e indicazioni
geografiche, in Enciclopedia del diritto, Aggiornato, vol. I, Milano, 1997, pag. 523 e ss. In giurisprudenza
per una chiara distinzione rispetto ai marchi collettivi, si veda Cassazione, sezione I, 28 novembre 1996,
n. 10587, in Giurisprudenza italiana, 1997, I, pag. 1538 e Tribunale Saluzzo 5 gennaio 2001, in
Giurisprudenza italiana, 2001, pag. 318 con nota di Ariani.
134
Sentenza del 7 novembre 2000, nel procedimento C-312/98. disponibile sul sito web: // curia.eu.int;
135
Cfr. E. Loffredo, Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche, in Rivista Diritto Industriale,
2003, n. 2, pag. 140.
176
fra gli stati aderenti. Il sistema convenzionale si implementò mediante passaggi
graduali, che si svolsero nell’arco di molti decenni.136
La Convenzione di Parigi per la proprietà industriale del 1884 include esplicitamente,
nell’ambito della proprietà industriale, le denominazioni d’origine e le indicazioni di
provenienza (articolo 1.2), senza tuttavia fornirne alcuna definizione. Nel 1981 venne
negoziato l’Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o
fallaci sui prodotti.137
Proseguendo nell’evoluzione normativa, l’Accordo di Lisbona sulla protezione delle
denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958
impegna gli stati aderenti alla protezione, sul proprio territorio, contro ogni usurpazione
o imitazione delle denominazioni di origine dei paesi aderenti, a condizione che le
stesse siano preliminarmente riconosciute e protette in tali paesi. A differenza delle altre
Convenzioni, l’Accordo di Lisbona all’articolo 2 contiene l’esplicita definizione
dell’espressione “denominazione d’origine”, intesa come “la denominazione geografica
di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che
ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o
essenzialmente, all’ambiente geografico comprendente i fattori umani e naturali”
(articolo 2).
In ambito OMC, l’Accordo TRIPs dedica alle indicazioni geografiche gli articoi 22-24,
definendole come “le indicazioni che identificano un prodotto come originario del
territorio di un membro, o una regione o località di detto territorio, quando una
determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano
essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica” (articolo 22.1). nell’Accordo
136
Per una completa ricostruzione storica si veda L. Bordelli, Indicazioni geografiche e denominazioni di
origine nella disciplina comunitaria, in Diritto Industriale, 1994, n. 9, pag. 837.
137
Cfr. Quivi, capitolo I, § 2, pag. .
177
non si fa menzione, invece, delle denominazioni di origine. Si ritiene in dottrina138 che
tale soluzione sia stata dettata dalla volontà di proporre un’unica denominazione e
definizione omnicomprensiva, che porti al superamento della distinzione tra indicazioni
geografiche e denominazioni di origine, spesso fonte di problemi interpretativi di non
facile soluzione.
La regolamentazione europea139 mantiene, invece, la distinzione classica e definisce
IGP come “il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a
designare un prodotto originario di tale area geografica, allorché una determinata
qualità del prodotto o la sua rinomanza sono attribuibili all’ambiente geografico, di cui
fanno parte fattori umani e naturali” e DOP come “il nome di una regione, di un luogo
o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e la
cui qualità o le cui caratteristiche sono attribuibili esclusivamente o in massima parte
all’ambiente geografico”.
138
Cfr. S. Sandri, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i Gatt-Trips’, Cedam, 1996, pag.
49.
139
Regolamento CE n. 281 del 1992, modificato dal Regolamento CE n. 692 del 2003.
178
g) I marchi collettivi
Si distinguono dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni d’origine, altri segni
distintivi per così dire volontari (e perciò accostabili, sotto questo profilo, ai marchi
d’impresa)140, destinati sempre a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati
prodotti o servizi. Si parla, con riferimento ad essi, di marchi collettivi, di garanzia o di
certificazione. Tale categoria è disciplinata nel nostro ordinamento dagli articoli 2570
codice civile e 11 codice della proprietà industriale.
Il marchio collettivo è il segno che garantisce non tanto la provenienza della merce da
un determinato produttore, quanto che il prodotto e il servizio, contrassegnati da detto
marchio, presentino una determinata origine o una determinata natura destinate a
riflettersi sulla qualità del prodotto o del servizio.
I marchi collettivi possono essere registrati dai soggetti, che svolgono funzioni di
garantire l’origine e la qualità di determinati prodotti e servizi, al fine di concedere in
uso detti marchi a diversi imprenditori (uso collettivo del segno)141 . All’atto della
registrazione del marchio, il soggetto, che provvede alla registrazione, deve poi
depositare un regolamento d’uso che precisi quali siano gli standard qualitativi che
coloro che faranno uso del marchio dovranno rispettare. Nel regolamento, inoltre, sono
di norma indicati i controlli cui saranno sottoposti gli utilizzatori del segno, nonché le
sanzioni a carico degli utenti per il caso di infrazione al disciplinare depositato.
140
In tal senso G. Sena, Il diritto dei marchi.., cit., pag. 249.
Cfr. A.Vanzetti – C. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2003, pag. 253 e ss. In
argomento si veda inoltre Ricolfi, in AA. VV., Diritto industriale, Torino, 2001, pag. 173.
141
179
h) Considerazioni conclusive: gli aspetti caratterizzanti il “made in Italy” dal
punto di vista della natura giuridica
Fino a quando non verrà istituito e contemporaneamente regolato il marchio “made in
Italy”, previsto dai commi 61 e 63 dell’articolo 4 della più volte citata legge finanziaria
2003, si può ritenere che, ad oggi, il “made in Italy” presenta caratteristiche comuni sia
al marchio collettivo che alla mera indicazione di provenienza142, senza poter essere
inquadrato completamente in nessuna delle esaminate categorie.
Gli elementi che avvicinano la dicitura “made in Italy” a una mera indicazione di
provenienza sono diversi.
Una prima considerazione si fonda sul dato letterale dei commi 61 e 63 dell’articolo 4
legge n. 350, nella parte che si riferisce alla campagna promozionale di tale segno
distintivo, da attuarsi anche attraverso la “regolamentazione dell’indicazione d’origine
o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel
territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine”.
Non essendo, ad oggi, il marchio ancora istituito e regolato, attualmente il “made in
Italy”, facendo riferimento al dato testuale (“.. regolamentazione dell’indicazione
d’origine…”), sarebbe protetto solo come indicazione di provenienza o, per usare
un’espressione utilizzata dall’articolo 22 della Convenzione TRIPs (poi riprodotta
dall’articolo 31 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 e da ultimo anche
142
In tal senso G. Martiello, La tutela penale…, cit., pag. 777 e ss.; A. Sirotti- Gaudenzi, Rafforzata la
tutela del “made in Italy”, cit. , pag. 135; S. Sandri, Marchi…, cit., pag. 67.
180
dall’articolo 30 del Codice della proprietà industriale), come “indicazione
geografica”143.
L’indicazione sui prodotti della provenienza geografica serve ad evocare nei
consumatori l’idea di qualità e caratteristiche dovute, a seconda dei casi, a fattori
naturali, umani e di tradizione, come la particolare qualità delle materie prime e dei
processi produttivi impiegati144 e questo sarebbe ciò che esprime, ad oggi, per
l’opinione comune, il “made in..”.
E’, sicuramente, un concetto diverso da marchio, come riconosciuto ad oggi nel nostro
ordinamento, in quanto l’indicazione del “made in Italy” non può esprimere alcun
significato in ordine alla provenienza da questo o quel produttore, né può, di
conseguenza, essere registrata in proprio dal singolo imprenditore.
In tale prospettiva viene sottolineato come il legislatore abbia riconosciuto importanza
all’ambiente geografico comprensivo non solo dei fattori naturali, ma anche di quelli
umani. E così è, non solo nell’articolo 29 del codice della proprietà industriale, relativo
proprio alle denominazioni d’origine ed alle indicazioni geografiche, ma anche nei
progetti di legge finalizzati all’istituzione del marchio “made in Italy”.145
Proprio la componente umana sarebbe quella che permetterebbe di enucleare un
concetto di “origine” da riferire ai prodotti nazionali, in rapporto ai quali (e
diversamente da quanto accade per i prodotti agro-alimentari) l’incidenza dell’ambiente
naturale sembrerebbe ininfluente.
Un’altra considerazione si fonda sul fatto che il legislatore non ha fatto rientrare il
“made in Italy” nell’ambito di applicazione delle fattispecie delineate negli articoli 473
143
Cfr. F. Cerioni, Il contrasto al commercio di merci contraffatte e usurpative e la tutela del “made in
Italy”, in Commercio internazionale, 2005, vol. 29, fasc. n. 23, pag. 13.
144
Cfr. A. Sirotti Gaudenzi, Made in Italy a prova di contraffazione, in Il codice della proprietà
industriale, dossier n. 3 del 2005 di Guida al diritto, pag. 133 e ss..
145
Al riguardo si veda la proposta di legge presentata dal deputato Contento (AC n. 472), il 4 giugno
2001 e pubblicata in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2001, pag. 411, che, all’articolo
1, considera realizzato in Italia il prodotto “ottenuto esclusivamente con il lavoro svolto sul territorio
nazionale”.
181
e 474 del codice penale, pacificamente destinate alla tutela dei soli marchi e dei segni
distintivi registrati dal singolo imprenditore, rispetto alle condotte decettive per il
pubblico circa la provenienza del prodotto.146
La finanziaria del 2004 richiama piuttosto l’articolo 517 codice penale, norma che, in
virtù della clausola di riserva che contiene, è letta come sussidiaria ed alternativa alle
disposizioni di cui agli articoli 473 e 474 codice penale, trovando applicazione solo nei
casi di violazione che non riguardino direttamente marchi o altri segni registrati147.
Questi fattori, sicuramente, portano ad avvicinare il “made in Italy” alla figura della
mera indicazione di provenienza. Altre considerazioni evidenziano che il “made in
Italy” ha altri aspetti, che lo assimilano, invece, ai marchi collettivi.
Innanzitutto
apporre il “made in Italy” non è obbligatorio, ma è una mera facoltà del produttore ed in
secondo luogo, ad oggi, l’indicazione di provenienza è usata solo per prodotti agricoli,
naturali, che senza dubbio presentano con il territorio un legame inscindibile. Per altri
prodotti, o meglio per i prodotti industriali in generale, è ancora discusso dalla dottrina,
ma anche dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, se il legame con il territorio
sia così forte da poterne giustificare la qualità. Tra i fattori utili a identificare una
indicazione di provenienza, si è sostenuto che per il “made in Italy” rileverebbe il
146
Proprio in questo senso è stato esplicitamente chiarito da A. Rossi Vannini, Diritto penale industriale,
in AA. VV., Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di A. Di Amato, vol. IV, Padova, 1993, pag.
141 e 169 che “l’unica funzione penalmente rilevante del marchio deve essere individuata (…) nel suo
porsi ad elemento identificativo del prodotto in relazione alla provenienza (costante) da una determinata
impresa. Insomma, lasciata da parte ogni considerazione circa la lavorazione o il prezzo, la tutela penale
si deve dirigere soltanto verso la fede pubblica, conseguendone che la valutazione circa la sussistenza o
meno del reato dovrà tener conto esclusivamente della contraffazione del marchio quale indicatore della
fonte d’origine”. “La contraffazione penalmente rilevante quindi,per costante interpretazione, si realizza
allorquando il marchio dei prodotti industriali viene riprodotto più o meno pedissequamente nei propri
elementi essenziali, in modo idoneo alla falsa indicazione di provenienza”.
Nello stesso senso A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, cit., pag. 437. Sul conectto di
valore identificativo di una fonte produttiva costante cfr. G. Marinucci, Il diritto penale dei marchi, cit.,
pag. 17.
147
Sui profili distintivi tra le diverse fattispecie richiamate si vedano, fra le altre. Cassazione, sez. V
penale, 26 giugno 1996, Pagano, in CED Cass. RV205552; Cassazione, Sez. V penale, 8 aprile 1981,
Federico, in Giustizia penale, 1981, II, pag. 713; Cassazione, Sez. V penale, 22 gennaio 1977, Soldano, in
CED Cass. RV135119.
182
fattore umano, ma forse è riduttivo considerare il lavoro manuale come l’unico
elemento che qualifica l’italianità di un prodotto, perchè la capacità organizzativa degli
imprenditori, il design italiano e tutta una vasta gamma di attività non sono riconducibili
al fattore meramente umano e perciò non possono essere non considerati.
Caratteristiche comuni presenta, come si diceva, con i marchi collettivi. Innanzitutto la
volontarietà della sua apposizione: ad oggi non esiste alcun obbligo per l’imprenditore
di apporre il “made in Italy”. Tale aspetto è comune anche al marchio commerciale.
Altro aspetto di somiglianza è l’impersonalità: il “made in..” non permette di venir ad
individuare questo o quel produttore, al pari del marchio collettivo.
Inoltre, come per il marchio collettivo, l’apposizione del “made in..” è possibile solo se
vengano rispettati alcuni parametri, che per il marchio collettivo sono riscontrabili nel
regolamento depositato al momento della registrazione. Invece, per l’uso del “made in
Italy”, tali parametri si ritrovano direttamente nella norma posta dal legislatore con l’
articolo 4, comma 49 della più volte citata legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004): può
apporre il “made in Italy” solo chi ha prodotto totalmente in Italia o chi ha svolto in
Italia una lavorazione o trasformazione sostanziale.
Ovviamente ci sono forti aspetti di differenza rispetto ai marchi collettivi come definiti
dall’articolo 2570 codice civile.
In primo luogo, allo stato attuale, il “made in Italy” non risulta regolamentato e per
l’utilizzo di detta espressione non è richiesta alcuna licenza, né alcuna autorizzazione.
Di fatto l’indicazione “made in Italy” si risolve, attualmente, in una dicitura
commerciale, la cui titolarità non può essere attribuita ad un soggetto privato, per cui
non può in alcun modo essere fatta rientrare nella categoria dei marchi tout court,
183
presentando elementi sia delle indicazioni di provenienza, sia dei marchi collettivi, ma
senza appartenere completamente a nessuna delle due categorie.
Sicuramente si è di fronte a una categoria nuova, che in virtù della sempre maggiore
importanza che viene data a tale dicitura necessita di un inquadramento dogmatico e di
una regolamentazione propria.
184
2- ANCORA
SULLA
NATURA
GIURIDICA:
CONSIDERAZIONI
SULL’ISTITUENDO MARCHIO “MADE IN ITALY”
Appare scarsamente coerente con il sistema dei marchi e denominazioni tutelate, specie
con riferimento all’attuale e consolidato concetto di marchio industriale, la prospettiva
affacciata nel corso dell’iter legislativo ed espressa nei commi 61 e 63 dell’articolo 4
legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), di un’eventuale e futura istituzione di un vero
e proprio marchio “made in Italy”.
Una simile disposizione, laddove attuata, porterebbe alla nascita di un istituto
radicalmente nuovo in seno alla sistematica del diritto industriale, tale da snaturare lo
stesso concetto di marchio fino ad oggi conosciuto e normato, aprendolo alla possibilità
di una titolarità non individuale, ma impersonalmente collettiva e nazionale.
Tale dicitura non potrà indicare in alcun modo la provenienza da questo o quello
specifico produttore, in ragione del fatto che lo stesso non è in alcun modo identificabile
tramite la generica indicazione “made in Italy” o “prodotto in Italia”.
I casi di diciture su prodotti che derivino dalle così dette produzioni su commissione
andranno risolti tenendo ben distinti i diversi concetti di “provenienza” (da un singolo e
identificato produttore, per quanto complesso al suo interno) e di “origine” (meramente
territoriale e dunque riferibile ad una nazione o ad un luogo fisico definito).
Così un’indicazione sulla merce che evidenzi la fonte produttiva (ossia il nome
dell’azienda produttrice) potrà risultare non veritiera, se non rappresenta correttamente nell’ambito della complessità interna a tale fonte- il soggetto industriale cui va riferita la
sostanziale responsabilità produttiva e giuridica per quella merce.
185
Al contrario le indicazioni che riportino un’indicazione territoriale (cioè il paese o la
regione) potranno risultare non veritiere, se non rappresentino correttamente la nazione
stessa di produzione delle merci, a prescindere dal nome dell’azienda produttrice.
Osservazioni critiche devono essere espresse anche nelle ipotesi in cui il futuro marchio
“made in Italy” fosse considerato un marchio collettivo.
Va precisato che i marchi collettivi possono essere registrati dai soggetti che svolgono
funzioni di garantire l’origine e la qualità di determinati prodotti e servizi, al fine di
concedere in uso detti marchi a diversi imprenditori148. I soggetti legittimati possono
essere tanto enti pubblici, quanto organizzazioni associative private (aventi di norma la
forma dell’associazione o del consorzio).
Se titolare del marchio collettivo è un soggetto privato, qualunque siano le regole
previste dal relativo regolamento non sussistono implicazioni rispetto ai principi
comunitari.
Ma la situazione è diversa qualora titolare del marchio sia un ente pubblico, come
sarebbe nel caso del “made in Italy”. Esempi di marchi collettivi di titolarità pubblica
sono alcuni marchi regionali e alcuni marchi di qualità, istituiti con appositi
provvedimenti legislativi (ad esempio i marchi “ceramica artistica tradizionale” e
“ceramica italiana di qualità”, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188).
La costante giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene incompatibile con il mercato
unico, sulla base dell’articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla
localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, “la
quale perciò limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgono in tutto o
148
In tal senso A. Vanzetti – C. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, cit., pag. 255.
186
in parte in altri Stati membri”149. A tale principio fanno eccezione unicamente le regole
relative alle denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza (DOP e IGP).
La casistica delle normative nazionali censurate in sede comunitaria è piuttosto ricca.
Si ricorda la decisione della Corte di Giustizia del 7 maggio 1997, cause riunite da C321-94 a C-324-94, Pistre e a., relativamente all’utilizzazione della denominazione
“prodotti della montagna francese”. La Corte ha affermato l’assimilabilità di tale segno
ad una indicazione di provenienza semplice e in quanto tale, operante come un marchio
di qualità diretto a promuovere i prodotti delle zone montane. Ad avviso della Corte,
l’uso della dicitura “montagna” accompagnata da aggettivazioni nazionali, ha carattere
discriminatorio nei confronti dei prodotti importati dagli stati membri, se riservata ai
soli prodotti nazionali ed elaborati a partire da materie prime nazionali ed è perciò
incompatibile con l’articolo 28 del Trattato.
Altra decisione della Corte esemplificativa Di tale giurisprudenza è la sentenza del 5
novembre 2002 (causa C-325/00), in cui la Corte ha censurato la Repubblica Federale di
Germania, per aver violato l’articolo 28 del Trattato con la concessione del marchio di
qualità “Markenqualitat aus deutschen Landen” (qualità di marca della campagna
tedesca), in quanto il messaggio pubblicitario, sottolineando la provenienza tedesca dei
prodotti, “può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio
(…) escludendo quelli importati”.
In materia di marchi regionali, con decisione del 6 marzo 2003 (causa C-6/02) la Corte
ha altresì affermato la responsabilità della Repubblica Francese, la quale “non avendo
posto fine, entro il termine prefissato nel parere motivato, alla protezione giuridica
nazionale concessa alla denominazione “Salaisons d’Auvergne”, “Normandie”, “Nord-
149
Corte di Giustizia Europea, 12 ottobre 1978, causa 13/78, (Eggers Sohn et Co contro Città di Brema),
in Raccolta, 1979.
187
Pas-de-Calais”, “Limousin” e “Lorrain” (…) è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’articolo 28 CE”.
Alla luce dei sovrastanti principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia,
brevemente ripercorsa, è difficile ritenere che un eventuale marchio collettivo di
titolarità pubblica, finalizzato ad identificare il “made in Italy” (quindi finalizzato a
identificare genericamente le produzioni realizzate in Italia) possa sfuggire alle censure
delle istituzioni comunitarie.
188
3. INDIVIDUAZIONE DEL BENE TUTELATO DALLE NORME SUL “MADE
IN ITALY”: OPINIONI CONTRASTANTI
Dottrina, giurisprudenza ed esperti del settore si sono interrogati su quale sia l’interesse
tutelato dalle norme extra codicem di nuovo conio poste a tutela del “made in Italy”.
Le proposte sul tema sono le più diverse: tutela del consumatore, tutela delle imprese
che producono interamente sul territorio italiano, tutela delle aziende che hanno delocalizzato parte della produzione150 od infine, come alcuni sostengono, rinnovata
rilevanza della tutela dell’ordine economico nazionale.
Sul tema del “made in Italy”, infatti, convergono, da un lato, istanze “protezionistiche”,
volte ad arginare la fuga dei produttori italiani all’estero, cercando di tutelare il mercato
interno dagli eventuali contraccolpi della globalizzazione all’economia nazionale e di
tutelare gli imprenditori che mantengono tutta la produzione in Italia e per questo sono
svantaggiati in termini di concorrenzialità; dall’altro le richieste degli imprenditori e
delle stessa economia di mercato di poter de-localizzare parte del processo produttivo
all’estero, per cercare di avere maggiore competitività sul mercato mondiale.
Inoltre, in tale quadro, si inserisce il consumatore, non più passivo acquirente di prodotti
standardizzati, ma sempre più attento alla provenienza nazionale, intesa come garanzia
di qualità. Non è un caso che proprio la FIAT, cioè l’azienda che per prima aveva
portato all’attenzione dei tribunali la questione della de-localizzazione nel 1999151,
imposti oggi, dal 2006, la campagna promozionale per la vendita delle proprie vetture
sulla localizzazione dell’intero processo produttivo nel territorio nazionale.
150
Si deve considerare che secondo i dati reperibili sul sito dell’Assonime ad oggi le imprese che delocalizzano parte della produzione sono solo il 7-8%, ma la percentuale è destinata ad aumentare in
maniera esponenziale.
151
Cfr. sentenza Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 2500 del 1999, Thun, cfr. cap. 1, § ,
pag.
189
Tale panorama evidenzia l’incertezza che aleggia in questo campo.
La corretta individuazione della ratio della norma
è molto importante, in quanto
permette la corretta interpretazione di tali difficili disposizioni, offrendo nel contempo il
criterio ispiratore per la formulazione delle nuove proposte di disciplina della tutela del
“made in Italy”.
190
a) Il
consumatore:
soggetto
non
più
passivo
che
compra
prodotti
standardizzati
Prima di procedere ad individuare come e in quali termini il consumatore è interessato
dalle norme del “made in Italy” occorre soffermarsi sul concetto di consumatore.
Senza alcuna pretesa di esaustività si possono richiamare alcune definizioni, anche
normative, sia in sede comunitaria che in sede nazionale, premettendo che su tale
nozione, anche in giurisprudenza, vi sono state differenti interpretazioni che hanno
contribuito a creare una certa confusione.
In Europa, già nella Convenzione di Bruxelles del 1968 (articolo 13) si definisce
consumatore chi agisce “per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua
attività professionale”, definizione ripresa dall’articolo 5 della Convenzione di Roma
del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Recentemente la Corte di Giustizia della comunità europea ha stabilito che spetta al
giudice determinare se un contratto sia stato concluso per soddisfare esigenze
professionali rilevanti oppure se le stesse siano insignificanti, riconoscendo che nel
contesto complessivo del contratto possono anche manifestarsi entrambe le esigenze.152
Varie direttive comunitarie si riferiscono inoltre specificatamente al consumatore,
considerandolo, in genere, come la persona fisica che agisce in ambito diverso
dall’attività di impresa o professionale.
Nell’ambito della legislazione italiana, ci sono diverse disposizioni che, direttamente o
indirettamente, fanno o facevano riferimento al consumatore.
152
Cfr. sentenza Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, n. C-464/01.
191
La legge n. 126 del 1996 conteneva le “Norme per l’informazione del consumatore” e
all’articolo 3 tra le definizioni considerava consumatore “la persona fisica che
nell’acquisto o nella utilizzazione dei prodotti…agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla sua attività professionale”.
Nello stesso periodo sono stati emessi vari altri provvedimenti che, pur comprendendo
campi diversi, avevano quale scopo generale di garantire la tutela del consumatore,
come ad esempio il decreto legislativo n. 733 del 1992 (prodotti che avendo un aspetto
diverso da quello che sono in realtà compromettono la salute o la sicurezza dei
consumatori); il decreto legislativo n. 74 del 1992 (pubblicità ingannevole); il decreto
legislativo n. 76 del1992 (prezzi su prodotti alimentari); il decreto legislativo n. 78 del
1992 (prezzi su prodotti non alimentari).
Con la così detta legge quadro n. 281 del 1998 ha fatto apparizione la nozione di
“utente” accanto a quella di consumatore e sono state in qualche modo codificati i diritti
fondamentali riconosciuti a tali soggetti.
Il decreto legislativo n. 24 del 2002, in attuazione della direttiva CE n. 44 del 1999,
riguardante taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, ha poi ribadito la
definizione di “consumatore” all’interno del codice civile, inserendo gli articoli 1519
bis e seguenti.
Molte altre normative specifiche riguardano il consumatore ed in linea di massima si
può dire che la ratio delle diverse disposizioni attiene a due grandi ambiti: la tutela del
consumatore e l’informazione al consumatore.
Alcune norme del codice penale (articolo 474 “Introduzione nello stato e commercio di
prodotti con segni falsi”; articolo 515 “Frode nell’esercizio del commercio”; articolo
517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”,come integrato dall’articolo 1
comma 10 del decreto legislativo n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005)
192
sono orientate alla difesa del consumatore dalla contraffazione e dall’inganno, mirando
a tutelare la possibilità di autonoma scelta e valutazione dei prodotti offerti.
Le regole sul “made in..”, cioè le regole che individuano l’origine di un prodotto, si
inseriscono, sicuramente, tra le disposizioni volte a tutelare, almeno in senso lato, anche
i consumatori. Più specificamente, si reputa che si tratti di disposizioni finalizzate
all’informazione al consumatore, il quale è, sicuramente, orientato nelle sue scelte
anche a seconda della provenienza del prodotto.
L’indicazione “made in Italy” inizialmente utilizzata dai produttori nazionali per
individuare l’origine geografica dei prodotti, ha, nel corso degli anni, assunto un valore
ulteriore rispetto a quello di mero indicatore di provenienza geografica, diventando
l’emblema di numerosi valori (qualità, estetica, design, tecnologie, ecc.) connessi al
fatto che la produzione avvenga in Italia.
La dicitura “made in Italy” ha un indubbio valore attrattivo e non è da escludere che il
consumatore preferisca acquistare un prodotto realizzato in Italia o perché intenzionato
a sostenere l’impresa italiana, o perché convinto che esso sia qualitativamente superiore
ad uno stesso prodotto, ma fabbricato altrove.
Il “made in Italy”, infatti, veicola ormai un messaggio riconosciuto in tutto il mondo e
questo a differenza di quanto accade con riguardo ad analoghe indicazioni di
provenienza di altri paesi.
In considerazione del fatto che, all’expertise italiano è ricollegabile un “valore
aggiunto” di tipo qualitativo, capace di influire nelle scelte dei consumatori, l’oggetto
protetto dalle norme extra codicem poste a tutela del “made in Italy”, quali è
l’incriminazione ex articolo 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 risulterà, sicuramente,
orientato alla difesa del consumatore contro le potenziali frodi sulle qualità funzionali
dei prodotti industriali.
193
Alcuni esperti153 del settore hanno negato che l’interesse tutelato dalle norme sul “made
in Italy” sia l’affidamento del consumatore, basando le loro argomentazioni su due
ordini di idee: in primo luogo sostenendo che la norma farebbe riferimento non solo
all’importazione, ma anche all’esportazione ed in secondo luogo, evidenziando che
l’articolo 517 codice penale non rientrerebbe tra le norme a tutela della fede pubblica, a
differenza dell’articolo 474 codice penale, bensì in quelle a tutela dell’industria e
commercio154.
Il consumatore resta, però, sicuramente uno dei soggetti più interessati all’informazione
sull’origine delle merci. Qualsiasi normativa, che verrà coniata a tutela del “made in
Italy”, dovrà tener conto dell’esigenza dei consumatori a non venir ingannati circa la
provenienza e origine dei prodotti. Non è un caso che il recente codice del consumo,
all’articolo 6, anche se non ancora attuato, nella lettera c) richieda tra le informazioni
che i prodotti destinati a consumatori devono riportare l’indicazione del paese di
origine, se situato fuori dall’Unione europea.
153
Cfr. intervento del dott. E. Forte, direttore affari giuridici e contenzioso agenzia dogane di Bologna, al
Convegno “La tutela del made in Italy attraverso la proprietà industriale”, Bologna 2 dicembre 2004
presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Bologna.
154
Cfr. capitolo I, § 1.a: oggetto materiale dell’articolo 517 codice penale, pag. 11.
194
b) La tutela penale del “made in Italy” nel mercato globalizzato: salvaguardia
del sistema produttivo nazionale
Una riflessione che sicuramente merita di essere analizzata è quella che vede nelle
norme a sostegno del “made in Italy” una rinnovata rilevanza della tutela dell’ordine
economico.
Come detto all’expertise italiano è ricollegabile e riscontrabile sul piano empirico “un
valore aggiunto” qualitativo, rispetto a beni dello stesso tipo, ma non originari
dall’Italia.
Nella fattispecie prevista dalla finanziaria 2003 e successive modifiche, però, non
risultano esservi riferimenti al potenziale inganno dell’acquirente sulla qualità della
merce e ciò potrebbe permettere di ampliare l’orizzonte di tutela della fattispecie,
inducendo a considerare tipica la commercializzazione di prodotti originari dall’Italia e
nondimeno marchiati “made in Italy” anche laddove la loro italianità non sia traducibile
in un apprezzabile quid pluris qualitativo155.
Rispetto a tale prospettiva è interessante la riflessione svolta da alcuni autori, secondo
cui che affermano che si potrebbe arrivare a sostenere che l’oggetto della tutela sia da
rinvenire nel sistema produttivo nazionale156.
Nell’attuale momento storico è fortemente avvertita l’esigenza di salvaguardare
l’assetto del rapporto capitale-lavoro, ponendo dei limiti esterni alla libertà di iniziativa
155
Cfr. G. Martiello, La tutela del “made in Italy” nel mercato globalizzato: tra difesa del consumatore e
salvaguardia del sistema produttivo nazionale, cit. , pag. 785.
156
Si legge nella proposta di legge n. 4001 della XIV legislatura: “il sistema produttivo italiano per sua
natura è proiettato verso i mercati esteri. Si ricordi che dalla metà degli anni ’90 i settori dell’alta
qualità italiana (scarpe, moda, arredo, alimentazione, meccanica) hanno assicurato un bilancio positivo
annuale di circa 70-75 miliardi di euro (…). Tali settori basati principalmente su piccole e medie imprese
rappresentano i due terzi della occupazione manifatturiera italiana e costituiscono un elemento di
progresso, di coesione e orgoglio”.
195
economica sancita dall’articolo 41 della Costituzione157. Se si considerasse il sistema
produttivo nazionale quale oggetto di tutela delle norme poste a tutela del “made in
Italy”, si riuscirebbero a comprendere i tentativi effettuati dal legislatore di scoraggiare
le de-localizzazioni produttive all’estero, concedendo agevolazioni fiscali alle imprese
che producono interamente in Italia (articolo 1, comma 12 e 13 del decreto legge n. 35
del 2005).158159
Non si può non rilevare che una simile interpretazione rievoca inevitabilmente il
concetto di “economia pubblica” in chiave di oggettività giuridica e ciò genera un
paradosso: mentre, infatti, il diritto vivente e la dottrina si sforzano di interpretare in
chiave evolutiva il delitto di cui all’articolo 517 codice penale per andare incontro alle
esigenze di difesa del consumatore, spogliandolo progressivamente degli ordinari
connotati ideologici160, proprio questi connotati di stampo ideologico, legati a un
patriottismo di impronta nazionalista, sarebbero in buona parte recuperati dalla
fattispecie di nuovo conio.
In dottrina già da tempo si sono sottolineati i limiti del concetto di “economia
pubblica”161: da un lato, si è evidenziato come sia un concetto intriso di una
157
Sul rapporto tra la libertà di iniziativa economica e limiti ad essa posti dallo stesso articolo 41 della
Costituzione, cfr. P. Patrono, Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, Padova, Cedam,
1993, pag. 15 e ss..
158
N. Picchi, in Marchio d’origine: ipotesi di tutela del “made in Italy” e quadro normativo
internazionale, che può leggersi in www.filodiritto.com, dubita della legittimità di una simile
interpretazione ermeneutica rispetto ai vincoli che derivano al nostro Paese dall’appartenenza al sistema
multilaterale dell’O.M.C..
159
In questo quadro si inserisce l’articolo 12 del decreto legge del 2005 convertito nella legge n. 80 del
2005, la così detta legge sulla competitività, che esclude infatti dai benefici di cui alla legge 100 del 1990,
al decreto legislativo 143 del 1998 ed alla legge 273 del 2002 le imprese che non prevedono il
mantenimento in Italia anche di una parte sostanziale delle attività produttive, dando un segnale della
rilevanza politica del luogo della materiale produzione del bene.
160
Cfr. C. Pedrazzi, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia, in Diritto penale, vol.
II, Milano, 2003, pag. 385. Nello steso senso in riferimento all’articolo 517 codice penale G. Fornasari, Il
concetto di economia pubblica nel diritto penale, Padova, 1994, pag. 126. Inoltre si veda G. Martiello, Il
delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci: profili interpretativi e ricostruttivi, cit., pag.
705 e ss..
161
Cfr. C. Pedrazzi, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Enciclopedia
del diritto, vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1967, pag. 279, che parla di “insieme delle attività economiche che
si svolgono nell’ambito nazionale, fatte oggetto di una considerazione globale (…) in quanto confluenti
in un sistema unitario”, penalmente tutelate quali espressione della forza e del prestigio dello Stato.
196
inaccettabile matrice ideologica, dall’altro, si è criticata la sua inidoneità ad esprimere il
contenuto offensivo delle fattispecie ad esso riferibili. Si è sostenuto che tale concetto
possa al massimo essere considerato ratio di tutela dei reati di cui al titolo VIII, Libro II
del codice penale162.
Tali obiezioni, di principio inoppugnabili, debbono tuttavia essere calate nell’attuale
realtà163.
La dottrina più attenta ad interpretare le tendenze del moderno ordinamento ha
registrato il progressivo mutamento del fondamento giustificativo dell’intervento
penale, non più necessariamente incentrato sulla tutela dei beni giuridici ricavabili
soltanto dal tipo legale. In molti casi l’interprete ha ricercato gli interessi tutelati al di
fuori della configurazione del fatto tipico, operando una trasformazione del contenuto
dell’illecito da offesa intranea alla norma ad offesa assume spesso le forme del pericolo,
apprezzabile soltanto in una più ampia dimensione teleologica. Si spiega, infatti, che i
valori espressi dalla Costituzione, quali ad esempio l’ambiente, la salute, l’economia
pubblica, non debbano intendersi come puntuali beni giuridici, bensì “referenti di
scopo” che richiedono la predisposizione di “programmi di tutela”, nel cui contesto la
fattispecie penale svolge il ruolo importante, ma non assorbente rispetto agli strumenti
extrapenali, di “presupposto preliminare”.164
162
Cfr. C. Pedrazzi, voce Economia pubblica,.., cit., pag. 279; F. Lemme, Riflessioni sul bene giuridico
tutelato nelle incriminazioni di aggiotaggio, in Cassazione penale, 1987, pag. 2272; M. Parodi Giustino, I
reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, pag. 48 e 52; E. Lo Monte, Le
disfunzioni dell’intervento penale in tema di criminalità economica, in Industria penale, 1999, pag. 1125.
Per un’ampia critica mossa a tale concetto, cfr. N. Mazzacuva – C. Costi, I delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, codice penale, parte
speciale, vol. V, diretta da Bricola- Zagrebelsky, Torino, 1996, pag. 234; G. Fornasari, Il concetto di
economia pubblica nel diritto penale, Padova, Giuffrè, 1994.
163
Cfr. G. Martiello, La tutela penale del …, cit., pag. 787.
164
Cfr. per la citazione testuale G. A. De Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale,
Torino, 2004, pag. 51. Sulla compatibilità dell’economia pubblica con i valori costituzionali, si veda
sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1976 n. 123, in Foro italiano, 1976, fasc. n. I, pag. 2080,
nonché, in dottrina, P. Patrono, Diritto penale.., cit., pag. 6, nota 10.
197
L’idea, quindi, di rinvenire il referente finale della tutela penale sempre e comunque in
un bene giuridico risulterebbe inadeguata, poiché, essendo divenuta la sanzione
criminale parte di un più articolato programma di tutela, non sarebbe affatto escluso che
essa si possa appuntare su condotte di per sé non espressive di offese ad un bene
giuridico autonomo: così, mentre quest’ultimo concetto pare subire una progressiva
erosione rispetto al suo originario contenuto euristico, gli “scopi” della tutela si
imporrebbero all’attenzione dell’interprete.165
In tal senso si potrebbe spiegare la rinnovata considerazione dell’economia pubblica
quanto meno in termini di referente di scopo del citato articolo 4, comma 49 legge n.
350/2003 tanto più nell’attuale e contingente quadro economico mondiale. In effetti, gli
attacchi che nel mercato globalizzato svariati paesi (in particolare si pensi alla Cina)
stanno portando alla sopravvivenza di interi settori dell’industria italiana ed europea
sono evidenti ed oggetto di continua riflessione da parte di vasti settori dell’opinione
pubblica. L’esigenza di rilanciare l’efficienza di determinati comparti industriali, ma
anche di irrigidire la difesa del sistema economico nazionale, preservandolo dalle più
sleali forme di aggressione, risulta ormai generalmente avvertita. Questo può aver
accreditato, anche presso il legislatore, l’idea che il sistema ex se possa tornare ad essere
legittimo referente della sanzione penale.
165
G. Martiello, La tutela penale del…, cit., pag. 672.
198
c) Le imprese italiane: i soggetti maggiormente interessati alle norme
sull’origine imprenditoriale e geografica dei prodotti
L’attuale assetto della tutela della proprietà industriale, rappresenta il punto di equilibrio
tra le opposte esigenze di tutela della capacità imprenditoriale acquisita da determinati
soggetti (desiderosi di proteggere le proprie idee inventive e di differenziare la propria
azienda e i propri prodotti da quelli dei concorrenti) e la libertà dell’iniziativa
economica.
Si deve ricordare che la difesa della proprietà industriale si è andata sviluppando sul
piano internazionale di pari passo con la globalizzazione dell’economia. Già nel corso
del 1800, infatti, lo sviluppo dei traffici ha generato in capo agli imprenditori il bisogno
di proteggere dai concorrenti lo sfruttamento economico delle idee inventive e dei
prodotti che, più di altri, incontravano il gusto dei consumatori. A tal fine nel 1883 fu
stipulata la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che aveva
ad oggetto la tutela delle invenzioni, dei marchi, dei disegni industriali, dei modelli di
utilità dei nomi di commercio e la repressione della concorrenza sleale.
Tuttavia è a partire dagli anni ’70 che i fenomeni della pirateria e della contraffazione
hanno conosciuto un incremento notevole e si è riscontrata l’inefficacia delle
disposizioni della convenzione di Parigi, priva di un sistema sanzionatorio adeguato.
A partire da questi anni, infatti, la crescita delle economie dei paesi in via di sviluppo ha
incentivato l’importazione di beni prodotti nei paesi industrializzati ma, nel contempo,
ha favorito anche la produzione a basso costo degli stessi da parte delle industrie locali,
spesso controllate da imprese estere o finanziate con capitali stranieri.
199
Da qui l’avvio delle trattative nell’ambito dell’Uruguay Round per l’approvazione di
una nuova convenzione multilaterale per la tutela della proprietà industriale. Dette
trattative sono state influenzate da due opposti interessi: da una parte i paesi
industrializzati, che vogliono rafforzare la tutela della proprietà intellettuale e dall’altra
parte i paesi in via di sviluppo, che vorrebbero ridurre l’incidenza nelle proprie
economie delle privative industriali.
Un’analoga tensione tra autorità e libertà può riscontrarsi oggi in relazione alle
disposizioni introdotte dalla finanziaria 2004, legge n. 350/2003, relative all’origine dei
prodotti.
La valorizzazione del “made in Italy” come indicazione geografica, pur facendo fronte
alla necessità di evitare la rilevante perdita di posti di lavoro nel settore industriale,
causata dall’esternalizzazione della produzione, contrasta con gli interessi di molti
imprenditori nazionali. Si tratta di quelli che, a partire dagli ultimi decenni del XX
secolo, si sono garantiti la competitività sul mercato globale attraverso l’impianto
diretto di attività produttive o l’instaurazione di stretti rapporti commerciali
(specialmente con la stipulazione di contratti di sub-fornitura) con imprese operanti in
quei paesi in cui si può ancora rinvenire manodopera a basso costo e, spesso,
legislazioni meno onerose per l’esercizio dell’attività d’impresa (le quali, ad esempio,
impongano minori oneri sociali nonché minori garanzie per la sicurezza dei lavoratori e
la salvaguardia dell’ambiente). Le imprese, infatti, si affrancano sempre più dal vincolo
territoriale e ricercano le soluzioni più vantaggiose, puntando alla de-localizzazione
della propria produzione, per affrontare la concorrenza, in ragione dei bassi costi della
mano d’opera o di condizioni fiscali o giuridiche più favorevoli.
L’Italia non ha ancora fatto grossi investimenti in Cina, a differenza degli Stati Uniti ed
altre nazioni europee, ma è rimasta, al momento, l’est europeo come punto di
200
riferimento per il decentramento della produzione (la Romania, per esempio, è definita
la nona provincia del Veneto).
Pertanto il problema che si è posto, già all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni, è se l’ordinamento garantisca, oltre al diritto dell’imprenditore italiano di
contrassegnare in modo unitario, col proprio marchio, prodotti provenienti da realtà
produttive comunque collegate all’impresa italiana, anche quello di omettere
l’indicazione del luogo esatto della produzione della merce, accanto alla menzione della
propria sede in Italia, e se le carenze di tutela della proprietà intellettuale siano da
imputare solo alla mancanza di efficaci azioni di contrasto alle frodi da parte delle
autorità competenti ovvero dipendano, in qualche modo, anche dai contrastanti interessi
degli attori del mercato, che si riflettano in complessi normativi di cui risulta difficile il
coordinamento sistematico.
Si è sostenuto che il soggetto realmente tutelato dalle norme di nuovo conio sia
l’imprenditore che mantiene tutta la produzione in Italia, ma a ben vedere forse non è
nemmeno questo il soggetto tutelato, in considerazione che ben presto la quasi totalità
delle industrie italiane hanno progetti futuri di de-localizzazione, per cui norme che ora
vengono richieste da parte degli industriali, ben presto potrebbero essere criticate da
questi stessi imprenditori.
201
d) L’”italianità” dei prodotti quale interesse tutelato dalle norme sul “made in
Italy”
Alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti non si può negare che tutti gli
interessi affermati dai diversi soggetti coinvolti nella questione dell’origine dei prodotti
siano veritieri e degni di tutela. È difficile, se non impossibile, rispondere
negativamente alle esigenze di completa informazione dei consumatori, ma di converso,
in un’economia globalizzata come è quella in cui viviamo, non si può negare agli
imprenditori di poter de-localizzare parte della produzione all’estero, caratterizzando
comunque i propri prodotti come espressione dell’expertise italiano, se lo sono.
A mio giudizio, pur essendo tutti questi valori inevitabilmente sottesi alle norme in
questione, quello che dovrebbe risultare quale essere il bene tutelato è il valore aggiunto
che il “made in Italy” può dare alla produzione italiana.
I beni italiani si vendono all’estero per il solo fatto che c’è scritto “made in Italy”,
soprattutto in alcuni settori in cui viene riconosciuta all’Italia una indiscutibile
leadership: abbigliamento, calzature, arredamento, ecc..166.
La produzione italiana è sinonimo nel mondo di eccellenza, di creatività, di cura e
attenzione dei particolari, di stile: è proprio a tale quid pluris che si deve guardare per
ricercare il bene che le norme del “made in Italy” dovranno tutelare.
La politica ha riconosciuto l’esigenza di impedire che il buon nome del “made in Italy”
sia danneggiato da false o fallaci indicazioni sull’origine che facciano passare per
prodotti in Italia dei beni che sono invece “made in China” ed ha trasfuso nella
166
Cfr. M. Fortis, Il made in Italy, Il Mulino, Bologna, 1998, pag. 33.
202
finanziaria 2003 tale esigenza. Forse, però, il legislatore avrebbe dovuto fare testuale
riferimento al valore aggiuntivo del “made in Italy”.
Si tratta di misure intese a valorizzare “l’italianità” di determinate produzioni, ovvero la
maggiore qualità che, in determinati settori di eccellenza, le industrie nazionali sono in
grado di assicurare. 167
167
Sul punto si veda anche Forte, Repressione dei traffici di merci contraffate usurpative, in Cerioni,
Forte, Palacchino, Il diritto tributario comunitario, Milano, Il Sole 24 ore-Pirola, 2004, p. 1001.
203
4. FONTI NORMATIVE DELLA TUTELA DEL “MADE IN ITALY”. LA
CONDOTTA INCRIMINATA.
Dall’esame effettuato nei capitoli precedenti si desume che le fonti normative che
regolano l’apposizione della dicitura “made in Italy” sui prodotti sono: il Regolamento
CE n. 2913 del 1992 che istituisce il codice doganale comunitario, l’articolo 517 codice
penale, l’Accordo di Madrid del 1891 (ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676 ed
integrato dalle norme per la sua applicazione del d. P. R. 26 febbraio 1968, n. 656),
l’articolo 4 comma 49 della legge finanziaria 2004, integrato dal decreto legge 14 marzo
2005 n. 35 e dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e le nuove norme introdotte dal
recente codice del consumo ( decreto legislativo n. 206/2005).
Tale complessa disciplina pone, evidentemente, problemi interpretativi e soprattutto di
coordimento.
L’Accordo di Madrid vieta l’apposizione sul prodotto di indicazioni false o fallaci circa
l’origine, disponendo l’eventuale fermo in dogana, e precisando che il venditore può
indicare sul prodotto il suo nome ed il suo indirizzo, ma se il prodotto è realizzato
all’estero deve aggiungere l’indicazione del luogo di produzione (articolo 3).
Altra norma generale è l’articolo 517 codice penale, che vieta la vendita di prodotti
industriali con marchi, nomi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore
sull’origine del prodotto.
204
La Corte di Cassazione ha sempre interpretato l’articolo 517 codice penale nel senso
che l’origine che rileva è solo l’origine imprenditoriale e non quella geografica, la quale
per nulla incide sulla qualità del prodotto.168
L’articolo 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 statuisce che è reato ai sensi
dell’articolo 517 codice penale, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione,
di prodotti “recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine”, intendendo
per “falsa indicazione” l’espressione “made in Italy” apposta su prodotti o merci non
originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine.
Tale normativa crea delicati problemi interpretativi quando un prodotto è il risultato di
diversi contributi (progettazione, styling, materia prima, fabbricazione, assemblaggio, ..)
realizzati in diversi paesi e da diverse imprese, a loro volta facenti o meno riferimento a
un medesimo gruppo societario.
Inoltre aggiunge che “costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata
l’origine e la provenienza estera dei prodotti, l’uso di segni, figure o quant’altro possa
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana”.
L’espressione “fallace indicazione” descrive, dunque, una fattispecie decettiva più
ampia della “falsa indicazione” costituita dall’espressione “made in Italy”.
Dalle sentenze analizzate si rileva, inoltre, che, nella maggior parte delle pronunce, la
Suprema Corte considera che “relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità
dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine deve intendersi quella
imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la
responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo”.
Viceversa nel caso di prodotti agro-alimentari, la cui qualità è connessa in modo
rilevante all’ambiente geografico in cui sono coltivati, trasformati o elaborati. Per
168
Si veda sentenza Thun, capitolo 1, § , pag.
;
205
questa categoria di prodotti “per origine del prodotto deve intendersi propriamente la
sua origine geografica o territoriale”169.
Con la legge n. 296 del 2006 (c.d. finanziaria 2007) è stata infine prevista una ipotesi di
reato ex articolo 517 codice penale, costituita dall’uso “fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”. Come
analizzato precedentemente si è visto come il riferimento sia da effettuarsi alla Direttiva
2005/29/CE dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali e in
particolare all’articolo 6 (Azioni ingannevoli) e all’articolo 7 (Omissioni ingannevoli).
Alla luce dell’interpretazione di tale sistema normativo effettuata dalla giurisprudenza,
in particolare dalla terza sezione della Corte di Cassazione e dall’Agenzia delle Dogane,
ad oggi, un’azienda può apporre la dicitura “made in Italy” su un prodotto quando:
a- tale prodotto è stato interamente fabbricato in Italia;
b- ha subito in Italia una fase di trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del
processo di fabbricazione (ai sensi del codice Doganale comunitario,
Regolamento CE 2913 del 1992).
Per individuare la lavorazione “sostanziale”, se si tratta di prodotti
tessili si deve far riferimento alle apposite liste di lavorazione
contenute nel Regolamento CE 2454 del 1993, nel caso di altre
169
Cfr. S. Masini, Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del “made in Italy”, nota a
Cassazione sez. III penale 23 settembre 2005, n. 34103, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e
dell’ambiente, fasc. n. 12, 2005, pag. 689, per il quale anche se non si arriva e registrare un marchio di
denominazione o un indicazione geografica, ciò che rileva per l’ordine economico, inteso come
protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l’origine territoriale.
206
categorie di prodotti, si deve far riferimento alle liste che li
riguardano negli allegati 10 e 11 del medesimo Regolamento; e nel
caso di prodotti non contenuti in nessuna lista, alla posizione e alle
relative liste stilate dalla Unione europea nell’ambito dei negoziati
dell’OMC.
Al riguardo in tale ipotesi, in caso di abbigliamento, la Suprema
Corte di Cassazione ritiene sufficiente che in Italia avvenga
l’assemblaggio del prodotto, cioè l’unione delle varie parti del capo
di abbigliamento in modo che sia reso indossabile.
In presenza di tali condizioni, un’azienda potrà, ad oggi, apporre la dicitura “made in
Italy” sul prodotto.
Se la suddetta dicitura sarà apposta in mancanza di dette prescritte condizioni,
l’imprenditore sarà punito ai sensi dell’articolo 517 codice penale e dell’articolo 4,
comma 49 legge n. 350/2003, senza considerare che la merce su cui è illegittimamente
apposta la dicitura “made in Italy” verrà sottoposta a sequestro ed eventualmente
distrutta.
In conclusione, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione un’azienda che delocalizza il processo produttivo (fenomeno dell’off-shoring) può importare in Italia i
propri prodotti fatti fabbricare e/o confezionare all’estero, senza dover specificare il
luogo dove tali prodotti sono stati fabbricati e/o confezionati (a meno che non si tratti di
prodotti alimentari) e senza incorrere nel reato e nelle sanzioni di cui all’articolo 517
codice penale, integrato dall’articolo 4 comma 49 legge 350/2003. Tale azienda
nazionale può, inoltre, a prescindere dell’effettivo luogo di lavorazione dei prodotti,
apporvi il proprio marchio o i propri segni distintivi. Se l’imprenditore nazionale non si
207
limita ad apporre al prodotto commissionato a terzisti il proprio marchio, ma faccia uso
di nomi, segni distintivi o altre indicazioni che possano indurre che il prodotto sia
fabbricato direttamente dall’imprenditore e/o in una determinata zona geografica, in
tutti questi casi ci si ritrova in una zona grigia, dipendendo l’applicazione della norma
penale
dalla
concreta
attitudine
ingannatoria
delle
indicazioni
utilizzate
dall’imprenditore.
Secondo la giurisprudenza, peraltro, neppure l’indicazione errata o imprecisa del luogo
di fabbricazione sarebbe sufficiente per integrare gli estremi del reato, quando fosse
comunque possibile ricondurre il prodotto a una determinata organizzazione aziendale.
A tutto ciò si devono aggiungere le implicazioni legate a un diverso testo normativo:
l’istituzione del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
Da quando entrerà in vigore l’articolo 6 lettera c) del decreto legislativo, a nulla varrà
l’interpretazione della Corte di Cassazione. Infatti, il dettato legislativo è molto chiaro:
sui prodotti commercializzati sul territorio nazionale dovrà essere necessariamente
riportato il riferimento al Paese di origine del prodotto se situato fuori dell’Unione
europea ( lettera c) articolo 6). La violazione di questa norma comporta sanzioni di
natura amministrativa e non penale (articoli 11 e 12 del Codice del Consumo).
Ci si chiede cosa intende in questa sede il legislatore con il termine “origine”, vale a
dire se sia necessario riportare sul prodotto la menzione del luogo, situato fuori
dall’Unione europea, in cui il prodotto ha subito una qualsiasi lavorazione anche
minima o se con origine si faccia riferimento a una particolare fase di lavorazione.
Sembrerebbe che il riferimento sia anche in questo caso a una “lavorazione sostanziale”,
con la conseguenza che qualora un’azienda commercializzi un prodotto che ha subito
una lavorazione sostanziale secondo i criteri comunitari doganali fuori dal territorio
208
dell’Unione europea, dovrà apporre oltre al proprio marchio anche la menzione del
luogo in cui il prodotto ha subito la lavorazione. Se, invece, un’azienda de-localizza
totalmente il proprio processo produttivo, ma lo fa all’interno dell’Unione europea,
potrà importare il prodotto apponendovi il proprio marchio senza specificare il luogo
materiale di fabbricazione.
209
a) Il coordinamento tra l’articolo 517 codice penale e l’articolo 4, comma 49,
legge n. 350/2003 (così detta finanziaria 2003)
Una prima osservazione riguarda la relazione tra l’articolo 517 codice penale e l’articolo
4, comma 49 della legge n. 350/2003 e sue successive integrazioni.
Deve osservarsi che la prima frase del vigente articolo 4, comma 49 non aggiunge nulla
a quanto già disposto dall’articolo 517 codice penale. Allo stesso modo rientra
altrettanto certamente nella fattispecie di cui all’articolo 517 codice penale la seconda
frase riferita alla stampigliatura “made in Italy”.
Con riguardo alle “fallaci indicazioni” si deve evidenziare una importante differenza
rispetto all’articolo 517 codice penale. La norma codicistica si riferisce all’inganno del
“compratore”, la norma extra codicem riguarda indicazioni atte ad indurre in errore il
“consumatore”. La norma della finanziaria risulta molto più specifica rispetto
all’articolo 517 codice penale e parrebbe riferirsi esclusivamente a prodotti destinati al
“consumatore finale”.170
Potrebbe quindi ritenersi che le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 49 deroghino
in quanto norme speciali (ex articolo 15 codice penale) alla norma più generale
dell’articolo 517 codice penale: il reato di “falsa indicazione”, ed in particolare la
dicitura “made in Italy” su prodotti non originari dall’Italia, sarebbe riferibile a tutti i
prodotti industriali, mentre il reato di “fallaci indicazioni” riguarderebbe esclusivamente
i prodotti destinati al “consumatore finale”.171
170
In tal senso G. Sena, Il diritto dei marchi, cit., pag. 136.
Cfr. sulla relazione delle due norme, Cassazione, sez. III penale, 14 aprile 2005, n. 13712 che definisce
“sussidiaria” la norma di cui all’articolo 517 codice penale.
171
210
b) Profili critici della formulazione dell’articolo 4, comma 49, legge n. 350 del
2003 (c.d. finanziaria 2004)
Facendo delle osservazioni più tecniche sull’articolo 4 comma 49 non si possono tacere
i dubbi sull’equiparazione tra “false” e “fallace”. Tale equiparazione può creare
possibili difficoltà di raccordo operativo con l’articolo 474 codice penale, innanzitutto
per l’equiparazione quod poenam di condotte che recano, di principio, un diverso
disvalore. Essa appare discutibile quanto meno sotto un profilo politico – criminale172.
In tale prospettiva, il richiamo alla “falsità”, che evoca un’operazione di contraffazione
od alterazione, come ad esempio si esprime l’articolo 474 codice penale, deve
probabilmente essere inteso, in questa sede, cum grano salis, potendosi forse presumere
che il legislatore del 2003 abbia voluto appuntare il rimprovero penale non tanto
sull’illecita riproduzione del segno “made in Italy”, quanto sull’operazione di
sostanziale “remplissage” realizzata dal reo: comportamento questo ricondotto
normalmente all’articolo 517 codice penale.
Inoltre l’utilizzo del termine “indicazioni fallaci”, accanto a quello che propriamente le
definisce “false”, risulta per taluni versi oscuro: giacchè se con il primo termine si
intendono ricomprendere anche le indicazioni colposamente apposte, che risultano non
veritiere, tale prospettiva è negata dal tenore necessariamente doloso del delitto; se
viceversa, come pare più plausibile, tale termine vuole riferirsi all’errore in cui versa il
compratore il profilo più pregnante appare l’induzione strumentale nell’errore, meglio
espressa da termini quali “ingannevoli” o semplicemente “false”, più ricorrenti
nell’ambito delle fattispecie penali.
172
Cfr. G. Martiello, La tutela penale…, cit., pag. 782.
211
Altro appunto che si può muovere alla formulazione della norma extra codicem è il
persistere del rimprovero penale anche laddove l’origine e la provenienza estera del
prodotto sia comunque indicata, posto che in tali casi la condotta sembrerebbe carente
della necessaria offensività.
Ulteriori dubbi, inoltre, suscita la fattispecie nella parte in cui viene incriminata, quale
“fallace indicazione”, non solo l’utilizzazione di segni o figure che richiamino
surrettiziamente la provenienza della merce dal nostro paese, ma anche l’uso di
“quant’altro” possa indurre a tale erroneo convincimento: espressione che se da un lato
permette di evitare facili elusioni della norma incriminatrice173, dall’altro presenta una
preoccupante indeterminatezza, tale da sollevare riserve sul rispetto del principio di
determinatezza delle fattispecie penali.
Non minori incertezze, infine, suscita la norma sul versante politico – criminale,
specialmente ove si consideri la sinergia applicativa con l’articolo 517 codice penale. In
effetti, sarebbe del tutto legittimo interrogarsi sulla razionalità di un sistema che, da un
lato, incrimina l’imprenditore nazionale che de-localizza all’estero la realizzazione di
certi suoi prodotti ed appone su questi ultimi, oltre al segno distintivo,la dicitura “made
in italy” e dall’altro esenta da pena l’altro imprenditore che, attuata la medesima
strategia industriale e lungi dal perpetrare una frode qualitativa, si limiti maliziosamente
a contrassegnare detta merce soltanto con il proprio marchio, confidando nel fatto che la
notorietà di quest’ultimo presso il pubblico indurrà il consumatore a ritenere tali
prodotti fabbricati negli usuali stabilimenti italiani.
173
Si pensi, ad esempio, alle semplificazioni proposte dalla già richiamata circolare 13 maggio 2005, n.
20/D delle agenzia delle dogane, la quale si riferisce a prodotti contrassegnati da etichette recanti “una
bandiera italiana, oppure la semplice dicitura Italy” oppure anche il nome di una città”. Critica verso le
soluzioni interpretative adottate dall’Amministrazione delle dogane è N. Picchi, Paesi emergenti, cit.,
pag. 58.
212
Inoltre la norma si presenta estremamente lacunosa, poiché limita il campo d’intervento
alle sole merci importate, esportate o messe in commercio, escludendo quelle vincolate
ai regimi economici e sospensivi o poste in zona franca o deposito franco.
La normativa nazionale non rispecchia nemmeno l’ambito revisionale del regolamento
CE n. 1383/2003, sulla tutela del diritto di proprietà intellettuale (merci contraffatte e
usurpative), che contempla correttamente tutte le destinazioni doganali delle merci174.
174
In tal senso P. De Felice, Riflessioni sugli argomenti di difesa del “made in Italy”, nella relazione a
confindustria di Aprile 2007.
213
c) Il coordinamento tra la nuova disciplina posta in essere dalla legge n. 350
del 2003 (c.d. finanziaria 2004) e l’Accordo di Madrid del 1981
Analoghe considerazioni debbono farsi in riferimento all’Accordo di Madrid relativo
alla repressione delle falsi o fallaci indicazioni di provenienza.
La Convenzione prevede il sequestro dei prodotti che rechino indicazioni di
provenienza false o fallaci e le norme per la sua applicazione (d. P. R. 26 febbraio 1968,
n. 656) disciplinano in Italia tale sequestro.
La parte finale dell’articolo 4, comma 49 introduce alcune norme relative alla sanatoria
sul piano amministrativo delle false o fallaci indicazioni.
Questa ultima procedura di regolarizzazione amministrativa non coincide con la
disciplina di cui al d. P. R. 656/68, cosicché si ripropone il problema del concorso delle
due normative o, piuttosto, della abrogazione della precedente norma da parte della
norma successiva.
Altro problema di coordinamento si ha tra l’articolo 3 dell’Accordo di Madrid e la
disposizione dell’articolo 4, comma 49 introdotto dalla finanziaria 2007. La prima
norma prevede l’ipotesi in cui il venditore di un determinato prodotto proveniente
dall’estero apponga il proprio nome e la indicazione della propria sede sul prodotto
stesso. La norma consente tale indicazione, ma richiede che debba essere accompagnata
dalla indicazione del paese di produzione.
Le modifiche introdotte dalla finanziaria 2007 consentono l’uso del nome e del marchio
del venditore, ma impongono particolari cautele di cui alla direttiva 2005/29/CE,
relative alle pratiche commerciali sleali.
214
d) Confronto tra l’accordo di Madrid e il Codice del consumo (decreto
legislativo n. 206/2005)
Altro confronto che si deve effettuare è tra l’articolo 3 dell’Accordo di Madrid e il così
detto Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/2005). L’articolo 6 del decreto
legislativo n. 206 impone l’indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio
nonché della sede del produttore o dell’importatore, unitamente alla indicazione del
paese di origine del prodotto, se situato fuori dall’Unione europea. La previsione
dell’Accordo di Madrid è senza dubbio più generale, mentre il codice del consumo si
riferisce, da un lato, solamente a prodotti realizzati in paesi estranei all’Unione europea,
dall’altro a prodotti destinati al consumatore. Anche in questo caso si deve ritenere che
le norme più recenti abroghino le precedenti, così che l’obbligo della indicazione del
paese di origine debba riguardare esclusivamente prodotti provenienti da paesi estranei
all’Unione europea e prodotti destinati al consumatore finale.
215
1- L’INDIVIDUAZIONE
DEL
MOMENTO
CONSUMATIVO:
SUPERAMENTO DI UN CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE
Tutta la dottrina e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come si evince dalle
sentenze esaminate nel capitolo precedente, è concorde nell’affermare che la legge n.
350 del 2003 (finanziaria 2004) ha il merito di aver posto fine al contrasto
giurisprudenziale, nato in seno alla terza sezione penale della Suprema Corte, relativo al
momento consumativo del delitto previsto dall’articolo 517 codice penale.
La previsione codicistica della vendita di prodotti industriali con segni mendaci si
consuma, come analizzato nel primo capitolo, nel momento in cui l’opera o il prodotto
sono “posti in vendita o messi altrimenti in circolazione”. Pertanto l’elemento oggettivo
del delitto dev’essere ritenuto sussistente sia quando si sia materialmente realizzata la
traditio della cosa dal venditore all’acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività
di porre in vendita, mettendo cioè semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali
acquirenti.175
È stato, invece, ulteriore oggetto di contrasto giurisprudenziale e dottrinale la questione
se la presentazione della merce in dogana per le operazioni di sdoganamento potesse o
meno configurare momento consumativo del reato in questione.
La Suprema Corte nel 2001, nel caso Andolfo176, ha affermato che “la presentazione
della merce in dogana per l’operazione di sdoganamento non costituisce atto di
circolazione dei prodotti”, per cui in tal caso il reato non esisterebbe oggettivamente.177
In altra pronuncia, caso Delaser del 1999, la Suprema Corte ha affermato il contrario
175
In tal senso Cassazione, Sez. IV penale, n. 184376 del 1990.
Cfr. Cassazione, Sez. III penale, 2 luglio 2001, Andolfo, n. 26754, in Giustizia Penale, 2002, fasc. 2,
pag. 702; nello stesso senso sentenza Cassazione, Sez. III penale, 10 gennaio 1996, n. 4374, Dubini.
177
In senso conforme sentenza Cassazione, sez. III penale, 10 gennaio 1996, n. 4373, Dubini.
176
216
interpretando l’espressione “mettere altrimenti in circolazione” come alternativa all’atto
del “porre in circolazione” e quindi comprensiva della “mera presentazione alla
dogana”. La presentazione della merce per lo sdoganamento sarebbe per la Suprema
Corte una fattispecie configurata però come tentativo del delitto ex articolo 517 codice
penale, perché la presentazione della merce in dogana può costituire “atto idoneo,
diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in
vendita”.178
L’articolo 4 della citata legge finanziaria nel terzo periodo del comma 49 ha specificato
il momento della consumazione del reato, risolvendo i contrasti interpretativi.
È stato precisato che il delitto in questione si considera “consumato sin dalla
presentazione della merce in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e
sino alla vendita in dettaglio”.
La norma individuata dalla legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), anche se costituisce
un’autonoma fattispecie di reato, che rinvia solo quod poenam all’articolo 517 del
codice penale, è destinata, dunque, a sovrapporsi, se non ad assorbire, la previsione
codicistica.
L’individuazione del momento consumativo del reato operato dall’articolo 4 comma 49
della finanziaria 2004 nel suo terzo periodo, in base a cui il reato è consumato sin dalla
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana, è uno degli elementi di maggior
rilievo nella prospettiva dell’avanzamento di tutela operato.
La dottrina più attenta ha osservato come l’individuazione ex lege del momento
consumativo del reato di cui all’articolo 4 comma 49 legge 2003 non paia, tuttavia,
178
In tal senso Cassazione, Sez. III penale, 13 Ottobre 1999, n. 11671, Desaler, in Rivista Penale, 2000,
fasc. I, pag. 41; in senso analogo Cassazione, 1 luglio 1998 n. 7639, Di Munno; Cassazione, 12 febbraio
1999, n. 1735, Tombola.
217
pacificamente estendibile, nel silenzio della legge, alla previsione codicistica, a causa
dell’autonomia delle due fattispecie179.
Tale riflessione è sicuramente condivisibile; ma anche se non si accedesse
all’interpretazione della Suprema Corte e si ritenesse, invece, di riferire l’espressa
penalizzazione dell’attività di presentazione della merce alla dogana alla sola previsione
di cui all’articolo 4 comma 49 della Finanziaria 2004, l’incidenza pratica della
questione sarebbe ridimensionata dalla portata incriminatrice di quest’ultima fattispecie,
che ha relegato la norma codicistica in un ambito applicativo assai ristretto.
Come sottolinea infatti la Suprema Corte “poiché la fattispecie di cui all’articolo 517
codice penale ha carattere sussidiario, applicandosi espressamente solo se il fatto non è
previsto come reato da altra disposizione di legge, bisognerebbe concludere che il suo
specifico ambito di operatività è limitato alla commercializzazione con segni
ingannevoli di opere dell’ingegno (letterarie, musicali, etc..). Per il resto essa è stata
assorbita dalla nuova fattispecie criminosa, che ha una estensione più ampia sia per
l’oggetto materiale (prodotti non solo industriali, ma anche agricoli) sia per la
condotta (indicazione di segni falsi e non solo fallaci)”. 180
179
180
Cfr. L. Mandelli, La problematica tutela…, cit., pag. 607.
Cfr. sentenza Legea.
218
CAPITOLO IV
PROPOSTE DE IURE CONDENDO
Sommario: 1. Le proposte di legge a livello nazionale: a) il sistema rigoroso: il “made
in Italy” può essere apposto solo su prodotti fabbricati interamente in Italia; b) il sistema
aperto: si può apporre il “made in Italy” anche se parte della produzione viene effettuata
all’estero, purchè vengano rispettati alcuni standards qualitativi; c) la soluzione
intermedia: il compromesso tra sistema “aperto” e “rigoroso” è quello che
maggiormente risponde alle esigenze dei soggetti interessati alle norme del “made in
Italy”. 2. Le proposte di istituzione del marchio d’origine “made in EU”. 3. Influenza
del diritto comunitario nel diritto penale interno.
1- LE PROPOSTE DI LEGGE A LIVELLO NAZIONALE
Un discorso de iure condendo sulla tutela della provenienza geografica e aziendale dei
prodotti industriali deve necessariamente fare i conti con le dinamiche complesse della
realtà economica moderna, caratterizzate da esigenze diverse, spesso contrapposte e
apparentemente inconciliabili.181
Tali esigenze, come emerso nel corso dell’analisi svolta nei precedenti capitoli, sono da
un lato costituiti dalla necessità di sostenere la capacità concorrenziale delle imprese
nazionali lasciando loro la possibilità di ricorrere alla de-localizzazione della
181
Cfr. G. Sagliaschi e L. Noja, Tutela della provenienza geografica e aziendale: la svolta del “made in
Italy”, in Commercio internazionale, 2005, fasc. n. 1, pag. 6.
219
produzione, dall’altro da quella di apprestare un’efficace tutela del consumatore e delle
norme internazionali sul lavoro.
La necessità della de-localizzazione della produzione è avvertita dalle imprese per
affrontare la concorrenza, in ragione dei bassi costi della manodopera e di condizioni
fiscali e assetti sindacali più favorevoli. In tal modo i produttori cercano di acquisire
margini di guadagno più elevati e nuove quote di mercato.182 Le imprese che hanno
iniziato il processo di de-localizzazione sostengono che la lavorazione in Italia non
garantisce la presenza di operai particolarmente specializzati, di quelle “maestranze” a
cui si riferisce la Cassazione nella sentenza n. 2648 del 2006183 e che neppure nelle
imprese in Italia lavorano solo operai italiani: perciò, la qualità del prodotto non può
dipendere dalla sua materiale provenienza geografica, ma dall’organizzazione e gestione
data da un determinato imprenditore. Tali imprese richiedono di poter apporre il “made
in Italy” se vi sia una organizzazione aziendale italiana, prescindendo dal fatto che
materialmente il prodotto sia fabbricato entro il territorio nazionale italiano.
Le imprese che producono totalmente in Italia, a loro volta, chiedono maggiore tutela
per il loro operato, sostenendo che producendo interamente in Italia supportano
maggiori costi, garantiscono l’occupazione della manodopera italiana e inoltre
affermano che per settori merceologici particolarmente apprezzati in campo mondiale
(abbigliamento, calzature, arredamento, arte orafa) il fatto di produrre dentro i confini
italiani assicura a tali prodotti una maggiore qualità: tant’è che il produttore delocalizzato fornisce maliziosamente al consumatore poche indicazioni, con l’intento di
182
N. Irti, in Norma e luoghi. Problemi di geo – diritto, Roma, 2000, a pag. 9 ha osservato che “gli
scambi economici,per intimo sviluppo e per inesauribile ricerca del profitto, non conoscono i vincoli
della territorialità (…) il moderno capitalismo sempre eccede la determinazione territoriale degli Stati, o
per acquisto di materie prime o di macchinari o per impiego di scoperte e invenzioni tecniche o per
ricorso al credito straniero”.
183
Cfr. Supra capitolo II, § , lettera , pag.
220
conferire al prodotto una maggiore affidabilità, non chiarendo che di italiano ci sarebbe
solo il marchio.
In questo quadro si inseriscono, altresì, le richieste delle associazioni dei consumatori
volte ad ottenere una maggiore tutela del pubblico, sostenendo che quando un
consumatore legge “made in Italy” su un prodotto lo ritiene completamente italiano sia
per origine geografica dello stesso (e di tutte le sue parti: cioè che le stesse sono state
prodotte tutte fisicamente in Italia), sia per origine imprenditoriale (cioè che è stato fatto
sotto il controllo di impresa italiana). Tali esigenze non corrispondono a quanto oggi
garantisce la legge italiana, per la quale basta la realizzazione in Italia, anche da parte di
una società straniera, di una lavorazione sostanziale che dia vita ad un prodotto nuovo
(ad esempio: l’assemblaggio di un prodotto i cui componenti sono di provenienza
estera), per rendere legittima l’apposizione del marchio “made in Italy”.
Orbene alla luce delle richieste dei soggetti maggiormente interessati in tale materia e in
considerazione dell’interesse tutelato da tali norme, individuato, come visto nel capitolo
precedente, nel quid pluris qualitativo proprio di determinati prodotti italiani, ci si
chiede se il sistema più opportuno per tutelarli e valorizzarli sia un sistema rigoroso o
invece un sistema aperto, in attesa della istituzione e della regolamentazione del
marchio “made in Italy” di proprietà dello Stato, previsto dall’articolo 4, commi 61 e 63
della legge n. 350 del 2003.
221
a) Il sistema rigoroso: “made in Italy” consentito solo su prodotti fabbricati
interamente in Italia
Un sistema che si potrebbe definire rigoroso potrebbe essere quello che garantisce un
collegamento reale e totale del prodotto all’Italia e per il quale, quindi, l’indicazione
“made in italy” potrebbe essere apposta solo sui prodotti aventi origine geografica
(realizzati fisicamente in Italia), imprenditoriale (realizzato da impresa italiana) ed
intrinseca italiana. Con origine intrinseca si vuole intendere un collegamento profondo
del prodotto con l’Italia: ad esempio perché realizzato con know how italiano, da operai
che usano le tecniche italiane e con materie prime o semilavorati italiani184.
L’uso del “made in Italy”, inoltre, potrebbe essere soggetto ad una licenza data da
autorità pubbliche, come le Camere di commercio o l’Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti indicati.
Un sistema come questo è proposto da diverse iniziative parlamentari volte a dotare la
produzione di origine italiana di un apposito segno distintivo, indice di garanzia
qualitativa.
Si tratta delle proposte di legge nn. 472, 1250, 2689, 2805, 3817, 4001, 4497
attualmente all’esame della Camera dei Deputati che, pur presentando alcune differenze
nell’articolato, sono accomunate dallo scopo comune di tutelare i prodotti italiani
mediante la predisposizione di una certificazione della loro provenienza.
Tali disegni di legge, in linea generale, propongono di apporre un marchio di
provenienza sui beni che siano stati interamente prodotti sul territorio nazionale.
184
Cfr. M. Locatelli, Appunti e spunti sul “made in Italy”, nota a Cassazione sez. III penale 23 settembre
2005, n. 34103, in Rivesta di diritto industriale, 2006, fasc. n. 2, pag. 127.
222
Il 25 maggio 2005 la Decima Commissione Permanente della Camera dei Deputati
(attività produttive, commercio e turismo), ha deliberato favorevolmente sul testo
unificato di dette proposte. Il progetto di legge all’esame del Parlamento prevede
all’articolo 1 l’istituzione del marchio “100 per cento Italia” di proprietà dello Stato
italiano.185
L’articolo appena citato precisa che tale marchio può essere apposto su prodotti
“interamente realizzati in Italia” e come tali si devono intendere i prodotti finiti per i
quali l’ideazione, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti
interamente nel territorio italiano, utilizzando materie prime anche d’importazione,
nonché semilavorati grezzi realizzati interamente in Italia.
L’uso di tale marchio, nel progetto di legge, è autorizzato dal Ministero delle Attività
produttive, dietro presentazione di apposita domanda alla Camera di commercio
territorialmente competente. Il marchio attesta oltre alla origine italiana il rispetto delle
norme di lavoro, fiscale e previdenziale, nonché l’esclusione dell’impiego di minori ed
il rispetto delle norme poste a tutela dell’ambiente.
Sempre nel progetto di legge è però previsto che i produttori potranno pur sempre
apporre “made in Italy” anche sui prodotti, per il quale non è richiesta l’intera
produzione nel territorio nazionale, essendo sufficiente che in Italia si sia realizzata
l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, ai sensi degli 23 e seguenti del
regolamento Ce 2913 del 12 ottobre 1992. Per le merci qualificate come “prodotte in
Italia” è prevista, inoltre, una carta di accompagnamento “una carta di identità del
prodotto finito” che contenga “informazioni utili al consumatore per conoscere la
provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni
eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri paesi”.
185
Disegno di legge n. 3463, approvato dalla Camera dei deputati il 30 maggio 2005 e assegnato al
Senato il successivo 8 giugno.
223
Inoltre, i produttori potranno richiedere agli uffici doganali o alle camere di commercio
industria e artigianato un certificato di origine che attesti che le merci esportate sono di
origine italiana.186
Il certificato d’origine non è in grado di svolgere la medesima funzione attrattiva,
suggestiva e di richiamo commerciale del marchio, ma sarà tuttavia in grado di
supportare la veridicità della menzione Italia, quale paese di fabbricazione della merce
esportata187.
Si ricorda, inoltre, che nel marzo del 2006 alcuni imprenditori hanno presentato il
progetto per la istituzione di un terzo marchio di origine italiana “qualificata”: “best in
Italy”.
Un sistema come questo, definibile rigoroso, dovrebbe prevedere poi, per semplificare
al massimo ed evitare confusione tra i significati delle diverse indicazioni di origine, il
divieto dell’uso di altre (oltre a “made in Italy”) indicazioni di provenienza italiane
come Italy, nomi di città, a meno che siano riportate nell’indirizzo della impresa
committente italiana. Il divieto d’uso potrebbe estendersi anche ad altre indicazioni di
provenienza qualificate (come il marchio “100 per cento Italia”).
I pregi del sistema rigoroso sarebbero i seguenti:
1- il “made in Italy” acquisterebbe valore e pregio, potendo essere usato solo da
una minoranza di imprese italiane, cioè solo dalle imprese che non delocalizzano la produzione all’estero;
186
Cfr. F. Cerioni, L’accertamento doganale, in Cerioni, Forte, Palacchino, Il diritto tributario
comunitario, Milano, Il Sole 24 Ore – Pirola, 2004, pag. 78.
187
Cfr. Carli, Indicazione di provenienza denominazione d’origine, II, Ordinamento comunitario, vol.
XVI, in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma.
224
2- il “made in Italy” acquisterebbe anche un significato secondario, consistente
nella convinzione che il prodotto con marchio “made in Italy” è stato realizzato
nel rispetto della legge italiana, nel rispetto, quindi, anche della normativa che
tutela i lavoratori italiani e delle normative di sicurezza dei prodotti;
3- si avrebbe il completo rispetto del principio di informazione introdotto a
livello comunitario e a livello nazionale con il codice del consumo (cfr. articolo
6 del decreto legislativo 6 dicembre 2005, n. 206), principio volto a imporre al
produttore di comunicare al consumatore il luogo in cui il prodotto stesso è stato
realizzato;
4- il consumatore sarebbe tutelato nel modo più ampio, in quanto saprebbe che
quando acquista un prodotto con la dicitura “made in Italy” compra un prodotto
completamente italiano. Di conseguenza non sarebbe tenuto ad avere
competenza da giurista per distinguere il significato di altre indicazioni di
provenienza italiane (essendo solo ammesso l’uso di “made in Italy”);
5-
le
autorità
di
controllo
(doganale
e
giudiziaria)
probabilmente
velocizzerebbero gli accertamenti degli illeciti, sapendo che solo per il prodotto
totalmente italiano e solo per il produttore che ha la relativa licenza d’uso
sarebbe lecita l’apposizione del marchio “made in Italy”.
Le critiche mosse a tale sistema si fondano sul rilievo che ormai si è di fronte a una
economia “globalizzata”, in cui le istanze protezionistiche di un sistema come questo
non trovano giustificazione.
Inoltre tale sistema sarebbe in contrasto con il divieto comunitario dell’articolo 28 del
Trattato Ce relativo alle restrizioni quantitative all’importazione nonché di qualsiasi
misura ad effetto equivalente. Secondo il consolidato orientamento della Corte di
225
Giustizia Ce, infatti, “in un mercato che deve possedere (…) le caratteristiche di un
mercato unico, il diritto ad una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe
dipendere, ad eccezione delle norme relative alle indicazioni di denominazione di
origine e di indicazioni di provenienza, unicamente alle caratteristiche obiettive
intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto rispetto allo stesso prodotto di
qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase di
produzione”.188
È la stessa Corte di giustizia Europea, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
di una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza di una precisa indicazione
circa l’origine di determinati prodotti, ne vietava la commercializzazione all’interno
dello Stato membro189, ha dichiarato un siffatto divieto incompatibile con l’articolo 30
del Trattato CEE.
In altre parole, la presunzione di qualità legata alla localizzazione del processo
produttivo di un determinato territorio trova giustificazione solo per quei peculiari casi,
consacrati come denominazioni di origine e provenienza (si pensi al Parmigiano
Reggiano), in cui la qualità sia strettamente legata all’ambiente in cui il prodotto nasce.
In tutte le altre ipotesi, invece, la qualità dei prodotti deve essere valutata solo con
riferimento al possesso di determinate caratteristiche, non al luogo geografico di
produzione.
L’istituzione di un marchio di qualità nazionale riservato a merci interamente prodotte
nel territorio, ma che non si giustifichi per quella stretta connessione ambiente-qualità,
si traduce, in definitiva, in un’arbitraria limitazione alla libera circolazione delle merci,
188
Sentenza Corte di Giustizia Comunità Europea, 12 ottobre 1978, (Joh. Eggers et Co. Vs Città di
Brema), causa 13/78, in Raccolta, 1978, pag. 1935; conformi anche le sentenze Corte di Giustizia
Comunità Europea 6 marzo 2003, (Commissione vs Repubblica francese), causa C-6/02, ivi, 2003, I, pag.
2401.
189
Sentenza Corte di Giustizia Comunità Europea, 25 aprile 1985, (Commissione Ce vs. United
Kingdom), Causa 207/83, in Raccolta, 1985, pag. 720.
226
in quanto induce il consumatore ad acquistare un prodotto proveniente da un
determinato paese membro a scapito di un altro.
La Corte Europea ha affermato, al riguardo, che essendo lo scopo delle indicazioni di
origine quello di permettere ai consumatori di distinguere tra prodotti nazionali e
prodotti importati, prevedere l’obbligo di inserire una tale indicazione sulle etichette dei
prodotti, di fatto dà ai consumatori “la possibilità di far valere i loro eventuali
pregiudizi nei confronti delle merci straniere”190.
La de-localizzazione di alcune fasi della produzione, infatti, non è suscettibile di
incidere necessariamente sulla loro qualità, in quanto siano rispettate le norme di legge
che eventualmente impongano controlli all’impresa italiana.
Introdurre nuove limitazioni od obblighi, lungi dal garantire una maggiore protezione ai
consumatori, può invece danneggiare sia il sistema produttivo italiano, scoraggiando la
de-localizzazione di fasi e processi produttivi, con un conseguente incremento dei costi
di produzione, che, in ultima analisi, gli stessi consumatori, su cui si ripercuoterebbe
l’aumento del prezzo finale del prodotto, dovuto ad un aggravio dei costi di produzione.
Va peraltro menzionato il fatto che la de-localizzazione anche parziale della produzione
in paesi extracomunitari viene addirittura spesso incentivata dall’Unione Europea, che
190
Nello stesso senso cfr. anche Commissione Ce vs. Repubblica federale di Germania, Causa C-325/00,
sentenza 5 novembre 2002 e Commissione Ce vs. Repubblica francese, Causa C-6/02, sentenza 6 marzo
2003. nel primo caso la Corte di Giustizia dichiarò che la Repubblica federale di Germania, con la
concessione del marchio di qualità “Markenqualitat aus deutschen Landen” (qualità di marca della
campagna tedesca) a prodotti finiti di una determinata qualità e fabbricati in Germania, era venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 30 del trattato Ce. Secondo la Corte, infatti, “la
disciplina controversa ha, quantomeno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle
merci tra Stati membri. Una simile disciplina introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei
prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolinea la
provenienza tedesca dei prodotti interessati, può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che
portano il marchio CMA, escludendo i prodotti importati”. Peraltro la Corte ha aggiunto “il fatto che
l’uso del marchio Cma sia facoltativo non ne elimina il carattere di ostacolo per gli scambi, dato che
l’uso di questo marchio favorisce o è atto favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti
che non possono fregiarsene. Si deve quindi, del pari, respingere l’argomento secondo cui il fatto che la
disciplina controversa persegua una politica di qualità la escluderebbe dal campo di applicazione
dell’articolo 30 del trattato. Infatti, l’esistenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 30 del Trattato
dev’essere valutata con riferimento all’effetto della misura interessata sugli scambi”.
227
ha stipulato accordi preferenziali con alcuni paesi terzi che prevedono un trattamento di
dazio agevolato o, addirittura, in alcuni casi azzerato.
In definitiva, più che azioni di protezionismo, sarebbero opportune serie azioni di tutela
contro la contraffazione internazionale del “made in Italy”.
Ad esempio, si potrebbe prevedere che la Comunità Europea, nei protocolli di intesa
con i paesi in via di sviluppo o extracomunitari in generale, inserisca come clausola
inderogabile l’impegno, da parte di questi ultimi, di impedire la contraffazione di
marchi e denominazioni di origine.
228
b) Il sistema aperto: “made in Italy” consentito anche per produzione
parzialmente effettuata all’estero nel rispetto di alcuni standards qualitativi
Un sistema che si potrebbe definire “aperto” sarebbe quello che permettesse
l’apposizione della dicitura “made in Italy” in presenza di presupposti meno rigorosi.
Potrebbe essere consentito l’uso del “made in Italy” a tutte le imprese che svolgono in
Italia una lavorazione sostanziale del prodotto sufficiente a dare vita ad un prodotto
nuovo. Nel sistema aperto potrebbe, poi, essere consentito l’uso di molteplici
indicazioni di provenienza (“made in Italy”, Italia, nomi di città italiane,loghi
richiamanti l’Italia), anche qualificate.
I vantaggi del sistema aperto potrebbero essere i seguenti:
1. la dicitura “made in italy” potrebbe essere usato legittimamente da parte di più
soggetti;
2. i prodotti con il “made in Italy” potrebbe avere maggiore visibilità all’estero;
3. molte imprese che non possa usare tale dicitura potrebbero comunque
valorizzare i propri prodotti apponendo sugli stessi altre indicazioni di
provenienza italiane, per comunicare l’origine imprenditoriale italiana;
4. le imprese che producano completamente in Italia con know how italiano
potranno comunicarlo a terzi usando anche altre indicazioni qualificate come
“100 per cento Italia”;
5. più imprese beneficeranno delle probabili maggiori vendite dei prodotti
recanti il marchio “made in Italy”, incentrando lo sviluppo dell’economia
nazionale mediante un maggior numero di esportazioni.
229
In sintesi, il sistema rigoroso previlegerebbe poche imprese, ma il consumatore sarebbe
tutelato al massimo, perché il prodotto che si accinge a comprare sarebbe sicuramente e
totalmente italiano. Il sistema aperto andrebbe maggiormente a vantaggio delle imprese,
il che comporterebbe che tali imprese possano rafforzarsi e ingrandirsi, con positive
ricadute sull’economia nazionale e l’occupazione.
230
c) La soluzione intermedia: compromesso tra sistema”aperto” e sistema
“rigoroso” quale maggiormente rispondente alle esigenze dei soggetti
interessati alla disciplina del “made in Italy”
La scelta tra un sistema “rigoroso” e un sistema “aperto” non è facile, anche perché la
sua utilità potrebbe variare a seconda del tipo di prodotto di cui si tratta. Per certi
prodotti, infatti, potrebbe essere indifferente l’origine italiana, per altri, come
l’abbigliamento, potrebbe essere fondamentale.
Forse una soluzione intermedia potrebbe rappresentare la scelta migliore.
Il legislatore nazionale potrebbe delineare un sistema di compromesso, di fronte
all’inerzia di quello comunitario. La soluzione più appropriata per il problema del
“made in Italy” sarebbe, comunque, quella di arrivare a un regolamento per la
stampigliatura dell’indicazione d’origine per alcuni prodotti (tra cui tesile,
abbigliamento, cuoio, calzature, mobili, ceramica e gioielleria) importati nella Comunità
da paesi terzi.
Il sistema deve consentire la de-localizzazione, perché ormai l’economia mondiale è
un’economia globalizzata. Per cui non deve proibire alle aziende di spostare parte della
produzione in paesi che permettano una maggiore concorrenza: oltre a violare i principi
comunitari, visti sopra, un tale divieto non permetterebbe alle aziende italiane di essere
concorrenziali. Comunque vi è la necessità che vengano rispettate le leggi italiane in
tema di tutela dei lavoratori, per esempio evitando l’ingresso nel nostro paese di quei
prodotti fabbricati con manodopera minorile. Tale esigenza potrebbe essere garantita
dalla previsione che l’apposizione, da parte delle imprese, della dicitura “made in Italy”,
231
possa essere effettuata solo dietro concessione di enti pubblici come le Camere di
Commercio o il Centro Italiano Brevetti.
L’apposizione del “made in Italy” potrebbe essere concessa, ovviamente, ai prodotti
fabbricati integralmente in Italia e ai prodotti fabbricati “in parte” all’estero, ma in base
a un Know how italiano e da imprese che hanno la sede in Italia. L’importante è che
vengano garantiti quei parametri di eccellenza che contraddistinguono i “nostri”
prodotti in tutto il mondo.
Su cosa si intenda “per parte” del prodotto, sufficiente ad attribuire l’origine italiana, il
riferimento alle regole doganali resta ancora il più valido, anche se ci sarebbe la
necessità che esponenti del governo, associazioni dei consumatori e confindustria
creassero nuove liste di attribuzione dell’origine, soprattutto per alcuni settori
particolarmente sensibili.
In ogni caso è chiaro che vi è la necessità di una soluzione sovra-nazionale appropriata e
al di là del sistema che si adotterà vi è la necessità di potenziare il sistema dei controlli,
in assenza dei quali la tutela del “made in Italy” rimarrebbe solo lettera morta.
232
2- LE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DEL MARCHIO D’ORIGINE “MADE IN
EU”
Le più volte richiamate dinamiche dell’economia globale devono indurre il nostro
legislatore a riflettere sul fatto che una riforma sul tema dell’origine geografica e
imprenditoriale dei prodotti industriali non può prescindere dal contesto internazionale e
che, anzi, qualsiasi riforma potrà godere di un certo grado di effettività solo nel
momento in cui venga condivisa quantomeno a livello europeo.
Alcune perplessità sorgono, dunque, in merito all’opportunità di una riforma
esclusivamente nazionale, visto anche l’acceso dibattito che si sta svolgendo, in sede
europea, per una regolamentazione comune della materia che, a breve, potrebbe portare
alla creazione di un marchio “made in Ue”.
Il tema di un marchio di origine comune per i prodotti realizzati all’interno del mercato
unico non è argomento nuovo in sede comunitaria.
Già nel 1980 la Commissione sottopose al Consiglio una proposta di direttiva
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità
europea, relativamente alle indicazioni d’origine di determinati prodotti tessili e
d’abbigliamento, proponendo l’indicazione sugli stessi della dicitura “made in the
European Community”. Il Comitato Economico e Sociale, nel 1981, espresse parere
sfavorevole, ritenendo che l’indicazione del paese di origine non costituisse una
priorità: altre indicazioni, come il prezzo, la composizione, la categoria, la qualità e le
istruzioni per l’uso erano da considerarsi più importanti, nell’interesse del consumatore.
233
Recentemente alcuni settori dell’industria comunitaria e membri del Parlamento
Europeo hanno risollevato la questione, sollecitando l’adozione di uno schema di
marchio di origine per i prodotti europei.191
In risposta alle sollecitazioni ricevute, la Commissione, in data 12 dicembre 2003, ha
sottoposto alle parti interessate il Documento di lavoro Marchio di Origine “made in
Eu” nel quale, dopo aver sommariamente analizzato benefici e svantaggi potenziali
dell’iniziativa, ha delineato tre ipotesi alternative:
1- l’adozione di una normativa comunitaria che regolamenti l’uso, su base
volontaria, del marchio di origine, sia per i prodotti realizzati all’interno
dell’Unione, sia per i prodotti importati;
2- l’adozione di una normativa comunitaria che introduca l’obbligo della
marchiatura del paese d’origine per i prodotti importati e che al contempo
regolamenti l’utilizzo, su base volontaria, del marchio “made in Ue” per i
prodotti realizzati all’interno dell’Unione (sistema equivalente a quello
degli Stati Uniti);
3- l’adozione di una normativa comunitaria che introduca l’obbligo, tanto
per i prodotti importati dai paesi terzi, quanto per i prodotti realizzati
all’interno dell’Unione, della marcatura d’origine sul prodotto (sistema
analogo a quello cinese).
Il documento di lavoro evidenzia la necessità che l’eventuale normativa comunitaria in
tema di marchiatura d’origine, quale che sia l’opzione prescelta tra le tre proposte,
rispetti tanto i principi comunitari, quanto gli impegni derivanti dal sistema multilaterale
del WTO.
191
Cfr., per un approfondimento del dibattito in sede europea, Made in the EU Origin Marking-Working
Document of the Commission Services, Brussels, 12 dicembre 2003.
234
“Se si volesse introdurre nell’UE una regolamentazione sulla marcatura d’origine,
questa dovrebbe necessariamente essere conforme al diritto comunitario ed altresì
all’articolo IX del GATT ed all’Accordo sulle regole di origine (AROO). Si deve notare
che l’articolo IX del GATT non contempla previsioni in merito al trattamento nazionale,
ma solo il requisito della nazione più favorita, lasciando libero ciascun membro del
WTO, nel caso in cui sia richiesta la marcatura di tutte le merci importate, di decidere
se imporre o meno la marcatura alla merce di produzione nazionale. In conformità con
le previsioni AROO, perla definizione della nazione di origine ai fini della
regolamentazione della marcatura, è necessario fare riferimento alle regole di origine
non preferenziale”.
Detto in altri termini:
1- in conformità al diritto comunitario, un eventuale obbligo di marchiatura
dell’origine per i prodotti realizzati all’interno del territorio dell’Unione non
potrebbe in alcun caso prevedere che questa consista nell’indicazione del Paese
membro all’interno del quale il prodotto è stato realizzato, ma unicamente
l’indicazione “made in Eu” o altra equivalente; la Commissione, nel documento
di lavoro, manifesta la necessità di approfondire ulteriormente l’eventualità di
prevedere, in aggiunta all’indicazione dell’origine comunitaria e su base
“puramente volontaria”, anche l’indicazione del Paese membro (per esempio
“made in the Member State X”).
In conformità agli impegni assunti in ambito WTO, il criterio per l’individuazione
dell’origine del prodotto non potrebbe essere diverso da quello dell’origine non
preferenziale: pertanto non sarebbe ammissibile una regola che, ad esempio,
235
riservasse ai soli prodotti interamente fabbricati all’interno dell’Unione
l’autorizzazione ad apporre il marchio “made in Ue”.
Nel documento la Commissione manifesta l’opinione che l’introduzione di una
normativa sul marchio di origine comunitario sia da ritenersi, in linea di principio,
un’iniziativa positiva e che pertanto sia opportuno procedere nell’approfondimento delle
valutazioni di opportunità, tenendo in considerazione le opinioni delle parti interessate
tra cui, oltre agli Stati membri, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e
Sociale, gli ambienti associativi dell’industria, del commercio e dei consumatori.
In merito, la Commissione evidenzia come in passato siano emerse posizioni
contrastanti sul tema, anche tra settori diversi della stessa industria comunitaria.
La Commissione sottolinea inoltre la necessità, per le amministrazioni nazionali, di
valutare l’impatto dei costi derivanti dall’implementazione di un’iniziativa che
necessita, per la sua concreta attuazione, di un efficace sistema di controlli.
Proprio con riferimento a tali implicazioni economiche il Gruppo consultivo dei
Consiglieri europei, nell’Opinione ECCG2004047, ha espresso parere contrario
all’introduzione dell’obbligo di un marchio di origine “made in Eu”.
Ancor più di recente si deve ricordare che il 16 dicembre 2005, nel semestre di
presidenza italiana, il nostro governo propose alla Commissione europea di adottare il
Regolamento per l’indicazione di origine obbligatoria su alcuni prodotti importati nei
settori: tessile e abbigliamento, calzature, oreficeria, mobili per arredo, ceramiche,
articoli di pelle e cuoio e della gomma.
Per comprendere la portata del cambiamento proposto, vanno sottolineati due aspetti del
processo legislativo europeo:
236
1. la politica commerciale è di competenza esclusiva dell’ Unione Europea;
2. in molti casi, la Commissione “adotta” le proposte, ma è il Consiglio, ossia i
Governi nazionali, che le “approva”.
Nel caso in esame, la Commissione ha compreso le argomentazioni italiane e le ha
sostenute davanti al Consiglio, dove la proposta attualmente si trova.
Confindustria, le Associazioni e le Federazioni di settore hanno operato in stretta
collaborazione con la Direzione Generale “Politica Commerciale” del MAP per
superare gli ostacoli posti da numerose lobby europee contrarie al provvedimento.
Le posizioni dei 25 Stati membri sono fortemente contrapposte ed in questo confronto si
sostanzia il conflitto tra l’industria manifatturiera europea, che intende mantenere una
forte base industriale in Europa, come quella italiana, e quella che ha de-localizzato i
propri investimenti produttivi in aree geo - economiche ad alto vantaggio comparato,
come quella dei paesi nordici (Germania, Svezia, Danimarca, Austria, Irlanda, Regno
Unito) che teme che i propri prodotti, se commercializzati con un “Made in China”,
divengano meno appetibili per il consumatore europeo. (L’Italia ad oggi può contare su
190 voti su 345, a fronte di una maggioranza richiesta di 255).
Da questo scenario si evince che gli ostacoli all’approvazione della proposta sono solo
apparentemente di natura tecnica, celando in realtà un’opposizione politica che è
funzionale al posizionamento strategico e produttivo su scala globale delle rispettive
industrie nazionali.
Il fondamento essenziale della posizione del governo italiano è stato che la marcatura
obbligatoria sui prodotti importati è già in vigore negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina,
che sono alcuni dei principali partner commerciali della Unione europea.
237
Tuttavia, la giurisprudenza GATT e WTO non ha mai chiarito se tale obbligo sia o
meno compatibile con il libero commercio.
Il negoziato è stato ovviamente influenzato anche dagli effetti dell’adesione della Cina
al WTO.
In sostanza, la discussione sui marchi di origine ha costituito una sorta di “laboratorio”
per il dibattito sull’impatto della globalizzazione sulla competitività del manifatturiero
europeo.
Una “semplice” norma tecnica, che dieci o quindici anni fa non avrebbe causato tali
contrapposizioni, ha favorito l’apertura della analisi delle problematiche collocate al
fenomeno delle de-localizzazioni e, con esso, ha portato in Europa un tema
fondamentale per il sistema industriale italiano: quello della tutela del “Made in Italy”,
che si può difendere in tanti modi, anche costringendo a marcare l’origine di ciò che
non lo è intrinsecamente.
Come richiesto da Confindustria, l’elenco dei prodotti allegato alla proposta è “aperto”,
cosicché, se altre organizzazioni europee di settore volessero includere alcuni loro
prodotti, potrebbero farlo.
Il processo che deve portare all’entrata in vigore della nuova disciplina è composto da
due fasi istituzionali.
La prima, già svoltasi all’interno della Commissione Ue e durata oltre due anni, ha
appianato le eccezioni tecniche che ostacolavano l’iter e si è conclusa il 16
dicembre 2005 con l’adozione di un testo che contiene tutte le richieste di
Confindustria.
238
La seconda, iniziata a febbraio 2006, si sta svolgendo all’interno del Consiglio, dove
il negoziato spetta al Governo. La votazione avverrà a maggioranza qualificata e
non è facile stabilire quando potrà concludersi.
Nel corso del 2006, la minoranza di blocco guidata da Svezia, Germania, Regno Unito,
Paesi Bassi e Danimarca si è gradualmente ridotta a seguito della lobby attuata
congiuntamente dal Governo e da Confindustria, che ha posto questo tema al centro
delle proprie relazioni bilaterali con tutte le organizzazioni imprenditoriali europee,
favorendo il passaggio di Stati, come la Francia, inizialmente contraria, verso il blocco
dei paesi favorevoli.
Attualmente, i due schieramenti contrapposti sono pressoché equivalenti, ma se si
votasse oggi, l’esito sarebbe ancora incerto. Pertanto, la strategia di Confindustria,
condivisa con il Governo, è di attrarre il maggior numero di paesi favorevoli per
assicurare i voti necessari, prima di andare al voto.
Le riunioni dei “comitati tecnici” del Consiglio, dove viene discussa la proposta, si
susseguono secondo il calendario stabilito dalla Presidenza di turno.
239
2- IL RAPPORTO TRA IL DIRITTO COMUNITARIO E IL DIRITTO
PENALE INTERNO
Considerando che una riforma solo nazionale in tema di origine e provenienza dei
prodotti non potrà essere sufficiente per contrastare il fenomeno della falsa o fallace
apposizione del “made in Italy”, essendovi la necessità di un intervento armonizzato
quantomeno a livello comunitario, è utile approfondire il rapporto esistente tra il diritto
comunitario e il diritto penale interno.
Negli ultimi anni si è registrata una profonda trasformazione del ruolo del diritto penale
all’interno delle istituzioni europee. Si è iniziato a parlare di un “diritto penale
comunitario”192 anche se ancora in senso molto vago, senza che ne potesse dare una
definizione unitaria193, accettata da tutta la dottrina e giurisprudenza.
192
Cfr. L. Picotti, Possibilià e limiti di un diritto penale dell’Unione Europea, a cura di L. Picotti,
Giuffrè, 1999, pag. XI e ss.
193
Cfr. sulle diverse accezione della locuzione “diritto penale comunitario” A. Bernardi, I tre volti del
diritto penale comunitario, in Possibilità e…, cit. , pag. 40 e ss.
240
a) L’impostazione tradizionale: il diritto penale non rientra tra le competenze
della comunità europea
Secondo l’impostazione tradizionale, diffusa soprattutto nei primi tempi di vita delle
Comunità europee194, il diritto penale non rientra nella competenza delle Comunità
europee, ma in quella di ciascun Stato membro195. Tale impostazione, supportata da
autorevole dottrina196, si fonda sulla considerazione che nelle Comunità europee c’è il
c.d. deficit democratico che non consente di rispettare il principio di legalità, in base al
quale un reato può essere introdotto solo da una legge, votata da un organo che sia
diretta espressione democratica dei popoli cui il precetto penale dovrà rivolgersi. Inoltre
un sistema penale comunitario risulterebbe privo di una esplicita base giuridica nei
Trattati costitutivi.
Pur non riconoscendo una competenza penale delle Comunità europee, non si è mai
negato che, comunque, il diritto comunitario esercita molteplici influenze sul diritto
penale dei singoli Stati membri e in particolare nel settore della disciplina penalistica
delle attività economiche197.
194
Si tratta della Comunità europea per il Carbone e l’Acciaio, istituita con il trattato firmato a Parigi il 18
aprile 1951 e la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 giugno 1952 n. 766, della Comunità
economica europea e della Comunità europea per l’energia atomica istituite con i Trattati firmati a Roma
il 25 marzo 1957 e la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1957 n. 1203.
195
Cfr. Ottava relazione generale sull’attività delle Comunità europee del 1974, Bruxelles-Lussemburgo,
1975, pag. 145, § 90. Cfr., anche Parlamento europeo, documenti di seduta 1976-1977, doc. 531/76, 2
febbraio 1977, Relazione presentata a nome della Commissione giuridica sulla correlazione fra il diritto
comunitario e il diritto penale (relatore: De Keersmaeker), pubblicata anche in Rivista diritto europeo,
1977, pag. 195 e ss.
In giurisprudenza tale principio è espresso nell’ordinanza 17 ottobre 1984, cause 83-84/84 (N.M.
c/Commissione e Consiglio C. E. ), in Raccolta, 1984, pag. 3575 e sentenza Corte di Giustizia delle
Comunità europee, 11 novembre 1983, causa 203/80 (Casati), in Raccolta, 1981, pag. 2595.
196
In tal senso P. Patrono, Diritto penale dell’impresa…, cit., pag. 147; Oehler, Der europaische
Binnenmarkt und sein wirtschaftsstrafrechtlicher Schutz, in Festschrift Baumann, Bielefeld, 1992, pag.
565.
197
Cfr. G. Grasso, Diritto penale dell’economia, normativa comunitaria e coordinamento delle
disposizioni sanzionatorie nazionali, in Rivista diritto internazionale privato e processuale, 1986, fasc. n.
1, pag. 219 e ss.
241
In primo luogo si è sempre riconosciuta al diritto comunitario un’efficacia, definita
“riflessa”, sui sistemi penali degli Stati membri198 e, in secondo luogo, l’attività delle
istituzioni comunitarie fa emergere una nuova serie di possibili oggetti di tutela penale,
che possono essere suddivisi in due grandi gruppi199: quello degli interessi definibili
“istituzionali”,
in
quanto
collegati
all’esistenza
e
all’esercizio
dei
poteri
soprannazionali, quello dei beni giuridici che emergono dall’attività della Comunità nel
suo concreto dispiegarsi. Si pone così un problema di tutela dei beni giuridici
soprannazionali al quale è stata data risposta facendo ricorso a diversi modelli.
Si deve sottolineare come nel corso del tempo si sia sempre più sviluppata l’interferenza
tra l’ordinamento comunitario e i sistemi penali nazionali, anche grazie agli interventi
della Corte di Giustizia, che ha sancito il definitivo declino dell’idea originaria di un
diritto penale impermeabile al processo di integrazione europea, anche se di una vera e
propria “questione penale” nell’Unione europea si può parlare solo da quando si sono
sviluppate le iniziative di cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri, volte a
contrastare quelle forme di criminalità organizzata che superano i confini dei singoli
Stati e possono dunque chiamarsi “transnazionali”.
Tale cooperazione giudiziaria si è progressivamente trasformata in una “diversa
dimensione della costituzione europea da affiancare a quella puramente economica
commerciale”200.
Il fenomeno ha assunto una diversa valenza grazie al Trattato di Amsterdam del 1997
che ha posto tra gli obiettivi delle istituzioni comunitarie la creazione di “uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia”.
198
Cfr. G. Grasso, Comunità europee e diritto penale – I rapporti tra l’ordinamento comunitario e i
sistemi penali degli stati membri - , Milano, Giuffrè, 1989, pag. 2.
199
Cfr. G. Grasso, Comunità…, cit., pag. 9.
200
Cfr. G. Grasso, Comunità…, cit., pag. 9.
242
È stata così superata l’impostazione tradizionale, secondo la quale il diritto penale non
rientrerebbe nelle competenza delle Comunità europee, ma in quella di ciascun Stato
membro: l’impiego di strumenti penalistici diventa oggi indispensabile per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea.
Il progetto di una nuova Costituzione per l’Europa ha aperto ora una “nuova fase” dei
rapporti tra diritto dell’Unione e diritto penale: ma considerando che la Costituzione
europea non è ancora entrata in vigore, è necessario fare il punto sullo stato attuale dei
rapporti tra diritto comunitario e diritto penale interno.
243
b) La tutela dei beni giuridici comunitari
Il nascere delle Comunità europee, ossia di organizzazioni soprannazionali che si sono
sostituite agli Stati membri nel governo di importanti settori della vita economica, ha
fatto emergere l’esistenza di beni giuridici che appaiono “meritevoli” di protezione
penale201 a livello europeo.
Tali interessi possono essere divisi in due grandi categorie:
1. i beni propriamente “istituzionali”, cioè legati all’esistenza stessa delle
Comunità europee, in quanto necessari per l’esercizio delle loro competenze e
dei poteri ad essi attribuiti dai trattati: moneta unica, interessi finanziari
comunitari, lo svolgimento dell’attività giurisdizionale da parte delle autorità
giudiziarie comunitarie.
2. gli interessi che nascono dall’attività normativa della Comunità, in relazione alla
creazione del mercato unico e all’affermazione delle libertà fondamentali: tutela
del mercato europeo dei capitali, disciplina societaria, tutela dell’ambiente e
lotta all’immigrazione clandestina. In tale ordine di interessi si può inserire la
lotta alla contraffazione, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
In assenza di un sistema penale comunitario per tutelare degli interessi propri della
Comunità, si deve ricorrere, se si eccettuano le limitate ipotesi in cui la normativa
comunitaria fa ricorso all’assimilazione degli interessi comunitari ai beni nazionali
corrispondenti, a due diverse tecniche: la creazione di un sistema punitivo a carattere
201
In tal senso G. Grosso, Comunità…, cit. pag. 9 e ss.
244
sopranazionale, concernente sanzioni comunitarie e il ricorso ai sistemi sanzionatori dei
singoli Stati membri .
245
c) La configurazione di sanzioni da parte della normativa comunitaria
Un primo modello di tutela è basato sulla configurazione di sanzioni poste direttamente
dalla Comunità europea. Tale sistema è utilizzato solo in pochi casi, anche se è in via di
espansione202: si ha, infatti, una progressiva estensione della competenza dell’Unione a
prevedere tali sanzioni.
Le sanzioni, che danno vita ad un vero e proprio “sistema sanzionatorio comunitario”,
possono essere divise in diverse tipologie.
Un primo gruppo è costituito dalle “ammende”203. Ci si riferisce alle ammende previste
in alcune disposizioni del Trattato CECA ed in alcuni Regolamenti adottati dal
Consiglio delle Comunità Europee nel settore della concorrenza sleale sulla base
dell’articolo 87 (ora articolo 83) del Trattato CEE (Regolamento n. 17/62, n. 101/68, n.
4056/86 e 4064/89).
Le ammende non possono essere inquadrate tra le sanzioni penali. La Corte di Giustizia
europea ha rilevato che le sanzioni in questione “hanno lo scopo di reprimere
comportamenti illeciti, come pure di prevenire il loro ripetersi”204. A sostegno di tale
conclusione militano diversi argomenti: le ammende sono inflitte dalla Commissione
delle comunità europea e non da un organo giurisdizionale, l’inconvertibilità in pena
detentiva, il carattere non infamante, l’applicabilità non solo alle persone fisiche e
202
Cfr. A. Bernardi, I tre volti…, in Possibilità e limiti…, cit., pag. 45.
Cfr. C. Honorati, La comunitarizzazione della tutela penale e il principio di legalità nell’ordinamento
comunitario, in Ordinamento penale e fonti non statali – l’impatto dei vincoli internazionali, degli
obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale, atti della sessione di
studio tenutesi a Milano il 21 novembre 2005, 10 marzo e il 24 marzo 2006, Milano, Giuffrè, 2007, pag.
135-136.
204
Sugli orientamenti della Corte di Giustizia cfr. Saggio, Orientamenti della Corte di Giustizia delle
comunità europee in materia di illeciti economici, in Il diritto penale europeo dell’economia, pag. 27-28.
203
246
inoltre, in caso di insolvenza, il costituire titolo esecutivo la cui esecuzione forzata è
disciplinata dalle regole di procedura civile della Stato membro in cui deve avvenire205.
Le finalità preventive ed il carattere repressivo di tali sanzioni, posti in luce dalla Corte
di Giustizia, consentono di accostarle alle “sanzioni punitive” proprie dei sistemi
sanzionatori amministrativi più evoluti: ad esempio le Ordnungswidrigkeiten206 del
diritto tedesco.
Un altro gruppo di sanzioni è quello costituito dalle sanzioni previste da alcuni
regolamenti in tema di agricoltura e pesca. Tali sanzioni si differenziano dalle normali
sanzioni pecuniarie per due ragioni: in primo luogo sono previste e regolate dalla
normativa comunitaria, anche se destinate ad essere applicate nei sistemi giuridici
nazionali; in secondo luogo per il loro contenuto: sono quasi sempre sanzioni non
patrimoniali.
La legittimità dell’introduzione di tali misure è stata criticata dalla Repubblica federale
tedesca con un ricorso presentato alla Corte di Giustizia207.
La Corte con sentenza pronunciata il 27 ottobre 1992 ha affermato la legittimità di tali
sanzioni, riconoscendone natura amministrativa208.
Per quel che concerne la disciplina delle sanzioni comunitarie, è individuata in alcune
sentenze della Corte di Giustizia, in qualità di organo garante del rispetto dei diritti
fondamentali in ambito comunitario, e da alcuni atti normativi comunitari, come il
Regolamento 2988/95. I principi a cui ispirano sono: legalità, proporzionalità,
colpevolezza, ne bis in idem.
205
Cfr. A. Bernardi, I tre volti…, in Possibilità e…, cit., pag. 53.
In tal senso cfr. Tiedemann, Der Allgemeine teil, pag. 1416-1417; contra però Oehler, Der Charakter,
pag. 137-138 che parla a questo riguardo di una sanzione sui generis.
207
Cfr. ricorso presentato dalla Repubblica federale di Germania il 1° agosto 1990.
208
Corte di Giustizia, 27 ottobre 1992, causa 240/90, (Repubblica federale di Germania contro
Commissione), in Rivista trimestrale diritto penale dell’economia, 1993, pag. 739 e ss, con nota di G.
Grosso, Recenti sviluppi in tema di sanzioni amministrative comunitarie, pag. 740 e ss.
206
247
Tale modello di tutela dei beni comunitari meritevoli di tutela è in via di espansione e
potrebbe non esaurirsi nell’ambito amministrativo, ma estendersi al diritto criminale.
248
d) Il ricorso ai sistemi sanzionatori degli Stati membri
Il ricorso ai sistemi sanzionatori degli Stati membri è il sistema normale di tutela penale
degli interessi finanziari della Comunità.
Gli Stati membri provvedono ad introdurre nei loro sistemi giuridici le norme necessarie
per la prevenzione e la repressione delle violazioni della normativa comunitaria209.
Su tale argomento si segnala un’evoluzione nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia.
Nella sentenza Amsterdam Bulb la Corte di Giustizia affermava che “l’articolo 5 del
Trattato, facendo obbligo agli Stati membri di emanare qualsiasi provvedimento di
carattere generale e particolare atto a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti
dagli atti delle istituzioni della Comunità, conferisce a ciascuno di essi la facoltà di
scegliere i provvedimenti idonei, ivi comprese le sanzioni, anche penali”210.
Parte della dottrina criticava tale impostazione sostenendo che la previsione di sanzioni
necessarie ad assicurare la prevenzione e la repressione delle infrazioni alla normativa
comunitaria è un obbligo e non una facoltà211.
Tale prospettiva è stata recepita dalla Corte di Giustizia nella sentenza relativa
all’affaire del mais greco e nella sua successiva giurisprudenza212213.
La Corte ha non solo riconosciuto l’esistenza di un obbligo per gli Stati membri di
sanzionare le violazioni della normativa comunitaria, ma ha anche precisato i contenuti
dell’obbligo in questione in una duplice direzione: le violazioni del diritto comunitario
209
Cfr. F. Mantovani, Diritto penale, Milano, Cedam, 2002, pag. 910-911.
Corte di Giustizia, 2 febbraio 1976, causa 50/76 (Amsterdam Bulb c/ Produktschap voor
Siergewassen), in Raccolta, 1977, pag. 149.
211
Cfr. G. Grasso, Comunità europee…, cit., pag. 172.
212
Corte di giustizia, 21 settembre 1989, causa 68/88 (Commissione c. Grecia), in Raccolta, 1989, pag.
2965 e ss.
213
Cfr. A. Bernardi, I tre volti…, in Possibilità e limit.., cit. , pag. 69-70.
210
249
devono essere sanzionate in condizioni analoghe, dal punto di vista sostanziale e
processuale, a quelle del diritto nazionale “di natura ed importanza similari”, in
secondo luogo, le sanzioni devono avere comunque “un carattere effettivo,
proporzionato e dissuasivo”.
Il nuovo indirizzo della Corte di Giustizia non ha esaurito né risolto i problemi connessi
alla tutela degli interessi della Comunità europea. Infatti non tutti gli Stati hanno
rispettato i principi della sentenza del 21 settembre 1989 e inoltre, anche quando tale
obbligo è stato rispettato, non si è riuscito a garantire una protezione penale uniforme in
tutto il territorio comunitario, anzi si èdato vita ad una tutela degli interessi comunitari
geograficamente frammentata214.
214
Cfr. C. Pedrazzi, Il ravvicinamento delle legislazioni nell’ambito della Comunità Economica Europea,
in Indice Penale, 1967, pag. 334-335.
250
e) Le prospettive di armonizzazione per la tutela dei beni giuridici comunitari
Da più parti si è sentita l’esigenza di un’iniziativa a livello comunitario diretta a
conseguire un’armonizzazione o un coordinamento delle disposizioni sanzionatorie
degli Stati membri, configurando dei vincoli ai legislatori nazionali in ordine ai
comportamenti da sanzionare e alla natura e alla misura della sanzione215.
La Comunità non ha competenza penale, ma la disparità esistente tra i diversi regimi
nazionali relativamente alla tipologia, alla struttura e al livello delle sanzioni ovvero
l’insufficienza delle sanzioni previste possono avere una incidenza negativa sul
funzionamento delle Comunità.
Se dunque si ammette un intervento delle istituzioni europee per giungere
all’armonizzazione delle diverse discipline nazionali, perplessità sorgono nell’indicare i
limiti di un intervento di tale tipo.
Le perplessità sorgono, in particolare, in merito alla potestà di obbligare gli Stati
membri a configurare degli illeciti penali e di precisare in modo puntuale le sanzioni da
introdurre, fino a eliminare ogni discrezionalità degli Stati membri al riguardo.
215
Cfr. L. Picotti, Possibilità e limiti…, cit. , pag. XI.
251
f) L’efficacia “riflessa” del diritto comunitario sul diritto penale
Per effetti “riflessi” si intendono le interferenze sui sistemi penali nazionali che si
producono in seguito alla normale penetrazione delle disposizioni comunitarie negli
ordinamenti degli Stati membri. Il carattere “riflesso” di tali effetti è da porre in
relazione alla circostanza che essi non costituiscono l’obiettivo delle previsioni o dei
principi sopranazionali, ma si realizzano per l’ordinario operare dei meccanismi
giuridici che sovrintendono ai rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento degli
Stati membri.
Una parte della dottrina parla a tale proposito di “europeizzazione del diritto penale
nazionale”216 per indicare proprio le interferenze alle quali il diritto penale nazionale si
trova sottoposto per effetto dell’intervento della normativa comunitaria.
Il fondamento giuridico di tale efficacia riflessa si ravvisa nel principio della
preminenza del diritto comunitario, uno dei principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico, nato dai trattati istitutivi delle tre Comunità.
Anche la Corte Costituzionale italiana ha deciso, ponendo fine ad un iniziale contrasto
rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che la norma interna contrastante
con la previsione comunitaria dev’essere disapplicata217.
Affinché il principio di preminenza del diritto comunitario possa operare è necessario
che la normativa comunitaria rilevante sia dotata di efficacia diretta218. Tale requisito,
216
Cfr. A. Bernardi, L’europeizzazione del diritto e della scienza nazionale, Torino, Giappichelli, 2004,
pag. 10 e ss.
217
Corte Costituzionale, 5 giugno 1984, n. 170, in Foro italiano, 1984, I, c. 2064 con nota di Tizzano, La
Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent’anni dopo.
218
Corte di Giustizia, 6 ottobre 1970, causa 9/70 (Grad) in Raccolta, 1970, pag. 825.
252
ad oggi, è ritenuto proprio non solo delle disposizioni dei Trattati e dei Regolamenti, ma
anche delle disposizioni contenute in decisioni o in direttive comunitarie219.
f. 1 L’interpretazione del giudice nazionale conforme al diritto comunitario
In base al principio del primato del diritto comunitario, il diritto interno dev’essere
interpretato conformemente alle fonti comunitarie220. Il diritto penale risulta anch’esso
sottoposto a tale principio221, anche se con alcuni limiti. Infatti, l’organo giudicante
nazionale non deve leggere la norma nazionale conformemente al diritto comunitario
quando ciò potrebbe portare alla creazione di un nuovo illecito penale o
all’inasprimento della pena. Dev’essere, dunque, esclusa l’analogia in malam partem e
contra legem222.
f. 2 La normativa comunitaria integra il precetto penale
L’influenza del diritto comunitario sul diritto penale si ha poi nell’ipotesi in cui le
norme giuridiche extrapenali, che precisano il contenuto degli elementi normativi, non
siano norma interne, ma norme comunitarie. Tale integrazione può avvenire in tre
diversi casi:
219
Corte costituzionale, 23 aprile 1985, n. 113, in Giurisprudenza italiana, 1986, I, pag. 28 e ss.
Cfr. Corte di Giustizia, 4 febbraio 1988, causa 157/86 (Murphy), in Raccolta, 1988, pag. 690; 13
febbraio 1990, causa 106/89 (Marleasing), in Raccolta, 1990, pag. 4159. sentenza Corte Costituzionale,
26 ottobre 1981, nn. 176 e 177, in Giurisprudenza Costituzionale, 1981, pag. 1543.
221
Contra Corte di Giustizia, 12 dicembre 1996, cause riunite 74/95 e 129/95 (Procedimenti penali c. X),
in Diritto penale e processo, 1997, pag. 146 e ss, e in Raccolta, 1997, pag. 6636.
222
Per taluni autori sarebbe possibile in alcuni settori l’interpretazione contra legem, cfr. Prechal,
Directives in European Community Law, Oxford, 1995, pag. 228.
220
253
1. il precetto penale è implicitamente improntato al “rinvio parziale”, in quanto utilizza
“unità linguistiche qualificate” che rimandano, per la conoscenza del loro esatto
significato, a disposizioni legali di matrice comunitaria. Ad esempio: i termini
“rifiuti”, “mezzo pubblico” e “genuinità” a cui il diritto comunitario ha conferito ex
novo una dimensione “normativo giuridica”223.
Questo è il caso della finanziaria 2007, legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
quando si riferisce “alla disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”,
definite nella direttiva 2005/29.
2. Il precetto penale è esplicitamente improntato al “rinvio parziale”: il precetto
penale è parzialmente in bianco e quindi destinato ad essere integrato da
norme penali. Come avviene nella finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2004)
che riferendosi alle “norme sull’origine comunitaria”, opera un rinvio al
Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992, che ha istituito il Codice
Doganale Europeo.
3. Il precetto penale rinvia totalmente ad una norma di fonte europea. Tale
ipotesi si ha soprattutto quando i legislatori degli Stati membri devono dare
attuazione sanzionatoria a norme contenute in regolamenti comunitari224.
L’integrazione del precetto penale ad opera di norme comunitarie è un fenomeno molto
diffuso nel diritto penale complementare e questo sia perché i nuovi precetti introdotti
dai regolamenti CE non possono essere trasportati in una fattispecie penale interna,
perché altrimenti il precetto rischierebbe di essere sottratto all’interpretazione
centralizzata della Corte di Giustizia (articolo 177 TCE) ed, inoltre, non si adeguerebbe
automaticamente agli eventuali interventi modificativi o sostitutivi di fonte comunitaria,
223
Cfr. A. Bernardi, Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e
leggi speciali, in rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2002, pag. 99 e ss.
224
Ad esempio articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1987, n. 460.
254
sia perché le norme penali extracodicistiche sono improntate molto spesso alla tecnica
del rinvio anche nei casi in cui il precetto meritevole di tutela risulti racchiuso in fonti di
diritto interno.
f. 3 La configurazione di cause di giustificazione
Un’altra forma in cui si manifesta l’influenza della normativa comunitaria sulla sfera di
applicazione dei sistemi penali nazionali è quella della configurazione di cause di
giustificazione. Tanto il trattato istitutivo della CEE, quanto la normativa comunitaria
derivata, hanno introdotto alcuni diritti di libertà il cui esercizio può entrare in conflitto
con talune disposizioni penali nazionali. In tali ipotesi l’esercizio del diritto riconosciuto
dalla normativa comunitaria, sia in virtù del principio di preminenza, sia in base al
principio generale dell’articolo 51 codice penale225, paralizzerà l’applicazione delle
fattispecie penali con esso in conflitto. Tali fattispecie non saranno caducate, ma
continueranno ad applicarsi in quelle ipotesi non scriminate dall’esercizio delle libertà
introdotte dalla normativa comunitaria.
Si tratta del tipico modo di operare delle cause di giustificazione, che escludono
l’antigiuridicità penale di un fatto in sé tipico, ma non modificano il contenuto
dell’incriminazione.
225
All’articolo 51 codice penale si richiama C. Pedrazzi, L’influenza della produzione giuridica della
CEE sul diritto penale italiano, in L’influenza del diritto europeo sul diritto italiano, pag. 622-623;
Lanzi, La scriminante dell’articolo 51 codice penale e le libertà costituzionali, Milano, 1983, pag. 93 e
ss.
255
f. 4 La disapplicazione da parte del giudice nazionale di norme incompatibili con il
diritto comunitario
Si deve poi sottolineare l’ipotesi in cui l’incriminazione prevista dal legislatore
nazionale sia incompatibile con la normativa delle Comunità europee. Molto spesso la
disciplina penale interviene, soprattutto nelle materie economiche, in funzione
sanzionatoria di regolamentazioni extrapenali. In questi casi se tali disposizioni
extrapenali si rilevano incompatibili con il diritto comunitario, il principio di
preminenza del diritto comunitario impedisce di continuare ad applicare una
disposizione incriminatrice che sanziona la violazione di precetti non più applicabili.
Nel caso Manghera la Corte di Giustizia226 ha affermato che l’articolo 37 del Trattato
CEE impone di riordinare ogni monopolio avente carattere commerciale in modo da
eliminare ogni discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le
condizioni relative all’approvvigionamento e agli sbocchi. In base a tale previsione,
secondo la Corte il diritto esclusivo d’importazione di prodotti lavorati spettante in
Italia al monopolio statale dei tabacchi “costituisce nei confronti degli esportatori
comunitari una discriminazione vietata dall’articolo 37, n. 1”; ne consegue allora che le
sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni che attribuiscono al monopolio
statale l’esclusiva d’importazione non potranno essere applicate con riguardo alle
importazioni da paesi della Comunità.
226
Corte di Giustizia, 3 febbraio 1976, causa 91/75, Manghera, in Foro italiano, 1976, IV, pag. 296 e ss.
256
g) La cooperazione giudiziaria in materia penale nel Trattato sull’Unione europea
Lo sviluppo di una “questione penale” nell’Unione europea si collega oggi alle
previsioni del titolo VI del Trattato sull’Unione Europea227, il così detto terzo pilastro,
che delineano una cooperazione giudiziaria in materia penale finalizzata alla creazione
di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
La costruzione di un’Europa senza frontiere ha fatto emergere l’esigenza di una
cooperazione giudiziaria tra gli Stati e di armonizzare molti settori del diritto penale dei
diversi Stati membri, come risulta dagli articoli 29 e 31 del Trattato.
Nel 1999 si svolse a Tampere un Consiglio Europeo dedicato esclusivamente alla
materia della giustizia penale. Le Conclusioni di Tampere costituiscono il primo
strumento programmatico di una politica criminale dell’Unione europea, a cui sono
seguite importanti decisioni quadro, rivolte all’armonizzazione delle discipline
nazionali. Si ricordano: la decisione quadro del maggio 2000 relativa alla lotta contro la
falsificazione dell’euro, quella del maggio 2001 relativa alla lotta alla frode e la
contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, quella del luglio del 2002
sulla tratta degli esseri umani, del maggio del 2003 sulla protezione dell’ambiente228,
del dicembre 2003 sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia, ecc…
L’armonizzazione raggiunta presenta comunque forti limiti, in quanto l’unanimità
richiesta per l’adozione degli atti del terzo pilastro rende difficile giungere ad altre
227
Il Trattato sull’Unione Europea è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed è entrato in vigore il
1 novembre 1993.
228
La decisione quadro 2003/80/GAI sulla protezione dell’ambiente è oggi superata grazie alla sentenza
Corte di Giustizia Europea, 13 settembre 2005, c-176/03, (Parlamento europea c. Consiglio dell’Unione
europea), reperibile sul sito www.curia.europa.eu.
257
decisioni quadro. Inoltre il recepimento degli atti del terzo pilastro è incompleto e
carente.
258
h) Le previsioni della Costituzione europea
Le previsioni del progetto di Costituzione Europea intendono modificare fortemente i
rapporti tra diritto comunitario e diritto penale interno.
Senza soffermarsi sulle novità sistematiche e politico-istituzionali della Costituzione,
ma concentrando l’attenzione sugli aspetti propriamente penalistici, grande rilevanza
assumeva l’articolo 270 che sanciva il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Tale previsione, proprio al fine di garantire il reciproco riconoscimento delle decisioni
giudiziarie e la cooperazione giudiziaria e di polizia, sancisce il potere normativo
dell’Unione Europea di ravvicinare le disposizioni processuali degli Stati membri.
Diversa è la situazione per il ravvicinamento del diritto sostanziale. Il primo comma
dell’articolo 270 sembra collegare anche il ravvicinamento delle disposizioni
incriminatici in materia penale alla cooperazione giudiziaria e l’articolo 271 prevede gli
ambiti in cui si può realizzare tale ravvicinamento, che può investire sia la struttura
delle fattispecie che le sanzioni, distinguendo le due ipotesi della criminalità grave, di
rilevanza transnazionale e quello in cui il ravvicinamento delle legislazioni si rileva
necessario per garantire l’attuazione di una politica dell’Unione in un settore già oggetto
di misure di armonizzazione.
Si ricorda, poi, che una particolare disciplina è prevista per gli interessi finanziari,
collocata al di fuori del capo relativo allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia,
nell’articolo III-145.
259
i) Il Trattato di Lisbona
In seguito agli esiti dei referendum francesi e olandesi del 2005 che hanno bloccato
l’iter di approvazione della Costituzione europea è stato avviato il c.d. “periodo di
riflessione” al termine del quale è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 il c.d.
“Trattato di riforma” destinato a sostituirsi alla Costituzione europea.
Il trattato è frutto dei negoziati condotti dagli Stati membri all’interno di una conferenza
intergovernativa, ai cui lavori hanno partecipato anche la Commissione e il Parlamento
europeo. Prima di entrare in vigore, questo trattato dovrà essere ratificato da ciascuno
dei 27 paesi dell’UE. Gli stati si sono dati come obiettivo l’entrata in vigore del trattato
entro il 1° gennaio 2009229.
All’esito della ratifica da parte dei 27 Stati firmatari non esisterà un solo Trattato (come
avrebbe dovuto essere la Costituzione europea), ma saranno riformati i vecchi trattati:
Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea,
ridenominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione”.
Il Trattato recepisce gran parte delle innovazioni contenute nella Costituzione europea,
come il venir meno della divisione in tre pilastri delle competenze dell’Unione Europea,
inoltre contiene molte altre novità: quali il venir meno di ogni riferimento alla natura
costituzionale del testo, l’eliminazione dei simboli europei, il ritorno alla vecchia
nomenclatura per gli atti dell’UE (tornano “regolamenti” e “direttive” al posto delle
“leggi europee” e “leggi quadro europee”230) e molte altre novità.
229
Alcuni Stati, tra i quali l’Ungheria, hanno già ratificato il Trattato.
V. Giscard d’Estaing, il Presidente della Convenzione europea, ha dichiarato che le differenze tra i
testi sono solo “cosmetiche” e li rendono meno comprensibili rispetto alla vecchia costituzione, mentre il
“think tank” euroscettico “Openeurope”si è spinto fino all’analisi dettagliata, notando che il Trattato è al
96% identico alla Costituzione europea.
230
260
Le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona rispetto al testo della Costituzione
europea in tema di “cooperazione giudiziaria in materia penale” sono però per lo più di
carattere solo letterale.
Infatti anche nel Trattato, appena firmato a Lisbona, l’asse portante della disciplina in
materia penale è costituito dal mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie
(articolo 69 A), come era nella Costituzione europea (articolo III 270).
L’articolo 69 B, al pari dell’articolo III- 271 della Costituzione, prevede gli ambiti in
cui si può realizzare il ravvicinamento delle legislazioni, distinguendo le ipotesi di
criminalità grave di rilevanza transnazionale (terrorismo, tratta degli esseri umani,
sfruttamento sessuale, corruzione, criminalità informatica, criminalità organizzata…), in
cui il Parlamento europeo e il Consiglio possono con direttive stabilire “..delle norme
minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni..” , da quelle in cui il
ravvicinamento delle legislazioni si rileva necessario per garantire l’attuazione di una
politica dell’Unione in un settore “già oggetto di misure di armonizzazione”.
In questo ultimo gruppo di beni ed interessi da tutelare penalmente che sono
originariamente propri dei singoli Stati, ma nei quali il carattere transnazionale della
condotta criminosa o delle esigenze di armonizzazione europea della disciplina extra
penale del settore pone il problema di una risposta coordinata, rientra la tutela della
provenienza dei prodotti industriali. Infatti le disposizioni del “made in Italy” pur
tutelando un bene giuridico propriamente nazionale, individuato nell’italianità dei
prodotti231, potranno essere realmente efficaci solo laddove vi sia una risposta
coordinata quantomeno degli Stati membri dell’Unione europea.
231
Cfr. supra capitolo III, § 3, pag. 189 e ss.
261
Tali disposizioni del nuovo Trattato apportano dunque delle significative innovazioni
rispetto al sistema precedente ed aprono a una nuova fase dei rapporti tra il diritto
dell’Unione Europea e il diritto penale. Si è solo in una fase intermedia di un lungo e
complesso processo di integrazione che è in itinere: se infatti non si può ancora parlare
di un sistema penale soprannazionale, però si è già di fronte a un chiaro consolidamento
delle competenze dell’Unione in materia penale. Un processo che ha avuto il suo punto
di svolta già nella sentenza della Suprema Corte di Giustizia CE in tema di tutela penale
dell’ambiente del 13 settembre 2005232 che riconosce in questo settore la possibilità per
il legislatore comunitario di prevedere sanzioni penali in caso di infrazione della
disciplina comunitaria e che trova riconferma nelle disposizioni del Trattato di Lisbona.
232
Cfr. Corte Giustizia CE, 13 settembre 2005, c-176/03, (Commissione c. Parlamento europea), in
www. Curia.europa.eu.
262
BIBLIOGRAFIA
A. Alessandri, voce Tutela penale dei segni distintivi, in Digesto delle discipline
penalistiche, volume XIV, Torino, Utet, 1999, pag. 432-469.
F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, volume II, XIV edizione
integrata e aggiornata a cura di L. Conti, Milano, Giuffrè, 2003.
F. Antonacchio, Tutela del “made in Italy”: corretta indicazione della provenienza e
dell’origine dei prodotti, in Rivista della scuola superiore dell’economia e delle
finanze, 2005, fasc. 6/7, pag. 378-391.
F. Antonacchio, Tutela del “made in Italy”, in Impresa, 2005, pag. 991 e ss.
F. Antonacchio, Etichettatura dei prodotti – Tutela del “made in Italy”, sicurezza dei
prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi, Milano, Giuffrè, 2007.
A. Balestri, Aiuti al tessile, ma no ai dazi, Sole 24 Ore, 23 febbraio 2005, pag. 16.
M. Barbuto, La piena tutela del “made in Italy” aspetta il regolamento delegato, in
Guida al diritto, 2005, fasc. 12, pag. 81-85.
A. Bernardi, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, Giappichelli,
2004.
263
K. Bilding, Lehrbuch des gemeinem deutschen strafrechts, Besonderer Teil, vol. II,
Leipzig, 1904, pag. 350 e ss.
F. Brusa, Falsi, Tar contro Cassazione, Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2006, pag. 32.
F. Brusa, Nella lotta ai “falsi” di origine asiatica il quadro normativo è poco chiaro, in
Guida al diritto, 2007, fasc. n. 15, pag. 115-121.
L. Camaldo, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi: analisi dei recenti
orientamenti
della
giurisprudenza,
file
reperibile
presso
il
sito
http://www.indicam.it, 2004.
S. Canestrari, A. Gamberini, G. Insolera, N. Mazzacuva, F. Sgubbi, L. Stortoni, F.
Tagliarini, Diritto penale, lineamenti di parte speciale, IV edizione, Monduzzi
editore, 2006.
C. C. Carli, voce Indicazioni di provenienza o denominazioni di origine, II,
Ordinamento Comunitario, in Enciclopedia giuridica, vol. XVI, 1999, Roma,
Treccani.
G. Casaburi, (In tema di) vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nota a Cass.
sez. III penale 19 Aprile 2005, in Il foro italiano, 2005, fasc. 12, pag. 81 e ss.
M. Casucci, La tutela del “made in Italy” in sede penale, nota a Cass. sez. III pen. 2
Febbraio 2005, n. 3352, in Il Diritto industriale, 2005, fasc. 3, pag. 277-285.
264
M. Casucci, L’ulteriore evoluzione interpretativa della Cassazione sul “made in Italy”,
nota a Cass. sez. III pen. 14 Aprile 2005, n. 13712, in Il Diritto industriale, 2005,
fasc. 4, pag. 377-378.
F. Cerioni, Il contrasto al commercio di merci contraffatte e usurpative e la tutela del
“made in Italy”, in Commercio internazionale, 2005, volume 29, fasc. 23, pag. 517.
F. Cerioni, L’accertamento doganale, in Cerioni - Forte - Palacchino, Il diritto
tributario comunitario, Milano, il Sole 24 Ore- Pirola, 2004.
F. Cingari, Misure punitive per il rilancio della competitività: tra repressioni
dell’incauto acquisto di prodotti “taroccati” e tutela del “made in Italy”, in Diritto
penale e processo, 2005, fasc. 11, pag. 1340-1345.
L. Conti,
voce Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale, in
Digesto delle discipline penalistiche, volume V, 1991, Utet, Torino, pag. 313-327.
L. Conti, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in
Novissimo digesto italiano, volume VI, Utet, Torino, 1960.
L. Conti, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in Digesto
delle discipline penalistiche, Torino, Utet, vol. IV, 1990.
265
C. Coratella, “Made in Italy”: tradizione da difendere. Ma il marchio a tutela non
piace all’Unione Europea – I dubbi di Bruxelles sulla concorrenza. Ermellini
rigorosi -, nota sentenza Cass. sez. III penale 9 Novembre 2005, n. 2648, in Diritto e
giustizia, 2006, fasc. 13, pag. 50.
C. Correra, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, Giuffrè, Milano, 2002.
G. Cozzi, La tutela del “made in Italy”. Un aspetto critico della globalizzazione dei
mercati: l’imitazione illegale dei marchi del “made in Italy”, in Economia e politica
industriale, 2003, fasc. 118, pag. 27-52.
G. A. De Francesco, Lex specialis, Milano, 1980, 140 e ss.
G. A. De Francesco, voce Concorso apparente di norme, in Digesto delle discipline
penalistiche, vol. II, Utet, Torino, 1988, pag. 425 e ss.
G. A. De Francesco, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino,
Giapichelli, 2004.
G. De Maio, Marchio d’origine, tutela della qualità, nota a sentenza Cass., sez. III
penale, 19 Aprile 2005, n. 34103, in Diritto e giustizia, 2005, fasc. 43, pag. 74.
F. Di Gianni, Il lungo viaggio alla ricerca dell’origine: norme e giurisprudenza relative
al made in, in Rivista di diritto industriale, 2007, fasc. 1, pag. 24- 60.
266
G. Ebner, sub Art. 517, in AA. VV., Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e
dottrina, a cura di G. Lattanzi- E. Lupo, IX, Milano, 2000, pag. 646.
G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte speciale. I delitti contro il patrimonio,
volume I, IV edizione, Zanichelli, Bologna, 2007.
S. Fiore, voce Diritto d’autore (reati in materia di ), in Digesto delle discipline
penalistiche, aggiornato, 2004, Torino, Utet, pag. 195 e ss.
P. Frassi, Notizie e novità legislative nazionali, commento alla legge 24 Dicembre
2003, n. 350, in Rivista di diritto industriale, 2004, fasc. 2, pag. 16-17.
G. Fornasari, Appunti sull’applicazione dell’art. 517 codice penale alla ipotesi di
produzione su commissione, in Foro italiano, vol. II, 1985, pag. 230 e ss.
G. Fornsari, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, Giuffrè, Padova, 1994.
C. Forte, Repressione dei traffici di merci contraffatte usurpative, in Cerioni – Forte –
Palacchino, Il diritto tributario comunitario, Milano, Il Sole 24 Ore- Pirola, 2004.
M. Fortis, Le due sfide del “made in Italy”: globalizzazione e innovazione: profili di
analisi della seconda conferenza nazionale sul commercio con l’estero, Il Mulino,
Bologna, 2005.
M. Fortis, Il made in Italy, Il Mulino, Bologna, 1998.
267
M. Fortis, La tutela del “made in Italy”. Un marchio d’origine contro la
contraffazione, in Economia e politica industriale, 2003, fasc. 118, pag. 21-25.
R. Franceschelli, Sui marchi d’impresa, Milano, Giuffrè, 1988.
A. Gaudenzi, La nozione comunitaria di origine radica al territorio solo piante e
animali, nota a sent. sez. III penale 17 febbraio 2005, n. 13712, in Guida al diritto
del Sole 24 Ore, numero 25 del 25 Giugno 2005.
C. Giraldi, Frodi industriali e commerciali: problematiche attuali e recenti
orientamenti giurisprudenziali, in Rivista il diritto penale e il processo, 1996, fasc.
n. 2, pag. 229 e ss.
F. Giunta, Lineamenti di diritto penale dell’economia, seconda edizione, Giappichelli,
Torino, 2004, pag. 135 e ss.
G. Grasso, Comunità europee e diritto penale – I rapporti tra l’ordinamento
comunitario e i sistemi penali degli stati membri -, Milano, Giuffrè, 1989.
C. F. Grosso, Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti
industriali con segni mendaci, in Rivista Italiana di diritto processuale penale,
Milano, 1989, p. 1265-1277.
N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo – diritto, Roma, 2000.
268
G. La Villa, Produzione su commissione, tutela penale del marchio e vendita di
prodotti industriali con segni mendaci, in Rivista di diritto industriale, 1979, fasc. 2,
pag. 241-249.
F. Leonelli – P. Pederzini – P. L. Costa – S. Corona, Commentario alla legge sui marchi
d’impresa, Milano, 1995.
F. Lemme, Riflessioni sul bene giuridico tutelato nelle incriminazioni di aggiotaggio, in
Cassazione Penale, 1987, pag. 2272.
M. Locatelli, Appunti e spunti sul “made in Italy”, nota a Cass. sez. III pen. 23
Settembre 2005, n. 34103; Cass. sez. III pen. 20 Gennaio 2006, n. 2648, in Rivista
di diritto industriale, 2006, fasc. 2, pag. 103-128.
M. Locatelli, Dell’esame comparativo tra il marchio contraffatto e quello originale e
dell’uso del nome geografico come marchio, in Rivista Trimestrale diritto penale
dell’economia, 1992, pag. 231-238.
G. Lovetere – A. Sgroi, Delocalizzazione all’estero di attività di mero assemblaggio,
confezionamento ed etichettatura e tutela del “made in Italy”, in Fisco, n. 32 del 5
settembre 2005, pag. 1- 5002.
E. Lo Monte, Le disfunzioni dell’intervento penale in tema di criminalità economica, in
Indice Penale, 1999, pag. 1125-1128.
269
A. L. Maccari, sub art. 517, in AA. VV., Commentario al codice penale, a cura di
Marini, La Monica, Mazza, III, Torino, 2002, pag. 2555.
A. Madeo, L’offerta di cibo congelato come atto unicamente diretta alla frode in
commercio, in Rivista diritto penale e processo, 2004, pag. 218 e ss.
A. Magliaro, voce Concorso di norme (diritto penale), in Enciclopedia del diritto, 1961,
pag. 547 e ss.
L. Mandelli, La problematica tutela del “made in Italy” tra diritto vigente e prospettive
di riforma, in Diritto penale e processo, 2006, fasc. 5, pag. 605-613.
V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, volume VII, Utet, Torino, 1986.
G. Marinucci, voce Falsità in segni distintivi delle opere dell’ingegno e dei prodotti
industriali, in Enciclopedia del diritto, XVI, Milano, Giuffrè, 1969, pag. 653-665.
G. Marinucci, voce Frode in commercio, in Enciclopedia del diritto, vol. XVIII,
Giuffrè, Milano, 1969, pag. 136 e ss.
G. Marinucci, Il diritto penale dei marchi, Giuffrè, Milano, 1962.
G. Martiello, La tutela penale del “made in Italy” nel mercato globalizzato: tra difesa
del consumatore e salvaguardia del sistema produttivo nazionale, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell’economia, 2005, fasc. 3, pag. 777-789.
270
G. Martiello, Il delitto di vendita industriali con segni mendaci: profili interpretativi e
ricostruttivi, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2004, pag. 697 e
ss.
G. Martiello, Falsi “made in Italy”, in Studium iuris, 2007, fasc. n. 2, pag. 232 – 233.
S. Masini, Delocalizzazione produttiva e applicabilità della tutela del “made in Italy”,
nota a Cass. sez. III pen. 23 Settembre 2005, n. 34103, in Diritto e giurisprudenza
agraria, alimentare e dell’ambiente, 2005, fasc. 12, pag. 687-689.
N. Mazzacuva – C. Costi, I delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio, in giurisprudenza sistematica del diritto penale. Parte speciale, Torino,
Utet, volume V, 1996.
G. Neppi Modona, Interesse della produzione e interesse del consumo nell’articolo 517
codice penale, in Rivista italiana diritto e processo penale, Milano, 1964, p. 795-812.
L. Noja e G. Sagliaschi, Tutela della provenienza geografica e aziendale: la svolta del
“made in Italy”, in Commercio internazionale, 2005, vol. 29, fasc. 1, pag. 5-12.
T. Padovani, Diritto penale del lavoro.Profili generali, Milano, 1983.
R. Panzarini, Marchio e nome geografico, in Rivista di diritto industriale, 1953, vol. 11,
pag. 231 e ss.
271
A. Pagliaro, voce Concorso di norme (diritto penale), in Enciclopedia del diritto,
Milano, 1961, Giuffrè, pag. 547 e ss.
M. Papa, La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra
ricettazione e norme disciplinanti la circolazione di “cose illecite”, in Rivista
italiana diritto e processo penale, 1985, pag. 756 e ss.
M. Parodi Giustino, I reati di pericoli tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990.
C. Paterniti, Diritto penale dell’economia, 1992, Torino, Giappichelli.
P. Patrono, Diritto penale dell’impresa e interessi umani fondamentali, Padova, Giuffrè,
1993.
S. Pernotti – K. Kiflè, Made in Italy. Marchio di origine o di provenienza?, in Impresa
commerciale e industriale, 2005, vol. 27, fasc. n. 6, pag. 1021 – 1032.
N. Picchi, Paesi emergenti e concorrenza sleale: gli strumenti giuridici di difesa per le
imprese italiane, Grafo, Brescia, 2005.
C. Pedrazzi, Appunti sulla tutela delle denominazioni di origine, in Rivista italiana
diritto penale, 1956, pag. 587 e ss.
C. Pedrazzi, voce Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la), in
Enciclopedia del diritto, volume XIV, Milano, 1965, Giuffrè, pag. 278-282.
272
C. Pedrazzi, Turbativa nei mercati, in Digesto delle discipline penalistiche, volume
XIV, Torino, 1998, Utet, pag. 421 e ss.
C. Pedrazzi, Tutela penale del marchio e repressione della frode, in Rivista di diritto
civile, 1958, fasc. 2, pag. 152 e ss.
C. Pedrazzi, La riforma dei reati contro il patrimonio e contro l’economia, in Diritto
penale, vol. I, Milano, 2003.
S. Riondato, Competenza penale della Comunità Europea – Problemi di attribuzione
attraverso la giurisprudenza -, Padova, Cedam, 1996.
G. Rocco, Sicurezza dei prodotti e “made in Italy”, in Disciplina del commercio e dei
servizi, 2007, fasc. n. 1, pag. 59.
A. Rossi Vannini, La tutela penale dei segni distintivi, in Trattato di diritto penale
dell’impresa, a cura Di Amato, Trattato IV, Padova, 1993, p. 109.
A. Rossi Vannini, I segni distintivi: riflessi penali, in AA. VV., Il diritto penale
dell’impresa, a cura di Conti, Padova, 2001, pag. 722 e ss.
V. Rubino, La tutela del “made in Italy” dopo la sentenza nr. 2648/06 della Corte di
Cassazione:considerazioni generali e ricadute nell’ambito delle produzioni
alimentari alla luce delle norme e della giurisprudenza comunitaria, in Diritto &
273
Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata su internet, file reperibile sul sito
www.diritto.it.
C. Ruga Riva, Ordinamento penale e fonti non statali – l’impatto dei vincoli
internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore sul
legislatore e sul giudice penale, Atti della sessione di studio tenutasi a Milano il 21
novembre 2005, il 10 marzo e il 24 marzo 2006, Milano, Giuffrè, 2007.
S. Sandri, Marchi, indicazioni geografiche, disegni, modelli nel capo II del nuovo
codice, in Diritto industriale, 2005, fasc. n. 22.
D. Sangiorgio, L’ultima sul “made in Italy”, nota a Cass. 23 Settembre 2005, n. 34103,
in Il diritto industriale, 2006, fasc. 3, pag. 224-228.
S. Screpanti e G. Procacci, La tutela penale della qualità, origine e provenienza dei
prodotti – singole casistiche e applicabilità delle diverse fattispecie, in Impresa,
2006, fasc. 19, pag. 45-53.
A. Sirotti Gaudenzi, Rafforzata la tutela del “made in Italy”, in Dossier mensile di
Guida al diritto, 2004, n. 1, pag. 134 e ss.
A. Sirotti Gaudenzi, Made in Italy a prova di contraffazione, in Il codice della proprietà
industriale, dossier di Guida al diritto, n. 3, 2005, pag. 133 e ss.
274
A. Sirotti Gaudenzi, La nozione comunitaria di origine radica nel territorio solo piante
e animali, Notiziario giuridico telematico.
A. Sirotti Gaudenzi, Brevetti rientro a sorpresa dei diritti, in Guida al diritto, 2007,
fasc. n. 11, pag. 22-24.
G. Sena, Il diritto dei marchi, IV edizione, Giuffrè, Milano, 2007.
L. Sordelli, voce Denominazione di origine ed indicazioni di provenienza, in
Enciclopedia del diritto, Aggiornato, I, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 523 e ss.
A. Vanzetti, Funzione e natura giuridica del marchio, nel volume celebrativo del XXV
anno della Rivista di diritto industriale, Milano, 1977, pag. 1168 e ss.
A. Vanzetti – V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2003, pag.
253 e ss.
F. Venturi, Tutela del “made in Italy”, in Rivista della scuola superiore dell’economia e
delle finanze, 2005, fasc. 8/9, pag. 587-606.
Atti del convegno, Padova Uniindustria, 15 Febbraio 2007, Come cambia la tutela dei
prodotti con la finanziaria 2007.
Atti dell’incontro di studio organizzato dal Dipartimento di Scienza giuridiche e dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento in cooperazione con
275
il centro di diritto penale tributario, Trento 3 e 4 ottobre 1997, Possibilità e limiti di
un diritto penale dell’Unione Europea, a cura di L. Picotti, Giuffrè, 1999.
Atti del convegno, Vicenza Associazione Artigiani, 15 Dicembre 2006, “Etichettatura e
“made in…””.
Atti del convegno, Vicenza Associazione industriale, 8 dicembre 2005, “origine delle
merci”.
Atti dell’incontro di studio interdistrettuale ed interdisciplinare presso l’ufficio dei
referenti perla formazione decentrata: distretti di Milano, Torino, Genova, Venezia e
Trieste, Profili critici della proprietà intellettuale ed effettività della tutela civile e
penale, a cura di M. Tavassi, Milano 12-13 febbraio 2007.
Atti del convegno organizzato dall’Associazione Franco Bricola, Bologna 28 febbraio-2
marzo 2002, a cura di S. Canestrai e L. Foffani dal titolo Il diritto penale nella
prospettiva europea –quali politiche criminali per quale europa?, Milano, Giuffrè,
2005.
276
GIURISPRUDENZA
1- Cassazione, Sez. IV penale, 30 Marzo 1967, in Rivista Penale, 1968, II, pag. 952.
2- Cassazione, Sez. V penale, 22 gennaio 1977, Soldano, in CED Cass. RV135119.
3- Cassazione, Sez. IV, 29 Gennaio 1979, Vitaloni, in Foro italiano, 1981, II, pag. 255.
4- Cassazione, Sez. III penale, 25 Settembre 1980, in Giustizia Penale, fascicolo 81, II,
pag. 130.
5- Cassazione, Sez. III penale, 21 gennaio 1981, in Rivista penale, 1981, pag. 819.
6- Cassazione, Sez. IV penale, 8 aprile 1981, Federico, in Giustizia penale, 1981, II,
pag. 713 e ss.
7- Tribunale Torino, 12 Ottobre 1984, Agnelli ed altri, in Foro italiano, 1985, II, pag.
230, con nota di G. Fornasari.
8- Cassazione, Sez. III penale, 11 Dicembre 1995, n. 4374, Dubini, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell’economia, 1996, pag. 1399;
9- Cassazione, Sez. III penale, 26 giugno 1996, Pagano, in CED Cass. RV205552.
277
10- Cassazione, Sez. II penale, 7 novembre 1997, Bernasconi, in Cassazione penale,
1998, pag. 3273.
11- Cassazione, Sez. III penale, 9 Dicembre 1998, Tombola, in Cassazione Penale,
2000, pag. 1285.
12- Cassazione, Sez. III penale, 25 Maggio 1998, Di Munno, in Giustizia Penale, 1999,
II, pag. 197.
13- Cassazione, Sez. III penale, 7 Luglio 1999, n. 2500, Thun, in Rivista penale, 1999,
fasc. 12, pag. 1107.
14- Cassazione, Sez. III penale, 13 Ottobre 1999, n. 11671, Delaser, in Rivista Penale,
2000, I, pag. 41.
15- Cassazione, Sez. III penale, 9 dicembre 1998, Tombola, in Cassazione Penale,
2000, pag. 1285 e ss.
16- Cassazione, Sez. III, 26 Aprile 2001, n. 26754, Andolfo, in Cassazione Penale,
2002, pag. 2124 o in Giustizia penale, 2002, II, pag. 702 e ss.
17- Cassazione, Sez. III penale, 29 Gennaio 2003, Piscitelli, in Rivista Penale, 2003,
pag. 381.
278
18- Cassazione, Sez. III penale, 8 settembre 2004, n. 36056, in Impresa c.i., fasc. n. 12,
2004.
19- Cassazione, Sez. III penale, 21 Ottobre 2004, n. 3352, Fro, in Foro italiano, 2005,
II, pag. 203, con osservazioni di Casaburi, in Guida al diritto 2005, n. 12, pag. 75,
con nota di Barbuto, nonché in Diritto industriale, 2005, pag. 271, con nota di
Casucci;
20- Cassazione, sez. III penale, 14 aprile 2005, n. 13712, Legea, in Guida al diritto,
2005, fasc. 25, pag. 71 e ss e in Diritto industriale, 2005, n. 4, pag. 372 e ss.
21- Cassazione, Sez. III penale, 20 Aprile 2005, n. 14644, Tarantino, in Foro italiano,
2005, fasc. 12 pag. 646-647, nonché in Guida al diritto, 2005, n. 43, pag. 92.
22- Cassazione, Sez. III penale, 20 Gennaio 2006, n. 2648, Giordani, in Diritto penale e
processo, 2006, fasc. 5, pag. 605-613.
23- Cassazione, Sez. III penale, 23 Settembre 2005, n. 34103, Ingam, in Guida al
diritto, 2005, 22, pag. 245 e ss.
24- Cassazione, Sez. III penale, 14 Aprile 2005, n. 13712, Monetti, in Guida al diritto,
2005, n. 25, pag. 71 e ss e in Diritto industriale, 2005, pag. 372 con nota di Casucci.
279
25- Cassazione, Sez. III penale, 17 Febbraio 2005, n. 13712, Acampora, in Guida al
diritto, 2005, n. 25, pag. 71, con nota di Sirotti Gaudenti, nonché in Foro italiano,
2005, II, pag. 374 con osservazioni di Casaburi.
26- Cassazione, Sez. III penale, 9 novembre 2005, n. 2648, Giordani, in Rivista di
diritto industriale, 2006, fasc. 2, pag. 90 e ss con nota di Locatelli.
27- Cassazione, Sez. III penale, 22 giugno 2006, n. 21797, Danzi.
28- Cassazione, Sez. III penale, 31 gennaio 2006, n. 3669, Huang Suwen.
29- Cassazione, Sez. III penale, 1 marzo 2007, n. 8684, Italian design, in Guida al
diritto, n. 15, 2007, pag. 116 e ss.
280
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
1. Corte di Giustizia Europea, 6 ottobre 1970, causa 9/70, Grad, in Raccolta, 1970,
pag. 825 e ss.
2. Corte di Giustizia Europea, 2 febbraio 1976, causa 50/76, Amsterdam bulb c.
Produktschap voor Siergewassen, in Raccolta, 1977, pag. 149 e ss.
3. Corte di Giustizia Europea, 3 febbraio 1976, causa 91/75, Manghera, in Foro
italiano, 1976, IV, pag. 296 e ss.
4. Corte di Giustizia Europea, 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et co contro
Città di Brema, in Raccolta, 1978, pag. 1935 e ss.
5. Corte di Giustizia Europea, 11 novembre 1983, causa 203/80, Casati, in Raccolta,
1981, pag. 2595 e ss.
6. Corte di Giustizia Europea, 17 ottobre 1984, causa 83-84/84, N. M. c. Commissione
e Consiglio CE, in Raccolta, 1984, pag. 3575 e ss.
7. Corte di Giustizia Europea, 25 aprile 1985, causa 207/83, Commissione Ce vs
United Kingdom, in Raccolta, 1985, pag. 802 e ss.
8. Corte di Giustizia Europea, 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione c.
Grecia, in Raccolta, 1989, pag. 2965 e ss.
281
9. Corte di Giustizia, 27 ottobre 1992, causa 240/90, Repubblica federale di Germania
c. Commissione, in Rivista trimestrale diritto penale dell’economia, 1993, pag. 739
e ss.
10. Corte di Giustizia Europea, 6 marzo 2003, causa c-6/02, Commissione vs
Repubblica francese, in Raccolta, 2003, I, pag. 2401 e ss.
11. Corte di Giustizia Europea, 13 settembre 2005, causa c-176/03, Commissione c.
Parlamento europeo, sul sito www.curia.europa.eu.
FONTI NORMATIVE
282
1- Accordo di Madrid, 14 aprile 1981, testo reperibile sul sito www.europa.eu.htm
2- D. P. R. n. 656/1968, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1968 n. 133.
3- Circolare 22 luglio 1989 n. 226 dell’Agenzia delle Dogane, integrata dalla circolare
302/VI del 20 ottobre 1989 reperibile sul sito www.agenziadogane.it.
4- Regolamento CE n. 2913 del 12 ottobre 1992, istitutivo del Codice Doganale
Comunitario, in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, 1992 L. 302/1.
5- Regolamento CE n. 2081 del 14 luglio 1992, sulla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine sui prodotti agricoli ed alimentari, in
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 1992, L. 208/1.
6- Decreto legislativo n. 198 del 1996, istitutivo del codice della proprietà industriale
7- Finanziaria 2004, legge n. 350 del 2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2003 – supplemento ordinario n. 196.
8- Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62
del 16 marzo 2005 e n. 111 del 14 maggio 2005, supplemento ordinario.
9- Relazione al decreto legge n. 35 del 2005, così detto “decreto competitività”, in
Guida al diritto, 2005, n. 13, pag. 55 e ss.
283
10- Codice della Proprietà industriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4
marzo 2005, supplemento ordinario n. 28.
11- Circolare 13 maggio 2005, n. 20/D della Agenzia delle dogane, reperibile sul sito
www.agenziadogane.it.
12- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo.
13- Finanziaria 2007, legge n.
del 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2003 – supplemento ordinario n. 244.
14- Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 17 dicembre 2007.
284