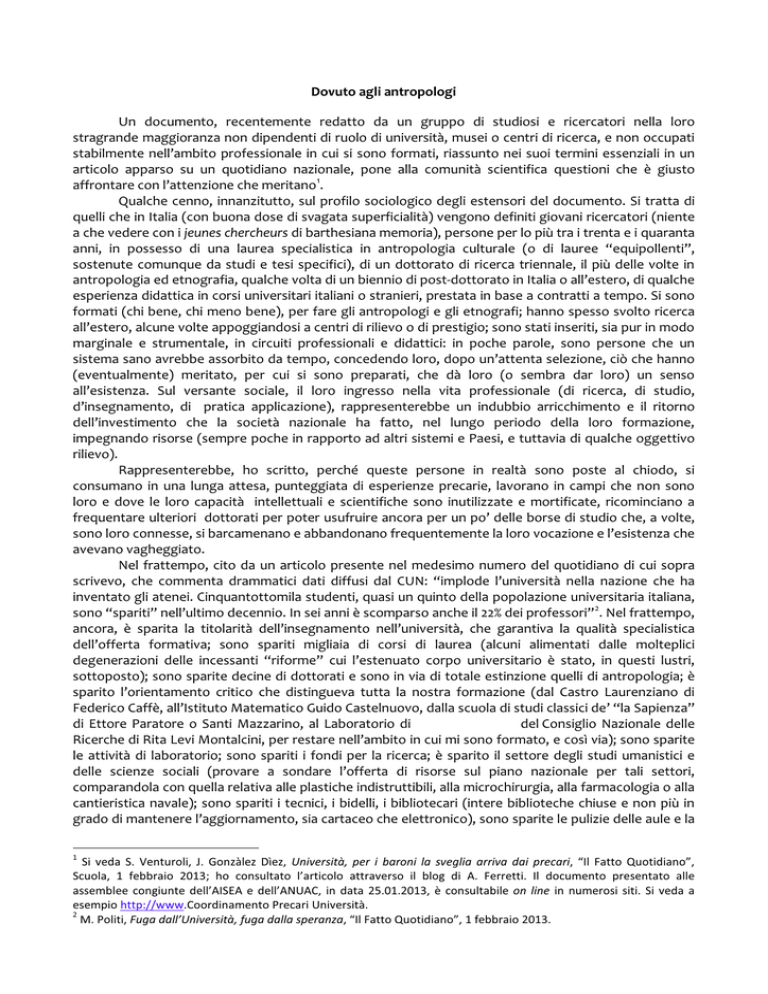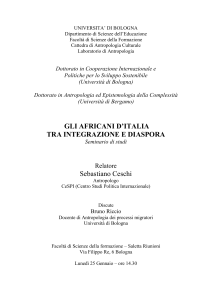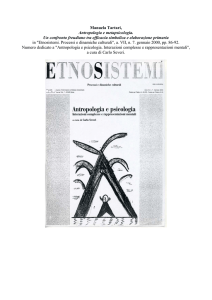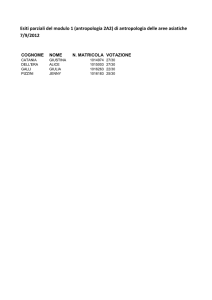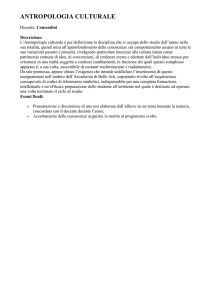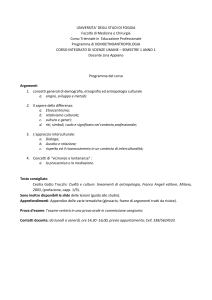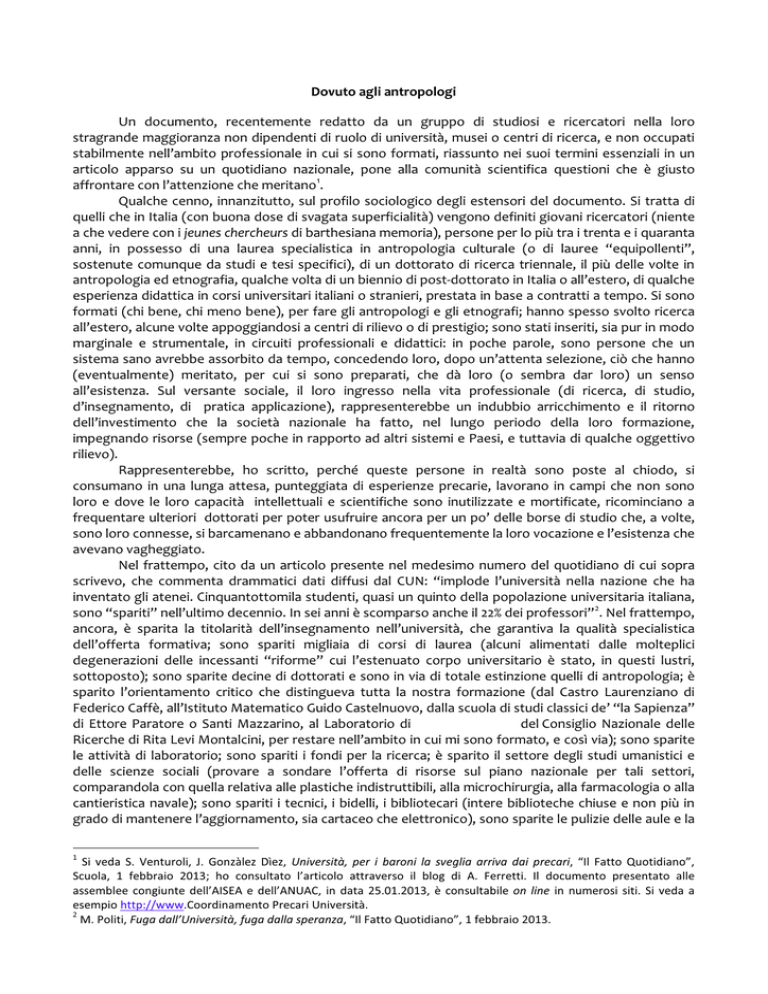
Dovuto agli antropologi
Un documento, recentemente redatto da un gruppo di studiosi e ricercatori nella loro
stragrande maggioranza non dipendenti di ruolo di università, musei o centri di ricerca, e non occupati
stabilmente nell’ambito professionale in cui si sono formati, riassunto nei suoi termini essenziali in un
articolo apparso su un quotidiano nazionale, pone alla comunità scientifica questioni che è giusto
affrontare con l’attenzione che meritano 1.
Qualche cenno, innanzitutto, sul profilo sociologico degli estensori del documento. Si tratta di
quelli che in Italia (con buona dose di svagata superficialità) vengono definiti giovani ricercatori (niente
a che vedere con i jeunes chercheurs di barthesiana memoria), persone per lo più tra i trenta e i quaranta
anni, in possesso di una laurea specialistica in antropologia culturale (o di lauree “equipollenti”,
sostenute comunque da studi e tesi specifici), di un dottorato di ricerca triennale, il più delle volte in
antropologia ed etnografia, qualche volta di un biennio di post-dottorato in Italia o all’estero, di qualche
esperienza didattica in corsi universitari italiani o stranieri, prestata in base a contratti a tempo. Si sono
formati (chi bene, chi meno bene), per fare gli antropologi e gli etnografi; hanno spesso svolto ricerca
all’estero, alcune volte appoggiandosi a centri di rilievo o di prestigio; sono stati inseriti, sia pur in modo
marginale e strumentale, in circuiti professionali e didattici: in poche parole, sono persone che un
sistema sano avrebbe assorbito da tempo, concedendo loro, dopo un’attenta selezione, ciò che hanno
(eventualmente) meritato, per cui si sono preparati, che dà loro (o sembra dar loro) un senso
all’esistenza. Sul versante sociale, il loro ingresso nella vita professionale (di ricerca, di studio,
d’insegnamento, di pratica applicazione), rappresenterebbe un indubbio arricchimento e il ritorno
dell’investimento che la società nazionale ha fatto, nel lungo periodo della loro formazione,
impegnando risorse (sempre poche in rapporto ad altri sistemi e Paesi, e tuttavia di qualche oggettivo
rilievo).
Rappresenterebbe, ho scritto, perché queste persone in realtà sono poste al chiodo, si
consumano in una lunga attesa, punteggiata di esperienze precarie, lavorano in campi che non sono
loro e dove le loro capacità intellettuali e scientifiche sono inutilizzate e mortificate, ricominciano a
frequentare ulteriori dottorati per poter usufruire ancora per un po’ delle borse di studio che, a volte,
sono loro connesse, si barcamenano e abbandonano frequentemente la loro vocazione e l’esistenza che
avevano vagheggiato.
Nel frattempo, cito da un articolo presente nel medesimo numero del quotidiano di cui sopra
scrivevo, che commenta drammatici dati diffusi dal CUN: “implode l’università nella nazione che ha
inventato gli atenei. Cinquantottomila studenti, quasi un quinto della popolazione universitaria italiana,
sono “spariti” nell’ultimo decennio. In sei anni è scomparso anche il 22% dei professori” 2. Nel frattempo,
ancora, è sparita la titolarità dell’insegnamento nell’università, che garantiva la qualità specialistica
dell’offerta formativa; sono spariti migliaia di corsi di laurea (alcuni alimentati dalle molteplici
degenerazioni delle incessanti “riforme” cui l’estenuato corpo universitario è stato, in questi lustri,
sottoposto); sono sparite decine di dottorati e sono in via di totale estinzione quelli di antropologia; è
sparito l’orientamento critico che distingueva tutta la nostra formazione (dal Castro Laurenziano di
Federico Caffè, all’Istituto Matematico Guido Castelnuovo, dalla scuola di studi classici de’ “la Sapienza”
di Ettore Paratore o Santi Mazzarino, al Laboratorio di Biologia cellulare del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Rita Levi Montalcini, per restare nell’ambito in cui mi sono formato, e così via); sono sparite
le attività di laboratorio; sono spariti i fondi per la ricerca; è sparito il settore degli studi umanistici e
delle scienze sociali (provare a sondare l’offerta di risorse sul piano nazionale per tali settori,
comparandola con quella relativa alle plastiche indistruttibili, alla microchirurgia, alla farmacologia o alla
cantieristica navale); sono spariti i tecnici, i bidelli, i bibliotecari (intere biblioteche chiuse e non più in
grado di mantenere l’aggiornamento, sia cartaceo che elettronico), sono sparite le pulizie delle aule e la
1
Si veda S. Venturoli, J. Gonzàlez Dìez, Università, per i baroni la sveglia arriva dai precari, “Il Fatto Quotidiano”,
Scuola, 1 febbraio 2013; ho consultato l’articolo attraverso il blog di A. Ferretti. Il documento presentato alle
assemblee congiunte dell’AISEA e dell’ANUAC, in data 25.01.2013, è consultabile on line in numerosi siti. Si veda a
esempio http://www.Coordinamento Precari Università.
2
M. Politi, Fuga dall’Università, fuga dalla speranza, “Il Fatto Quotidiano”, 1 febbraio 2013.
carta igienica. Le macerie dell’istituzione in cui sopravviviamo sono sotto gli occhi di tutti, appena velate
da superficiali e approssimativi (quando non balbettanti) elementi di innovazione e sedicente
democratizzazione. Queste sparizioni, inoltre, occorre tenerlo presente, sono interne alla sparizione di
ogni altro ente o istituto che connoti la vita civile dell’Italia, all’eclisse globale di un Paese, preso alla gola
dalla più feroce operazione di saccheggio, rapina, smantellamento della sua storia, dalla sostituzione di
ogni sensata istanza con le pratiche criminali di un ceto politico, di governo e amministrativo,
inqualificabile. Sparizioni, del resto, di cui il Paese, con poche e nobili eccezioni, si è fatto rassegnato
complice.
E giungiamo al documento.
Esso rappresenta la condizione degli studiosi e ricercatori di cui sopra, evidenziandone aspetti
essenziali. Porta, inoltre, l’attenzione su alcuni obiettivi concreti, non conseguiti (o soltanto
parzialmente conseguiti) dalla comunità antropologica, in grado di riaprire in qualche modo il futuro: il
riconoscimento della figura professionale dell’antropologo per l’inserimento nel MiBAC e nelle
Soprintendenze; il riconoscimento della specificità della formazione antropologica al fine
dell’insegnamento dell’antropologia negli istituti secondari di secondo grado; il riconoscimento
dell’antropologo nelle istituzioni sanitarie e della mediazione culturale, a esempio. Ma anche,
ovviamente, l’ampliamento delle risorse per le specifiche carriere di ricerca e insegnamento nelle
università e nel CNR.
In questa prospettiva di lettura non si può che condividere gli enunciati del documento: con una
sola, non marginale, puntualizzazione. Gli obiettivi in esso evocati non sono stati individuati da coloro
che lo hanno steso (non mi pare che vi sia un solo obiettivo originale, per così dire, messo in campo ed
elaborato da una specifica categoria o gruppo generazionale): come una letteratura vastissima può
documentare, sono obiettivi individuati da perlomeno un ventennio dalla comunità scientifica italiana
nel suo complesso, e portati avanti, forse con poca fortuna ma non con incerta determinazione da
alcuni. Si potranno eventualmente avanzare riserve su due aspetti: quello di un’inefficacia nell’azione
politica dei colleghi più anziani (di noi, di chi scrive); quello di una certa frammentazione della comunità
scientifica nel suo complesso, che ne ha determinato debolezza e, come risultato, inefficacia.
Tornerò su questi due aspetti, ma un elementare cenno genealogico intorno alle questioni sul
terreno non può essere omesso.
Vi sono, tuttavia, nel documento alcune inesattezze, che mi sembra opportuno rilevare, al fine di
una corretta valutazione della situazione che stiamo attraversando.
Non è anzitutto vero, come si adombra nel testo, che l’antropologia fuori d’Italia, viva una
situazione tranquilla e abbia “acquisito un pieno riconoscimento disciplinare non solo in ambito
accademico ma anche nella sfera pubblica”. In molti Paesi occidentali, l’antropologia che, anche grazie
all’esperienza coloniale e post-coloniale aveva acquisito posizioni di rilievo sia dentro che fuori
l’università, è in decisa crisi e cede il passo a discipline, assai più vaghe, accomodanti e rassicuranti, quali
la psicologia, la sociologia dei processi culturali, le “storie” delle religioni e dei nuovi culti, spesso
misticamente ispirate, i cultural studies, i gender studies, i post-colonial studies, etc. La mia esperienza
personale di frequenza, in qualità di visiting professor, di direttore di studio invitato e di senior fellow
presso prestigiose istituzioni spagnole, francesi e americane, mi restituisce un quadro di
disorientamento complessivo, di restringimento e ridimensionamento degli insegnamenti, di
annacquamento della specificità antropologica dei dipartimenti, di riduzione dei finanziamenti per la
ricerca, di erosione del prestigio accademico, per lo meno in Spagna, Francia e Stati Uniti. Ciò che
cambia, naturalmente, sono le basi di partenza da cui la disciplina (specialmente, tra i Paesi prima
ricordati, in Francia e negli USA) muoveva, sicché l’attuale regressione (avvertita con forte
preoccupazione da chi lì vive e opera), appare meno evidente e marcata con l’occhiale italiano. Musei
influenti, ancora in Francia, in USA, in Austria, in Svizzera, non sono (più) diretti da antropologi e,
soprattutto, negano o marginalizzano quelle stesse specificità antropologiche ed etnografiche che
erano state all’origine della loro edificazione: l’esempio parigino del Musée du Quai Branly appare
esemplare in tale direzione. Se rilevo tutto ciò non è perché voglia implicitamente suggerire a chi mi
legge la sciagurata idea del “mal comune, mezzo gaudio”, ma perché avere gli occhi aperti su tali realtà
ci consente di capire meglio la vicenda politico-sociale in atto nel nostro Paese.
Non è ancora vero (è del tutto semplicistico), affermare che “la crisi finanziaria del 2008 ha
aperto in Europa una fase di profonda trasformazione economica, sociale e politica, tale da scuotere le
certezze del passato e da porre con forza il problema della valorizzazione del patrimonio di
conoscenze”. Non vi è relazione diretta tra crisi finanziaria (?) e smantellamento delle conoscenze, dei
saperi, dell’attività scientifica e della formazione critica; se pensassimo questo, penseremmo nella
stessa perversa maniera di chi nega il diritto alle belle cose di cui sopra semplicemente perché non c’è
abbastanza danaro. La crisi finanziaria del 2008 (quella economica, in realtà, che è un’altra cosa, che
data da oltre un decennio prima, che ha a che vedere con il mutamento del modello produttivo, con la
progressiva finanziarizzazione delle economie reali, con la globalizzazione, con la liberazione delle
energie produttive di due terzi del mondo, prima bloccati dallo stalinismo o dall’arretratezza
tecnologica) è soltanto un pretesto, usato dai regimi autoritari del neocapitalismo liberista per bloccare,
ogni volta che lo si è ritenuto opportuno, l’evoluzione democratica nei Paesi occidentali, in transito da
un regime di spartizione bipolare del mondo e delle sue risorse, a un regime di gestione maggiormente
negoziato, plurale e polifonico. Le risorse per la scienza critica, la sua concreta organizzazione, sono in
netta relazione di dipendenze rispetto a quanto prima affermato. Il taglio dei cordoni della borsa a
questi settori del sapere non dipende dal fatto che “i soldi sono finiti”, ma dall’idea, ben radicata, che i
soldi non devono andare lì, perché lì dannosi, oltre che del tutto sprecati. A riprova di quanto detto,
infatti, va osservato che in molti Paesi occidentali (e non solo) dove le condizioni di degenerazione
politico-sociale e di involuzione capitalistica sono meno marcate, alla contrazione delle ricorse globali ha
corrisposto un aumento degli investimenti in scienza e cultura (pur se, è legittimo pensare, non in
direzione dell’antropologia).
Se queste puntualizzazioni hanno un senso, bisogna dedurne che la crisi dell’antropologia si
colloca, pur con sue specificità e peculiari drammaticità, dentro il contesto globale della liquidazione dei
saperi che hanno a che fare con la memoria sociale e con l’anamnesi critica del presente. Non più
necessaria a produrre conoscenze che potessero, direttamente o indirettamente, contribuire a
razionalizzare il dominio coloniale; non più collegata all’esplorazione di realtà solide, stabili, osservabili
in uno spazio circoscritto, in una rassicurante lontananza, e ancorabili a una confortante allocronia;
superata da apparati di conoscenza più duttili, fluidi, metodologicamente mutanti, ibridi, più simili
all’oggetto liquido rappresentato dalla serpeggiante presenza dell’alterità; vincolata a una sua radicale
impostazione critica, esercitata con tenacia negli ultimi quattro decenni, fondata su paradigmi forti
avvertiti come minaccia per l’esercizio del potere, l’antropologia non ha più motivo di esistere per chi
progetta e determina i profili sociali e culturali contemporanei e del futuro prossimo. Se non si pone
l’accento su questo aspetto centrale, si perde di vista, a mio avviso, la realtà. Ciò su cui occorre iniziare a
interrogarsi, insomma, è la relazione che esiste tra il potere mutante del capitalismo irrelato, su scala
planetaria, le strategie di creazione del consenso attraverso la gestione mass-mediatica, le nuove
rappresentanze politiche nazionali e sovranazionali, la scienza critica e, al suo interno, quella quattro
volte desueta di cui ci occupiamo.
Tale mi sembra essere lo scenario più generale; ma vi è certamente una specificità italiana.
Riguardante l’assorbimento, in genere, della competenze scientifiche e di elevata professionalità;
riguardante il contesto antropologico, in particolare.
Da perlomeno quaranta anni, a mia memoria, il sistema italiano non dedica attenzione e risorse
all’assorbimento pronto ed efficiente delle competenze e dei saperi qualificati, nel contesto sociale così
come nella realtà accademica. Il precariato è la forma endemica di espressione sociale del sapere nel
nostro Paese, in epoca contemporanea. La mia generazione, affacciatasi alla vita professionale e
accademica agli inizi degli anni Settanta dello scorso secolo, ha sperimentato mediamente dieci-venti
anni di precariato. La sospensione del reclutamento nelle università, per parlare del settore che meglio
conosco, è stata totale per circa tre lustri. Il passaggio di stato e ruolo, quando si è entrati in accademia,
è stato lento, inceppato, sottoposto a vincoli e pastoie burocratiche di ogni tipo, al realizzarsi, quasi
miracoloso, di contingenze economiche favorevoli. Vi sono colleghi della mia generazione, alle soglie del
pensionamento, meritatamente vincitori di pubblico concorso da ordinari, che non hanno potuto
prendere ancora (e probabilmente non potranno prendere mai) il loro posto. L’esistenza poi, con la
nascita dei corsi di dottorato, di un’evidente strozzatura tra gli studiosi in formazione e l’assoluta
mancanza di risorse destinate al loro impiego e alla prosecuzione della loro attività di ricerca, ha reso la
forma endemica del precariato qualcosa di angoscioso e deviante, come ritrovarsi una mattina (il giorno
dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca), trasformati nell’imbarazzante e ingombrante
scarafaggio di kafkiana memoria.
Naturalmente la forma endemica del precariato ha comportato, come conseguenze,
impoverimento delle istituzioni, che non hanno potuto usufruire delle energie che naturalmente
promanano dalle fasi inaugurali di ogni attività, senilizzazione del personale, gerontocrazia, sclerosi. E’
diventato addirittura un luogo comune la constatazione che all’età dei nostri “giovani” ricercatori
precari, negli USA, a esempio, si è soliti dirigere, come conseguenza di accorte politiche istituzionali, un
dipartimento universitario.
L’antropologia, in tale contesto, ha subito una sorte ancor più dura di altre discipline. Ho tentato
di individuare, in un mio saggio di due anni fa, le modalità della costante negazione della tensione
antropologica presente tra i ceti intellettuali italiani, sin dai primi anni dell’unità nazionale, che ha
portato a mortificare sistematicamente il flusso di iniziative di viaggio, esplorazione, ricerca,
catalogazione, conoscenza sistematica del mondo (pur nell’angustia di una condizione occidentale
“minore”), riconducendolo alla gestione dello spazio domestico e delle sue contraddizioni sociali
immediate. Ho tentato di porre in evidenza, casi alla mano, ciò che ho chiamato sindrome di Colombo
dell’intellettualità italiana, portata a emigrare per poter realizzare il proprio progetto di conoscenza, o a
mettersi al servizio degli altri. L’antropologia è stata contraddetta e negletta, marginalizzata e umiliata.
L’antropologia si è dovuta adattare, per sopravvivere, rinunciando allo schema teorico e metodologico
che le era proprio e che la andava facendo adulta in altri Paesi occidentali.
Che, all’interno di questo disegno di compressione, marginalizzazione, adattamento, abbiano
giocato un ruolo importante alcune tendenze eterogenee ed eterodosse della disciplina, e dei suoi
studiosi, nel nostro Paese, è sicuramente vero. Ma le abdicazioni, per così dire, degli antropologi non
sono mero frutto di ripiegamento o vigliaccheria; sono il risultato di una condizione storica in cui la
disciplina non ha avuto corso ed è apparsa inutile, pleonastica, extravagante. Le stesse basi culturali
dominanti per molti decenni, legate a un crocianesimo sempre più stanco e logoro, hanno
rappresentato una negazione in vivo del paradigma antropologico. La banalizzazione cui la disciplina è
stata sottoposta negli anni più recenti, del tutto conforme rispetto a un più generale processo di
degrado della società, addita efficacemente l’inutilità dell’apparato concettuale a lei legato, il disprezzo
implicito per le sue modellizzazioni complesse, per la sua vocazione empirica, per la sua tensione
etnografica, oltre che per i suoi altrove e i suoi (misteriosi) altri. La macchiettista reductio
dell’antropologo, in televisione o sulla stampa quotidiana e periodica, a mondano esegeta dei misteri
della trasmissione “Misteri”, o della speranzosa vocazione italiana al gioco del lotto, o delle pittoresche
“tradizioni” pasquali e delle ricette della buona cucina del tempo andato, la dice lunga intorno a ciò che
si vuol far dire all’antropologo e a ciò che da lui non si vuole proprio udire. La carica di conoscenza critica
dei fenomeni legati alla complessità sociale propria della disciplina è stata del tutto ignorata, in
definitiva, quando non apertamente sbeffeggiata.
Accennavo sopra ai nostri errori. Dentro la realtà di fondo sin qui tratteggiata vi sono stati sbagli
dei cultori della disciplina, come è fatale per tutte le cose della terra: il particolarismo, il localismo, un
settarismo a tratti viscerale; il mancato riconoscimento della diversità degli altri e la mancata
legittimazione di tutti coloro che erano dignitosamente dentro il perimetro disciplinare; le pratiche di
baronaggio accademico; la chiusura verso i mondi escludenti, come forma di autodifesa che ha finito per
trasformare gli esclusi in ghettizzati; l’accontentarsi degli spazi residuali concessi dal sistema,
occupandoli comunque per timore di ancor più radicali emarginazioni, a esempio. Ma pensare che
queste siano le cause di un degrado che è la configurazione sociale contemporanea di una storica
esclusione e di una permanente condizione di marginalità, significa posporre le cose, tramutare le cause
in effetti, non vedere né lontano, né vicino. Vi è poi da dire, ancora, per quell’onestà storiografica che
deve essere alla base di ogni riflessione critica, che la mia generazione non ha avuto, rispetto alla vita
accademica e alla realtà disciplinare, in certi suoi rappresentanti (non certamente in tutti) lo stesso stile
accademico dei suoi antecessori. Che ha tentato, pur nella condizione di minorità gerarchica e di
precariato cui ho fatto cenno, di promuovere regole nuove, nuove forme discorsive e rappresentative,
un nuovo modo di stare tra le persone e le cose. Le chiamate generali di correità, anche recentemente
udite nel dibattito congiunto tra le associazioni nazionali rappresentative degli antropologi prima
ricordato in nota, vanno rispedite al mittente; ognuno di noi è tenuto a rispondere della propria
posizione intellettuale, del proprio stile accademico, del proprio comportamento civico.
Ciò vale anche per i più giovani, naturalmente; l’appartenenza generazionale non è un
salvacondotto, non rende immuni dalle pecche e dagli errori che ho sopra riassunto. Nella mia
esperienza a contatto con coloro che si affacciano agli studi o li hanno da poco intrapresi ho incontrato
persone del tutto esenti dai mali storici che affliggono l’antropologia italiana e che hanno reso infermi
alcuni (o molti) di noi, ma ho visto anche la riproduzione opportunista dei peggiori stili accademici, resa
ancor più grottesca dall’assoluta assenza di ratio specifica.
Fin qui mi sono soffermato su alcune delle cose positive e meno positive che il documento da cui
sono partito contiene, e sulle considerazioni correlate che tali cose suggeriscono. Vorrei ora passare ad
analizzare quanto il documento non contiene affatto, soverchiato com’è, nelle sue pur apprezzabili
istanze, da un tono sindacalista di discutibile profilo.
Occorre partire da quello che vorrei convenzionalmente definire il mutamento della domanda
nei confronti dell’antropologia. Convenzionalmente, perché come sopra ho accennato, in realtà, la
società italiana non ha mai chiesto niente (forse con qualche circoscritta eccezione, quale l’impresa
loriana dell’’11, a esempio) all’antropologia. A fronte di questo silenzio della committenza sociale e
politica, l’antropologia si è scelta da sé le proprie tematiche; e tali tematiche si sono mosse, molto
spesso, in direzione antagonista e critica. Chi ha scelto di fare antropologia, per decenni, ha scelto di
stare all’opposizione, di essere fuori, di essere vox clamantis in deserto. Voce a volte miracolosamente
ascoltata, sia pur distrattamente e con buone dosi di sussiego, perché utile a portar acqua al mulino
della contestazione del potere costituito. Negli ultimi dieci, venti anni, ciò non si è più verificato. Si è
cominciato a lavorare su una presupposta domanda della società nei confronti della disciplina, a
intercettare i bisogni sociali che emergevano dalle nuove contraddizioni di sistema. Con effetti di
drammatica disillusione sul piano pratico. Ma, soprattutto, con una ricaduta nella configurazione
morfologica della disciplina, che ha portato alla riformulazione dell’ordine di priorità nelle sue
tematiche: esse non sono state più suggerite dalla logica interna (scientifica), ma dalla contingenza
sociale. Il tentativo, insomma, è stato quello di farsi notare, di rendersi utili, se non indispensabili. Così
non si è più studiato ciò che il modello teorico complessivo della disciplina, sul piano internazionale,
postulava (centinaia di domande, maturate nelle temperie strutturalista, post-strutturalista, riflessiva,
sono restate inevase), ma ciò che si riteneva potesse trovare più facile e immediata accoglienza sul
mercato. Poca teoria, in altre parole, abbandono assai evidente delle tematiche in grado di produrre
modelli di elaborazione logico-formale, grande abbuffata di studi sugli immigrati (assai superficiali,
condotti senza profonda conoscenza dei contesti e delle lingue native, studi sugli immigrati fatti nella
stessa lingua delle polizie, per dirla con le parole di uno stimato collega anglo-americano), sulle politiche
di governance delle asl, sulla discriminazione etnica nelle scuole, e così via. Il presupposto è quello
dell’immediata utilità sociale del sapere antropologico (e dunque dell’antropologo).
Il problema è che, invece, la specificità dell’approccio teorico-metodologico dell’antropologia, è
quella di produrre modelli, apparati concettuali, modalità pratiche di rapporto con la realtà, nel
presupposto di costruire il più cospicuo e sofisticato apparato di riserva concettuale delle scienze sociali.
In concorrenza con lo psicologo, con l’assistente sociale e con il sociologo, all’interno di una asl
assediata dalle difficoltà e riottosa a ogni assunzione problematica della realtà (uso una qualsiasi
metonimia o sineddoche), l’antropologo ha cercato di aprirsi un suo spazio, del tutto rinunciando alla
propria specificità, che è quella di elaborare, come ho scritto, modelli concettuali utili a porre in
discussione le visioni acquisite della realtà.
Da qui, interrogativi che il documento non si pone affatto: quale tipo di antropologia nella
società del terzo millennio, che su un piano generale non vuol avere a che fare con un sapere critico qual
è quello specifico, che nel contesto italiano naufraga in un’assoluta indifferenza verso temi, problemi,
ordini logici propri della disciplina? Quale tipo di antropologi i nuovi antropologi vogliono essere? Sono
ben certi di voler indorare la pillola della diversità etnica nei luoghi dove si consuma lo scontro nord-sud
del mondo? Sono felici di insegnare antropologia nei licei resi impraticabili da decenni di incuria statale e
del tutto imbastarditi dalla cosiddetta riforma Gelmini? Sono determinati a spiegare agli attoniti
poliziotti che reprimono le condotte trasgressive dei centri sociali che la “modica quantità” va
interpretata in base alla cultura degli attori sociali?
Come riposizionare, dunque, nell’eventualità in cui tutto ciò ci renda inquieti o dissenzienti, gli
apparati concettuali della disciplina rispetto al declino (o alla ripetizione manieristica) della stagione
riflessiva, al riproporsi delle tendenze neo-oggettive, al faticoso tentativo di ritagliare un cantuccio per
un’antropologia sociale della realtà politica e dello spazio pubblico? Come riformulare la professione di
antropologo a contatto con il digital turn, che sempre più va investendo lo statuto epistemologico della
disciplina, i sistemi di raccolta e archiviazione dei dati, le modalità di comunicazione, le strategie di
rapporto con gli interlocutori privilegiati, con i contesti nativi e con i campi di ricerca, le scelte di
formalizzazione linguistica (lingue nazionali, lingue locali, lingue internazionali)?
Credo siano questi interrogativi che non è lecito ignorare e che dovranno orientare il lavoro
futuro di restauro della nostra disciplina (nella direzione di una continuità che, nel bene e nel male, io
avverto come fondante). Come credo anche che occorra trovare nelle ragioni culturali complessive di
questo Paese (per quel che ancora una memoria labile, distorta e colonizzata ce le trasmette) la via per
un’affermazione originale dei nostri studi; screditati all’estero, si è affermato nel corso dell’assemblea
più volte ricordata. Io non lo direi proprio quando essi, con fatica e umiltà, cercano un loro percorso
originale; screditati soltanto nella misura in cui ripercorrono stancamente, venti, trenta anni più tardi,
strade che altri hanno già percorso, scimmiottando lessico, modalità espressive, posture già da tempo
consunte.
Qualche sollecitazione pratica, infine, che ancora dalla lettura del documento promana.
Quella di paventare, innanzitutto, lo strisciante riaffermarsi di forme di settarismo (su base
generazionale, questa volta) che la comunità scientifica nel suo complesso, con fatica, sta tentando di
superare. Molte delle cose sacrosante che il documento chiede di modificare non sono modificabili dalle
associazioni degli antropologi (stanti anche le coordinate generali che ho rapidamente richiamato), ma
sono state da tali associazioni fatte proprie da tempo. Trovare in esse un facile bersaglio (fare di esse un
capro espiatorio) per una più generale, pervicace, complessa e multiforme impotenza, non è corretto e
rischia di provocare malintesi e irrigidimenti di cui assolutamente la comunità scientifica nel suo
complesso non ha bisogno.
Quella di scorporare la riflessione scientifica, da condurre nel seno della comunità, secondo le
regole proprie di una comunità, dalla legittima rivendicazione sindacale, operando su tavoli differenti, e
fondando la seconda sulle solide e imprescindibili ragioni della prima.
Quella di procedere con urgenza a un’indagine conoscitiva, cui le due associazioni nazionali
storiche degli antropologi ritengo siano ben liete di offrire il loro contributo e il loro supporto, circa lo
stato delle cose nell’universo, diciamo così, non strutturato. Ingenerosamente è stato affermato che la
radiografia presentata in occasione dell’incontro del 25 gennaio conteneva soltanto i dati relativi agli
strutturati, da ciò desumendo un’insensibilità dei direttivi delle associazioni nei confronti di chi non lo è.
I primi dati in effetti, è possibile dedurli con una certa facilità, mentre quelli relativi al magmatico mondo
non garantito, nella sua complessità, ci sfuggono largamente. Credo che radiografare anche tale realtà
sia necessario e urgente.
Un’ultima cosa vorrei aggiungere, certamente assai personale, per concludere le mie
considerazioni, e tale cosa riguarda il cosiddetto “amore per l’antropologia”. Vecchi e giovani,
strutturati e non strutturati, accademici, museografi e cooperanti si ritrovano uniti in questo bel topos
retorico di deamicisiana suggestione. Malgrado tutto, le delusioni, i calci in faccia, le gerarchie
immotivate e le esclusioni dal mondo, la nostra disciplina non si può non amare; ha a che fare con
l’uomo, e chi può non amare l’uomo? (Claude Lévi-Strauss, in realtà, nella fase avanzata della sua vita,
saggiamente mostrava di non amare poi troppo il bipede aggressivo cui va tanta umanistica
considerazione). Per mio conto, mi riconosco in una diversa postura epistemologica ed etica, le cui
ragioni tento di comunicare ai miei allievi, soprattutto durante la loro formazione dottorale.
L’antropologia è essenzialmente uno strumento di conoscenza. Strumento, appunto, e la conoscenza è
il fine. Come strumento, né migliore, né peggiore di altri. Ciò che è fondamentale, allora, non è l’amore
(eventualmente settario?) per una disciplina, ma la postura intellettuale con la quale ci si pone di fronte
alla realtà. Vi sono amori onesti e altri disonesti. Vi sono amori motivati dalla viva realtà che
approcciamo e altri che tale motivazione non presentano Vi sono amori ricambiati e altri che, nella loro
indifferenza, alimentano malessere, disillusione e turpitudine. Dunque, niente amore per l’antropologia.
Ma un atteggiamento civile di fronte alla realtà e al suo studio, e la ferma intenzione di compiere il
proprio dovere con scrupolo professionale.
Roma, 03.02.2013
Francesco Faeta