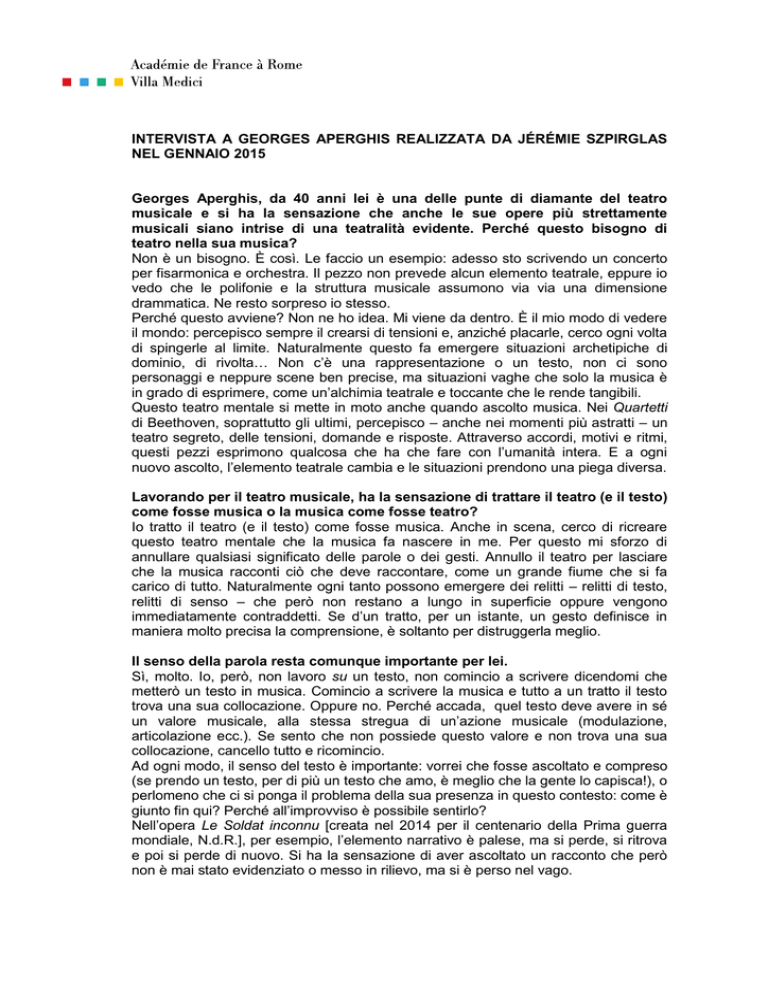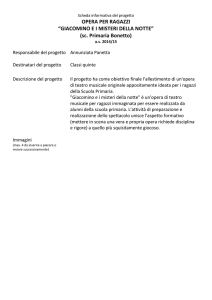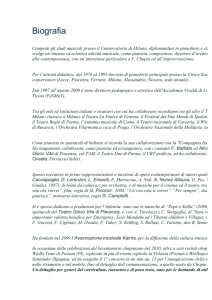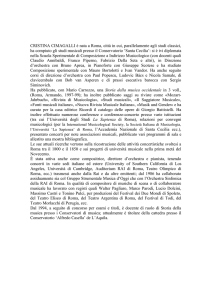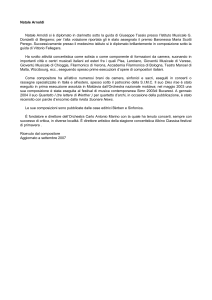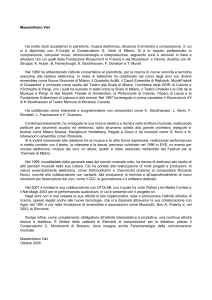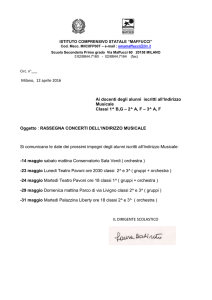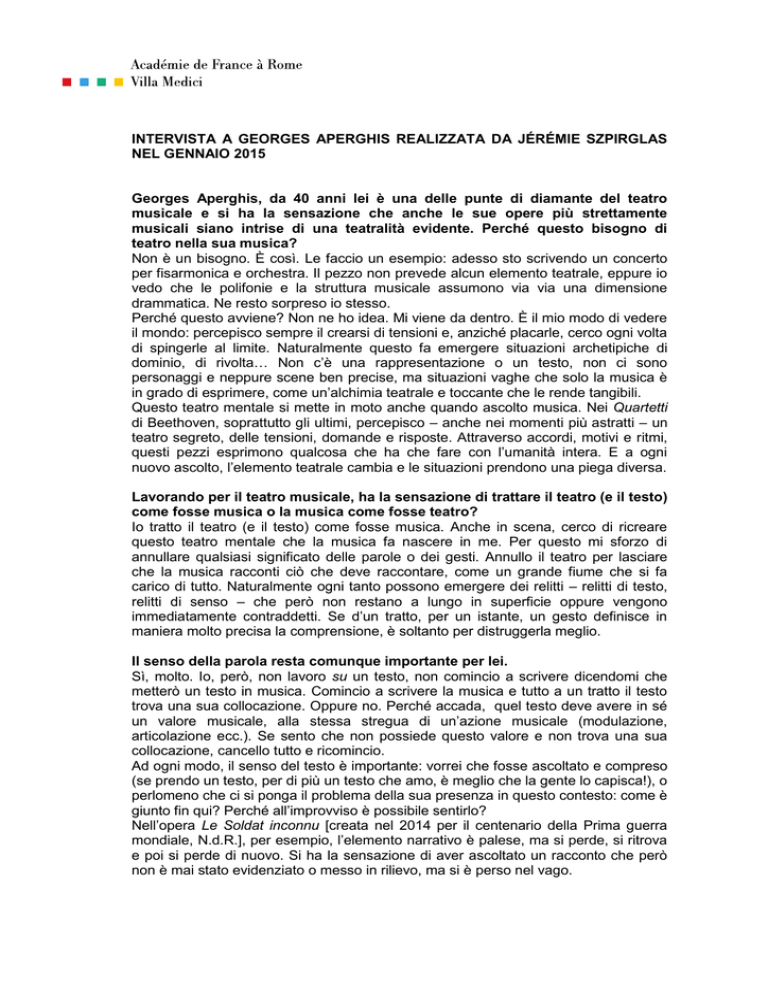
INTERVISTA A GEORGES APERGHIS REALIZZATA DA JÉRÉMIE SZPIRGLAS
NEL GENNAIO 2015
Georges Aperghis, da 40 anni lei è una delle punte di diamante del teatro
musicale e si ha la sensazione che anche le sue opere più strettamente
musicali siano intrise di una teatralità evidente. Perché questo bisogno di
teatro nella sua musica?
Non è un bisogno. È così. Le faccio un esempio: adesso sto scrivendo un concerto
per fisarmonica e orchestra. Il pezzo non prevede alcun elemento teatrale, eppure io
vedo che le polifonie e la struttura musicale assumono via via una dimensione
drammatica. Ne resto sorpreso io stesso.
Perché questo avviene? Non ne ho idea. Mi viene da dentro. È il mio modo di vedere
il mondo: percepisco sempre il crearsi di tensioni e, anziché placarle, cerco ogni volta
di spingerle al limite. Naturalmente questo fa emergere situazioni archetipiche di
dominio, di rivolta… Non c’è una rappresentazione o un testo, non ci sono
personaggi e neppure scene ben precise, ma situazioni vaghe che solo la musica è
in grado di esprimere, come un’alchimia teatrale e toccante che le rende tangibili.
Questo teatro mentale si mette in moto anche quando ascolto musica. Nei Quartetti
di Beethoven, soprattutto gli ultimi, percepisco – anche nei momenti più astratti – un
teatro segreto, delle tensioni, domande e risposte. Attraverso accordi, motivi e ritmi,
questi pezzi esprimono qualcosa che ha che fare con l’umanità intera. E a ogni
nuovo ascolto, l’elemento teatrale cambia e le situazioni prendono una piega diversa.
Lavorando per il teatro musicale, ha la sensazione di trattare il teatro (e il testo)
come fosse musica o la musica come fosse teatro?
Io tratto il teatro (e il testo) come fosse musica. Anche in scena, cerco di ricreare
questo teatro mentale che la musica fa nascere in me. Per questo mi sforzo di
annullare qualsiasi significato delle parole o dei gesti. Annullo il teatro per lasciare
che la musica racconti ciò che deve raccontare, come un grande fiume che si fa
carico di tutto. Naturalmente ogni tanto possono emergere dei relitti – relitti di testo,
relitti di senso – che però non restano a lungo in superficie oppure vengono
immediatamente contraddetti. Se d’un tratto, per un istante, un gesto definisce in
maniera molto precisa la comprensione, è soltanto per distruggerla meglio.
Il senso della parola resta comunque importante per lei.
Sì, molto. Io, però, non lavoro su un testo, non comincio a scrivere dicendomi che
metterò un testo in musica. Comincio a scrivere la musica e tutto a un tratto il testo
trova una sua collocazione. Oppure no. Perché accada, quel testo deve avere in sé
un valore musicale, alla stessa stregua di un’azione musicale (modulazione,
articolazione ecc.). Se sento che non possiede questo valore e non trova una sua
collocazione, cancello tutto e ricomincio.
Ad ogni modo, il senso del testo è importante: vorrei che fosse ascoltato e compreso
(se prendo un testo, per di più un testo che amo, è meglio che la gente lo capisca!), o
perlomeno che ci si ponga il problema della sua presenza in questo contesto: come è
giunto fin qui? Perché all’improvviso è possibile sentirlo?
Nell’opera Le Soldat inconnu [creata nel 2014 per il centenario della Prima guerra
mondiale, N.d.R.], per esempio, l’elemento narrativo è palese, ma si perde, si ritrova
e poi si perde di nuovo. Si ha la sensazione di aver ascoltato un racconto che però
non è mai stato evidenziato o messo in rilievo, ma si è perso nel vago.
Quindi non si tratta di mettere in musica un testo, ma è il testo che emerge nel
pezzo come un materiale musicale.
Esatto. In ogni caso è quello che ricerco. Non sempre ci riesco.
Ma come sceglie i testi che utilizza? Lei collabora da lungo tempo con lo
scrittore François Régnault, che le manda dei testi e la lascia libero di farne ciò
che vuole: tagliarli, farli a pezzi… In questo caso, ma anche (e soprattutto) nel
caso di un’opera come Avis de tempête, in cui ritroviamo Melville, Hugo, Kafka,
come sceglie tra questi materiali?
Nel caso di Avis de tempête, ho lavorato con Peter Szendy. Oltre ai suoi testi, sulla
mia scrivania c’erano sempre volumi di Baudelaire, Hugo e Melville. Testi che avevo
preso in considerazione, senza sapere affatto se avrebbero fatto parte
dell’avventura. Testi molto densi, capaci di raccontare tanto in appena due righe. È
scrivendo che all’improvviso emerge una frase. Due versi di Baudelaire, per
esempio, di cui a un tratto sento la necessità. Due versi che trovo magnifici, due versi
che si rivelano salvifici perché arrivano al momento giusto, proprio quando mi
servono. Questi frammenti di testo fanno riposare il flusso sonoro caricandosi allo
stesso tempo di un grande valore musicale: raccontano qualcosa, nutrono lo
spettatore apportandogli un elemento che la musica prima non poteva dargli: il
senso. Un senso immediato, portato da un testo che è già di per sé musica.
Il fatto che questi frammenti siano opera di grandi scrittori, da Flaubert a
Baudelaire, è importante per lei? Il loro significato e contesto d’origine hanno
una funzione?
Certo: se li ho presi in considerazione per un certo progetto, è perché hanno un
rapporto più o meno vicino con il “soggetto”. Ma scarto anche moltissimi dei testi che
avevo sondato all’inizio del lavoro, semplicemente perché non trovano una loro
collocazione.
Lei stesso scrive dei testi che poi usa nella sua musica: qual è il suo approccio
alla scrittura letteraria?
In genere parto da costruzioni molto formali come matrici, parole disarticolate, come
si sente benissimo nelle Récitations. Sono passato attraverso vari processi, che via
via si sono evoluti. Si tratta di scegliere il testo con la musicalità più ricca, badando al
senso che ne scaturisce: perché nel momento stesso in cui si uniscono due o tre
sillabe, un senso emerge sempre. Anche se quelle sillabe non vogliono dire niente, la
mente umana, sentendole, non può fare a meno di attribuire loro un significato. Si
pongono allora diversi interrogativi: quel senso è appropriato? Fino a che punto si
lascia al testo la libertà di avere un senso? Non sarebbe invece meglio distruggerlo?
Ecco perché lavoro molto sulla ripetizione: con la ripetizione, uno stesso motivo può
tornare in un contesto diverso, con un’altra funzione, e il senso che si credeva di
potergli dare non ha più ragione di essere. Un po’ come una giostra. In questo modo
non si ha più un significato unico e univoco, ma diversi significati che si trasformano
costantemente e ci sfuggono: la logica cartesiana è incessantemente tradita e io
posso arrivare all’ascoltatore prima che capisca qualcosa. Immagino sia la situazione
in cui si trovano i bambini quando sentono i discorsi incomprensibili degli adulti e si
aggrappano a sillabe o a sonorità carpite al volo che suscitano in loro dei pensieri, a
volte senza alcun nesso. In realtà, si tratta dello stesso processo intellettivo che entra
in ballo nell’ascolto “teatralizzato” della musica di cui parlavamo poco fa.
Perché si è rivolto allo scrittore Olivier Cadiot per Tourbillons?
Olivier aveva lavorato molto con Pascal Dusapin, ed è così che ci siamo incontrati. È
un grandissimo scrittore, e un personaggio fuori dagli schemi. Parla come scrive!
Abbiamo scoperto subito di avere una forma di dinamismo comune e ci è venuta
voglia di collaborare. Tourbillons esisteva già, ma sotto forma di sei brevi pezzi vocali
disseminati di frammenti parole francesi; lui li ha dissezionati per elaborare il suo
testo – un testo astratto e al tempo stesso concreto, pieno di poesia. Poi me l’ha
mandato dicendomi di farne ciò che volevo. Ho sempre un enorme rispetto per un
testo che mi viene regalato: gli resto molto fedele e faccio attenzione a ogni parola.
Questo rapporto con il testo è presente e attivo anche nella sua musica
strettamente strumentale?
A volte, anzi spesso. Soprattutto nei piccoli ensemble strumentali e praticamente
sempre nei soli, molto meno nella musica orchestrale. In genere, per me il solo
rientra nel parlato: ho anche composto un brano per contrabbasso intitolato
Parlando. Ovviamente non si sa mai cosa si dice, ma certi ascoltatori mi raccontano
di avere la sensazione di sentire diversi personaggi che si esprimono uno dopo l’altro
o tutti insieme. Non so cosa dire… Per me è un monologo.
Perché si è lanciato nell’avventura dell’ATEM (Atelier Théâtre et Musique), e
cosa ha tratto da questa esperienza?
Il progetto aveva un duplice obiettivo. Da una parte, si trattava di fondere il mondo
del teatro e quello della musica, di fare del teatro musicale una disciplina, una forma
artistica a tutti gli effetti, dandosi il tempo di inventarne il vocabolario e la
grammatica. Dall’altra, volevamo che questo lavoro coinvolgesse una periferia. Il
1968 non era lontano e noi eravamo pieni di ideali. Avevamo in mente questa utopia
di un contatto diretto tra gli artisti e il pubblico, senza intermediari. Un’utopia
associata a una problematica sociale: come arrivare a un pubblico che non è mai
stato a teatro o a un concerto, e che ha come unico punto di riferimento la
televisione? Alcuni si sono commossi, altri si sono sentiti colpiti, altri ancora hanno
riso. Avevamo di fronte un pubblico che non conosceva i codici, che non possedeva
la chiave di accesso del linguaggio utilizzato – il che per certi versi era stimolante:
dovevamo trovare un modo di far entrare quel pubblico nel nostro universo, senza
appesantire il discorso con un approccio didattico e senza compromettere il nostro
percorso artistico, il tutto continuando a offrirgli una dimensione ludica. In effetti si
trattava di una visione del tutto utopica. Era un po’ come procedere su una scala a
cui mancano dei gradini: cerchi di mettere delle corde per aiutare qualcuno a salire
ma ti rendi subito conto che non basta…
L’esperienza dell’ATEM è stata estremamente fruttuosa ma anche logorante. Gli
incontri sono stati fantastici, inaspettati e insoliti, ma ora sono contento di passare la
palla a qualcun altro.
Lavorando nell’ambito del teatro musicale, non ha frequentato solo musicisti
ma anche attori…
Il lavoro dell’attore mi ha dato molto. La mia frequentazione di artisti che spesso non
conoscevano il solfeggio non è peraltro estranea al mio approccio nei confronti della
lingua.
Restando in tema, la sua scrittura vocale si distingue per l’immensa varietà, in
particolare nella resa della parola…
Per me si tratta sempre di musica: la musica della parola. Io utilizzo il dire in maniera
diversa, facendone qualcosa che non è esattamente parlato e neppure musica, ma
una sorta di punto di incontro tra i due, qualcosa di sospeso a un filo. Così gioco su
tutti i dettagli dell’enunciato che sono assenti nel testo scritto e che possono tradurre
musicalmente lo stato di una persona: canto, parlato-cantato, pausa, fiato ecc. Il
problema è trovare una logica, una forma di continuità e dinamica. Per
drammatizzare un testo, per esempio, immagino che qualcuno lo reciti. La musica è
una preparazione dell’enunciato del testo, come un parto.
Lei affronta l’attività di regista come quella di compositore? Le considera due
facce di uno stesso mestiere?
Io non sono un regista, i miei pezzi sono quasi le uniche cose che metto in scena.
Una volta creato il suono (testo, musica…) e ideata la cornice scenica, il mio lavoro
consiste nel far coesistere ciò che si vede e ciò che si sente, perché l’uno chiarisca
l’altro senza metterlo in ombra, in una continua ricerca di equilibrio: la dimensione
visiva è spesso predatrice e troppo facilmente prende il sopravvento sulla musica. In
realtà, si tratta di un’opera di “sistemazione” volta a far sì che lo spettatore possa
recepire l’insieme senza interrompere l’ascolto.
Un temps bis, con Valérie Dréville e Geneviève Strosser, è stato la mia prima
esperienza di messa in scena di opere musicali non mie. Ovviamente ero vincolato al
testo di Samuel Beckett, ma bisognava anche sistemare i pezzi di Helmut
Lachenmann e Franco Donatoni. È stato un lavoro lento e molto complesso.
Abbiamo scandagliato il testo parola per parola, per capire veramente com’era
costruito. Dopodiché ci siamo chiesti come far comprendere questo materiale così
complesso, che si arricchisce di un senso nuovo a ogni lettura. Eravamo come un
violoncellista alle prese con una Suite di Bach: ci trovavamo continuamente di fronte
a scelte, concatenazioni, articolazioni, respirazioni… Questa pluralità di opzioni
interpretative contribuisce, a mio avviso, alla bellezza di un’opera.
Nello stesso spirito, io che non sono affatto credente mi interesso molto – come
fosse un gioco per bambini – ai testi sacri e ai loro commenti di commenti di
commenti.
Come dicevamo all’inizio di questa intervista, lei è uno dei pionieri dei nuovi
formati della rappresentazione musicale, ma non si sente del tutto a suo agio
con le forme e gli organici “canonici” della musica occidentale: per esempio,
non ha composto molto per orchestra o per quartetto… Perché?
È buffo che lei mi ponga questa domanda, perché ho appena ricominciato a scrivere
un pezzo per orchestra dopo due anni. Nel caso specifico, è il risultato di una serie di
incontri: lavoro con il direttore Emilio Pomarico, del quale ho enorme stima, e per le
ottime orchestre di Colonia e Monaco.
Nella scrittura per orchestra sento molto la mancanza del quarto di tono: non oso
inserirlo in partitura! Ma in questo momento sono completamente immerso in questo
lavoro, da cui traggo immensa soddisfazione.
Poco fa parlavamo della sua visione del solo: nell’orchestra, le interessa il
concetto di “sezione”?
Sì, anche se scrivo spesso per sezioni “divise”. E quando il materiale si fa più
rarefatto, i piccoli soli non sono infrequenti. Ma questo non impedisce in alcun modo
di andare a cercare ogni tanto la massa orchestrale, quando serve.
Per tornare alla sua domanda, riguardo al quartetto ho fatto un bell’incontro con il
Quatuor Arditti, per il quale ho composto Dix pièces pour quatuor à cordes (1986).
Ma per me il quartetto resta un mistero. Non ho ancora trovato la porta d’accesso – o
perlomeno la mia porta d’accesso – per addentrarmi realmente in questo universo.
Forse non la troverò mai.
Il trio – trio d’archi, violino violoncello, piano o clarinetto, violoncello, piano – non mi è
oscuro: ho già provato e sono riuscito a intravedere delle porte d’accesso possibili.
Ma il quartetto…
Non c’è niente di più facile che scrivere un brano per quattro – e ci provano in molti,
io per primo. Ma un quartetto è un’altra cosa. Il quartetto è uno strano animale!
Prendiamo i Quartetti di Haydn, o gli ultimi di Mozart, per non parlare poi di
Beethoven o Bartók: ascoltandoli si ha la sensazione di trovarsi di fronte una bestia
sensibile, suscettibile. Come ammansirla? Come farle dire ciò che si ha voglia di
dire? Non lo so, non ho ancora trovato la soluzione.
È ovvio che io sia intimidito dalla storia del quartetto e da tutti i suoi capolavori! Ho
troppi dubbi. La mia musica lavora principalmente sui margini e penso che, prima di
lanciarsi, il quartetto esiga scelte radicali. Come quelle che ha saputo fare così bene
Helmut Lachenmann: ma il suo approccio rumoristico è il risultato di un’avventura
umana a cui ha dedicato tutta la vita. Non sarei assolutamente in grado di scrivere un
quartetto rumoristico all’altezza dei suoi. È chiaro che non è quella la mia porta
d’accesso. Forse potrei tentare con una nuova visione dell’armonia.
Eppure in quei quattro musicisti sul palco c’è una certa teatralità, ma una teatralità
lieve che non riesco a dominare. Forse perché, quando ascolto i classici, quell’intima
teatralità è di un tale rigore! Ho l’impressione che non potrà mai appartenermi, che
faccia parte del passato, che sia già stato detto tutto – per quanto Helmut sia riuscito
a esprimere anche dell’altro!
Poco fa abbiamo sfiorato il tema: lei ha un certo numero di interpreti fedeli,
alcuni dei quali sono invitati a Roma per Controtempo 2015 (Donatienne
Michel-Dansac, l’ensemble Accroche Note e Geneviève Strosser). Sono
interpreti “feticcio”, nel senso che la loro conoscenza del suo universo è tale
che può chiedere loro ciò che vuole, oppure sono interpreti fedeli, innamorati
della sua musica e pronti a tutto?
È strano: credo si tratti piuttosto di amicizie che si creano tramite la musica. Ed è un
vero piacere lavorare con degli amici perché riesci a indovinare cosa potrebbe
interessare o piacere loro. È come fare dei miniritratti, anche se restano vaghi e
indefiniti.
Col passare del tempo li conosci meglio, c’è uno scambio continuo, e non scrivi più
per loro come all’inizio, non affronti più i problemi alla stessa maniera. Quando
conosci un interprete, puoi anche chiedergli di più, puoi lasciarti andare. La stima e la
fiducia reciproca è tale che se mi dice che non può fare quello che chiedo, gli credo e
correggo senza esitazioni il passaggio incriminato. Quando compongo per queste
persone, non considero mai veramente conclusa la partitura che mando.
Conoscere bene i propri interpreti, però, può anche causare dei problemi: a
conoscerli troppo, a frequentarli troppo, si tende a rappresentarseli sempre con gli
stessi tratti, con lo stesso colore. L’immagine che se ne ha può cristallizzarsi.
Viceversa, è interessante ignorare quell’immagine e portare i propri interpreti su
territori che non corrispondono al carattere che attribuiamo loro.
Mi piace molto anche scrivere per qualcuno che non conosco affatto, che posso solo
immaginare, ma l’amicizia mi fa correre dei rischi in più.
Bisogna conoscere a fondo la sua musica per interpretarla bene, come fanno i
suoi fedeli?
Non credo. Certo, inizialmente la mia musica è difficile, ma per fortuna è anche
possibile che l’interprete non conosca né me, né la mia musica e che la cosa funzioni
comunque.
Mi è capitato proprio ultimamente: Holger Falk, un baritono tedesco mai visto né
conosciuto doveva riprendere ad Atene Le Soldat Inconnu, una parte che avevo
scritto per Lionel Peintre, un mio carissimo amico e collaboratore di lunga data. Ho
avuto modo di ascoltare la registrazione del concerto di Atene e sono rimasto molto
stupito nel constatare che il risultato era molto vicino a quello di Lionel, anche se Falk
sembra interpretare il testo con più distanza e umorismo. Eppure io non lo conosco
per niente, e lui non conosce affatto Lionel. Vuol dire che la scrittura è lì, e che basta
da sola a produrre la musica.
Il che ci riporta al teatro: il fatto di conoscere così bene i suoi interpreti la fa
giocare con il loro “personaggio” e la loro presenza scenica oltre che con il
loro talento musicale?
Siccome li conosco bene, li immagino sulla scena. Fa parte della scrittura: mi aiuta a
sapere quello che viene o non viene loro naturale. Devo tener conto di questo
aspetto e trasporlo nella partitura oppure contrastarlo? In questo mi baso
essenzialmente sull’intuizione personale.
Prendiamo ad esempio Tourbillons: conoscevo già molto bene Donatienne, e ho
composto in funzione di quello che immaginavo di lei, in particolare per quanto
riguarda l’irruzione della musica nel testo, anche se il nucleo dei Six Tourbillons per
voce era stato scritto in precedenza per Martine Viard. Abbiamo montato lo
spettacolo in tre giorni! Durante le prove, mi rendevo conto che Donatienne reagiva
positivamente e che il lavoro le corrispondeva, ed è senz’altro per questo che siamo
andati così veloci.
In linea generale, detesto convincere. È qualcosa di molto lontano da me. Se un’idea
non funziona, la metto da parte e faccio altro. Non voglio perdere il mio tempo in
spiegazioni: bisogna andare avanti. Si trovano altre soluzioni. Non ne esiste una sola
possibile.
La sua musica dà spesso l’impressione che lei abbia ancora lo spirito di un
bambino – solo che i giochi che lei manipola in tutti i modi sono i suoni, le
parole e così via.
Amo molto giocare. E voglio passare la mia vita a giocare. È un privilegio incredibile.
Sono molto curioso e ho bisogno che la mia curiosità sia stimolata da cose che non
conosco o immagino, o che ho dimenticato (a volte mi pongo problemi che mi sono
già posto molto tempo fa). Sul momento non so dove questo mi porterà. Che incontri
farò? In che polifonia, con quali altre voci mi imbarcherò? Che cosa accadrà? Chi
prenderà il sopravvento?
È un gioco e questo mi stimola, mi spinge a mettere in gioco delle forze e a vedere
come si sviluppano e interagiscono. Un po’ come quei trenini elettrici che si lanciano
sui binari calcolando con esattezza la distanza dagli incroci: i vagoni riusciranno a
evitarsi all’ultimo secondo o assisteremo a una minicatastrofe?
Anche tutto ciò che è burlesco mi affascina: il circo, i maghi, Méliès, Robert Houdin, i
prestigiatori. Li trovo magnifici, mi fanno impazzire!
Lei sarebbe un prestigiatore dei suoni, che fa apparire e sparire il senso a suo
piacimento…
Ci provo!
I suoi pezzi possono essere molto divertenti: ricerca la risata o arriva da sola?
Dipende. A volte il riso comincia timidamente, e basta una piccola spinta per
rivelarlo, ma la maggior parte delle volte nasce in maniera spontanea: viene, lo vedo
arrivare e non lo elimino mai. Bisogna fare in modo che conservi questa fragilità del
non fatto apposta. Se si calca la mano, diventa troppo pesante e triste.
Il pubblico ride ascoltando la sua musica?
Forse interiormente. Quando facevo pezzi di teatro musicale come Énumérations o
Conversations, rideva molto. Ne andavo molto fiero: il riso è un’arma incredibile.
Permette di raccontare tanto. Più dei lamenti.
di Jérémie Szpirglas