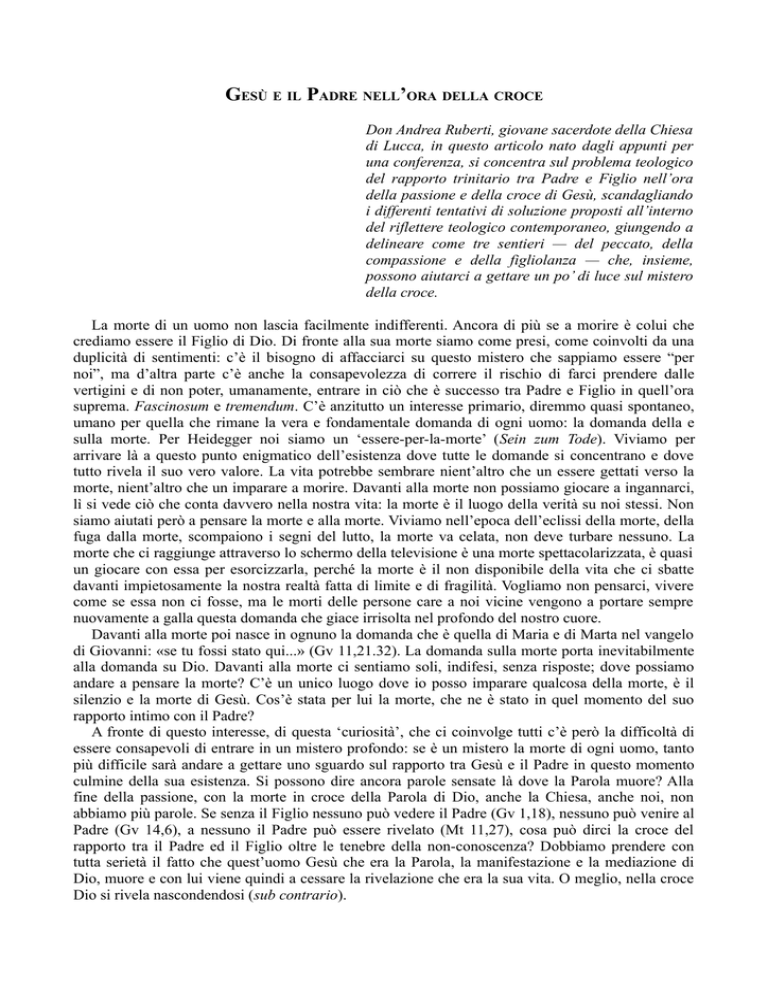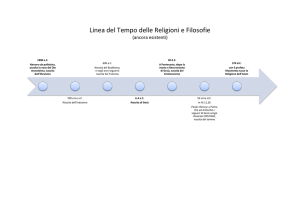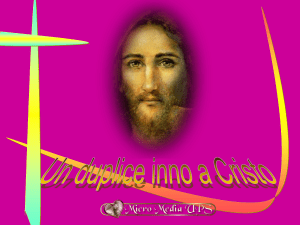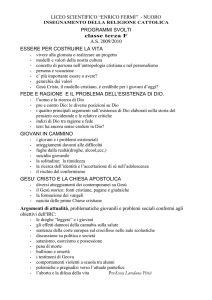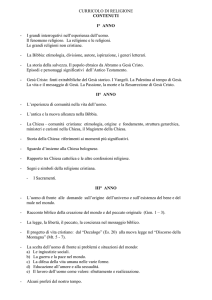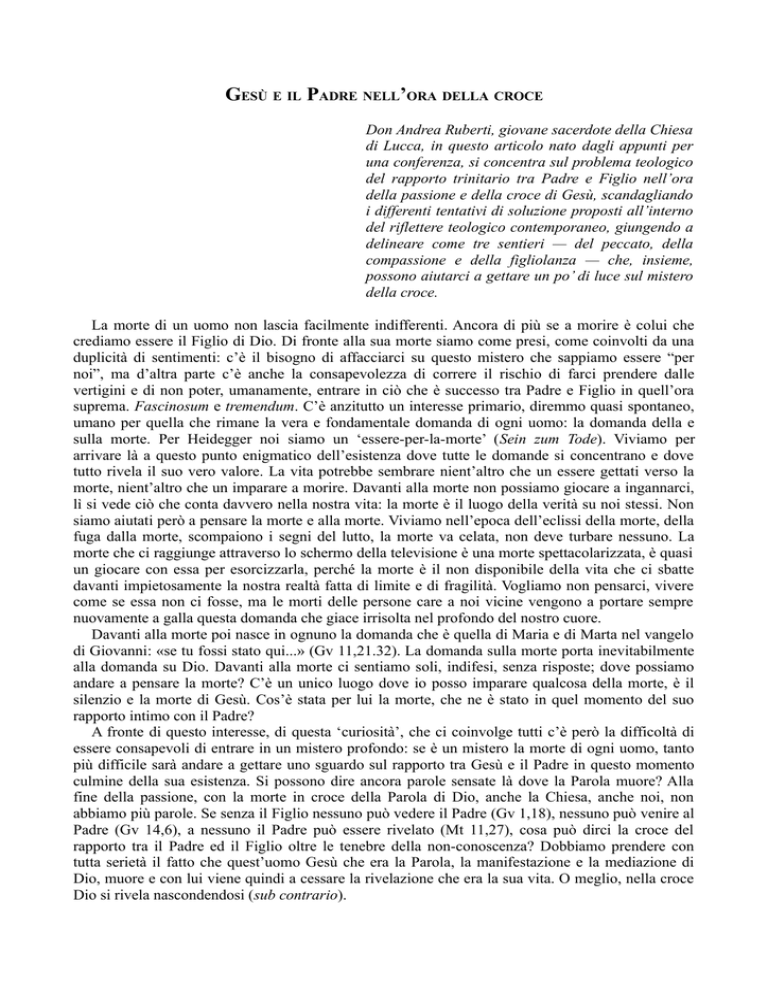
GESÙ E IL PADRE NELL’ORA DELLA CROCE
Don Andrea Ruberti, giovane sacerdote della Chiesa
di Lucca, in questo articolo nato dagli appunti per
una conferenza, si concentra sul problema teologico
del rapporto trinitario tra Padre e Figlio nell’ora
della passione e della croce di Gesù, scandagliando
i differenti tentativi di soluzione proposti all’interno
del riflettere teologico contemporaneo, giungendo a
delineare come tre sentieri — del peccato, della
compassione e della figliolanza — che, insieme,
possono aiutarci a gettare un po’ di luce sul mistero
della croce.
La morte di un uomo non lascia facilmente indifferenti. Ancora di più se a morire è colui che
crediamo essere il Figlio di Dio. Di fronte alla sua morte siamo come presi, come coinvolti da una
duplicità di sentimenti: c’è il bisogno di affacciarci su questo mistero che sappiamo essere “per
noi”, ma d’altra parte c’è anche la consapevolezza di correre il rischio di farci prendere dalle
vertigini e di non poter, umanamente, entrare in ciò che è successo tra Padre e Figlio in quell’ora
suprema. Fascinosum e tremendum. C’è anzitutto un interesse primario, diremmo quasi spontaneo,
umano per quella che rimane la vera e fondamentale domanda di ogni uomo: la domanda della e
sulla morte. Per Heidegger noi siamo un ‘essere-per-la-morte’ (Sein zum Tode). Viviamo per
arrivare là a questo punto enigmatico dell’esistenza dove tutte le domande si concentrano e dove
tutto rivela il suo vero valore. La vita potrebbe sembrare nient’altro che un essere gettati verso la
morte, nient’altro che un imparare a morire. Davanti alla morte non possiamo giocare a ingannarci,
lì si vede ciò che conta davvero nella nostra vita: la morte è il luogo della verità su noi stessi. Non
siamo aiutati però a pensare la morte e alla morte. Viviamo nell’epoca dell’eclissi della morte, della
fuga dalla morte, scompaiono i segni del lutto, la morte va celata, non deve turbare nessuno. La
morte che ci raggiunge attraverso lo schermo della televisione è una morte spettacolarizzata, è quasi
un giocare con essa per esorcizzarla, perché la morte è il non disponibile della vita che ci sbatte
davanti impietosamente la nostra realtà fatta di limite e di fragilità. Vogliamo non pensarci, vivere
come se essa non ci fosse, ma le morti delle persone care a noi vicine vengono a portare sempre
nuovamente a galla questa domanda che giace irrisolta nel profondo del nostro cuore.
Davanti alla morte poi nasce in ognuno la domanda che è quella di Maria e di Marta nel vangelo
di Giovanni: «se tu fossi stato qui...» (Gv 11,21.32). La domanda sulla morte porta inevitabilmente
alla domanda su Dio. Davanti alla morte ci sentiamo soli, indifesi, senza risposte; dove possiamo
andare a pensare la morte? C’è un unico luogo dove io posso imparare qualcosa della morte, è il
silenzio e la morte di Gesù. Cos’è stata per lui la morte, che ne è stato in quel momento del suo
rapporto intimo con il Padre?
A fronte di questo interesse, di questa ‘curiosità’, che ci coinvolge tutti c’è però la difficoltà di
essere consapevoli di entrare in un mistero profondo: se è un mistero la morte di ogni uomo, tanto
più difficile sarà andare a gettare uno sguardo sul rapporto tra Gesù e il Padre in questo momento
culmine della sua esistenza. Si possono dire ancora parole sensate là dove la Parola muore? Alla
fine della passione, con la morte in croce della Parola di Dio, anche la Chiesa, anche noi, non
abbiamo più parole. Se senza il Figlio nessuno può vedere il Padre (Gv 1,18), nessuno può venire al
Padre (Gv 14,6), a nessuno il Padre può essere rivelato (Mt 11,27), cosa può dirci la croce del
rapporto tra il Padre ed il Figlio oltre le tenebre della non-conoscenza? Dobbiamo prendere con
tutta serietà il fatto che quest’uomo Gesù che era la Parola, la manifestazione e la mediazione di
Dio, muore e con lui viene quindi a cessare la rivelazione che era la sua vita. O meglio, nella croce
Dio si rivela nascondendosi (sub contrario).
Il ‘900 ha un luogo simbolo del silenzio e del nascondersi di Dio: Auschwitz. Riflettere da
credenti sul dramma della croce e sull’opprimente senso di distanza che essa sembra porre tra il
Padre e il Figlio — distanza che finisce poi per riversarsi inevitabilmente nel rapporto Dio–uomo
—, è anche un umile recarci, in pellegrinaggio, verso questo tragico luogo della memoria per
lasciarci mettere in crisi dalla domanda che ha inquietato la coscienza e il pensare di molti teologi
del dopo guerra: “Si può ancora parlare di Dio dopo Auschwitz”? Perché Dio, il Dio d’Israele ha
abbandonato il suo popolo? La “soluzione finale” di Hitler tesa ad annientare gli ebrei, non ha
annientato Dio e la sua onnipotenza agli occhi dell’uomo moderno? Questo luogo del “male
assoluto”, metafisico, del nostro secolo, luogo che sembra decretare la fine di ogni teologia della
storia, non può non restare sullo sfondo ogni volta che oggi torniamo a gettare lo sguardo sull’altro
luogo dove il male si è scatenato con tutta la sua forza: la croce del Figlio di Dio 1.
Presi tra questi due sentimenti contrapposti, possiamo andare a scrutare i racconti della passione
(ad iniziare dall’ultima cena) dei vangeli facendo attenzione ai passi nei quali è messo in evidenza il
rapporto tra Gesù e il Padre 2. Il risultato è interessante: non possiamo leggere sotto un registro unico
questo rapporto. Ci sono passaggi nei quali la distanza si fa massima e quasi insostenibile, altri
invece rivelano al contrario una profonda comunione e un’estrema fiducia che si fa abbandono
reciproco. Addirittura per Luca Gesù sulla croce, lungi dal sentirsi ripudiato dal Padre, ha ancora la
forza per pregarlo e abbandonarglisi. Significativo ci sembra il vangelo di Giovanni nel quale i
riferimenti al rapporto tra Gesù e il Padre abbondano nei capitoli 13-17 e sono tutti tesi ad
evidenziare un’intimità e un’unità che sembrerebbe al riparo da ogni sorpresa. Dal momento
dell’arresto nel Getsemani però il Padre scompare 3 e ciò non può non colpire il lettore. Anche per
Giovanni, l’evangelista del «chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9), arriva un momento —
quello delle tenebre — nel quale il Padre si fa da parte, si nasconde e lascia un vuoto tragico nella
vita del Figlio, un vuoto nel quale andrà a piantarsi la croce. Giovanni non parla esplicitamente
della distanza, della separazione tra Padre e Figlio sulla croce, ma fa uscire il Padre dalla scena…
Queste diverse sfumature non possono annullare lo scandalo della croce. Gesù si era presentato
come il profeta del regno a venire, come il Figlio prediletto del Padre in un rapporto di speciale
intimità con lui. Ora però è morto e questo non può non sconcertare. Come colui che annuncia
l’imminenza del regno ha potuto scomparire senza che Dio, foss’anche all’ultimo momento,
intervenisse per dare ragione con potenza al suo profeta e riconoscere con tenerezza il suo Figlio?
Dio assume qui un nome oscuro, egli è “Colui che abbandona”, ed anche se la risurrezione ci
svelerà altri nomi di Dio a partire da quello di “Colui che ha risuscitato Gesù dai morti”, questi non
possono far dimenticare gli altri. La domanda su Dio posta dalla croce non può trovare risposta
solamente nella risurrezione (anche se per At la morte è opera dei giudei, mentre l’opera del Padre è
la risurrezione: At 3,13ss), la risposta dovremo cercare di trovarla, per quanto è possibile, negli
stessi racconti della morte.
Entriamo quindi in punta di piedi nell’evento centrale della fede cristiana — la vicenda della
passione — sapendo che tutto quello che qui accade avviene “per noi e per la nostra salvezza” come
Sui riflessi di Auschwitz sulla fede e la teologia: M. BROCKE – H. JOCHUM (ed.), Wolkensäule und Feuerschein. Jüdische
Teologie des Holocaust, München 1982; H. JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Genova 1989;
J.B. METZ, «Ökumene nach Auschwitz – Zum Verhältnis von Christen und Juden in Deutschland», in E. Kogon – J.B.
Metz (ed.), Gott nach Auschwitz, Freiburg 1979, 121 ss.; ID., «Al cospetto degli ebrei. La teologia cristiana dopo
Auschwitz», in Concilium 20 (1984), 5, 50-65; E. JÜNGEL, «Gottes ursprüngliches Anfangen als schöpferische
Selbstbegrenzung», in Gottes Zukunft –Zukunft der Welt, München 1986, 265-275; A. LIPPI, «La teologia dopo
Auschwitz. Riflessioni su E. Wiesel e H. Jonas», in La Sapienza della croce 8 (1993), 95-106; ID., «Fackenheim e la
testimonianza contro Auschwitz », in La Sapienza della croce 9 (1994), 11-22; A.H. FRIEDLANDER, Das Ende der Nach.
Jüdische und christliche Denker nach dem Holocaust, Gütersloh 1995; C. MÜNZ, Der Welt ein Gedächtnis geben.
Geschichtstheologisches Denken im Judentum nach Auschwitz, Gütersloh 1995; M. GIULIANI, Auschwitz nel pensiero
ebraico, Brescia 1998; J. MOLTMANN, «La fossa – e Dio dov’era? Teologia ebraica teologia cristiana dopo Auschwitz»,
in Id., Dio nel progetto del mondo moderno. Contributi della rilevanza pubblica della teologia, Brescia 1999, 165-184.
2
I passi sono riportati in appendice.
3
L’ultimo versetto in cui il Padre è nominato si riferisce proprio alla scena dell’arresto: «Rimetti la tua spada nel fodero;
non deevo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» (Gv 18,11).
1
recitiamo nel Credo. I tre giorni del mistero pasquale sono da interpretarsi nel duplice senso che ha
in italiano la parola “passione” per capire correttamente il mistero di Cristo: la storia di Cristo è la
storia di una grande passione, di una speranza appassionata, di una dedizione a Dio ed al suo regno
che diventa anche la storia di una passione inaudita, mortale. Al centro della fede cristiana sta la
passione del Cristo appassionato. Passione come grande desiderio, come grande amore e passione
come sofferenza fino alla morte; ecco i due aspetti inseparabili della croce di Gesù 4. Egli vive la sua
grande passione per Dio e per l’uomo fino a patire le sofferenze e la morte in croce: «Avendo amato
i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). La storia della passione è dunque la
storia di un grande amore, una storia nella quale troviamo sicuramente l’amore di Gesù per il Padre:
«Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato»
(Gv 14,31); nella quale troviamo certamente l’amore di Dio per noi: «Dio dimostra il suo amore per
noi, perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,8); «non siano stati
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione
per i nostri peccati» (1 Gv 4,10). Ma possiamo dire di trovare anche l’amore del Padre per il Figlio?
Paolo mettendo in parallelo la croce con il sacrificio di Isacco nel Primo Testamento dice: «Dio non
ha risparmiato il proprio Figlio» (Rm 8,32). È possibile che questo “non risparmiare” manifesti il
suo amore? Proprio la storia di Abramo che fa da sottofondo a questo testo ci apre uno spiraglio: nel
testo di Gen 22 l’attenzione non è centrata su Isacco, sul suo essere vittima innocente, sulla sua
paura, sul suo dolore, tutto è teso a mostrarci il sacrificio che Abramo deve compiere; così in Rm
Paolo vuole sottolineare l’aspetto sacrificale della donazione del Figlio da parte del Padre, il dono
non indifferente che il Padre fa del Figlio.
La storia della passione appassionata di Gesù comincia nell’orto del Getsemani. Diverse volte i
vangeli ci raccontano di Gesù che si ritira in preghiera di notte per unirsi al Padre. Qui, per la prima
volta, Gesù sembra aver paura di restare solo con Dio e cerca la compagnia dei suoi amici, porta
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e, provando paura, tristezza e angoscia, inizia a pregare perché il
Padre allontani da lui il calice, perché gli risparmi la sofferenza che lo attende. Certamente c’è nella
preghiera di Gesù la paura umana di fronte alla morte e ad una morte preceduta da una lunga agonia
piena di sofferenza e di dolore, ma l’angoscia da cui Cristo è sconvolto fino a sudare sangue è di
tutt’altro genere: è il timore che lui, il Figlio unigenito, che ama il Padre come nessuno lo ha amato,
possa essere da lui abbandonato, ha paura della separazione dal Padre. Gesù non teme tanto per la
sua vita, ma per la sua relazione con il Padre 5. Questo è il vero tormento della passione di Gesù, il
calice che non gli verrà risparmiato. Egli dovrà passare attraverso le tenebre di Dio, la notte oscura
dell’anima come la chiamano i mistici, attraverso il tremendo silenzio di Dio che non sembra
mettersi dalla sua parte contro i carnefici. E il Padre sembra davvero non ascoltare la supplica del
Figlio suo, il Padre si sottrae al Figlio e lo lascia solo. Se durante tutta la sua vita Gesù aveva
continuamente affermato con le parole, con i fatti e con il suo atteggiamento che “Io e il Padre
siamo una cosa sola”, qui questa unione stretta sembra incrinarsi. Dio si sottrae. Dio tace. Con
questa preghiera non esaudita e respinta dal silenzio di Dio, Gesù inizia la sua passione, la sua
agonia nell’abbandono del Padre. Eppure c’è nel Nuovo Testamento un testo che sembra
contraddire tutto questo: «nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti
grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà» (Eb 5,7). Dio
risponde, Dio esaudisce, ma a modo suo6.
Vedi ciò che afferma J. MOLTMANN, Trinità e regno di Dio. La dottrina su Dio, Brescia 1983, 32: «Il termine ‘passione’
ha il duplice significato di sofferenza e ardore, e appunto in questa duplice accezione è atto ad esprimere la verità
centrale della fede cristiana. Questa vive della sofferenza di un grande ardore ed è essa stessa la passione disposta a
soffrire per la vita».
5
J. MOLTMANN, Trinità e regno di Dio, 87, si chiede: «A quale sofferenza egli allude con questo ‘calice’, il calice
inebriante? Supplica di venir preservato dalla morte, di venir sottratto ad essa? Io penso che egli abbia paura della
separazione dal Padre, dell’orrore di fronte alla ‘morte di Dio’».
6
Sul silenzio di Dio si possono consultare i seguenti contributi: G. BOF, Parola e silenzio nella teologia cristiana, in M.
Baldini - S. Zucal (ed.), Le forme del silenzio e della parola, Brescia 1989, 389-402; B. FORTE, «Alta silentia»: il
silenzio nella comunione trinitaria alla luca del silenzio della croce, in Dio parla nel silenzio, Roma 1989, 59-76; A.
NEHER, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, Casale Monferrato 1983.
4
C’è un verbo greco che attraversa tutti i racconti di passione, è paradidÒnai7. La vicenda della
passione è una storia di consegne, di consegne umane e di consegne divine. Al suo inizio troviamo
Giuda, un apostolo, uno degli intimi di Gesù, che lo tradisce consegnandolo agli avversari: «Allora
Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù» (Mc
14,10). Il sinedrio poi, custode e rappresentante della Legge, consegna il bestemmiatore all’autorità
romana: «Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver
tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato» (Mc 15,1).
Questi, pur convinto della sua innocenza, cede alla pressione della folla sobillata dai suoi capi e
«dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso» (Mc 15,15)8. La vicenda
delle ultime ore di Gesù si snoda attraverso questa catena di consegne, di passaggi di mano, ma chi
lo ha messo nelle loro mani? «Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini
e lo uccideranno» (Mc 9,31) aveva detto Gesù stesso annunciando la sua passione. Ma chi è il
soggetto di questa consegna? Dietro questo passivo divino c’è il Padre, è lui a consegnarlo nelle
mani degli uomini: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,16);
«Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi» (Rm 8, 32). Gesù
affermando che «Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini» (Lc 9, 44)
percepiva, prima e al di là delle azioni degli uomini, la volontà del proprio Padre. Questa
affermazione, Dio che consegna il Figlio nelle mani dei peccatori è una delle più inaudite del
Secondo Testamento: Cristo venne abbandonato con assoluta premeditazione del Padre al destino
della morte, Dio lo ha spinto in braccio alle potenze della corruzione. Paolo legge tutto questo come
il grande amore di Dio per noi dal quale «nulla potrà mai separarci» (Rm 8, 39). Quel Padre che
invia il proprio Figlio nell’abisso e nell’inferno del suo abbandono, nella solitudine e
nell’annientamento, quello stesso Padre è presente, con il Figlio, in tutti i suoi, in ogni luogo di
consegna e di abbandono. Il Padre abbandona e consegna il Figlio ‘per noi’, cioè lo abbandona per
diventare il Dio e il Padre degli abbandonati. Ma questo aspetto inquietante della consegna del
Padre riceve nel NT un necessario completamento dall’autoconsegna che il Figlio fa di sé: «mi ha
amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20) dice Paolo 9; «camminate nella carità, nel modo
che anche Cristo vi ha amato e ha consegnato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di
soave odore» (Ef 5,2). Nell’avvenimento della consegna dunque Gesù non è soltanto oggetto, ma
pienamente soggetto; la sua non è una passione subita, ma una passio activa, una via crucis
volutamente imboccata, un’agonia accettata per il suo amore appassionato per Dio e per gli uomini.
Questa consegna di sé l’aveva già annunciata durante la sua vita: «Il Figlio dell’uomo infatti non è
venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45);
«Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me
la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo.
Questo comando ho ricevuto dal Padre mio» (Gv 10,17-18). Così, lì dove sembrava esserci la
massima separazione, troviamo invece la più profonda comunione d’intenti tra il Figlio consegnato
e il Padre che volutamente consegna. Sulla croce sono massimamente separati, ma anche così uniti
da esprimere un unico movimento di donazione per la nostra salvezza. Soprattutto qui allora vale il
detto: “Chi vede il Figlio vede il Padre” 10.
Sulla “consegna” vedi H.U. VON BALTHASAR, «Mysterium Paschale », in Mysterium Salutis, VI, Brescia 1971, 254 ss.;
W. POKES, Christus traditus. Eine Untersuchung zum Begriff der Dahingabe im NT, Zürich 1967; H. BECK, «parad…
dwmi», in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Bologna 1976, 790-791.
8
Per H.U. VON BALTHASAR, «Mysterium paschale», in J. Feiner – M. Löhrer (ed.), Mysterium salutis, vol. VI, Brescia
1971, 261 questa “teologica” catena di consegne mostra efficacemente come tutti — cristiani, giudei e pagani — hanno
a che fare con la morte del Figlio di Dio: essa è il modo in cui «vengono in un primo tempo inseriti, nella colpa per la
morte di Gesù, tutti i rappresentanti dell’umanità teologicamente considerata, nel senso di Rm 11,32: “Dio ha racchiuso
tutti nella disubbidienza per usare a tutti misericordia».
9
Vedi anche i seguenti brani: «ha dato se stesso per i nostri peccati» (Gal 1,4); «ha dato se stesso in riscatto per tutti» (1
Tm 2,6); «ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità» (Tt 2,14); «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se
stesso per lei» (Ef 5,25).
10
L’obbedienza fino alla morte trasforma la croce di Gesù da un’esperienza di separazione ad una di comunione: F.X.
DURRWELL, «La mort du Christ, rupture ou communion?», in Studia Moralia 27 (1989), 781-790. Ivi, 782: «Gesù non
7
Per la lettera agli Ebrei, Cristo «con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio» (Eb
9,14): il duplice abbandono avviene nello Spirito; è in lui che si unifica la separazione ed è in lui
che termina il movimento di consegna: «E, chinato il capo consegnò lo spirito» (Gv 19,30); «Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). Nel momento in cui il Padre si rende assente ed
abbandona, lo Spirito è lì, è il compagno della passione di Gesù, è l’unità nella separazione
partecipando della consegna del Padre e dell’autoconsegna del Figlio per divenire egli stesso il
consegnato al Padre e agli uomini 11.
La separazione iniziata con la preghiera inesaudita del Getsemani, pur in questa misteriosa unità
nello Spirito, raggiunge il suo culmine nel grido della croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?» (Mc 15,34). Queste parole che ci riportano l’ultima esperienza che del Padre fece
Gesù prima della morte, non ci sarebbero tramandate dai vangeli se Gesù non le avesse davvero
pronunciate sulla croce. In esse risuona con forza il dolore di colui che chiamava Dio Abba e che
adesso si sente abbandonato da lui. Altri manoscritti di Marco esprimono questo grido in modo
ancora più crudo: «Perché mi hai esposto al ludibrio?» e «Perché mi hai maledetto?»; la lettera agli
Ebrei dice addirittura che egli «ha sperimentato la morte a vantaggio di tutti khoris theou», “lontano
da Dio”, “senza Dio” (Eb 2,9)12. E non ci sembra affatto casuale che, mentre le preghiera al
Getsemani era ancora rivolta al Padre qui, per la prima volta, Gesù si rivolga a Dio non
chiamandolo ‘Padre mio’ ma, quasi da lontano, ‘Dio mio’. Ciò che nel Getsemani lo faceva sudare
sangue avviene sulla croce: il Padre lo ha abbandonato. Gesù ha conosciuto questo momento di
vertigine e di oscurità in cui tutte le cose perdono senso, ivi compresa la sua missione. Il Salvatore
del mondo ha gridato per essere salvato. Ha conosciuto il fallimento. Anche la sua relazione con il
Padre finisce travolta da questa notte. Il grido di abbandono è lo scandalo della croce vissuto dallo
stesso Gesù, un grido del quale solo vagamente riusciamo ad intuire la sua importanza e la sua
indispensabilità per la nostra vita. In fondo questo è il grido nel quale si riconosce tanta parte
dell’umanità disperata che in mezzo ai tormenti si domanda “Dov’è Dio?”. Questo grido è il
paradosso che come cristiani dobbiamo sostenere senza cadere nella tentazione di addolcirlo, di
rendercelo più ‘digeribile’, ma cercando in esso delle vie di interpretazione e di rivelazione circa il
rapporto tra il Padre e il Figlio che si consuma sulla croce. Cercheremo di tracciare brevemente
come tre sentieri che la teologia contemporanea apre in questo bosco oscuro, tre sentieri che ci
sembra offrano la visione di tre aspetti complementari.
1. Il sentiero del peccato13
muore separato, ma in una comunione assoluta, quella della sua totale obbedienza»; 787: «nella morte, la distanza
esistenziale tra Gesù e suo Padre diviene incommensurabile, ma la comunione diviene assoluta nell’“obbedienza fino
alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8)». Per H.U. VON BALTHASAR, «Mysterium paschale», 238, questa obbedienza che
supera lo iato non è una semplice virtù morale di Gesù, ma un tratto essenziale del Figlio: rappresenta «la traduzione
kenotica del suo amore eterno di Figlio davanti al Padre sempre più grande».
11
Sul ruolo dello Spirito Santo nella morte di Gesù, con particolare riferimento a Eb 9,14, vedi: V. BATTAGLIA, Gesù e lo
Spirito nell’evento della croce secondo Eb 9, 14 e Gv 19, 30.34, in La Sapienza della croce I (1986), 2, 33-46; M.
BORDONI, Cristologia e pneumatologia. L’evento pasquale come atto del Cristo e dello Spirito, in Lat 47(1981), 432492; R. FABRIS, La morte di Gesù nella lettera agli Ebrei, in Associazione Biblica Italiana, Gesù e la sua morte. Atti
della XXVII settimana biblica, Brescia 1984, 177-189; A. VANHOYE, L’azione dello Spirito Santo nella passione di
Cristo secondo l’epistola agli Ebrei, in Credo in Spiritum Sanctum, Atti del Congresso Teologico di Pneumatologia, I,
Città del Vaticano 1983, 759-773; ID., Esprit éternel et feu du sacrifice en He 9, 14, in Biblica 64 (1983), 263-274; J.J.
MC GRATH, “Through the Eternal Spirit”. An Historical Study of the Exegesis of Hebrews 9:13-14, Roma 1961.
12
La bibbia della CEI preferisce leggere: chariti theou: «perché per la grazia di Dio sperimentasse la morte a vantaggio
di tutti», e nella nuova versione del 1997: «perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti». È J.
MOLTMANN, Trinità e regno di Dio, 89 che preferisce la variante khoris theou. A sostegno di questa tesi porta
un’affermazione di O. MICHEL, Der Brief and die Hebräer, Göttingen 196011, 74: « khoris theou è più attendibile per la
critica testuale. Dio conduce Cristo alla passione (2,10), ma al tempo stesso intensifica la sofferenza mediante la
tentazione dell’abbandono di Dio (Mc 15,34)». R. GISANA, «La lettera agli ebrei», in La Bibbia Piemme, Casale
Monferrato 1995, 2960, ammette che l’espressione «per la grazia di Dio» pone qualche problema di critica testuale, ma
per lui è attestata dai migliori manoscritti.
13
Per questa parte vedi in modo particolare H.U. VON BALTHASAR, Gloria. Un’estetica teologica, VII, Milano 1991, 185213; ID., «Mysterium paschale», 171-412; ID., «Cristologia e obbedienza ecclesiale», in ID., Lo Spirito e l’istituzione,
Due testi tratti dalle lettere di Paolo stanno all’inizio di questo sentiero: «Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore» (2 Cor 5,21); «Cristo ci ha riscattati
dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: Maledetto
chi pende dal legno» (Gal 3,13). Gesù si è caricato di tutto il nostro peccato ed è questo peccato che
l’ha portato sulla croce: sulla croce viene sofferto dal Figlio di Dio tutto l’abisso del no umano
contro l’amore di Dio al nostro posto: «Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della
croce» (1 Pt 2,24). Gesù, che non aveva commesso peccato, prende su di sé tutto il peccato del
mondo, diventa fino in fondo solidale con noi ed è trattato dal Padre come peccato. Nell’abbandono
della croce mostra tutta la serietà dell’essere al nostro posto, del caricarsi del nostro peccato per
ridonarci un posto da figli accanto al Padre: «mettendosi al posto dei peccatori, Cristo è il luogo
dell’essere figli dei peccatori»14. Dio, ci dice Paolo nella lettera ai Colossesi, ci ha dato vita
«annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha
tolto di mezzo inchiodandolo alla croce» (Col 2,14). Perché il peccato del mondo sia vinto, perché
l’umanità possa riacquistare la comunione perduta con Dio, era necessario il dono supremo d’amore
del Figlio stesso di Dio. Su questa linea interpretativa della croce nella storia della teologia si è
spesso caduti in alcuni eccessi. Si è visto Dio come un essere assetato di giustizia, di una giustizia,
lesa dal peccato dell’uomo, che non poteva essere ristabilita che con la morte del suo Figlio. Gesù
subirebbe così sulla croce la vendetta del Padre sul peccato che egli rappresenta ai suoi occhi, egli
sarebbe castigato dal Padre stesso, di cui i carnefici divenivano in qualche modo gli alleati. Ecco
come si esprimeva un famoso predicatore del XVII secolo, Bossuet, in un discorso tenuto il venerdì
santo del 1662 alla corte del re di Francia:
L’anima santa del mio Salvatore è presa dall’orrore che incute un Dio minaccioso e mentre si sente attratta a
buttarsi nelle braccia di questo Dio per cercarvi conforto e sollievo, vede che egli torce la faccia, lo respinge,
l’abbandona, lasciandolo tutto e completamente in preda al furore della sua giustizia irritata. Ti getti, o Gesù, tra
le braccia del Padre e ti senti respinto, senti che è proprio lui che ti perseguita, che ti colpisce, lui che ti
abbandona, proprio lui che ti schiaccia sotto il peso enorme e insopportabile della sua vendetta... La collera di un
Dio irritato: Gesù prega e il Padre adirato non l’ascolta; è la giustizia di un Dio vendicatore degli oltraggi
ricevuti; Gesù soffre e il Padre non si placa! 15.
È un Padre e un Dio tremendo quello che ci viene rappresentato in questa predica, un Dio del
quale avere molta paura. Ma al di là degli eccessi, questo sentiero del peccato può esserci d’aiuto
nella nostra riflessione sulla passione, poiché fa emergere con chiarezza lo strettissimo legame tra
peccato e croce e cosa opera il peccato nel nostro rapporto con Dio. La distanza drammatica tra il
Padre e il Figlio sulla croce, la loro separazione, l’abbandono subito non sono altro che il risultato e
il senso del peccato che è in se separazione da Dio: Gesù sperimenta per noi la realtà dell’inferno.
L’opposizione tra Padre e Figlio che il grido di Gesù rivela è causata dall’inserimento nella loro
relazione del nostro peccato: Dio assume in se stesso il dramma del peccato dell’uomo fino a
renderlo il proprio dramma e fino a provare in se stesso la tragica esperienza della separazione e
della morte16. La realtà del peccato irrompe nel rapporto eterno tra il Padre e il Figlio non come
qualcosa di esterno, ma come una realtà assunta dal Figlio nella sua vita, realtà che lo porta a
sperimentare in se stesso l’odio del Padre verso il peccato 17, e che trasforma l’ineliminabile
Brescia 1979, 115-138; ID., «Solitudine nella Chiesa», in ID., Lo Spirito e l’istituzione, 217-247; N. HOFFMANN, Kreuz
und Trinität. Zur Theologie der Sühne, Einsiedeln 1982.
14
N. HOFFMANN, Kreuz und Trinität, 77.
15
J.B. BOSSUET, Oeuvres complètes, IV, Paris 1836, 365.
16
H.U. VON BALTHASAR, «Mysterium Paschale», 263 afferma chiaramente che «la croce è soprattutto esecuzione del
giudizio divino sul “peccato” (2 Cor 5,21)» e che in essa «è stato sofferto tutto l’abisso del no umano contro l’amore di
Dio. Con altre parole: Dio è solidale con noi non soltanto in ciò che è sintomo e pena del peccato, ma anche nel cosperimentare, nel peirasmós della natura stessa del no, senza che tuttavia abbia peccato (Eb 4,15)» ( ivi, 285).
17
L’espressione è certamente forte, ma ecco cosa afferma E. RIGGENBACH, Das Geheimnis des Kreuzes Christi, Stüttgart
– Basel 19273, 16: «Dio non può amare il male, ma semplicemente odiarlo. In forza della sua stessa natura il male sta in
contraddizione assoluta con la natura divina, esso è il contrario dell’amore santo di Dio. Non si dà amore autentico
senza collera; la collera infatti è l’altra faccia dell’amore. Dio non potrebbe amare realmente il bene se non odiasse e
respingesse il male» (citato in H.U. VON BALTHASAR, «Mysterium Paschale», 287).
relazione tra Padre e Figlio nella modalità del ripudio, dell’interruzione dei rapporti,
dell’inaccessibilità di Dio. La comunione divina diventa così separazione che manifesta l’estrema
serietà del peccato. La croce del Figlio ha portato il male e il peccato in Dio stesso, sconvolgendo la
sua stessa vita. L’abbandono del Figlio sulla croce è l’immagine dello stato di lontananza da Dio in
cui ci getta il nostro peccato ma, come afferma la Commissione Teologia Internazionale:
«Qualunque sia l’allontanamento dell’uomo peccatore nei riguardi di Dio, esso è sempre meno
profondo del distanziarsi del Figlio rispetto al Padre nel suo svuotamento chenotico (Fil 2,7) e della
miseria dell’abbandono (Mt 27,46)»18. Gesù prende su di sé il carico del dolore e del peccato
passato, presente e futuro del mondo, entra fino in fondo nell’esilio da Dio per assumere questo
esilio dei peccatori nell’offerta e nella riconciliazione pasquale. L’abissale e inaudita distanza che si
frappone sulla croce tra il Padre e il Figlio diventa così per noi lo spazio del nostro ritorno al Padre,
manifestazione suprema del suo amore misericordioso: «lo trattò da peccato in nostro favore» (2
Cor 5,21).
2. Il sentiero della compassione19
Dio Padre dunque è solo colui che fa soffrire il Figlio o che resta impassibile di fronte al dolore
del Figlio? È questo il Dio cristiano, il vero volto del Padre che Gesù ci ha rivelato durante la sua
vita? Il Padre che abbandona il Figlio non lo abbandona nell’indifferenza e non sta certamente dalla
parte dei carnefici: nella consegna del Figlio pure il Padre si dà, anche se non allo stesso modo:
abbandonando il Figlio il Padre abbandona anche se stesso. L’altra faccia dell’abbandono è un
amore misericordioso20. Il Figlio soffre la morte nell’abbandono e il Padre soffre la morte del Figlio,
la soffre nel dolore infinito del suo amore per lui. Alla morte del Figlio risponde il dolore del Padre.
La mancanza del Padre che il Figlio prova, risponde alla mancanza del Figlio che il Padre sente. Il
Dio di Gesù non è il Dio filosofico che non può soffrire, che è impassibile, è un Dio che si lascia
totalmente coinvolgere nella storia e nel dolore perché è un Dio che ama di un amore
misericordioso, cioè capace di soffrire21. E la croce in tutta la sua drammaticità è la manifestazione
più alta di questa capacità amante per cui, proprio il momento in cui Gesù sente il Padre più lontano
e grida: «Perché mi hai abbandonato?» è, in realtà, il momento in cui il Padre gli è più vicino e lo
stringe a sé in una stretta d’amore, perché è il momento in cui la volontà umana del Figlio è più
unita alla volontà divina. «Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita» (Gv 10, 17): il
momento dell’amore è il momento del massimo amore del Padre. Lo ha capito benissimo la
tradizione iconografica occidentale che quando deve raffigurare la Trinità si rifà al Golgota e mostra
il Padre intento a reggere la croce dove è appeso suo Figlio. Il Padre è presente, amante e sofferente
nella croce di Gesù e nelle croci dei suoi figli disseminate per tutta la storia e si rivela come il Dio
solidale. Se dall’inizio del vangelo Dio appare in Gesù come un Dio con noi, se lungo il vangelo
CTI, Alcune questioni riguardanti la cristologia, in CivCat 131 (1980), IV, 276.
Vedi soprattutto gli scritti di J. MOLTMANN, Il Dio crocifisso, Brescia 1973, ID., Trinità e regno di Dio, 30-71; 86-95;
ID., La via di Gesù Cristo, Brescia 1991, 177-243.
20
Lo afferma J. Moltmann ivi, 207: «Mal comprenderemmo, anzi stravolgeremmo nel suo contrario, la teologia della
dedizione quando non la intendessimo come teologia del dolore di Dio e quindi della compassione divina. Naturalmente
il termine paolino e giovanneo di ‘abbandonare’ esprime soltanto un lato del processo, l’altro lo troviamo racchiuso nei
termini di ‘amore’ e ‘misericordia’».
21
Si aprirebbe qui tutto un campo di riflessione sulla mutabilità e passibilità di Dio. Vedi per un approfondimento: A.N.
WHITEHEAD, Process and Reality, Cambridge 1929; C. HARTSHORNE, The Divine Relatività, New Haven 1948; H. MÜHLEN,
La mutabilità di Dio come orizzonte di una cristologia futura, Brescia 1974; K. KITAMORI, Teologia del dolore di Dio,
Brescia 1975; E. JÜNGEL, Dio, mistero del mondo, Brescia 1982; J. MOLTMANN, Trinità e regno di Dio, 30-71. La passione
di Cristo è anche la «passione del Dio sofferente» (ivi, 32). Come Moltmann ricorda in queste pagine, Origene è stato
l’unico tra i padri greci e latini che abbia osato parlare della sofferenza di Dio: «Ma il Padre stesso, Dio dell’universo,
lui che è pieno di longanimità, di misericordia e di pietà, non soffre forse in qualche modo? O forse tu ignori che,
quando si occupa delle cose umane, egli soffre una passione umana? […] Il Padre stesso non è impassibile! Se lo si
invoca, egli ha pietà e compassione. Egli soffre una passione d’amore» (Ez., h. 6,6); «nel suo amore per l’uomo,
l’Impassibile ha sofferto una passione di misericordia» (Mt., 10,23). Su questi testi e sull’immagine di Dio in Origene
vedi H. DE LUBAC, Storia e spirito, Milano 1985, 249-268.
18
19
egli si manifesta man mano come un Dio per noi, nella croce egli appare come un Dio in nostro
potere e soprattutto un Dio come noi. E proprio per questo può essere la nostra salvezza e la nostra
gioia. Davanti alla sofferenza il Padre non fa nulla di quello che come uomini ci attenderemmo che
facesse. Egli non la toglie, non né dà una spiegazione, non né rivela il senso; l’unica cosa che la
croce ci dice è che Dio stesso prende su di se la sofferenza. Il Padre prende su di se la storia di
sofferenza del mondo e prendendola su di se dice da che parte sta, con chi è solidale. Il silenzio del
Padre nella momento della croce, come silenzio di dolore del Padre stesso, si può interpretare
paradossalmente come solidarietà con Gesù e con i crocifissi della storia: il Padre soffre con loro,
com-patisce. Possiamo anche esprimerlo con le parole di un poeta: «la lancia al braccio di Longino
è andata più lontano del cuore del Cristo. Essa ha aperto Dio, ha attraversato persino il cuore stesso
della Trinità»22.
3. Il sentiero della figliolanza23
Per percorrere l’ultimo sentiero partiamo da un dato che abbiamo già illustrato in precedenza: la
storia della passione è una storia di consegne. Ma se Dio consegnasse alla morte il proprio Figlio
diletto nel modo in cui lo fanno i nemici, se il suo consegnare fosse della stessa natura di quello di
Giuda, questo atto sarebbe la negazione radicale del suo amore paterno, sarebbe un rinnegare la sua
paternità e quindi se stesso, poiché se il Padre abbandona il Figlio, non è solo il Figlio che perde la
filiazione, è anche il Padre che perde la propria paternità. Il Padre però consegna il Figlio in un altro
modo, nel modo che gli è proprio e che connota tutto il suo agire e tutto il suo essere: «non si è
padre consegnando alla morte, ma generando. Nel suo amore per gli uomini, Dio consegna il
proprio Figlio generandolo in questo mondo»24. Questa generazione ha il suo momento
manifestativo di gloria nella risurrezione che è l’azione propria di Dio: gli avversari lo crocifiggono
e lui lo risuscita e lo costituisce Signore e Cristo (cfr. At 2, 36); non è il Padre che condanna il
Figlio a morte, egli è invece colui che lo salva dalla morte. Paolo, predicando nella sinagoga di
Antiochia di Pisidia dice: «[Dio ha risuscitato] Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: Mio
figlio sei tu, io oggi ti ho generato» (At 13, 33). Il mistero pasquale è dunque un mistero di
generazione e di esso fanno parte tanto la risurrezione come la morte; per mezzo di essa si realizza
in pienezza la nascita del Figlio in questo mondo. Ma come si può comprendere che, per Gesù, la
morte è pienezza di nascita e, da parte del Padre, generazione eterna? Gesù ha sempre vissuto del
Padre e per il Padre, tutta la sua vita terrena lo mostra, ma solo nella morte, nel dono totale di sé,
poteva vivere pienamente il suo essere Figlio, poiché è solo lì che come uomo poteva compiere il
gesto dell’amore più grande, quello di dare la vita (cfr. Gv 15, 13), ed essere «obbediente fino alla
morte» (Fil 2, 8) facendo fino in fondo della volontà salvifica del Padre la sua volontà. Solo nella
morte Gesù è pienamente Figlio. Ma il Padre è veramente Padre? Ancora una volta, se
l’invocazione paterna che Luca pone sulle labbra di Gesù sulla croce — «Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito» (Lc 23, 46) — dimostra sufficientemente come il suo sentimento di
figliolanza fosse l’unica cosa che sentiva ancora fortemente sua nel momento in cui tutto gli era
tolto, il grido di desolazione riportato invece da Marco e da Matteo non è invece una smentita della
generazione? Dio non può essere il Padre che a volte ama e a volte detesta il Figlio, colui che un
momento condanna e consegna il Figlio alla morte e un attimo dopo lo fa nascere nella risurrezione.
Sarebbe un Padre dal comportamento schizofrenico, un Padre che gioca con la vita del Figlio e non
possiamo attribuire questo a Dio. Dobbiamo allora cercare il senso del grido sulla croce all’interno
della relazione di paternità e di filiazione, dentro lo stesso mistero di generazione come l’estremo
avvicinarsi alla nascita in pienezza.
Ogni nascita in fondo è per il bambino esperienza traumatica di essere gettato fuori dalla sicura
intimità del ventre materno. Il bambino piange per questo, ma è proprio attraverso questo
P. CLAUDEL, L’épée et le miroir, 256 (citato in H. DE LUBAC, Storia e spirito, 266).
Vedi G. LAFONT, Dio, il tempo e l’essere, Casale Monferrato 1992, 63-80; 131-161; F.X. DURRWELL, Il Padre. Dio nel
suo mistero, Roma 1995, 56-70.
24
Ivi, 56.
22
23
allontanamento dalla madre, questo doloroso uscir fuori, che egli nasce a se stesso e diventa persona
autonoma pronta a vivere nello stesso tempo nell’alterità e nella comunione. Per Durrwell, si
potrebbe esprimere il senso della preghiera di Gesù sulla croce con il grido che il bambino emette al
momento di nascere: «Mamma! Perché mi respingi?» 25. È un momento doloroso ma necessario sia
per la vita del bambino che per la vita della madre. Il bambino non viene respinto: nasce a se stesso
e si trova accolto immediatamente nelle braccia della madre. Ogni parto poi, e ogni mamma può
testimoniarcelo, è dolore anche per chi genera e questa constatazione ci riporta sul secondo sentiero,
quello della com-passione tra il Figlio e il Padre-Madre. In Gv Gesù ci dice: «Sono uscito dal Padre
e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre» (Gv 16,28): la morte è il
momento limite tra questa uscita (nascita nel mondo) che giunge alla sua pienezza e l’ora del ritorno
al Padre, qui Gesù vive in totalità al tempo stesso la comunione e l’alterità filiale 26. Poiché il Padre
consegna il Figlio in modo diverso da come lo fanno gli uomini, la morte è diventata il contrario di
quella che essi volevano infliggergli, lungi dall’essere una fine di vita, è una nascita: la nascita del
Figlio generato eternamente nell’umanità. Gesù muore generato. Morte e glorificazione
costituiscono un unico eterno mistero, quello della filiazione divina interamente realizzata in un
uomo. Tutto questo viene a gettare una luce anche sulla nostra morte: essa è una nascita, il nostro
diventare pienamente figli, il termine della generazione iniziata nel battesimo e cresciuta attraverso
l’incontro eucaristico con Gesù nella sua morte. Per questo il giorno della morte dei martiri prima e
poi di tutti i santi è chiamato dies natalis, per questo s. Ignazio d’Antiochia, in una lettera alla
comunità di Roma verso la quale era condotto in catene per subire il martirio poteva scrivere: «Si
avvicina il mio parto...» (Rm 6, 1). E che nella morte di Gesù si riveli appieno il suo essere Figlio ce
lo indica chiaramente il centurione dei vangeli: «Il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare
in quel modo [cioè gridando: «Dio mio, Dio mio...»], esclamò: Davvero quest’uomo era Figlio di
Dio» (Mc 15, 39). Agli occhi del centurione, occhi che nulla predisponevano a credere, occhi che
erano incaricati di vigilare sulla buona riuscita dell’esecuzione, la morte atroce di Gesù e il suo
grido di abbandonato diventano la rivelazione piena della sua figliolanza. Ha inteso il grido di Gesù,
ha percepito il silenzio di Dio eppure ha visto in quel modo di morire un atteggiamento filiale. Sono
gli occhi che dobbiamo chiedere anche noi insistentemente nella preghiera per entrare nel mistero
della croce e della morte di Gesù e di ogni uomo. Già diverse volte abbiamo citato Rm 8, 32: «Dio
non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato [lo ha consegnato, ora potremmo tradurre: lo ha
generato] per tutti noi»; s. Paolo poi continua affermando: «come non ci donerà ogni cosa insieme
con lui?» e nel versetto precedente aveva detto: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?». Il
percorrere i tre sentieri che abbiamo illustrato, il celebrare i misteri della nostra salvezza, non hanno
altro scopo che quello di ricordarci il grande amore con il quale il Padre e il Figlio ci hanno amati e
ci amano, di ricordarci che Dio è radicalmente, fino alla morte, dalla nostra parte, che la causa di
Dio è la causa dell’uomo per il quale il Figlio è pronto a dare la vita perché noi abbiamo vita in
abbondanza. Sotto la croce possiamo davvero dire con Paolo: «Chi ci separerà dunque dall’amore di
Cristo? [...] Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8, 35.38-39).
A conclusione di questa nostra riflessione sulla croce, ascoltiamo una pagina tratta da un
romanzo di uno scrittore ebreo, E. Wiesel, che ci aiuta a spostare il tema trattato dall’anno 33 circa
al nostro secolo e ci mostra ancora una volta come agisce questo amore di Dio che mai ci
abbandona:
Le S.S. sembravano più preoccupate, più inquiete del solito. Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di spettatori
non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era
livido, quasi calmo, e si mordeva le labbra. L'ombra della forca lo copriva. Il Lagerkapo si rifiutò questa volta di
Ivi, 66.
È interessante notare come la professione di fede dell’undicesimo sinodo di Toledo del 675 parli dell’incarnazione del
Verbo usando un’esplicita metafora della maternità umana: «Il Figlio infatti, dobbiamo credere, non fu generato né dal
nulla né da un’altra qualsiasi sostanza, ma dal grembo del Padre [sed de Patris utero]» (DH 526). Per l’edizione critica
del testo di questa professione di fede vedi J. MADOZ, Le symbole du XIe concile de Tolde, Louvain 1938.
25
26
servire da boia. Tre S.S. lo sostituirono. I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero
introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi.
— Viva la libertà! — gridarono i due adulti.
Il piccolo, lui, taceva.
— Dov'è il Buon Dio? Dov'è? — domandò qualcuno dietro di me.
A un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava.
— Scopritevi! — urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a noi, noi piangevamo.
— Copritevi!
Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra. Ma la terza corda
non era immobile: anche se lievemente il bambino viveva ancora... Più di una mezz'ora restò così, a lottare fra la
vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo
quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti.
Dietro di me udii il solito uomo domandare:
— Dov'è dunque Dio?
E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:
— Dov'è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca... 27.
27
E. WIESEL, La notte, Firenze 1980, 66-67.
Appendice
Gesù e il Padre nell’ora della croce
nei racconti della passione dei vangeli
Matteo
26, 2: Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere
crocifisso.
26, 29: Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo con voi nel regno del Padre mio.
26, 39: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi
tu!
26, 42: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua
volontà.
26, 53-54: Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici
legioni di angeli? Ma allora come si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve
avvenire?
26, 64: D’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del
cielo.
27, 40: Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!
27, 43: Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!
27, 46: Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”
27,54: Davvero costui era Figlio di Dio!
Marco
14,36: Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio,
ma ciò che vuoi tu.
14,41: Ecco, il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori.
14,61: Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: Io lo sono! E vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo.
15,34: Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lema sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?
15,39: Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!
Luca
22,28: Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno,
come il Padre l’ha preparato per me.
22,42: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
22,69-70: Da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti esclamarono: Tu dunque sei il Figlio di Dio? Ed egli disse loro: Lo dite voi
stessi: io lo sono.
23,34: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.
23,46: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
23,47: Veramente quest’uomo era giusto.
Giovanni
13,1: Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
13,3: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava...
13,31: Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
14,2: Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un
posto.
14,6-11: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il
Padre; fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre
e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che
io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre
che è in me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non
altro credetelo per le opere stesse.
14,12-13: Io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia
glorificato nel Figlio.
14,16: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore.
14,20: In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre.
14,21: Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui.
14,23: Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui.
14,24: La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
14,26: Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome.
14,28: Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me.
14,30-31: Viene il principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo
sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato.
15,1: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo.
15,8-9: In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi.
15,15: Vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi.
15,16: Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda.
15,23-24: Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che
nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno
odiato me e il Padre mio.
15,26: Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal
Padre, egli mi renderà testimonianza.
16,3: Faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me.
16,5: Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai?
16,10: Quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più.
16,15: Tutto quanto il Padre possiede è mio.
16,23: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
16,25-28: Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l’ora in cui non vi parlerò più in
similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e
io non vi dico che pregherò i Padre per voi: il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete
amato, e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel
mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre.
16,31: Io non sono solo, perché il Padre è con me.
17,1: Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te.
17,4: Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre,
glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il modo fosse.
17,10: Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie.
17,21-23: Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché
siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.
17,24: Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato, siano con me dove sono io, perché
contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato.
17,25: Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi
hai mandato.
18,11: Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?