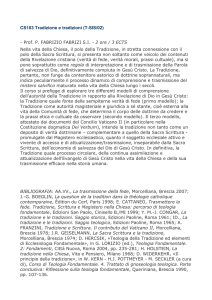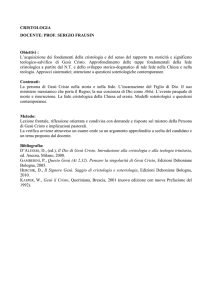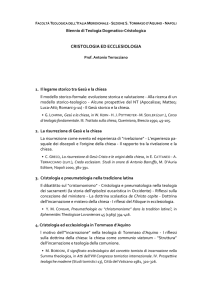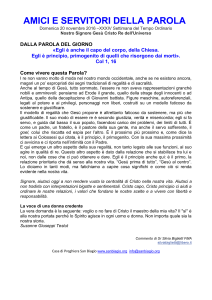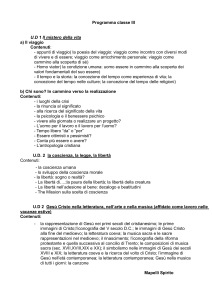FRANCESCO ALFIERI
Pessoa humana e singularidade em Edith Stein.
Uma nova fundação da antropologia filosófica
Perspectiva, São Paulo 2014,
pp. 180
l libro affronta uno dei temi centrali
della ricerca promossa da F. Alfieri
ossia l’intricata questione sulla singolarità/individualità della persona,
tema filosofico-teologico che Edith
Stein ha affrontato a più riprese nello
svolgimento della sua ricerca e della
sua attività didattica. La stessa vicenda filosofica e biografica della fenomenologa ha interessato – scrive S.
Filho nella Prefazione – «molti lettori
brasiliani, che, tuttavia, non hanno
molta familiarità con la fenomenologia e il suo vocabolario “così tecnico”»
(XIV). Il libro è frutto di una serie
di lezioni che Alfieri ha tenuto all’università del Salvador, introducendo
anche molti ascoltatori nell’intricato
mondo della fenomenologia husserliana. L’avvio è dato dall’approfondire
il concetto chiave di persona umana
nel pensiero della Stein e introdurre al metodo fenomenologico che
«consiste justamente em não conceber
o ser humano como un ser dotado de
consciência e situado em contraposição
com o mundo» (XVIII), evidenziando
anche l’importanza del pensiero della
fenomenologa nel contesto attuale del
panorama filosofico. Il primo intento del libro è, giustamente, collocare
questo pensiero steiniano nel contesto
della scuola di E. Husserl, passando in
rassegna gli sviluppi centrali nei suoi
Rassegna di Teologia 57 (2016) 329-352
ramificati e articolati risvolti. Le lezioni si basano sull’idea di fondo che la
fenomenologia applicata allo studio
della filosofia medievale permette alla
Stein di fondare una nuova antropologia filosofica avente come base/supporto una concezione di individualità
[principium individuationis]. Il leit
motiv, per ritrovare una sorta di filo
di Arianna nelle intricate riflessioni
della Stein, rintracciato da Alfieri, è
la magna quaestio dell’individuazione,
omologabile, a suo avviso, alla meticolosa analisi dell’Aufbau der Person,
indiscutibile fulcro d’interesse su cui
s’intessono i motivi di fondo della
filosofia fenomenologica. Nel testo
vengono presentati da Alfieri i risultati sulle influenze scotiste. Il Doctor
Subtilis non accoglie l’ipotesi che vede
la corporeità come principio di individuazione, a differenza di Tommaso,
e sostiene essere l’anima il principio
individuante, che Tommaso pone
nella materia signata quantitate ossia
«matéria assinalada por uma signata quantitate» (154). Edith Stein si
orienta, pertanto, all’haecceitas scotista, in portoghese tradotto con istidade (153), pur non conoscendo la
pseudo-autenticità della formula, ne
riesce a cogliere il senso profondo.
Nell’utilizzo delle fonti Edith
Stein si affida alle traduzioni vigenti,
Recensioni
I
329
ignara, suo malgrado, dell’imponente
stratificazione terminologica di quegli
scritti, pertanto Alfieri nel suo studio
capillare stabilisce che, per esempio,
l’autore indiscusso delle Quaestiones
disputatae de rerum principio non è
Scoto, bensì il francescano Vitalis de
Furno divenuto l’inconsapevole fonte
delle dottrine scotiste, in questo caso
pseudo-scotiste, non solo della Stein,
ma anche di altri fenomenologi che si
erano avvalsi di questi scritti. Analoga
situazione si è verificata per lo scritto per l’abilitazione di M. Heidegger
(Die Kategorien- und Bedeutungslehre
des Duns Scoto). Il principio d’individuazione per gli esseri viventi non
è dato dalla materia, ma da una pienezza qualitativa che è ultima solitudo [insuprimível solitude/solidão],
trovando la sua ulteriore specificazione nel Kern personale. A partire dai
Beiträge apparsi sullo Jahrbuch diretto
da Husserl, la Stein presenta un dichiarato interesse verso la questione
dell’individualità che viene elaborato sulla base del Kern personale; ella
è convinta che questo Kern non sia
determinato da elementi quantitativi
o qualitativi inerenti la singolarità.
L’individuazione si situa oltre ogni
possibile determinazione psichica
o materiale, i cui tratti inalienabili
quali la consistenza e l’immutabilità
determinano un chiaro andamento
nella persona, non è, quindi, lo sviluppo della persona a forgiare il Kern,
bensì è questo che orienta qualsiasi
evoluzione psichica e/o materiale di
questo andamento. La materia signata
quantitate non può essere il fondamento dell’individualità, in quanto
la genericità della relazione tra ma330
teria e forma non ci dice nulla sulla
singularitatae della persona umana,
pertanto non è una semplice Leerform
[forma vazia, in portoghese], ma una
qualità dell’ente che si evidenzia nella
concrezione dell’indipendenza. Il principium individuationis non può essere
dedotto da una considerazione che
vagli solo la specificazione di generi
e specie, variamente intrecciati, ma
la sua “pienezza qualitativa”, nei suoi
svariati strati ontologici come quello
dell’ultima solitudo. Il ritorno a Tommaso d’Aquino e agli autori medievali, per Stein, non era stato dettato solo
dalla filosofia “ufficiale” della Chiesa,
ma dalla decisa volontà di recuperare un mondo che aveva affrontato gli
stessi problemi della fenomenologia,
ma con un diverso linguaggio filosofico, con delle soluzioni, come nel caso
di Scoto, veramente interessanti. Tuttavia, nel ricercare il nucleo personale
ella ritorna ai suoi esordi filosofici in
cui tentando di colmare, a suo avviso, una lacuna dell’analisi husserliana
s’imbatte nella tensione tra originario
e non originario dell’atto entropatico, che da inizio a quelle analisi che
la condurranno a interrogare l’essere
umano come via privilegiata alla conoscenza dell’alterità, non solo della
persona, ma anche della trascendenza
divina. Alfieri, in questa sua ultima fatica, analizza quelle citazioni scotiste,
vagliandole anche nelle loro intricate
questioni filologiche e storiografiche,
e che diedero un impulso decisivo alla
ricerca della Stein, creando una sorta
di fondazione all’ambizioso progetto,
mai concluso, di esplorare la singolarità e originalità dell’essere umano.
Duns Scoto sotto molti aspetti supe-
ra la posizione di Tommaso laddove
coglie la stessa incarnazione di Dio
come una prevedibile modalità di attuazione del suo amore divino; non
sembri fuori luogo che lo stesso K.
Rahner, anche se da presupposti filosofico-teologici del tutto opposti, abbia affrontato e condotto una operazione di risposta a una sfida immane
e di faraoniche proporzioni. Il libro si
conclude, anche, con un interessante
glossario che traduce in lingua portoghese importanti concetti della fenomenologia e della filosofia medievale,
dando un ulteriore opportunità a chi
si avvicina al testo di avere la possibilità esemplificata di importanti supporti linguistici per avventurarsi nell’intricato mondo della fenomenologia e
della filosofia medievale rivisitata, con
estrema originalità, da Edith Stein.
Nicola Salato
GERHARD LOHFINK
L’
A., noto studioso del Nuovo Testamento, affronta con coraggio
e lucidità l’argomento dell’identità
di Gesù di Nazaret. Con linguaggio
chiaro e discorsivo si propone di «accostarsi in modo critico, con discernimento e con fiducia al Gesù reale» (6).
Il libro è diviso in due parti. La
prima parte comprende dodici capitoli, dedicati a «ciò che Gesù volle».
I temi affrontati sono: 1. Il cosiddetto Gesù storico; 2. La proclamazione
del regno di Dio; 3. Regno di Dio e
popolo di Dio; 4. Il raduno d’Israele; 5. La chiamata alla sequela; 6. La
multiformità della chiamata; 7. Le parabole di Gesù; 8. Gesù e il mondo
dei segni; 9. I miracoli di Gesù; 10. Il
monito del giudizio; 11. Gesù e l’Antico Testamento; 12. Gesù e la Torah.
La seconda parte dell’opera comprende
nove capitoli che indagano su «Chi fu
Gesù?». Gli argomenti trattati sono:
13. La risolutezza assoluta nella vita di
Gesù; 14. Il fascino del regno di Dio;
15. La decisione a Gerusalemme; 16.
Morire per Israele; 17. Il suo ultimo
giorno; 18. Gli eventi pasquali; 19.
L’autorità rivendicata da Gesù; 20. La
risposta della Chiesa; 21. Il regno di
Dio: un'utopia?
Di grande interesse e attualità risulta il rapporto che Gesù ha mantenuto
con l’Antico Testamento e con la Torah in specifico. L’A. stesso considera
il capitolo «Gesù e la Torah» «uno dei
più importanti del libro» (232). Con
chiare argomentazioni rigetta la “diseredazione” storico-salvifica di Israele,
sostenuta nel passato con intenzioni
sostitutive da parte della Chiesa. Soffermandosi su temi sensibili come:
duplice comandamento, amore dei
nemici, divieto di adirarsi, divorzio,
rispetto dei genitori, rispetto del sabato, puro e impuro, con dovizia di
331
Recensioni
Gesù di Nazaret.
Cosa volle – Chi fu
Queriniana, Brescia 2014,
pp. 456, € 43,00
citazioni dimostra quanto profondo e
rispettoso sia l’atteggiamento di Gesù
nei confronti delle Scritture del suo
popolo. «Gesù non abroga la Torah,
non la abolisce, non la sostituisce con
una nuova Torah, ma la interpreta
[…] Cerca dietro la lettera la volontà
originaria di Dio […] mette in luce il
centro: il comandamento dell’unicità e della sovranità di Dio. […] Pone
tutta la Torah nella luce del regno di
Dio e sottopone a tale regno tutti i
comandamenti. Unisce il comandamento principale con il comandamento dell’amore del prossimo di Lv
19. Conferisce così alla Torah il suo
centro […] Parlò sempre dell’una e
unica legge di Dio, facendola solo riecheggiare in una maniera del tutto
nuova […] il discorso della montagna non è una nuova Torah» (258).
E ancora, Gesù «non ha trasceso la
Torah, ma ne ha trovato il centro e
l’ha così portata tutta a compimento
[…] Egli ha effettivamente vissuto la
Torah con tutta la sua esistenza e l’ha
confermata in una maniera irrevocabile e irraggiungibile nella sua persona» (259).
Pertanto, Gesù viene riconosciuto
come l’interprete escatologico della
Torah, letta con stupefacente sensibilità alla luce del suo centro dinamico:
lo Shemà (cf Dt 6). Al di là dei pregiudizi o dei luoghi comuni, Lohfink sostiene che la Legge mosaica non può
332
essere considerata obsoleta o abrogata, ma tutta la Torah va interpretata
alla luce di Gesù Cristo per scoprire
quale sia la volontà di Dio.
L’A. si domanda ancora: come mai
Israele, sempre sconfitto, perseguitato
e disperso nel mondo, è sopravissuto come popolo? Solo in virtù delle
Scritture custodite gelosamente. Grazie a esse Israele si distingue per la sua
capacità di discernimento. «La chiesa ha urgentemente bisogno quanto
la sinagoga di tale continua opera di
discernimento. Essa non può cadere
in quello stato morboso dello spirito,
in cui tutto è uguale, tutto parimenti
valido, tutto indifferente. Lì dove non
si discerne più tornano i vecchi dèi»
(261). Quanto è vero!
Infine, condividendo un’affermazione del teologo F. Crüsemann, asserisce: «L’identità del Dio biblico dipende
dal legame con la sua Torah». «Perciò
la Chiesa non può e non deve mai rinunciare alla Torah. Neppure a parti di
essa. Deve naturalmente viverla e leggerla nello spirito di Gesù» (262).
La lettura di questo lavoro esegetico e teologico apre la mente a chi vuole cercare la verità, a chi è interessato
a conoscere Gesù di Nazaret. Scritto
in maniera brillante e preciso, è da
ammirare anche per l’assenza di tanti
svarioni così frequenti anche in libri
più specialistici del presente testo.
Antonio Carapellese
ARMANDO AUFIERO
I
n cinque impegnativi capitoli il
testo si concentra sull’analisi e sul
senso della sofferenza umana. Nel
primo l’A. mette in evidenza “l’esperienza della sofferenza”, come dato
ineliminabile della vicenda umana.
Poi espone il dialogo tra Nietzsche e
Scheler sul senso del soffrire, cercando di comprendere la critica dell’uno
e la risposta del secondo, nel rapporto tra esaltazione della vita e valore
dell’impegno ascetico. Quindi passa
a presentare la vita e l’opera di mons.
Luigi Novarese (1914-1984): giovane
ammalato di tubercolosi ossea, guarito miracolosamente per intercessione di don Bosco, ordinato sacerdote
e impegnato al servizio della S. Sede
in Segreteria di Stato, fondatore del
Centro Volontari della Sofferenza e
dei Silenziosi Operai della Croce. Ora
anche lui beatificato per decisione di
Benedetto XVI, l’11 maggio 2013.
Mons. Novarese insiste molto sulla dignità personale del malato, e sulla
possibilità di trasformare la sofferenza
da privazione e dramma, in opportunità e offerta redentrice in Cristo. Il
malato non deve essere considerato
una persona diminuita da commiserare, ma una persona normale che deve
essere rispettata e aiutata ad assumere
in modo responsabile la propria situazione esistenziale.
Il dolore e la sofferenza devono essere prima combattuti: bisogna lottare per la salute contro la malattia. La
cura del malato deve rivolgersi al corpo, per diminuire o eliminare il dolore fisico; e deve raggiungere l’anima,
dove ognuno è chiamato a decidere
come vivere e cosa fare nella concreta
situazione in cui si trova.
A livello spirituale, davanti alla
sofferenza che non passa, e anzi progredisce verso la morte, si coglie l’angosciosa fragilità dell’esistenza umana
nel tempo. In questa situazione limite
tutto può essere messo in discussione.
Tutto però può anche essere illuminato dalla fede, e ognuno può decidere di mettere la propria sofferenza
accanto alla sofferenza di Cristo per la
salvezza del mondo. Questo è il messaggio cristiano e questa è la redenzione della sofferenza: non più fattore di
distruzione, ma forza di redenzione.
La luce della Croce infatti dà senso al
mistero dell’uomo minacciato dalla
morte.
L’A. fa un discorso austero quando
invita a non sottovalutare il dramma
della sofferenza e a non dare risposte
affrettate e consolatorie; soprattutto
la tecnica della “rimozione” si rivela
negativa, perché prima o poi il male
attacca tutti. Da sempre il dolore,
e specialmente il dolore innocente,
333
Recensioni
La questione teologica del soffrire.
Il profilo morale e cristiano dell’esperienza
della sofferenza nell’opera di Luigi Novarese
CVS, Roma 2015,
pp. 333, € 25,00
pone in modo acuto domande sul
senso dell’esistenza e sul rapporto
dell’uomo con Dio. Perciò è necessario annunciare in modo integrale, con
semplicità e forza, il mistero di Cristo,
dove la passione e la morte sfociano
nella risurrezione. Così la pazienza
cristiana non è rassegnazione all’ineluttabile destino, ma è speranza sicura
nella vita nuova che non finisce.
La lettura di questo libro (un lavoro di dottorato discusso all’Università
Gregoriana) aiuterà a riflettere sull’intera problematica relativa al dolore,
alla ricerca di vie umane e cristiane per
affrontare la sofferenza e aiutare i sofferenti con equilibrio e partecipazione.
Domenico Marafioti SJ
MATTEO BERGAMASCHI
Performance divino-umana.
La concettualità del drammatico nella proposta
teologica di H.U. von Balthasar
Mimesis, Milano 2015,
pp. 340, € 26,00
Matteo Bergamaschi offre un testo
genuinamente teoretico, che affronta
in maniera sistematica e puntuale uno
degli snodi cruciali – e tutto sommato meno frequentati – del pensiero
del teologo svizzero. È la nozione di
dramma, inteso come incontro – e dinamica interazione – tra libertà a costituire il cuore dell’indagine di Bergamaschi, che si è qui misurato con
un compito per nulla facile o scontato. Difficoltà relativa non solo alla
necessità di orientarsi nel vasto pelago
della produzione balthasariana, quanto, più profondamente, all’urgenza di
ponderare e attentamente valutare la
specificità della sua ermeneutica teologica.
Troppo spesso si è ingenuamente
ridotta la concezione balthasariana
del pulchrum come trascendentale
dell’essere a pretesto per riflessioni di
tipo “estetico” o artistico, mentre la
nozione di un’estetica teologica va in334
tesa nel senso kantiano di studio della
percezione, percezione della forma
(Gestalt) unica e insuperabile che il
Dio invisibile assume, manifestandosi
nella storia in Cristo (tale è la fede).
Come ricostruisce l’A., simile strategia concettuale basata sul fenomeno
dell’apparire e del percepire può servirsi a questo scopo dello strumentario del bello, rientrando a pieno titolo
nell’esposizione della teologia fondamentale.
L’impalcatura teorica edificata dal
grande teologo, che ci permettiamo
di paragonare a una solida, complessa
e maestosa cattedrale gotica, si pone
come la grande sintesi cattolica del
XX secolo. Non è dunque possibile indagare con serietà alcuno dei
concetti cardine di tale sistema, senza possedere una sicura conoscenza
dell’edificio in generale. Tale la sfida,
ardua e affascinante a un tempo, affrontata dall’A.
discorso balthasariano. Temporalità
e rappresentazione, escatologia e cristologia, ecclesiologia e mariologia,
esistenza e messa in scena, performance; coscienti di non poter, in questo
breve spazio, ripercorrere nemmeno a
grandi linee questioni di tale portata,
intendiamo piuttosto evidenziare solo
alcune delle realtà che l’attenta analisi
di Bergamaschi ci accompagna a leggere e considerare. Il discorso teologico non è solo esercizio “alto” del pensiero; quando affrontato, come nel
caso qui discusso, in relazione ai tratti
dell’esperienza umana, risulta piuttosto in grado di evidenziare aspetti che
pertengono al dramma stesso dell’esistenza.
La teodrammatica balthasariana,
nell’originale lettura di Bergamaschi,
si rivela così in grado di configurare
una co-relativa “antropodrammatica”;
è quanto ci aiuta a capire l’A. in diversi momenti della sua analisi. Analizzando i tratti del teodramma balthasariano, nel capitolo III, egli evidenzia
come per il teologo, attraverso la mediazione dello Spirito Santo, la frattura tra l’io e il ruolo – connaturata al
teatro, e al teatro del mondo nella sua
declinazione rappresentativa – può
infine saldarsi; così evidenzia perfettamente come, per diventare degli “io”
autentici, non alienati, gli uomini
avessero bisogno di un supporto ulteriore, non immaginabile o prevedibile nel suo darsi gratuito e sovrano;
era insomma necessario che in scena
entrasse anche una libertà infinita. È
in senso cristologico che il nodo viene
sciolto: «nell’Uomo-Dio si verifica la
coincidenza tra l’identità dell’attore e
il ruolo che questi deve esercitare nel
335
Recensioni
Concettualità del drammatico, e
strumentario teorico relativo al mondo del teatro sono, è cosa nota, posti
al centro dell’attenzione del teologo
svizzero fin dall’inizio del suo cammino speculativo. Meno chiari risultano invece natura, legame e senso tra
l’interesse per il teatro e la sua storia,
da una parte, e teologia, dall’altra.
L’ipotesi dell’A., verificata sia in un
serrato confronto con i testi – in particolare con il Trittico – sia con diverse proposte offerte dai più autorevoli
critici, è molto chiara. Per Balthasar
l’oggetto della teologia, il suo focus
risiede nel drammatico incontro tra
la libertà sovrana e infinita di Dio e
la libertà finita e ferita dell’uomo; il
ricorso al drammatico, argomenta
Bergamaschi, è in questo senso per
l’A. «funzionale all’elaborazione di categorie da impiegare per la riflessione
teologica, ovvero per illustrare e spiegare i “contenuti” della fede cristiana.
L’analisi del teatro è volta a delineare
l’interpretazione dei misteri della fede
[…]. A questo fine, Balthasar recupera l’aspetto evenemenziale dell’azione
teatrale, in modo da enunciare il carattere di evento reale, effettuale, che
pertiene al dramma tra Dio e l’uomo,
dramma che ha il vertice nell’azione
cristologica» (16).
Gli argomenti affrontati dall’A.
sono molteplici, e la puntuale ricostruzione storico-critica della letteratura balthasariana – lavoro questo
che trova già in sé una precisa ragion
d’essere – è nello scritto di Bergamaschi sempre funzionale a un secondo
momento, quello relativo alla riflessione, alla portata cioè teoretica – e
tangenzialmente antropologica – del
teodramma» (170). Da un punto di
vista “antropodrammatico”, il problema risiede nel fatto che l’azione umana, dal momento che si realizza in un
contesto sociale, facilmente s’inscrive
nell’alienazione tra interiorità e ruolo
sociale che si deve assumere per agire
(la stessa cosa che si verifica nel teatro,
tra attore e ruolo); Cristo presenta l’unico caso in cui ciò non avviene, perché Colui che lo origina (il Padre che
lo genera come Figlio) è Colui che
“contemporaneamente” lo invia, affidandogli la missione di Redentore (il
Padre lo manda come Inviato, gli dà
il ruolo di Inviato); è dunque soltanto in questo caso che le due cose non
sono separate, ed è solo nella misura
in cui noi diventiamo figli nel Figlio
che possiamo avere una missione, una
possibilità di azione (un ruolo) che
non ci alieni; si evidenzia così come la
vocazione cristiana si ponga come l’unica azione in cui persona e ruolo non
sono separati. Certo, per analogia, per
partecipazione, a un livello simbolico
(come già e non ancora); eppure, realmente ed effettivamente.
Ed ecco così raggiunto un primo
guadagno considerevole, evidenziato
dall’A.; per essere degli “io” reali, non
alienati, ci voleva Cristo. È a questo
livello, relativo alla vita intradivina, al
suo dispiegamento economico come
Performance assoluta e irripetibile (e
che pertiene anzitutto al Figlio-inviato), che si presenta uno degli snodi
più complessi della teodrammatica
balthasariana. Ed è qui – tra gli altri
luoghi – che possiamo cogliere in actu
exercito la lettura che ne offre l’A.
Bergamaschi ritiene che Balthasar, abbandonate le categorie della
336
teologia scolastica, si rivolga alla concettualità del teatro cercandovi un
veicolo meno inadeguato e più dinamico per esprimere nel suo aspetto
drammatico l’incontro tra liberta divina e libertà umana. Il cristianesimo
è anzitutto evento, azione, partecipazione; in questo senso «anziché l’esse
della scolastica, è l’azione il concetto
analogo per comprendere la rivelazione cristiana» (310). Quale, in ultima istanza, il modello drammaturgico impiegato da Balthasar in sede
teologica? L’A., dopo una scrupolosa
ricostruzione della produzione balthasariana relativa al suo interesse
per il teatro, conclude così: Balthasar
conosce e impiega i paradigmi relativi al teatro della rappresentazione il
quale, tuttavia, non si rivela in grado di soddisfare le esigenze profonde
del teologo. Tale concettualità non si
rivela cioè in grado né di esporre in
maniera adeguata i contenuti della
dogmatica, né di veicolare quello che
per l’A. si pone come il concetto unificatore della teologia balthasariana,
la categoria cioè di azione: «è questa
la categoria fondamentale, peculiare
della sua proposta teologica; il teatro
è impiegato nella misura in cui è il
dispositivo, l’apparato, che in Occidente ha tentato di rendere l’azione
(materiale) nel suo aspetto (formale) drammatico, evenemenziale […]
L’articolazione tra dramma e azione
risiede nel fatto che l’incontro delle libertà, al cuore della proposta
dell’autore, si realizza attraverso l’azione unica di un attore sul palcoscenico del mondo; il rapporto tra
libertà finita e infinita non è pertanto
una “struttura”, un’“essenza”, quanto
dell’A., che insieme a Balthasar e da
lui istruito e ispirato, ci indica una
via alternativa, sovversiva e meno
frequentata dagli abitanti del nostro
tempo. Il senso è un'azione, sì, ma
non una qualsiasi azione; il senso è
un azione qualificata, l’agire di un
io non alienato, di un soggetto consistente, una performance cioè – finalmente! – libera dall’angoscia di
un esito calcolato e preordinato da
un impersonale sistema socio-economico. Il cammino del Dio che
si fa uomo, e il nostro con lui, è il
passaggio dalla performance (diventa
il migliore!) alla Performance (sii te
stesso). Questo, per chi scrive, il valore “antropodrammatico” del lavoro
di Bergamaschi, che nell’evidenziare
un tratto fondamentale della produzione balthasariana, il teatro e la sua
funzione teologica, oggettivamente
ancora poco indagato – lacuna tanto
più grave se pensiamo a quanto esso
rivesta un ruolo centrale al suo interno – ci fornisce anche una splendida testimonianza di cosa significhi,
come scrive S. Ubbiali nell’introduzione, onorare i grandi pensatori,
accompagnandone intelligentemente
l’originale spinta riflessiva.
Davide Navarria
337
Recensioni
piuttosto una dinamica che avviene
in modo evenemenziale, attraverso
un’azione unica e irripetibile» (302303).
Condizione per il dispiegarsi del
dramma divino-umano è la non separazione tra l’attore e il pubblico. Ed
è questo il motivo per cui Balthasar
devia in direzione del teatro della
performance. Tale torsione tuttavia,
procede l’A., è tronca, incompiuta
almeno dal punto di vista della sua
articolata e cosciente esplicitazione.
Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che Balthasar continui a utilizzare,
almeno da un punto di vista terminologico, i “vecchi abiti” del teatro della
rappresentazione.
Balthasar (almeno implicitamente)
abbandona il paradigma della rappresentazione, e, sebbene non tematizzi
mai la cosa, essendo occupato dalla
dogmatica e dalla cristologia, si approssima agli sviluppi della drammaturgia della performance (o per altri
versi al teatro povero di Grotowski).
«Il senso è un’azione» (279).
Questa affermazione, netta e
lapidaria, restituisce la cifra di
quanto (insieme a una documentata
e pertinente ricostruizione storicocritica) è in grado di veicolare il testo
VALTER DANNA
Universo, vita, coscienza.
Introduzione alla filosofia della scienza
e della natura
Effatà, Cantalupa 2015,
pp. 335, € 22,00
S
i tratta di un libro complesso, che
affronta, come promette il titolo,
tre fondamentali problemi scientifici,
che hanno immediato riscontro a livello filosofico e implicazioni a quello
teologico, e che riguardano l’esistenza
e la natura dell’universo, della vita e
della coscienza umana. Questo approccio è frutto della competenza
dell’Autore in ambito sia scientifico
(a partire dalla laurea in fisica teorica) che filosofico (dalla tesi di laurea
in filosofia, in cui ha approfondito il
pensiero di Bernard Lonergan, alla
docenza accademica in Filosofia teoretica) e teologico (a partire dagli studi relativi).
Come rileva la prefazione di E.
Segatti, attualmente all’interno di
ogni tipo di sapere è necessario ridefinire i propri limiti i propri ambiti e
i propri compiti, senza pretese di superiorità da parte di una o di un’altra
disciplina, ma, anzi, in un atteggiamento di ascolto reciproco e con la
consapevolezza della reciproca interdipendenza (cf 5). Ciò vale, quindi,
per il complesso dei tre ambiti della
scienza, della filosofia e della teologia.
È lungo questo filo conduttore
che si sviluppa tutto questo libro, in
cui le varie tematiche e le problematiche ad esse relative appaiono a un
tempo connesse dal triplice approccio, utilizzato ogni volta, e distinte
338
secondo la peculiarità di ciascuna di
esse. Ne risulta un quadro unitario
molto stimolante, anche se il libro
non è stato originariamente scritto
come tale, ma costituisce una raccolta di varie pubblicazioni, conferenze
inedite e lezioni accademiche sulla
filosofia della scienza e della natura
(come recita il sottotitolo) condotte
nell’arco di venticinque anni (cf 7).
Questa unitarietà di fondo, nonostante la frammentarietà ed eterogeneità delle circostanze occasionanti,
indica come nella coscienza dello
stesso Autore (non disposto a rinunciare all’esercizio dello spirito critico
per nessuna delle tematiche affrontate) le sue molteplici acquisizioni
non sono rimaste elementi isolati e
affastellati, ma hanno potuto essere
confrontate e integrate fra loro; si
tratta di un processo che, invece, in
tanti casi non avviene, come si evince
anche da opere in cui pure sono presentati punti interessanti di risultati
scientifici e di riflessioni filosofiche e
teologiche. Questa intelligente integrazione costituisce un pregio peculiare del libro.
Nella prima delle quattro parti
dell’opera, organicamente costituita,
sono affrontate le scienze della natura, evidenziandone: lo sviluppo storico sia in seguito alla prima rivoluzione scientifica, a partire da Copernico,
alla tecnica, alla bioetica nel quadro
del primato dell’etica sulla tecnologia, al movimento verso la sapienza
nel dialogo tra scienze della natura e
teologia. La bibliografia è molto ricca
e articolata; spiace solo che non contenga tutte le numerose opere citate.
Detto questo, molte singole interessanti questioni trattate nei vari
capitoli andrebbero segnalate. Se ne
possono dare qui solo alcuni esempi:
la possibilità o meno di cittadinanza della causalità finale in ambito
scientifico; la natura peculiare della
chimica, con la sua collocazione tra
fisica e biologia, anche considerando specificamente la caratterizzazione del vivente e il valore della teoria
scientifica dell’evoluzione biologica;
gli argomenti di riflessione sul rapporto mente-cervello, o, in un’altra
prospettiva, anima-corpo, che scaturiscono da risultati sperimentali
delle neuroscienze; il ruolo, secondo
la prospettiva lonerganiana, del realismo critico nel percorso da epistemologia a metafisica; le contrapposte
tesi dei sostenitori e degli oppositori
del principio antropico; le modalità
auspicate di interazione tra scienza,
filosofia e teologia, includendo anche
il dialogo tra scienze della natura e
scienze dell’uomo; i problemi della
divulgazione scientifica e dell’etica
del lavoro scientifico. In conclusione,
un libro di cui si raccomanda vivamente la lettura, e la rilettura, non
superficiali.
Cloe Taddei Ferretti
339
Recensioni
che della seconda rivoluzione scientifica, a partire dall’inizio del XX secolo; i metodi e le procedure specifici, attingendo anche dal pensiero di
Lonergan; e lo sviluppo della nozione
stessa di scienza, anche qui attingendo da Lonergan.
Nella seconda parte si tratta ancora delle scienze della natura, ma dal
punto di vista sia epistemologico, in
relazione alla rivoluzione antropologica moderna, al problema del realismo, al confronto tra le visioni di
Popper e di Lonergan, sia dal punto
di vista ontologico, nuovamente confrontandosi con Lonergan. Va anche
notato, a quest’ultimo proposito,
che il rifarsi dell’Autore al pensiero
di Lonergan, come a quello di altri
studiosi, esprime la capacità di metabolizzare tale pensiero non come un
masso a sé stante, ma come un tesoro
sapienziale da spendere in varie circostanze nelle riflessioni personali.
Nella terza parte si affrontano criticamente in particolare le tematiche
della moderna cosmologia e della
creazione, considerando l’evoluzione
cosmica e l’ipotesi antropica, i diversi
punti di vista delle scienze, della filosofia e della teologia sulla creazione,
l’intervento di Dio secondo la prospettiva filosofica e secondo quella
teologica, il cosiddetto Disegno Intelligente e l’ipotesi opposta dell’autosufficienza del cosmo.
Nella quarta parte, l’attenzione è
per i problemi etici in epoca post-moderna, in riferimento alla scienza e
MAURO GAGLIARDI (ED.)
Il Filioque.
A mille anni dal suo inserimento nel Credo
a Roma (1014-2014)
LEV, Città del Vaticano 2015,
pp. 378, € 25,00
I
l volume pubblica gli Atti di un
Convegno che ha voluto fare il
punto sulla vexata quaestio del Filioque. L’impresa, che ha visto il contributo di autorevoli studiosi cattolici, si
articola in quattro tempi: storia, patrologia, teologia ed ecumenismo. A
ciò si aggiunge una sorta di appendice
(Aspetti complementari).
La riflessione sulla storia muove
dal contributo di J. Grohe che riassume la vicenda del Filioque dal V sec.
sino al “sinodo romano” del 1014
che determinerà la sua inserzione nel
Credo romano per volontà di Enrico
II. Importanza vien data ovviamente
ai concili spagnoli (cf Toledo III del
589), al ruolo della chiesa franca e a
Paolino di Aquileia.
La duplice crisi dei secc. IX e XI,
cioè al tempo di Fozio e di Michele
Cerulario è illustrata da E. Morini;
mentre N. Tanner prende in esame i
due Concili filioquisti, cioè Lione II
(1274) e Ferrara-Firenze (1439).
La sezione patristica comporta
quattro contributi di rilievo: S. Giuliano ripercorre la dottrina dei Padri
latini (Ireneo, Tertulliano, Ilario, Ambrogio, Fulgenzio); N. Cipriani espone la dottrina di Agostino nelle sue varie fasi e sottolienando il “principaliter
a Patre”. C. Moreschini offre alcune
osservazioni sulla pneumatologia dei
Cappadoci (Basilio e i due Gregorio),
340
non senza affrontare la delicata questione dei problemi di autenticità dei
testi pervenutici.
C. dell’Osso espone con acribia e notevole onestà intellettuale la
posizione di Massimo il Confessore
prendendo le distanze da facili concordismi, specie per quanto riguarda
la “Lettera a Marino”. Il Confessore
resta infatti molto fedele alla visione
orientale: «esiste un solo Dio, Genitore (Gennêtôr) di un solo Figlio, il
Padre e fonte (Pêgê) dell’unico Spirito
Santo: unità inconfusa e Trinità indivisa; Mente senza principio, unico
Genitore dell’unico Verbo essenzialmente senza principio e Fonte dell’unica Vita eterna, ovvero dello Spirito
Santo» (Quindici Capitoli, 4; PG 90,
1180A, cit. 162). La conclusione è
che «Massimo non dovrebbe essere
considerato un sostenitore della dottrina del Filioque» (163).
La parte peculiarmente teologica
offre uno spaccato di esegesi, di teologia medievale e di approccio speculativo.
Dell’ambito biblico si fa carico M.
Meruzzi che analizza i luoghi giovannei sullo Spirito (specie Gv 14,26 e
16,7) per poi concentrarsi sul verbo
“ekporeuomai” di Gv 15,26 e dei suoi
ricorsi in Ap (specie Ap 22,1). Forte
l’insistenza dell’esegeta (sulla scorta di
Brown, Morris, Beasley-Murray, Van-
Per la prospettiva ecumenica, A.
Pacini pone in confornto soprattutto
la prospettiva più dialogante di Bulgakov (come già Bolotov) con quella
decisamente rigida (palamita) di Losskij poi seguita da Meyendorff e altri
esponenti. N. Bux esamina i documenti del dialogo cattolico-ortodosso
(specie il testo del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei
cristiani del 1995).
Gli “Aspetti complementari” danno conto di una riflessione filosofica
(A. Livi sul nesso tra verità e amore),
sulla presenza del Filioque nella liturgia (Mc Namara) e su alcuni possibili
risvolti morali del Filioque (Woodall).
Il Lettore non troverà una Bibliografia
né un Indice di nomi in fine volume.
Non potendo soffermarci su ciascun contributo rileviamo solo alcuni
spunti che più ci hanno interessato.
Troviamo interessante (sebbene forse assai irrealistica) la proposta
di E. Morini di fare il grande passo
ecumenico di riconoscere il concilio
di unione “foziano” di Santa Sofia
dell’879-880 (edito dal Gemeinhardt
per la Brepols nel 2013) in cui si prevede congiuntamente la rimozione del
Filioque dal Credo e la legittimazione
di un pluralismo teologico (cf Unitatis
Redintegratio, 17). Siamo personalmente d’accordo con lo stesso Morini
quando dichiara che «le due diverse
opzioni teologiche sono troppo radicate nei rispettivi contesti patristici e
nelle successive determinazioni dogmatiche per poter essere messe fruttuosamente in discussione» (61). Ma
ci pare che sia proprio tale divergenza
patristica che vada inseguita e ulteriormente approfondita per indurre a un
341
Recensioni
ni, ecc.) sul carattere peculiarmente
“economico” e storico-salvifico dei
passi biblici addotti.
F. De Feo ripercorre il tema del
Filioque nella variegata teologia monastica occidentale intorno al XII sec.:
Anselmo, Ruperto, Abelardo e Riccardo di San Vittore. Per Anselmo, massimo esponente del filioquismo latino,
che giunge a rifiutare pure la processione principaliter a Patre e per Filium,
il Filioque esprime la derivazione dello Spirito dall’essenza o divinità del
Padre ed è necessario per esplicitare
razionalmente il dogma. L’Abate di
Deutz si concentra di più sul rapporto
tra Trinità “immanente” ed “economica” offrendo stimoli ecumenici con la
sua riflessione circa il rapporto bi-univoco (“pericoretico”) tra Figlio e Spirito nella creazione e nella santificazione
(cf De glorificatione, I, 16; cit. 215s).
Abelardo ritorna alla dialettica mentre
il Vittorino nel suo De Trinitate elabora una irenica e originale filosofia
trinitaria e metafisica dell’amore.
G.M. Salvati riassume la difesa del
Filioque propria di Tommaso d’Aquino, indicandone le fonti biblico-patristiche e la visione teologica. Preziosa
la disamina dell’unum principium che
sarà ripreso dal Concilio fiorentino.
Il curatore del volume, M. Gagliardi propone una lunga riflessione
di tipo specualtivo in cui si richamano
vari capisaldi della teologia trinitaria
(il Grundaxiom rahneriano, l’inversione soteriologica balthasariana; i due
modelli indicati da de Régnon, la persona come relatio subsistens, l’anarchia
del Padre, il principaliter a Patre…) e
una sintesi sul conflitto circa l’inserzione del Filioque nel Simbolo.
possibile superamento (Aufhebung) di
entrambe le prospettive per giungere a quella “pienezza di verità” che lo
Spirito stesso deve ancora rivelare alla
Chiesa. È in questa direzione che ci
siamo mossi, proprio mentre si teneva il Convegno, mediante un saggio
al quale ci permettiamo di rimandare
(«Credo in un solo Spirito Santo che
procede dall’unico Padre del Figlio
Unigenito. Discernimento storico-teologico per un consenso ecumenico sul
Filioque», in Lateranum, 80/2 [2014]
371-420). Il punto a nostro parere è
che va operato un discernimento sui
pregi e i limiti di entrambe le opzioni
pneumatologiche: quella che risale ad
Agostino con l’accento sulla communio d’amore tra Padre e Figlio e quella
che risale a Gregorio di Nazianzo con
l’esaltazione dell’anarchica (aghennêsia) monarchia paterna. Come conciliare queste due prospettive, di fatto
storicamente divergenti e come tali
irriducibili nel loro inevitabile approdo al filioquismo e al monopatrismo?
E qui pensiamo che vada attenutato il
giudizio di Moreschini secondo cui «il
Filioque, anche se non esplicitamente
affermato dai Cappadoci (su questo
non vi è dubbio), poteva apparire a
dei lettori posteriori – ma comunque
di ambiente greco – come una conseguenza, più o meno giustificata, della
loro pneumatologia» (146). Questo
ci pare eccessivo, almeno nel caso del
Nazianzeno che inaugura chiaramente
la linea monopatrista proseguita dal
Damasceno, Fozio e Palamas.
La via da noi additata (in consonanza con teologi come Durrwell,
342
Cantalamessa, Weinandy, ecc.) è il
recupero di un’autentica e piena teologia del Padre e della pericoresi in
una prospettiva di piena correlazione
tra primato e comunione.
Dal punto di vista ecumenico, ricordiamo quanto avemmo già modo
di sottolineare su questa rivista: con la
Chiesa ortodossa ci troviamo di fronte al singolare e duplice paradosso per
cui da un lato proprio i due principi
di unione, quello invisibile (lo Spirito
Santo) e quello visibile (il Papa) assurgono a pietre di scandalo; d’altro
lato entrambi «il Filioque e il Primato
pontificio mettono in gioco i due termini Primato e Comunione, sebbene
in modo esattamente inverso. Sul versante trinitario, la teologia orientale
accentua il primato (monarchia/taxis)
del Padre mentre quella latina sottolinea la comunione (koinonia/homoousia) tra Padre e Figlio. Sul versante
ecclesiologico si verifica il contrario:
gli Occidentali insistono sul primato
del Papa e gli Orientali invece sulla
comunione tra i vescovi (collegialità). Facciamo l’ipotesi che in forza del
nexus mysteriorum soltanto mediante
una comune riscoperta del pervasivo
principio teologico del “primato comunionale” si potrà giungere a una
vera ed accettabile soluzione di entrambe le questioni disputate» («Quale primato per il terzo millennio?»,
in Rassegna di Teologia, 46 [2005]
97-114). A tal proposito va aggiunto
che è lo stesso curatore del presente
volume ad aver percepito il suddetto
paradosso (cf 283).
Carlo Lorenzo Rossetti
FRANCESCO GIACCHETTA
I
l saggio del teologo F. Giacchetta
affronta alcuni dei principali nodi
teologico-pastorali emersi con vigore
negli ultimi anni di riflessione ecclesiale. Si tratta di uno studio che accompagna il lettore nella riscoperta
della propria identità battesimale e lo
aiuta a ripensare gli elementi centrali
di un itinerario di fede, come anche
il proprio ruolo nella Chiesa e nella
società. La questione di fondo attraverso la quale offrire nuovi stimoli
per l’evangelizzazione non è tanto la
distinzione classica tra credenti e non
credenti, la preoccupazione numerica
di fare proseliti tra i neopagani, con lo
spirito fondamentalista del “dentro o
fuori”, quanto piuttosto elaborare una
presenza intelligente che sappia tenere insieme identità e carità. Quando i
cristiani di ogni tempo sono riusciti
in questo compito, cioè quando sono
stati autenticamente testimoni, non
hanno avuto bisogno di particolari
alchimie o stratagemmi per condurre gli uomini alla fede, perché la loro
stessa vita, per osmosi, è diventata
evangelizzante.
Nel primo capitolo del volume l’A.
propone una riflessione filosofico-teologica sull’indispensabilità del dubbio
nell’atto di fede. Si tratta di un’espressione che rasenta l’ossimoro, e tuttavia tale dinamica è insita nel termine
«credente», un participio presente che
rimanda a una persuasione quotidianamente riacquistata. L’atto di fede
è presentato come un continuo percorso che coinvolge l’uomo a tutti i
livelli (esistenziale, intellettuale, spirituale) e che avrà compimento in prospettiva escatologica. Muovendo dalla
Scrittura (Abramo, Giobbe, Qoelet,
i Magi, la Vergine Maria) Giacchetta
mostra che la fede è essenzialmente
peregrinatio, è cioè un cammino in cui
certezza e dubbio rappresentano un
binomio irriducibile. Qui il discorso
viene precisato terminologicamente.
Per l’A., infatti, un conto è dubitare «della» fede, e un altro è dubitare
«nella» fede: «Il dubbio nella fede è lo
spazio per un interrogativo che vive
nella fiduciosa attesa d’una risposta,
per una ricerca che mantiene aperto il
dinamismo di crescita nell’essere credente» (33). Con questa affermazione
l’A. prende le distanze dalla visione
apologetica che ha attraversato il magistero cattolico nella modernità per
seguire e problematizzare un itinerario a cui hanno contribuito interpreti
come Pascal, Kierkegaard, Newman
e Pareyson, fino ad approdare al giovane Ratzinger, il quale, nel celebre
Introduzione al cristianesimo, vede
nel dubbio non un ostacolo alla fede,
bensì un passaggio necessario che ac343
Recensioni
Tra gli altri. “Chiesa in uscita”.
Appunti teologici di un fedele laico
Cittadella, Assisi 2015,
pp. 147, € 13,50
compagna credenti e non credenti a
decidere della propria esistenza: «Nessuno può sfuggire completamente al
dubbio, ma nemmeno alla fede; per
il credente la fede si rende presente
contro il dubbio, per l’altro attraverso
il dubbio e sotto forma di dubbio […]
E chissà mai che proprio il dubbio,
il quale preserva tanto l’uno quanto
l’altro dalla chiusura nel proprio isolazionismo, non divenga d’ora in poi
la sede per intavolare delle conversazioni, per scambiare e comunicarsi
qualche idea. Esso infatti impedisce
ad ambedue gli interlocutori di barricarsi completamente in se stessi» (41).
Il secondo e terzo capitolo hanno per oggetto il ripensamento della
presenza cristiana nel mondo in un
contesto laico e postmoderno. Tale
analisi muove dall’immagine plastica
di «Chiesa in uscita», che è vista come
alternativa «alla cristianizzazione delle
strutture, all’occupazione di spazi di
visibilità o di potere» (45). Quest’ultima è una via tipica del contesto socio-ecclesiale di cristianità, ma che
talvolta si è riproposta con forza anche
in tempi recenti nel tentativo, rivelatosi illusorio, di recuperare terreno
rispetto alla città secolare. Giacchetta
affronta la questione da due punti di
vista. Il primo è la testimonianza feriale e quotidiana come indirizzo che
rende pensabile la nuova evangelizzazione. In questo senso, l’A. propone
una chiave di lettura sacramentale: la
dinamica eucaristica è quella che permette la trasfigurazione della ferialità
(«il solito pane») nella straordinarietà
di un’esistenza redenta («il buon pane
quotidiano»). Il secondo (Legge naturale, democrazia ed evangelizzazione
344
nel contesto multiculturale) è invece la
traduzione del discorso nelle implicazioni etiche, giuridiche e politiche
delle società democratiche in cui il
cristianesimo trova espressione. Negli ultimi anni, il magistero cattolico
ha invocato l’intervento dello Stato
perché sancisse giuridicamente determinati comportamenti rendendo così
normativamente vincolanti alcuni limiti di tipo etico. La legge naturale è
stata l’argomento centrale di questo
atteggiamento. Tuttavia, se è vero che
«il diritto positivo sostiene e protegge atteggiamenti etici preesistenti,
mantenendo desta la coscienza etica
della società», è altrettanto vero che
«esso non può creare dal nulla, con
una semplice disposizione normativa, una coscienza etica mancante; né
salvaguardare regole morali in via di
disgregazione: le norme giuridiche
debbono trovare nei loro destinatari
e nella società stessa un fondamento
che le sostenga poiché non possono
assolutamente vivere della loro coercitività» (62-63).
La seconda parte del volume
(Chiesa in uscita. Tra gli altri con il Vaticano II) consta del quarto e quinto
capitolo, che hanno per oggetto rispettivamente una proposta di esegesi
dell’allocuzione di Giovanni XXIII
Gaudet Mater Ecclesia e alcuni richiami di teologia dell’evangelizzazione
scaturiti da Gaudium et spes. Si tratta
in fondo, sintomaticamente, di due
testi collocati esattamente all’inizio
e alla fine del concilio Vaticano II. Il
primo non è propriamente un prodotto del concilio, data la paternità
esclusiva e riconosciuta di papa Roncalli, che ha vergato personalmente il
stesso tempo. L’A. preferisce deliberatamente «corresponsabilità» a «collaborazione» facendo proprio parte del
linguaggio ecclesiologico successivo
al Vaticano II. Altro è, infatti, lavorare a un compito con uno stile esecutivo, per quanto possa trattarsi di
un ufficio pastorale e spirituale, altro
è sentirsi corresponsabili alla pari di
uno stesso progetto condiviso. Vi è
una distanza siderale tra questi due
metodi, sebbene terminologicamente
possa sembrare solo una questione di
cesello. «Corresponsabilità», infatti, è
uno stile che richiama la collegialità,
la sinodalità, la partecipazione ecclesiale a tutti i livelli e che in definitiva
fotografa meglio di altre immagini la
visione ecclesiale del Vaticano II.
Quello di Giacchetta è dunque
uno studio stimolante a più livelli che
interpella la coscienza della presenza
cristiana nel mondo contemporaneo.
Non sono le strutture, il potere, la visibilità, gli accordi con i governi del
momento a garantire efficacia alla
missione della Chiesa, sembra dire
l’A., ma unicamente la coerenza della
testimonianza di vita individuale ed
ecclesiale. In effetti, anche ai nostri
giorni, per allargare il quadro di riferimento, non è infrequente osservare
come le Chiese che vivono in contesti di persecuzione siano anche quelle
più vivaci e resilienti, mentre, viceversa, quelle che si sviluppano in paesi
democratici e tutelanti nei confronti
delle minoranze stiano attraversando
vistosi fenomeni di erosione. Talvolta
il passaggio repentino dalla prima alla
seconda condizione coincide con una
crisi religiosa e spirituale particolarmente intensa, come, ad esempio, nel
345
Recensioni
discorso inaugurale. Tuttavia, è storicamente corretto affermare che tutti i
documenti conciliari sono stati redatti nello spirito impresso da Giovanni
XXIII all’assemblea attraverso tale allocuzione e non vi è stata crisi nel corso dei lavori che non sia stata superata
appellandosi a tale testo programmatico. In esso il papa bergamasco scardinava il catastrofismo antimoderno
della Chiesa e invocava la necessità di
intravedere segni di speranza nel tempo presente. Non c’è un documento
che più di Gaudium et spes abbia saputo raccogliere tale appello. Già nel
titolo veniva espressa una nuova concezione della presenza della Chiesa,
che ora si percepiva «nel» mondo contemporaneo, e non più esclusivamente in contrapposizione ad esso. L’ovvio incipit secondo il quale le gioie e
le speranze degli uomini d’oggi sono
le stesse della Chiesa è stata per secoli
un’affermazione tutt’altro che scontata. Seppur sinteticamente, l’A. prende
in considerazione i cardini teologici
principali della costituzione pastorale:
la teologia della storia, l’identità del
fedele laico, il ripensamento dell’evangelizzazione, la cultura, la natura
del cristiano e della Chiesa.
Nella terza e ultima parte (Chiesa
in uscita. Tra gli altri da fedele laico),
Giacchetta affronta il tema della corresponsabilità ecclesiale nell’evangelizzazione. Nel sesto capitolo l’angolo
prospettico è quello del fedele laico,
nel settimo è la dimensione familiare.
La scelta della categoria «corresponsabilità» come elemento propulsivo
capace di rinnovare la missione della
Chiesa in tutti i suoi aspetti è una
dinamica cogente e provocatoria allo
caso dei paesi a influenza comunista.
Questo non vuol dire naturalmente che l’unico paradigma possibile
dell’evangelizzazione sia quello della
missione impedita. Al contrario, dobbiamo abituarci a un Occidente tollerante, in cui però il cristianesimo rischia di essere sempre più irrilevante.
La sfida sembra essere dunque saper
realizzare una presenza significativa
come cristiani nel mondo superando,
da un lato, la visione della cristianità
e la sua riproposizione in chiave contemporanea della religione civile, e,
dall’altro, la rinuncia programmatica
ad ogni testimonianza pubblica della
fede, quasi fosse politicamente scorretto sfidare la soglia di laicità delle
democrazie occidentali.
Enrico Brancozzi
KARL-HEINZ MENKE
Sacramentalità.
Essenza e ferite del cattolicesimo
Queriniana, Brescia 2015,
pp. 384, € 38,00
L
a tesi centrale del saggio teologico di Menke può essere così sintetizzata: il cattolicesimo non è una
determinata dottrina cristiana né una
organizzazione religiosa, ma un modo
specifico e particolare di vivere e pensare il cristianesimo, ossia viverlo e
pensarlo in termini di sacramentalità.
C’è un “di più” della comunicazione sacramentale con Cristo rispetto
a quella non sacramentale. Tuttavia,
per comprendere questo, è necessario
distinguere la sacramentalità dal sacramentalismo. Mentre il sacramentalismo è l’identificazione della Chiesa
visibile con quella invisibile, la sacramentalità «poggia sulla distinzione tra
il piano indicante e il piano indicato,
tra la Chiesa invisibile e quella visibile, tra l’autorità di Cristo e l’autorità
del ministero apostolico, tra la verità
in sé e il dogma che la indica» (5).
346
Il piano indicante/significante, nella
prospettiva sacramentale, non è mero
simbolo convenzionale, ma è inseparabile, nonostante tutta la diversità,
da quello indicato/significato. Il testo
di Menke è strutturato in cinque ampi
capitoli. Nel primo capitolo il teologo
prende in considerazione l’essenza del
cattolicesimo secondo la critica protestante. È il tentativo di scandagliare la
propria essenza mettendosi dal punto
di vista dell’altro, cercando di vedersi
con gli occhi di un protestante. Sono
analizzate le teologie protestanti di R.
Sohm, A. von Harnack, E. Troeltsch,
alla luce delle quali l’essenza del cattolicesimo appare come l’identificazione
della Chiesa con una organizzazione,
l’identificazione della parola di Dio
con l’uomo Gesù, del Vangelo con il
dogma, l’identificazione dell’assoluto
con un fatto storico (cf 40). Attraver-
e pneumatocentrica della Chiesa. Si
tratta di una questione controversa
che, nel campo del dialogo cattolico-protestante, si presenta nella forma
dello specifico problema della definizione del rapporto tra Chiesa visibile e Chiesa invisibile. Gran parte del
capitolo è consacrata alla descrizione
in chiave sacramentale delle proprietà
ecclesiali dell’unità, dell’apostolicità, della cattolicità e della santità (cf
181-272). Il capitolo conclusivo si occupa delle conseguenze di una sacramentalità incrinata, ovvero dei fenomeni diffusi della desacralizzazione,
del funzionalismo, del misticismo e
dell’integralismo, vere e proprie ferite
inferte al cuore dell’identità cattolica.
Pian piano si è passati da una ecclesiologia sacramentale a una ecclesiologia
funzionale, che finisce per svuotare di
significato l’Eucaristia e il ministero.
La tentazione misticistica del cattolicesimo e quella integralistica rappresentano una perversione dell’essenza
del cattolicesimo, perché giudicano
e pensano in modo antisacramentale:
il misticismo e l’integralismo hanno
in comune l’antisacramentalismo; in
entrambi non esiste la distinzione tra
realtà significante (sacramentale, rappresentante) e realtà significata (trascendente, rappresentata). Per il paradigma misticistico, reale è ciò che è
sperimentato dal singolo soggetto; per
il paradigma integralistico, reale è solo
quello che l’autorità oggettivamente
presenta (cf 308). Il saggio di Menke
è particolarmente interessante perché
rimette al centro del pensare teologico
la categoria della sacramentalità, in un
contesto socio-culturale in cui il pensiero sacramentale è fortemente in crisi
347
Recensioni
so l’analisi e il confronto tra la teoria
cattolica del simbolo (K. Rahner) e
quella protestante (P. Tillich), Menke
prepara la testi esposta nel capitolo
secondo: il cattolicesimo sta o cade
con la sua sacramentalità. La Chiesa, con e in Cristo come sacramento,
è il mezzo e lo strumento da lui inseparabile per salvare anche l’ultimo
fratello e l’ultima sorella. La Chiesa è
«sacramento e simbolo reale, perché
non solo allude a Cristo come al totalmente Altro, ma perché Cristo si lega
talmente ad essa da essere solo con
essa e niente affatto senza di essa la
salvezza del mondo» (120). Nel terzo
capitolo del suo lavoro, Menke riflette
sull’essenza sacramentale della Chiesa
come popolo di Dio, nato dal Corpo
di Cristo. Egli polemizza contro una
ecclesiologia talvolta esplicitamente
antisacramentale. Partendo dall’intimo legame tra Eucaristia e Chiesa,
tra la sacramentalità del dono di sé
fatto da Cristo nell’Eucaristia e la sacramentalità della Chiesa, è illustrato
il “di più” della comunicazione sacramentale con Cristo rispetto a quella
non sacramentale: «questo “di più” sta
nel fatto che la comunicazione sacramentale è una comunicazione visibile
e, quindi, una pubblica professione
di fede. Il cristiano che si comunica
sacramentalmente si identifica pubblicamente con la comunità professante la propria fede, che è rappresentata dal vescovo locale menzionato per
nome in ogni celebrazione dell’Eucaristia e dal successore di Pietro, parimenti menzionato per nome» (122).
Il quarto capitolo affronta la delicata
questione del rapporto fra Cristo e lo
Spirito, tra concezione cristocentrica
ed estraneo al pensiero postmoderno.
Il pensiero sacramentale e il pensiero
postmoderno – nota il teologo tedesco – si comportano tra loro come
due opposti, si escludono a vicenda,
perché il pensiero postmoderno non
riesce a custodire la distinzione antropologica tra io e non-io e quella ontologica tra un piano indicante e un
piano indicato, che sono presupposte
dal pensiero sacramentale (cf 321).
Il libro di Menke è provocatorio, soprattutto dal punto di vista ecumenico; esso sembra aprire fossati da lungo
tempo creduti colmati e parla senza
mezzi termini di una differenza fondamentale tra cristianesimo protestante
e cristianesimo cattolico: da un lato
l’azione esclusiva diretta (pneumatica) da parte di Dio, dall’altro l’attività
congiunta sacramentalmente media-
ta. Menke non ama compromessi
ecumenici fatti a spese della verità, è
contrario a un ecumenismo, talvolta
irenico, di dichiarazioni congiunte e
di pezzi di carta che mette a tacere la
differenza fondamentale tra protestantesimo e cattolicesimo. I documenti
elaborati dai teologi delle diverse parti interessate mostrano un crescente
consenso in ambito ecumenico e una
comprensione reciproca sempre più
profonda. Sono passi importanti e necessari, ma non sufficienti, perché la
differenza fondamentale può essere superata non con la riflessione teologica
(l’unione concettuale non è un’unione reale), ma unicamente mediante la
traduzione dell’incarnazione di Cristo
nell’incarnazione sacramentale della
Chiesa (cf 7).
Agostino Porreca
GIACOMO MINNINI
Verso il mare.
La filosofia della storia di Giorgio la Pira
Ladolfi Editore, Novara 2015,
pp. 97, € 10,00
N
ell’agosto del 1849, in uno dei
più bei discorsi socio-politici mai
pronunciati, Victor Hugo, salutando
i delegati internazionali radunati in
Congresso a Parigi dichiarava che la
ricerca della Pace costituisce «le dernier
et le plus auguste feuillet de l’évangile,
celui qui impose la paix aux enfants du même Dieu, et, dans cette ville
qui n’a encore décrété que la fraternité
des citoyens, vous venez proclamer la
348
fraternité des hommes […] Messieurs,
cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles
d’un lien commun, l’évangile pour loi
suprême, la médiation substituée à la
guerre […] c’est un but réalisable, je
dis c’est un but inévitable. On peut
en retarder ou en hâter l’avénement,
voilà tout. La loi du monde n’est pas
et ne peut pas être distincte de la loi
de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n’est
rettamente, anche se filtrato e corretto
dalla riflessione tommasiana, La Pira
ritiene soprattutto la rilettura di Mt 13
in cui il dramma storico è prospettato come crescita simultanea del buon
grano e della zizzania. Ma a presiedere
questo progresso è la Provvidenza che
tutto dispone «a questo fine tanto supremo (la preghiera finale di Cristo!)
della pace e della unità della Chiesa e
dei popoli di tutta la terra» (10). E qui
il pensiero lapiriano si fa più positivo
rispetto all’antico Padre. Allo scopo
indicato concorrerà soprattutto, oltre
all’evangelizzazione e alla carità della
Chiesa, una riabilitazione (in senso tomistico) della politica come necessario
servizio alla comunità, l’ecumenismo
e pure l’avvicinamento e la collaborazione delle tre famiglie abramitiche. Il
fine ultimo della storia è ovviamente
trans-storico e rispetta ciò che la teologia chiama la “riserva escatologica”;
eppure vi è un fine ‘penultimo’ da perseguire: una “nuova civiltà”, “civiltà
universale”, in cui, al massimo grado
si compia la volontà divina (di amore, pace, giustizia e fratellanza) “come
in Cielo, così in terra”. Questa visione
prelude e corrisponde alle intuizioni
della Gaudium et spes (specie al 39,
giustamente richiamato a p. 85, n. 6).
Il fine di unità e pace – storicamente perseguibile e realizzabile in forza
dell’azione storica ecclesiale – è come
un teilhardiano Punto Omega, un
polo d’attrazione che attira e orienta i
flussi storici. Questi, sempre rispettosi
del libero arbitrio, lo possono ritardare
o accellerare, ma esso rimane lo scopo
e il senso della storia.
Leggendo Hegel (di fatto la Filosofia del Diritto, nell’edizione di Croce e
349
Recensioni
pas la guerre, c’est la paix. Les hommes
ont commencé par la lutte, comme
la création par le chaos. D’où viennent-ils? De la guerre; cela est évident.
Mais où vont-ils? A la paix; cela n’est
pas moins évident».
Premettiamo questa citazione perché essa è in perfetta consonanza con
il pensiero di Giorgio La Pira († 1977)
proposto dal libro di Minnini. Si tratta di un agile volumetto che offre uno
spaccato della visione della storia del
“sindaco santo”, di origine siciliana,
padre costituente (a lui si deve in specie
l’art. 2 della Carta) e soprattutto primo
cittadino di Firenze, ruolo in cui si distinse per la ricostruzione postbellica,
l’aiuto ai senzatetto e ai disoccuppati e
per la sua infaticabile attività a favore
della pace. Il saggio è inserito in una
bella collana (“Ametista”) diretta da M.
Schoepflin che conta sinora una quindicina di titoli dedicati a vari temi di
filosofia con ispirazione cristiana (E.
Mounier, L. Wittgenstein, E. Stein, R.
Girard…).
Merito precipuo di Minnini è quello di aver attirato l’attenzione sul nerbo
dell’azione poliedrica di La Pira. La visione cioè della storia come ambito di
sinergia tra reale libero arbitrio umano
e onnipotente Provvidenza divina: un
grande fiume che scorre “verso il Mare”,
ovvero verso la destinazione voluta da
Dio che è quella dell’Unità e della Pace
della famiglia umana, verso quella che
già Pio XII additava come una grande “estate” dell’umanità (cf Discorso ai
Giovani del 19 marzo 1958).
I primi due capp. situano La Pira
rispetto a due giganti della filosofia
(e/o teologia) della storia, Agostino e
Hegel. Del primo, che lo influenza di-
Gentile del 1913), La Pira ne denuncia
le possibili derive immanentistiche e
totalitarie giacché il procedere del Geist
schiaccia e soppianta la singola persona
a favore del Tutto e dello Stato. È così
recepita la lezione maritainiana specie
ne Il valore della persona umana e ne
le Premesse della politica. Ciò che si assume del filosofo idealista è «il sistema
storico dialettico, la visione della storia
come un processo in perpetuo divenire,
mai esaurito in se stesso, perennemente
costruentesi e perfezionantesi» (34).
Gli altri (ben più brevi) capitoli del
volume declinano l’intuizione fondamentale alla luce di alcune metafore di
ascendenza evangelica: la “barca” che
procede sul fiume, il “campo” in cui
è seminato il seme evangelico, il “lievito” che fermenta la massa, “l’aurora”
che deve sorgere. La sezione intitolata
«Politica e storia» mette in parallelo la
visione lapiriana con la dottrina del
Vaticano II.
Le pagine dedicate a «Un’altra navigazione» (87-93) esprimono il lato
oscuro della storia percepito con realismo da La Pira in occasione della
crisi nucleare tra USA e URSS in cui
si prospetta la catastrofica possibilità
nichilistica dell’“affondamento della
barca” per auto-distruzione. La storia,
pur avendo un fine divino comporta
una possibilità di scacco, un “crinale
apocalittico”: il bivio tra la distruzione
della terra ovvero della pace universale
attraverso la “via isaiana” della conversione delle armi in aratri (cf Lettera a
Krusciov, 17 novembre 1961).
Alcuni rilievi: manca, a nostro parere, un capitolo introduttorio con
una breve sintesi biobibliografica di
La Pira. La Bibliografia in fondo al li350
bro (95-97) è utile, ma non distingue
come dovuto le “fonti” lapiriane (che
andrebbero menzionate in ordine cronologico) dalla letteratura secondaria.
Così come manca un capitolo prettamente teologico in cui si sarebbero focalizzati i capisaldi del pensiero cristiano
lapiriano (la novità del Cristo risorto,
la grazia dello Spirito, la Chiesa con
la sua azione nella storia; la bipolarità
Stato-Chiesa).
Alcuni giudizi dell’autore, specie
riguardo sant'Agostino sembrano alquanto tranchants e probabilmente
ingenerosi (cf 17, 36). D’altronde non
si capisce perché il cap. 1 si intoli «La
Pira e Agostino», allorché il contenuto
mette in rilievo il ben più grande influsso esercitato da Tommaso sul terziario domenicano.
Nella lettera succitata a Krusciov,
La Pira fa un accenno un po’ infelice ai
“mille anni” (cf Ap 20). Siamo persuasi
che l’uso di questo testo sia improprio
a indicare il fine positivo intrinseco alla
storia. Va detto che il ‘sindaco santo’ è
comunque in buona compagnia se ci si
ricorda dei Padri pre-niceni, dello stesso Antonio Rosmini per non parlare
dei russi Dostojevsky e Bulgakov. (Sia
lecito rimandare a un nostro articolo
in Gregorianum, 88/2 [2007] 274).
A proposito delle fonti e affinità del
pensiero lapiriano: l’A. menziona ovviamente i grandi personalisti francesi
Maritain e Mounier, ma anche Péguy.
Sarebbe stato interessante però approfondire con maggiore documentazione
i nessi tra La Pira e Teilhard de Chardin (cf 11, 89s) e Vico (25, 73-74),
ma anche con autori non menzionati
quali Gioacchino da Fiore, Bonaventura, Bossuet e poi, tra i contempo-
solo con i fasti della potenza e della
gloria, ma ancora più con quelli anche
migliori dell’umana virtù, della bontà
popolare, della prosperità collettiva
della vera civiltà: la civiltà dell’amore»
(1º gennaio 1977). E si noti che il più
recente magistero pontificio, col dovuto realismo, ci sospinge verso quella medesima direzione: «La storia ha
una meta, ha una direzione. La storia
va verso l’umanità in Cristo, va verso
l’uomo perfetto, verso l’umanesimo
perfetto […] Sì, c’è progresso nella storia. Progresso è tutto ciò che avvicina
a Cristo e ci avvicina così all’umanità
unita, al vero umanesimo». «Vogliamo che finisca questo mondo ingiusto. Vogliamo anche noi che il mondo
sia fondamentalmente cambiato, che
incominci la civiltà dell’amore, che
arrivi un mondo di giustizia, di pace,
senza violenza, senza fame» (Benedetto XVI, Ud. gen., 5 gennaio 2006 e
12 novembre 2008). «Signore, prendi
noi col tuo potere e la tua luce, / per
proteggere ogni vita, /per preparare un
futuro migliore, / affinché venga il tuo
Regno / di giustizia, di pace, di amore
e di bellezza» (Francesco, Laudato si’,
246; cf anche 207).
Detto ciò, siamo grati a Minnini
che ha saputo fornire in poche pagine
e con discreta documentazione l’essenziale della grandiosa visione della storia
di uno dei migliori uomini politici italiani, la cui testimonianza e il cui messaggio mantengono, nei nostri tempi,
tutta la loro attualità. Personalmente
questo scritto ci conferma ulteriormente nella convinzione che La Pira
sia stato davvero un precursore e un
profeta della “civiltà dell’amore”.
Carlo Lorenzo Rossetti
351
Recensioni
ranei, Lanza del Vasto, A. Capitini, I.
Giordani. Ma è soprattutto il rapporto
con papa Montini che sarebbe stato
prezioso indagare. Ma questo costituirebbe argomento per una peculiare monografia. È ben nota l’amicizia
profonda e di lunga data (testimoniata
da un migliaio di lettere di corrispondenza). L’“eu-topia” montinana di “civiltà dell’amore”, – di fatto integrata
nel successivo Magistero (cf in ultimo
Francesco, Laudato si’, 231), – si interseca e quasi confonde con l’ideale
lapiriano: «La causa dell’uomo, non
solo non è perduta, ma è in sicuro vantaggio. Le grandi idee, che formano i
fari del mondo moderno, non si spegneranno. L’unità del mondo si farà. La
dignità della persona umana sarà, non
soltanto formalmente, ma realmente
riconosciuta. L’intangibilità della vita,
dal seno materno all’ultima vecchiaia,
avrà comune ed effettivo suffragio. Le
indebite disuguaglianze sociali saranno
colmate. I rapporti fra i Popoli saranno
pacifici, ragionevoli e fraterni. Non l’egoismo, non la prepotenza, non l’indigenza, non la licenza dei costumi, non
la ignoranza, non le tante deficienze
che ancora caratterizzano e affliggono
la società contemporanea, impediranno d’instaurare un vero ordine umano,
un bene comune, una civiltà nuova»
(4 aprile 1971). «Sogniamo noi forse
quando parliamo di civiltà dell’amore?
No, non sogniamo. Gli ideali, se autentici, se umani, non sono sogni: sono
doveri» (31 dicembre 1975) «Non è un
sogno la Pace, non è un’utopia, non è
un’illusione. E nemmeno essa è una
fatica di Sisifo: no, essa può essere prolungata e corroborata; essa può segnare le più belle pagine della storia, non