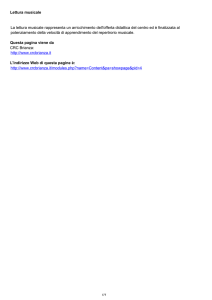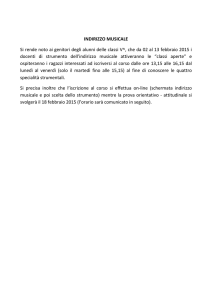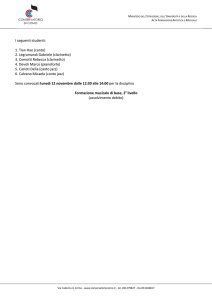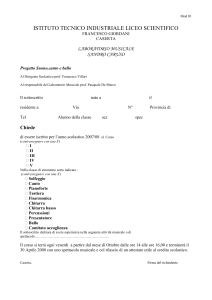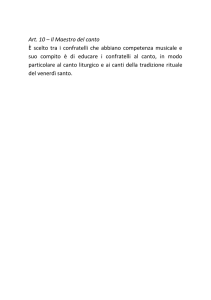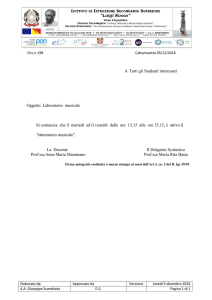CON “STRANGE FRUIT”, UN MANIFESTO DI DURA,
IMPIETOSA ACCUSA IN FORMA DI POESIA,
DEL RAZZISMO IMPERANTE, LA CANTANTE
OTTIENE LA RIBALTA INTERNAZIONALE
la Voce
del popolo
musica
www.edit.hr/lavoce
Anno 9 • n. 69
mercoledì, 24 aprile 2013
BILLIE
HOLIDAY
LAREGINATRISTEDEL JAZZ
IL PERSONAGGIO
VITA NOSTRA
VOCI STORICHE
In ricordo di Sergio Sablich autentico
gentiluomo della musica
Il libro di bitinade di Vlado Benussi
una testimonianza preziosa
La rocambolesca vita del tenore Tito
Schipa che affascinò le platee dell’epoca
Musicologo e critico di origini fiumane e personaggio
di primo piano della scena musicale italiana, è venuto
a mancare nel 2005 suscitando il profondo cordoglio
degli ambienti culturali
L’eclettico musicista rovignese, grande cultore della
tradizione popolare della sua città natale, ha raccolto in un
volume un centinaio dei caratteristici canti di Rovigno, i
quali rientrano nel patrimonio immateriale dell’umanità
Il cantante ed attore leccese, uno dei maggiori
tenori del ‘900, contrastò le vicende della vita e del
palcoscenico con la spavalderia dell’eroe romantico
affrontando pericoli e peripezie
4|5
6|7
8
2
musica
mercoledì, 24 aprile 2013
la Voce
del popolo
LE LEGGENDE DEL JAZZ
L’ECCEZIONALE PARABOLA ARTISTICA DI BILLIE HOLIDAY TRA TRASGRESSIONI, ECCESSI E UNA
QUELLA
E QUELLA
CHE ARRI
«S
econdo te, chi è più brava, io o
Sarah?»
Billie Holiday è appena rientrata
a casa dopo avere passato dieci mesi in
stato di detenzione e disintossicazione
obbligatoria all’Alderson Federal Prison
Camp (West Virginia). Isolata dal mondo
e dalla musica dal 27 maggio del 1947
al 16 marzo del 1948, una volta uscita
ritrova gli amici e gli estimatori di
sempre, ma anche tante novità. Quella
che la tormenta di più è la fama raggiunta
da Sarah Vaugham, che la critica reputa
la migliore jazz-singer del momento,
superiore, non solo a lei, ma anche a Ella
Fitzgerald.
La domanda è rivolta all’amico Tony
Scott, clarinettista e pianista di peso. Il
quale, per tutta risposta, le dice: “Quando
Sarah canta ‘My man is gone’ è risaputo
che il suo uomo è sceso a comperare le
sigarette. Quando la canti tu, è chiaro che
se n’è andato per sempre”.
In questa battuta del musicista italoamericano (Anthony Joseph Sciacca,
nato a Morristown, 17 giugno 1921 e
morto a Roma, 28 marzo 2007, figlio di
trapanesi emigrati negli States) c’è tutta
Billie Holiday, ossia la cantante che –
come hanno detto e scritto tanti jazzisti
americani – ha dato voce all’anima,
trasformando ogni brano musicale,
compresi gli standard accompagnati da
orchestre ad archi, in blues.
Nata sotto cattiva stella
L’insicurezza della Holiday non è, però,
frutto dello stato di coercizione vissuto ad
Alderson: è, bensì, il culmine, l’esplosione,
di una sofferenza che solo l’incessante
lavoro, le continue registrazioni, i
concerti, i tour e, ovviamente, il costante
stato di inebetimento da alcol e droghe,
avevano impedito di far scatenare prima.
Brutalmente parlando, Billie nasce
“disgraziata”: i genitori sono poco
più che ragazzi quando la mettono al
mondo; fin da piccola, vive di stenti
e con la madre va in giro per New
York a lavare scale e ingressi di locali
pubblici. A undici anni è violentata
da un quarantenne: “Mi sono sempre
chiesta cosa gli passasse per la testa,
mentre si sfogava con una bambina”, si
domanda Billie nell’autobiografia, scritta
a quattro mani con William Dufty, “Lady
Sings the Blues”, uscita nel 1957 (“La
Signora canta il Blues”, ultima edizione
italiana – Feltrinelli, collana Universale
economica 2002). Una mattina si sveglia,
come in un film horror, impossibilitata a
liberarsi dall’abbraccio della nonna, morta
durante la notte e accanto a cui amava
addormentarsi. Insieme a sua madre, si
prostituisce in un bordello clandestino.
Viene rinchiusa in una sorta di collegio,
dove compagne ed educatrici le fanno di
tutto. Insomma, motivi per essere allegre,
proprio non ne ha, nell’infanzia.
“Esplode” il successo
Le cose cambiano quando viene scoperto
il suo straordinario talento canoro.
Diciottenne, dopo essersi esibita quasi
per caso in uno dei tanti club neviorkesi,
musicisti di buon cuore e grande fiuto la
raccomandano a colleghi più fortunati.
I primi successi
In breve tempo, Billie si vede
accompagnata dai mostri sacri dello swing
e del jazz: canta con l’orchestra di uno
dei più famosi bandleader Bianchi: Benny
Goodman, quindi con il pianista Teddy
Wilson, con il complesso di Artie Show.
Addirittura, con la Big Band di Count
Basie, in cui milita lo shouter Jimmy
Rushing.
Alla fine degli anni Trenta – lei ne ha
suppergiù venticinque - Eleonora Fegan,
nata a Filadelfia il 7 aprile del 1915, è già
“Billie Holiday”, anzi “Lady Day”, come la
ribattezza il tenorsassofonista del “Conte”,
Lester Young, da lei a sua volta ricambiato
col soprannome “Prez”, che gli rimarrà
addosso per tutta la vita.
Ovviamente, è una notorietà interna al
mondo del jazz e del blues: sia di quello
Bianco che, soprattutto, di quello Nero. Il
bello è, che in repertorio, almeno per ora,
non ha “cavalli di battaglia”, pezzi che la
contraddistinguano rispetto alle colleghe,
presenti e passate. Il fatto è, che è lei ad
essere un cavallo di battaglia!
Gli strani frutti del razzismo
Ma ecco che trova il pezzo, e con esso la
fama al di fuori della cittadella del jazz,
che ne sarà e farà il tratto distintivo. E’ un
pezzo autenticamente unico – definirlo
“canzone” sarebbe fuorviante - che Billie
decide di incidere nemmeno due mesi
dopo averlo cantato per la prima volta
al Caffè Society, agli inizi del 1939: si
intitola “Strange fruit”. Ne è autore un
insegnante comunista, ebreo-russo, Abel
Meeropol, che si firma Allen Lewis. Ma
non è un testo qualsiasi, per quanto
intrigante e ”diverso”: è un manifesto di
dura, impietosa accusa in forma di poesia,
del razzismo imperante. E’ una poesia
musicata, una poesia su un linciaggio da
poco avvenuto: il linciaggio di un Nero;
pratica abbastanza normale negli Stati del
sud:
“Gli alberi del sud danno uno strano
frutto,
sangue sulle foglie, sangue sulle radici,
un corpo nero dondola nella brezza del
sud,
strano frutto appeso agli alberi di pioppo”.
Si rifà a una scena da lei vista, nel corso
di una tournée, quando cantava per una
band bianca ed era costretta a trascorrere
il prima e il dopo delle proprie esibizioni,
fuori dal locale, e mangiare da sola (unica
colored in un’orchestra di wasp con
qualche raro italo o ispano-mericano),
essendole proibito trattenersi nel locale.
E’ un atto d’accusa che il jazz fino a quel
momento non aveva mai conosciuto.
A ben guardare, nemmeno il blues.
Ancora non siamo agli anni dell’impegno
sociale e politico del jazz afroamericano
(timidamente all’inizio, convintamente
dopo un decennio, spalleggiato dai
colleghi Bianchi), quelli in cui si sarà
affermato il Be-bob, dalla metà dei
Quaranta, grazie al coraggio civile, sul
fronte cinematografico e teatrale di
Paul Robeson, e su quello prettamente
musicale e jazzistico di Billy Eckstine;
ma anche del clarinettista Milton Mezz
Mezzrow, un ebreo il quale esige che
nei documenti stia scritto “negro”, e il
cantante Herb Jeffries, Bianco, per parte
di padre di origini sicule (“Trovatemi un
siciliano nell’Ottocento, che non abbia
radici moresche”, suole dire), il quale
non solo si esibisce solo con orchestre
“colored” (Earl Hines, Duke Ellington),
ma sarà pure il primo cow-boy Nero nei
“race movies” degli anni Trenta.
L’uscita del disco è una bomba. Che il
titolare della label con cui era sotto
contratto – John H. Hammond e la
Columbia Records - si era rifiutato di
incidere, ma non volendo perdere quella
miniera di soldi di nome Billie Holiday (a
cui peraltro, dava una miseria; d’altronde,
fu lui a scoprirla e a farle avere tutti gli
ingaggi fino a quel momento), permette
che venga registrata da una casa
discografica più che semisconosciuta, la
Commodore Records.In men che non si
dica, Billie diventa un’icona.
Va da sé che né ciò, né l’affetto e la stima
di compagni di lavoro, estimatori di varia
estrazione sociale ed etnica, musicisti
in genere e intellettuali progressisti,
non riescono nemmeno a scalfire la sua
grande sofferenza interiore per tutto
quanto ha passato. Anzi, proprio le
accresciute possibilità finanziarie (ma,
ripetiamo, niente in confronto a quello
che le sarebbe spettato) le offrono la
possibilità di acquistare droghe e alcolici
di prima qualità, con cui stordirsi, e
affetti umani tutt’altro che sinceri, a cui
legarsi. In proposito, ricorderè una più
che azzeccata battuta che Arsen Ostojić
e Ksenija Prohaska, nel loro atto unico
– “Billie Holiday” – allestito alcuni anni
fa con il TNC di Spalato, mettono in
bocca all’amico di Billie, Charly, il quale,
segretamente innamorato della cantante
di vent’anni più grande di lui, le dice in
un momento di rabbia: “E’ mai possibile
che ti innamori o ti metti sempre e
soltanto con persone sbagliate? E’ come se
andassi a comperare arance in un negozio
di ferramenta!?”.
Ebbene, sì’. Tutte le scelte affettive di
Billie sono un fallimento.
Infallibile intuito artistico
Non così, quelle artistiche. E’ vero che in
questo campo c’e’ chi la sa guidare, ma è
altrettanto vero che non di rado gli artisti,
più artisti sono e più si convincono di cose
che in seguito si riveleranno deleterie. E
invece, la Holiday non ne sbaglia una. Né’
quando si tratta di scegliere le orchestre,
né quando decide di farsi accompagnare
da combo, messi in piedi in occasione
di una registrazione: sa alla perfezione
da quali musicisti, solisti e strumentisti
farsi circondare, come pure a quali
arrangiamenti affidare.
L’esperienza di Alderton interrompe per
un breve periodo la spirale fatta di droghe
e alcol. Ben presto ci ricasca. Dopo un po’
sembra riprendersi e avviarsi a un nuovo
inizio, specialmente in seguito a due
tournee’s europee, in cui scopre di essere
famosissima e amata, e che il colore della
sua pelle non comporta negli interlocutori
nessun connotato negativo. Ma anche
questo stato di grazia dura poco: le é
sufficiente rituffarsi nella “sua” America,
che torna ad essere, al di là di tutto, una
musica
la Voce
del popolo
mercoledì, 24 aprile 2013
3
di Sandro Damiani
A STRAZIANTE SOLITUDINE
VOCE
A PASSIONE
IVANO ALL’ ANIMA
negra. Oltre tutto, vive accanto a un
uomo dalle mani bucate, che sperpera
anche quel non molto che le passano i
discografici. Ne è consapevole, d’altronde,
dice “sono stufa di passare le notti sola
con i miei cani in albergo, dopo un
concerto”. O peggio, farà capire, andare a
letto ogni sera con un uomo diverso...
Il suo sogno segreto
Tuttavia, non ha del tutto perso le
speranze di un domani migliore. In attesa
dell’uscita dell’autobiografia – siamo
nella seconda metà dei Cinquanta - e
convintissima che le porterà un guadagno,
confessa agli amici il suo più nascosto
desiderio: “Quando diventerò ricca mi
comprerò una grande casa in campagna,
così potrò adottare tanti bambini, di tutti
i colori; e preparerò loro da mangiare con
le mie mani, li accompagnerò a scuola, li
coccolerò; e mi circonderò di tantissimi
cani”...
Purtroppo, nel frattempo bisogna vivere,
e lei non ha mai imparato quest’arte.
Ripiomba nella droga. Riesce a malapena
a incidere altri due dischi (l’ultimo, “The
Last Recording” uscirà postumo); finisce
in ospedale, piantonata dalla Narcotici,
ulteriormente depressa dall’avvenuta
morte del suo più caro amico, il succitato
Lester Young, con cui aveva cantato
l’ultima volta l’anno precedente (il brano
“Fine and Mellow” è immortalato su
Youtube: con il suo sguardo tragico e
dolce puntato su “Prez”, mentre esegue
un assolo al tenore). Il 17 luglio del
1959, Billie Holiday si spegne a causa
di sopraggiunte complicazioni per
un’epatite.
I funerali saranno grandiosi. Vi
partecipano jazzisti di tutta l’America.
Testimoni oculari dicono che non c’era
un solo presente che non piangesse.Per
un paio di anni, i suoi dischi andranno a
ruba, poi il silenzio.
|| Billie Holiday agli inizi della carriera
Il revival con Diana Ross
Finché nel 1970 la più grande star del
pop afroamericano, Diana Ross, forte dei
milioni e milioni di dischi venduti e di una
straordinaria fama internazionale, non si
cuce addosso il personaggio di Billie nella
pellicola “Lady Sings the Blues”, regista
Sidney J.Furie. (Vi lavora pure Richard
Pryor). Il film è orribile, la Ross – che si
arroga il diritto di cantare, lei, i pezzi di
Billie - è inudibile: è come se Celentano
facesse un film sulla vita di Luciano
Pavarotti e ne cantasse le arie...
La comunità afroamericana, la pensa
diversamente, ma non la cittadella
del jazz... D’altronde, i Neri d’America
sono da poco usciti (e nemmeno tutti
e neppure ovunque) da uno stato di
semiclandestinità e di segregazione.
L’America bianca, a sua volta, ben sa di
cosa e quanto ha da farsi perdonare; e
Hollywood, meglio di altri. Sicché, nel
|| Lester Young, il migliore amico di Billie Holiday
1972 Diana Ross è Candidata all’Oscar,
quale migliore attrice protagonista (idem
dicasi per i BAFTA Awards britannici del
1974) e nel 1973 riceve il Golden Globe
come “Nuova migliore protagonista”; non
mancano altre Nomination...
Una leggenda che non smette di affascinare
Ma ciò che più importa, è che il film porta
a conoscenza dei giovani – di quei giovani
che non erano neppure nati quando lei
“imperversava”, o avevano pochi anni
- la vita e le canzoni di Billie Holiday.
Da allora, Lady Day non ha smesso di
incantare, affascinare, commuovere. E
tanta critica ha anche rivisto le proprie
posizioni rispetto alla Holiday degli anni
Cinquanta, quella che uscì da Aldrerson,
con una vocalità straziata e straziante,
assai meno mobile, ma con una punta di
tragicità sconosciuta nell’ambito canoro,
non solo jazzistico.
Da allora ad oggi, la “stella” di Billie
Holiday non ha smesso di brillare. Talune
sue interpretazioni sono state addirittura
utilizzate per uso commerciale, come
sottofondo musicale a prodotti di
bellezza di alta classe, Non c’è paese in
|| La copertina di “Strange Fruit”, il primo grande successo di Billie
cui la sua autobiografia (in verità, se
paragonata alle tante testimoniante di
chi l’ha conosciuta e amata, parecchio
spurgata, abbellita) non sia stata
ripubblicata varie volte. Comunque, non
c’è bisogno di conoscere la storia della
sua esistenza per commuoversi. Basterà
ascoltare alcuni brani, e non solo degli
ultimissimi anni – “I am Full to Want
you”, “You’ve Change”, “You don’t Know
what Love is” – ma anche i precedenti
“Solitude”, “God Bless the Child”, “Don’t
Explain”, “Fine and Mellow”...: altro che
groppi in gola...
4
lalaVoce
Voce
del popolo
del popolo
mercoledì, 24 aprile 2013
La personalità appassionata
di un gentiluomo della musica
Sergio Sablich è nato a Bolzano il 7
luglio 1951. I genitori, nati entrambi a
Fiume, avevano lasciato la città natale
nel 1945, dopo aver optato per la
cittadinanza italiana quando Fiume fu
ceduta alla Jugoslavia.
Nel 1952, la Famiglia si trasferisce a
Firenze, ma Bolzano resterà sempre
un punto di riferimento importante
nella vita di Sablich, che in età
adolescenziale trascorre a casa degli
zii a Bolzano buona parte delle
vacanze estive e natalizie.
Approfondita formazione musicale
Dopo la maturità classica si iscrive
alla Facoltà di Lettere & Filosofia
dell’Università degli Studi di
Firenze, dove nel 1976 consegue
la laurea, presentando una tesi in
Storia della musica dal titolo Il
“Doktor Faust “ nella problematica
teatrale e musicale di Ferruccio
Busoni. Contemporaneamente, si
diploma in composizione, musica
corale e direzione di coro presso il
Conservatorio “Cherubini” di Firenze.
Infine, all’Università di Monaco di
Baviera si perfeziona in Musicologia.
Dal 1976 è docente di ruolo di
Conservatorio per l’insegnamento
di Storia della musica ed Estetica
musicale e sceglie Bolzano, con
abilitazione all’insegnamento in
lingua tedesca, quale sede della sua
prima attività di docente, seguita da
Ferrara e dal 1989 da Firenze, dove
risiedeva.
Importanti incarichi direzionali
È stato per dieci anni (1976-1985)
direttore del Centro Studi Musicali
“Ferruccio Busoni” di Empoli;
dal 1986 al 1990, durante la
Sovrintendenza di Giorgio Vidusso,
assistente alla direzione artistica e
responsabile delle manifestazioni
promozionali e collaterali del Teatro
Comunale di Firenze e del Maggio
Musicale Fiorentino.
OMAGGIO A SERGIO SABLICH, SIGNIFICATIVO
MUSICOLOGO, SAGGISTA, CRITICO E ORGANIZZATORE
DELLA VITA MUSICALE DI ORIGINI FIUMANE, VENUTO
A MANCARE NEL 2005. PROPONIAMO DUE SUE
RIFLESSIONI, RISPETTIVAMENTE SU DALLAPICCOLA
E SUL RAPPORTO GLOBALIZZAZIONE-MUSICA
Dal 1991 al 1998 ricopre l’incarico
di direttore artistico dell’Orchestra
Sinfonica di Torino della RAI e
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI, dopo essere stato tra gli
artefici della riunificazione delle
quattro orchestre preesistenti in
un’unica orchestra, ma nel 1998 lascia
questo ruolo, pur con molti dubbi, per
seguire a Roma il Maestro Giuseppe
Sinopoli che lo invita a ricoprire
la carica di Sovrintendente della
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma,
incarico da cui si è dimesso nel 1999,
dopo molte amarezze e delusioni. A
cavallo tra il 2000 e il 2001 crea e
organizza il festival internazionale di
musica sacra “Anima Mundi” a Pisa,
su progetto ideato insieme a Sinopoli
ed a lui dedicato dopo la prematura
scomparsa del Maestro.
Sablich sarà poi Consulente per la
musica della Regione Toscana, e
dal maggio 2002 direttore artistico
dell’Orchestra della Toscana (ORT)
incarico che sarebbe terminato
nel mese di aprile del 2005, e
bruscamente interrotto il 27 gennaio,
giorno in cui è stato colpito da
ictus cerebrale. Nel febbraio 2003
era stato chiamato al Teatro La
Scala di Milano come consulente
artistico, esperienza rivelatasi
poi nefasta per la non chiarezza
e indifferenza degli interlocutori
coinvolti. Sablich ne soffrirà molto,
fino a parlare chiaramente, nei mesi
immediatamente precedenti la sua
malattia, di danni biologici legati al
malessere della vicenda Scala.
Critico, docente, autore di monografie
Sablich ha pubblicato, oltre a
numerosi saggi e articoli, studi e
monografie su Ferruccio Busoni (EDT,
1982), Wolfgang Sawallisch (Passigli
Editori, 1989), Richard Strauss (EDT,
1991), Richard Wagner (Il libro bruno,
Passigli Editori, 1992), Goffredo
Petrassi (Suvini Zerboni, 1994), Franz
Schubert (il volume L’altro Schubert,
EDT, 2002), Luigi Dallapiccola (L’Epos
di Palermo, 2004).
Ha collaborato inoltre alla “Storia
della Letteratura Italiana” Einaudi con
un saggio sui rapporti tra letteratura
e musica nel Novecento. Su questo
argomento ha tenuto dal 1996 al 1998
un corso biennale come professore a
contratto presso l’Università IULM di
Milano. Nell’anno accademico 20012002 ha insegnato Storia della musica
del Novecento come professore a
contratto presso l’Università di Pisa.
Ha svolto inoltre attività di critico
musicale, oltre che per “La Nazione”
di Firenze, per “Il Giornale” di Milano
e “La Voce” diretti da Indro Montanelli
ed ha collaborato con le principali
riviste musicali italiane.
Muore a Firenze, dopo 40 giorni di
coma, il 7 marzo 2005, all’età di 53
anni.
IL PERSONAGGIO
UNA SCELTA IN FAVORE DELLA MO
FOSSE ANCHE TESTIMONIANZA DI I
LUIGID
UN MUSIC
L
uigi Dallapiccola (1904-1975) è
stato, accanto al coetaneo Goffredo
Petrassi, non soltanto uno dei maggiori
compositori italiani del Novecento, ma anche
una figura di spicco della musica europea.
Porre l’accento sulla vocazione europea di
Dallapiccola significa anzitutto riconoscere
in lui un modello di apertura mentale e
di determinazione artistica nei percorsi
accidentati e nelle eclettiche vicende della
nostra epoca, e in secondo luogo inquadrare
la sua evoluzione nella progressiva conquista
di prospettive che, partendo da solide radici
culturali e umanistiche, ampliarono gli
orizzonti della musica italiana e indicarono
la via alle nuove generazioni, quelle, per
esempio, di Berio e di Nono, di Bussotti e di
Togni.
Non bisogna dimenticare che quando
Dallapiccola compositore si affacciò alla
ribalta, nei primi anni Trenta del Novecento,
l’Italia era ancora essenzialmente il “Paese
del melodramma”. Alcuni compositori della
generazione precedente, nati cioè intorno
agli anni Ottanta dell’Ottocento, come
Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti e
soprattutto i più giovani Gian Francesco
Malipiero e Alfredo Casella, verso i quali il
giovane Dallapiccola mostrò subito interesse
e ammirazione, avevano cercato di reagire
isolatamente a questa situazione di fondo,
elevando la musica italiana sul piano
culturale, rinnovandola e aprendola alla
civiltà europea. Comune a queste istanze di
rinnovamento era l’atteggiamento critico nei
confronti del melodramma ottocentesco - e
più in generale dell’Ottocento in quanto
secolo dominato in Italia dal gusto dell’opera
-, estremizzato nel rifiuto, che sarà poi netto
in Dallapiccola, se non del melodramma in
quanto tale, delle correnti che facevano capo
al Verismo e al Naturalismo della “Giovane
Scuola”. Parallelamente, la riacquisizione
e la rivalutazione del patrimonio musicale
antico - cioè preottocentesco - avevano
aperto la strada alla rivendicazione, anche
in senso orgogliosamente nazionalistico,
della grandezza della tradizione italiana
nel campo della musica strumentale. In
Dallapiccola, però, la convinzione che
la nuova musica italiana dovesse basare
la propria identità tanto sullo studio e
sull’insegnamento degli antichi maestri
quanto sull’assimilazione di condizioni
linguistiche ed esigenze artistiche
necessariamente mutate, saldava questo
recupero del passato con l’esplorazione
di insondati, originali terreni espressivi e
formali, non limitati al filone dominante
del “neoclassicismo”. La vocazione europea
di Dallapiccola, superando con fermezza
condizioni obiettivamente difficili, si
realizzò in una scelta di campo in favore
della modernità, nella quale l’opera del
compositore fosse anche testimonianza di
impegno civile e umano.
Prima ancora di compiere il passo decisivo
e definitivo dell’adozione della dodecafonia
come base del comporre (espressione
di una “nuova logica”, ma anche di uno
“stato d’animo” interiore), Dallapiccola
fu attratto in modo singolare dalle voci
più disparate della musica europea. In
Ferruccio Busoni, anch’egli figlio inquieto
della civiltà mitteleuropea, individuò il
modello ideale della ricerca illimitata e di un
fondamentale, lieto ottimismo. Finalmente
la conoscenza, nutrita di devozione, dei
musicisti della Scuola di Vienna - Arnold
Schönberg, Alban Berg e Anton Webern
la Voce
musica
del popolo
mercoledì, 24 aprile 2013
Il tramonto dell’Occidente segna la fine di un primato culturale
ODERNITÀ, NELLA QUALE L’OPERA DEL COMPOSITORE
IMPEGNO CIVILE E UMANO
DALLA PICCOLA
ICISTA EUROPEO
- ebbe sviluppi concreti e personali
nell’ambito della creazione, chiarificando
presupposti e sollecitazioni provenienti da
altri campi, soprattutto dalla letteratura, a
dimostrazione, scriverà Dallapiccola, che “il
problema attuale delle arti è uno solo”. E’
proprio nell’incontro con la letteratura che
la produzione di Dallapiccola, elettivamente,
quasi costituzionalmente vocale, sviluppa
per intero i suoi caratteri artistici e musicali,
favoriti da un talento tanto innato quanto
coltivato con ferrea autodisciplina. Tutti
questi elementi cementarono i tratti di una
personalità profondamente intrisa di valori
5
umanistici e di tensioni spirituali, di un
senso del dovere e della responsabilità
(evidente retaggio schönberghiano:
“l’arte non deriva dal potere, ma dal
dovere”) di intransigenza quasi morale,
di un impegno artistico approfondito nel
dubbio e nella solitudine e indirizzato
verso l’alto, che sottende, in una sorta
di illuminante vertigine visionaria, la
meta di un approdo trascendente. Ecco
perché attorno a Dallapiccola, musicista
di frontiera e del molteplice, è possibile
ricostruire uno dei percorsi principali,
luminosi, della musica del Novecento.
Un suono global o no global?
Globalizzazione, orrendo neologismo
caro ai nostri tempi. Anche Riccardo
Muti, durante una recente tournée in
Sud America con la Filarmonica della
Scala, l’ha usato per mettere in guardia
da un pericolo: la globalizzazione sta
invadendo anche la musica. Il termine,
par di capire, è usato nel senso di
appiattimento, standardizzazione,
normalizzazione, equalizzazione.
Attenzione, dice Muti (e naturalmente
non è il solo a pensarlo), a favorire
una tendenza nella quale l’immagine
esteriore, l’efficienza spettacolare,
prevalga decisamente sui contenuti
idiomatici, sulle identità nazionali,
sulle particolarità culturali: si corre il
rischio non soltanto di non apprezzare
più le differenze, ma anche di non
saperle più distinguere. E quindi di
uniformarsi a un modello unico la cui
sostanza è soprattutto brillante, vuota
apparenza.
Nella vita musicale corrente, teatrale e
concertistica, è ormai un luogo comune
sentir ripetere che le grandi orchestre
si assomigliano sempre di più, i
repertori sono ovunque gli stessi, gli
artisti – direttori, cantanti, registi –
passano disinvoltamente e
rapidamente da un continente
all’altro, offrendo qua e là le loro
lussuose prestazioni come pacchi
preconfezionati: una sorta di ditta
Gondrand della musica abbinata al
Concorde, impegnata a non perdere
un solo ordine, spesso noncurante
delle destinazioni e delle finalità
del trasporto. Il famoso villaggio
globale è una metafora che sembra
adattarsi anche alla musica. Ciò che
conta, in questo circuito impazzito,
è da un lato sopravvivere (alla crisi
economica, alla caduta vertiginosa del
mercato discografico, alle riduzioni
dei cachet), dall’altro mantenere le
posizioni acquisite, che significano
non solo privilegi ma anche danaro:
danaro come status symbol oltre che
come ricchezza reale. La forbice si
allarga: un concerto di una grande
orchestra europea o americana costa
mediamente fra i tre e i quattrocento
milioni, e tutti vogliono solo quello.
Con la differenza che la nozione di
grande orchestra si assottiglia sempre
più: pochi nomi, sempre quelli, a
rappresentare il banchetto ideale
dell’eccellenza. Niente che non fosse
stato previsto, da Adorno in giù,
con la logica dell’osservazione e del
ragionamento: solo che, una volta
caduti i principi ideologici (Adorno
descriveva una tendenza negativa
credendo così di combatterla), l’ipotesi
è divenuta realtà, quasi sottraendosi al
controllo del suo significato.
Ma il mondo globalizzato
dell’industria musicale è anche il
regno del paradosso, dove esiste
tutto e il contrario di tutto. È insieme
compresenza e annullamento delle
diversità, omologazione e separazione,
accettazione di facciata e rifiuto nella
sostanza. Tutto è possibile; il sistema
ingloba ogni espressione e la converte
in impulsi: i piani si confondono e un
valore economico sostituisce l’altro. Il
disorientamento da un lato, la delega
al demiurgo-divo osannato e richiesto
dall’altro, sono la fatale conclusione
del cammino. Proprio nel campo della
musica cosiddetta classica si assiste al
paradosso più stridente: la mancanza
di un ricambio del repertorio che
sia in grado di indirizzare questo
cammino verso una crescita continua
del nuovo. Le statistiche dicono che più
dell’ottanta per cento del repertorio
è costituito da musiche del passato:
globalizzate anch’esse dal mito
dell’interprete o dell’interpretazione.
La colonizzazione verso l’esterno passa
attraverso l’interprete, e, al suo interno,
dall’interpretazione che trasforma il
testo per attualizzarlo e rivenderlo a
usura con propaganda adeguata. Un
mostro che divora se stesso, sfruttando
tecniche e tecnologie sempre più
raffinate di autoconservazione. C’è poi
l’altra parte della musica, aggressiva
e creativa, nella quale culture e
tradizioni diverse s’incontrano per
inventare linguaggi scaturienti da un
tentativo di comprensione reciproca:
dove popolare implica un concetto
inedito di universale, che parte dal
basso. È quanto la musica colta
occidentale ha recepito nel Novecento
in regime di avanguardie, gettando
la spugna col dissolversi di una
tradizione eminentemente europea.
Il tramonto dell’Occidente segna la
fine di un primato culturale: forse ciò
che chiamiamo globalizzazione non
è che il tentativo di differire la fine
pretendendo di riscuotere gli interessi
materiali.
6
mercoledì, 24 aprile 2013
musica
la Voce
del popolo
VITA NOSTRA
SALVAREDALL’OBLIO
|| Benussi con il pittore Bruno Mascarelli
UNGRANDEPATRIMONIO
DICANTOPOPOLARE
D
ai “cantaduri” alla pagina scritta.
Eseguita, ascoltata e condivisa
da generazioni di rovignesi,
la particolare forma univoca di canto
polivocale che vede un cantante solista
accompagnato da altri “cantùri” che
imitano con la propria voce diversi
strumenti musicali, si presenta ora ai
lettori ed estimatori con il libro “∫i bitinàde
d’uca∫ion…”, scritto dal maestro Vlado
Benussi, uno dei più grandi cultori della
tradizione folcloristica e canora rovignese.
Insegnante fin dal 1972 di fisica ed
educazione musicale presso la scuola
elementare italiana “Bernardo Benussi”
dove cura pure il coro scolastico ed il
gruppo del dialetto rovignese nonché il coro
del Giardino d’infanzia italiano “Naridola”,
è non meno attivo alla CI. Prima corista
e poi dirigente per una ventina d’anni del
coro della SAC Marco Garbin, oggi dirige
i piccoli cantanti della Comunità con il
gruppo dei “Minicantanti” che fanno parte
del coro “Batanola”.
Di livello non minore è la sua carriera di
musicista e autore musicale, a partire dalla
prima canzone scritta ancora nel 1963
quando faceva parte del complesso “Le
perle” divenuto poi “I cannibali”. Nella
sua carriera musicale ha creato pure il
gruppo vocale le “Quattro colonne” e il
trio “Biba, Vlado & Ricky” mentre ora fa
parte del nuovo quartetto vocale “Monte”
e, assieme all’inseparabile moglie Biba e
ad Eligio Bosazzi ha ricreato un nuovo
trio. Prestigiosa pure la sua produzione di
canzoni per l’infanzia, testimoniata da più
di un centinaio di opere che hanno vinto
diverse edizioni del festival “Voci nostre”
organizzato dall’Unione Italiana, mentre
la “Barchetta di carta” ha vinto il secondo
posto all’edizione del 1993 dello “Zecchino
d’oro”.
Un discorso specifico riguarda la sua
produzione in dialetto rovignese, che vanta
ben nove raccolte di poesie, numerose
canzoni, alcune commedie musicali e
persino una raccolta a fumetti dal titolo
“Stuòrie”. Nel 2007 ha pubblicato il suo
primo libro intitolato “Viecia Batana”,
dedicato alla canzone simbolo e inno
della Città di Rovigno scritta da Giorgio
Devescovi su musica di Amedeo Zecchi nel
lontano 1907.
Ora è stata la volta di “∫i bitinàde
d’uca∫ion…” che rimarrà una pietra miliare
dell’opera di recupero della tradizione
canora rovignese.
Come si arriva a una pubblicazione di
questo genere?
Questo libro nasce dal mio desiderio
di catalogare tutte le canzoni che sono
state cantate in bitinade almeno nell’arco
del tempo che coincide con la mia
permanenza musicale tra le fila del coro
della Marco Garbin iniziata nel 1963
quando frequentavo ancora l’ottava classe
delle elementari. A farmi conoscere questo
mondo è stato mio zio Francesco Benussi
detto Chico. Ricordo che assieme a mio
fratello Libero già da piccoli abbiamo
imparato a cantare in famiglia a tre voci.
Sono sempre rimasto legato al coro anche
quando suonavo in Italia nel complesso “I
cannibali” e ogni volta che ritornavo nella
mia Rovigno, circa ogni 15 giorni, non
perdevo mai l’occasione di partecipare alle
prove. Il mio amore per il canto tradizionale
rovignese non poteva essere sostituito da
nessun’altra forma musicale, tanto era forte
il legame che avevo nei confronti della mia
città e della sua tradizione.
Cos’è una bitinada considerata dal punto
di vista musicale?
Si tratta di una forma di canto tipicamente
rovignese che prevede un solista o un
duetto che viene accompagnato da un
gruppo di “bitinadùri”, di solito formato
da una quindicina di persone che con la
proprie voci imitano gli strumenti musicali
di un’orchestrina. Questa forma di canto
è particolare perché i “bitinadùri” non
vengono suddivisi per voci come nelle
altre forme di canto corale, ma in modo
più spontaneo. Solo la sezione dei bassi è
obbligata e propone una struttura di basso
continuo che segue la melodia cantata
dai solisti, mentre un gruppo aggiunge
un sostegno armonico–ritmico imitando
i suoni della chitarra. La più grande
particolarità è data da quelli che mi piace
definire i tiratori liberi della bitinada che
devono eseguire i “tin – teîni” cioè quei
suoni che rimandano a strumenti come il
mandolino, la chitarra hawaiana, l’oboe,
il clarinetto e in passato anche la tromba
e la cornetta. Propri con i “tin – teîni”, i
“bitinadùri” danno il meglio di sé perché
ogni esecuzione è spesso irripetibile ed è
VLADO BENUSSI PRESENTA
IL LIBRO DEDICATO
ALLE BITINADE “∫I BITINÀDE
D’UCA∫ION…”
basata sull’improvvisazione dei cantori che si
completano a vicenda utilizzando la propria
bravura con una serie di canti e controcanti
unici nel loro genere.
In questo libro sono raccolte un centinaio di
canzone cantate in bitinada. Infatti, oltre a
quelle tradizionali ci sono anche evergreen
italiani e delle canzoni che lei ha composto
espressamente per questo tipo di canto. Che
particolarità deve avere una canzone per
essere cantata in bitinada e quali sono le più
famose?
Le più usate per il canto in bitinada sono delle
marcette o dei valzer più o meno veloci. La
maggior parte della bitinade è scritta da autori
anonimi e la più cantata è sicuramente “Vien
Fiamita” scritta da Carlo Fabretto nel 1908
che, come altre bitinade ha subito numerose
inflessioni sia nel testo che nella melodia. Di
questa canzone esiste anche una registrazione
che risale al 1942 quando venne usata
dall’Istituto Luce come sottofondo musicale per
il documentario “Boschi sul mar”. Tra i classici
italiani cantati in questo modo c’è “Sotto le
lenzuola” di Adriano Celentano che è stata
eseguita dal solista Guerrino Poropat e il motivo
napoletano “Santa Lucia” di Teodoro Cottrau
che è stato interpretato in modo magistrale dal
solista Antonio Bartoli e dal soprano Oriana
Vozilla. Da parte mia sono una decina le
bitinade che ho scritto nella mia carriera. Fra le
più famose è “A Figarola” dedicata ad una delle
isole dell’arcipelago di Rovigno e “∫i bitinàde”
che è una canzone autoreferenziale dedicata
alla bitinada che dà il titolo al volume e che ho
scritto, come le altre, in dialetto rovignese.
la Voce
del popolo
musica
di Sandro Petruz
|| In trio con Biba ed Eligio Bosazzi
|| Con il coro “Batanola”
Questo volume non è un semplice catalogo,
ma offre altre interessanti possibilità. Ci può
spiegare quali?
Nel libro stati anche inseriti gli accordi cifrati di
ogni canzone cantata in bitinada il che permette
così di fatto una maggiore divulgazione di
questa forma di canto. Inoltre, ogni coppia
include due compact disc in allegato. Il
primo contiene le 29 bitinade più famose e
rappresentative registrate in alta qualità il
secondo ben 75 registrate nel formato mp3. Il
volume ha anche una sezione dedicata ai più
grandi solisti che hanno intonato le bitinade.
Di ciscun interprete, oltre al nome e alla data
di nascita, viene riportato il soprannome della
famiglia nel dialetto istroromanzo locale. Tra i
più grandi cantanti del passato ci sono le voci
di Antonio Bartoli detto Cadìto, Liliana Budicin
Manestar (Streîsa), Tea Salvi (Iàie), Guerrino
Poropat (Salàta) e tanti altri. Le potenzialità
di questo libro sono già state dimostrate lo
scorso febbraio, quando l’ho presentato alle
consultazioni degli insegnanti di educazione
musicale delle scuole elementari presenti in
Istria. Grazie alle indicazioni del volume siamo
riusciti a riproporre le bitinade, nonostante per
la maggior parte dei presenti si trattasse della
prima esibizione da “bitinadùr”.
La ricca tradizione canora rovignese non è
formata solo da bitinade. Quali sono le altre
forme di canto tipiche della città di Santa
Eufemia?
I cantori rovignesi hanno una grandissima
dote che è l’armonizzazione spontanea. Si
dice che bastino tre rovignesi per avere un
coro. Infatti, la grande tradizione corale del
posto ha forgiato i “cantùri” che poi hanno
potuto attingere dalle particolari forme di
canto locale. La tradizione è stata tramandata
in forma quasi esclusivamente orale da
moltissimi secoli e le altre due forme tipiche
di canto rovignesi sono le ‘arie da nuoto’ e le
‘arie da cuntrada’. Le arie da nuoto rispetto
alle bitinade sono una forma di canto corale
dai contorni più classici, anche se differiscono
dei canti corali alpini o dalmati per il
tipico modo di cantare “in tiersa” in
modo da armonizzare con solo tre voci.
Sulle arie da nuoto mio fratello Libero
Benussi ha già scritto numerosi interventi
nelle pubblicazioni del Centro di ricerche
storiche di Rovigno che probabilmente
presto verranno raccolte in un volume
a parte. Le arie da contrada sono motivi
tipici interpretati a due voci da donne
in specie negli slarghi rovignesi mentre
erano intente a svolgere i lavori casalinghi
all’aperto. Un’altra caratteristica delle
arie da nuoto e da cuntrada rispetto alle
bitinade è che ci sono più testi scritti in
lingua italiana rispetto a quelli dialettali.
Alla realizzazione di questo volume
hanno partecipato diversi professionisti
che hanno voluto dare il proprio
contributo per rendere quest’opera
ancora più degna di nota. Ci può parlare
di queste collaborazioni?
Sono molto onorato delle partecipazioni,
questo volume, dalla pagina di copertina
che è stata impreziosita dall’affresco
“Pescatori Rovignesi” di Bruno Mascarelli,
pittore di fama internazionale che non
solo ha dato l’assenso all’utilizzo di una
delle sue opere, ma ha anche concesso
una dedica autografata, riportata su ogni
copia. Un grazie speciale all’amico collega
Massimo Brajković per la bellissima
prefazione e al vicesindaco Marino Budicin
per aver redatto il volume e curato
l’introduzione storica. Devo assolutamente
ringraziare la Città di Rovigno, il ministero
degli Affari esteri italiano e l’UI per
aver sostenuto il progetto. Non posso
dimenticare il contributo dello staff della
Comunità degli Italiani di Rovigno ma
soprattutto mi preme ringraziare la mia
famiglia per il supporto e la pazienza avuta
e che dovrà avere ancora perché sto già
lavorando al progetto legato alla tradizione
dei cori rovignesi.
mercoledì, 24 aprile 2013
7
DONNE IN MUSICA
|| Elisabetta Capurso
Dalla natia Mattuglie
all’Olimpo della musica
È nativa di Mattuglie Elisabetta
Capurso, pianista, compositrice,
musicologa, ed ha studiato pianoforte
con Carlo Vidusso, quindi con Carlo
Zecchi al Mozarteum di Salisburgo;
composizione con Domenico Guaccero,
quindi con Brian Ferneyhough a
Darmstadt. Ha studiato inoltre
Direzione d’orchestra con Daniele Paris
e composizione elettronica con Giorgio
Nottoli.
Si è laureata con lode in lettere
all’Università La Sapienza di Roma con
una tesi su Laborintus II di Luciano
Berio ed Edoardo Sanguineti.
Rinomata concertista
Concertista di livello internazionale,
con un repertorio che si estende
dalla musica di tradizione fino
alle espressioni più avanzate della
letteratura pianistica del Novecento,
ha suonato in sale prestigiose invitata
dalle maggiori associazioni italiane
e straniere, tra le quali Teatro Colòn
e Conservatorio Nacional di Buenos
Aires, Barbara Hall al Victoria
Memorial di Calcutta, Teatro Olimpico
e San Leone Magno di Roma, Teatro
Petruzzelli e Teatro Piccinni di Bari, RAI
Radiotelevisione italiana, Auditorium
Santa Cecilia di Roma.
Ha effettuato numerose registrazioni
di opere prime; per la RAI
Radiotelevisione italiana ha registrato
l’opera omnia pianistica di Anton
Webern. All’estero ha tenuto corsi di
interpretazione pianistica e stages
per le importanti Istituzioni dei paesi
toccati dalle tournées concertistiche: la
Chulalonkorn University di Bangkok,
l’Università della Musica di Rosario;
in Italia ha tenuto corsi di alto
perfezionamento per l’Accademia
Musicale Pescarese, per l’Arts Academy
di Roma. È stata invitata spesso a fare
parte di Giurie di concorsi nazionali ed
internazionali.
Scrittura contrappuntistica e comunicativa
Alterna l’attività di interprete con quella
di compositrice; presente ai Ferienkurse
di Darmstadt e nelle programmazioni
ELISABETTA CAPURSO,
ECCELSA PIANISTA,
COMPOSITRICE
E MUSICOLOGA
di note istituzioni come la Fondazione
Incontri Internazionali di Musica
contemporanea possiede una scrittura
compositiva caratterizzata da un
sapiente contrappunto e da una
notevole capacità comunicativa.
Le sue composizioni sono state
eseguite in Italia e all’estero: al terzo
programma della RAI, Radio Vaticana,
Festival Nuova Consonanza, Festival
Antidogma Musica Torino, Nuovi spazi
musicali, I corpi del suono di L’Aquila,
Stagione concertistica Internazionale
d’organo di Lecce, nei teatri delle
principali città dell’Argentina Cordoba,
Buenos Aires, nella Sala La Caturla del
Teatro Amedeo Roldan de La Havana
(Cuba).
Le sue opere sono pubblicate da
Edizioni Musicali Zanibon (Peters),
Edipan, AFM Accord for Music. Ha
registrato per Icons Antidogma Records
e per Radio Vaticana.
È presente nella Enciclopedia italiana
dei compositori contemporanei Pagano.
Docente a S. Cecilia
Direttore artistico dei corsi di
perfezionamento e del Festival Musicale
di Offida, tiene spesso dei seminari
in Università italiane e in alcune
Istituzioni musicali quali La Sapienza
di Roma, UCSA Roma; collabora,
inoltre, con varie riviste di musiche
contemporanee.
Già docente al Conservatorio G. Rossini
di Pesaro, è professore di pianoforte
principale presso il Conservatorio
S. Cecilia di Roma, dove tiene
anche i corsi di Semiografia della
musica contemporanea nel biennio
specialistico. Ha ricevuto premi e
riconoscimenti per gli alti meriti
artistici.
8
musica
mercoledì, 24 aprile 2013
VOCI STORICHE
la Voce
del popolo
L’AVVENTURUOSA VICENDA ARTISTICA DI TITO SCHIPA
UN WERTHER
FINORA
INSUPERATO
R
affaele Attilio Amedeo Schipa
nasce a Lecce, quarto figlio di una
famiglia modesta (il padre Luigi è
guardia daziaria) nel quartiere popolare
delle Scalze negli ultimi giorni del 1888,
ma viene iscritto all’anagrafe il 2 gennaio
89 per questioni di leva militare.
Il suo sovrannaturale talento vocale viene
notato immediatamente dal maestro
elementare Giovanni Albani poi da tutta
Lecce, per cui fu sempre “propheta in
patria”.
Con l’arrivo da Napoli del vescovo
napoletano Gennaro Trama (1902) vero
talent scout dell’epoca, l’avvio all’arte del
giovane talento, soprannominato ormai
“Titu” (piccoletto), è garantito con la sua
entrata in seminario, dove studierà anche
da compositore.
Il trionfo con Tosca
Dopo un adolescenza piuttosto agitata
nella sua città natale, dove dà prova, oltre
che del suo talento artistico, anche della
sua predisposizione all’avventura e alla
seduzione, su consiglio del suo miglior
maestro di canto, Alceste Gerunda,
Tito “emigra” a Milano per completare
gli studi con Emilio Piccoli e cercare
l’occasione di debutto (naturalmente a
pagamento) che avviene a Vercelli con
una Traviata (4 Febbraio 1909).
Il successo non è immediato (le
caratteristiche vocali del ragazzo sono del
tutto inconsuete per il pubblico medio
dell’epoca) ma la progressione è sicura
e costante, fino a che, dopo una lunga
routine di formazione nella compagnia
operistica di Giuseppe Borboni, culminata
a Roma per l’Esposizione Universale
del 1911, il primo trionfo lo aspetta a
Napoli nella stagione del 1914 diretta da
Leopoldo Mugnone, dove con una Tosca
leggendaria il nome d’arte “Tito Schipa”
si impone definitivamente alle cronache
artistiche e mondane.
Affermazione internazionale
Il successo lo porta subito in Spagna, e lo
spagnolo è la lingua più esemplare della
sua naturale predisposizione poliglotta
(ne parlerà correntemente quattro e ne
canterà undici compreso l’aborigeno
australiano più, come ripeteva, il
la Voce
del popolo
Anno 9 /n. 69 / mercoledì, 24 aprile 2013
IN PIÙ Supplementi è a cura di Errol Superina
[email protected]
Edizione
Progetto editoriale
Caporedattore responsabile
Errol Superina
Collaboratori
Sandro Damiani, Sandro Petruz
Foto
Sandro Petruz e archivio
MUSICA
Silvio Forza
Redattore esecutivo
Patrizia Venucci Merdžo
Impaginazione
Annamaria Picco
|| Nella parte di Werther
napoletano) il che lo aiuta a conquistare
con facilità il cuore degli spagnoli, orfani
del loro idolo, il tenore catanese Giuseppe
Anselmi.
Con una Manon del 14 Gennaio 1918
al Real di Madrid anche il primo trionfo
all’estero è assicurato.
Segue un periodo di viaggi tra la Spagna
e il Sud America, dove si gettano le
fondamenta di un lungo intenso rapporto
con il pubblico, specialmente argentino.
Ma la guerra, col pericolo dei sottomarini,
vede il giovane Schipa intentare e vincere
una causa con la sua agenzia artistica per
farsi riconoscere il diritto a non navigare
fino alla cessazione delle ostilità.
Il 1919 è l’anno dell’approdo negli Stati
Uniti, invitato dalla soprano Scozzese
Mary Garden e dall’impresario Cleofonte
Campanini, che insieme gestiscono la
Civic Opera di Chicago. Qui sposa la
soubrette francese Antoinette Michel
d’Ogoy, conosciuta a Montecarlo in
occasione della prima assoluta di La
Rondine di Giacomo Puccini, da cui avrà
due figlie, Elena e Liana.
Successi e intrighi americani
Questa volta è Rigoletto l’opera
del debutto trionfale a Chicago (4
Dicembre). Inizia per Tito Schipa
l’avventura statunitense, cominciata
come probabile successore di Caruso ma
in realtà definitasi come quella dell’AntiCaruso per eccellenza, che lo vede
tenore stabile di Chicago per 15 anni,
indi primo tenore al Metropolitan di
New York, ormai tra i più famosi e i più
pagati cantanti dell’epoca, specialmente
nella categoria del “tenore leggero” o
“di grazia” dove si assicura il titolo di
massimo interprete d’ogni tempo.
La permanenza e la quasi naturalizzazione
americana comportano, per il carattere
dinamico e curioso del soggetto, una serie
di coinvolgimenti artistici, mondani e
sociali di grande importanza e spesso di
grande rischio:
Progetta di scrivere un’opera-jazz
(quindici anni prima di Gershwin), si
avvicina al repertorio leggero spagnolo
e napoletano con risultati insuperati
nell’ambito tenorile (grazie anche alla
amicizia e collaborazione con gli autori
José Padilla e Richard Barthelemy), si
apre all’esperienza del nuovo cinema
sonoro diventando anche un più che
discreto attore di musicals (Vivere! del
1937 capeggerà il box-office italiano
sia con la pellicola stessa che con le
due canzoni di Bixio incluse, Vivere
e Torna piccina mia), si compromette
con i gangster di Al Capone venendone
classicamente prima ricattato poi
blandito, colleziona onorificenze e
riconoscimenti prestigiosi, tra cui la
Legion d’Onore francese, passa da
un’avventura sentimentale all’altra con
risultati disastrosi per il suo matrimonio,
e soprattutto guadagna cifre vertiginose
che sperpera con abilità diabolica,
rimbalzando continuamente dalla
classifica degli uomini più ricchi del
mondo a quella di bersaglio ideale per le
stangate di ogni tipo.
La seconda guerra mondiale e il suo
nuovo legame sentimentale con l’attrice
Caterina Boratto, che lo riavvicina
all’Italia, lo portano a coinvolgimenti
eccessivi con il regime fascista, soprattutto
per l’antica amicizia personale con Achille
Starace, suo conterraneo. L’America del
pre-maccartismo lo dichiara indesiderato,
e lo stesso fa l’Italia del Teatro alla Scala
appena restaurato e riaperto.
Un secondo inizio
L’opera di autocritica e di rigenerazione
è lunga e faticosa, ma a metà degli anni
‘40 il cinquantenne Tito Schipa è pronto
a ripartire per un’altra lunga fetta di
carriera che lo porta davanti ai pubblici di
tutto il pianeta con la sola esclusione di
Cina e Giappone.
Nel 1944 conosce l’attrice Teresa Borgna,
in arte Diana Prandi, che sposerà nel
1947 e da cui avrà Tito Jr.
Nel 1956 un invito a dirigere una scuola
di canto a Budapest lo porta per la
prima volta oltre cortina, esperienza
che culminerà con la presidenza della
giuria del festival della gioventù a Mosca
nel 1957. Le sue nuove simpatie per il
pubblico sovietico gli fruttano i sospetti
dei servizi segreti italiani, che gli dedicano
un fascicolo del SIFAR e boicottano il suo
progetto di aprire un’Accadenia di canto
in Italia sotto gli auspici del Quirinale.
Ritorno negli States
Accusato stavolta di filocomunismo,
vittima di gravi traversie economiche
e coinvolto in manovre poco chiare di
alcuni suoi manager e collaboratori, è
costretto a tornare negli Stati Uniti, dove
viene accolto, ancora una volta, con
entusiasmo.
La scuola di canto nasce a New York, ed
è mentre insegna canto che il diabete
contratto negli anni ‘40 lo porta a morte
il 16 dicembre 1965, settantasettenne,
dopo una carriera di 57 anni, del tutto
straordinaria in un cantante lirico per
lunghezza, varietà e glamour.
Specializzatosi in un repertorio
limitatissimo (segreto della sua
strabiliante longevità vocale) Tito Schipa
ha raggiunto i vertici della sua Arte nei
tre ruoli di protagonista di Werther di
Massenet, di L’Elisir d’Amore di Donizetti
e di L’Arlesiana di Cilea, in cui resta a
tutt’oggi insuperato e forse insuperabile,
oltre che nel repertorio classico della
canzone spagnola e napoletana.