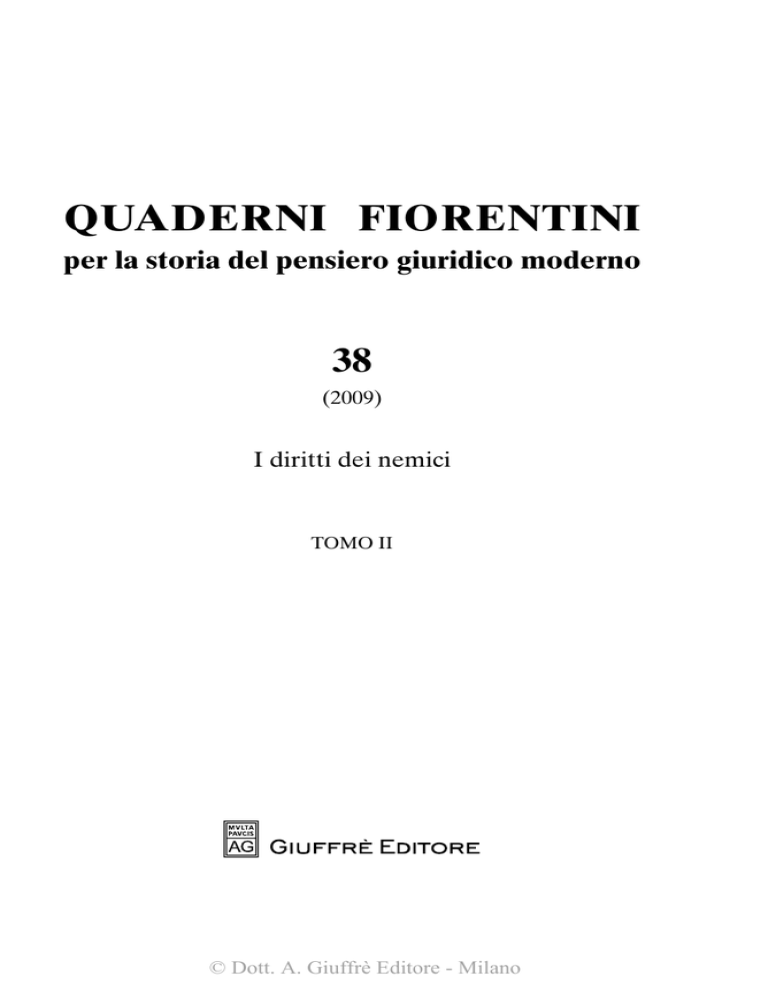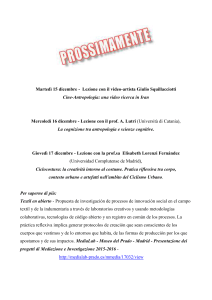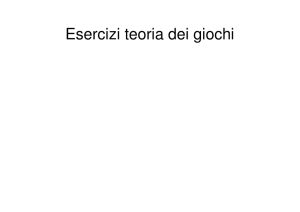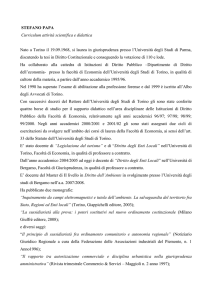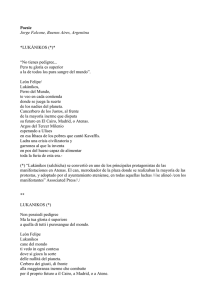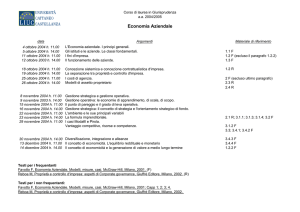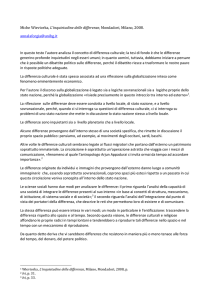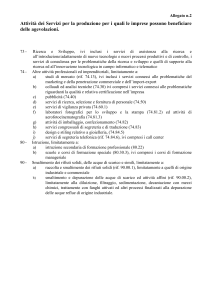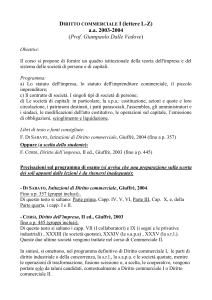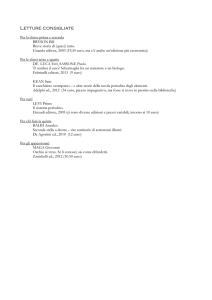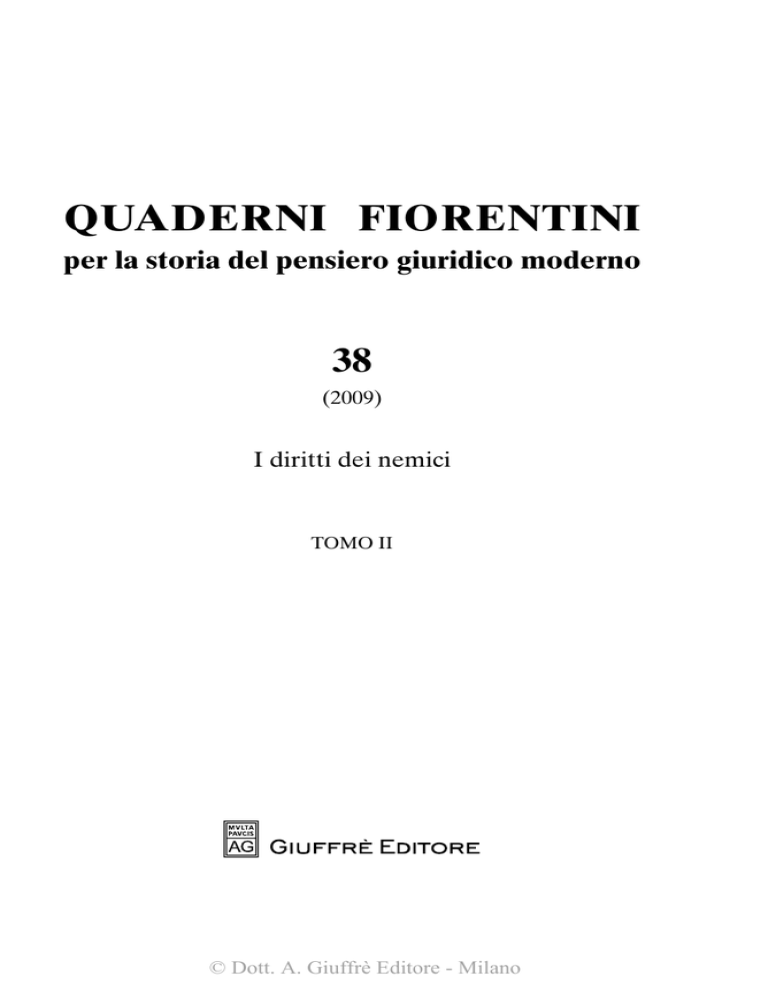
QUADERNI FIORENTINI
per la storia del pensiero giuridico moderno
38
(2009)
I diritti dei nemici
TOMO II
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
Letture
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
MARIO BERTOLISSI, GIUSEPPE DUSO, ANTONIO SCALONE (a cura di), Ripensare la costituzione. La questione della pluralità, Milano, Polimetrica, 2008.
L’idea di costituzione è, ormai da diversi anni, al centro di un
dibattito assai vivace. Se nel nostro paese, si lamenta sovente la pratica
di una costituzione « ferita » (1) o « aggredita » (2), più in generale e in
tutta Europa, ci si interroga sul futuro della costituzione e sulle sue
residue capacità normative (3), giungendo a denunciarne la progressiva
perdita di centralità come prodromo di quella pericolosa deriva definita
col nome di decostituzionalizzazione (4). Il motivo di tanta attenzione,
è noto, sta nelle profonde trasformazioni del presente. Due sono i poli
che delimitano lo spazio di riflessione nel quale anche questa raccolta di
scritti si colloca. Il primo è rappresentato dalla cosiddetta globalizzazione; il secondo dal processo costituente europeo.
Si tratta di due fenomeni che obbligano il giurista ad interrogarsi
sul significato e persino sul senso delle principali architravi concettuali
che hanno sostenuto il pensiero costituzionale negli ultimi tre secoli:
l’orizzonte obbligato dello Stato, la qualità specifica del potere sovrano,
il mito e la pratica della democrazia, il significato della rappresentanza.
Il pregio di questo volume è senz’altro quello di offrire una indagine a
tutto tondo, condotta con generosità, articolata su versanti molteplici.
Un’indagine che non scade mai nell’esegesi semantica e che, pertanto,
è capace di offrire al lettore spunti di riflessione non banali.
Il primo di essi, di spiccato interesse metodologico, mi pare essere
rappresentato — lo si afferma con esplicita ammissione di partigianeria
disciplinare — dal tentativo di delineare quello che Schiera definisce
« un percorso di “storia costituzionale” del “costituzionalismo” » (5).
(1) A. PIZZORUSSO, La costituzione ferita, Roma-Bari, Laterza, 1999.
(2) L. ELIA, La costituzione aggredita. Forma di governo e devolution al tempo della
destra, Bologna, Il Mulino, 2005.
(3) G. ZAGREBELSKY-P.P. PORTINARO-J. LUTHER (a cura di), Il futuro della costituzione, Torino, Einaudi, 1996 ma anche D. GRIMM, Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1991.
(4) A. BRANDALISE, Democrazia e decostituzionalizzazione in « Filosofia politica »,
3/2006, pp. 403 ss.
(5) P. SCHIERA, Tra costituzione e costituzionalismo (costituito e costituente).
Appunti sul mutamento costituzionale (ricostituente) in Ripensare la costituzione. La
questione della pluralità, a cura di M. Bertolissi, G. Duso, A. Scalone, Monza, Polimetrica, 2008, p. 79. Virgolette e grassetto sono dell’autore.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1830
LETTURE
Un percorso che individua cioè nella dimensione storico-concettuale un
portato indispensabile dell’analisi giuridica. Produrre una riflessione
che « abbia capacità innovative e sappia confrontarsi con la realtà
presente » (6) appare infatti possibile solo a condizione di non cedere
alla tentazione degli assoluti giuridici, procedendo invece per demitizzazioni e contestualizzazioni progressive (diacroniche e sincroniche).
Solo accettando pienamente, in definitiva, la categoria della Werdung
come coessenziale all’analisi costituzionalistica. Anzi, per dirla ancora
con le parole di Schiera, solo pensando la « Verfassung come Werdung » (7). A queste condizioni, e forse solo a queste condizioni, la
modernità cessa di essere una minacciosa spada di Damocle pendente
sopra le categorie dogmatiche per apparire invece effettivamente
« un’occasione felice per il pensiero » (8).
E quanto più sono vaste e fondanti le categorie con cui confrontarsi, tanta più onestà intellettuale serve all’odierno pensiero giuridico.
È il caso, ad esempio, della sovranità. Alla domanda più scontata, se
abbia ancora o no senso parlare oggi di sovranità, risponde efficacemente Troper: « la crise de la souveraineté ne signifie pas que le concept
ou le principe seraient devenus inutiles, mais bien au contraire qu’ ils
sont indispensables » (9). Crisi è una parola ambivalente: nell’alfabeto
cinese significa pericolo; ma anche opportunità. L’erosione del concetto
di sovranità, esasperato dalla liquefazione dei confini degli Stati nazionali, non comporta tuttavia la perdita di senso del concetto: ribadisce al
contrario, la ancora più urgente necessità di un « principe d’imputation » (10), elemento grammaticale fondamentale per la costruzione del
discorso giuridico, nonché, come sostiene con forza Carrino, unico
ormeggio possibile in grado di garantire oggi un ancoraggio democratico all’Europa nascente. Ma la necessità della sovranità come principio
di imputazione (democratico), non esime dal ripensare questo concetto.
Vi è un richiamo ricorrente in questa raccolta di scritti: quello che invita
ad abbandonare l’idea di una sola sovranità possibile, che poi sarebbe
quella costruita dalla tradizione europeo-continentale. Non tutte le
associazioni politiche nascono col sistema del new beginning tipico della
rivoluzione francese, ammonisce Fioravanti. Vi sono anche altre strade,
che procedono per via « incrementale » (11). Gli Stati Uniti ne sono un
(6) M. BERTOLISSI-G. DUSO, Ripensare la costituzione? La questione della pluralità
politica in Ripensare la costituzione, cit., p. 10.
(7) P. SCHIERA, Tra costituzione e costituzionalismo, cit., p. 88.
(8) M. BERTOLISSI-G. DUSO, Ripensare la costituzione?, cit., p. 10.
(9) M. TROPER, La souveraineté comme principe d’imputation, in Ripensare la
costituzione, cit., p. 77.
(10) Ivi, p. 61.
(11) M. FIORAVANTI, La forma politica europea in Ripensare la costituzione, cit.,
p. 33.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1831
LETTURE
esempio. Là la sovranità è da sempre incardinata su un doppio binario:
nazionale e federale. Non si tratta qui, naturalmente, di sostenere la
natura federale dell’Unione, ma di sottolineare la possibilità di pensare
la sovranità in maniera differente: non esclusiva, non assoluta. Priva
cioè di quel carattere della radicale indivisibilità che Bodin le attribuı̀
nel Cinquecento e che per secoli è sembrato rappresentare la vera cifra
della moderna idea del concetto: dirimente elemento di distinzione con
la tradizione medievale della costituzione mista.
È possibile allora pensare la sovranità senza riferirla necessariamente ad un sovrano? Lo è, ma la sfida del ripensamento critico va
accettata fino in fondo. Per accedere ad una diversa idea di sovranità,
infatti, occorre rimettere in discussione per intero tutto quel percorso di
fondazione che, a partire dalla Dichiarazione del 1789, ha costruito
l’unità politica moderna sulla base di un astratto e fittizio corpo
collettivo in nome del quale giustificare l’obbligatorietà della decisione
politica. Oggi, probabilmente, la spinta propulsiva di tale percorso
fondativo si è ormai esaurita (cosı̀ Lucien Jaume, ma anche Hasso
Hofmann), come testimoniato anche dalla presenza, accanto alla tradizionale legittimità statale, « des “revendications de légitimité” concurrentes, que nous appellerons “alterlégitimités” » (12).
Ma se è proprio il principale criterio di unità politica ormai a non
reggere più, allora è giocoforza riprendere le fila del discorso partendo
dalla pluralità, evidenziata dai curatori — che ne fanno esplicita menzione nel sottotitolo dell’opera — come vera chiave di lettura di questo
volume. E la questione della pluralità è effettivamente declinata in
numerosi suoi significati all’intero dei vari contributi: la pluralità di
opinioni politiche interna all’ordinamento incarnata efficacemente dalla
complessiva vicenda partitica, ad esempio, è tratteggiata abilmente nel
saggio di Scalone attraverso un confronto dialettico tra la dottrina
weimariana e quella del secondo dopoguerra; la pluralità di confessioni
religiose è invece descritta da Pin sotto l’interessante profilo del diverso
impatto che la Chiesa cattolica e l’Islam europeo hanno sul pluralismo
classicamente inteso; vi è inoltre la pluralità come dimensione interna
alle istituzioni, come forma di organizzazione del potere, che induce
Pasquino a sottolineare l’insostituibile ruolo della giurisprudenza all’intero dello stato costituzionale di diritto; fino a toccare quello che appare
il punto più delicato: la pluralità degli ordinamenti. È questa la frontiera
sulla quale, pressati dall’evoluzione del diritto comunitario e dal recente
tentativo di produrre una costituzione europea, è più necessario produrre un’altra idea di sovranità e un’altra interpretazione dell’unità
politica.
Sotto il primo profilo, si colloca la proposta interpretativa di
(12) L. JAUME, Défis et déficit démocratique: le revendications de légitimité, in
Ripensare la Costituzione, cit., p. 93.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1832
LETTURE
Fioravanti, secondo il quale la forma politica europea si è andata
costruendo attraverso un dialogo continuo tra le parti (gli Stati nazionali, la loro sovranità e i loro ordinamenti costituzionali) e l’intero
(l’Unione, l’ordine giuridico europeo e il suo diritto). Parti e intero
come due fuochi di un ellisse, come riferimenti geometrici indispensabili (entrambi indispensabili) alla costruzione dell’Europa politica. Ne
consegue pertanto che l’errore da non commettere è proprio quello di
considerare questo dialogo come meramente strumentale al raggiungimento di una qualche forma predefinita. È il dialogo infatti ad essere nel
senso più pieno del termine, costituente. Sembra evidente il nuovo
richiamo ad un’idea dinamica di costituzione, ad una costituzione intesa
come pratica. « La costituzione è l’uso che se ne fa » (13) afferma
suggestivamente Gangemi, richiamando Elazar. Se davvero il peccato
originale del costituzionalismo continentale è rappresentato dall’astrattezza di quel soggetto collettivo che permette di legittimare il comando,
allora evidentemente ogni soluzione che intenda uscire da questa
impasse non può che recuperare un’immagine di quel soggetto più
realistica: per scoprirlo per nulla unitario e astratto, ma decisamente
composito e concreto.
È per questa via che si giunge, almeno cosı̀ pare a chi scrive, alla
seconda urgenza: reperire una nuova formulazione per l’unità politica.
L’idea della pluralità non è infatti autosufficiente, ma è solo un corno
del dilemma. Guai a estrapolarlo dalla sua naturale collocazione: quella
che lo vede in continuo dialogo con l’altro polo, quello dell’unità. A ben
vedere, l’intera storia costituzionale moderna potrebbe essere letta in
questi termini: come un dialogo continuo (quasi un moto perpetuo) tra
unità e pluralità. Quale unità, dunque, per la forma politica europea?
La risposta che Gangemi e Duso sembrano offrire, è quella del federalismo. Naturalmente non inteso nel tradizionale significato di Stato
federale, ma piuttosto come pratica di governo (o governance che dir si
voglia) concreta, depurata dai formalismi e delle astrattezze. Come
tentativo di compensare la progressiva perdita di senso fatta registrare
dalla rappresentanza politica nelle democrazie contemporanee proprio
attraverso l’abbandono della rassicurante ma fittizia identificazione tra
governanti e governati, per approdare — attraverso la presa di coscienza di una effettiva alterità tra i due soggetti — ad una più concreta
ed effettiva partecipazione degli attori politici (individuali e collettivi,
pubblici e privati) al governo. Cosı̀ facendo, naturalmente, si perviene
ad un’unità politica affatto diversa da quella tradizionale: non cristallizzata, ma dinamica per definizione, in perenne equilibrio e, per ciò
stesso, in perenne movimento.
Una sovranità non assoluta ed un’unità politica da costruirsi dina(13) G. GANGEMI, Rappresentanza e partecipazione tra costituzione formale e costituzione materiale in Ripensare la Costituzione, cit., p. 176.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1833
LETTURE
micamente: queste le risposte che sembrano affiorare da questo volume
collettaneo che, pertanto, si colloca a pieno titolo nella tradizione
tracciata dalla riflessione costituzionalistica del secondo dopoguerra.
Del resto, una sovranità costituzionalmente limitata e la valorizzazione
del pluralismo non sono forse le due lezioni più importanti che abbiamo
appreso nel superare le dottrine dello Stato sovrano per approdare a
quelle della costituzione?
MASSIMILIANO GREGORIO
EMILIO GENTILE, Il fascino del persecutore - George L. Mosse e la
catastrofe dell’uomo moderno, Roma, Carocci, 2007, pp. 223.
1. Uno storico che racconta uno storico; non solo: uno dei massimi
storici del fascismo — Emilio Gentile — che ripercorre le tappe salienti
della vicenda intellettuale di un altro storico — George Lachmann
Mosse — che ha ugualmente dedicato la parte più rilevante del proprio
impegno scientifico allo studio dei totalitarismi del XX secolo (1). Per
Gentile, tuttavia, lo studio della riflessione mossiana non ha rappresentato né l’occasione per comparare la propria lettura del fenomeno
fascista con quella abbracciata dall’illustre amico e collega, né per
effettuare una ricognizione generale della storiografia sul fascismo.
Piuttosto, Gentile ha scelto di lasciar la parola a Mosse nel tentativo
(pienamente riuscito) di ricostruirne dall’interno la complessità dell’itinerario storiografico, anche al di là di eventuali divergenze interpretative. In particolare, mi sembra che l’esigenza, da cui nasce il libro, del
pieno recupero del messaggio mossiano sia originata dal bisogno di
riconoscere a Mosse il beneficio della complessità (almeno) su due
fronti, legati entrambi alla centralità del problema epistemologico, al
modo, cioè, con cui Mosse intendeva il mestiere dello storico. Anche
attraverso l’analisi di una cospicua mole di scritti inediti — appunti,
(1) Due precisazioni per il lettore; una di tipo meramente tipografico: nel testo si
sono usati due tipi di virgolette a seconda che i testi riportati siano quelle di Emilio
Gentile (in tal caso si è fatto ricorso a queste virgolette: « ») oppure di George Mosse
(in tal caso le virgolette usate sono queste: “ ”). Mentre le pagine citate nel testo della
recensione sono sempre quelle del libro di Gentile, libro cui si rinvia anche per
consultare l’utile nota bibliografica finale nella quale sono indicate le principali pubblicazioni di Mosse. L’altra precisazione attiene al modo con cui si sono utilizzati i termini
fascismo, fascismi, totalitarismo, termini cui si è fatto riferimento in una accezione
generica, chiamata a designare sia l’esperienza propriamente fascista — quella italiana —
sia quella nazionalsocialista. Per quanto attiene, poi, alle perplessità di Mosse relative alla
utilizzazione della stessa nozione di totalitarismo, v. infra note 17 e 37.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1834
LETTURE
testi di lezioni e conferenze — Gentile mira infatti a restituire i tratti di
un lavoro storiografico disposto a riflettere continuamente su se stesso,
ad assestare la propria traiettoria di indagine in seguito a un’ attività di
documentazione e ricerca aperta alle più varie sollecitazioni culturali. A
emergere — ecco il primo fronte del recupero — è insomma il ritratto
di uno ‘storico-storico’, di uno storico che ha verificato e approfondito
le proprie intuizioni interpretative, di uno storico quindi che non si è
limitato a sfruttare — da ebreo tedesco vissuto tra le due guerre
mondiali — esperienze e percezioni autobiografiche per tratteggiare il
volto del persecutore. « L’intreccio tra autobiografia e storiografia » (2)
che — nota Gentile — sorregge per intero la produzione mossiana, è
servito semmai a Mosse a portare avanti una scommessa epistemologica
di altro tipo, una scommessa — ecco il secondo fronte del recupero —
attraverso la quale egli ha mirato, pionieristicamente, a includere nel
campo documentario dello storico materiali che, negli anni Sessanta,
erano reputati di competenza esclusiva di altre discipline (sociologia,
antropologia, arte, letteratura).
Sotto un simile profilo, Mosse assunse consapevolmente le vesti di
“agente provocatore” (3) proprio perché ritenne che tali materiali non
dovessero servire soltanto a tornire o ad arricchire il discorso storiografico ma a definirne perimetro e intelaiature. Non sorprende dunque
che Mosse abbia deciso di entrare ufficialmente (4) nell’area degli storici
del totalitarismo pubblicando, nel 1957, uno studio sulle origini dell’antisemitismo moderno, studio nel quale ipotizzava l’esistenza di un
legame tra gli stereotipi antisemiti veicolati dai romanzi popolari tedeschi del XIX secolo e le successive manifestazioni antisemite del
nazionalsocialismo. Ed è un saggio, questo di Mosse, dal quale già
emergono con chiarezza alcuni tratti tipici della sua attività scientifica.
In primo luogo, emerge la centralità attribuita da Mosse alla storia della
cultura come varco privilegiato per la conoscenza storiografica. Anzi, da
un simile punto di vista, l’intero lavoro mossiano può esser letto,
secondo Gentile, come la progressiva messa a punto degli « strumenti
[…] di una nuova storia culturale » (5); nuova perché disposta a
includere tra le manifestazioni culturali di un’epoca anche quelle —
come il romanzo popolare — normalmente neglette per il loro modesto
spessore speculativo o artistico, ma nuova anche perché sorretta dalla
convinzione che la cultura identificasse un patrimonio complesso e
articolato di convinzioni e credenze, patrimonio che rappresentava, sı̀,
il frutto e il prodotto di un determinato contesto storico, ma che allo
(2 )
(3)
( 4)
fascismo
( 5)
E. GENTILE, Il fascino del persecutore, p. 10.
Ivi, p. 68.
Mosse — dice infatti Gentile — aveva prestato attenzione al problema del
fin dalla fine degli anni Quaranta, dedicando a esso lezioni e conferenze.
Ivi, p. 24.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1835
LETTURE
stesso tempo si mostrava capace di tornare a quel contesto, di reagire su
di esso contribuendo a formarlo e a orientarne gli svolgimenti (6). La
storia delle idee che proponeva Mosse non era dunque una storia
interessata a ricostruire il loro “valore intrinseco” (7), ma cercare “di
vedere in che modo, attraverso la formazione degli atteggiamenti, esse
penetrano nella realtà della storia”. (8)
Con alcune conseguenze rilevanti che Gentile mette bene in luce e
che rappresentano altrettante costanti della vicenda intellettuale mossiana, dai tardi anni Cinquanta alla morte, avvenuta nel 1999. Prima
conseguenza: l’interesse mostrato da Mosse — fin dagli scritti di esordio
sul Seicento inglese (9) — per stagioni storiche percorse da grandi
rivolgimenti socio-politici nasce dalla convinzione che i periodi di crisi
e di cambiamento non valessero soltanto a portare allo scoperto le
contraddizioni annidate nelle strutture di organizzazione sociale, politica o economica, ma costituissero anche una decisiva occasione di
confronto tra diverse concezioni del mondo, tra diverse, e diversamente
recepibili, immagini del futuro. Certo — affermò Mosse nel ’63, in una
conferfenza a Stanford che gli attirò non poche critiche — la “storia
delle idee di per sé, non può spiegare gli eventi in modo soddisfacente”;
ma neppure una indagine sulla sola “situazione sociale ed economica”
può dirsi sufficiente “perché gli uomini — proseguiva il Nostro —
erano e sono posti a confronto non con una sola opzione, ma con
diverse possibilità di scelta. Ed è a questo punto che il condizionamento
ideologico, e anche in condizionamento psicologico entrano in gioco,
procedendo insieme. E la gente si trova sempre di fronte a varie opzioni.
Cosı̀, anche se parlate degli eventi concreti, si pone sempre la questione:
perché la gente compie determinate scelte?” (10).
Altra conseguenza: affrontare un simile interrogativo era l’unico
modo che avrebbe consentito, secondo Mosse, di prender sul serio il
fascismo, di vedere in esso un “movimento serio di natura rivoluzionaria” (11). Solo tentando una contestualizzazione più ampia del fenomeno fascista, una contestualizzazione che fosse disposta ad avvicinar la
catastrofe chiedendosi, “senza timore né favore”, “come gli uomini del
passato intendevano il loro tempo” (12), diventava infatti possibile
(6) Ivi, p. 70.
(7) Ivi, p. 69.
(8) Ivi, p. 69; tra i tanti passaggi in cui si sottolinea questo profilo, v. anche ivi, p.
11, p. 70 e p. 41.
(9) Studi che furono volti soprattutto a indagare il problema della nascita della
sovranità e i rapporti tra cristianesimo e ragion di Stato (ivi, p. 18).
(10) Ivi, p. 69; sempre nello stesso senso, v. anche ivi, p. 29 e p. 90.
(11) Ivi, p. 64.
(12) Ivi, p. 11; pur consapevole che “la storia passata” fosse in fondo “sempre
storia contemporanea”, esposta, in quanto tale, alla individuale sensibilità dello storico,
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1836
LETTURE
spiegare le ragioni che avevano reso proprio l’Europa, la culla della
civiltà occidentale (13), lo scenario disposto ad allevare nel suo seno i
regimi fascista e nazista. Mentre se si continuava a forzare dati e
documenti nelle maglie di sistemi interpretativi precostituiti rispetto
all’oggetto specifico dell’indagine storiografica, non c’era alcuna speranza, per Mosse, di far convergere in un quadro interpretativo unitario
i due problemi capitali sollevati dal totalitarismo: il problema delle
masse e, ancor più, il problema del consenso di massa che i regimi
furono in grado di aggiudicarsi promuovendo una visione della politica
e del mondo che parve seducente e risolutiva a “milioni di italiani e di
tedeschi” (14); seducente perché sembrava rispondere tanto al bisogno
di un nuovo, e più profondo, « coinvolgimento emotivo nella collettività
della nazione o della razza » e risolutiva perché capace di dar seguito
all’altro e non meno forte desiderio di « ordine, stabilità, sicurezza » (15).
Critico, per tali ragioni, sia nei confronti delle interpretazioni
liberali e marxiste « unicamente concentrate sull’analisi della lotta
politica e della lotta di classe » (16), sia nei confronti di quelle letture
che, sottolineando, a seconda dei casi, la vocazione antiliberale (17),
antimarxista (18), o antidemocratica del fascismo, finivano per ricostruirne la fisionomia in termini meramente oppositivi rispetto a modelli
mutuati altrove, Mosse non nascose le proprie perplessità anche nei
Mosse riteneva tuttavia che lo storico dovesse sforzarsi di coltivare la “qualità” dell’
“empatia”nel tentativo, appunto, di avvicinare il passato dall’interno, assumendo il
punto di vista di coloro che si trovarono a viverlo (ibidem e anche ivi, p. 189).
(13) Ivi, p. 12.
(14) Ivi, p. 58.
(15) Ivi, p. 116.
(16) Ivi, p. 13; sempre per la critica a queste concezioni, v. anche ivi, p. 26.
(17) In questo senso Mosse si dichiarò contrario alla definizione di totalitarismo
fatta propria da Hannah Arendt, definizione che gli sembrò “una tipica generalizzazione
dipendente da un punto di vista liberale. Vediamo infatti che chi ne fa uso […] lo applica
a ogni cosa che sia contro le istituzioni liberal-parlamentari. Costoro mettono quindi
nello stesso mazzo comunismo e fascismo, Stalin e Hitler. Questa è una delle critiche che
io rivolgo al punto di vista liberale: esso adopera il concetto di totalitarismo come
un’etichetta buona per qualsiasi cosa sia antiliberale […]” (ivi, p. 43). Ugualmente
critico fu Mosse nei confronti della biografia di Mussolini scritta da Denis Mack Smith,
biografia nella quale lo storico inglese vide nel fascismo “semplicemente un metodo di
conquista del potere”, senza riconoscere a esso la capacità di elaborare una propria
visione del mondo. Una simile lettura, secondo Mosse, nasceva dal fatto che Mack Smith
« giudicava il fascismo dal punto di vista del liberalismo anglosassone » e “alla luce del
presente inglese” (ivi, pp. 111-112).
(18) Per queste ragioni Mosse contestò soprattutto la tesi di Ernst Nolte, su cui v.
ivi, p. 62 e p. 88.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1837
LETTURE
riguardi di quelle letture che, pur dando spazio alla storia delle idee, o
si arrestavano alla considerazione delle sole manifestazioni culturali
d’élite (19) o si mostravano “troppo propensi a valutare le idee sulla base
della loro immediata utilità e applicazione sociale” (20) senza vedere in
esse altrettanti fattori capaci di condizionare e determinare il corso degli
eventi. E se il rigetto delle letture del primo tipo condusse Mosse a
tessere « l’apologia della storia dei fatti » (21), la critica delle concezioni
correnti di storia culturale portò invece Mosse a sostenere il « primato
dell’ideologia » (22), intesa quest’ultima, come realtà multiforme, poliedrica, largamente – anche se spesso sotterraneamente — circolante e
capace, in quanto tale, di definire lo “Zeitgeist” (23), lo spirito complessivo di un’epoca.
2. Da un simile punto di vista — nota Gentile — la scelta di
avvicinare il problema del nazionalsocialismo attraverso uno studio sul
romanzo popolare, rappresentava un segnale netto lanciato alla comunità degli storici (24). Solo accettando di chinarsi sulle manifestazioni di
cultura popolare diventava infatti possibile entrare in contatto col volto
più autentico di regimi, come quelli di massa, che vollero e seppero
rivolgersi (anche) a uditorii non elitari. Senza che questo, tuttavia —
ecco un’altra, importante, conseguenza messa in luce da Gentile —
servisse a creare un circuito interpretativo di segno opposto ma ugualmente semplificante, un circuito, cioè, orientato a creare una corrispondenza diretta, lineare, tra cultura popolare, ‘incultura’ delle masse e
successo dei regimi totalitari. Non meno viziate da intellettualismo
infatti parevano a Mosse quelle letture propense a veder nelle masse
solo un coacervo di pulsioni elementari, manovrabili a piacimento dalla
abilità demiurgica dei nuovi capi carismatici (25). Certo, le masse
dovevano rappresentare la nuova e necessaria unità di misura del
discorso storiografico sul XX secolo, ma doveva trattarsi — questo il
(19) Queste invece le ragioni — dice Gentile — che portarono Mosse a criticare
la concezione di storia delle idee abbracciata da Lovejoy, Croce e Hughes (ivi, p. 35).
(20) Ivi, p. 36, ma anche p. 32.
(21) Ivi, p. 21.
(22) Ivi, pp. 26 ss.
(23) Ivi, p. 33.
(24) In questo articolo del 1957 — afferma infatti Gentile — « Mosse analizzava
per la prima volta la dimensione ideologica non nella forma tradizionale del pensiero
politico o religioso elaborato da studiosi laici e teologi, ma come luogo di produzione e
di diffusione di stereotipi e di atteggiamenti attraverso romanzi di modesta qualità e
molto popolari » (ivi, p. 30).
(25) Costante fu la critica di Mosse nei riguardi di quelle letture volte appunto a
legare il successo dei fascismi alla pura e semplice manipolazione delle masse operata dai
dittatori; sul punto, v. ivi, p. 28, p. 63 e pp. 112-113.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1838
LETTURE
punto — di una unità di misura composita che comprendesse al suo
interno l’analfabeta come il premio Nobel (26). La cultura di massa,
dunque, non descriveva solo la sub-cultura degli illetterati, ma diveniva
il sinonimo di una realtà radicale e diffusa capace di permeare di sé un
intero contesto, contesto che allo storico spettava di ricostruire attraverso l’esame delle manifestazioni più disparate (anche quelle meno
auliche) nel tentativo di comprendere le ragioni che a un certo punto
valsero a rendere accettabile, ‘normale’, il discorso politico nazi-fascista.
A dover essere indagato era insomma quel complesso universo simbolico fatto di miti, stereotipi, stati d’animo che agli occhi di Mosse svolse
un ruolo decisivo nel determinare il fascino che il persecutore esercitò
su quelli che “chiunque avrebbe potuto considerare ottimi vicini di
casa” (27). Non si trattava, come qualcuno gli rimproverò, di aprire la
ricerca storica a campi “stravaganti”, se era vero che niente era più
“stravagante — a esempio — dell’idea di ebreo e di ariano che avevano
i nazisti”; eppure — le parole sono sempre di Mosse — “queste idee
non sembrarono per nulla assurde a molti rispettabili membri della
società, i quali le abbracciarono” (28). Ma non si trattava neppure di
inneggiare alla potenza dell’irrazionale, semmai si trattava di riconoscere (anche) al sostrato emozionale di un’epoca la capacità di incidere
sul corso degli eventi, con una ulteriore e importante conseguenza, ben
messa in luce da Gentile, e coinvolgente il problema delle origini dei
fascismi.
Problema che — nota Gentile — giocò un ruolo decisivo specialmente nella prima stagione della storiografia mossiana sul fascismo,
stagione — compresa tra il 1957 e il 1966 (29) — nella quale Mosse
« po[s]e i pilastri fondamentali della sua interpretazione, concentrata
soprattutto sul problema della ideologia e della cultura » (30). Al centro
di questa stagione sta la pubblicazione, nel 1961, de La cultura dell’Europa occidentale nell’Ottocento e nel Novecento, libro che, secondo
Gentile, costituisce « un originale e valido tentativo di fornire una
visione complessiva dei principali movimenti culturali e politici che
avevano dominato nella società europea dall’inizio dell’Ottocento alla
prima metà del Novecento » (31). Pur non trattandosi di un’opera
espressamente dedicata al problema del fascismo, tuttavia da essa
traspariva con chiarezza l’esigenza di far luce su tendenze e movimenti
(26) Ivi, p. 46; “due premi Nobel — disse Mosse — erano accesi nazisti” (ibidem).
(27) Ivi, p. 73.
(28) Ivi, p. 31.
(29) Cioè tra l’articolo sulle origini dell’antisemitismo moderno, appunto del
1957, e il libro, edito nel 1966 a New York e intitolato Nazi Culture. Intellectual Origins
of the Third Reich.
(30) Ivi, p. 60.
(31) Ivi, p. 41.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1839
LETTURE
che, nati e sviluppatisi precedentemente alla affermazione dei fascismi,
ebbero, secondo Mosse, un ruolo decisivo nel fertilizzare il terreno sul
quale essi poterono attecchire. La cultura dell’Europa occidentale –
afferma Gentile — costituı̀ una tappa centrale del lavoro mossiano,
proprio perché in esso si approfondivano posizioni già espresse in
precedenza ponendo le basi per successivi e ulteriori sviluppi interpretativi: dal saggio del 1957, dedicato alle origini dell’antisemitismo, nel
quale Mosse aveva sostenuto come lo stereotipo antisemita fosse già
vecchio di “di più di un secolo” (32) quando Hitler prese il potere, per
passare a uno scritto del 1973 orientato a richiamar l’attenzione sul
ruolo specifico giocato dal nazionalismo “come movimento di massa,
basato sulla trasformazione della folla in una congregazione”, come
movimento, cioè, che nacque e si sviluppò in stretta relazione con
“l’impulso democratico” tipico del XX secolo (33), per arrivare fino al
1980, a L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, libro nel quale
Mosse arrivò a scorgere proprio nella “mancanza di idee originali” uno
specifico punto di forza dei totalitarismi. (34)
Convinto che non fossero nè il segno di una storia improvvisamente
imbizzarrita, né il frutto esclusivo del trauma prodotto dalla Grande
guerra (35), Mosse ritenne che i fascismi rappresentassero piuttosto “il
culmine di molti abiti mentali che si erano formati dopo il romanticismo” (36), che rappresentassero, cioè, l’esito possibile, anche se non
inevitabile (37), di una crisi della cultura europea che aveva avuto la sua
manifestazione più evidente negli anni finali dell’Ottocento, anni che,
essendo caratterizzati da « un più accelerato dissolvimento delle cer(32) Ivi, p. 31
(33) Si tratta di Mass Politics and the Political Liturgy of Nationalism, in Nationalism, The Nature and the Evolution of an Idea, a cura di E. Kamenka, Camberra 1973 (le
citazioni riportate sono leggibili nel testo di Gentile rispettivamente a p. 101 e p. 100).
(34) “La mancanza di idee originali — cosı̀ appunto Mosse nella introduzione a
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste — non fu uno svantaggio [per il fascismo],
come hanno fatto credere molti storici, in quanto l’originalità non porta al successo in
un’epoca di politica democratica di massa. La sintesi che il fascismo provò ad attuare fra
attivismo e ordine, tra rivoluzione e l’assorbimento delle tradizioni del passato, si rivelò
eccezionalmente riuscita”: il fascismo fu, da un simile punto di vista, un “organismo
saprofago, che cercò cioè di appropriarsi di tutto ciò che tra l’Ottocento e il Novecento
aveva affascinato la gente: romanticismo, liberalismo e socialismo, come pure del
darwinismo e della tecnologia moderna. Si è prestata pochissima attenzione a questa
azione di recupero, che era stata sussunta nel cosidetto eclettismo fascista” (ivi, p. 120).
(35) Ivi, p. 57.
(36) Ibidem.
(37) Ivi, p. 62 e p. 72, sede nella quale Mosse contesta l’idea di un Sonderweg
tedesco che attraverso l’ideologia völkisch avrebbe reso possibile individuare una linea
unica di sviluppo « da Lutero a Hitler ».
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1840
LETTURE
tezze dell’uomo moderno » (38), concorsero ad allevare i germi della
futura soluzione totalitaria. Dal punto di vista di Mosse — a dirlo è
sempre Gentile — romanticismo, nazionalismo e, per il caso tedesco,
razzismo, costituirono altrettanti movimenti culturali che « influenzandosi e mescolandosi tra di loro [contribuirono] a preparare la via al
totalitarismo anche se nessuno di questi movimenti era un blocco unico
ed omogeneo esclusivamente orientato a sacrificare l’individuo alla
collettività » (39). La prima guerra mondiale, in un simile quadro, giocò
un ruolo importante nel rendere particolarmente accattivante, tra le
tante praticabili, proprio la soluzione totalitaria (40): io “penso” infatti
— le parole sono sempre di Mosse — “che, in una situazione difficile,
queste immagini [che gli uomini si formano della realtà] sono esasperate in una sorta di desiderio di appagamento completo, in una fuga
dalla realtà, in un volo nella metafisica” (41).
(38) « Nuove teorie scientifiche, dal principio di indeterminazione alla teoria della
relatività, disgregarono la visione illuministica e positivistica di un universo retto da leggi
fisse e immutabili, mentre la scoperta dell’inconscio, la psicoanalisi […] minarono alla
base la fiducia nella razionalità umana e nel progresso regolato dalla crescente espansione del dominio della ragione sulle passioni » (ivi, p. 50).
(39) Ivi, p. 48.
(40) “Il fascismo, in quanto concreto movimento storico, è stato il prodotto della
prima guerra mondiale e questo dato di fatto — cosı̀ Mosse — è stato usato o per negare
o per sopravvalutare i suoi legami con il passato prebellico […] Il fascismo viene in tal
modo strettamente collegato alla sua epoca, cioè all’Europa tra le due guerre. Questo
punto di vista non vuole essere un’apologia del fascismo, ma in realtà cerca di dare a quel
movimento la sua fisionomia, e lo considera come una risposta diretta a una particolare
situazione storica. Vi è parecchia verità in questa analisi, perché il crollo dell’Europa
dopo la guerra fu una componente essenziale del fascismo e diede una grande efficacia
alla sua forza d’attrazione popolare. Eppure, malgrado ciò, tutti questi storici ignorano
il fascismo in quanto movimento di massa, e anche in quanto democrazia di massa,
fenomeni che avevano una lunga storia dietro di sé prima che i nazisti e gli altri fascisti ne
facessero buon uso. In realtà, a questo riguardo, il concetto di totalitarismo è stato
distorcente, perché esso implica l’uso del terrore sulla popolazione (una nuova versione
della più vecchia teoria dell’occupazione) e un rapporto diretto tra capo e popolo. Esso
si basa sul presupposto che solo il governo rappresentativo può essere democratico […]
Perché furono proprio i miti e i culti dei primi movimenti di massa che diedero al
fascismo una base dalla quale operare e lo misero in grado di rappresentare un’alternativa alla democrazia parlamentare. Milioni di persone videro nelle tradizioni di cui
parlava Mussolini una possibilità di partecipazione politica più vitale e significativa di
quella offerta dall’ideologia borghese della democrazia parlamentare, e questo poté
succedere solo perché esisteva una lunga tradizione, rappresentata non solo dai movimenti di massa nazionalisti, ma anche dai movimenti di massa dei lavoratori” (ivi, pp.
104-105).
(41) Ivi, p. 61.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1841
LETTURE
Lo studio della cultura, quindi, intesa come “stato o abito mentale
incline a diventare un modo di vivere intimamente legato alle sfide e ai
dilemmi della società contemporanea” (42) non aveva solo portato Mosse
a collocar più indietro le origini del fascismo, ma gli aveva soprattutto
permesso — nota Gentile — di riportare il fascismo nell’alveo complessivo della modernità, di una modernità che, ai suoi occhi, si spiegava
soprattutto sul piano antropologico, sul piano, cioè, della immagine che
l’uomo coltivava di se stesso e del proprio futuro. Coi fascismi che riuscirono a guadagnarsi un seguito importante proprio perché promisero
di porre fine a quel senso di alienazione e di precarietà dolorosamente
sperimentato dall’uomo moderno (43), e di porvi fine attraverso una promessa (non nuova) di integrazione in dimensioni superindividuali, promessa che però venne declinata sulla base di una peculiare concezione
della nazione (o della razza), come dimensioni capaci di esprimere una
“realtà più autentica [e] genuina” (44) e di realizzare, cosı̀, una fusione
integrale tra individuo e collettività.
Ma questa storia intesa come “antropologia culturale retrospettiva” (45) — nota Gentile — conduceva Mosse a estendere in direzioni
ulteriori il problema del fascismo, o, per dir meglio, i problemi sollevati
dallo studio del fascismo: se infatti l’intera modernità imponeva allo
storico il confronto col volto di un uomo scisso tra desiderio di
autonomia e ricerca di autorità (46), il patrimonio simbolico promosso
e utilizzato dai totalitarismi esprimeva solo una delle variabili storicamente possibili e sperimentabili per (ri)costruire l’identità individuale e
collettiva. Sotto un simile profilo, il ricorso a miti e stereotipi, l’esigenza
di definire in positivo una realtà attraverso la creazione (e la stigmatizzazione) della diversità, del “controtipo” (47), rappresentava una insidia
costitutiva della modernità, anche di quella precedente e successiva alla
stagione totalitaria. “Chiaramente — notava Mosse — quanto più la vita
nella società industriale si andava razionalizzando, tanto più la gente si
rifugiava in un irrazionalismo che le dava sicurezza e poteva dare un
senso al mondo minaccioso della modernità”. (48)
Sotto un simile profilo, il successo dei fascismi nasceva, per Mosse,
soprattutto dalla capacità che essi mostrarono nell’attingere a un patrimonio di credenze in gran parte preesistente alla loro comparsa sulla
scena politica europea e di trasformarlo in strumento concreto di
organizzazione del potere e delle relazioni tra individuo, collettività e
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
Ivi, p. 39.
V., tra i tanti luoghi in cui ricorre una simile lettura, ivi, p. 57.
Ivi, p. 48; v. anche, tra i molti esempi possibili, ivi, p. 77.
Ivi, p. 39.
Ivi, p. 17.
Ivi, p. 139.
Ivi, p. 103.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1842
LETTURE
Stato. Riconoscere ai totalitarismi del XX secolo una « individualità
storica » (49) positiva e costruttiva sul fronte culturale non significava
infatti per Mosse ricercare i contorni di sistemi ideologici nuovi,
conclusi e concludenti (50); significava piuttosto addentrarsi nello specifico, e questo sı̀ originale, processo di trasfigurazione che alcune idee
già circolanti subirono al contatto con la peculiare promessa di riscatto
portata avanti da tali regimi.
3. Ed è proprio l’indagine sul lato squisitamente costruttivo della
politica fascista e nazionalsocialista che occuperà la seconda parte della
storiografia mossiana, quella che — secondo la datazione di Gentile —
copre gli anni tra il 1969 e il 1979, anni nei quali « il problema centrale
della sua analisi del fascismo diviene [proprio] la politica di massa, con
una ridefinizione del concetto di cultura intesa come concezione della
totalità della vita espressa attraverso miti, riti e simboli, in cui acquista
importanza decisiva la rappresentazione estetica » (51). Fino a quel
momento infatti — prosegue Gentile — Mosse « aveva svincolato il
concetto di ideologia dalla sua identificazione con il razionalismo
teorico, dando importanza storica all’irrazionalismo di correnti di pensiero che la storiografia tradizionale aveva considerato appartenenti ad
una sfera sub intellettuale, indegna di seria considerazione; tuttavia la
sua analisi era rimasta comunque limitata alle forme di espressione
verbale dell’ideologia […]. In tal modo, però egli dovette rendersi
conto che un aspetto cospicuo e importante del fascismo, cioè il suo
apparato rituale e simbolico, le cerimonie di massa e la rappresentazione dell’ideologia attraverso l’estetica piuttosto che la teoria, rimanevano ai margini della sua interpretazione culturale. […]. Certamente
Mosse non aveva ignorato questo aspetto nei suoi precedenti scritti sul
(49) Ivi, p. 116.
(50) “Il pensiero politico fascista e nazionalsocialista — cosı̀ Mosse nel 1975 in La
nazionalizzazione delle masse — non può essere giudicato in termini di tradizionale teoria
politica; esso ha poco in comune con questi sistemi razionalmente e logicamente
costruiti, ipotizzati da Hegel o da Marx. È un fatto che ha dato da pensare a molti
studiosi i quali, nell’analizzare il pensiero politico fascista, ne hanno condannato la
indeterminatezza e le ambiguità. Ma gli stessi fascisti parlarono del loro pensiero politico
più come di un atteggiamento che come di un sistema, ed esso infatti era una teologia che
offriva una cornice al culto nazionale. In quanto tale, i suoi riti e le sue liturgie erano la
parte centrale, essenziale, di una dottrina politica, che non si appellava alla forza
persuasiva della parola scritta. […]. La parola detta si integrava con i riti cultuali e, in
realtà, quello che veniva detto finiva per diventare meno importante dello scenario e dei
riti che facevano da contorno al discorso” (ivi, p. 103-104).
(51) Ivi, p. 60. Al centro di questa seconda stagione degli studi di Mosse stanno
la pubblicazione, nel 1975, de La nazionalizzazione delle masse e la seconda edizione de
La cultura dell’Europa occidentale, del 1974.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1843
LETTURE
fascismo, ma aveva interpretato i riti, i simboli, le cerimonie di massa
essenzialmente come strumenti machiavellici del potere, come tecniche
di dominio usate dai governanti per sedurre e controllare le masse. In
questo modo, Mosse aveva utilizzato concetti come manipolazione,
propaganda, tecnica di potere che erano tipici della storiografia pragmatica, da lui sempre criticata. Su di essi, inoltre, di fondavano le
interpretazioni del fascismo come rivoluzione del nichilismo, che egli
contestava vivacemente, perché impedivano di capire la vera natura del
fascismo come sistema di potere ispirato e condizionato da un genuino
sistema di credenze, e riducevano il ruolo dell’ideologia ad un mero
strumento usato dai capi per manipolare le masse ». (52)
Sulla scorta di nuove letture storiche e antropologiche (53), Mosse
ritenne quindi che l’attenzione prestata al ruolo e al valore delle
“pratiche e dei sentimenti popolari” (54), sarebbe riuscita a spiegare
adeguatamente la capacità mostrata dai regimi nel razionalizzare l’irrazionale (55), la capacità di collegare “l’arte di governo alle sorgenti
irrazionali dell’azione umana” (56), attingendo, a tal fine, a un patrimonio di “miti e simboli familiari e fondamentali” (57). I nuovi apparati
liturgici cui ricorsero i regimi svolsero dunque un ruolo decisivo: perché
permisero di collegare questi miti a quella (autentica) ansia di integrazione e partecipazione espressa (anche) dalla società primo-novecentesca, ma soprattutto perché permisero di convogliare stereotipi e atteggiamenti già esistenti all’interno della specifica ricetta fascista di riscatto
individuale e collettivo. Anzi, il richiamo alla tradizione e — direi, la
stessa creazione della tradizione — “contribuı̀ a forgiare gli stereotipi in
base ai quali venne definito il modello ideale di una comunità nazionale,
[appunto] rigenerata attraverso il rinvigorimento delle sue radici storiche e sottratta alla corsa precipitosa del tempo e al ritmo frenetico della
modernità » (58).
(52) Ivi, p. 83.
(53) Da Cassirer a Levy Strauss, dal Russeau che si era occupato delle feste
civiche, agli studi di Talmon sulla democrazia totalitaria fino a l’Huizinga de L’autunno
del Medio evo (v. ivi, pp. 89-96).
(54) Ivi, p. 89.
(55) Ivi, p. 84.
(56) Ivi, p. 58.
(57) Ivi, p. 89.
(58) Ivi, pp. 106-107. “Il richiamarsi alla storia — nota Mosse — fu una maniera
per organizzare il tempo, per fare fronte al suo veloce trascorrere” (ivi, p. 107). Fu un
modo, direi, per organizzare anche la indispensabile tensione al futuro, la tensione verso
un avvenire migliore che per realizzarsi richiedeva sia la capacità di garantire incessante
vitalità all’impeto rivoluzionario, sia la — non meno necessaria — capacità di assicurare
una successione ordinata e disciplinata alle tappe incaricate di tradurre, di render
concreto, quello stesso impeto. E se il problema dell’ “addomesticamento della rivolu-
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1844
LETTURE
Ma neppure il ricorso alla liturgia — dice Mosse — fu una
invenzione dei fascismi: se infatti molti dei mezzi utilizzati furono nuovi,
perché nuove furono le opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica novecentesca, l’idea di far leva su una liturgia squisitamente laica,
incaricata di veicolare e allo stesso tempo consolidare una certa immagine del potere, delle sue virtù rigenerative, costituiva una risorsa
ugualmente tipica della modernità, almeno a partire dalla rivoluzione
francese (59). Inedita e decisiva per il successo dei fascismi fu semmai
l’idea di far degli impianti liturgici “la parte centrale, essenziale di una
dottrina che non si appellava alla forza persuasiva della parola
scritta” (60), di una dottrina che dunque sembrava attribuire alla estetica
della politica un ruolo spiccatamente fondativo rispetto al problema
della propria legittimità. Le forme della nuova politica diventavano cosı̀
il modo per imprimere un “ritmo ufficiale” (61) al mito, per creare un
circuito simbiotico tra i regimi, e i loro capi, circuito che si rivelò capace
di produrre una “autorappresentazione” dei regimi stessi, efficace —
ancora una volta — nella misura in cui si rivelava capace di “interagi[re]
con le speranze e i sogni di un vasto settore della popolazione” (62).
Che poi i regimi totalitari — e, secondo Mosse, questa era l’unica
accezione condivisibile dello stesso concetto di ‘totalitarismo’ — avessero
risposto a questa promessa di riscatto con la « tendenza a trasformare gli
esseri umani in tipi, in categorie stratte, e quindi a spersonalizzarli e a
disumanizzarli » (63), poco contava. L’‘omogeneizzazione’ (64) di tutti gli
individui, unita alla disintegrazione del ‘nemico’, disintegrazione che
ebbe nell’Olocausto la sua espressione più tragica e risoluta (65), fu infatti
zione”, il problema, cioè, della tensione costante tra rivoluzione e ordine — nota Gentile
— ha occupato una parte cospicua dello sforzo ricostruttivo di Mosse, più fragile appare
la ricostruzione mossiana — ma si tratta di un rilievo strettamente personale — quando
sottolinea la vocazione spiccatamente antimoderna dei regimi fascista e nazionalsocialista. Vocazione che, a parere di chi scrive, striderebbe un po’ con quella promessa di
‘conquista del futuro’ che ebbe non poca parte — almeno nel caso italiano — nel
determinarne il fascino.
(59) Ivi, specialmente pp. 94 ss.
(60) Ivi, p. 103.
(61) Ivi, p. 88.
(62) Ivi, p. 92.
(63) Ivi, p. 53.
(64) Ivi, p. 141.
(65) Anche in questo caso, con una interpretazione che creò molto clamore,
Mosse vide nell’Olocausto una “sintesi delle forze storiche del XX secolo”, l’esito
evitabile ma non imprevedibile di un contesto che aveva affidato alla stereotipizzazione
del nemico un ruolo decisivo nella definizione della propria identità ‘positiva’ . Sul fronte
dell’Olocausto, però, fu decisivo il ruolo riconosciuto al cataclisma della prima guerra
mondiale, come momento storico che deprezzò su larga scala il valore della vita umana
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1845
LETTURE
sorretta da un apparato simbolico e liturgico che venne ritenuto capace
di rispondere al duplice bisogno di ordine e di fede, quale che fosse il
rapporto effettivamente ipotizzabile tra le soluzioni propugnate e i “concreti problemi” (66) di coloro che erano ammessi a partecipare alla nuova
ritualità fascista. E se già nel ’57 Mosse aveva chiaro come lo iato tra realtà
e rappresentazione potesse costituire, più che una debolezza, un punto
di “forza” per creare la “base emozionale” (67) della soluzione totalitaria,
in questa fase del suo lavoro, Mosse replicava alle critiche dei colleghi
sostenendo che gli uomini erano stati “spesso attratti più dalla teologia
che dai canoni del pensiero politico classico” (68). Particolarmente forte
fu, per queste ragioni, la sua polemica nei confronti del “nuovo positivismo”, del “modello funzionalista” che, sulla scia del libro di Franz
Neumann (69) tendeva a rappresentare il regime nazista come « un’aggregazione disordinata di potentati fra di loro in perpetua lotta » (70),
rispetto al quale Hitler sarebbe stato solo l’abile e opportunista burattinaio. Si trattava, per Mosse, di una “storia sociale e istituzionale portata
agli estremi”, originata soprattutto dal bisogno di trovar “conforto e protezione nei confronti dell’irrazionalità dei movimenti di massa come il
nazionalsocialismo. Sfortunatamente — concludeva Mosse — non è mai
cosı̀ semplice spiegare la razionalità dell’irrazionale” (71).
acutizzando il ruolo della “mentalità manichea, affamata delle nette e in equivoche
distinzioni tra l’amico e il nemico proprie del tempo di guerra” (ivi, pp. 134-136). Val la
pena, al riguardo, soffermarsi sulle osservazioni di Gentile e Mosse al riguardo. Mosse —
dice Gentile — fu molto impressionato dal tenore delle memorie di Rudolf Höss,
comandante di Auschwitz, il quale sostenne che gli ebrei, nel campo di concentramento,
si comportavano « al modo tipicamente ebraico » perché cercavano « di danneggiarsi
l’un l’altro come potevano », per sottrarsi al lavoro e accaparrarsi qualche privilegio. I
campi di sterminio — notava Mosse commentando queste parole — rappresentarono lo
strumento consapevolmente creato per “trasformare l’essere umano nel tipo che l’ideologia riteneva che fosse”, per creare, cioè, una corrispondenza tra la realtà e lo stereotipo
(ivi, pp. 127).
(66) Ivi, p. 73; estesamente: una ideologia, come quella nazionalsocialista, che
“soltanto vagamente aveva attinenza con i concreti problemi che il popolo tedesco
doveva affrontare finı̀ per divenire normativa, proprio per la soluzione di tali problemi
[…] fu il genio di Adolf Hitler, che spostò la fuga nazional-patriottica dalla realtà alla
disciplina e alla efficiente organizzazione del potere”(ibidem).
(67) Estesamente: “L’immagine dell’ebreo restava al di fuori di una seria analisi
politica e sociale, e in ciò stava la sua forza: in questo modo essa forniva la base
emozionale per una soluzione totalitaria di questi problemi”.
(68) Ivi, p. 107.
(69) Si tratta del libro Behemoth, pubblicato nel 1942.
(70) Ibidem.
(71) Ivi, pp. 108-109.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1846
LETTURE
4. Qualche parola, in conclusione, sugli ultimi capitoli del libro
di Gentile, capitoli dei quali si sottolineano solamente due aspetti
rilevanti, ma legati entrambi alla centralità che Mosse attribuı̀ al
fattore antropologico nella ricerca storiografica. Il primo aspetto attiene alle direzioni nelle quali si sviluppò l’impegno scientifico di
Mosse dalla fine degli anni ’70 alla morte. In questo periodo — nota
Gentile — « Mosse non fece più ricerche specifiche sul fascismo e il
nazionalsocialismo » (72), ma si servı̀ del patrimonio interpretativo
messo a fuoco nei decenni precedenti per affrontare, da angoli visuali
nuovi, quelli che ormai gli apparivano i problemi capitali ed eterni
dell’età moderna e contemporanea. Che ritornasse — anche sull’onda
dell’impressione suscitata dal movimento sionista — a occuparsi di
guerra e nazionalismo, o che affrontasse il discorso sugli stereotipi
facendo riferimento al ruolo giocato dal modello della mascolinità o
della rispettabilità borghese (73), in ogni caso si trattava di una ricerca
ancora una volta interessata a ricostruire quel complesso circuito che
legava percezioni e soluzioni, circuito nel quale la definizione del tipo
conforme attraverso il ricorso a stereotipi, a una “rappresentazione
immutabile dell’altro” (74), del diverso, continuava a giocare un ruolo
decisivo. Con il solito rischio in agguato, che Gentile mette bene in
luce, in una delle poche pagine in cui decide di prender la parola e di
far lo storico del fascismo. Il rischio, cioè, di elaborare interpretazioni
che sopravvalutassero la portata della dimensione cultural-ideologica tralasciando la considerazione dei fattori più propriamente istituzional-organizzativi. « Non credo possibile — afferma al riguardo
Gentile — elaborare una teoria generale del fascismo dissociando
l’ideologia dalla storia, il mito dall’organizzazione, la cultura dall’istituzione. Dopo tutto, va tenuto presente — prosegue sempre Gentile
— che l’irrazionalità della cultura fascista fu politicamente efficace
non solo perché affascinò le masse con i miti, i simboli e i riti ma
perché si coniugò con la razionalità dell’organizzazione e dell’istituzione, diventando partito e regime » (75).
Ma si trattò, sembra dire Gentile, di rischi inevitabilmente legati al
lavoro del pioniere, rischi che valeva la pena correre non solo per render
sensibile la storiografia nei confronti di alcune manifestazioni peculiari
dei regimi, ma soprattutto per restituire pienamente il fascismo alla modernità e alle sue contraddizioni. Al punto che Mosse, se non fosse stato
‘protetto’ dalla sua biografia di perseguitato, « forse sarebbe stato accusato — conclude Gentile — di essere uno storico revisionista nel senso
spregiativo del termine, cioè di essere un apologeta del fascismo, perché
(72)
(73)
(74)
(75)
Ivi,
Ivi,
Ivi,
Ivi,
p. 116.
pp. 140 ss.
p. 141.
p. 124.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1847
LETTURE
aveva preso sul serio le sue idee e i miti, utilizzando per definirlo concetti
come cultura, democrazia, rivoluzione, consenso, partecipazione ». (76)
Ed è sempre questo intreccio tra storiografia e autobiografia che
consente di introdurre l’ultima osservazione, cui si accennava in apertura del paragrafo. Se infatti per Mosse il fascismo costituiva parte
integrante della modernità, una delle soluzioni storicamente praticate
per rispondere a quel bisogno di integrazione costantemente avvertito
dall’uomo moderno, non si poteva che dichiarare sempre aperto il
pericolo di una soluzione totalitaria (77). Il che portò a Mosse a
sostenere la necessità di quello che Gentile chiama il « machiavellismo
della democrazia » (78), la necessità, cioè, per le democrazie postbelliche
di consolidare un patrimonio di valori opposto a quello autoritario,
patrimonio nel quale un posto di spicco doveva esser occupato dalla
tutela dei “diritti inalienabili dell’individuo” (79), delle sue libertà, e di
consolidarlo anche avvalendosi degli strumenti tipici « della nuova
politica, dei riti e dei simboli per dare alle masse un senso di integrazione e partecipazione, procedendo, nello stesso tempo, a produrre
cambiamenti reali ed efficaci per rispondere ai bisogni della gente » (80).
Con un ruolo importante che gli stessi intellettuali dovevano saper
(76) Ivi, p. 193.
(77) “La degradazione dell’individuo nel fascismo e nel nazionalsocialismo, il
valore minimo — diceva Mosse — che questi movimenti attribuivano alla vita stessa e gli
stermini di massa che alla fine ne scaturirono, hanno lasciato un’impronta profonda sulla
generazione alla quale l’autore appartiene. La Seconda guerra mondiale non ha arrestato
questa tendenza e il problema della società totalitaria rimane un problema generale non
confinato all’Europa orientale” (ivi, p. 47). E ancora: “Il pericolo di un qualche tipo di
autoritarismo è sempre presente, quantunque mutato rispetto alle forme iniziali o alle sue
manifestazioni attuali nel mondo” (ivi, p. 123). “La conclusione [offerta dai totalitarismi]
fu tragica, ma i problemi che essi tentarono di risolvere ossessionano ancora la nostra
epoca. Infatti, chi fra di noi ha già trovato una maniera per porre fine all’alienazione? Chi
ha colmato l’abisso tra il materialismo e la creatività” (ivi, p. 156).
(78) Ivi, p. 175.
(79) Ivi, p. 151.
(80) Ivi, p. 175; sempre in questa ottica di convogliare verso un patrimonio di valori
condivisibili le pulsioni tipiche delle società contemporanee, Mosse tentò di individuare
anche una versione positiva del nazionalismo e della rispettabilità borghese vedendo in essi
non solo gli abiti mentali chiamati a identificare il ‘diverso’ , il ‘nemico’ , ma anche capaci
di costituire un cemento positivo, ‘inclusivo’ nel rapporto tra gli uomini. Fu il modo,
questo, con cui Mosse — nota Gentile — « tentò di elaborare una nuova casistica in grado
di trovare una via realistica alla conciliazione tra i principi, gli ideali, i valori del liberalismo,
del socialismo umanistico e della tradizione illuministica, da una parte, e, dall’altra, la forza
dell’irrazionale inerente alla politica di massa e alle esigenze emotive dell’uomo moderno,
al suo bisogno di orientamento, di sicurezza, di stabilità, di integrazione in una collettività,
per soddisfare il desiderio di appartenenza e di identità » (ivi, p. 181).
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1848
LETTURE
svolgere nella tutela di questo patrimonio di valori e con la conoscenza
storiografica che appariva a Mosse il varco ideale per l’“educazione al
dubbio” (81), per svelare i miti e mettere ogni società a confronto con i
propri (82). Certo, diceva Mosse, lo storico è “più abile ad analizzare i
problemi che a risolverli” e in questo sta la sua “frustrazione” principale (83), ma lo storico, al pari degli altri intellettuali, doveva saper trarre
esempio dal comportamento tenuto da tanti illustri uomini di cultura durante i regimi totalitari, « quando i professori si sottomisero al conformismo ideologico o ritraendosi nella torre d’avorio degli studi specialistici
o partecipando all’esaltazione nazionalista, giustificando successivamente
il loro comportamento, caduto il regime nazista, come una sorta di “tattica
di guerriglia in difesa della libertà di ricerca […]. Il miserabile fallimento
di questa tattica — concludeva Mosse, che non a caso fu attivamente impegnato a difendere la libertà di insegnamento e a contrastare il maccartismo (84) — dovrebbe essere un ammonimento per noi” (85).
IRENE STOLZI
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, Politische Schriften, in ID., Sämtliche Schriften und Briefe, Vierte Reihe, Sechster Band. 1695-1697, hrsg. von der
Leibniz-Editionsstelle Potsdam der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Akademie Verlag, Berlin 2008, pp. 906.
Il sesto volume delle Politischen Schriften, all’interno dell’edizione
critica leibniziana, contiene un numero consistente di testi rilevanti, in
una versione eccellente dal punto di vista filologico e storico, a differenza delle edizioni precedenti (in particolare, Mollat, Foucher, Klopp,
Grua), con il loro carattere lacunoso: esso costituisce il frutto dell’attività meritoria della Leibniz-Edition di Potsdam, diretta da Wenchao Li.
Occorre rilevare che, per quanto la produzione politica leibniziana sia
molto ampia e presenti elementi decisamente significativi, essa non ha
ancora trovato il pieno riconoscimento fra gli storici del pensiero
politico. La ragione di tale inadeguata considerazione va rinvenuta, in
(81) Ivi, p. 158.
(82) Poiché “i miti — queste appunto le parole di Mosse — sono la razionalizzazione dei pregiudizi del gruppo e la loro connessione con la realtà può essere, nel
migliore dei casi, molto tenue […] la funzione del mondo della conoscenza, per studenti
e professori, è analizzare il mondo dei miti, mettere la società a confronto coi propri
miti” (ivi, p. 171).
(83) Ivi, p. 186.
(84) Ivi, pp. 151 ss.
(85) Ivi, p. 151.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1849
LETTURE
primo luogo, nel fatto che gli scritti leibniziani relativi al diritto e alla
politica appaiono estremamente diversificati, e quindi non risulta agevole individuare un ‘filo rosso’ della riflessione. A differenza che in altri
pensatori (si pensi, ad esempio, ad Hobbes, con il Leviatano, a Locke,
con il Secondo Trattato sul governo o a Rousseau, con il Contratto
sociale), in Leibniz manca un testo ‘sistematico’, capace di racchiudere
il senso complessivo della sua filosofia politica, che risulta invece
‘disperso’ in una molteplicità di opere. Gran parte di queste ultime,
infatti, appare legata ‘a doppio filo’ a eventi contingenti, che si rivelano
irriducibili ad una codificazione complessiva, dotata di una valenza
generalizzante. D’altronde, per Leibniz la politica appartiene al novero
delle verità di fatto, distinte dalle verità di ragione, possedendo un
carattere di rigore, ma, nello stesso tempo, senza raggiungere quella
necessità assoluta, che è propria delle leggi logiche. In tale richiamo alle
verità di fatto emerge il tema della contingenza come elemento-chiave
dell’indagine intorno alla politica. Il tentativo consiste nel ‘tenere
insieme’ tale radicamento dell’analisi politica in una situazione specifica, con l’idea di una connessione decisiva, ma non immediata e
aproblematica, fra metafisica e politica. Tenendo presente il secondo
elemento indicato, occorre sottolineare che la politica non può essere
intesa solamente iuxta propria principia, e quindi sulla base di caratteristiche del tutto ‘interne’, dal momento che essa si inserisce nella
dimensione complessiva della realtà. Il percorso leibniziano è contraddistinto da tale tensione, mai risolta fino fin fondo, tra il rilievo sulla
contingenza come segno distintivo della politica, da un lato, e l’individuazione del nesso metafisica-politica, dall’altro.
Gli aspetti menzionati attraversano continuamente il volume in
questione, che raccoglie scritti compresi tra il 1695 e il 1697, ripartiti in
nove sezioni: nell’ampia ed esauriente Einleitung (pp. XXIII-LXVIII)
ne vengono evidenziati gli elementi più significativi dal punto di vista
critico-filologico e da quello storico-politico. Nella prima sezione, Rechtsund Staatswesen, è contenuto anche un interessante testo, De poena
mortis (1697), in cui viene sottoposta a critica, in quanto assolutamente
contraria alla ragione, la pratica della pena di morte. Nella seconda
sezione, Haus Braunschweig-Lüneburg, sono presenti vari scritti rilevanti, tra cui la Lettre sur la connexion des maisons de Brunsvic et d’Este
(1695) e la Lettre sur le Neuviême Electorat (1697). Quest’ultimo testo
trova alla propria base il fatto che nel 1692 Ernst August di Braunschweig-Lüneburg (Hannover) pretese, per la casata, la creazione di un
nono elettorato, in cambio dell’aiuto militare fornito durante la guerra
contro la Francia per la successione del Palatinato: nonostante le
proteste degli elettori cattolici, venne accontentato il duca Ernst August, risultando cosı̀ rafforzata la presenza protestante. In tale scritto, in
cui viene appoggiata la decisione imperiale, emerge un elemento-chiave
del discorso leibniziano: « […] je presuppose que chacun se doit mettre
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1850
LETTURE
à la raison tant en matiere de religion qu’ailleurs. D’où il s’ensuit, que
lorsqu’ on negotie avec des gens d’une autre religion, on doit garder les
regles de l’equité, et permettre que d’autres fassent, ce que nous faisons
ou ferions au besoin. Autrement c’est rompre tout commerce et venir
aux extremités dont les suites fatales ne sont que trop connues de part
et d’autre. Ce qui seroit contraire aux lois et aux conventions de
l’Empire, au bien public, et même aux regles de la charité et de la
conscience » (p. 92). La ricerca di un equilibrio fra la componente
cattolica e la componente protestante all’interno dell’Impero dovrebbe
quindi rispondere al criterio leibniziano del nihil sine ratione. In questo
senso, successivamente, nell’epistolario con Burnet Leibniz elaborerà il
concetto di « Impero della ragione », per connotare una comunità
inconciliabile con qualsiasi assetto dotato di un pouvoir arbitraire,
arbitrario non in quanto illegittimo, ma in quanto privo della dimensione razionale indicata (cfr. Leibniz an Thomas Burnett, “Beilage”, 18
luglio 1701, in Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm
Leibniz, hrsg. von C. I. Gerhardt, Band 3, Georg Olms, Hildesheim
1960, pp. 277-278).
Nella terza sezione, Reich und Europa, di particolare interesse è il
testo Sur Sherlock, The case of The Allegiance due to soveraign powers
(1695), in cui, a partire da un esame analitico dell’opera di Sherlock,
Leibniz affronta la questione relativa alla funzione dell’autorità politica
e alla possibilità o meno della resistenza di fronte ad essa. Qui Leibniz,
differentemente che in altri scritti, sembra escludere recisamente la
legittimità della resistenza, anche nel caso in cui sia un pirata ad
appropriarsi del potere: « L’auteur croit que les pirates et voleurs n’ont
pas leur autorité de Dieu. Mais je crois qu’ entre un pirate et un
Conquerant injuste, la difference n’est que du grand au petit, et qu’
estant meme sousmis à un pirate je luy dois un certain degré de fidelité »
(p. 128). Poi risulta cruciale il tema del confronto critico, vera e propria
Auseinandersetzung, con Pufendorf, cosı̀ come emerge in particolare in
due testi, In Pufendorfii historias (1695-1696) e Remarques sur Pufendorf
(1695). In ogni caso, al centro della sezione indicata sta l’analisi della
struttura del Reich, sia in merito a questioni interne, di diritto pubblico,
come il ruolo svolto dagli Stände (ad esempio, si prenda in considerazione l’opera Verthaydigung der hohen Stande des Reichs gegen die harte
Beschuldigungen eines falschgenanten Caesarei Turriani, 1696, pp. 184239), sia in merito a questioni esterne, relative allo jus gentium, come il
riferimento alla guerra ai Turchi e a alle varie crisi dinastiche e di
successione, nelle quali Luigi XIV, il ‘Re Cristianissimo’, ha esercitato
una funzione, a giudizio di Leibniz, devastante.
In rapporto alla politica estera, importante è il richiamo alla pace di
Rijswijk (come emerge soprattutto nelle Considerations sur la paix faite
à Riswyck entre l’Empire et la France, 1697), che Leibniz critica per i
suoi effetti negativi sull’Impero tedesco: « C’est une chose manifeste
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1851
LETTURE
que ce traité est extremement prejudiciable non seulement à la dignité
et aux droits de l’Empereur et de l’Empire mais encor à la liberté
Germanique, et à la religion protestante » (p. 291). Inoltre è assai
significativa l’indagine della situazione della Russia, elemento presente
in vari testi, come Denkschrift zur Entwicklung Russlands, e, ancor di
più, in Sur l’avancement des sciences et des arts en Russie (1697), in cui
è contenuta una vera e propria esaltazione di Pietro il Grande, per la
sua spinta ‘modernizzatrice’: « Je ne voy point comment un Grand
Prince puisse former un plus beau dessein que celui de rendre ses Etats
fleurissans, et de cultiver en perfection la plantation que Dieu luy a
confiée. Le Grand Tzar des Russes fait voir l’elevation extraordinaire de
son genie […] » (p. 280). A partire da tale stato di cose favorevole,
Leibniz propone l’istituzione di un projet General, volto al rafforzamento delle scienze e delle arti in Russia, anche grazie al contributo di
altri paesi. Da questo punto di vista, non si può dimenticare che in
Leibniz è presente un notevole riconoscimento del ruolo della Russia
nello scacchiere europeo, sulla base di un’idea di espansione degli
orizzonti (cfr. L. Richter, Leibniz und sein Russlandbild, Akademie
Verlag, Berlin 1946).
La quarta sezione del volume, Kirchenpolitik, affronta questioni
centrali nel percorso leibniziano, concernenti il rapporto fra politica e
teologia. In Remarques sur le journal du voyage Leibniz afferma: « Il est
visible que l’amour de Dieu et de l’ordre divin qui en resulte, fera que
nous tacherons aussi à nous conformer à cet ordre et à ce qui est le
meilleur » (p. 364). Cosı̀ nel concetto di « armonia universale » confluiscono teologia, metafisica, etica e politica, dal momento che la comprensione dell’ordine dell’universo fa tutt’uno con l’adozione di una
pratica della virtù, sulla base dell’assunzione del « punto di vista altrui »
come « giusto punto di prospettiva, cosı̀ in politica come in morale »
(cfr. La place d’autruy, 1679, in G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und
Briefe, Vierte Reihe, Dritter Band, Akademie Verlag, Berlin 1986, p.
903). In ogni caso, l’analisi della struttura della Chiesa non assume solo
un carattere strettamente teologico, ma viene a rivestire una valenza
politica, sulla base di quell’‘alleanza’ fra teoria e pratica che costituisce
uno dei segni distintivi dell’orizzonte leibniziano. D’altronde, appare
evidente come, nell’epoca in questione, il superamento delle controversie religiose rappresentasse uno scopo politico fondamentale, consistente nel raggiungimento di un equilibrio, o meglio, di una balance tra
gli Stati europei. Da tale punto di vista, gli sforzi di Leibniz andavano
a delineare una posizione ecumenica, volta ad attenuare le differenze fra
cattolici e protestanti, e quindi le rigidità dogmatiche, ‘settarie’ di
entrambe le confessioni, per garantire una coesione politica: spesso
Leibniz adoperava, con i cattolici, argomentazioni protestanti e, con i
protestanti, argomentazioni cattoliche.
In questo contesto si assiste ad un confronto serrato con Christian
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1852
LETTURE
Thomasius e con Pufendorf. Per quanto concerne il primo, occorre
menzionare in particolare Christiani Thomasii dissertatio ad Petri Poireti
libros de eruditione solida (1695), testo critico nei confronti di Thomasius, più per i toni utilizzati da tale pensatore che per i contenuti
specifici. Alla base di un’altra opera, De dissertatione thomasiana an
haeresis sit crimen (1697-1698), sta l’analisi della posizione di Thomasius in merito all’eresia, esaminando la questione in rapporto alla sfera
pratica, sulla base di quel cogitare practice che costituisce uno dei segni
distintivi del percorso leibniziano: « Haeresin […] non tantum in
theoreticis, sed et maxime in practicis reperiri censo » (p. 371). Elementi-chiave del discorso risultano essere, quindi, la pietas e caritas, con
il loro radicamento nella dottrina cristiana, ma anche con il loro
fondamento nella ratio, capace di condurre ad un amor omnium che si
pone in antitesi a qualsiasi forma di settarismo: « Certe pessimae
omnium sunt haereses, quae pietati plurimum obsunt, audiasque passim jactari sententias quae et amorem erga deum, et caritatem erga
proximum magnopere laedunt; in quas tamen nulla severitas exercetur » (p. 372). Occorre sottolineare che la visione religiosa di Leibniz si
rivela molto più complessa rispetto al modo in cui tradizionalmente
viene rappresentata. Infatti, se in apparenza ci si trova di fronte sic et
simpliciter ad una rivendicazione di ortodossia cristiana, in polemica
con l’‘ateismo’ di Spinoza, in realtà la posizione indicata approda ad
una sorta di razionalizzazione della religione, sulla base di un richiamo
costitutivo alla dimensione razionale, in grado di accomunare tutti gli
uomini al di là del riferimento ad un orizzonte dogmatico: sicuramente
sono presenti elementi che precorrono la « religione naturale » degli
Illuministi. Per quanto riguarda Pufendorf, vari testi sono incentrati
sull’analisi del suo Jus feciale; in particolare, Sur le livre intitulé Jus
feciale divinum de Pufendorf (1695), contiene una dura critica all’opera
in questione: « Il a fort écrit sur le droit de la nature et des gens, mais
comme il n’avoit pas étudié à fonds la jurisprudence, ny la philosophie
solide, on le trouve assez superficiel. Le meilleur qu’ il y donne est la
periphrase des sentimens de Grotius, et quelques fois de Hobbes. Et
comme l’excellent livre de feu Monsieur Grotius du droit de paix et de
guerre n’est pas à la portée de toute sorte de lecteurs; Monsieur
Puffendorf a proposé la doctrine de ce celebre auteur d’une maniere
plus populaire et plus propre à estre entendue des jeunes gens qui
étudient dans les universités d’Allemagne » (p. 326). Secondo Leibniz,
Pufendorf è molto debole sia come giurista sia come filosofo, e apprezzabile solo per la sua capacità di ‘popolarizzare’ il diritto naturale,
semplificando le dottrine di Grozio e Hobbes, senza però possedere la
profondità dei pensatori indicati.
La quinta sezione dell’edizione, Europa und China, costituisce una
testimonianza dell’interesse leibniziano per la Cina. Da questo punto di
vista, una funzione importante è stata esercitata dal gesuita Claudio
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1853
LETTURE
Filippo Grimaldi, che Leibniz ha incontrato a Roma nel 1689. Più in
generale, le missioni dei Gesuiti in Cina, a partire dal 1582, con l’idea
della propagatio fidei per scientias ad esse sottesa, provocarono un
intenso scambio culturale fra l’Europa e la Cina. Figura significativa al
riguardo è quella di Matteo Ricci, che tentò una sorta di accomodatio fra
Cristianesimo e Confucianesimo, favorendo l’ingresso del pensiero
europeo in Cina. Poi un evento storico decisivo è costituito dal cosiddetto Editto di tolleranza (1692) dell’imperatore cinese, che aprı̀ spazi
per la diffusione del Vangelo in Cina. In questo contesto va inserita
un’opera leibniziana molto rilevante, qui pubblicata: Novissima Sinica (I
ed.: 1697, II ed.: 1698-99). Secondo Leibniz le ‘novità’ cinesi possono
contribuire alla storia del secolo che stava terminando. Cosı̀ viene
valorizzata la presenza, in Cina, di una dottrina filosofica, o meglio, di
una teologia naturale, di gran lunga più antica di quella greca: sarebbe
insensato non entrare in relazione con essa, a partire dall’argomento
secondo cui tale teologia naturale non si accorda immediatamente con
le nozioni scolastiche. Al di là di alcuni limiti nella rappresentazione
della Cina, l’aspetto più importante al riguardo è costituito dal fatto che
Leibniz non intende ‘ridurre’ la cultura cinese al presunto ‘modello’
della cultura europea, cercando piuttosto di operare una ‘fusione degli
orizzonti’ fra realtà che rimangono differenti, ma che risultano accomunate dal riferimento alla dimensione razionale e non ad un elemento
fideistico (cfr. W. Li-H. Poser, hrsg. von, Das Neueste über China. G.
W. Leibnizens “Novissima Sinica” von 1697, « Studia Leibnitiana Sonderheft », Franz Steiner, Stuttgart 2000). Cosı̀, in modo analogo a
quanto sottolineato in merito alla Russia, occorre mettere in luce che
Leibniz tiene in costante considerazione il fenomeno dell’espansione
dell’universo politico, e quindi dell’allargamento degli orizzonti esistenti: non si può trascurare la rilevanza politica di tale ricerca di
ampliamento delle realtà conosciute, da indagare nella diversità delle
loro forme ma attraverso un dialogo costante tra di esse.
La sesta sezione, Bibliothek, Literatur, Sozietät, Bildung, comprende scritti relativi alla strutturazione delle biblioteche (tra l’altro, nel
1691 Leibniz era diventato bibliotecario della Bibliotheca Augustana di
Wolfenbüttel), all’ordinamento del sapere, e quindi alla sua divisione in
facoltà (teologia, giurisprudenza e medicina), in discipline (« philosophia intellectualis », « philosophia rerum imaginationis seu Mathematica » e « philosophia rerum sensibilium seu physica »), oltre che in
literae humaniores e literae communia. Un testo molto significativo,
Unvorgreiffliche Gedancken betreffend die Ausübung und Verbesserung
der teutschen Sprache (1697-1712), parte dall’idea del linguaggio
(Sprach) come « specchio dell’intelletto (Spiegel des Verstandes) » (p.
532), dotato di un carattere storico, in quanto proiezione delle società
che l’hanno prodotto: « Es ist bekand […] dass die Völcker, wenn sie
den Verstand hoch schwingen, auch zugleich die Sprache wol ausü-
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1854
LETTURE
ben » (p. 532). Esiste un nesso stringente fra la disciplina morale e la
‘pulizia’ delle parole: « Es ist […] in der Sitten-Lehre mit Sauberkeit
der Worte nicht ausgerichtet: es ist doch aber auch solche kein geringes » (p. 564). In questo contesto si inserisce la forte valorizzazione
della « Teutsche Nation » (p. 532), che, secondo Leibniz, doveva
risollevarsi, dopo la Guerra dei Trent’anni, con i suoi effetti devastanti
sul piano economico, sociale e culturale, e, facendo leva sul suo ruolo
rilevante all’interno della Cristianità, doveva far valere le proprie prerogative anche dal punto di vista linguistico, non accettando più
l’egemonia della lingua francese e di quella latina. Al di là della
contraddizione consistente nel fatto che lo stesso Leibniz ha elaborato
gran parte delle opere in latino e in francese, e non in tedesco, occorre
sottolineare che il testo in questione, interpretato da alcuni studiosi
come una sorta di precorrimento dei Discorsi alla nazione tedesca di
Fichte, pur contenendo rischi di nazionalismo, si riferisce alla Germania
non in senso razziale, ma in senso culturale.
Della settima sezione, Gesundheitspolitik, è necessario, in particolare, menzionare il testo Relatio ad inclytam societatem Leopoldinam
(1695-1696). Concludono il quadro i Gedichte (ad esempio, è da
segnalare, sempre in merito a Pufendorf, In Pufendorfii historiam
Friderici Guilielmi, 1695), i Nachträge (tra cui, Apologia catholicae
veritatis, 1685), e, infine, ricchissimi indici dei nomi, delle opere, degli
argomenti e dei riferimenti biblici. Del volume indicato occorre mettere
in luce l’estrema acribia filologica, che permette di mettere a disposizione una serie di scritti che precedentemente risultavano lacunosi, in
alcuni casi incompleti, l’ampiezza del contesto storico-culturale indicato
in ogni testo, e le puntuali note e osservazioni, sulla base delle numerose
variazioni dei manoscritti.
In conclusione, fra i molti aspetti presenti nell’edizione in questione appare particolarmente rilevante sottolineare il fatto che l’orizzonte politico leibniziano si configura come una critica radicale alla
costruzione teorica contrattualistica, con riferimento in primis a Hobbes e a Pufendorf (qui esaminato in modo molto approfondito). Di tale
concezione Leibniz rifiuta tutti gli elementi-chiave: il carattere artificiale
della politica, il depotenziamento della giustizia, l’assolutezza e l’illimitatezza dell’autorità costituita, il misconoscimento della dimensione
della pluralità. Secondo Leibniz, Pufendorf, al di là di una serie di
‘complicazioni’ rispetto al modello hobbesiano (si faccia riferimento, ad
esempio, alla teoria degli entia moralia), nella sostanza aderisce a esso,
e quindi all’idea secondo cui ‘auctoritas, non veritas facit legem’: la
posizione indicata fa sfociare la riflessione in una reductio della politica
alla logica della legittimazione, pervenendo ad una giustificazione dell’arbitrium potentis. L’intreccio di teologia, metafisica e politica, delineato da Leibniz, fa emergere la convinzione secondo cui esista un
‘comune’ eccentrico rispetto a qualsiasi ordinamento giuridico e dotato
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1855
LETTURE
di un dinamismo irriducibile a soluzioni predeterminate: nessun sovrano può fondare ex novo la comunanza e la giustizia, in quanto esse
si radicano nella struttura delle cose a prescindere da qualsiasi meccanismo autoritativo.
LUCA BASSO
FRANCESCO MIGLIORINO, Il corpo come testo. Storie del diritto, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008, pp. 172.
Questo libro comincia, in misura e maniera che eccedono l’ovvio,
con la copertina. La illustra la riproduzione di una delle versioni di Felt
Suit, una specie di scultura, opera di Joseph Beuys. Non l’ha scelta
l’editore; proprio dal dimesso vestito di feltro, semplicemente appeso a
una gruccia, pigliano avvio le pagine introduttive, che gli si intitolano.
Il corpo come testo: in copertina però compare non un corpo ma,
appunto, un vestito. Un’incongruenza? Cercare una risposta a questa
domanda è il proposito principale delle rapsodiche annotazioni che
seguono: che puntano comunque l’attenzione (anche un poco a dispetto
dell’Autore, forse) su alcune delle sporgenze teoretiche, per dire alla
svelta, che il libro presenta.
A chi scrive capitò una volta di sentire Carlo Dionisotti interrompere un verboso di molte pretese esclamando: « Ma Lei ci parla di
teorie! A noi interessano invece i fatterelli ». Dopo, a beneficio dei più
candidi, aggiunse a mezza voce: « Anche questo, dei fatterelli, è un gran
punto di teoria, naturalmente ». Anche a Migliorino sono cari i « fatterelli »; gli preme il circostanziato. Il libro è in sette capitoli: raccoglie,
in parte rifatti e aggiornati nell’apparato, sette studi pensati « in occasioni e contesti diversissimi fra loro », pubblicati tra il 1995 e il 2007 (di
quattro è cambiato o ritoccato il titolo; d’uno era uscita anche una
traduzione tedesca). La molteplicità è rivendicata, sottolineata. Appena
svoltata la copertina, la bandella di prima chiarisce subito che il
sottotitolo, Storie del diritto, ha peso: « Ci sono libri che raccontano una
storia, e che vanno letti dall’inizio alla fine. Questo, di storie ne racconta
più d’una […]. Ecco perché ognuna di esse può essere letta come un
avvenimento singolare, circoscritto nello spazio e nel tempo ». Non
suoni però come elogio di un operare pacatissimo, tra sponde nitide e
salde. La bandella fa un primo elenco di oggetti e sfondi di questi studi:
« dalla censura alla confessione, dalla grammatica dei segni alle retoriche del sacro, dall’ordinaria miseria di esistenze oscure alle interminabili prose del potere ». Proprio il contrario, come si vede, di orti
ordinati e conclusi, di registri tranquilli. Ancora sulla soglia del libro, p.
11, Migliorino ha occasione di riprendere e distendere le indicazioni
della bandella. Ribadisce che Il corpo come testo « si accontenta di
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1856
LETTURE
raccontare storie del diritto (al plurale) »; e annota: « modestamente ».
La pagina è però irta di polemica. E addita una posta altissima: le storie
al plurale hanno da soppiantare « la magniloquente Storia (al singolare) ». Per sorreggere e alimentare l’opposizione di storie e Storia
Migliorino convoca, di punti di teoria, una costellazione intera; in due
capoversi successivi fa apparire: Benjamin, Nietzsche, Freud, Adorno.
Che possono avere da spartire, codesti autori? Prima di tutto, è il chiaro
suggerimento di Migliorino, una ripulsa: la ripulsa di ogni maniera o
guisa di teoria che si proponga come « pensiero sistematico », come
« totalità », come « dialettica della sintesi e della conciliazione ». Il
molteplice delle storie è insomma come un acido che corroda l’uno
della Storia. Una teoria dei « fatterelli » ha da trovare o inventare un
altro modo di congegnare.
A fare schietta, risoluta apologia dei « fatterelli » erano intese le
lettere, ventidue, che tra il 1960 e il 1964 Delio Cantimori inviò alla
rivista genovese « Itinerari » (poi raccolte, a cura di Francesco Rossi, in
D. Cantimori, Conversando di storia, Bari, Laterza, 1967). Specialmente
ricca di spigoli e di umori è la seconda lettera, che, quasi intera, discorre
della prima versione italiana di Hubert Jedin, Breve storia dei Concili
(Roma, Herder, 1960). Alla copertina è dedicata grande attenzione, un
capoverso fitto. Ci si poteva aspettare (per ragioni che non è il caso di
riesumare qui) che richiamasse il Concilio di Trento, invece rappresenta
una sessione di quello di Costanza; chi poi percorra la lettera di
Cantimori (e il testo di Jedin) avrà da scoprire, o almeno da sospettare,
che nella copertina è apparecchiato un indizio. Cantimori non trascura
il colore dello sfondo, che è mutato, rispetto all’edizione tedesca: e cosı̀
risaltano meglio « le posture delle mani » dei Padri, che « non indicano
solo vivacità » ma « hanno significati determinati ». Il capoverso sulla
copertina dà il tono e la chiave. Le lezioni che Cantimori trae da Jedin
(o che con Jedin illustra) risultano chiarissime. Ci viene rammentato,
intanto, che in un libro è da leggere non solo quello che è detto in verbo
ma anche, e altrettanto, quello che è scritto, come in inchiostro invisibile, in figura; che importa anche, e altrettanto, quello che un libro ha
da mostrare, quello che in modi diversi un libro fa: a cominciare, per
l’appunto, dalla scelta e confezione della copertina. Un testo, in questa
veduta, è anche un gesto (una serie, un insieme di gesti). È una lezione
a fortiori. Chi scriva di Concili riguarda, ha da riguardare, il sommo
della speculazione; ma fa mestiere di storico, e non di « oracolo
pomposo », se si curva sui « fatterelli » (che sono, poi, tracce e scie
dell’Incarnazione). Si raccoglie l’esempio di Jedin se ci si ingegna di
fissare l’attenzione ai modi e agli episodi nei quali dottrine e pratiche si
incontrano e reciprocamente si adottano (e si adattano, reciprocamente). Questa Breve storia dei Concili è « un gran libretto » perché
tanto dice quanto mostra e fa, ovvero perché dice anche nel mostrare e
fare. Cantimori sottolinea che Jedin, qui, non ha dati nuovi, fonti
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1857
LETTURE
particolari, materiali rari; vale la sapiente disposizione, conta l’accortissimo allestimento. Per questo, ci viene indicato, la Breve storia dei
Concili è libro specialmente attento ai luoghi e momenti che congiungono il dire, il fare, il mostrare: attento dunque, per esempio, proprio
ai gesti. Emblematiche, « le posture delle mani » che spiccano in
copertina. Nei gesti la dottrina piglia corpo, si fa corpo.
Migliorino fa eco. Delle lezioni di Cantimori dà folto riscontro, per
esempio, lo studio che fa da capitolo secondo, Comunicazione e significazione. Il capitolo è infatti sontuosa ricognizione di snodi della
vicenda di segni e gesti, ossia di segni che prendono corpo e di corpi che
fanno segno: dalla solidarietà di manus e lingua (p. 35, da uno spunto
di Bauman) alle domande che si faceva Bartolo sulla lingua dei sordi
(pp. 40-41). E l’attenzione all’incrocio di dottrine e pratiche viene
naturalissima: perché di questo incrocio è fatto per l’appunto il diritto.
Il diritto di Migliorino non è un che di piano e omogeneo: è « per sua
natura pervasivo » (è detto a p. 34, rinviando a un indimenticabile
saggio di Sbriccoli); si dà come una vocazione del diritto alla « contaminazione » (cosı̀ a p. 52, dove è richiamata la lezione di Paolo Grossi).
Terreno specialmente adatto, la storia del diritto, a esercitare le lezioni
di Cantimori. Di certo. Migliorino fa di più, comunque ha dell’altro da
fare. Della veduta di Cantimori (o che da Cantimori si è cavata qui,
molto alla buona) Migliorino ha di mira soprattutto il prolungamento,
o il risvolto. La dottrina piglia corpo; ma il corpo non è materia
innocente, tanto densa quanto plastica: il corpo dei gesti, il corpo che
fa segno, è corpo indottrinato. Ma di più. Il corpo come testo implica
dottrina, effetti di dottrina, li costituisce: non, semplicemente, li suppone. È punto capitale, nel quale forse i diversi profili e itinerari di
questo libro si ritrovano e fanno capo insieme. È, in ogni caso, nitido
punto di programma: questo libro, si legge tra p. 9 e p. 10, « va alla
ricerca di una declinazione del corpo che, da superficie della scrittura,
sia visto invece esso stesso come scrittura di un testo ».
Migliorino raccoglie e interpreta anche l’altro versante della didascalia di Cantimori: un testo dice, ma è anche un fare, un mostrare;
importano i materiali e gli attrezzi ma anche di più importa l’allestimento, il montaggio. Ecco, montaggio è la parola che forse dà la chiave
principale, per Migliorino. Bisogna tornare alla bandella di prima, che
formula la domanda cruciale: come siamo stati « fabbricati »? Non
creati o prodotti o (in qualche accezione categoriale) costituiti: « fabbricati ». Se c’è un perno di tutto il discorso di Migliorino, è probabile
che lo si possa individuare nel convincimento che non si dà (non si è
mai data, non si può dare) unità o identità che sia, per cosı̀ dire,
creaturale: tutta d’un pezzo, integra, originaria. « Fabbricati » vuol dire
assemblati; siamo quelli e quello che siamo perché siamo l’esito di un
montaggio. Il montaggio fa uno perché (e finché) da uno funziona.
L’essere, se c’è ancora da parlarne, viene dopo. Si può dire, per
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1858
LETTURE
esempio, che sono peccatore perché (e finché) commetto peccati; non è
da dire, invece, che commetto peccati per il fatto di essere peccatore.
Roba moderna o, chissà, postmoderna? O non era, piuttosto, l’assunto,
anzi l’acquisto, dei Padri cappadoci?
Si affollano nodi teorici delicatissimi. Per darne rapido conto può
servire un’altra copertina, o meglio un frontespizio. Ai tempi di Hobbes
non usavano le copertine ma si facevano a volte frontespizi cospicui.
Celebre è quello del Leviatano. Raffigura uno: anzi, l’uno. Rappresenta
infatti il sovrano, dalla cintola in su; torso e braccia sono di montaggio:
a comporli concorrono, in numero indefinito, indefiniti individui. Il
nodo di teoria risulta subito se, tenendo a mente la figura, si salta la
dedicatoria e si va dritti all’incipit. La prima riga del Leviatano reca una
definizione della natura, della natura come arte di Dio: « la natura, l’arte
con cui Dio ha fatto e governa il mondo »; è quest’arte divina che va
« imitata » per « costruire un animale artificiale ». Con I filosofi e Dio
(Roma-Bari, Laterza, 2005) Sergio Landucci ha offerto una magistrale
ricostruzione di radici e movenze di questa dottrina (e delle varianti e
alternative); qui basti una spuntatura. Frontespizio e incipit concorrono
a inquadrare un campo di questioni intorno alla premessa che l’uno non
si dà, non è per cosı̀ dire un primum ontologico: l’uno si costruisce, è da
costruire. L’incipit dice che anche il modello, da « imitare », è un che di
prodotto, che si viene anzi producendo: è un effetto di « governo ». Il
frontespizio dà immagine a un altro, e di certo separabile, assunto,
ovvero all’assunto che l’uno abbia carattere, diciamo cosı̀, frattale: che
si produca, cioè, per oblazione delle resistenze, delle singolarità. Il
montaggio funziona se identifica, nel senso proprio, i componenti. Sul
frontespizio del Leviatano è come se gli individui, spogli di ogni
carattere, si avviassero a essere inghiotti dal, o anzi nel, corpo del
sovrano. A Migliorino preme invece ciò che l’uno ha da « fagocitare »,
ossia, si legge a p. 11, « il dissimile, il non identico, il diverso, l’individuale ».
A dare almeno un obliquo colpo di luce allo sfondo di Migliorino
soccorra un altro incipit celebre. Anche la Critica della ragion pratica
attacca con una definizione: « I princı̀pi pratici sono proposizioni che
contengono una determinazione universale della volontà, la quale ha
sotto di sé parecchie regole pratiche ». Chi scrive ha ora a mano la
benemerita traduzione di Francesco Capra, rivista da Eugenio Garin
(tante volte ristampata da Laterza); « universale » è comunque resa
costante, salvo errore, di allgemein, che è aggettivo di minori pretese,
meno esposto. Di « universale » i princı̀pi pratici hanno il fatto di
riferirsi a classi di deliberazioni e azioni. Codesti princı̀pi comprendono
però le « massime », considerate, da chi le adotti, valide « soltanto per
la sua volontà »; per tutti quanti valgono invece quelle che Kant chiama
« leggi ». Una distinzione limpida, terminologicamente, compare nella
Critica molto più in là (Kant la appoggia a una coppia di latinismi,
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1859
LETTURE
universell e generell). Ora, rammentare Kant aumenta il rischio di
correre a conclusioni troppo vaghe. Migliorino, si può essere tentati di
dire, ha a bersaglio quella figura rigida e cava dell’uno e dell’universale
che sarebbe la Legge: che con « la magniloquente Storia (al singolare) »
fa distico. Storie del diritto è espressione a due termini, e ha in effetti
due rovesci, due antagonisti: per fare i conti e con la Legge e con la
Storia. Nel libro di Migliorino è dunque da riconoscere una specie di
manifesto per il restauro conservativo del sommesso, del « particolare »,
del non identico? Sarebbe, a dire il minimo, lettura mozza. Il campo
degli esercizi di Migliorino è forse invece proprio quello segnato
dall’universale equivoco, poroso, di Kant: l’universale in quanto allgemein, che è nome di genere, prevede guise e maniere diverse e,
soprattutto, ha gradi.
Il corpo come testo ha un’ampia cerchia di interlocutori, sostegni,
complici. Il più citato è Michel Foucault, non sorprendentemente. Può
sorprendere, semmai, che di Foucault non venga mai citato Sorvegliare
e punire. La ragione potrebbe essere che proprio quel libro è come
assimilato in radice, è quasi l’ovvio punto di partenza; ne offrono
indizio diverse locuzioni e inflessioni del vocabolario di Migliorino
(basterebbero le risonanze del titolo del capitolo primo: Grammatica dei
desideri e docilità dei corpi). Di certo Sorvegliare e punire ha segnato la
fine dell’innocenza e della naturalezza del corpo; ha mostrato che il
corpo è integralmente « fabbricato »: non un che di organico, piuttosto
un abito, ossia una foggia di habitus, risultato di conculcate abitudini.
(E potrebbe bastare, a giustificazione di Felt Suit in copertina.) Foucault
si vantava di aver disseminato l’opera sua di citazioni crittate. Chi scrive
tiene per certo che una di queste sia il titolo del libro in questione. La
« Neigung zur Beaufsichtigung und Bestrafung », ovvero appunto la
tendenza a « sorvegliare e punire » (« surveiller et punir », nella traduzione francese), è quella che Freud attribuisce al Super-io. Nell’occasione il Super-io è definito « la coscienza morale che agisce nell’Io ». Il
punto è che codesta « coscienza morale » non è comunque, e non ha, un
soggetto: è l’esito, o il vettore, di un insieme di apparati e congegni.
Freud ne tratta nel saggio che affronta, nel 1924, Il problema economico
del masochismo. È questione, dunque, di Ökonomie. Il termine indica di
regola in Freud, che ne fa uso frequente, una combinazione di istanze
(una gerarchia, più o meno labile, talvolta un labirinto). Da sottolineare,
qui, che siffatta Ökonomie freudiana ha per correlato non l’omogeneità
o l’identificazione degli elementi ma, al contrario, la loro partizione per
singolarità; un apparato funziona, e funzionando si stabilisce, nel dare
a ciascuno il suo. La « coscienza morale », per esempio, dà forma, sı̀: ma
si forma nel dare forma. È su questo sfondo, probabilmente, che vanno
letti gli interventi di Foucault sul potere pastorale (in specie Omnes et
singulatim, titolo eloquentissimo). È su questo medesimo sfondo, probabilmente, che vanno lette anche le considerazioni di Migliorino
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1860
LETTURE
intorno al fatto, segnalato per esempio a p. 30, che « la scrittura è
costitutiva della dogmatica ».
A bilancio del capitolo su Comunicazione e significazione Migliorino dichiara che aveva intento di « apprezzare » ciò che serve « soprattutto a conferire un’identità agli uomini » (p. 44). Si tratta appunto di
« conferire un’identità », che non può essere evocata né presupposta.
Ma soprattutto importa che a « conferire un’identità agli uomini »
siano, è detto con lecita enfasi, « segni ». E a p. 10 si leggeva che a
sovrintendere alla « costruzione sociale del soggetto e della sua identità » sono dei « congegni ». Vale a dire che non c’è, che non c’era, alle
spalle, un testo (un Testo) che poi si imprime e si trascrive nella carne
degli uomini. A « conferire un’identità » è ciò che prende figura, e
appunto corpo, nell’operazione. Il corpo è un testo perché anche il testo
è un corpo: accidentato, fatto di pezzi e strati. È il capitolo terzo, Il
soave conforto dei colpevoli, a mostrare come viene, o avviene, un testo
che funziona, che appunto fa testo. Oggetto del capitolo sono le
Summae confessorum. Che sono testi secondo l’etimo, da materiali
difformi e mani diverse: frutto di stesure e ristesure, di potature e
innesti, di contaminazioni innumerevoli. Sono il congegno, il congegnarsi, di dottrine e pratiche. E sono, intrinsecamente, dei multipli:
sequele di varianti, che fanno a meno di un originale, ossia scansano la
questione del Testo. (Anche Felt Suit è un multiplo; di questa come
d’altre opere sue Beuys ha dato più versioni: non c’è, non ci può essere,
l’autentica.)
Che l’abito in copertina sia da intendere come habitus è almeno
accennato dal modo della presentazione. Ci viene detto che, « spogliato
del suo corpo », Felt Suit appare « pronto, all’occorrenza, per innumerevoli altri corpi ». Migliorino è frequentatore assiduo di testi, anzi di
biblioteche, medievali; pare difficile che nell’espressione che adopera
non sia da avvertire come un’eco della facilis et perfecta potestas di
Alberto Magno o della potentia habitualis di Alessandro di Hales; l’eco,
del resto, rimanda anche alla disputatio XLIV, De habitibus, di Suárez,
e a Suárez è dedicato un capitolo intero (il quinto, Il Paradiso perduto).
Alberto Magno, Alessandro di Hales e Suárez hanno poco, pochissimo,
che li accomuni, tranne la caratterizzazione di habitus come luogo della
perfectio, ossia dell’incontro di determinatezza e indeterminatezza, determinazione e indeterminazione. Perfetto è ciò che abbia compiuto,
esaurito, tutti i processi di cui è capace; risulta cosı̀ spogliato della
determinatezza della genesi e diventa buono a tutto, pronto a tutto,
indeterminatamente. La perfezione di habitus non è comunque lo
svolgersi di una essentia, è un cumulo di acquisizioni. In “Être” et
“avoir” dans leurs fonctions linguistiques, saggio del 1960 che merita
riletture, Émile Benveniste aveva proposto un binario semplice. Il verbo
essere stabilisce, cioè ritrova, tra i termini che connette, un rapporto
intrinseco di identità; quando a connetterli è invece il verbo avere, i
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1861
LETTURE
termini restano distinti: il rapporto, estrinseco, è aperto al sospetto o al
rischio di incongruenza (e di insufficiente determinazione). Avere è il
verbo del « fabbricare ». (E se la figura in copertina esibisce un margine
di incongruenza è, si può ritenere, per allusione, o con allusione, al
carattere di ogni montaggio, di ogni “fabbricazione”.)
Si rammenti che Migliorino è l’autore di Fama e infamia. Problemi
della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII,
Catania, Giannotta, 1995). Al tema è specialmente dedicato il capitolo
quarto, Corpo scrittura identità (ma quando è apparso in una prima
versione, negli Studi per Giuseppe Nicosia, si intitolava Lo spazio dell’infamia). Quando non è più da supporre « una fabulosa sostanza
preliminare » (la suggestiva espressione è a p. 53) sono le nomee, i nomi,
« gettati addosso alle cose come un abito » (è detto con Nietzsche, in
nota di p. 63), a fare il corpo, il corpo come testo. I nomi scandiscono
singolarità. Non sono però garanzia, o concessione, di un proprium;
sono ritmo e respiro del montaggio. Di questo racconta il capitolo
ultimo, Bonifica umana, che riguarda il manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto (e andrebbe accompagnato dal cortometraggio
Aria. Voci scritture immagini del manicomio criminale di Barcellona
Pozzo di Gotto, di cui è autore lo stesso Migliorino). Mostra che c’è un
modo di congegnare e articolare che è alternativo a quello hobbesiano,
un modo che mette in conto « l’irruzione nella storia del soggetto
nuovissimo di massa » (p. 151). La massa, soprattutto la massa, chiede
« governo ». Il manicomio conferma che l’infamia è formidabile raccordo di omnes et singulatim; che « la più straordinaria macchina
normativa » è, come già si leggeva a p. 18, il linguaggio. I nomi,
comunque, non sono voci del verbo essere: servono piuttosto a perimetrare le vicende incerte dell’avere, ossia a sagomare campi di battaglia.
Qualcuno si ricorderà di quella figura somma e ineluttabile dell’universale che erano le leggi del mercato. Battute in lesta ritirata, è
improbabile che non ritornino. Teniamolo allora di conto, questo libro
di Migliorino: ci aiuterà a maneggiarle.
ROBERTO RIGHI
MARIANNA PIGNATA, Dominium e possessio tra ius e factum. La Lectura di
Giovanni Bolognetti, Napoli, Jovene, 2007 (Pubblicazioni della
Facoltà di Giurisprudenza - Seconda Università degli Studi di
Napoli, sezione monografie XXXI).
Indagine doppiamente difficile quella che Marianna Pignata ha
scelto quale tema della sua prima monografia, sollecitata probabilmente
dal suo consapevole Maestro Aurelio Cernigliaro che ne ha voluto in tal
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1862
LETTURE
modo saggiare le reali doti di ricercatrice sul terreno storico-giuridico.
Doppiamente difficile, perché ha puntato la sua attenzione su un
giurista felicemente ambiguo del pieno Cinquecento, il bolognese Giovanni Bolognetti, e su un tema sotto ogni profilo fra i più ardui per uno
storico del diritto, che è quello della appartenenza di un bene in un
momento di intensa transizione come il secolo XVI.
Non è, infatti, certamente facile cogliere le valenze culturale e
tecnica di un giurista che avverte il peso della tradizione bartolista ma
che non rinuncia a respirare liberamente i vènti affrancatorii provenienti da Oltralpe e soprattutto dalla Francia. Né è certamente facile
penetrare nell’ordito dei diritti reali, dove — particolarmente in un’età
di forti mutazioni strutturali e ideali — questo nodo di istituti, per il
congiungersi e intrecciarsi di una forte dimensione ideologica e politicoeconomica a quella squisitamente tecnico-giuridica, si complica non
poco.
Ed è proprio qui che Marianna Pignata dimostra il suo talento di
autentica storica del diritto, mettendo a frutto le risorse varie e diverse
a sua disposizione, le quali soltanto — se integrate in una necessaria
congiunzione — riescono a fornire all’indagatore la cifra di una lettura
che possa dirsi perfettamente riuscita sul piano storico-giuridico.
E si deve proprio lodare lo strumentario utilizzato dalla Autrice,
che unisce il possesso adeguato dell’ideario tecnico dei giuristi medievali ed umanisti a una conoscenza altrettanto adeguata dei problemi
strutturali, delle visioni antropologiche, delle realtà istituzionali presenti
nel multilineare e complesso secolo XVI.
Quasi a conferma dell’impegno storicistico della Pignata, il libro si
articola in due parti. La prima, dedicata a un profilo di Bolognetti e al
suo inserimento nei varii contesti sociali, istituzionali, scientifici in cui
venne via via ad operare (a Bologna, a Salerno, a Napoli, ancora a
Bologna, a Pavia). La seconda, interamente rivolta alle tormentate
diagnosi e costruzioni tecnico-giuridiche bolognettiane a mezzo del
guado fra le maestose sistemazioni del diritto comune classico e le sottili
erosive intuizioni dei nuovi giureconsulti umanisti. Segue, a chiusura
del volume, una utile appendice documentaria.
Fulcro centrale del nuovo atteggiamento metodologico è il ‘Tractatus de differentia iuris et facti’ cui l’Autrice rivolge una vigile attenzione,
mentre ne è manifestazione schietta la rivalutazione in chiave romanistica della categoria del possesso (rimasta abbastanza in disparte, e
comprensibilmente, nelle analisi dei medievali), la quale sembra destinata ad assorbire, contenere e, in qualche modo, anche controllare il
fascio innumerevoli delle fattualità.
Resta la croce del dominio diviso, e soprattutto di situazioni di
godimento elevate disinvoltamente a dominio utile nella piena convinzione che di situazioni perfettamente dominative si trattasse; croce per
un personaggio come Bolognetti, perennemente diviso fra tentazioni
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1863
LETTURE
bartoliste e, al contrario, squisitamente umanistiche. Il nostro giurista si
rigira — per cosı̀ dire — fra le mani l’arnese tecnico del dominio utile,
e lo avverte ambiforme e in qualche misura anche ripugnante per la sua
coscienza di uomo nuovo. Da qui il suo insistere sulla discrepanza di
poteri fra direttario e utilista. Ha ragione la Pignata quando sottolinea
che Bolognetti « pur conservando la dinamica formale del dominio
diviso si mostrava convinto assertore dell’unitarietà substantiale dell’istituto » (p. 82).
Sul dominio utile la coorte umanistica soffre incrinature: se Cujas,
Vultejus, Bronchorst non hanno esitazione nel reputarla un artificio
medievale e nulla più, ecco che Douaren e Le Baron lo configurano
come ‘ius dominio proximum’ conscii di non poter interamente demolire un istituto vivo e vegeto nella prassi agraria della Francia cinquecentesca, ma salvandosi l’anima sia pure con una buona dose di
nicodemismo.
La scelta di Bolognetti è diversa, più raffinata, più tecnicamente
suadente e si allinea a quella concezione del grande Zasius, altro
ambiguo e tormentato partecipe dell’umanesimo renano, su cui io
stesso parecchi anni fa ritenni di dedicare una sosta autonoma nelle mie
ricerche sulla storia del dominio diviso: il dominio è realtà complessa,
al cui interno sono rilevabili alcuni gradus; il dominio utile altro non è
che un gradus in dominio.
Insomma, con Bolognetti siamo a una tappa — rilevante anche se
tuttora segnata da incertezze — nell’itinerario che corre verso la
proprietà unica della Rivoluzione (dapprima) e dei Codici (immediatamente dopo). E ha avuto buon fiuto Marianna Pignata a riproporla alla
nostra odierna attenzione storiografica.
Credo che si debba guardare con favore a questo libro, formulando
conclusivamente anche un augurio rivolto genericamente ai giovani
studiosi: che vogliano proseguire su questo cammino fertile, con indagini come questa della Pignata idonee a colmare l’ancora enorme vuoto
storiografico rappresentato dalla storia della scienza giuridica europea
nei secoli della crisi del diritto comune; un vuoto che è grave proprio sul
terreno delle costruzioni giuridiche, che è per l’appunto il piano in cui
si cimenta la valente studiosa napoletana ficcando ben a fondo lo
sguardo all’interno dell’officina dei giuristi e frugando sui loro banchi di
lavoro.
Commendevolissimo è ai nostri occhi il suo angolo di osservazione,
sorretto dalla coscienza che il diritto è un tessuto esperienziale ordinato
dalle categorie e dalle invenzioni tecniche di giuristi teorici e pratici,
nonché di legislatori. Il merito della Pignata è di avere inforcato sul
proprio naso gli occhiali proprii di un giurista cinquecentesco, volendo
comprendere il suo linguaggio speciale e decifrando i nodi tecnici del
suo discorso. Le tecniche diventano in tal modo uno strumento di rara
espressività storica, che permette di arrivare a cogliere tutta la realtà
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1864
LETTURE
sociale economica politica, tutte le idealità e ideologie che stanno dietro
di esse.
Nell’analisi di un tornante cosı̀ complesso come il Cinquecento
giuridico si deve dare atto alla Autrice di possedere una corretta bussola
orientatrice. Mi permetterei solo un rilievo: probabilmente metteva
conto di sottolineare con vigore e più apertamente quella convinzione
che la Pignata confina in una nota di pagina 119 (la nota 91), e cioè la
novità del modo con cui si osserva e si dà rilevanza alla res nelle analisi
umanistiche, una novità che discende da quella rinnovata antropologia
che esige una relazione tutta nuova fra soggetto e cose. L’Autrice ne ha
coscienza, e le si farebbe torto non constatandola; basterebbe quel
frammento del teologo volontarista Pietro di Giovanni Olivi che la
Pignata ha voluto in esergo, un frammento modernissimo anche se
scritto a fine Dugento, dove si lega proprietà e libertà, proprietà come
facultas dominandi e carica vitale interna al soggetto. A mio avviso,
questa coscienza latente avrebbe dovuto emergere con maggiore franchezza fino a diventare l’ossatura anche apparente del volume, una
ossatura che l’ambiguo Bolognetti è il primo ad avvertire anche se i suoi
irretimenti bartolistici gli impediscono di compiere le scelte decise di un
Cujas.
PAOLO GROSSI
ANTONIO RIVERA GARCIuA, Reacción y revolución en la España liberal,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2006 (Biblioteca Saavedra Fajardo de
Pensamiento Polı́tico, 1), 355 pp.
Una vez superada definitivamente su habitual función de hacer
patria y construir Estado, acaso el futuro de la historia del derecho en
cuanto materia de docencia se cifre en su decidida conversión, por un
lado, en una introducción a las materias jurı́dicas, dando cabida a
capı́tulos hasta ahora descuidados como la historia criminal, las relaciones laborales, la constitución de la propiedad y el derecho internacional (1), y por otro, en una historia constitucional comparada, donde
los avatares nacionales figuren a modo de ejemplo o como instrumento
de contraste. El enfoque adoptado por esta segunda rama podrı́a
asimismo abandonar la tradicional y poco constitucional historia de las
instituciones estatales, tomando como clave de lectura la entidad de los
(1) Un primer ejemplo en este sentido lo facilita la misma escuela que impulsa
estos cuadernos en Maurizio FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato moderno in Europa.
Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 2002.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1865
LETTURE
derechos (2) e integrando sin reparos el lado cultural y más directamente teórico-polı́tico de la experiencia constitucional (3). Y precisamente la exposición de los modelos filosófico-polı́ticos circulantes en la
España decimonónica, con expresa consideración además del lugar
respectivo que en cada uno de ellos ocupaban los derechos, es el
servicio que a mi juicio rinde el excelente libro que se reseña a
continuación.
Es fruto de la encomiable consagración a la profesión académica de
su joven autor y del impulso dado a la investigación filosófico-polı́tica
por su maestro José Luis Villacañas. El aliento de este infatigable
filósofo de la Universidad de Murcia se percibe no sólo en la iniciativa
editorial que la obra inaugura, una colección de historia del pensamiento polı́tico cuidada por él mismo. Su huella también se hace
patente en la temática elegida — una historia polı́tica española que el
maestro se ha propuesto recorrer exhaustivamente (4) —, en la metodologı́a empleada — una weberiana reconstrucción de tipos ideales —
y en la sensibilidad ideológica exhibida — un republicanismo ilustrado
y liberal de estirpe kantiana que el mismo Villacañas ha expuesto de
modo sistemático en lo que interesa a la filosofı́a jurı́dica (5). Es, por
tanto, obra de escuela, gestada y debatida en los encuentros y seminarios del grupo Res Publica, según reconoce el propio autor (p. 32, n. 1),
pero al mismo tiempo goza éste de un perfil marcado, de intereses
singulares y, en definitiva, de una agenda cientı́fica propia. Filósofo,
jurista e historiador, Antonio Rivera combina en su prolı́fica carrera
literaria el estudio de los conceptos polı́ticos y los autores de la
modernidad con el examen del pensamiento público hispánico entre el
barroco, la ilustración y el liberalismo. A la primera de estas vertientes,
(2) Emulando el gesto de quien ilumina la configuración de los poderes desde la
integridad de los derechos y trata de pueblos mejor que de estados: Bartolomé CLAVERO,
El Orden de los poderes. Historias Constituyentes de la Trinidad Constitucional, Madrid,
2007.
(3) Siguiendo ahora la ruta excepcionalmente abierta por Pietro COSTA con su
Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, Roma-Bari, 1999-2001, 4 vols, y también
recorrida por António M. HESPANHA, Guiando a mão invisivel. Direitos, estado e lei no
liberalismo monárquico português, Coimbra, 2004. Para el caso hispano, Joaquı́n VARELASUANZES insiste en la conveniencia de conciliar para la historia constitucional el aspecto
jurı́dico con el teórico-polı́tico predicando con el ejemplo en la recopilación de trabajos
titulada Polı́tica y Constitución en España (1808-1978), Madrid, 2007.
(4) Examinando los diversos modos de legitimación del poder polı́tico activos en
nuestra cronologı́a, recorrida, por ahora, hasta el comienzo de la llamada Edad Moderna
con los tı́tulos La formación de los reinos hispánicos y Monarquı́a Hispánica publicados en
2006 y 2008 respectivamente.
(5) VILLACANx AS, Res Publica. Los fundamentos normativos de la polı́tica, Madrid,
1999.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1866
LETTURE
y siguiendo la lı́nea que para la historia jurı́dica han trazado autores
como Harold J. Berman, ha dedicado sus primeros ensayos sobre
Republicanismo calvinista (Murcia, 1999) y Clericalismo jesuita y Estado
moderno (Hildesheim, 1999), en los que se anudan teologı́a e historia de
la filosofı́a del mismo modo que lo hacen en su último texto sobre las
« patologı́as polı́ticas de la modernidad » (6). Y a la segunda de tales
derivaciones corresponde la monografı́a que nos ocupa, ocasión para
sistematizar y destilar intervenciones y contribuciones anteriores sobre
el « liberalismo doceañista », « la reacción católica » y el « republicanismo liberal español » (7).
Reacción y revolución abarca desde el primer liberalismo hasta el
fracaso de la I República y aborda el pensamiento de los principales
publicistas de la España liberal, sin perder de vista el escenario polı́tico
en que se formuló y sin descuidar tampoco sus implicaciones jurı́dicas
más relevantes. El trabajo oscila entre el comentario de la obra de
autores singulares y la reconstrucción de modelos teóricos generales
con el examen de cada uno de los factores que los conforman. Por su
mayor complejidad y abstracción, es este último polo reconstructivo el
más sustancioso cientı́ficamente. De una primera aproximación parece
deducirse que el relato está compuesto del análisis de cinco sistemas
teóricos más o menos sucesivos cronológicamente: el liberalismo gaditano, el liberalismo progresista, el liberalismo moderado, el tradicionalismo católico y el republicanismo federal. Mas, en realidad, de una
lectura más detenida se infiere que tres fueron los protagonistas de la
cultura jurı́dico-polı́tica decimonónica, figurando en primer lugar los
impulsores de la revolución liberal, en segundo los responsables de la
reacción y en tercero los defensores de un « justo medio » entre ambos
extremos revolucionario y reaccionario. El mapa de nuestro libro
quedarı́a entonces marcado por dos paradas principales, las relativas al
moderantismo — « responsable de la corrupción del sistema liberal »
(p. 103) — y a la « constitución monárquica y tradicional », y atravesado por un hilo conductor, el de la revolución liberal y democrática,
(6) Vid. El dios de los tiranos. Un recorrido por los fundamentos teóricos del
absolutismo, la contrarrevolución y el totalitarismo, Córdoba, 2007, texto también
fraguado en el grupo Res Publica que, convocado por Villacañas, se reúne « en Murcia
para debatir libremente sobre filosofı́a e historia de los conceptos polı́ticos », p. 33 n. 2.
(7) Baste citar los siguientes textos preparatorios: El concepto de libertad en la
época de las Cortes de Cádiz, en Manuel CHUST, Ivana FRASQUET (coords.), La trascendencia del liberalismo doceañista en España y en América, Valencia, 2004, pp. 93-114; La
reacción católica. El pecado liberal y la constitución tradicionalista en la España del siglo
XIX, en Ángel RIVERO, Francisco COLOM (coords.), El altar y el trono. Ensayos sobre el
catolicismo polı́tico iberoamericano, Madrid, 2006, pp. 17-42; El republicanismo liberal
español. Libertad, democracia y asociación en el pensamiento republicano del siglo XIX, en
« Spagna contemporanea », 30, 2006, pp. 49-70.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1867
LETTURE
con su irrupción primera a principios de siglo, su atemperación posterior en la versión del progresismo y su radicalización ulterior en los
libros y folletos de los federalistas, demócratas y republicanos, por
quienes, en sincera y esclarecedora conexión, el autor expresa su
simpatı́a desde el mismo encabezamiento de su obra, paráfrasis del de
aquella otra suscrita por Francisco Pi y Margall bajo el tı́tulo La reacción
y la revolución (Barcelona, 1854).
La estructura expositiva de nuestra monografı́a suele detenerse en
los fundamentos filosóficos, morales y sociales de cada una de las
corrientes citadas, ası́ como en la organización de los poderes y en la
condición y amplitud de los derechos postuladas por todas ellas.
Equiparando la justicia al equilibrio entre autoridad y libertad, el
moderantismo de los Joaquı́n Francisco Pacheco, Antonio Alcalá Galiano o Francisco Martı́nez de la Rosa constituye ası́ una tendencia
identificada moralmente con el utilitarismo, socialmente con la « mesocracia » — es decir, con el protagonismo institucional de los poseedores de las riquezas y las « capacidades » — y polı́ticamente con la
soberanı́a compartida. Con tales premisas, especialmente con aquella
utilitarista que atribuye preponderancia a los intereses generales de la
nación frente al individualismo exacerbado, el espacio de las libertades
queda bien angosto, subordinadas como están al mantenimiento del
« orden público » (p. 21) y no siendo en ningún caso naturales e
ilegislables, sino más bien materia decidida y concretada por la ley
estatal (pp. 152 ss.). El único margen dejado al discurso de la libertad
incide no tanto en los atributos naturales del individuo dignos de
reconocimiento y protección cuanto en las condiciones indispensables
de un poder público ordenado y legı́timo. Y tales requisitos se resumen,
como se ha sugerido, en la conveniencia realista de que las instituciones
integren y reproduzcan a los factores económica, intelectual y espiritualmente prevalentes de la sociedad, lo cual implica, a mi entender,
que el conservadurismo continuaba otorgando prioridad a la legitimidad sobre la legalidad.
Al recaer entonces todo el peso sobre la organización del Estado,
el autor, con buen criterio, pormenoriza los aspectos teóricos de la
administración doctrinaria, comenzando por su principal axioma, el
que, desvinculando « soberanı́a » y « representación », « derecho civil y
natural », « poder constituyente y constituido » (p. 112, p. 116), abre la
inevitable pendiente autoritaria del moderantismo. Una deriva plasmada de modo rutinario en una « omnipotencia parlamentaria » equivalente a la omnipotencia del poder ejecutivo del monarca y sus
ministros y materializada de modo extraordinario en la dictadura
ejercida por el « hombre o institución providencial », por aquel sujeto
o « cuerpo » (militar) con suficiente poder fáctico para imponer el
orden en una « situación excepcional » (p. 115).
Si en la exposición de la doctrina moderada prima el análisis de su
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1868
LETTURE
programa institucional, en el tradicionalismo católico destaca el examen
de sus fundamentos. Ubicados en esta perspectiva, queda bien patente
el contraste entre la noción moderna de la libertad como « autolegislación » y su concepto « antimoderno » como obediencia a una heterónoma « ley natural » (p. 163), entre el entendimiento racionalista de la
historia como progresiva « liberación del hombre » y la « teologı́a de la
historia » que siempre halla tras los acontecimientos el eco de la
providencia (pp. 173 ss.), entre la ruptura reformadora y la « continuidad del presente con la sabidurı́a de la Edad Media » (p. 243), en
definitiva, entre la autonomı́a gradual del hombre y el « pecado monstruoso » de querer actuar como dios creando sus propias normas (p.
178, pp. 181 ss., p. 210). En su presentación de las doctrinas de — entre
otros — Juan Donoso Cortés, Jaime Balmes y Antonio Aparisi Guijarro,
Rivera muestra en mi opinión su lado más enérgico y convincente, y
aunque en ocasiones desmerezca « las farragosas argumentaciones »
reaccionarias (p. 194), reconoce asimismo la corrección y profundidad
de sus diagnósticos (p. 186). La identidad tradicional queda además
fijada por su pertinente contraste con el socialismo revolucionario, al
que a un tiempo admira por consecuente y teme por disolvente, y por
el necesario — y a mi entender no culminado — cotejo con el
moderantismo, convergente en tantos puntos — algunos más de los que
el autor expresamente indica — con los principios tradicionalistas que
resulta más conservador que liberal (p. 171).
Por lo que respecta a la faceta normativa del tradicionalismo, en
relación a los derechos, junto a las beligerantes opiniones de los autores
católicos contrarias a las libertades de imprenta y cultos, se percibe de
nuevo que la protección de la libertad vuelve a radicar en una determinada organización del poder, concretamente la dictada por una
« constitución mixta » donde los lı́mites sean los sustantivos de la
religión católica y los materiales de los « cuerpos intermedios » (pp. 252
ss.) en vez de los adjetivos y formales de la « artificiosa » constitución
liberal. En lo relativo a los poderes, el libro de Rivera defiende como
conclusión la controvertible tesis de la « nación católica » como « nación sin Estado » (pp. 279 y ss.), convicción discutible porque la nación
del Estado liberal no fue sola ni principalmente la revolucionaria de los
individuos — formalmente — « libres e iguales », sino la romántica,
orgánica e histórico-natural del tradicionalismo en la que encaja sin
fricciones la conceptuada por los católicos. Nuestro texto delinea
también a este respecto el perfil institucional postulado por los reaccionarios, introduciendo con eficacia, en el lado negativo, la precoz
crı́tica reaccionaria al parlamentarismo, instrumento divisivo incapaz de
representar la unidad social, y en el afirmativo, la organización pública
perseguida por los tradicionalistas, estructura institucional cuyo pluralismo corporativo la hace inconfundible con una totalitaria unidad sin
mediaciones (p. 263), aunque sı́ resulte compatible con la admisión de
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1869
LETTURE
una dictadura militar algo diversa de la moderada, visto que para la
reacción los desórdenes revolucionarios que la justificaban no eran sino
un sı́ntoma de « la decadencia de la religión católica » y del olvido de
la « constitución histórica » que el dictador tenı́a precisamente como
misión restaurar (pp. 271 ss.).
Junto a los modelos antedichos, y recorriendo de principio a fin
nuestro volumen, figuran los defensores de la revolución liberal, auspiciada en primer lugar por un temprano liberalismo basado en los
principios de la soberanı́a nacional y la separación de poderes, ralentizada después por un progresismo internamente contradictorio y sin
personalidad propia e intensificada finalmente por los federalistas,
republicanos y demócratas que reclamaban la universalización de los
derechos polı́ticos. A los fundamentos de esta revolución — soberanı́a
popular y derechos naturales universales — se adhiere el autor identificándolos, en su más acabada expresión demócrata, con el « republicanismo liberal » (p. 30) y reconociendo asimismo su deficitaria materialización efectiva a lo largo de todo el siglo (p. 16). Ahora bien, la
merma de los axiomas liberales residı́a asimismo en el terreno discursivo: ası́ ocurrı́a con la sustracción deliberada de derechos a buena parte
de la población defendida por los liberales gaditanos, según señala el
mismo Rivera (8), como también acontecı́a con la problemática « universalidad » de los « derechos civiles » o con un no menos elitista
concepto de « pueblo » o de « soberanı́a nacional », asuntos sobre los
que el autor no llega a incidir. Fueron, en efecto, los demócratas
radicales y federalistas republicanos los que, rompiendo con la tibia
doctrina progresista, declararon natural, ilegislable y universal tanto la
libertad civil como la polı́tica (p. 289), propugnaron la justicia ciudadana y reivindicaron una plena soberanı́a popular remontando el mito
del « pueblo indiviso » (p. 296). Rivera expone con tino y estrategia este
republicanismo liberal, cualitativamente diverso del colectivismo comunista y del invasivo jacobinismo, con teorı́a propia del pacto social en la
que los sujetos nunca ceden su soberanı́a y nada ajeno a los fundamentos tradicionales del orden social. La dificultad estriba entonces en
cómo derivar, sin incurrir en teleologı́a — o sea, en una secularizada
teologı́a de la historia — esta comprensión extensiva — aunque todavı́a
insuficiente — de los derechos y la democracia de unas bases primeras
expresamente excluyentes, pues acaso la realización del programa
(8) En las pp. 78-79, pasando de puntillas sobre el controvertido estatuto de los
« sirvientes domésticos », expresamente excluidos del juego polı́tico por el liberalismo
doceañista. Vid. sobre el asunto Bartolomé CLAVERO, Amos y sirvientes. ¿Primer modelo
constitucional?, en « Anuario de Historia del derecho español », 56, 1986, pp. 995-1016
y Carlos PETIT, Amos, sirvientes y comerciantes: algo más sobre el primer modelo
constitucional, en ID. (ed.), Derecho privado y revolución burguesa, Madrid, 1990, pp.
87-122.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1870
LETTURE
ilustrado, racionalista y liberal requiriese, más que el desarrollo, depuración o perfeccionamiento de sus comienzos, una resuelta ruptura con
el liberalismo y sus connaturales exclusiones.
SEBASTIÁN MARTIuN
RODOLFO SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria
del diritto, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 352, collana « Collezione
di testi e di studi. Diritto ».
1. Storia, antropologia, etologia, filosofia, linguistica, religione,
senza beninteso dimenticare diritto e comparazione giuridica (si tratta
pur sempre dell’opera d’uno dei massimi giuristi italiani viventi (1)): se
questo è il background disciplinare sul cui sfondo il volume va letto,
risibile in partenza sarebbe il tentativo di darne conto nel battito d’ali
d’una recensione. Neppure un libro intero basterebbe. Meglio allora dir
d’anticipo che si è dinanzi ad un testo seminale: « contiene semi », essi
germogliano col leggere e rileggere, meglio, col ruminare. Non per caso
un verbo d’animali aiuta per un’opera che fa loro buon posto, per
fortuna più vichiani « scimmioni » (« Società animali […] che più
assomigliano all’uomo nel fisico e nei comportamenti » (2), ad esempio
« spidocchiare oggi ed essere spidocchiato domani » (3)) che non
hobbesiani lupi.
Il volume ha già un’edizione francese (4), certamente anche a
motivo dell’appassionato rinvio che Sacco effettua in più punti alla
Francia (« Paese dell’antropologia giuridica per eccellenza » (5)) ed alle
opere dei « sommi antropologi dell’area francofona » (6): Durkheim e
(1) P. CENDON (a cura di), Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione
giuridica alle soglie del 3° millennio, Milano, Giuffrè, 1994, due tomi. Si veda nel tomo
primo la Biografia (non firmata, con tutta probabilità di Sacco lui-même), nonché la
Bibliografia collazionata fino al 1994 (nel prosieguo, si farà rinvio a questi testi con B).
(2) A (=SACCO, Antropologia giuridica), p. 33.
(3) Ivi, p. 310.
(4) R. SACCO, Anthropologie juridique. Apport à une macro-histoire du droit, Paris,
Dalloz, 2008, collana « L’esprit du droit ». La giovane collection ospita al suo interno già
altra opera di provenienza italiana, confermandosi luogo editoriale dal respiro compiutamente interculturale.
(5) A, p. 37. In Francia esiste un’opera omonima, N. ROULAND, Anthropologie
juridique, Paris, Puf, 1988, trad. Antropologia giuridica, Milano, Giuffrè, 1992 (=AG),
ampiamente menzionata da Sacco, spec. A, p. 23 n. 16.
(6) Ivi, p. 20.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1871
LETTURE
Mauss (i padri), nonché C. Lévi-Strauss, H. Lévy-Bruhl, M. Alliot, R.
Verdier, N. Rouland, E. Le Roy, fra gli altri.
È già stato detto che si è in presenza di un’antropologia filosofica
a tutto tondo, non solamente giuridica, la quale « coraggiosamente »
suscita « immani questioni » appunto sul piano filosofico (7). Scomodando Villey e Bobbio, è possibile aggiungere che si tratta dell’antropologia filosofica d’un giurista, specificando inoltre che si è forse in
presenza d’una prima assoluta in tema (8). Il che potrà aiutare nel
concentrar l’attenzione maggiormente sulla complessità strutturale
dello sforzo compiuto invece che sulle singole parti, e non perché
l’attenzione vada sviata da esse, anzi! È lo sforzo d’immaginazione
complessiva che va in primis evidenziato. Immaginazione felice, immaginazione feconda.
Non è facile metter a nudo le fonti filosofiche del giurista Sacco, il
quale peraltro aspirava in gioventù a farsi storico del medioevo del
diritto (9). Ma alcune tracce possono esser seguite, peraltro a proposito
d’una ricerca che spesso ricorre essa stessa a ragionamenti congetturali
e « pure ipotesi (ardite) » (10). Le tracce sono: un Premio Capograssi nel
1988, con successivo conferimento di cittadinanza onoraria del comune
di Sulmona (11), luogo natale dell’autore de Il problema della scienza del
diritto; un esplicito rinvio al « criterio di validazione vichiano verum
ipsum factum » (si sa quanto importante anche per il giusfilosofo
sulmonese), nella comparazione giuridica quale « scienza storica che si
dedica a ciò che è reale », i « dati effettivi » e non il metodo dogmatico (12); in generale, le « prospettive di tipo epistemologico » (13) e il
(7) A. G. CONTE, Erlebnisrecht. Diritto vissuto/esperienziale nell’antropologia
filosofica di Rodolfo Sacco, « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 3, 2008, p.
407: « Prima domanda: Qual è lo statuto ontologico delle norme? Seconda domanda: È
possibile inferire norme da comportamenti? ». Cfr. anche A. G. CONTE, Nomotropismo:
agire in funzione di regole, « Sociologia del diritto », 1, 2000.
(8) L’Antropologia giuridica di Rouland aveva aperto una porta in questa direzione, affrontando nella Conclusione generale il tema Antropologia giuridica e metafisica,
cfr. AG, pp. 453-58.
(9) Si legge in B, p. VIII-IX. Il legame con la storia è rimasto intatto: « Il diritto
muta, instancabilmente. Il giurista […] ha bisogno degli strumenti conoscitivi adatti, e
questi strumenti sono insegnati al giurista dallo storico. Il giurista ha dunque un debito
con la storia », A, p. 22.
(10) Ivi, p. 194, 205, 206, 248.
(11) B, p. XXVIII.
(12) R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, Utet, 1992 (= I), pp.
50-53. Detto con i giusrealisti scandinavi, Law as Fact; detto con Carbonnier, Le droit
comme phénomène.
(13) B, p. X; A, p. 197; la prima e la quarta delle cinque Tesi di Trento, cfr.
Comparazione giuridica, « Digesto. Discipl. priv., sez. civ. », III, 1988 (=TT), p. 48 ss.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1872
LETTURE
dialogo col « grande » (14) epistemologo tedesco Joseph Esser; qua e là
nelle opere, con parsimonia, i nomi di Hare, Hayek, Leoni, Austin,
Searle (15).
Qui si vuol adesso aggiungere un elemento ulteriore, forse nuovo
anch’esso nello sforzo interpretativo (16) attorno al volume: la presenza
in esso di Lucien Lévy-Bruhl, storico della filosofia alla Sorbona nei
primi decenni del Novecento, poi etnologo nella seconda parte della
vita fino alla scomparsa nel 1939; definito genio da Sacco (17). Reciprocamente qualcuno, definendo genio Sacco, potrebbe altresı̀ evidenziare
anche nel suo caso un simile transitare fra discipline diritto poi antropologia. Genialità di metamorfosi nella conoscenza.
Sacco è uno dei rari studiosi contemporanei ad aver serbato
memoria dell’autore di opere quali Les fonctions mentales dans les
sociétés inférieures (1910) e Le surnaturel et la nature dans la mentalité
primitive (1931). Egli cita la prima non solo nei Riferimenti bibliografici,
bensı̀ più volte direttamente (18), nonché indirettamente attraverso
l’impiego di concetti quali « logica della partecipazione » (o « i partecipi », componenti il gruppo sociale), « soprannaturale », « mentalità » (19).
Ma soprattutto, quella presenza è ben palpabile nel rimando ai
sentimenti che l’epistemologo Sacco effettua in tutto il corso dell’opera
in analisi, sfera di quella che Capograssi (anch’egli conoscitore di
Lévy-Bruhl (20)) chiamava « vita emozionale », esperienza tout
court (21). Ed è noto che Lévy-Bruhl definiva l’expérience affective in
termini di mystique, vale a dire « esperienza di una rivelazione e, al
(14) B, p. XII.
(15) In A si veda, p. 185, 246, 202.
(16) In CONTE, Erlebnisrecht, cit., va segnalata la nota 6 alla p. 407: elenco delle
analisi cui il volume di Sacco è stato sottoposto, a tutto maggio 2008.
(17) Comunicazione orale pubblica, Trento, 27 marzo 2009. Nell’occasione egli
menzionò anche l’antropologo Leo Frobenius, studioso della « commozione » e del
paideuma quali doni che aprono l’uomo alla « concezione della realtà, […ed alla… ]
facoltà di esser commossi dalla essenza dei fenomeni », L. FROBENIUS, Storia delle civiltà
africane, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 49-56.
(18) A, p. 187n, 211n.
(19) Ivi, p. 124, 140, 198, 207ss. ecc. Anche I, p. 128, « La soggezione ai crittotipi
costituisce la ‘mentalità’ del giurista di un determinato paese ».
(20) G. CAPOGRASSI, Agricoltura, diritto, proprietà [1952], in Opere di Giuseppe
Capograssi (= O), t. V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 284 n. Capograssi fa uso del concetto
di « partecipazione » in relazione al legame fra legge, volere personale e realtà già nel
Saggio sullo Stato del 1918 (ivi, t. I, p. 75-76); nonché, in rapporto alla « importanza e
autonomia della vita sentimentale », fin dagli Studi sull’esperienza giuridica del 1932 (ivi,
t. II, pp. 224-25, nonché 237-39, 289-90, 320-21).
(21) Ivi, p. 227.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1873
LETTURE
contempo, complesso psichico nel quale gli elementi affettivi occupano
un posto preponderante » (22).
L’Antropologia giuridica di Sacco, in effetti, fa ampio spazio agli
elementi affettivi, quelle che un filosofo secentesco avrebbe chiamato
« passioni » (23). Ciò si può notare fin dall’Indice del volume, nel quale
compaiono in più punti vocaboli quali « sentimento della propria
inferiorità », « gelosia », « desiderio di imitazione », « sentimento della
superiorità della propria cultura », « fedeltà », « egoismo », « solidarietà ».
Una citazione a mo’ d’esempio: « Poiché la gelosia culturale non è
razionale, e razionalmente non si giustifica, l’interpretazione della storia, prigioniera della propria razionalità, non ama farle il posto che essa
merita. La politologia, l’etnopsichiatria non la mettono al centro della
loro attenzione. Ma la gelosia nei confronti delle culture più appaganti
è una delle chiavi fondamentali della storia dell’uomo. […]. Beninteso,
accanto alla gelosia culturale troviamo altre forme di gelosia, più
facilmente ricostruite (e confessate): ad es., la gelosia economica. Non
sempre sarà facile distinguere una gelosia dall’altra » (24).
2. Ma dunque, com’è articolata un’opera simile? Un primo approccio ad essa potrebbe anche offrirsi classificandola nella sempiterna
categoria della manualistica: trattandosi della sintesi del lavoro d’un’intera esistenza dedicata alla comparazione giuridica, in quelle pagine è
depositato un sapere completo ed articolato, certamente sintetizzato
nelle parti che ne scandiscono il percorso ma altrettanto capace di
offrire al lettore, allo studioso, tutti i riferimenti necessari — tematici,
nell’articolazione delle cinque parti, dei capitoli, dei paragrafi; bibliografici, con oltre venti pagine in coda — al fine di esser introdotti, poi
continuare in proprio, una ricerca sulla macrostoria del diritto. Che è
poi quel che si chiede ad un manuale vero e proprio. Manuale di diritto
muto e parlato, ecco l’altro possibile titolo del libro.
Cinque le parti, come cinque sono le Tesi di Trento sulla comparazione giuridica cui Sacco contribuı̀ in modo decisivo nel 1987: il
parallelo regge nel dettaglio. La Parte prima è dedicata a La varianza del
diritto, vale a dire a porre le fondamenta della « conoscenza comparante » del diritto: conoscenza in chiave antropologica che si apre
all’etnologia, all’etologia (25), allo studio della cultura e della variabilità
(22) L. LÉVY-BRUHL, L’expérience mystique et les symboles chez les primitifs, Paris,
Félix Alcan, 1938, pp. 9-10.
(23) E che Capograssi nomina ancora cosı̀: O, t. I, pp. 50-55; t. II, p. 250.
(24) A, p. 64.
(25) « Le facoltà giuridiche potrebbero predisporre per i propri studenti, accanto
ai corsi di antropologia, corsi di etologia. […]. In Italia, il decano dei civilisti [Angelo
Falzea, cui il volume è dedicato] è un precursore, e vede che l’informazione antropologica
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1874
LETTURE
del diritto (inclusa la sua possibile, storica, uniformità), in chiave di
pluralismo giuridico.
« Antropologia giuridica e comparazione giuridica rientrano a pari
titolo nella conoscenza comparante; differiscono perché si interessano
ad aree un po’ diverse. La comparazione che abbiamo sotto gli occhi
tende ad ignorare le società ‘senza scrittura’ e senza strutture di potere
centralizzato » (26). Ma Sacco cita in nota nella medesima pagina la
previsione dell’antropologo Griffiths, « Un giorno le due discipline si
confonderanno ». Il volume in analisi mostra che quel giorno, forse, è
infine giunto.
È la macrostoria a far la differenza dalla « comparazione che
abbiamo sotto gli occhi »: si tratta dello « studio del divenire umano nel
suo intiero svolgimento », a partire da homo habilis (fra - 2.500.000 e 1.600.000 anni) e in generale dall’epoca paleolitica; insomma, qualcosa
di più ampio di una semplice « preistoria ». Qui deve soccorrere
appunto l’etologia, lo studio delle società animali nei loro comportamenti e legami, in certo senso, pregiuridici.
« La parola, una volta nata, dilaga. Fabbrica curiose realtà fatte di
parole. […]. L’atto muto non riesce a costituire oggi un’obbligazione
destinata ad avere esecuzione in un dato momento del futuro. La parola
può creare quella obbligazione. […]. La parola ha vinto. Ha sopraffatto
il diritto muto. Ma sopraffare non vuol dire cancellare. Il diritto muto
è arretrato. È diventato consuetudine e uso. È diventato diritto inferenziale. È diventato crittotipo. È entrato in uno stato di latenza. Non
ha cessato di esistere. L’etologo sapiente ci dice che anche oggi nell’uomo c’è tutto l’animale. Il giurista gli risponde che anche oggi nel
diritto dell’uomo dell’informatica soggiace il diritto dell’uomo delle
origini, continuazione del prediritto dell’antenato prossimo dell’uomo » (27). Homo duplex, diceva Durkheim; logica della partecipazione e razionalità convivono, specificava Lévy-Bruhl.
La Parte seconda studia la comparazione giuridica facendo uso dei
« criteri di validazione delle scienze storiche »: Il diritto nella diacronia,
le grandi epoche del diritto. Nascita del giurista, nascita del legislatore,
nascita del potere dello stato in società a potere diffuso, emersione del
soprannaturale (magia, religione) e del linguaggio (beninteso, sempre in
rapporto al diritto) all’epoca del muto, la quale, come si vedrà a breve,
non è solamente categoria d’analisi dell’ars cinematografica bensı̀ anche
dell’ars boni et æqui. Il capitolo ospita un godibilissimo intermezzo
e etologica potrebbe incidere sulla formazione del giurista. Da qualche anno, la ‘Rivista
di diritto civile’ ospita saggi di giovani che si tengono al corrente di ciò che l’etologo
trova nell’area di interesse del giurista », ivi, p. 35.
(26) Ivi, pp. 22-3.
(27) Ivi, p. 195.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1875
LETTURE
d’analisi Law & Literature, ripercorrendo il processo a Gano di Magonza nella Chanson de Roland (28).
La Parte terza offre lumi per la « misura delle differenze che
intercorrono fra i sistemi giuridici »: strumenti ne sono la legittimazione
dell’autorità e del potere studiata alla luce della « naturalezza » delle
possibili giustificazioni (senso etico, timore della forza dell’apparato
sanzionatorio), nonché delle differenti, possibili soluzioni in chiave
sincronica nelle diverse aree considerate (protezione-educazione, competenza nel soprannaturale, consuetudini, famiglia allargata e baronia,
partito, ecc.). Detto en passant, è la parte del volume dove più sensibile
aleggia l’approccio weberiano alla Macht ed alla Herrschaft: si fa parola
non solo di questioni di legittimazione attinenti potere e diritto ma
anche del carisma (« Personaggio dominante ») e del suo potere, e ciò
in un contesto generale nel quale le analisi procedono wertfrei (29) e su
base idealtypisch (l’uomo del soprannaturale, l’impero, la città operosa,
ecc.). La Parte si chiude sull’analisi di quel che corrisponde, nei rapporti
umani, al diritto cosı̀ giustificato: la figura che aiuta è quella della
subalternazione dell’uomo all’uomo, con le molte possibili metamorfosi
(in società a potere diffuso e a potere centralizzato, nel conflitto di
poteri, ecc.)
Parte quarta: compatibilità fra « regole operazionali e proposizioni
teoretiche elaborate per rendere conoscibili le regole operazionali ». È
il capitolo più innovativo e fascinoso del volume, quello per il quale
verrebbe di contraddire l’« anonimo » estensore della Biografia laddove
egli afferma che Introduzione al diritto comparato sarebbe « l’opera che
dovrebbe sopravvivergli » (30). Ben deputato a quel compito potrebbe
invece essere il volume in recensione, o almeno — considerato che si
tratta di auspici — nel caso potranno sopravvivergli entrambe.
Due capitoli in questa Parte: quello su Il diritto, il pensiero, la
parola, dove Sacco offre il meglio di sé, nel senso che offre la « sua »
scoperta nell’analisi della fonte muta. « L’autore di queste pagine (lui
solo, però) guarda con favore l’espressione diritto muto » (31), intendendo diritto « spontaneo », creato senza intervento dell’autorità né di
rivelazioni o giudici o sapienti. Insomma, « diritto vivente » (versione
Ehrlich), law in action, effettività. È il diritto di quanti « osservano » la
(28) Sulla « importante » proposizione normativa che « si esprime in discorsi
(prosa o poesia), […] rivela[ndo] il diritto senza ben precisarne i termini », si veda il
paragrafo Il proverbio, regola di diritto semiverbalizzata contenuto in R. SACCO, Il diritto
non scritto (=D), in G. ALPA ET AL., Le fonti non scritte e l’interpretazione, Torino, Utet,
1999, pp. 68-69. Superata l’epoca macrostorica del muto, afferma Sacco, « La parola
narra il diritto », A, p. 195 (sottolineatura mia).
(29) Ivi, pp. 24, spec. 26-27, 86. Weber non è mai citato nel volume.
(30) B, p. XVI.
(31) A, p. 179.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1876
LETTURE
regola (32): al centro dell’analisi viene non il diritto bensı̀ l’atto di
esercizio del diritto, nonché il suo opposto, l’adempimento del dovere.
Insomma, analisi delle consuetudini (33) attraverso correlazione fra
regole ed atti. Il capitolo studia nel dettaglio anche il rapporto tra parola
e diritto, evidentemente la verbalizzazione della regola.
Si è in tal modo nominato il cuore dell’opera e, più in generale,
dell’intera vita d’un giurista e filosofo: diritto muto (34). È qui che il
volume mostra la pertinenza della definizione che Carbonnier dava
dell’antropologia giuridica qua disciplina: « Renaissance à sa façon d’un
droit naturel, [… il quale dovrà contare …] moins sur le droit comparé
que sur l’ethnologie » (35). Ma forse, a ben vedere, lo sforzo di Sacco va
proprio nella direzione d’allargare il concetto medesimo di « comparazione giuridica », facendo rientrare a pieno titolo nella misurazione
delle differenze e delle identità tra sistemi giuridici anche i sistemi di
diritto naturale, e tutti quei possibili sistemi, i muti inclusi, non solo i
parlati.
Il secondo capitolo in questa Parte è per intero consacrato ad
analisi fini sul rapporto tra il surnaturel e la verità in campo giuridico:
si sente il fascino che il tema esercita su Sacco, si tratta forse del capitolo
più « sperimentale » del volume (et pour cause! esperienza, sentimenti...). Dunque storia, sociologia religiosa, teologia, sari’a e ius…
Quinta parte, l’ultima, dedicata alle « informazioni » o istituti in
prospettiva macrostorica, la più tradizionale in un manuale se di
manuale qui si tratta: la partizione pubblico/privato, i gruppi, le
persone, i beni, i servizi, i conflitti.
3. Si sarà compreso: Antropologia giuridica di Sacco confina non
poco con la sociologia (36), nonché con la sociologia giuridica (37), a tal
(32) Cordero scrisse un libro dal titolo Gli osservanti. Fenomenologia delle norme,
Milano, Giuffrè, 1967; Torino, Aragno, 20082.
(33) Si veda anche tutto D.
(34) Scrive CONTE, Erlebnisrecht, cit., p. 410 e nota: « Che cosa significa, in
Rodolfo Sacco, l’aggettivo ‘muto’? La duplice affinità (affinità fonica, affinità semantica)
tra ‘muto’ e ‘mistico’ non sembra essere indizio di affinità etimologica ». La questione,
indirettamente, è cosı̀ posta, peraltro da un autore attento alla mistica: Wittgenstein e
Silesius sono presenti in CONTE, Nomotropismo, cit., p. 28.
(35) J. CARBONNIER, L’apport du droit comparé à la sociologie du droit, in J.
CARBONNIER, Écrits, Paris, Puf, 2008, p. 1185.
(36) A, p. 23: « In un primo tempo l’antropologo era per definizione uno studioso
di popoli esotici (se si fosse interessato all’Europa occidentale, si sarebbe chiamato
sociologo e non antropologo) ». Ricorre peraltro in lungo e in largo, nel volume, la
categoria durkheimiana della divisione sociale del lavoro.
(37) Ibid., riferimento ad Ehrlich. Eppure, « Ehrlich viene elogiato e citato, e non
imitato », ivi, p. 179.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano
1877
LETTURE
punto da rendere perplesso il lettore quando vede sostanzialmente
taciuto — in parti non minime dell’intera opera, quelle che egli
controlla — il nome d’un giurista sociologo, contemporaneo di Sacco a
quasi tutto il 2003, Jean Carbonnier, studioso molto attento alla prospettiva comparatistica (38).
La chiusa della recensione è dedicata, cosı̀, al dialogo interdisciplinare: forse merita proseguire nella comparazione anche di categorie
epistemologiche, per esempio diritto muto e non-droit. Entrambe sono
« categorie affettive del soprannaturale », esattamente nel senso inteso
da Lévy-Bruhl: entrambe sanno far di conto col tema della « necessità »
in rapporto alla visione della giustizia (39); entrambe omaggiano il
« sommo principio della reciprocità », o « istituzione antenata » (40),
quale base del futuro adattamento alla vita giuridica.
Anche il diritto « naturale » di Sacco piacerebbe al geniale scopritore del non-droit: « La natura dell’uomo è mutevole. Quel diritto
‘razionale’ che appartiene al sapiens di questi ultimi secoli corrisponde
alla natura dell’uomo venuto dopo i metalli e dopo secoli di meditazione e di sapere. È dunque un diritto debitore di sé alla natura. Ma sarà
meglio non chiamarlo diritto naturale, perché quel nome è legittimamente detenuto da quella realtà che sapienti di un altro tempo hanno
acutamente definito come ius quod natura animalia docuit » (41).
Carbonnier sottoscriverebbe, non v’è dubbio — anzi assente,
muto.
FRANCESCO SAVERIO NISIO
(38) Unici riferimenti a Carbonnier incontrati: D, p. 77 (in tema di legittimazione
mitologica della consuetudine); tre ricorrenze nell’analisi sistemologica del « modello
francese » (analisi, formalmente, non di Sacco) in A. GAMBARO-R. SACCO, Sistemi
giuridici comparati, Torino, Utet, 2002, p. 287, 300, 322. Su Carbonnier e la comparazione, retro, nota 34, poi J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, Puf/Quadrige, 2004,
pp. 20-23; Droit civil, Paris, Puf, 2004, pp. 153-64; A beau mentir qui vient de loin, ou
le mythe du législateur étranger, in J. CARBONNIER, Essais sur les lois, Paris, Répertoire du
Notariat Defrénois, 19952.
(39) A, p. 323.
(40) Ivi, pp. 283, 310-11.
(41) Ivi, p. 149.
© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano