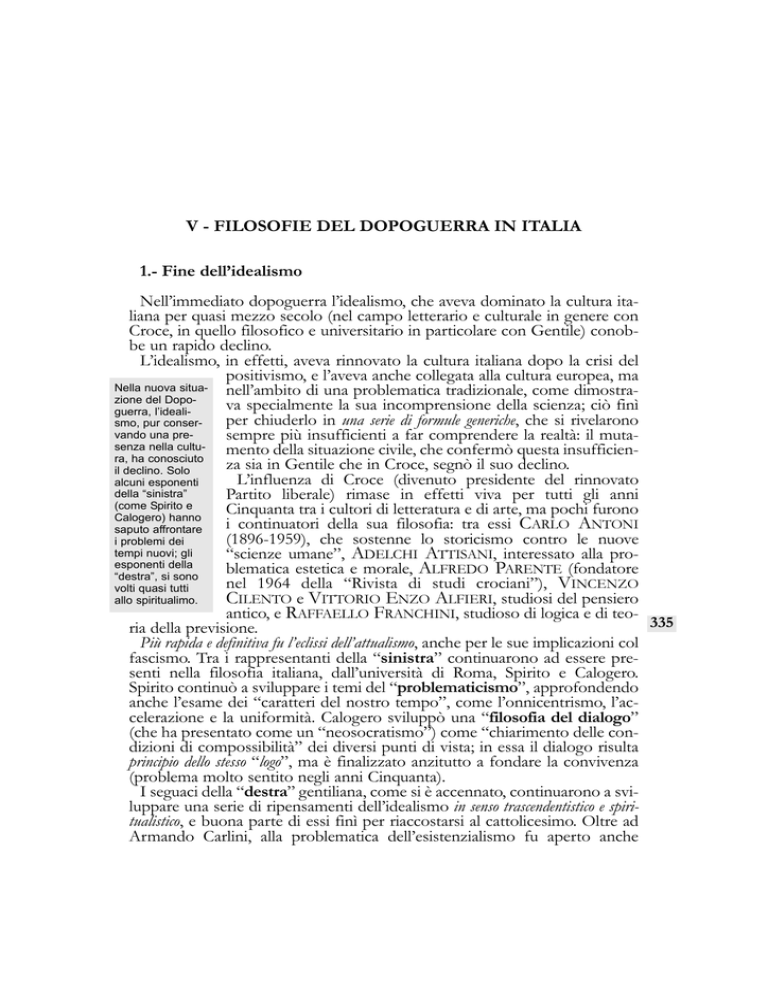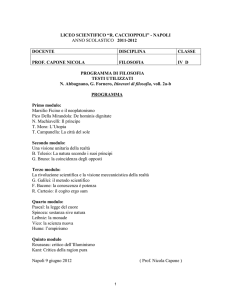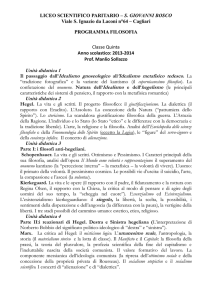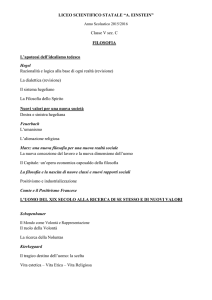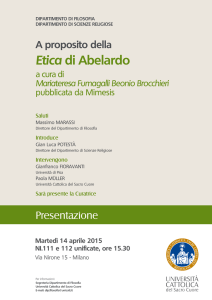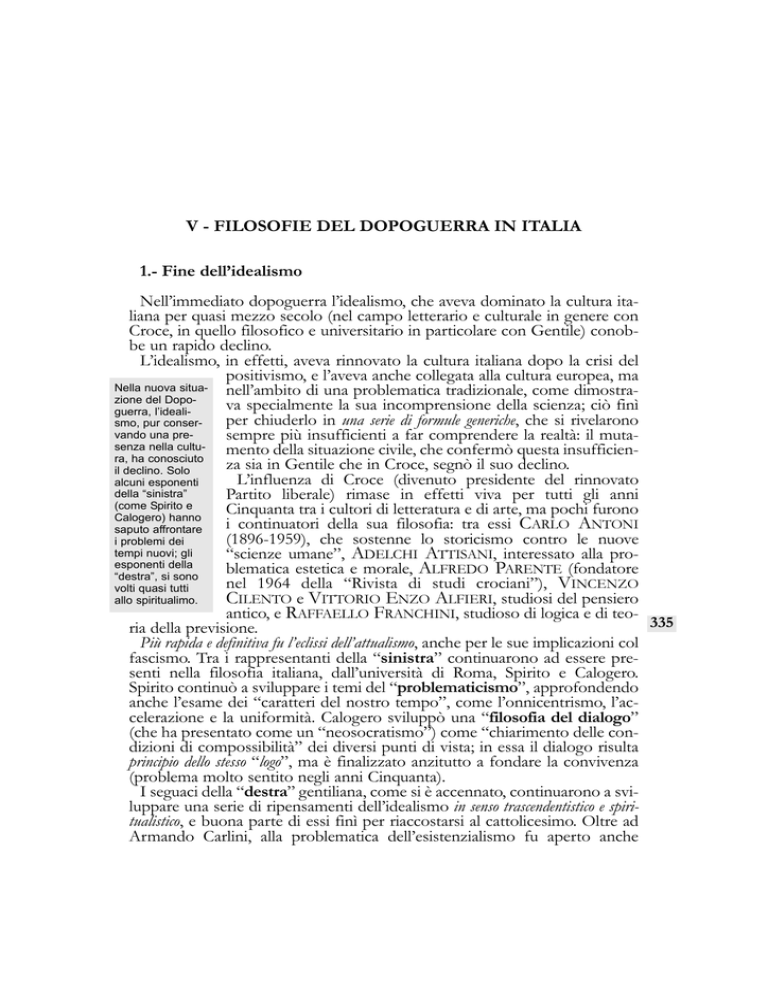
V - FILOSOFIE DEL DOPOGUERRA IN ITALIA
1.- Fine dell’idealismo
Nell’immediato dopoguerra l’idealismo, che aveva dominato la cultura italiana per quasi mezzo secolo (nel campo letterario e culturale in genere con
Croce, in quello filosofico e universitario in particolare con Gentile) conobbe un rapido declino.
L’idealismo, in effetti, aveva rinnovato la cultura italiana dopo la crisi del
positivismo, e l’aveva anche collegata alla cultura europea, ma
Nella nuova situanell’ambito di una problematica tradizionale, come dimostrazione del Dopova specialmente la sua incomprensione della scienza; ciò finì
guerra, l’idealiper chiuderlo in una serie di formule generiche, che si rivelarono
smo, pur conservando una presempre più insufficienti a far comprendere la realtà: il mutasenza nella cultumento della situazione civile, che confermò questa insufficienra, ha conosciuto
za sia in Gentile che in Croce, segnò il suo declino.
il declino. Solo
L’influenza di Croce (divenuto presidente del rinnovato
alcuni esponenti
della “sinistra”
Partito liberale) rimase in effetti viva per tutti gli anni
(come Spirito e
Cinquanta tra i cultori di letteratura e di arte, ma pochi furono
Calogero) hanno
i continuatori della sua filosofia: tra essi CARLO ANTONI
saputo affrontare
(1896-1959), che sostenne lo storicismo contro le nuove
i problemi dei
tempi nuovi; gli
“scienze umane”, ADELCHI ATTISANI, interessato alla proesponenti della
blematica estetica e morale, ALFREDO PARENTE (fondatore
“destra”, si sono
nel 1964 della “Rivista di studi crociani”), VINCENZO
volti quasi tutti
CILENTO e VITTORIO ENZO ALFIERI, studiosi del pensiero
allo spiritualimo.
antico, e RAFFAELLO FRANCHINI, studioso di logica e di teo335
ria della previsione.
Più rapida e definitiva fu l’eclissi dell’attualismo, anche per le sue implicazioni col
fascismo. Tra i rappresentanti della “sinistra” continuarono ad essere presenti nella filosofia italiana, dall’università di Roma, Spirito e Calogero.
Spirito continuò a sviluppare i temi del “problematicismo”, approfondendo
anche l’esame dei “caratteri del nostro tempo”, come l’onnicentrismo, l’accelerazione e la uniformità. Calogero sviluppò una “filosofia del dialogo”
(che ha presentato come un “neosocratismo”) come “chiarimento delle condizioni di compossibilità” dei diversi punti di vista; in essa il dialogo risulta
principio dello stesso “logo”, ma è finalizzato anzitutto a fondare la convivenza
(problema molto sentito negli anni Cinquanta).
I seguaci della “destra” gentiliana, come si è accennato, continuarono a sviluppare una serie di ripensamenti dell’idealismo in senso trascendentistico e spiritualistico, e buona parte di essi finì per riaccostarsi al cattolicesimo. Oltre ad
Armando Carlini, alla problematica dell’esistenzialismo fu aperto anche
LUIGI STEFANINI (1891-1956), che orientò il suo spiritualismo in senso per-
sonalistico (ispirato a Mounier). Una forma di spiritualismo fu anche quella
elaborata da AUGUSTO GUZZO (1894-1986), che non veniva dall’idealismo,
ma lo ebbe sempre come punto di riferimento.
Guzzo si era opposto per tempo all’idealismo (Sic vos non vobis, 1936), rifiutando la riduzione dell’individuo all’universale della ragione (L’io e la ragione,
1947); si definì però sempre idealista, considerando l’universale come il riferimento necessario dell’individuo e l’origine della sua tensione al superamento di se
stesso, sia nella conoscenza che nella moralità; La moralità è il titolo di un suo
volume del 1950, La scienza quello di un vasto studio del 1955, dedicato
soprattutto all’esame dei processi mentali della scienza, individuati nella dialettica ipotesi-sperimentazione. Docente a lungo nell’università di Torino (dove
fondò anche la rivista “Filosofia”), Guzzo vi formò una scuola, da cui provengono studiosi come FRANCESCO BARONE (1923-2003) e VITTORIO
MATHIEU (1923).
Tra gli spiritualisti,
Guzzo ha illustrato quale caratteristica dell’uomo,
sia nella conoscenza sia nell’azione, la tensione
verso l’universale.
Analogamente
Sciacca ha cercato nell’interiorità
un rimando oggettivo, ispirandosi a Agostino e a
Rosmini. Una
importante attività
svolse il Centro di
studi filosofici cristiani di Gallarate.
2.- Spiritualismo e neotomismo
Nel secondo dopoguerra, tuttavia, l’esponente dello spiritualismo più attivo sia in campo teoretico che in campo storiografico, è stato MICHELE FEDERICO SCIACCA (19081974). Egli approdò presto allo spiritualismo (cui poi diede un
coronamento cristiano), ma all’interno dello spirito individuale cercò
sempre un principio oggettivo, che sviluppò ispirandosi prima
a s. Agostino, poi a Rosmini (oggetto di studi organizzati dal
centro di Stresa). Tra i suoi molti scritti i più importanti sono
Interiorità oggettiva (1951), Atto ed essere (1956), Filosofia e metafisica, 1959, Morte e immortalità, 1959, La libertà e il tempo. Docente
a Genova (dove diresse anche la “Rivista di metafisica”),
Sciacca ha avuto una numerosa scuola.
Nel 1945 un certo numero di filosofi cristiani organizzò un
incontro a Gallarate su “Orientamenti contemporanei della
filosofia cristiana e delle filosofie non cristiane”; ne nacque il “Centro di 336
studi filosofici cristiani”, di cui furono promotori F. Battaglia, A. Guzzo,
U.A. Padovani, M.F. Sciacca, L. Stefanini e segretario C. Giacon. Oltre a una
serie di incontri annuali, risultato dell’attività del Centro fu una Enciclopedia
filosofica (1950-58, ampliata in successive edizioni), cui si affiancò (sempre
diretta da cattolici) la Grande antologia filosofica.
Negli anni Cinquanta, l’orientamento spiritualistico ha finito per annoverare nelle sue fila la maggioranza dei pensatori formatisi nel periodo idealista,
fossero essi di matrice idealistica o cattolica, e di inclinazione prevalentemente teoretica o prevalentemente morale. La prima prevalse in VINCENZO
LA VIA (1895-1982), fondatore della rivista “Teoresi” (teorico di un “assoluto realismo”) e in CARMELO OTTAVIANO (1906-1980), fondatore della
rivista “Sophia” (teorico di una “metafisica dell’essere parziale”, che necessariamente rimanda all’essere assoluto). L’inclinazione morale prevalse in
RENATO LAZZARINI (1891-1975), che cercò una risposta, etica e metafisi-
ca, al problema del male, in una prospettiva soteriologica. Da parte sua, FELICE
BATTAGLIA (1902-1977) approfondì i problemi del senso della storia, di cui
considerò punto di riferimento i valori (“La storia... sta nel mezzo, sostenuta
dai valori”), e la stessa tematica affrontò NICOLA PETRUZZELLIS (19101988). Una forma di spiritualismo è stata anche la “filosofia dell’ascesi” (di
ispirazione schopenhaueriana) svolta da TEODORICO MORETTI COSTANZI
(1912-1994).
Accanto allo spiritualismo, nel pensiero cattolico è stata vivace la presenza del neotomismo, i cui esponenti hanno fatto riferimento al Centro di
Gallarate, ma si sono anche organizzati autonomamente: tra essi, l’ex discepolo di Martinetti UMBERTO A. PADOVANI (1894-1968), fautore di una
posizione “non esigenziale, postulatoria, fideistica”, ma razionale, e perciò
convinto che della storia non si dà filosofia ma solo teologia (essendo il suo senso
fondato sulla rivelazione), e il gesuita CARLO GIACON (1900-1984), studioso di Aristotele. Dalla neoscolastica partì CARLO MAZZANTINI (18951971), poi passato all’esperienza dell’esistenzialismo.
Il pensiero cattoliCaratteristica del neotomismo, anche nel secondo dopoco è stato rappreguerra, è stata la ricerca storiografica, in cui si sono distinti
sentato anche dal
MARIANO CAMPO (Kant), CORNELIO FABRO (Kierkegaard)
neotomismo, connotevoli studi stoe SOFIA VANNI ROVIGHI (Kant, Husserl, la Scolastica).
rici. Bontadini ha
Come nell’anteguerra, i loro studi hanno avuto anche un intencriticato il soggetto critico, volto non più contro l’idealismo, ma contro l’esistenziativismo della filolismo, il neopositivismo e il marxismo, in difesa della metafisica e delsofia moderna e
presentato la
la teologia. - Nell’ambito della Cattolica si sono formati anche
metafisica come
pensatori come CARLO ARATA, VIRGILIO MELCHIORRE,
esito necessario
EVANDRO AGAZZI, ADRIANO BAUSOLA.
delle contraddiTra i pensatori legati al neotomismo (o, più in generale, alla
zioni dell’esperienza. Tale esito
neoscolastica), GUSTAVO BONTADINI (1903-1990), docente
è stato sostenuto
alla Cattolica, si è distinto per essersi rifatto alla metafisica
da M. Gentile sul
classica. A suo giudizio, la filosofia moderna, col suo gnoseolomodello della metafisica “classica”.
gismo (Studi sulla filosofia dell’età cartesiana, 1947, Indagini di struttura sullo gnoseologismo moderno, 1952, e Studi di filosofia moderna,
1966) si risolve necessariamente nell’idealismo; secondo Bontadini, invece, 337
l’essere è preesistente all’esperienza, e le contraddizioni dell’esperienza rimandano, in
forza del principio di non contraddizione, ad un principio teologico (Saggio
di una metafisica dell’esperienza, 1938, Conversazioni di metafisica, 1971).
Una ripresa ed essenzializzazione dei temi della metafisica classica (aristotelica) è stata compiuta, tra i pensatori cattolici, anche da MARINO GENTILE
(1906-1992), docente a Padova, in opposizione alla concezione matematicistica e meccanicistica della realtà sviluppata dalla filosofia moderna in funzione della realizzazione del “regnum hominis”. Secondo Gentile (Filosofia e umanesimo, 1948,
Come si pone il problema metafisico, 1955, Trattato di filosofia, 1974), l’esperienza,
con la sua problematicità, si presenta come una potenza che richiede una integrazione nell’atto puro. Alla scuola di Gentile si sono formati studiosi come ENRICO
BERTI e FRANCO CHIEREGHIN.
3.- Esistenzialismo e fenomenologia
Il tomismo, e soprattutto lo spiritualismo, furono le filosofie dominanti nel
dopoguerra fin verso la fine degli anni Cinquanta, anche per la loro corrispondenza alla situazione politica. Ma l’esigenza, anche politica, di un rinnovamento culturale effettivo, suscitò interessi specie per tematiche sin’allora trascurate, cui vennero incontro numerose iniziative culturali (come riviste nuove o
rinnovate, di vario orientamento, e dibattiti).
Nella diffusione di queste tematiche, specie della filosofia tedesca del
Novecento, si era distinto, già prima della guerra, ANTONIO BANFI (18861957), nell’ottica di una concezione della filosofia come “sistematica del sapere”;
dopo la guerra, docente a Milano, egli continuò con impegno l’opera di
aggiornamento e di ripensamento della filosofia italiana (da un punto di vista
marxista, riflesso nei saggi de L’uomo copernicano, 1950), attraverso la rivista,
fondata nel 1946, “Studi filosofici”, con la collaborazione dei suoi discepoli.
Molti di essi sono poi stati, in varie direzioni, protagonisti del
Dalla fine degli
dibattito culturale dei decenni successivi (Paci, Preti, Cantoni,
anni Cinquanta
Anceschi). Una approfondita analisi della cultura della “crisi”,
entrano il Italia le
una informazione ampia sulle “scienze umane” e una presenfilosofie straniere,
a partire da fenotazione critica del marxismo ha elaborato REMO CANTONI
menologia ed esi(1914-1978), nella prospettiva di uno storicismo umanistico.
stenzialismo. La
Vicino alle tematiche “umanistiche” fu FRANCO LOMBARDI
fenomenologia è
(1906-1989), docente a Roma, che ha sviluppato una ricerca
ripresa da Banfi,
(poi approdato al
su Il mondo degli uomini (titolo della riedizione delle opere commarxismo), che
plete, 1967), imperniata su una concezione dell’uomo come
con la sua scuola
essere finito ma libero (Lombardi parla di “libertà pesante”).
opera un aggiorTra le nuove correnti, tra gli anni Quaranta e la metà degli
namento della
cultura italiana.
anni Cinquanta, risonanza particolare ebbe l’esistenzialismo,
L’esistenzialismo
soprattutto nella versione di NICOLA ABBAGNANO (1901ha un rappresen1990),
a lungo docente a Torino. Scolaro di Aliotta, egli aveva
tante di rilievo in
evidenziato Le sorgenti irrazionali del pensiero (1923), e stabilita la
Abbagnano.
necessità di un rinnovamento della filosofia (Il principio della
metafisica, 1936), che La struttura dell’esistenza (1939) pose nell’incontro tra filo- 338
sofia ed esistenza. Secondo Abbagnano, infatti, proprio dell’esistenza è il
rapporto con l’essere, e la riflessione su questo rapporto è la filosofia.
Il rapporto con l’essere non è per Abbagnano un dato, ma una possibilità,
legata alla “finitudine” dell’uomo. Diversamente da Heidegger e Jaspers,
però, per Abbagnano questo rapporto è una possibilità effettiva, purché sia stabilito in modo da non rendere impossibile, ma da mantenere aperta la possibilità di se stesso (“possibilità trascendentale”). Abbagnano ha svolto questa
concezione nelle sue opere successive, da Introduzione all’esistenzialismo (1942)
ai saggi di Possibilità e libertà (1956). Un dialogo storico con le posizioni degli
altri filosofi volle essere la sua Storia della filosofia (1946-1950), la più autorevole del dopoguerra.
In polemica con Heidegger, Jaspers e Sartre, la cui filosofia termina in una
negazione delle possibilità dell’uomo, Abbagnano ha definito il proprio un esistenzialismo positivo (L’esistenzialismo positivo, 1948). In Filosofia, religione, scienza
(1947), egli ha indicato la radice ad esse comune in un atteggiamento di
“fede” (in senso umano); ma poi, sulla scia di Dewey, ha posto nella ragione
il principio di ricostruzione dell’esistenza, allargando i suoi interessi alle “tecniche”
con cui la ragione può rapportarsi alla realtà e orientare la vita, e in particolare alle metodologie delle scienze naturali ed umane.
Tra i seguaci di Abbagnano, PIETRO CHIODI (1915-1970) ha studiato il
concetto di possibilità nell’esistenzialismo e in Kant; ARMANDO VEDALDI
(1908-1961) ne ha rilevato le aperture sociali. Ma l’esistenzialismo ha trovato riscontro in molti altri pensatori, tra cui GIUSEPPE CAPOGRASSI (18991966), attento soprattutto ai problemi del diritto, nel suo scolaro PIETRO
PIOVANI (1922-1980) e in ENRICO CASTELLI (1900-1977), docente a Roma,
conoscitore e diffusore della teologia esistenziale tedesca. Studioso dell’esistenzialismo, ma di ispirazione blondeliana, è stato PIETRO PRINI (19152008), autore fra l’altro di una Storia dell’esistenzialismo.
LUIGI PAREYSON (1918-1994, docente a Torino) ha visto nell’esistenzialismo (Studi sull’ esistenzialismo, 1943) la manifestazione di proAbbagnano problematiche che solo il rimando oltre la soggettività può risolvere
pugna un esisten(Esistenza e persona, 1950). Questo rimando è stato approfonzialismo positivo,
dito da Pareyson in Estetica: teoria della formatività (1954), incenimpegnato a realizzare un rapportrata sulla polarità (schellinghiana) tra “forma formante” e
to effettivo con
“forma formata”; e lo ha condotto negli anni Sessanta a conl’essere, e perciò
cepire la filosofia come ermeneutica, in base al rapporto “rivedà importanza
lativo” che, secondo Pareyson, sussiste tra pensiero e realtà
alle “tecniche”
della ragione. Su
(Verità e interpretazione, 1971). Su questa base, Pareyson ha rifiuquesta linea si
tato l’ontologia negativa di Heidegger.
diffonde nella culVicino all’esistenzialismo di Abbagnano è stato ENZO PACI
tura italiana il
(1911-1976; docente a Milano), discepolo di Banfi (Pensiero, esi“neoilluminismo”.
Anche Pareyson
stenza e valore, 1941, Il nulla e il problema dell’uomo, 1950), il quale
sostiene la possisi
è poi rifatto a Whitehead per sviluppare un “relazionismo”
bilità che la realtà
(Dall’esistenzialismo
al relazionismo, 1957) secondo cui la relaziosi riveli alla ragione è necessaria a costituire gli individui, e ha infine ripreso la prone.
spettiva fenomenologica, applicandola all’indagine dei bisogni
concreti dell’uomo (il “precategoriale” di Husserl); su questa base ha svilup- 339
pato i temi della Crisi di Husserl in Funzione delle scienze e significato dell’uomo
(1963) e approfondito la concezione dell’uomo del giovane Marx (ossia i
temi della prassi, dell’alienazione, ecc.).
Tra gli adepti della fenomenologia si è distinto GIUSEPPE SEMERARI
(1922-1996, formatosi con Carabellese), studioso di Schelling e di Spinoza;
l’interesse per Whitehead è stato approfondito dal discepolo di Paci (e,
prima, di Barié) CARLO SINI (1928), docente a Milano, poi dedicatosi allo
studio di Heidegger e di Nietzsche e al pensiero “postmoderno”.
4.- Neoempirismo e neoilluminismo
Dalla metà degli anni Cinquanta, e fino alla metà degli anni Sessanta, entrò
nella filosofia italiana anche il neoempirismo, attraverso l’attività divulgativa
e critica di studiosi come FRANCESCO BARONE, FERRUCCIO ROSSI LANDI
(1921-1985), PAOLO FILIASI CARCANO (1911-1977) e altri. Importanti in
particolare è stato lo studio di Barone Il neopositivismo logico (1953, ripetutamente riedito), che poi ha studiato anche l’intreccio dei rapporti tra Logica
formale e logica trascendentale (1957-1965). Barone (docente a Pisa) ha ispirato le
proprie concezioni particolarmente ad Hartmann.
Una posizione particolare all’interno dell’orientamento neopositivistico ha
avuto GIULIO PRETI (1911-1972; docente a Firenze), che ha accolto dal
neoempirismo il programma di analisi critica delle proposizioni filosofiche
(escludendo per tal via la metafisica), ma ha elaborato anche una “filosofia
della prassi” derivata da Dewey e dal giovane Marx (Praxis ed empirismo,
1957) carica di risonanze politiche, ma non bene accetta al marxismo “ufficiale”; ha poi movimentato il dibattito culturale col polemico saggio Retorica
e logica (1968), sul tema dei rapporti tra le “due culture”.
Al neopositivismo ha fatto riferimento non come concezione teorica ma
come modello di analisi rigorosa (applicata specialmente agli studi di diritto)
anche NORBERTO BOBBIO (1909-2004, docente a Torino,
Dalla fine degli
direttore,
anche con la collaborazione di Abbagnano, della
anni Cinquanta,
“Rivista di filosofia”), sul presupposto di un forte impegno
c’è anche una
culturale e politico, che ne ha fatto uno dei politologi più
ripresa di motivi
neoempiristici,
influenti dagli anni Cinquanta (Politica e cultura, 1955, Destra e
soprattutto nel
sinistra, 1994).- Con impostazione analoga gli studi di diritto e
metodo. In questa
di politica sono stati proseguiti da UBERTO SCARPELLI,
ottica Bobbio
NICOLA MATTEUCCI e GIOVANNI SARTORI.
affronta i problemi
del diritto e della
L’attività di questi pensatori (e dei loro discepoli) ha confipolitica; Preti svigurato, tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, un orientaluppa un accostamento detto da Abbagnano (che ne fu in certo senso il capomento tra pragfila), con esplicito richiamo a Dewey, “neoilluminismo”, cioè
matismo e marxismo. Cresce l’indi fiducia nei poteri della ragione educata scientificamente. Esso ha
teresse per la
costituito
la punta più avanzata della cultura italiana, anche del
scienza, sopratdibattito
civile,
sino al “boom economico”, quando l’approtutto ad opera di
Geymonat.
fondirsi di contraddizioni sociali e culturali ha reso necessario
un rinnovamento dei temi e dei metodi anche della filosofia, 340
ed un suo più concreto collegamento coi problemi sociali e politici.
Tra le organizzazioni che sostennero la diffusione della filosofia della
scienza fu il Centro di studi metodologici di Torino (costituito nel 1948 da
Abbagnano, Buzano, Frola, Geymonat, Nuvoli, Persico); dalla fine degli anni
Cinquanta, gli interessi si estesero anche alle scienze umane (del cui studio
era stato pioniere Cantoni), e nel 1961 fu istituita a Roma la prima cattedra
di sociologia, affidata a un discepolo di Abbagnano, FRANCO FERRAROTTI
(1926). Nel 1962 Abbagnano curava la prima Storia delle scienze, con contributi di vari studiosi, tra cui Geymonat.
LUDOVICO GEYMONAT (1908-1991) ha dato il contributo più rilevante
alla ricerca, alla divulgazione e all’approfondimento della problematica inerente alla scienza; occupò la prima cattedra di filosofia della scienza a Milano.
Dopo Studi per un nuovo razionalismo (1945), Saggi di filosofia neorazionalistica
(1953), ha pubblicatoIl pensiero scientifico (1954), Filosofia e filosofia della scienza
(1960), Scienza e realismo (1977), e coronato la sua attività di studioso (dopo
l’importante Galileo Galilei) con una grande Storia del pensiero filsofico e scientifico.
Nei primi saggi, Geymonat aderiva al neoempirismo come metodo di analisi filosofica, funzionale a un “nuovo razionalismo”, nuovo in quanto fondato su un concetto della ragione non metafisico, ma definito dai metodi con cui
opera, e perciò (come insegna la nuova scienza) finito e convenzionale; questi assunti erano per Geymonat anche la condizione per un rinnovamento
della cultura italiana e della stessa convivenza civile. In questo senso egli presenta il nuovo razionalismo come “ben più agguerrito e penetrante di quelli
che caratterizzarono i secoli passati”.
Dagli anni Sessanta, Geymonat ha abbandonato il neopositivismo e il convenzionalismo, sottolineando soprattutto la necessità di un’analisi della scienza non astratta ma aderente alle sue effettive manifestazioni storiche (Filosofia
e filosofia della scienza, 1960); egli ha quindi inquadrato questa concezione in
uno storicismo di tipo marxista (diverso però, come vedremo, da quello di
Gramsci), e infine del marxismo ha recuperato il realismo e il concetto della
dialettica di Engels (Scienza e realismo, 1977); su questa base ha
Partito dal
prospettato una visione della storicità della scienza, imperniata (in
neoempirismo,
polemica
con la “nuova epistemologia”) sulla complessa diaGeymonat ha
lettica di continuità e rottura, condizioni esterne e dinamica
sempre più
approfondito la
interna, che caratterizza il “patrimonio tecnico-scientifico”.
realtà intellettuale
Alla scuola di Geymonat si sono formati numerosi studiosi
e sociale della
di
logica e di storia della scienza. Gli interessi epistemologici
scienza, in una
sono stati coltivati (sul presupposto del realismo) anche nel
prospettiva marxista (engelsiana).
campo cattolico, soprattutto da EVANDRO AGAZZI, e in
L’opera di storico
seguito da DARIO ANTISERI (studioso e seguace di Popper).
di Geymonat, di
Dalla metà degli anni Sessanta, infine, alcuni studiosi (RENZO
Garin, di Dal Pra,
PIOVESAN, ANTONIO PIERETTI, EUGENIO LECALDANO,
di Paolo Rossi e
di altri studiosi
ecc.) hanno seguito gli orientamenti della filosofia analitica
ha contribuito a
Al rinnovamento della filosofia tra la fine degli anni Cinrinnovare vecchi
quanta
e gli anni Sessanta ha contribuito anche una storiograschemi storiografia tesa a ricostruzioni più rigorose e oggettive; in questo
fici idealistici.
senso un’opera di rilievo hanno svolto numerosi studiosi, tra
cui spiccano EUGENIO GARIN (1909-2004), docente a Firenze, preciso 341
conoscitore della filosofia e della cultura del Rinascimento e del Novecento,
il quale ha maturato anche una concezione della filosofia come sapere storico, e MARIO DAL PRA (1915-1992, docente a Milano, fondatore e direttore
della “Rivista critica di storia della filosofia”), ligio alla ricostruzione filologica del pensiero. All’inizio degli anni Sessanta si sviluppò anche un vivace
dibattito sui fondamenti della storiografia filosofica, in parte ancora aperto.
Più di recente, negli anni Sessanta e Settanta, PAOLO ROSSI (1923), docente a Firenze, ha esplorato con acume alcune fasi salienti del pensiero scientifico. Ai legami (anche teorici) tra la filosofia e le scienze (in particolare le
scienze umane) hanno prestato attenzione gli allievi di Abbagnano PIETRO
ROSSI (1930, studioso dello storicismo) e CARLO AUGUSTO VIANO (1929,
studioso di Aristotele e di Locke), docenti a Torino, ultimamente inclini a una
risoluzione della filosofia nelle scienze umane.
5. Marxismo
Nell’Italia del dopoguerra, spiritualismo e neotomismo da un lato, esistenzialismo e neoilluminismo dall’altro hanno rappresentato, anche negli orientamenti politici, le “aree” cattolica e laica; accanto ad essi, però (e anche in
essi, come si è visto per alcuni neoilluministi), fin dai primi anni del dopoguerra è stato presente il marxismo. Attraverso la discussione di problemi
concreti (sociali, civili, scientifici) ed efficaci iniziative culturali (riviste come
il “Politecnico”, “Società”, “Rinascita”) ed editoriali, anzi, esso si è imposto
nella cultura italiana fino alla metà degli anni Settanta.
Un punto di riferimento hanno costituito, specie per il dibattito politico, i
Quaderni del carcere di Gramsci, con le loro originali indicazioni sui nodi fondamentali della civiltà nazionale (la questione meridionale, gli intellettuali,
ecc.). Essi furono pubblicati tra il 1948 e il 1951 per iniziativa di P. Togliatti,
segretario del P.C.I; e fecero di Gramsci il centro di un’operazione culturale
e politica, che mirava a fare del marxismo il rovesciamento, e
Oltre alla cultura
insieme la continuazione, dell’idealismo, cioè una forza intimacattolica e laica,
mente
inserita nella tradizione culturale italiana.
negli anni ’50 e
Il “gramscismo” non è stato tuttavia l’unico orientamento
’60 si è sviluppata
la cultura marxidel marxismo italiano, che si è sviluppato in diverse direzioni,
sta, su una linea
fondate su nuove letture dei classici del marxismo e particolagramsciana, finari riprese delle tematiche tradizionali (a cominciare da quella
lizzata a inserirsi
dell’incidenza rispettiva delle condizioni oggettive e soggettinella cultura
nazionale.
ve della storia). Le due direzioni principali del marxismo italiaAvverso a questa
no non gramsciano fanno capo rispettivamente a GALVANO
linea è stato Della
DELLA VOLPE (1895-1968) e a CESARE LUPORINI (1909-1993).
Volpe (studioso
Formatosi all’idealismo, avverso all’esistenzialismo, Della
anche di estetica), che ha cerVolpe approdò al marxismo attraverso la discussione della
cato di collegare
“libertà marxista” (come libertà “sostanziale” in opposizione
il marxismo piutalla libertà “formale” borghese soprattutto in La libertà comutosto alle scienze
nista, 1946); quindi ha precisato la sua intepretazione del marsperimentali.
xismo in Logica come scienza positiva (1950) nel quadro di una
visione della storia del pensiero come contrapposizione tra concezioni reali- 342
stico-empiristiche e concezioni idealistico-mistiche.
Della Volpe ha ricondotto il marxismo alle prime, giudicandole le sole
capaci di aderire alla realtà; ha perciò espunto dal marxismo la dialettica, ed
ha presentato la “logica storica” come una ripresa del metodo galileiano, inteso
come “circolo concreto-astratto-concreto o circolo di materia e ragione o di
induzione e deduzione, che si dica”, cioè continuo rimando tra pensiero e
realtà. Della Volpe, che ha svolto anche particolari indagini sul “gusto” estetico, ha avuto una scuola, in cui si sono formati alcuni dei più noti marxisti
italiani (Lucio Colletti, Mario Rossi, Nicolao Merker, Umberto Cerroni).
Luporini, dopo un’esperienza più coinvolgente dell’esistenzialismo
(Situazione e libertà nell’esistenza umana, 1942), ha elaborato una concezione del
marxismo essenzialmente come conoscenza scientifica della società e della storia in
funzione della progettazione rivoluzionaria; perciò ne ha respinto le versioni
storicistiche (che lo riducono a ideologia in funzione della politica) e strut-
turalistiche (che ne annullano il rapporto con la storia), ed ha giudicato fondamentale in Marx non l’antropologia giovanile, ma le analisi di economia politica
(Dialettica e materialismo, 1974).
Luporini è noto anche per un saggio su Leopardi progressivo (1933) che ha
dato un nuovo orientamento alla critica leopardiana. Il tema è stato studiato
anche da SEBASTIANO TIMPANARO (1923-2000), un pensatore isolato, che
ha insistito sull’ispirazione materialistica del marxismo.
Altri orientamenti alimentarono il dibattito sul marxismo (e nel marxismo)
tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta: Mario Dal Pra, ad esempio, formulò (con Andrea Vasa), un “trascendentalismo della prassi”; Giulio Preti propose una fusione tra marxismo e pragmatismo nel concetto di “prassi” trasformatrice; Geymonat contrappose a quello di Gramsci uno storicismo non
“umanistico” ma attento ai problemi della scienza, fondamentali per la società moderna (provocando la reazione di Colletti), ecc.
Vicine al marxismo, più che marxiste, furono altre posizioni, ad es. il “marxismo umanistico” di CLETO CARBONARA (1904-1979), scoAnche Luporini
laro di Aliotta (Materialismo storico e idealismo critico, 1947),
ha privilegiato,
preoccupato di salvare Persona e libertà (1959), o il “marxismo
rispetto al Marx
cattolico” di FELICE BALBO (1913-1964), ripreso da FRANCO
“umanista”, il
Marx scienziato
RODANO (1920-1983) negli anni Settanta. Questo fu avversadell’economia e
to particolarmente da AUGUSTO DEL NOCE (1910-1989),
della società.
che vedeva nel marxismo la “realizzazione pratica” dell’ateiTra gli anni ’60 e
smo potenziale della filosofia moderna.
’70 si sono diffuse in Italia anche
All’inizio degli anni Sessanta, poi, fu effettuato un “recupealtre versioni del
ro”
del marxismo “occidentale”, in particolare di Lukács, per
marxismo.
opera di CESARE CASES (1920-2005), della scuola di FrancoIl marxismo in
forte e in particolare di Marcuse (punto di riferimento del
genere è stato
combattuto da
Sessantotto), in parte anche dello strutturalismo (isolato il
Del Noce, come
recupero della dialettica di Engels da parte di Geymonat), che
l’esito del razioaccompagnarono la discussione sulla società in trasformazionalismo moderno
ne fino a metà degli anni Settanta. A questi orientamenti, tal(ateistico).
volta confusi, si rifaceva, nel linguaggio se non nei concetti,
343
buona parte della cultura anche non marxista.
6.- Ultimi sviluppi
Dalla metà degli anni Settanta, col mutare della situazione politica e sociale, la
rigidità delle diverse posizioni filosofiche si è andata smussando; l’“egemonia” del marxismo è andata declinando; e lo stesso mutamento generazionale ha stimolato la ricerca di nuovi modelli di pensiero, più duttili, aperti alle influenze dell’ermeneutica, di Heidegger e di Nietzsche, che sono penetrate sia tra
i cattolici che tra i marxisti.
Di formazione cattolica (scolaro di Bontadini) EMANUELE SEVERINO
(1929), si è allontanato dal cattolicesimo (e dalla Cattolica, da cui è passato a
Venezia) con il discusso articolo Tornare a Parmenide (1964), in cui nega la realtà del divenire; nelle numerose opere successive (Essenza del nichilismo, 1972, Gli
abitatori del tempo, 1978, Techne. Le radici della violenza, 1979, Destino della necessi-
tà 1989) ha sviluppato su questo tema complesse applicazioni, recuperando
spunti di Heidegger e di Nietzsche.
Secondo Severino, l’ammissione del divenire comporta quella del nulla e quindi il “nichilismo”; per questo il pensiero occidentale le ha sempre opposto
degli “immutabili” (dalla filosofia alla scienza), che però non hanno potuto
nascondere le sue necessarie conclusioni; queste sono alla radice della civiltà
contemporanea, fondata sulla scienza e sulla tecnica, per le quali la realtà è
costitutivamente trasformabile; e rendono uguali, nella sostanza, concezioni
metafisiche e religiose, capitalismo e socialismo.
Dalla metà degli anni Settanta, infine, si è diffuso il tema della “crisi della
ragione”, da Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein
(1976) di MASSIMO CACCIARI (1943), a La crisi della ragione (1979), raccolta
di saggi curata da ALDO GARGANI (1933-2009, discepolo di Paci), sulla
“fine” della “ragione classica” e scientifica, a Il pensiero debole (1983), altra raccolta di saggi di pensatori dell’ultima generazione, curata di GIANNI
VATTIMO (1936) e PIER ALDO ROVATTI (1942, altro disceNegli anni ’70,
polo di Paci), che definisce appunto la razionalità “postmoderSeverino ha prena” ed “ermeneutica”.
sentato il pensieTra i pensatori che hanno aderito a questo orientamento, il
ro occidentale
come votato al
più noto è Gianni (Gianteresio) Vattimo, allievo di Pareyson,
nulla, e molti
docente a Torino, studioso di Nietzsche, Heidegger, Schleierhanno cercato
macher, Gadamer, al cui pensiero si è ispirato, presentando i
nelle filosofie
temi del “postmoderno” nella prospettiva di un avanzante
recenti modelli di
un “pensiero
nichilismo, nel senso heideggeriano di un affievolirsi della
debole” in opposi“voce” dell’essere nella cultura contemporanea; su queste basi,
zione al “pensiero
egli auspica, sostanzialmente, l’avvento di una filosofia non
forte” della cultura
“violenta”, ma, come quella di Rorty, “conversativa” (Le avvenmoderna.
Posizioni
ture della dialettica. Che cosa significa pensare dopo Nietzsche e
“epigonali”
Heidegger, 1980, La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica
rispetto alla tradinella cultura postmoderna, 1986, ecc.).
zione filosofia
Questa tendenza ha provocato vivaci reazioni polemiche da
occidentale.
parti di pensatori “moderni” come, fra l’altro, Carlo A. Viano,
Paolo Rossi e Lucio Colletti, mossi da un ideale “scientifico” del pensare. 344
Altri, come REMO BODEI (1938, autore fra l’altro di Scomposizioni. Forme dell’individuo moderno, 1987, e Geometria delle passioni, 1989), registra le trasformazioni della società “postindustriale” e lo stato “epigonale” della filosofia
contemporanea, ma come stimolo a ritrovare “schemi di senso articolati e
persistenti”, per cui costituiscono sempre riferimenti irrinunciabili i classici
del pensiero filosofico.
Riferimenti bibliografici
Studi: V. i riferimenti del capitolo VII della Parte XIII; inoltre: AA. VV., La cultura filosofica italiana dal
1945 al 1980, Guida, Napoli 1982; AA. VV., La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi, Laterza, Roma-Bari
1985; AA. VV., Filosofia italiana e filosofie straniere nel dopoguerra, a cura di P. Rossi e C. A. Viano, Il Mulino,
Bologna 1991; M. Ciliberto, Filosofia e politica nel Novecento italiano, De Donato, Bari 1982; AA. VV., Il neoilluminismo italiano. Cronache di filosofia (1953-1962), a cura di M. Pasini e D. Rolando, Il Saggiatore, Milano
1991; AA.VV., La filosofia della scienza in Italia nel ’900, a cura di E. Agazzi, Angeli, Milano 1986.