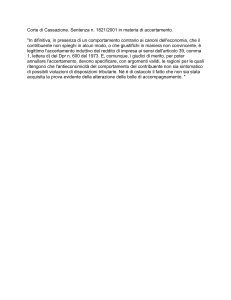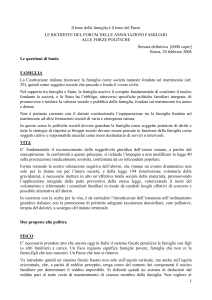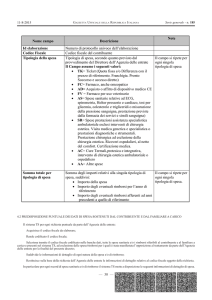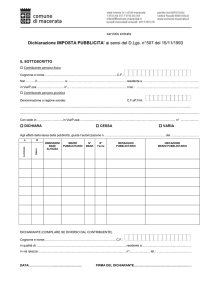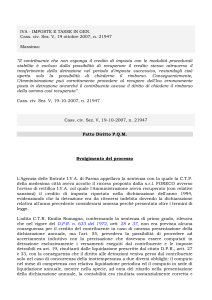RINNOVI
RIVISTE
RIVISTE IPSOA:
L’INFORMAZIONE DI QUALITÀ
SU TUTTI I MEDIA
NE
W
CARTA
SMARTPHONE
TABLET
PC
OMAGGIO
PREZZO
BLOCCATO
IPSOA è l’unica a garantirle la possibilità di sfogliare ogni numero del suo abbonamento anche in mobilità e online su smartphone*, tablet e PC.
In più, rinnovando il suo abbonamento entro il 15/12/2013 potrà usufruire del
prezzo bloccato al 2013 e di un omaggio a scelta fra:
- nuova edizione de il Codice Civile - Codice di procedura civile IPSOA
- Guida Osterie d’Italia 2014 a cura di Slow Food.
* La versione smartphone è disponibile solo per i sistemi Android.
CAMPAGNA
Rinnovi subito il suo abbonamento
L’elenco completo è disponibile su www.ipsoa.it/agenzie e su www.indicitalia.it/agenzie
adv_IPSOA_rinnovi_21x29,7_2014_4.indd 1
Y18EE LE
sul sito www.ipsoa.it/rinnoviriviste
chiamando il Numero Verde 800.916935
contattando il suo Agente di riferimento
06/09/13 11.42
Sommario
Luglio Agosto 2013
4
Aspetti strutturali
Il federalismo fiscale era un «diversivo tributario»?
di Raffaello Lupi, Marco Di Siena .....................................................................................................
Crescita, pressione fiscale e determinazione della ricchezza
di Mariano Bella e Luciano Mauro, RL.............................................................................................
Tassazione attraverso le aziende: dai numeri ai concetti in una recente monografia
di Mario Damiani, Raffaello Lupi......................................................................................................
Statuto del contribuente: rigidità di ritorno della codificazione frammentaria del buonsenso
di Marzia Lerani, Antonio Puce, RL ..................................................................................................
361
367
375
383
Accertamento
Accertamento prematuro e procedimento amministrativo
di Raffaello Lupi, Maria Rita Silvestri, Dario Stevanato ..................................................................
389
Redditi d’impresa
Sulla deducibilità di ritenute fiscali inizialmente omesse e versate a seguito di accertamento
di Simone Covino, RL.........................................................................................................................
Interessi passivi su debiti contratti per pagare dividendi: il principio è salvo
di Raffaello Lupi.................................................................................................................................
Cessione contro rendita vitalizia: la continuità dei valori fiscali esclude la doppia tassazione
di Gaudenzio Albertinazzi, RL, DS.....................................................................................................
402
405
410
Redditi fondiari
Reddito figurativo degli immobili non locati tra «socio-matematica» e manovre finanziarie
di Alessandro Santoro, RL..................................................................................................................
413
Operazioni straordinarie
Conferimenti di partecipazioni da persone fisiche e neutralità fiscale: la «continuità»
non è agevolativa
di Valentina Perrone, Raffaello Lupi..................................................................................................
419
Contenzioso tributario
Diritto tributario, giudici e processo
di Massimo Basilavecchia, Raffaello Lupi.........................................................................................
431
Reati tributari
Gli interposti, gli imprenditori e le aziende (tra caso Mediaset e tutoraggio fiscale)
di Raffaello Lupi.................................................................................................................................
435
Sanzioni
Sull’applicabilità d’ufficio delle mitigazioni sanzionatorie previste «ex lege» dopo l’introduzione
del giudizio
di Alessia Vignoli, RL .........................................................................................................................
4/2013
443
359
Sommario
Fiscalità internazionale
Le due anime dei costi «black list» tra ricchezza non registrata (retrocessione occulta)
e «transfer pricing rinforzato»
di Fabio Gallio, Valentina Perrone, Raffaello Lupi...........................................................................
Esterovestizione societaria: conferme della lettura «anti-abuso», nei limiti dell’evasione
interpretativa
di Simone Covino, RL.........................................................................................................................
360
4/2013
451
461
Aspetti
strutturali
Il federalismo fiscale
era un «diversivo tributario»?
di Raffaello Lupi, Marco Di Siena
Sono passati circa vent’anni da quando il «federalismo fiscale» sembrava essere un palliativo per
rispondere al malessere tributario italiano. È evidente oggi che si confondevano le insoddisfazioni per gli squilibri tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli Uffici col malessere della
parte relativamente più efficiente e produttiva del Paese in ordine agli squilibri tra provenienza
del gettito e sua allocazione territoriale. Venivano quindi intrecciati due profili diversi, e la loro
combinazione, con espressioni ammiccanti e suggestive, era mediaticamente molto efficace. Ma
fuorviante, con una apparenza che confondeva molto la sostanza. Si giocava in proposito sull’equivoco, diffuso nell’opinione pubblica, e tra le stesse classi dirigenti, tra tassazione e fiscalità,
concetto più ampio, e che comprendeva anche l’allocazione territoriale della spesa, e non solo i
tributi in senso stretto. Non ci si rendeva conto, quindi, del ruolo che gli enti locali possono giocare nella determinazione della ricchezza che sfugge alle aziende, e della loro riluttanza politica
a svolgerlo.
Il federalismo fiscale non è tributario, o almeno non sempre
Raffaello Lupi
L’articolo di Marco Di Siena fa il punto su di
una serie di confusioni diffuse nella pubblica
opinione italiana, in materia finanziaria e tributaria, davanti alle quali ci sono varie reazioni
possibili: quella tipica dello scienziato sociale,
che cerca di riflettere sui comportamenti umani,
sulle riflessioni dei suoi simili nel settore, riorganizzandole e riproponendole agli interlocutori; quella del professionista, che non si cura delle cause, ma cerca di utilizzarne le ricadute in
termini di lavoro; quella di chi cerca di suggerire chiavi di lettura per avere visibilità politica,
facendo intendere di aver capito qual è il problema e chiedendo, per superarlo, deleghe, che poi
si traducono in credibilità e potere.
Queste reazioni possono anche combinarsi tra di
loro, con varie sfumature, in cui si può spaziare:
dalla comunicazione della ricerca sociale al
bluff, con le innumerevoli gradazioni intermedie
che caratterizzano le nostre discipline. Si è giocato molto sull’equivoco tra tassazione e fiscalità, concetto più ampio, e che comprende anche
l’allocazione territoriale della spesa, e non solo i
tributi in senso stretto. In questo modo il federa-
lismo è diventato, come Pirandello diceva del
fascismo, una scatola in cui ognuno mette quello
che gli pare. Agli enti locali non pare vero di
usare il federalismo fiscale per chiedere più funzioni e soldi, senza però trasformarsi in esattori
dei tributi, compito sgradevole che preferiscono
lasciare a organi centrali. Altri usano il federalismo fiscale per tagliare la spesa pubblica, altri
per calmierare sproporzioni nei trasferimenti.
Non ci si rende conto, in questo modo, degli
aspetti tributari del federalismo fiscale, cioè del
ruolo che gli enti locali possono giocare nella
determinazione della ricchezza che sfugge alle
aziende.
Vediamo di fare quindi un po’ d’ordine sugli
aspetti tributari del federalismo fiscale, partendo
dalla necessità che la determinazione della ricchezza ai fini tributari sia sufficientemente sistematica, perché - come ricordiamo sempre su
questa Rivista e sui siti internet che la accompagnano - «le tasse si pagano quando qualcuno le
richiede». Più esattamente, dando corpo al concetto di «autotassazione» rispetto a «tassazione
attraverso le aziende», si pagano quando si pre4/2013
361
Aspetti
strutturali
vede che, altrimenti, sarebbe abbastanza probabile una richiesta del Fisco con applicazione di
sanzioni. A pensarci bene, la tassazione attraverso le aziende non è «autotassazione», per i contribuenti tassati dalle aziende, cioè consumatori,
risparmiatori e lavoratori. Essi sono tassati in
modo capillare dalla loro controparte «azienda»,
che lo fa perché la legge lo prevede, e nessuno,
nell’organismo sociale chiamato «azienda» (salvo il titolare, che può disporne), se la sente di
esporsi per disattendere prescrizioni legislative.
Dove l’azienda non arriva, l’autotassazione deve
essere sistematica, e come tale bene si addice
agli enti locali. Non a caso questi ultimi erano
largamente utilizzati in materia di tassazione,
proprio come gruppi sociali intermedi (1), col
gettito che «saliva» dalla periferia al centro,
senza percorrere, come adesso, il percorso inverso, dopo essere stato raccolto attraverso le
aziende. Le autorità centrali naturalmente tendevano a utilizzare come esattori di molte imposte,
soprattutto quelle ad elevata frammentazione, le
già indicate comunità locali. Lo Stato gestiva direttamente le imposte che presupponevano il
controllo dei confini, delle vie di comunicazione, della giustizia e dei titoli di proprietà. Per le
altre imposte, soprattutto quelle sulla condizione
economica delle persone, era però più comodo
servirsi delle comunità locali. Attraverso le quali
il gettito andava quindi «dalla periferia al centro», inversamente rispetto ad oggi, a causa
dell’avvento della «tassazione attraverso le
aziende», con un processo graduale, culminato
con le riforme degli anni settanta del secolo
scorso, e l’esternalizzazione della tassazione
sulle aziende, tramite la richiesta attraverso atti
legislativi.
Dove le aziende non arrivano occorre una richiesta delle imposte adeguatamente sistematica, anche se non capillare, da far adempiere
«spontaneamente» anche coloro che non ne sono
raggiunti, inducendoli a pensare che, se non pagassero di propria iniziativa, andrebbero incontro, con ragionevole certezza, a richieste coercitive e a sanzioni. Gli enti locali, soprattutto dopo che gli Uffici delle entrate si sono ritirati, per
l’accertamento, su base provinciale, sono elementi teoricamente fondamentali per la tassazione attraverso gli Uffici. Che è un problema tri-
362
4/2013
butario, non fiscale. Mentre il federalismo, inteso come controllo della spesa, costi standard,
gestione dei trasferimenti statali, salvataggio dei
Comuni in crisi, e via enumerando, è un problema fiscale, generale, non solo tributario. I due
problemi sono collegati per molti versi, ma se
non si parte da questo punto fermo sarà difficile
utilizzare gli enti locali, desiderosi di soldi da
spendere, e quindi di trasferimenti, come esattori del tributo. Chiedere i tributi, infatti, fa perdere consenso, mentre i Comuni vogliono soldi da
spendere, in quanto la spesa porta consenso.
Giustamente Marco Di Siena, mette in risalto il
fallimento delle aspettative miracolistiche verso
il federalismo fiscale (2). Perché non è con un
colpo di bacchetta magica normativa che si può
risolvere il problema. Però, anche la restituzione
ai Comuni di una potestà impositiva è un elemento importante di responsabilizzazione. Proprio come i costi standard dal lato della spesa.
In entrambi i casi bisogna fare delle scelte fortemente valutative, e non ci si può limitare ad
«applicare la legge». Altrimenti la rivitalizzazione della tassazione locale insisterà sempre su
ricchezza già visibile, senza allargare l’ambito
della ricchezza tassata.
Note:
(1) Segnalo soprattutto le comunità territoriali, etniche e professionali, ma comunque con una notevole pressione delle autorità.
(2) Vedi il post «Passata la lega, finito il federalismo: presentazione del volume di Luca Antonini», su www.giustiziafiscale.com.
Aspetti
strutturali
Il federalismo fiscale all’italiana: quando i sogni muoiono all’alba
Marco Di Siena
L’estate 2013 ci ha portato, fra l’altro, l’allarme
sulla progressione geometrica della pressione fiscale esercitata dagli enti locali (3). A bene considerare non è dato sapere se si sia trattato di un
mero «riempitivo» della foliazione estiva dei
quotidiani ovvero di un’iniziativa tesa a sviluppare un minimo dibattito sulla sfida del «più tasse per tutti» che l’Italia sta affrontando. Si tratta,
tuttavia, di un’occasione per riflettere e, in particolare modo, per riflettere su quello che - a mio
avviso - è uno dei «grandi sconfitti» di quest’ultimo periodo: il cosiddetto federalismo fiscale
tracciato dalla legge delega n. 42/2009 e l’idea
che tale sistema fosse contraddistinto da una
sorta di intrinseca superiorità morale ed operativa la quale avrebbe fatto in modo che la pressione fiscale complessiva diminuisse e, al tempo
stesso, la gestione delle finanze pubbliche divenisse più sana ed efficiente.
La prassi ha dimostrato che non è così ed ha fatto perdere al federalismo fiscale quell’aura
«quasi taumaturgica» di cui per anni si è alimentato il dibattito al riguardo. L’esperienza nazionale, infatti, si è sinora risolta in un incremento
del prelievo tributario esercitato a vario titolo
dai vari centri impositivi senza che il meccanismo asseritamente virtuoso del «pago - vedo voto» (4) abbia realmente esplicato alcun effetto
positivo. Su tale sostanziale fallimento (pur con
differenti nuances) mi sembra difficile dissentire
visto che, in un proprio recente ed efficace saggio (5), lo stesso presidente della Commissione
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale - pur addebitando le criticità principalmente
ad una implementazione troppo timida dell’iniziativa - riconosce l’esito assai deludente del federalismo fiscale varato con la legge delega n.
42/2009 ed i relativi provvedimenti delegati.
Ora, se lo «stato dell’arte» è deludente - senza
volere indulgere all’inutile ricerca del colpevole
-, è doveroso chiedersi cosa non abbia funzionato e perché (6). E mi sembra una domanda tanto
più pressante quanto più risulta evidente come
la crescita del debito pubblico mostri una dinamica «autonoma» (e purtroppo crescente) che,
non solo, non è influenzata dal maggiore o minore livello di decentramento dell’ordinamento
nazionale, ma rischia anche di giustificare l’affermazione secondo cui «si stava meglio quando
si stava peggio» (ossia quando il livello di decentramento dell’ordinamento nazionale era assai limitato) (7). Quali, quindi, le principali cause del fallimento (ormai anche «mediatico») di
Marco Di Siena - Avvocato in Roma - Chiomenti Studio Legale
Note:
(3) Si veda, a titolo esemplificativo, M. Sensini, «La carica delle
tasse federali. Addizionali più pesanti del 573%», in Il Corriere della
Sera del 21 luglio 2013. Di pochi giorni precedente S. Padula - G.
Trovati, «Un macigno insopportabile», in Il Sole - 24 Ore del 16 luglio 2013.
(4) Su tale formula, per tutti, cfr. G. Tremonti - G. Vitaletti, Il federalismo fiscale, Bari, 1994. Gli Autori, infatti, evidenziano che «è nel
budget che la rappresentanza e la responsabilità politica trovano il
loro punto di massima trasparenza: pago e prendo, voto e vedo. È
nel budget che si concentra il principio costituzionale fondamentale no taxation without representation; il controllo politico sul circuito
delle origini e degli impieghi delle risorse economiche destinate alla finanza pubblica. Dalle entrate alle uscite, il ciclo elettorale coincide infatti essenzialmente con il ciclo fiscale» (cfr. pag. 62).
(5) Cfr. L. Antonini, Federalismo all’italiana, Padova, 2013.
(6) Peraltro non nego che il mio giudizio sul cosiddetto federalismo fiscale è stato, sin dalla formalizzazione della legge delega n.
42/2009, non particolarmente positivo. In tal senso rinvio a M. Di
Siena, «Note minime (problematiche) sulle entrate tributarie degli enti sub-statali nella recente legge delega sul federalismo fiscale», in Riv. dir. trib., 2009, I, pag. 949 e ss.
(7) A bene considerare, infatti, la stessa serie storica del debito
pubblico evidenziata dai sostenitori del federalismo fiscale (si veda,
ad esempio, G. Tremonti, Lo Stato criminogeno, Bari, 1997 e, in particolare, pag. 43 e ss.) potrebbe essere intesa più che come la dimostrazione empirica dell’esigenza di accentuare il decentramento
come quella del fallimento di approcci decentralizzati. La crescita
esponenziale del debito pubblico italiano, infatti, ha avuto inizio
all’atto dell’implementazione della riforma regionale degli anni ’70
ed è proseguita inarrestabile in costanza di riforme e/o meccanismi ispirati alla valorizzazione dei livelli di governo locale come, ad
esempio, la riforma del titolo V della Costituzione ovvero la progressiva federalizzazione del prelievo. D’altronde, quand’anche non
se ne voglia condividere la vis polemica, v’è senz’altro del vero in
quanto affermato da V. Visco, «Federalismo come migliorare», in Il
Sole - 24 Ore del 14 febbraio 2009, pag. 10 secondo cui «il livello di
decentramento fiscale e finanziario che già esiste in Italia è (…)
molto consistente e quantitativamente più che adeguato: negli ultimi 10 anni (1995 - 2006), infatti, le entrate tributarie delle amministrazioni locali sono triplicate passando dal 15% del totale delle
entrate a oltre il 44%. (…) Ne deriva che non vi è alcun bisogno di
realizzare in Italia il federalismo fiscale: esso infatti è stato già realizzato dalle riforme degli anni ’90».
4/2013
363
Aspetti
strutturali
quella che, invece, avrebbe dovuto rappresentare un’«alba radiosa» per le finanze pubbliche?
Presumibilmente vi sono molteplici cause ma alcune di esse di ordine macro.
Un equivoco semantico
In primo luogo v’è stato un equivoco semantico
(sovente alimentato in maniera voluta).
Come rilevava Lupi, la stessa espressione di
«federalismo fiscale» è ambigua, ed ha contribuito a «caricare» di aspettative eccessive un’iniziativa assai differente rispetto al termine impiegato per designarla. Il vero fulcro del cosiddetto federalismo fiscale tracciato dalla legge n.
42/2009 è un quid che con l’attività «tributaria»
(intesa come insieme delle operazioni di prelievo) e con l’assetto federalista dello Stato ha assai poco a condividere: si tratta, infatti, principalmente del superamento del modulo di finanziamento della spesa degli enti locali incentrato
sul criterio della «spesa storica», previa sostituzione dello stesso con un meccanismo alternativo basato sui fabbisogni standard. Un’iniziativa
del tutto meritoria che, tuttavia, costituisce una
misura per rendere più efficiente la «spesa» degli enti locali e che non incide - se non in modo
marginale - sulle loro «entrate tributarie».
Si tratta, per di più, di un obiettivo realizzabile
anche rebus sic stantibus, ossia senza alcuna
esigenza di rendere più federalista l’ordinamento nazionale (8), e, soprattutto, rappresenta un’iniziativa priva di quelle connotazioni «epocali»
che la vulgata politica ha sempre correlato alla
nozione di federalismo fiscale nonché assai lontana da quella necessità di «permanenza fisica»
a livello locale delle entrate tributarie identificata come obiettivo prioritario da parte di una certa opinione pubblica.
Di qui, quindi, il primo grande misunderstanding sotteso al federalismo fiscale all’italiana.
Evocato a livello di propaganda come il mezzo
per evitare che i tributi raccolti sul territorio fossero destinati altrove e percepito talvolta come
opzione sostitutiva di un obiettivo latamente
«secessionista» si è dimostrato, alla prova dei
fatti, un qualcosa di assai differente. Un’iniziativa molto più pragmatica ma, proprio per questo,
assai lontana dagli ideologismi sottesi alla «questione del Nord» e, in particolare, un’iniziativa
364
4/2013
incredibilmente «distratta» su quello che alcuni
si attendevano: vale a dire la «territorializzazione spinta» del prelievo e l’introduzione di un
«federalismo» molto più «all’americana» (ossia
competitivo) di quello «cooperativo» di stampo
tedesco da ultimo adottato in via legislativa (9).
Più che di fallimento del cosiddetto federalismo
fiscale, si può parlare di esaurimento dell’effetto
di annuncio; questo, tuttavia, è anche un problema di «comunicazione» dei suoi reali contenuti
e di «disaffezione» dell’opinione pubblica determinata dalla dissociazione fra la «sostanza» del
fenomeno (assai poco focalizzato sulla materia
impositiva) e la «forma» lessicale impiegata per
evocarlo (che dell’attributo «fiscale» ha fatto il
proprio fulcro).
Un equivoco strutturale
V’è stato, anche, a mio giudizio, un equivoco
strutturale di cui occorre prendere atto. L’assetto
determinato dalla legge n. 42/2009 se, da un lato, ha garantito un sensibile incremento di risorse pecuniarie a beneficio dei livelli di governo
inferiori a quello statale, dall’altro, ha realizzato
questo obiettivo in modo poco coerente con il
principio di accountability cioè di responsabilizzazione, che dovrebbe, invece, rappresentare
una caratteristica del federalismo fiscale (10).
Note:
(8) Non è affatto casuale, quindi - a mio avviso - che E. De Mita,
Le basi costituzionali del federalismo fiscale, Milano, 2009 - all’esito
di un esame sintetico del testo del disegno di legge delega poi
traslato nella legge n. 42/2009 - si chiedesse «dov’è il federalismo» (pag. 77).
(9) Che, sfrondato dalle implicazioni polemiche di ordine politico,
il corpus rappresentato dalla legge n. 42/2009 e dai provvedimenti
delegati abbia implicazioni tributarie incomparabilmente inferiori
a quelle evocate dall’espressione «federalismo fiscale» è dimostrato, a mio avviso, dalla stessa analisi condotta da L. Antonini,
Federalismo all’italiana, cit., il quale dedica meno di un 1/3 del proprio saggio all’esame di tematiche tributarie in senso proprio.
(10) In tal senso cfr. G. Tremonti, «Più regole globali per la ripresa», in Il Sole - 24 Ore del 25 giugno 2009, pag. 14 (estratto del discorso tenuto in occasione del 235° anniversario di fondazione
del Corpo della Guardia di Finanza tenutosi a Roma il 23 giugno
2009) secondo il quale «federalismo fiscale vuole dire insieme:
responsabilità, moralità, equità, fiscalità. E in specie: responsabilità:
(…) se (i governi locali - N.d.R.) vogliono allargarsi (…) lo devono prima chiedere e poi fare pagare direttamente ai cittadini di
quel territorio». Sull’accountability come cifra del federalismo fiscale si veda altresì L. Antonini, «La vicenda e la prospettiva dell’autonomia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119
della Costituzione», in Le Regioni, 2003, pag. 18 ss.
Aspetti
strutturali
La legge delega, infatti, ha tracciato un assetto
largamente basato sui tributi propri derivati (ossia in concreto «etero diretti» dallo Stato sulla
scorta dell’archetipo dell’IRAP) ed ha previsto
un rilevante ricorso all’istituto delle compartecipazioni a forme di prelievo erariale. In ultima
analisi, si è dato vita ad un sistema contraddistinto, sin dalla sua genesi, dal rischio che il
nesso relazionale fra le decisioni di spesa, da un
lato, ed il prelievo, dall’altro, risultasse attenuato o comunque non immediatamente percepibile
dalla platea dei contribuenti allorquando, invece, il nucleo di una forma ideale di federalismo
fiscale è il budget che è «ottimo se c’è coincidenza tra struttura dell’imposizione, struttura
della rappresentanza politica, struttura dell’amministrazione: se (…) il soggetto tassato vota il
soggetto tassatore, se l’oggetto tassato è nella
competenza dell’amministratore votato» (11).
I decreti delegati della legge n. 42/2009 hanno
peggiorato la situazione diluendo vieppiù il livello di reale responsabilità fiscale degli enti locali rispetto allo standard minimo richiesto da
un’impostazione in astratto federalista come
quella propagandata (e ciò ancorché soprattutto i
Comuni siano stati, da ultimo, costretti ad accentuare le sgradite funzioni di «esattori» a
fronte di un ridimensionamento sensibilissimo
delle risorse trasferite dallo Stato). L’emergenza
spread (causa dell’anticipata applicazione dell’IMU con una assai poco comprensibile - se
non in termini meramente contabili - «riserva
statale») e le ultime convulsioni politiche (all’origine della «disfida ideologica» sulla possibile
abolizione dello specifico tributo sulla prima
abitazione) (12) hanno quindi concorso a «ferire
a morte» un sistema già esile nei suoi presupposti concettuali.
Una debolezza, peraltro, che - a mio avviso - è
tutt’altro che casuale e rispondeva ad una precisa scelta di campo dei responsabili politici più
interessati alla gestione della cosa pubblica a livello «infranazionale». Gli enti sub-statali infatti, non solo, sono sovente meno efficienti in termini di gestione complessiva dei tributi, ma soprattutto non hanno interesse (se non coartati)
ad assolvere i compiti di accertamento ed esazione. Non è un caso, quindi, che le proposte più
interessanti come quella di attribuire agli enti
sub-statali tributi propri completamente difformi
da quelli di tradizionale competenza erariale
(ma proprio per questo maggiormente ispirati al
principio di sussidiarietà tipico dei sistemi federali) non abbiano trovato alcuna eco nel contesto
del federalismo fiscale italiano. In tale prospettiva ritengo che l’obiettivo politico dei supporters
del «localismo finanziario» (veicolato mediaticamente con la suggestiva espressione di «federalismo fiscale») fosse evidente: disporre di
maggiori risorse finanziarie allontanando (per
quanto possibile) il ruolo di immediato esattore
che doveva continuare ad essere percepito dalla
collettività come di principale (se non esclusiva)
competenza dell’Autorità statale. Come rilevava
Lupi, soldi da spendere piuttosto che tributi da
riscuotere. Senza giudizi draconiani su una
realtà molto più complessa di quanto appaia in
superficie, il modulo tracciato dalla legge n.
42/2009, all’atto pratico, ha mostrato criticità e
contraddizioni che una formula politicamente
accattivante come quella di federalismo fiscale
ha lungamente mascherato nella fase di elaborazione del materiale normativo.
I limiti della decentralizzazione del prelievo
Il punto dirimente - tuttavia - è, a mio avviso, un
altro. Ciò che, presumibilmente, è errato è ritenere che la «delocalizzazione» del prelievo e
della spesa costituisca un bene in sé e garantisca
de plano maggiore efficienza e migliore controllo democratico. Purtroppo (e non solo per i difetti intrinseci della legge delega e dei relativi
provvedimenti delegati) l’esperienza dimostra
che non è così. Per un verso, infatti, la decentralizzazione del prelievo rischia di gravare su
Note:
(11) Cfr. G. Tremonti - G. Vitaletti, op. cit., pag. 63.
(12) Un’iniziativa che, come evidenziato dalla pressoché unanime
dottrina, contraddice le più elementari istanze di federalismo fiscale perché fa gravare il peso del tributo immobiliare comunale
principalmente sui «non residenti», in radicale antitesi al menzionato principio del «pago - vedo - voto». In tal senso, cfr. G. Muraro, «Come fare un’IMU più equa» del 18 marzo 2013 (liberamente accessibile sul sito www.lavoce.info). In tale contributo l’Autore chiarisce come l’abolizione (più o meno integrale) del tributo
immobiliare comunale sia destinata a risolversi in una mera «illusione finanziaria» visto che le risorse finanziarie così mancanti
sarebbero inevitabilmente sostituite da forme di imposizione alternativa.
4/2013
365
Aspetti
strutturali
strutture locali esili e storicamente impreparate
a gestire funzioni di accertamento e riscossione
in maniera impegnativa come inevitabilmente
presuppone un sistema federale (e ciò spiega per
quale motivo nel sistema delineato dalla legge n.
42/2009 la struttura portante del Fisco locale sia
rappresentata principalmente da «tributi propri
derivati» e da «compartecipazioni» ossia da misure che presuppongono un intervento minimale
da parte degli enti locali). Per altro verso, poi, la
decentralizzazione della spesa finisce spesso per
risolversi in un policentrismo decisionale che risulta difficilmente controllabile e non è necessariamente virtuoso ed attento alle esigenze delle
collettività locali (ma anzi risulta spesso viepiù
esposto a pressioni di ordine localistico).
La conclusione è che non esiste - a mio avviso alcuna superiorità morale e gestionale del cosiddetto federalismo fiscale rispetto ad altri moduli,
ove mai, contraddistinti da una maggiore pervasività delle decisioni delle autorità centrali. V’è
- come sempre - da gestire nel migliore dei modi
le procedure che si implementano e non è detto
366
4/2013
che nel «contenitore» del federalismo fiscale vi
siano solo iniziative buone o solo iniziative deteriori. V’è solo da scegliere in modo consapevole ed attuare in maniera conseguente. Di certo, tuttavia, occorre abbandonare quell’approccio ideologico che per lungo tempo ha caricato
il federalismo fiscale di responsabilità insostenibili facendone un’iniziativa che (non è dato sapere come) avrebbe garantito maggiore efficienza gestionale e minore pressione fiscale. Per il
momento - come visto dalla recente campagna
di stampa - né l’uno né l’altro obiettivo si sono
realizzati. V’è da augurarsi che per il futuro
qualcosa possa mutare ma non certamente per
effetto di ricette miracolose ma solo quale conseguenza di una (forse poco accattivante in termini «mediatici» ma senz’altro più efficace)
realizzazione di obiettivi di medio periodo da
individuare in modo puntuale e monitorare in
maniera progressiva. Il tutto abbandonando approcci da «rivoluzione epocale» e senza stupirsi
davanti all’accresciuta incidenza del Fisco locale. È il federalismo bellezza!
Aspetti
strutturali
Crescita, pressione fiscale
e determinazione della ricchezza
di Mariano Bella e Luciano Mauro, RL
Davanti al generale malessere tributario, alle sperequazioni e alle assurdità, la diminuzione della
pressione fiscale è un auspicio diffuso e convincente. Bisogna però chiedersi se la spesa pubblica
è una macchina da cui si può scendere, oppure se l’unica alternativa disponibile è quella di far
funzionare la macchina cui la medesima si riferisce. Ottenendo in cambio di stipendi «non comprimibili» servizi reali per la comunità. L’efficienza di una macchina pubblica che non vende nulla
può però derivare solo da iniziativa e responsabilizzazione. Uscendo da quel paralizzante circuito del «governo della legge», che blocca la macchina pubblica e innesca tendenze verso il suo ridimensionamento, anziché verso il suo corretto funzionamento.
Sul rapporto tra crescita e pressione fiscale
Mariano Bella e Luciano Mauro
Se le preferenze di una collettività, in qualche
modo computate, vanno nella direzione di attribuire all’operatore pubblico cospicui compiti,
tra cui quello di redistribuire ricchezza, allora,
verosimilmente, si osserverà un’elevata pressione fiscale. Pure in questo contesto, uno scrutinio
attento dei risultati della allocazione di compiti
tra mercati privati e azione pubblica è doveroso.
In Italia la frazione di output intermediata dallo
Stato e dagli altri enti pubblici non è dissimile
da quella riscontrata presso molte nazioni europee. Tuttavia, non soltanto è comune percezione
che la qualità dei servizi sia inferiore a quella
ragionevolmente attesa, ma i conteggi effettuati
restituiscono un quadro insoddisfacente, sia in
termini di capacità di riduzione delle disuguaglianze (1), sia in termini di crescita economica.
Proprio su quest’ultimo punto vogliamo proporre alcune riflessioni, non perché le dimensioni
della qualità dei servizi pubblici o dell’efficacia
delle politiche di equità siano meno importanti,
ma perché è il deficit di crescita il problema
principale, a nostro avviso, dell’Italia. Se si risolvesse questo, si avrebbero benefici anche sugli altri temi.
Le figure n. 1 e n. 2 (cfr. pag. 368) testimoniano
una correlazione - non certo una causalità specifica, tanto meno unidirezionale - tra incremento
della pressione fiscale e riduzione della capacità
di crescita, misurata in termini di PIL. La seconda figura è più nitida della prima perché sono
stati esclusi Paesi che, partendo da un carico fiscale particolarmente esiguo - tra essi vi è anche
qualche Paradiso fiscale - hanno potuto incrementare il peso del Fisco compatibilmente con
una vistosa crescita economica.
In Italia l’accelerazione della pressione fiscale è
stata la più accentuata fra le economie sviluppate: a questo fenomeno ha corrisposto la peggiore
performance in termini di crescita.
La nostra economia ha continuato a contrarsi ad
un ritmo di un decimo di punto l’anno, a fronte
di un incremento cumulato della pressione fiscale di 3,3 punti di PIL.
Naturalmente, si tratta di un processo di declino
che ha radici lontane ed è collegato sia al progressivo indebolimento del processo di produzione di ricchezza nazionale, sia al continuo ridimensionamento, comune peraltro a molte economie avanzate, della produttività multifattoriale. Non è certo tutta colpa del carico tributario e
contributivo su cittadini e imprese. Però tale
Mariano Bella e Luciano Mauro
- Ufficio Studi Confcommercio
Nota:
(1) ISAE, 2007, Politiche pubbliche e redistribuzione.
4/2013
367
Aspetti
strutturali
Figura n. 1 - Incremento della pressione fiscale e riduzione della capacità di crescita
Figura n. 2 - Incremento della pressione fiscale e riduzione della capacità di crescita
368
4/2013
Aspetti
strutturali
evidenza, unita alla citata inefficacia delle politiche redistributive e all’acclarata inadeguatezza
dei servizi pubblici, per lo meno dovrebbe indurre una semplice riflessione: l’attuale pressione fiscale non solo è incompatibile con la ripresa, ma non favorisce la crescita e, dopo tutto,
non sembra particolarmente utile per alcuno degli scopi che dovrebbero essere perseguiti dal
cosiddetto Stato sociale.
Nella Tabella n. 1 (a pag. 369) è riportato il tasso medio annuo di crescita del PIL pro capite
reale nel lungo periodo nelle principali economie europee, in Giappone e negli Stati Uniti.
Si vede chiaramente come per il nostro Paese il
processo di crescita si arresta praticamente all’inizio degli anni duemila, considerando che nel
quarantennio precedente le performance sono
state, anche se progressivamente decrescenti, di
tipo «asiatico» e comunque sempre superiori a
quelle della pur poderosa manifatturiera economia tedesca, divenuta poi, soprattutto nel recente presente, un penalizzante benchmark di riferimento. Poi, nel periodo 2001-10, pur soffrendo
tutti i Paesi la pesante flessione del 2009, l’Italia
è l’unica economia a denotare un tasso medio
annuo negativo.
Ciò non può essere frutto del caso e il fatto og-
gettivo di avere sperimentato il più forte incremento di pressione fiscale (come visto dalle Figure n. 1 e n. 2) va tenuto in considerazione come concausa o, perlomeno, come fattore facilitatore del declino.
Senz’altro, su base intuitiva, si deve chiamare in
causa anche l’incapacità dei nostri policy maker
di utilizzare i vantaggi di un lungo periodo di
politica monetaria accomodante, con bassi tassi
di interesse, per risanare la finanza pubblica,
rendere più efficiente la spesa e sviluppare i necessari investimenti infrastrutturali. Quella stessa incapacità ha poi costretto, dal 2008, a forme
sempre più stringenti di consolidamento fiscale,
per di più in una fase di acuta recessione, e
quindi a progressivi inasprimenti della pressione
tributaria e contributiva, con i risultati che è
possibile leggere in un’ulteriore perdita di altri 4
o 5 punti di PIL pro capite nel biennio 20122013.
A nostro avviso il ruolo dell’operatore pubblico
va ripensato, recintandone l’azione all’interno di
un perimetro meglio definito (e magari ridotto
rispetto a quello attuale). La sua presenza pervasiva nelle attività economiche - basti pensare al
ruolo delle partecipazioni statali ancora fino ai
primi anni novanta, all’articolazione delle fon-
Tabella n. 1 - PIL pro capite in termini reali
var. % medie annue
1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-10
2011
2012
2013
Belgio
4,3
3,2
1,9
1,9
0,8
0,9
-0,9
-0,7
Danimarca
4,0
1,9
2,1
2,2
0,2
0,7
-0,8
0,5
Germania
3,5
2,7
2,0
1,5
1,0
3,0
0,5
0,2
Spagna
6,2
2,5
2,7
2,5
0,7
0,3
-1,5
-1,3
Francia
4,6
3,1
1,8
1,5
0,5
1,1
-0,6
-0,6
Italia
5,0
3,3
2,3
1,6
-0,2
0,0
-2,6
-1,7
Olanda
3,8
2,2
1,9
2,5
0,9
0,5
-1,3
-1,3
Austria
4,1
3,5
2,1
2,2
1,1
2,3
0,3
0,1
Finlandia
4,4
3,5
2,5
1,7
1,4
2,3
-0,7
-0,2
Svezia
3,9
1,6
1,9
1,7
1,6
2,9
0,1
0,8
Regno Unito
2,2
1,8
2,7
2,2
1,2
0,2
-0,5
-0,2
Stati Uniti
2,9
2,2
2,1
2,2
0,6
1,1
1,5
1,2
Giappone
9,0
3,2
3,7
0,9
0,8
-1,1
2,1
1,5
Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Commissione Europea-AMECO.
4/2013
369
Aspetti
strutturali
dazioni bancarie, all’affidamento in house della
maggior parte dei servizi pubblici locali nelle
utilities - riduce l’incentivo all’innovazione nel
sistema produttivo, contribuendo alla compressione della produttività multifattoriale (Tabella
n. 2 a pag. 370).
Anche in questo caso il nostro Paese, sempre a
partire dai primi anni duemila, denota le dinamiche negative più accentuate, a testimonianza
che, al di là dei difetti nell’organizzazione della
produzione e dei fallimenti del mercato, il «contesto», sotto forma di inefficienza diffusa del
settore pubblico - dal peso della burocrazia, alla
esasperante lentezza della giustizia, alla farraginosità della legislazione in ambito amministrativo e fiscale - è ormai un ambiente ostile all’attività d’impresa, rendendone ancora più difficile
la competitività sui mercati.
Uno di questi fattori di «contesto» che deriva,
tra l’altro, dall’incapacità del settore pubblico di
sottrarsi alla regola dello spend and tax, è proprio la pressione fiscale, che nel corso degli ultimi venti anni ha manifestato un vero e proprio
cambio di regime, a partire dalla seconda metà
degli anni duemila (Figura n. 3 a pag. 371).
A partire dal 2006-07, infatti, si può verificare
come la pressione fiscale si sia portata rapidamente verso il 43% per poi stabilizzarsi, nel periodo attuale, intorno o al di sopra del 44%, un
livello inusitato nella storia nazionale, considerando che si tratta di una misura della pressione
fiscale apparente, cioè che incorpora nel PIL la
quota di sommerso economico. Al netto di quest’ultima, la pressione fiscale che potremmo definire «legale» è superiore mediamente di circa
10 punti percentuali.
Non solo. L’estenuante rincorsa del carico fiscale nei confronti della spesa si accompagna, come visto, a una riduzione del PIL che, a sua volta, accresce il rapporto debito/PIL. Di conseguenza, gli investitori, riconosciuta la problematica sostenibilità di un onere crescente, domandano maggiori interessi per acquistare titoli del
nostro debito sovrano, enfatizzando gli squilibri.
Si è rapidamente passati, così, dallo spend and
tax allo spread and tax, un titolo sintetico per
descrivere la nostra recente storia economica.
I fattori cambiano, ma il tax, cioè la presunta ricetta, rimane sempre là, anche se somministrata
in dosi crescenti. E continua a non curare, ma ad
aggravare la situazione.
Bastano queste considerazioni, sintetiche seppu-
Tabella n. 2 - Produttività multifattoriale
var. % medie annue
1961-70
1971-80
1981-90
1991-00
2001-10
2011
2012
2013
Belgio
3,3
1,9
1,2
0,9
0,2
0,5
-0,7
-0,4
Danimarca
2,9
0,9
1,1
1,8
-0,1
1,2
-0,4
0,5
Germania
2,6
1,5
1,0
0,7
0,4
1,8
-0,3
-0,2
Spagna
5,0
1,9
1,0
0,3
-0,2
1,0
1,1
0,6
Francia
3,7
1,7
1,2
0,9
0,0
0,7
-0,6
-0,7
Italia
4,3
1,7
1,1
1,0
-0,4
0,1
-1,7
-0,6
Olanda
2,6
1,3
1,2
1,2
0,5
0,3
-0,7
-0,4
Austria
3,5
1,4
1,2
1,3
0,5
1,2
-0,5
-0,4
Finlandia
2,7
2,2
1,6
2,3
0,6
1,5
-0,8
0,1
Svezia
2,5
0,3
0,9
1,9
1,2
1,5
-0,3
0,7
Regno Unito
1,7
1,1
1,6
1,7
0,6
0,2
-0,9
-0,2
Stati Uniti
1,9
0,9
1,0
1,3
0,7
1,1
0,5
0,7
Giappone
7,0
1,5
2,2
0,0
0,8
-0,3
1,8
1,3
Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Commissione Europea-AMECO.
370
4/2013
Aspetti
strutturali
re confuse (molti passaggi sono stati omessi),
per chiarire che il problema del carico fiscale è
il «problema» italiano? Se si è convinti di questo, le considerazioni sul (difficile) reperimento
delle risorse necessarie per un alleggerimento
del carico fiscale assumono un significato diver-
so da quello che hanno oggi: non più un’esigenza importante, ma la soluzione progressiva di
una questione vitale.
Secondo noi, l’acquisizione di tale consapevolezza è il primo passo per risolvere il problema.
Sul quale, eventualmente, ritorneremo.
Figura n. 3 - Livello di pressione fiscale negli ultimi 20 anni
4/2013
371
Aspetti
strutturali
Spesa pubblica: è troppa o «non funziona»?
RL
Su Dialoghi non ci occupiamo degli effetti delle
imposte, ma della determinazione della ricchezza ai fini tributari. Concettualmente sono due
questioni diverse, perché si può avere una determinazione efficiente e perequata della ricchezza,
che però finanzia spese pubbliche inutili. Entrate e spese sono tuttavia interdipendenti almeno
per un aspetto, in quanto la determinazione della
ricchezza ai fini tributari è una funzione pubblica che - dove non arrivano le aziende a fare da
esattori del Fisco - è in una condizione di semiparalisi. La critica degli Autori che precedono è
rivolta alla quantità dell’intervento pubblico,
che però è equivalente, come costo e quota del
PIL, ad altri Paesi europei. Il problema è la scarsa qualità dell’intervento pubblico, in larga parte
dovuta a pastoie interne delle modalità con cui
vengono prese le decisioni ed i denari vengono
spesi.
Ha ragione Attilio Befera quando dichiara che
«chi paga le tasse compra civiltà», però lo spettacolo di una spesa pubblica paralizzata e «incivile» non giova a quest’immagine. Per questo si
crea una tendenza «antitasse», in cui per molti
versi si inseriscono anche gli economisti che mi
hanno preceduto; anche nel loro intervento si
percepisce però che al problema della cattiva
qualità della spesa non si può rispondere solo riducendo la spesa. Bisogna capire invece che
nella società moderna la più grande azienda di
un Paese è proprio l’apparato pubblico, dal cui
funzionamento dipende in gran parte anche la
buona salute delle aziende private (2). Se non si
capisce questo, è normale che nella pubblica
opinione prendano piede tendenze dove la cattiva qualità della spesa pubblica diventa un motivo di ostilità verso i tributi. La reazione più opportuna, davanti al cattivo funzionamento della
maggior parte delle funzioni pubbliche, non dovrebbe essere l’eliminazione delle medesime,
ma il loro rilancio, mettendone a punto
quell’«aziendalizzazione» che dovrebbe prendere il posto della loro vecchia organizzazione
«gerarchico-militare» (3).
L’economia pubblica, l’intervento dello Stato, la
372
4/2013
sua efficienza, cammina sulle gambe del diritto,
cioè della combinazione tra regole e valori che
deve guidare il comportamento di istituzioni
operanti per definizione «fuori mercato». Proprio l’arretratezza mentale del diritto italiano,
come scienza sociale, secondo quanto rileviamo
nella prefazione a questo numero di Dialoghi, è
alla radice della crisi della spesa pubblica. Per
ragioni giuridiche, davanti alle quali gli economisti sono impotenti, le spese inutili si autoproducono e si autoalimentano, in un vortice di passaggi burocratici praticamente provvisto di vita
propria. Sempre per ragioni giuridiche non si
riescono a prendere le decisioni più sensate al
momento opportuno, in tutti i campi dell’agire
pubblico, fino alle motovedette della guardia costiera a Lampedusa che non prendevano a bordo
i naufraghi, salvati da pescherecci privati, per timore di «infrangere il protocollo», in una manifestazione momentanea della malattia della macchina pubblica. Cioè dell’idea distorta di «governo della legge», in cui tutti temono di valutare quale sia «la cosa giusta», l’azione più opportuna, che deve essere effettuata anche tenendo
conto dei regolamenti, ci mancherebbe altro, ma
non elevandoli a feticcio per coprirsi le spalle.
Questo avviene con la solita frase «io applico
solo le leggi, e le leggi non le ho fatte io», che
maschera solo il desiderio di non esporsi, di non
assumersi quel grado di responsabilità necessario a gestire la situazione. Per questo la crisi dell’economia pubblica è «giuridica» e non ha soluzioni legislative. Per questo si finanziano manifeste assurdità, dove però tutti sono formalmente
«a posto», e al tempo stesso magari per una spesa davvero utile e sensata si rischia l’abuso di
ufficio. Si potrebbe parlare, seguendo gli Autori
che precedono, di mancanza di controllo della
Note:
(2) È un filo conduttore del mio Manuale giuridico di scienza delle
finanze, Dike, 2012, messo a punto nel successivo Compendio di
scienza delle finanze, Dike, 2013. In sintesi, se si supera la confusione tra diritto e legislazione, «l’economia pubblica è diritto».
(3) Sul fallimento, per adesso, di questo passaggio, e sulle relative
ragioni, R. Lupi, Manuale giuridico, cit., pag. 194 ss.
Aspetti
strutturali
spesa pubblica, ma non in termini quantitativi
assoluti, quanto al suo interno, dove il buonsenso è sistematicamente mortificato da una spesa
che si «autoproduce», vivendo di vita propria,
mentre non si riescono a spendere pochi spiccioli per interventi utili, ma «non in budget». Tra
queste condizioni della spesa pubblica e la ritrosia a pagare le tasse c’è un collegamento evidente, ma strumentale, dove gli evasori difendono le
proprie scelte con lo slogan, «non glieli ho dati
perché altrimenti sprecavano anche quelli». L’inefficienza della spesa fa concepire l’evasione
come una legittima difesa dei titolari di ricchezza sfuggente, che magari non pagherebbero neppure se la macchina pubblica fosse efficiente. La
scarsissima qualità della spesa pubblica fa montare una polemica contro le tasse, ma il problema non è ridurre la spesa. Si tratta piuttosto di
far funzionare la più grande azienda italiana,
cioè i pubblici uffici. Compresi quelli destinati
alla determinazione della ricchezza ai fini tributari, dove le aziende non arrivano. Perché, come
vedremo in altri articoli, l’evasione non è una
«perversione privata», bensì una delle tante disfunzioni della macchina pubblica, a loro volta
radicate in deficit formativi della classe dirigente a proposito di determinazione amministrativa
della ricchezza. L’imperativo quindi, mentre si
riduce la spesa superflua, è anche cercare di far
funzionare quella inevitabile.
4/2013
373
CODICE
CIVILE
ANNOTATO
CON LE LEGGI
TRIBUTARIE
a cura di TOMMASO LAMEDICA
Gli articoli del Codice civile, aggiornati con le più recenti modifiche,
sono annotati con la legislazione complementare più significativa ai
fini delle correlazioni esistenti tra l’ordinamento civilistico e quello
tributario, riportata - al pari di quella normativa tributaria - di seguito
al Codice civile, in ordine cronologico.
Il collegamento tra i due ordinamenti (civilistico e tributario) è attuato
mediante segnalazione, in calce all’articolo del Codice civile, delle correlazioni tributarie, delle segnalazioni giurisprudenziali e dei principi
contabili applicabili.
Le disposizioni tributarie sono corredate da sintesi delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza, dal Ministero delle finanze e dalle
Agenzie delle entrate.
pagg. 2820 - 129,00
Il volume è completato dagli indici sistematico e analitico-alfabetico
delle disposizioni contenute nel Codice civile e dall’indice cronologico
delle altre norme.
Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it
oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.ipsoa.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.
acquistare il volume Codice civile a cura di Tommaso Lamedica a € 129,00.
Cognome e Nome
Azienda/Studio
Via
CAP
Città
Tel.
Fax
e-mail (obbligatoria):
Cod. cliente
Partita IVA
C.F.
q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura
q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito:
q Mastercard (16 cifre)
q American Express (15 cifre)
n°
Nome e indirizzo titolare carta di credito
Timbro e firma
q VISA (16 cifre)
q Diners (14 cifre)
Data di scadenza
Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i
suoi dati personali saranno registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal.
F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e
saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che
La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma
4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un
Fax al numero: 02.82476.403.
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi
dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte
del cliente senza che questi abbia comunicato con
raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia
S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile confermati
con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la
propria volontà di recesso, la proposta si intenderà
impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In
caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso
termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene
dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver
Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090
Assago (MI) - telefax 02.82476.799.
Y86EC FI
(00138590) Si, desidero
Aspetti
strutturali
Tassazione attraverso le aziende:
dai numeri ai concetti
in una recente monografia
di Mario Damiani, Raffaello Lupi
Chiedersi quanto gettito arriva dalla tassazione attraverso le aziende è un po’ come chiedersi
quanta acqua c’è nel mare. Verrebbe da dire «tanta», con una risposta intuitiva, ma poco precisa,
un po’ come è stimata - per converso - la ricchezza tributariamente non registrata. Mario Damiani ha provato a fare qualche passo avanti in un suo volume appena pubblicato, che conferma
ovviamente la sensazione diffusa, e inserisce qualche indicazione numerica in più. Fino ad arrivare a risultati non molto diversi da quelli pubblicati in Tassazione aziendale in cerca di identità, allegato a Dialoghi nel 2010, dove si indicava che circa 7.500 contribuenti con oltre 40 miliardi di
fatturato forniscono oltre la metà del dichiarato IVA. Il problema non è tanto la determinazione
valutativa, da parte degli Uffici tributari, della ricchezza dove le aziende non arrivano, ma la mancata comprensione del ruolo tributario delle aziende, persino da parte di chi ci lavora.
Il contabilismo «funziona» dove ne esistono i presupposti,
il problema sono le stime
Mario Damiani
L’intervento che segue prende lo spunto dalla
presentazione di un libro, da poco pubblicato da
chi scrive col titolo «Tassazione attraverso le
aziende tra contabilismo e stime», con il sottotitolo «Dimensioni organizzative d’impresa e profili patologici della fiscalità».
La prefazione di Raffaello Lupi, al quale va il
mio profondo ringraziamento, si intitola «Una
conferma del peso della tassazione attraverso le
aziende». In essa si osserva, tra l’altro, come il
libro costituisca un punto di incontro tra diritto
ed economia, generale ed aziendale, confermando come l’economia pubblica si regge su tributi
prelevati con un intervento «virtuale» delle istituzioni giuridico-amministrative, che fanno leva
«sulle aziende» come esattori di tributi.
Le aziende esattori dei tributi
e il mancato coordinamento
tra la tassazione contabilistica
e quella valutativa
Nel pretendere dalle aziende che esse richiedano
i tributi che gravano sulle controparti (come l’IVA dei consumatori finali, le ritenute dei lavoratori e dei risparmiatori, le imposte sui consumi di
chi acquista carburanti o paga le bollette della luce, del gas, del telefono, fino alle imposte sostitutive sui redditi finanziari), lo Stato, massima
aggregazione sociale, viene ad utilizzare altre
aggregazioni sociali «intermedie» (le aziende).
La ricchezza che non passa attraverso le aziende
dovrebbe però continuare ad essere determinata
(e tassata) attraverso gli Uffici tributari, come
avviene da sempre, nel consueto modo valutativo «per ordine di grandezza».
Invece la necessità di coordinare codesta (nuova) tassazione di tipo contabilistico con la tassazione valutativa attraverso gli Uffici, dove le
aziende non arrivano, non è stata adeguatamente
considerata.
Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l’Università LUM J. Monnet - Bari - Titolare modulo J. Monnet della
Commissione europea
4/2013
375
Aspetti
strutturali
Non di rado si indugia, piuttosto, in disquisizioni su tecnicismi di dettaglio che hanno poco a
vedere con la determinazione tributaristica della
ricchezza, così che resta in questo modo scoperto il concetto stesso di «evasione fiscale» (col
rischio di creare nella pubblica opinione confusione tra la ricchezza non registrata e la maggiore imposta accertata), e ci si limita a reinterpretare circostanze registrate o comunque palesi,
non evidenziando a sufficienza la distinzione tra
la ricchezza non registrata e l’evasione interpretativa, realizzata forzando l’inquadramento giuridico della ricchezza registrata, o comunque palese, in schemi impropri, dettati solo da convenienza tributaria.
Nel libro si è anche cercato di inquadrare organicamente in termini quantitativi il fenomeno tributario e di mettere ordine nei numeri sulla tassazione attraverso le aziende, identificando l’ordine
di grandezza dei flussi economici che attraverso
di esse pervengono alle casse dello Stato ed in tal
modo si è avuta conferma che circa il 70% del
gettito tributario è ottenuto per il tramite di non
più di trentamila aziende munite di una certa organizzazione, senza dimenticare però che un’azienda può essere al tempo stesso un «esattore
del Fisco» ed uno strumento di evasione nell’interesse della proprietà (singola o associata) (1).
Infatti se l’azienda può essere utilizzata come
organizzazione per trattenere le imposte sulla
parte di ricchezza prodotta che spetta a soggetti
terzi, ed in tale veste appare abbastanza agevole
controllarla, tanto con i sistemi contabili di registrazione dei redditi (retribuzioni ed altri compensi) erogati che con le dichiarazioni quali sostituti, non altrettanto può dirsi per la ricchezza
propria. In ultima analisi si tratta della ricchezza
spettante all’imprenditore, che - a differenza
dell’azienda - ha bisogni personali. Questo è il
settore dove resiste più a lungo la ricchezza non
registrata, e dove occorre verificare con più attenzione se esistono forme insidiose di patologia
tributaria, al di là dell’evasione interpretativa.
Soffermandosi sul peso economico della tassazione attraverso le aziende in correlazione con
la strumentazione giuridica allestita disordinatamente dal legislatore, nel libro si è anche cercato di spingere verso il superamento dei, pur involontari, squilibri nella distribuzione del prelie-
376
4/2013
vo, dovuti al rilevantissimo incremento della
pressione fiscale, intervenuta dal 1970 ad oggi,
come pure delle lacerazioni e degli equivoci che
pervadono la nostra società in materia di determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Quali soggetti economici, le aziende, comunque
le si voglia qualificare giuridicamente (imprese
o lavoratori autonomi), sono l’essenziale fonte
di produzione della ricchezza e da esse promanano o in esse transitano i flussi di reddito, e di
ricchezza in generale, attribuiti ai soggetti che vi
concorrono (lavoratori dipendenti e non, finanziatori, soci o titolare). Il momento della tassazione dovrebbe quindi essere quello in cui la
ricchezza entra, in qualsiasi forma o modalità,
nel circuito dell’economia personale o famigliare per essere spesa o risparmiata.
La visibilità amministrativistica delle aziende
viene a costituire, allora, un elemento cardine
del sistema tributario, essendo ad esse richiesta
un’importante attività di compliance col Fisco,
che presuppone una organizzazione amministrativo-contabile minimale, propria o affidata a servizi professionali esternalizzati.
Come vitale centro di interessi economici, le
aziende costituiscono il tramite per il quale transitano o possono transitare i flussi finanziari ed
economici che riguardano gli altri soggetti economici (aziende clienti o fornitrici) con cui vengono a relazionarsi per i rapporti d’affari intrattenuti. È possibile, allora, intercettare la ricchezza che vi transita o che comunque genera flussi
finanziari in entrata o in uscita, sia per prelevarne una parte destinata al Fisco, sia per raccogliere notizie utili da segnalare al Fisco stesso (elenco delle transazioni intervenute, elenchi delle
operazioni intracomunitarie, elenco delle spese
eseguite dai clienti privati, banche dati ai fini
delle indagini finanziarie). Occorre chiedersi,
perciò, dove si trova la ricchezza non registrata
e quali forme dissimulate può assumere per
sfuggire all’imposizione per cercare, tra l’altro,
di organizzare e dosare le risorse dell’Amministrazione finanziaria dedicate ai controlli fiscali.
Al momento, infatti, queste forze sembrano più
Nota:
(1) Come dimostra ad esempio il noto caso esaminato in R. Lupi,
«Gli interposti, gli imprenditori e le aziende (tra caso Mediaset e
tutoraggio fiscale)», in questa Rivista, pag. 435.
Aspetti
strutturali
concentrate sulla individuazione e formulazione
di contestazioni interpretative, intese come riqualificazione giuridico-tributaria di fattispecie
dichiarate e comunque non nascoste o non nascondibili, che sulla ricerca della ricchezza occultata. E le attività sono ancora troppo sbilanciate nelle verifiche nei confronti delle aziende
strutturate organizzativamente in modo soddisfacente rispetto a quelle che non lo sono e che,
quindi, essendo connotate da una naturale ben
maggiore pericolosità fiscale, richiedono una
maggiore fatica e competenza.
L’assetto molto polverizzato della struttura
dell’economia italiana, con un numero spropositato di micro-aziende, rende difficile una programmazione di verifiche ricorrenti e richiede,
perciò, un’attenta analisi di priorità dei controlli,
a partire dalle situazioni di maggior pericolo. Ma
la valutazione della loro efficienza economica
suggerisce di non dedicare molte energie sui
controlli relativi alle piccole aziende, a causa di
un rapporto costi-benefici troppo alto, e di riservare, invece, maggiore attenzione a quelle medio-grandi, suscettibili di produrre maggior gettito. Così facendo, però, si trascura gran parte
dei fenomeni di evasione «vera» (intesa come
ricchezza realmente occultata e non quella da interpretazione dell’emerso), che nella grande numerosità dei soggetti interessati comporta importi complessivi rilevanti. In questo universo di
piccoli operatori economici, i sistemi contabili,
spesso curati con mero formalismo ragioneristico, difficilmente riflettono in modo genuino la
gestione aziendale e s’impongono perciò, da parte del Fisco, controlli sostanziali di natura valutativa anche quando la contabilità non sia disattesa nel suo insieme. E tuttavia i sistemi di tassazione «stimata» in modo standardizzato, più o
meno affinato, quali sono gli studi di settore,
contengono una dose di arbitrarietà ed incertezza
ancora elevata per assurgere a surrogato appagabile e generalizzato della tassazione analiticocontabile, tanto che si assiste alla loro esaltazione in una fase storica ed alla loro svalutazione in
quella successiva; la circolare dell’Agenzia delle
entrate 31 luglio 2013, n. 24/E (2) esprime bene
questa sensazione, cercando di apparire «buonista» nel fornire indicazioni sull’uso del redditometro quale strumento di misurazione della ric-
chezza prodotta. In realtà, qualunque elaborazione statistico-matematica, quali che siano gli indicatori utilizzati per la stima, esprime un datorisultato tendenziale accettabile ai fini dell’accertamento e può condurre ad una valutazione di
maggiore o minore pericolosità fiscale che richiede ulteriori elaborazioni mediante un’indagine individualizzata che costa fatica e tempo e rischia di produrre risultati limitati. E qui si ritorna, allora, alla tentazione di realizzare un corto
circuito ed aggredire così le aziende organizzate
ricercando gli errori (veri o presunti) di qualificazione giuridico-tributaria delle singole fattispecie impositive, da contestare con inevitabili
diatribe processualistiche che tendono a distrarre
rispetto al nocciolo del problema.
È necessario perciò che l’assetto organizzativo
dell’accertamento dei tributi tenga conto del
ruolo delle aziende, quali esattori del Fisco e
che anzi si sostituiscono al Fisco nel richiedere
le imposte, ne agevoli la funzione, riducendo gli
adempimenti inutili o ripetitivi e ne esalti le
possibilità di segnalazione automatizzata degli
indicatori di capacità economica. Se si immaginasse che al posto delle aziende organizzate ci
fossero solamente i piccolissimi operatori, i rischi di evasione complessiva (per tributi propri
e per quelli trattenuti da terzi) sarebbero molto
più preoccupanti ed estesi ed il bilancio complessivo rischierebbe di essere negativo. Questo
è il quadro tipico delle economie statiche da
tempo, non coinvolte in processi di rinnovamento ed innovazione significativi, in cui mancano
strutture produttive robuste e capaci di competere nei mercati internazionali ed in cui l’estrema
polverizzazione delle attività economiche è funzionale anche ad un controllo politico della società, non di rado autoritario.
Lo scenario futuro non può, allora, che essere
quello che procura di favorire il processo di aggregazione e di ampliamento dimensionale delle
aziende ed il rafforzamento di quelle organizzate o suscettibili di esserlo anche mediante outsourcing, quale cerniera essenziale ai fini della
tassazione della ricchezza prodotta, da una parte
spingendo ulteriormente il processo che tende a
Nota:
(2) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
4/2013
377
Aspetti
strutturali
ricondurre la tassazione attraverso esse e, quando ciò non è possibile, cercando di concentrare
le risorse dei controlli fiscali sugli altri soggetti
in ordine decrescente di pericolosità e di possibile gettito recuperabile.
In questa strategia di ricerca di un giusto equilibrio tra efficienza organizzativa del sistema tributario e di ricerca del recupero dell’evasione, è
da considerare anche l’effetto mediatico che si
produce con la spasmodica attenzione, spesso
superficiale, al fenomeno fiscale. L’evasione
non è sempre considerata dai media alla stessa
maniera; si tende infatti a distinguere quella «da
sopravvivenza» (3), senza la quale, cioè, il piccolissimo operatore sarebbe costretto a chiudere
l’attività, con incremento del numero dei disoccupati e loro transito, non di rado, nell’area degli autonomi border line, ulteriori aspiranti evasori, così che essa viene considerata con una
certa indulgenza. Diverso è il giudizio che viene, giustamente, riservato con severità all’evasione per «avidità», che è quella che pratica il
soggetto che dispone di un reddito ben superiore
alle sue necessità ed al suo tenore di vita e che
sottrae parte dell’imponibile solo per accumulare ulteriore ricchezza.
Il grado di complessità organizzativa ed operativa delle grandi aziende, come le banche o le
compagnie di assicurazione, ovvero delle grandi
imprese che erogano servizi pubblici soggetti ad
accisa (gas, elettricità ecc.) è alquanto elevato,
mentre è un dato di fatto che le rudimentali strutture organizzative delle piccole imprese, che sono le più numerose nel nostro Paese (quasi il
95% di tutte le imprese), non le rende affidabili.
Ciò è motivo di preoccupazione per l’Amministrazione finanziaria, la quale è sempre più portata a valutare favorevolmente un ulteriore processo di esternalizzazione degli adempimenti fiscali per i quali codeste aziende si affidano agli
studi professionali, che, a loro volta, diventano i
soggetti attuatori degli adempimenti aziendali in
materia di ritenute e prelievi alla fonte.
Ricordando che la parte di ricchezza nazionale
tassata attraverso le aziende è notevole, e va dal
66 al 71%, a seconda che si considerino solo i
tributi totali ovvero solo quelli erariali e che i
relativi adempimenti possono risultare affidabili, anche per le imprese medio-piccole, attraver-
378
4/2013
so il tutoraggio professionale, resta comunque
una significativa frazione di tributi propri, che
dev’essere tassata con attività diretta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, che potranno avvalersi di informazioni utili mediante ricorso ai dati delle aziende di credito, utilizzando
ad es. le recenti disposizioni in materia di obbligo di alimentazione della banca-dati dell’anagrafe tributaria con la segnalazione delle operazioni e dei conti bancari. Si realizza in tal modo
una integrazione dei sistemi di tassazione tra
aziende segnalatrici di dati e Uffici accertatori e
la tassazione avverrà secondo i vecchi canoni
dell’accertamento in rettifica o d’ufficio e quindi attraverso la richiesta di imposte da parte del
Fisco dove le aziende non arrivano.
Concentrare gli sforzi e le capacità operative
dell’Amministrazione sulle aree di formazione
della ricchezza nelle quali non vi è l’intervento
delle aziende quali esattori è essenziale, ma richiede sistemi di acquisizione delle informazioni utili di tipo reticolare. In essi ogni input o
punto di rete è essenziale, ma ne vanno studiate
e ricercate le fonti, dai pur limitati dati provenienti dalle altre Amministrazioni pubbliche
(Comuni, organi di polizia, ecc.) a quelli delle
aziende che hanno comunque avuto rapporti con
i soggetti verificati, ai contrasti d’interesse, fino
ai riscontri dei flussi finanziari già nella disponibilità dell’amministrazione.
Il sistema tributario va perciò considerato, studiato ed attuato in modo da realizzare la più ampia sinergia tra i diversi metodi di tassazione,
privilegiando la ricerca della ricchezza non registrata ed occultata da parte di quei soggetti i cui
flussi di ricavo e di reddito non sono intercettati
dalle aziende e nei cui confronti i controlli debbono essere, non solo selettivi (in ordine di importanza e grandezza dei flussi che si ritengono
occultati e degli indici di pericolosità fiscale),
ma anche strutturati in modo da acquisire la
maggiore quantità possibile di informazioni.
Va aggiunta la necessità che il diritto tributario
Nota:
(3) Su questo profilo si sono recentemente sviluppate anche polemiche politiche, che non hanno colto l’essenza di queste argomentazioni, forse ritenendo che costituissero una giustificazione
dell’evasione anziché un tentativo di spiegarne origini e motivazioni.
Aspetti
strutturali
estenda i propri interessi fino a considerare e valutare gli effetti delle norme giuridiche di carattere tributario o pantributario sull’organizzazione aziendale ed istituzionale. Si tratta di esaminare l’impatto che ciascuna disposizione tributaria può avere sull’organizzazione delle aziende e
delle istituzioni (in primis l’Amministrazione finanziaria), sulle modifiche o sugli adattamenti
organizzativi che può comportare, sull’efficacia
di queste variazioni e sulla idoneità a migliorare
la rete delle informazioni dirette al Fisco, sempre più utili, non solo alla tassazione che già avviene attraverso le aziende, ma anche a quella
che si realizza attraverso gli organi diretti di
controllo del Fisco.
La dimensione organizzativa delle aziende
e la sua rilevanza tributaria
Quando si parla di «aziende» è necessario intendersi sugli elementi essenziali che devono esistere affinché possano essere ritenute entità effettivamente significative per l’economia nazionale e, quindi, per il Fisco, essendo capaci di
produrre ricchezza con automatismi economicoorganizzativi che le rendono autosufficienti.
Proprio l’autosufficienza è un fattore da considerare, forse più della dimensione misurata dal
fatturato o dal numero degli addetti, per attribuire al concetto di azienda un’autonomia di funzionamento e quindi di sopravvivenza e di profittabilità che prescinde dall’apporto del titolare,
dei soci o addirittura del vertice del management. A parità di volume d’affari o di dipendenti, un’azienda è autosufficiente solamente se è in
grado di autogestirsi nell’attività ordinaria anche
senza i vertici, che invece sono certamente essenziali nell’elaborare le strategie di crescita, di
riconversione o di governo dei cambiamenti e
delle crisi. In questo caso l’organizzazione è talmente efficiente da risultare affidabile per definizione e quindi tale da poter fare accreditare
l’azienda anche nei confronti del Fisco come
soggetto idoneo ad evitare disfunzioni gestionali
o operative preordinate all’evasione fiscale ovvero a correggere immediatamente tali anomalie
quando si verificano.
Le aziende che non hanno queste caratteristiche
di autosufficienza in gran parte non possono
neppure definirsi tali quando la loro vitalità ed
attività dipende da un solo soggetto, seppure
coadiuvato da qualche collaboratore e famigliare, dovendo invece parlarsi, nella sostanza, di
lavoratore autonomo dalla cui opera dipendono
futuro e risultati dell’attività svolta. Sfrondate
da queste entità minori, le vere aziende sarebbero comparabili con quelle di altri Paesi assimilabili all’Italia per popolazione e struttura economica.
Per i soggetti che non hanno la connotazione dell’autosufficienza organizzativa sarebbe necessario prevedere modalità di controllo fiscale, di accertamento e di vigilanza del tutto diversi da
quelli applicabili alle aziende strutturate. Così come solo alle aziende autosufficienti andrebbe richiesto l’impegno ad intercettare la ricchezza che
si forma loro tramite ed a farne segnalazione al
Fisco, che potrà contare sulla efficienza della loro
organizzazione, compreso un apprezzabile sistema di controlli interni, e sulla loro indipendenza
rispetto alla proprietà ed ai vertici aziendali.
Un adeguato sistema di responsabilità dei soggetti apicali e degli altri da questi delegati, ampliando all’area fiscale, con opportuni adattamenti, le linee portanti della legge n. 231/2001
sulla responsabilità degli enti, potrebbe contribuire a far fare a queste aziende un salto di qualità, non solo per accreditarle in termini di tax
compliance, ma per essere anche utilizzabili per
fornire al Fisco i dati salienti dei rapporti con
controparti utili per la verifica della correttezza
fiscale dell’operato di queste ultime (tipici potrebbero essere i controlli di filiera e di rete).
Molti studiosi ritengono però ancora non maturi
i tempi per questa innovazione, dubitando che le
funzioni aziendali possano essere in grado di assicurare un adeguato controllo interno e che
possa addirittura essere costruito un modello organizzativo tale da fronteggiare efficacemente i
rischi di commissione dei reati tipici tributari.
Infine, nell’intento di superare il tradizionale
metodo di studio e di ricerca giuridica, fondato
soprattutto sull’analisi interpretativa della norma, nel libro si è cercato di analizzare in primo
luogo i fatti economici e di risalire poi alla coerenza di sistema della disciplina tributaria applicabile alle fattispecie considerate. Ecco perché
esso presenta una sequenza logica di approfondimenti di quei profili di patologia fiscale, che
4/2013
379
Aspetti
strutturali
costituiscono situazioni di confine tra legittimo
risparmio d’imposta, elusioni ed evasioni reali e
quelle che derivano da interpretazioni discutibili
della normativa (la cd. evasione interpretativa) o
che possono debordare nelle frodi fiscali che sono la riserva degli strateghi delle aziende con limitate inibizioni legalitarie, spesso di rilevanza
internazionalistica.
Perché le aziende non si rendono conto del loro ruolo?
Raffaello Lupi
Il disorientamento dei tributaristi
Quando i tributaristi alzano gli occhi dai dettagli
della loro personale esperienza professionale,
non sembrano rendersi conto del contesto in cui
si trovano. Magari iniziano a divagare sul rapporto tra «stato» e «mercato», «spesa pubblica»
e «spesa privata», bisogno di gettito, cattiva
qualità delle spese pubbliche, onestà e disonestà
dei contribuenti, lotta all’evasione e via enumerando. Tutte questioni generiche, estranee alla
determinazione della ricchezza ai fini tributari,
principale parametro cui far riferimento per determinare i tributi.
Questi ultimi, come si ricava dalla stessa parola
«imposta», devono essere «imposti da qualcuno»
e Mario Damiani ci ricorda che oggi questa richiesta avviene «attraverso le aziende», intese come
organismi di persone tenute assieme da uno scopo
economico, senza confonderle con i lavoratori indipendenti, titolari di un’azienda solo in senso
materiale, cioè attrezzature e merci, che non possono certo condizionare il comportamento fiscale
del titolare, ed unico addetto all’azienda.
Damiani mette in evidenza che l’utilizzazione ai
fini tributari delle registrazioni contabili e della
documentazione amministrativa posta in essere
dalle aziende per propri fini di controllo interno
è facile ed è efficiente, man mano che l’azienda
si spersonalizza rispetto al titolare; Damiani sostanzialmente conferma che il 60-70% del gettito tributario, tra ritenute, IVA, tassazione dei
profitti e del risparmio, accise sui consumi, proviene dalle circa 4.000 «aziende di grandi dimensioni», e diventa la quasi totalità se si considerano le circa 30 mila aziende di dimensioni
medie (50-250 addetti). I tributaristi sembrano
non rendersi conto di quanto precede, e continuano ad appiattirsi sui «materiali normativi»,
come se prima di essi non ci fosse nulla, come
380
4/2013
se fossero loro a creare i problemi, e come se
potessero magicamente risolverli. Un inconcludente circuito di commenti ai materiali normativi, critica al legislatore e invocazioni al medesimo pervade ormai la materia tributaria, frutto di
una mancata consapevolezza che travalica il
mondo degli accademici e dei professionisti,
estendendosi al resto delle classi dirigenti.
La mancata autocoscienza delle aziende
(o meglio «di chi ci lavora»)
Neppure le classi dirigenti, né le stesse persone
che lavorano nelle aziende si rendono conto che
l’organizzazione amministrativa aziendale è lo
strumento utilizzato dal Fisco italiano per determinare la ricchezza ai fini tributari, e richiedere
le imposte. Per molti versi questa incapacità di
comprensione deriva dalla carenza di formazione
socioeconomica della nostra opinione pubblica,
comprese le classi dirigenti. Abbiamo già messo
in evidenza su Dialoghi macroscopiche confusioni sul concetto stesso di «azienda», dove si
accostano gli organismi pluripersonali a milioni
di attività, al massimo gestite tra marito e moglie, o tra due fratelli tuttofare, dove l’«azienda»
esiste solo nel suddetto senso «materiale», dagli
scaffali alle merci offerte sul banchetto dell’ambulante. Accomunare in questo modo «aziende»,
come aggregazioni di persone, e «lavoro indipendente» (fino a considerare «azienda» anche il
venditore di caldarroste) genera equivoci pericolosissimi, e pone le premesse per non capire nulla, non solo di tassazione, ma anche di gestione
dell’economia, secondo un filo conduttore di
Dialoghi, su cui non insisteremo mai troppo (4).
Nota:
(4) Vedi in proposito da ultimo S. Capitani, R. Lupi, «Aziende e lavoratori indipendenti: anche gli studiosi confondono?», in Dialoghi
Tributari n. 3/2013, pag. 252.
Aspetti
strutturali
Damiani spiega che attraverso le aziende non si
riesce a raggiungere in modo equilibrato tutta la
ricchezza. Dai dati del volume emerge che in
Italia ci sono abbastanza aziende organizzate da
renderle insostituibili come esattrici delle imposte, ma al tempo stesso 1) inutilizzabili per la
tassazione del lavoro indipendente al consumo
finale, dove occorre la tradizionale valutatività
sistematica degli Uffici e 2) abbastanza piccole
da consentire al titolare di nascondere quote di
ricchezza percentualmente poco rilevanti, ma distruttive in termini di immagine pubblica delle
aziende, come indichiamo in altri articoli di
questo fascicolo (5).
Damiani conferma quindi che l’evasione è una
questione di organizzazione produttiva ben prima che di onestà, strumento di comprensione rudimentale e distruttivo. Che blocca la determinazione valutativa, da parte degli Uffici, della ricchezza dove le aziende non arrivano. Questi deficit esplicativi spiegano perché l’Italia si è adagiata sulla possibilità di acquisire una fetta importante del gettito attraverso la determinazione
ragionieristica della ricchezza, da parte delle
aziende, senza replicare con adeguata sistematicità le valutazioni dove le aziende non arrivano.
Sarebbe illusorio attendersi spiegazioni di quanto precede da parte delle aziende, per la loro
stessa natura di organismi spersonalizzati, tenuti
assieme dal prodotto, indifferenti ad una sistematizzazione sociale generale, di competenza
della politica ed estranea agli specifici oggetti
delle varie attività aziendali. Ogni azienda ha i
suoi problemi, è concentrata sul suo business,
non fa pedagogia sociale, né promuove movimenti di opinione, neppure sul ruolo delle aziende nell’organizzazione sociale.
Quindi le aziende fronteggiano l’inferno della
ricchezza palese, che pure le colpisce pesantemente, in ordine sparso. Ognuna si gestisce al
meglio (forse, al peggio ...) i propri rilievi sull’elusione, sulle valutazioni di bilancio, sull’inerenza, sui prezzi di trasferimento, sull’IVA comunitaria, su tanti altri aspetti sofisticati della tassazione. Magari le aziende pagano parcelle milionarie a costosissime macchine da soldi professionali, ma storcono il naso davanti alla richiesta di
esporsi «sull’idea di azienda», magari aiutando a
far passare nell’opinione pubblica i concetti che
stiamo spiegando. La parte tributaria de Il Sole 24 Ore, pur emanazione del mondo aziendale,
oscilla tra tecnicismi di dettaglio e luoghi comuni, impermeabile al concetto di tassazione attraverso le aziende. È il riflesso di uno strabismo
praticistico in cui le aziende, e le loro associazioni, da un lato sparano troppo corto, disperdendosi in tecnicismi specialistici oppure - quando se
ne distaccano - si disperdono, come dicevo all’inizio, su spesa pubblica, spesa privata, onestà,
disonestà, ecc. La risposta è che le aziende italiane sono troppo piccole, per fatturato e per mentalità, per essere strumenti di spiegazione della
società, e sono poco più che strumenti di produzione e distribuzione di beni e servizi. Fanno
cioccolatini e detersivi, insomma, non producono
idee, ed andrebbe benissimo così, se solo ci fosse
qualcun altro in grado di produrre idee. Sarebbe
bene che gli uomini operanti nelle aziende si rendessero conto che tutti i loro problemi tributari
non derivano dalle questioncine di dettaglio su
cui sono formulati i rilievi, ma dalla grossolanità
delle spiegazioni sull’adempimento e sull’evasione, e dalla mancata percezione dell’esternalità
positiva tributaria delle aziende. Che andrebbe
valorizzata anche se ciò «non serve ad alcuna
azienda in modo specifico». Invece ogni azienda
si chiede legittimamente perché dovrebbe pagare
lei, od esporsi lei, per una azione genericamente
utile a tutte le aziende. Peccato che questo gigantesco equivoco ostacoli, non solo la crescita delle
aziende, ma l’organizzazione sociale, in gran
parte fondata su di loro, come uniche strutture
efficienti della nostra organizzazione sociale.
Una società disorientata e rancorosa in materia
tributaria, con buona pace della consulenza fiscale milionaria, nuoce anche alle aziende. Cui
conviene aiutare l’opinione pubblica a capire la
tassazione attraverso le aziende, ottenendo per
loro quel riconoscimento di ruolo utile a sdrammatizzare il problema, rasserenando il settore, a
beneficio del patto fiscale e del patto sociale che
legano la nostra comunità.
Nota:
(5) R. Lupi, «Gli interposti, gli imprenditori e le aziende (tra caso
Mediaset e tutoraggio fiscale)», in questa Rivista, pag. 435.
4/2013
381
MANUALE
DELL’ACCERTAMENTO
DELLE IMPOSTE
Unico
nel
panorama
editoriale
italiano,
il
MANUALE
DELL'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE, giunto alla ottava edizione,
offre un’ampia ed organica trattazione della materia.
Nel manuale, l’Autore esamina le diverse tipologie di accertamento
(sintetico, induttivo, parziale, con adesione) con particolare attenzione alla natura dei poteri degli uffici finanziari (accessi, ispezioni) alle
forme di elusione, agli strumenti di difesa a disposizione del contribuente con le garanzie, ampiamente analizzate, offerte dallo Statuto
del contribuente.
Il perdurare della crisi economico e finanziaria, con conseguente
caduta dei ricavi e, quindi, delle entrate tributarie, ha evidenziato
talune criticità in materia di accertamento che l’Autore non manca
di evidenziare.
di Saverio Capolupo
Nell’opera, oltre a frequenti richiami all’indirizzo della dottrina e della
pagg. 3000 - 160,00
giurisprudenza più recente, particolarmente significativi risultano
VIII Edizione
alcuni spunti propositivi dell’Autore, frutto dell’esperienza maturata
in tanti anni di attività.
Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it
oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.ipsoa.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.
acquistare il volume Manuale dell'accertamento delle imposte di S. Capolupo a € 129,00.
Cognome e Nome
Azienda/Studio
Via
CAP
Città
Tel.
Fax
e-mail (obbligatoria):
Cod. cliente
Partita IVA
C.F.
q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura
q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito:
q Mastercard (16 cifre)
q American Express (15 cifre)
n°
Nome e indirizzo titolare carta di credito
Timbro e firma
Y64EF_FI.indd 1
q VISA (16 cifre)
q Diners (14 cifre)
Data di scadenza
Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i
suoi dati personali saranno registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal.
F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e
saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che
La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma
4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un
Fax al numero: 02.82476.403.
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi
dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte
del cliente senza che questi abbia comunicato con
raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia
S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile confermati
con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la
propria volontà di recesso, la proposta si intenderà
impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In
caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso
termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene
dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver
Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090
Assago (MI) - telefax 02.82476.799.
Y64EF FI
(00146591) Si, desidero
01/10/13 09:04
Aspetti
strutturali
Statuto del contribuente:
rigidità di ritorno della codificazione
frammentaria del buonsenso
di Marzia Lerani, Antonio Puce, RL
Anche per lo Statuto del contribuente vale quello che vale per tutte le leggi, espressione di tendenze diffuse nella pubblica opinione, che coesistono con altre, in equilibri precari che, spesso,
colgono solo una parte dei problemi, e la travisano, per poi essere modificate senza essere state
particolarmente utili. Lo Statuto del contribuente ha certamente dato un appiglio a chi doveva
difendere soluzioni di buonsenso, che in quanto tali sarebbero state sostenibili comunque, ma
ha anche innescato nuove rigidità e formalismi. Facendo dimenticare che la migliore tutela del
privato davanti a una istituzione non sta nelle norme, ma nella condivisione dei concetti; a tal fine bisogna coordinare tutti i profili rilevanti nel caso specifico. Codificarne qualcuno in modo
isolato provoca rigidità controproducenti anche nel caso di molte disposizioni statutarie.
Lo Statuto del contribuente come «legge manifesto»
Marzia Lerani
L’espressione «legge manifesto» non è una critica, ma un punto di partenza per una riflessione, che va al di là di un ipotetico «bilancio»
dello Statuto dei diritti del contribuente. Bisogna chiedersi piuttosto in quale misura siano
codificabili in astratto principi di buonsenso,
che ricorrono in concreto secondo sfumature diverse.
Lo Statuto senz’altro dà una possibilità di appiglio per chi vuole riflettere e quindi dare un fondamento normativo a principi valoriali di senso
comune diffusi, quali, la buona fede, l’imparzialità, il contraddittorio. Tali valori però devono
essere contestualizzati e paragonati ad altri, ricorrenti anch’essi in concreto, per poter capire
l’intensità con cui di volta in volta ognuno di essi si presenta.
Le ombre di quella che è stata ritenuta una «legge manifesto» sono la rigidità, il formalismo, in
quanto si cristallizza in una legge un valore, rendendolo invocabile anche quando ne manca un
bisogno concreto, col rischio di formalismi e disfunzioni sul buon funzionamento dell’Amministrazione pubblica, e di indebolimento dei prin-
cipi statutari proprio nei casi in cui il loro rispetto sarebbe invece più importante.
Lo Statuto è emblematico del rapporto che da
sempre intercorre tra valori e norme. Non si
vuole sminuire l’importanza del valore nella
sua portata generale, ma se lo stesso viene posto rigidamente a fondamento di una norma,
questo spiana la strada al formalismo creando
per altri versi una incertezza del diritto, tanto
più se la regola è dettata da una classe dirigente
disorientata e lacerata, come quella italiana sul
Fisco.
Accertamento prematuro
Queste rigidità emergono ad esempio nella disposizione sull’accertamento prematuro, la cui
interpretazione è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, iniziati con la sentenza
n. 22320 del 2010, nella quale la Corte di cassazione aveva affermato che l’accertamento prematuro non è affetto da nullità, e culminati con
la sentenza delle Sezioni Unite n. 18184 del
Marzia Lerani - Dottore in Giurisprudenza
4/2013
383
Aspetti
strutturali
2013 (1), che probabilmente non chiuderà la
questione.
In merito il quesito che sarebbe opportuno porsi
è se può essere considerato rispettoso del principio di proporzionalità punire gli Uffici per non
aver atteso che il contribuente formulasse delle
deduzioni difensive.
Posto che il diritto di difesa del contribuente
può esercitarsi comunque anche successivamente in via giudiziale con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, deve innanzitutto rilevarsi
che la sanzione di nullità non interviene a garanzia del diritto di difesa del contribuente, ma a
garanzia del contraddittorio anticipato, mancante nella ordinarietà degli avvisi di accertamento
non preceduti da verbale.
Inoltre questa nullità può essere facilmente superata se sussistono fondati motivi di urgenza.
Si è parlato di costruire un vizio della funzione,
cioè chiedersi quale potrebbe essere la giustificazione di una meccanica sanzione di nullità
dell’atto «prematuro» rispetto al termine dei 60
giorni. Perché in una materia di matrice amministrativistica non c’è da discutere su di un «vizio
della volontà», ma su di un vizio della funzione.
Un vizio della funzione desumibile dal complesso quadro procedimentale. Insomma, il vizio
della funzione non sta tanto nell’accertamento
prematuro, ma in quello che c’è attorno. E che
spesso merita la sanzione di nullità, ma non in
modo pregiudiziale.
Sarebbe opportuno, quindi, appigliarsi a questa
possibilità solo se c’è un fondato motivo di controdedurre, visto che il contribuente ha comunque possibilità di presentare ricorso.
Che senso ha una pregiudiziale sanzione di nullità? Forse sarebbe il caso di valutare volta per
volta se sia opportuna questa sanzione, per evitare di creareuno strumento pretestuoso di contestazione privo di presupposti sostanziali.
La permanenza degli operatori per
le verifiche presso la sede del contribuente
Stesso discorso si può fare anche con riferimento al comma 5 dell’art. 12 dello Statuto, secondo
cui la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria, dovuta a
verifiche presso la sede del contribuente, non
può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili
384
4/2013
per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare
complessità individuati e motivati dal dirigente
dell’Ufficio.
Anche tale disposizione risente del fatto che nello Statuto del contribuente si riversarono tendenze latenti nella pubblica opinione, che coesistono, magari in angoli diversi del cervello delle
stesse persone: è una specie di schizofrenia, altalenante tra «tutela del contribuente»e «lotta all’evasione», derivante dallo scoordinamento tra
tassazione attraverso le aziende e attraverso gli
Uffici. Anche lo Statuto riflette l’illusione di
mettere ordine per legge, come se la certezza del
diritto derivasse dalla legislazione, e non dall’atteggiamento verso di essa. Si conferma quindi il clima di forte confusione che caratterizza il
nostro sistema e la necessità di riflessione, perché solo la comprensione dei problemi, e la loro
discussione possono rasserenare gli animi, aiutando anche a redigere una legislazione più adeguata. Se invece ci si aspetta la salvezza passivamente, dalla legislazione, il tira e molla normativo continuerà in eterno, con progressiva paralisi e deresponsabilizzazione. Il diritto deve
assicurare la pacifica convivenza sociale senza
essere svilito a mera documentazione normativa,
deve cercare di coordinare e sviluppare diversi
valori, esperienze e riflessioni con un metodo
umanistico. Non si può pretendere di garantire i
diritti del contribuente con una legge, ossia con
un mero manifesto politico, quando è l’intero sistema che non funziona.
Queste disfunzioni del nostro sistema sono dovute alla eccessiva fiducia nel legislatore della
pubblica opinione, che, essendo priva di formazione economica, sociale e politica, concepisce
il legislatore come colui che può risolvere tutti i
mali, illudendosi. Il potere politico, per migliorare la situazione del Paese, per non perdere
consensi, si limita ad emanare nuove leggi, instaurando un circolo vizioso che non ha fine e
non porta da nessuna parte, se non ad una stratificazione normativa priva di utilità, come è accaduto anche con lo Statuto del contribuente.
A questo punto c’è da chiedersi se non occorra
Nota:
(1) R. Lupi, M.R. Silvestri e D. Stevanato, «Accertamento prematuro e procedimento amministrativo», in questa Rivista, pag. 389.
Aspetti
strutturali
ammettere che la protezione che lo Statuto garantisce è risultata essere palesemente insuffi-
ciente e se non sia il caso di ripensare la materia
della tutela del contribuente.
Istruttoria tributaria e Statuto del contribuente: la sterile codificazione
del buonsenso
Antonio Puce
Le rigidità di cui parla Lerani nell’articolo che
precede, sia pure su valori importanti, visti però
in assoluto e non contestualizzati, sussistono anche a proposito del comma 5 dell’art. 12 dello
Statuto del contribuente.
Mi riferisco al limite rigido di cui secondo cui
«la permanenza degli operatori civili o militari
dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può
superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili
per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare
complessità dell’indagine individuati e motivati
dal dirigente dell’Ufficio. Gli operatori possono
ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente
dell’ufficio, per specifiche ragioni».
Appare chiaro che si tratta di una «norma capestro», in quanto sprovvista di clausole generali,
che consentano di motivare periodi più lunghi
di svolgimento della verifica, che potrebbero
essere necessari per situazioni di particolare
complessità. Se da una parte la norma è iugulatoria per la permanenza presso la sede del contribuente, è di opposta rigidità per la durata della verifica, che stando alla suddetta disposizione poteva anche non finire mai, visto che tra un
giorno di permanenza e l’altro, presso il contribuente, potevano anche trascorrere mesi, o anni.
La conseguenza del protrarsi della verifica, oltre
il termine previsto dallo Statuto, anche se non
comminata espressamente, dovrebbe essere l’inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti
oltre questo limite, poiché ogni elemento raccolto, dagli operatori della Guardia di finanza, oltre
il limite temporale di 30 giorni, eventualmente
prorogabile, è frutto di attività posta in essere in
violazione della norma stessa.
Eppure non sembra giusto che una prova oggettivamente ammissibile non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l’ha acquisita,
il quale dovrà, semmai, rispondere nelle sedi
competenti. La prova non può ritenersi illegittima solo perché illecitamente acquisita, si tratta
di due profili diversi che non possono essere
confusi. L’indiscutibile esigenza di approntare
un’adeguata tutela al contribuente deve accordarsi con gli interessi della collettività, che esige
un’adeguata lotta all’evasione ed all’elusione fiscale.
Il rischio di vanificare una quantità considerevole di accertamenti era ancora più elevato con
l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui
il limite dei 30 giorni non era da intendersi come riferito alla permanenza effettiva, ma alla
durata della verifica, contando cioè anche i giorni che passavano tra una «permanenza aziendale» e la successiva.
Per arginare tale situazione l’art. 7 del D.L. n.
70/2011 - il cd. decreto sviluppo - ha modificato
in senso pro fisco la disposizione. Infatti, secondo la nuova formulazione «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al
primo periodo, così come l’eventuale proroga
ivi prevista, non può essere superiore a quindici
giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta
presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi
[rectius «in entrambi i casi» come sostituito in
sede di conversione del decreto legge], ai fini
del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli
Antonio Puce - Master Diritto tributario Professionale, Università
di Roma - Tor Vergata
4/2013
385
Aspetti
strutturali
operatori civili o militari dell’Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente».
Nell’ultimo periodo si fa riferimento ai giorni di
effettiva presenza, bloccandosi l’interpretazione
giurisprudenziale, con una norma di carattere interpretativo, senza dubbio sensata.
Si è così, da un lato, arginato il rischio di dover
considerare nulli una notevole quantità di accertamenti, magari per il resto fondati, a causa di
una posizione eccessivamente garantista della
giurisprudenza, anche se, dall’altro lato, resta
aperto il problema delle «verifiche che non finiscono mai».
Peraltro, in sede di conversione del decreto, la
parola «anche in tali casi» è stata sostituita con
la locuzione «in entrambi i casi» e tale modifica
è stata interpretata nel senso che la norma interpretativa col termine «entrambi» voglia riferirsi
esclusivamente alle imprese in contabilità semplificata e ai lavoratori autonomi, per i quali è
stato previsto il più breve termine di durata delle
verifiche di 15 giorni, e non invece ai contribuenti in contabilità ordinaria, per i quali il termine di durata delle verifiche è di 30 giorni.
Meno rigida è invece la disposizione programmatica dell’art. 12 secondo cui «Tutti gli acces-
si, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine
e controllo sul luogo».
Si tratta di una enunciazione tanto importante
quanto ovvia, ed inutilmente tautologica, come
sono inevitabilmente tautologiche le circolari
emanate al riguardo dall’Agenzia delle entrate e
dalla Guardia di finanza secondo cui i controlli «si
svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni
commerciali o professionali del contribuente».
Non particolarmente utilizzati, oppure utilizzati
per motivi tattici, appaiono le disposizioni del
comma 6, sulla possibilità di rivolgersi al Garante del Contribuente.
Si tratta però sempre di elastiche «indicazioni di
valori», cui si può far riferimento contro eventuali accanimenti investigativi ed altre patologie, ai limiti dell’abuso di potere (che poi è la
vera preoccupazione del diritto amministrativo,
compreso quello dei tributi).
Statuto del contribuente e relativismo dei valori
RL
L’importanza dello Statuto del contribuente è
paradossalmente un riflesso della profonda crisi
di un «diritto» che, appiattendosi sui resoconti
normativi, giurisprudenziali e dottrinali, come
diciamo sempre su Dialoghi, è rimasto allo stadio di «legislazione».
Lo Statuto del contribuente esprime uno dei casi
in cui ci si attende un rimedio dalla legislazione,
mettendo in secondo piano i valori e la riflessione. Tutte le leggi in un certo senso sono dichiarazioni programmatiche dirette alle istituzioni,
ma lo Statuto del contribuente conferma la «sussidiarietà» della legge cui si deve far ricorso solo quando è eccessivamente difficile trovare una
soluzione soddisfacente in base ai valori. Le
leggi sono una guida per le istituzioni, ma un
386
4/2013
Paese è sereno quanto più le istituzioni agiscono
in modo accettato e condiviso (2). Quando in un
settore dell’organizzazione sociale, dei suoi apparati istituzionali e di coloro che li studiano c’è
riflessione e serenità e i valori sono condivisi,
non c’è bisogno di codificarli. Lo Statuto del
contribuente è un’occasione per riflettere, in
Nota:
(2) Prova ne sia l’Inghilterra, dove addirittura manca una Costituzione scritta e si vive benissimo, ma anche altri Paesi, come gli
Stati Uniti, in cui le Costituzioni e le dichiarazioni dei diritti sono
chiaramente intese come «leggi manifesto», nel senso positivo di
essere «indicative», tendenziali, flessibili, come un inventario di
valori, redatto quasi settant’anni fa, ma utile per adattarsi alle caratteristiche delle situazioni concrete oltre che alla graduale evoluzione dei costumi.
Aspetti
strutturali
materia tributaria, sul rapporto tra legislazione e
valori, tipico del diritto, dove una qualche codificazione dei valori è necessaria, in una società
complessa. Molte questioni sarebbero irrisolvibili se si dovesse risalire di volta in volta ad un
imprecisato «spirito del popolo» (3), che non si
può certo evocare per risolvere bagatelle e minuzie, dove è più opportuno, in nome della certezza dei rapporti giuridici, cristallizzare i valori
in regole. I valori restano però, non solo un criterio di interpretazione delle regole, ma anche
un punto di riferimento per tutte le questioni di
principio, non codificabili ex ante, in quanto,
come rilevavano gli Autori precedenti, i valori
non si presentano mai da soli; in concreto, infatti, la buona fede, la certezza dei rapporti, la perequazione tributaria, la snellezza dell’attività
amministrativa, il rispetto dei patti, la collaborazione tra Fisco e contribuente, e tutti gli altri valori cui si fa riferimento nello Statuto del contribuente, si presentano mescolati tra di loro, con
gradazioni differenti in concreto (4). Le enunciazioni valoriali, che si susseguono nei vari articoli dello Statuto, a compartimenti stagni (5),
sono prive di coordinamento reciproco; per questo rischiano di essere troppo rigide, prestandosi
quindi a utilizzazioni formalistico avvocatesche,
che finiscono per delegittimare la suddetta portata argomentativa dello Statuto. Che in un certo
senso è utile in un ambiente degenerato, in senso formalistico, e deresponsabilizzato, per l’equivoco del «governo della legge», che mette in
ombra la riflessione. Quando, davanti a un ragionamento convincente, invece di replicare con
un altro ragionamento si chiede troppo spesso
«dove sta scritto», allora lo Statuto ha una utile
portata legittimante; serve cioè, come rilevava
Lerani, a dare una base normativa testuale ad un
ragionamento di buonsenso. Che però in un contesto di serenità e di responsabilità dovrebbe bastare a se stesso, cioè non dovrebbe aver bisogno di una norma per prevalere. Il riflesso negativo dell’utilizzazione della norma è il rischio di
un irrigidimento dell’enunciazione normativa,
presentata come un «valore assoluto», al di là
del suo più sensato coordinamento con altri valori. I valori non vengono mai in considerazione
da soli, ma assieme ad altri, con la necessità di
stabilire il peso di ciascuno nel caso concreto.
La rigidità dell’enunciazione astratta dei valori
caratterizza anche lo Statuto del contribuente.
Quest’ultimo enuncia in modo isolato una serie
di valori, spesso meritevoli di tutela in concreto,
ma spesso del tutto irrilevanti. A questa enunciazione si collegano rigidità, spesso brandite avvocatescamente come uno spadone retorico, che
mette in ombra tutti gli altri valori sul tappeto. È
un circolo vizioso in cui stanno i pregi e i difetti
metodologici dello Statuto del contribuente, come due facce della stessa medaglia. In un diritto
appiattito sulla legislazione, lo Statuto del contribuente ha la sua utilità per dare un fondamento al buonsenso di alcuni valori, ma al tempo
stesso ostacola il ragionamento, e quindi la possibilità di uscire dall’appiattimento sulla legislazione. Che è il vero problema di tutto il diritto,
non solo tributario, che rischia di narcotizzare le
istituzioni e provocare una valanga di legislazione. Che però è il sintomo della paralisi mentale
sopra indicata, non la sua causa.
Note:
(3) Come lo definivano secoli or sono Kirchmann e Wolf, Il valore
scientifico del diritto, Giuffrè, 1964, nella parte meno convincente
del loro brillante volume (edito nel 1964 da Giuffrè, col titolo
parzialmente fuorviante «il valore scientifico della giurisprudenza» in quanto il volume si riferisce al diritto in generale, nel senso in cui definiamo le «facoltà di giurisprudenza»).
(4) è la teoria del relativismo dei valori, e dell’erroneità logica del
concetto stesso di valore assoluto, riflessioni che probabilmente
hanno formulato in molti, e che, per quanto mi riguarda, sono
presenti al par. 11 di Società, diritto e tributi, Milano, 2005, esaurito,
ma disponibile su www.fondazionestuditributari.com top menu
pubblicazioni.
(5) In proposito mi piace riportare un aforisma di Paola Melone
(una poetessa recentemente scomparsa che vale la pena di googlare) «La teoria dei compartimenti stagni funziona solo in idraulica; se la applichiamo alla mente, otterremo solo pensieri putridi
come l’acqua fetida di uno stagno». Questa tendenza a pensare a
compartimenti stagni si ritrova quando, sugli stessi organi di
stampa, accostate nella medesima pagina, si ritrovano enfatiche
enunciazioni opposte, che inneggiano da una parte alla «lotta all’evasione» e dall’altra alla «tutela del contribuente». È una delle
tante conferme che il settore tributario, senza un coordinamento
delle riflessioni, è giunto alla schizofrenia.
4/2013
387
il Fallimento
e le altre procedure concorsuali
L’approfondimento più autorevole dei profili sostanziali
e processuali della materia concorsuale.
Ogni mese tutte le novità su:
•fallimento
•concordato preventivo
e accordi di ristrutturazione
dei debiti
•amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi
•liquidazione coatta amministrativa
•sovraindebitamento
Direzione scientifica: Giovanni Lo Cascio
Comitato di direzione: Massimo Fabiani, Giovanni Lo Cascio, Adriano Patti
Comitato scientifico: Luigi Abete, Giuseppe Bozza, Francesco De Santis, Antonino Dimundo, Corrado Ferri, Massimo Ferro,
Luciano Panzani, Cesare Proto, Giorgio Tarzia
Abbonati subito per il 2014
Inizi a ricevere la rivista da ottobre 2013 in omaggio!
Y91EF LE
www.shopwki.it/riviste2014
Y91EF_LE.indd 1
30/10/13 15:19
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
Accertamento prematuro
e procedimento amministrativo
di Raffaello Lupi, Maria Rita Silvestri, Dario Stevanato
La Corte di cassazione, chiamata a decidere sugli «accertamenti prematuri», in violazione del
«termine dilatorio», previsto dallo Statuto del contribuente, difficilmente avrebbe potuto decidere diversamente, visto il contesto e il testo normativo di riferimento. La sentenza n. 18184
del 2013 per certi versi smentisce le diffuse affermazioni secondo cui la Cassazione sarebbe
sbilanciata sulle posizioni del Fisco; quello che è travisato come «sbilanciamento» è invece solo
il riflesso del ruolo oggettivo della Cassazione in questa materia, cioè quello di un giudice oggettivamente amministrativo che inevitabilmente usa esperienze e sensibilità tipiche della magistratura ordinaria, nelle sue varie componenti. Una soluzione diversa, intuita «ex post» da Raffaello Lupi, sarebbe stata tortuosa e complessa, e quindi la decisione è ineccepibile. Anche se restano tutti i dubbi sull’applicabilità dei principi generali del procedimento amministrativo, i rapporti tra vizi formali e termini di decadenza, e la possibilità di instaurare per legge un vero proficuo contraddittorio amministrativo tributario.
Margini «culturali» stretti per una soluzione diversa?
Raffaello Lupi
L’imbarazzo giurisprudenziale davanti
alla rigidità dello Statuto
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione sul divieto di «accertamenti prematuri» (1), cioè notificati prima della decorrenza di
60 giorni dal processo verbale, è stata preceduta
da sentenze contrastanti, che talvolta degradavano la notifica «prematura» dell’accertamento a
«mera irregolarità», evidentemente timorose dei
formalismi di cui diremo tra un attimo.
Poi ci fu anche un passaggio intermedio stravagante, con il rinvio di una Commissione tributaria provinciale alla Corte costituzionale che sollevava la questione di legittimità della disposizione dello Statuto del contribuente, partendo
dal singolare presupposto che essa fosse censurabile perché non prevedeva una sanzione di
nullità. La Corte costituzionale (2) rigettò facilmente la censura, affermando che non era stata
valutata la possibilità di considerare immanente,
anche se non esplicitamente prevista, la sanzione di nullità che, secondo il giudice a quo, sarebbe stata necessaria. Veramente il rigetto della
questione di costituzionalità neppure riguardava
la specifica tematica dell’accertamento «prematuro», perché la sentenza spostava il discorso
sulla non meglio precisata violazione dell’obbligo di motivazione, sovrapponendo la motivazione delle ragioni dell’urgenza con la motivazione
della pretesa fiscale. Poi si facevano erronei riferimenti all’art. 24 e all’art. 111 della Costituzione, cioè a disposizioni processuali, mentre
l’accertamento prematuro violava regole di ordine amministrativo. Questo apparato argomentativo, abbastanza nebuloso, non voleva dire che
secondo la Corte costituzionale l’interpretazione
fosse nel senso della nullità, ma costituiva solo
un modo di «eludere», giustamente, una ordinanza di rimessione a dir poco sconclusionata.
La sentenza della Corte costituzionale fu invece
palesemente travisata, secondo la consueta tendenza a leggere messaggi impliciti e arcane razionalità all’interno di «materiali» che sempliceNote:
(1) Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184. Il testo della sentenza
è riportato a seguire.
(2) Ord. 24 luglio 2009, n. 244, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
4/2013
389
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
mente servono a «sbrigare la pratica», nella convinzione illusoria che le istituzioni (Corte costituzionale e legislatore compresi) servano a sistematizzare i concetti, svolgendo un’opera cui sono preposti gli studiosi (purtroppo non surrogabili). Anche questa vicenda dimostra invece il
contrario, cioè che la sistematizzazione dei concetti non passa attraverso le istituzioni, legittimamente preoccupate di altri problemi, a partire
dal legislatore, sempre impegnato, anche con lo
Statuto del contribuente, a dar seguito a qualche
legittima tendenza della pubblica opinione, perseguendo consenso e coesione sociale; nello
Statuto del contribuente la tendenza seguita dal
legislatore si inseriva sulla sensazione diffusa,
nella pubblica opinione, di un comportamento
inefficiente, meccanicistico e spesso inconsapevolmente vessatorio della macchina fiscale.
Su questa premessa, lo Statuto del contribuente,
come indicato in un altro articolo in questo numero (3), è importante per dare un appiglio a ragionamenti di buonsenso a favore del contribuente, ma nella sua inevitabile rigidità ha provocato anche formalismi di segno opposto, come del resto tutte le cristallizzazioni normative
di preoccupazioni sociali anche legittime. Giustamente, il legislatore dello Statuto si è preoccupato di dare voce ad una importante tendenza
di opinione, che però nella società si intreccia
con altre, come quella che viene impropriamente
chiamata «lotta all’evasione fiscale» (4), e che
tende a salvaguardare gli atti di accertamento da
censure di ordine formale. Le tendenze che circolano nella pubblica opinione, e che la sua
espressione politico legislativa coglie, sono infatti molteplici. E coesistono non solo all’interno della pubblica opinione, ma anche nella mente di ciascun individuo, in varie gradazioni. Accanto alla sensazione di inefficienza e vessatorietà della macchina pubblica, tutti avvertono
anche una preoccupante evasione fiscale. Noi
sappiamo che si tratta di due facce della stessa
medaglia, cioè dell’incapacità della macchina
pubblica di prendere iniziative su larga scala e
assumersi la responsabilità di scelte discutibili,
ma sensate, sulla determinazione valutativa della ricchezza dove le aziende non arrivano, con
adeguata sistematicità.
Noi sappiamo anche che il principale ostacolo a
390
4/2013
questa gestione secondo buonsenso della macchina pubblica è la degenerazione dell’idea di
«governo della legge», che spinge a cercare «copertura», protezione, in un qualche testo normativo o in qualche tendenza codificata, in sede
amministrativa o giurisprudenziale (5). Tuttavia,
nella pubblica opinione si pensa che l’evasione
dipenda da carenze legislative e insufficienti interventi amministrativi.
Ecco le ragioni delle incertezze e dei «mal di
pancia» chiaramente intuibili nella sentenza in
rassegna, prima di vanificare un accertamento
che, in ipotesi, poteva essere fondato. Tuttavia
non c’era altra scelta, come vedremo al punto
successivo.
Una scelta faticosa, ma obbligata
Si è appena indicato perché la soluzione, cui sono infine giunte le Sezioni Unite, non era facile.
Anche nelle vicende giurisprudenziali precedenti, compresa quella portata davanti alla Corte
costituzionale, sembrava che ogni istituzione
cercasse di sgusciare via da un problema imbarazzante, in cui voleva essere coinvolta il meno
possibile, passando la patata bollente a qualcun
altro, o cavandosela con qualche ammiccante
stereotipo.
Traspare la consapevolezza generale che la formulazione eccessivamente rigida e astratta dello
Statuto del contribuente poteva vanificare anche
atti sostanzialmente fondati, in nome di deduzioni potenziali del contribuente, del tutto irrilevanti rispetto alla plateale evasione scoperta del
Fisco. Anche il caso particolare oggetto della
Note:
(3) M. Lerani, A. Puce, RL, «Statuto del contribuente: rigidità di ritorno della codificazione frammentaria del buonsenso», in questa
Rivista, pag. 383.
(4) Ci sarebbero tanti spunti di riflessione su quello che può fare
la legge, che non è «irrazionale», ma solo parzialmente razionale,
destinata a riflettere le incertezze, i disorientamenti e gli sfasamenti di opinione che coesistono nella società e - spesso - nella
mente delle singole persone. Più sono forti questi disorientamenti, più la legge li rispecchia, ed è contraddittoria anche senza volerlo e con la massima buona fede, temendo di mettersi in rotta
di collisione con altre tendenze di opinione diffuse nella società e
tra le classi dirigenti.
(5) Sono le chiavi di lettura del comportamento della macchina
pubblica, per certi versi la più grande azienda del Paese, su cui
per ora rinvio a R. Lupi, Manuale giuridico di scienza delle finanze,
Dike, 2012, pagg. 198-213.
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
decisione delle Sezioni Unite sembra del resto
riguardare una contestazione fiscale in cui, nel
merito, il contribuente aveva poco da obiettare,
tanto è vero che il pubblico ministero aveva
chiesto l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia
delle entrate.
Tuttavia, alla fine, occorre prendere atto di come
è scritta la legge, anche perché, tutto sommato,
la proceduralizzazione dell’attività amministrativa di accertamento, dopo oltre un decennio
dall’entrata in vigore dello Statuto, riesce comunque ad assicurare il rispetto del termine dilatorio, rendendo poco probabile il pregiudizio a
pretese tributarie per altri versi fondate, collegate a fenomeni gravi di ricchezza non registrata.
La soluzione della sentenza in rassegna si è
quindi potuta arrendere ad una lettura del testo
normativo conforme al senso proprio delle sue
parole, anche vista la sostanziale mancanza di
alternative soddisfacenti e facilmente percorribili. Palesemente inadeguata sarebbe stata infatti
la soluzione secondo cui la previsione dello Statuto non prevede una sanzione, e la relativa norma sarebbe cioè inutiliter data, comportando
una «mera irregolarità» priva di conseguenze
giuridiche sulla validità dell’atto. In questo modo la necessità di attendere 60 giorni si sarebbe
svuotata di contenuto, riducendosi a «una burla», cioè a quello che in gergo goliardicamente
avvocatesco viene denominato «termine canzonatorio». La certezza matematica di salvaguardare accertamenti, per altri versi fondati, da contestazioni formalistiche di essere «prematuri»,
avrebbe imposto, come prezzo, lo svuotamento
della previsione statutaria, salve le sfumature
«sperimentali», che proveremo a svolgere nel
paragrafo successivo.
Le opzioni disponibili per l’ermeneutica corrente, cioè la sensibilità giuridica diffusa, non lasciavano molte alternative alla sentenza in rassegna. Salvo titoli giornalistici del tipo «la cassazione svuota lo statuto», di cui i giudici intravedevano la sostanziale fondatezza, rispetto a
quella combinazione di «lettera e di spirito»
che, secondo la sensibilità comune del tecnico
del settore, deve «fondare l’interpretazione».
Per non svuotare lo Statuto, la soluzione più ragionevole, rispetto alle tecniche interpretative
diffuse, e spiegabili, è stata quindi quella in con-
creto utilizzata (6). Che non a caso viene accompagnata da argomentazioni sulla valenza logico sistematica dello Statuto del contribuente e
sull’importanza del contraddittorio tra Fisco e
contribuente; malignamente potremmo però osservare che, in altri casi, in materia di accertamenti bancari e di accertamento sintetico, come
pure in materia di «richiesta di chiarimenti», la
Cassazione non si è mostrata particolarmente
sensibile alle esigenze del contraddittorio amministrativo, rinviando al processo l’analisi delle
argomentazioni del contribuente, con verosimile
violazione, tenuto conto della sbrigatività del
processo tributario, del suo diritto di difesa. In
quei casi mancava però una previsione specifica, che legittimasse il contraddittorio, anche se
esso era nei fatti necessario, mentre qui lo Statuto attribuisce una elevata importanza ai chiarimenti, anche dove nei fatti sono magari superflui. Quindi, visto il complesso delle variabili
che orientavano la decisione, si spiega la valorizzazione di concetti in altra sede trascurati. Si
costruisce così un apparato argomentativo utile
a razionalizzare e a legittimare, sul piano della
sensatezza, una soluzione di cui non si percepivano alternative, che quindi «sta bene così». Anche perché le alternative che ipotizziamo al paragrafo seguente sono ancora a livello, per così
dire, «sperimentale».
Una possibile contestualizzazione
della violazione
Fino a questo punto abbiamo contestualizzato la
logicità della sentenza in esame. Siccome però
Dialoghi è una rivista teorico-progettuale, anche
se ambisce a riflettere assieme «ai pratici», cerchiamo di andare oltre l’impasse descritta al paNota:
(6) L’alternativa che la Cassazione si era posta era, testualmente,
se l’accertamento prematuro fosse «una mera irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze esterne, ovvero dia luogo, ad
eccezione di casi di “particolare e motivata” urgenza, ad un vizio
di legittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, che può
essere fatto valere dal contribuente al fine di ottenere, per ciò
solo, in sede contenziosa, l’annullamento dell’atto stesso». Posta
così la questione, non ci deve stupire che la sentenza prosegua
affermando che «il Collegio ritiene di dover adottare la seconda
soluzione, per le ragioni e con le precisazioni che seguono»
(compresi i mal di pancia che precedono, ed ho indicato nel testo).
4/2013
391
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
ragrafo precedente, risolta in modo legittimo e
comprensibile dalla Cassazione. Per andare oltre
bisogna porsi nella consueta ottica istituzionalistico-amministrativistica del diritto tributario,
che portiamo avanti su Dialoghi. Bisogna comprendere cioè che il giudice, come spieghiamo
anche in questo fascicolo assieme a Basilavecchia (7), è chiamato nel diritto tributario a sindacare il comportamento di una diversa istituzione pubblica, non a determinare direttamente
la ricchezza ai fini tributari. Il meccanicismo
mentale giusprivatistico, improntato ad un equivoco «governo della legge», dove la funzione
pubblica esercitata dal giudice è rispondere a
domande su beni della vita, si complica nel nostro caso, perché il giudice deve valutare il comportamento istituzionale di una diversa pubblica
autorità.
Sotto questo profilo si sarebbe potuto utilizzare
l’emanazione prematura dell’accertamento come
un elemento da valutare, senza automatismi, nel
contesto complessivo, avente ad oggetto il comportamento dell’Ufficio tributario. Su questa
premessa si sarebbe potuto valorizzare, in relazione alla materia del contendere, il pregiudizio
concreto derivante dal mancato contraddittorio,
con riferimento a quanto aveva da dire il contribuente nell’ambito del giudizio più ampio sul
comportamento dell’Ufficio; si sarebbe potuto,
su questo presupposto, valutare con maggiore
apertura le allegazioni del contribuente, tenendo
conto che egli non aveva avuto modo di manifestarle nel procedimento. Dall’accertamento prematuro sarebbe derivata una maggiore disponibilità per le allegazioni del contribuente, la richiesta di minori riscontri, ecc. La violazione
dello Statuto sarebbe stata oggetto di una sanzione indiretta, meno meccanicistica e collocata
nell’ottica amministrativa del processo tributario, tendente a valutare la complessiva azione
dell’Ufficio fiscale in relazione alla pretesa. Sarebbe stato un modo per evitare una soluzione
meccanicistica, spesso in concreto fuori luogo,
senza svuotare di contenuto la previsione dello
Statuto del contribuente.
Segnaliamo per completezza anche un’ulteriore
possibile soluzione, tipica di tutti i «vizi formali», cioè la remissione in termini degli Uffici per
un riesame «immune da vizi» della precedente
392
4/2013
determinazione; tale soluzione, idonea per tutto
meno che per la motivazione dell’accertamento,
è però contraria a concezioni profonde, e forse
esagerate come un mito, della certezza dei rapporti giuridici, delle decadenze, ecc.
A rigore neppure il diritto alla riservatezza, al
domicilio, che comportano l’inutilizzabilità dei
dati acquisiti in indagini fiscali che li violano,
sono «valori assoluti» e la sanzione comminata
in loro nome deve rispettare, come tutte, il principio di proporzionalità delle sanzioni, cioè della loro ragionevolezza rispetto al bene tutelato;
tale bene è rappresentato, per le indagini illegittime, dal diritto alla riservatezza in senso ampio
e per l’accertamento prematuro dall’esigenza
del contraddittorio. Il giudizio sulla proporzionalità della sanzione dipende anche dalla pienezza con cui, in assenza dell’illecito, si sarebbe realizzato l’interesse protetto che - invece - è
stato sacrificato dalla negligenza. Qui è pertanto da chiedersi in quale misura si sarebbe verificato un effettivo contraddittorio sulle deduzioni
ipoteticamente presentate dal contribuente, in
assenza dell’accertamento «prematuro»; se ordinariamente ci fosse un contraddittorio esaustivo e soddisfacente, in cui si scoprono le carte e
si cerca davvero una soluzione amministrativa
alla determinazione dell’imposta, la mancanza
di questa fase sarebbe un grave pregiudizio, non
solo per il contribuente, ma anche per la serietà
dell’attività amministrativa. L’esperienza però
ci insegna che il contraddittorio dell’Ufficio
sulle deduzioni del contribuente si risolve generalmente in una presa di posizione meramente
formale, riassunta in una serie di giri di parole,
stereotipi apparentemente in tema, stralci normativi e di giurisprudenza con cui l’Ufficio
commenta le osservazioni del contribuente, e
quindi procede per la propria strada. Il contraddittorio in base alle deduzioni «da Statuto» si
risolve quindi in un mero rituale, che per molti
versi appare eccessivo quindi presidiare, come
fa lo Statuto del contribuente, con la sanzione
di nullità. Il giudizio sulla proporzionalità della
sanzione dipende anche dal sacrificio imposto
Nota:
(7) M. Basilavecchia, R. Lupi, «Diritto tributario, giudici e processo», in questa Rivista, pag. 431.
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
agli altri interessi, diversi da quello tutelato, come quello ad una equilibrata e perequata percezione dei tributi, talvolta declinato in termini di
«lotta all’evasione fiscale». Sotto questo profilo, la questione avrebbe potuto essere risolta
con una nuova questione di legittimità costituzionale, impostata in modo contrario a come fu
posta alcuni anni or sono. Allora l’ordinanza di
rimessione si chiedeva se fosse irragionevole la
mancanza di una «sanzione di nullità». Adesso
ci si sarebbe potuto interrogare sulla ragionevolezza di una disposizione che pregiudizialmente
vanifica accertamenti in ipotesi fondati per una
questione di forma. Ci si sarebbe potuto chiedere cioè se sia conforme al principio di capacità
contributiva che accertamenti magari fondati
siano posti nel nulla solo perché non fu consentito al contribuente di notificare deduzioni difensive che, nel caso concreto, potrebbero anche non essere provviste di alcuna valenza né
utilità.
Il contraddittorio sostanziale, proficuo, utile per
la giustizia, non deriva dal rituale di una procedura, ma risiede nella sostanza e nella condivisione. Si tratta cioè dello scambio di riflessioni
sostanziali, nel confronto che approfondisce la
conoscenza dei fatti e della loro qualificazione
giuridica da parte dell’Amministrazione e del
giudice. Il buonsenso non passa per la legge,
neppure per lo Statuto del contribuente, che
qualche volta gli dà un supporto, ma qualche
volta gli fa un (formalistico) sgambetto.
Accertamento prematuro: una «terza via di compromesso»
tra certezza del diritto e salvezza dell'attività di accertamento
Maria Rita Silvestri
Dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione emerge, come rileva Lupi, un qualche imbarazzo connesso alla soluzione prescelta, che rende opportuna qualche riflessione, riprendendo gli stimoli di Lupi, sull’esistenza di
una terza via tra la «mera irregolarità» e l’annullamento, senza possibilità di appello, di un accertamento per altri versi fondato.
Come anticipava Lupi questa «terza via» è basata
su di un insieme di disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo, soprattutto
gli artt. 21-septies, opties e nonies della legge n.
241/1990, come modificata dalla legge n.
15/2005. Nell’art. 21-septies, a proposito della
«nullità», si ritrova un riferimento alla tassatività
delle relative previsioni legislative, mentre la annullabilità per violazione di legge (21-octies) è
esclusa, per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Questa disposizione comporterebbe non già quella meccanica invalidazione dell’atto che aveva descritto
Lupi, quanto piuttosto una analisi del fumus delle
argomentazioni adducibili dal contribuente, in se-
de di contraddittorio amministrativo: se queste
ultime, con valutazione prognositica e ipotetica,
avessero fatto presumere che il contenuto del
provvedimento avrebbe potuto essere diverso,
quest’ultimo sarebbe stato annullabile.
Il riferimento della legge n. 241/1990 alla vincolatezza va contestualizzato nel settore tributario, e specialmente nel rapporto tra il processo
verbale di constatazione e il successivo avviso
di accertamento: in altre parole l’Amministrazione ha il potere di discostarsi dalle risultanze
emerse in sede di verifica anche qualora il contribuente, nelle ipotetiche deduzioni, adduca argomenti fondati, in fatto o in diritto.
In tale contesto, quindi, il mancato rispetto del
termine ex art. 12, comma 7, dello Statuto non è
automaticamente liquidabile come una violazione formale sempre e comunque; non sono automaticamente trasferibili in materia tributaria le
concezioni secondo cui se il provvedimento finale è vincolato nel contenuto e ha comunque
raggiunto lo scopo per il quale è stato adottato,
l’eventuale mancato rispetto di un obbligo di
Maria Rita Silvestri - Dottore in Giurisprudenza. Fondazione Studi
Tributari
4/2013
393
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
forma non è circostanza idonea a viziare l’intera
attività amministrativa svolta né, pertanto, il
contenuto del provvedimento stesso (8).
In molti casi, tuttavia, quando l’impatto delle
possibili (e non fornite per l’accertamento prematuro) memorie del contribuente al PVC è trascurabile, potrebbe trovare applicazione la regola
di cui all’art. 21-octies della legge n. 241/1990,
che sancisce la prevalenza della sostanza dell’attività amministrativa sui formalismi procedimentali e che, di conseguenza, consente di sanare
con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi
non sostanziali eventualmente presenti nell’atto.
Si potrebbe obiettare che il termine dilatorio ex
art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente
abbia carattere sostanziale, effettivamente assolvendo la funzione di rendere concreto il diritto
di difesa del contribuente e rappresenta il momento (ancorché solo potenziale) in cui si instaura il contraddittorio con l’Amministrazione
procedente.
Di fronte al mancato rispetto di un termine che è
e resta procedimentale, ma che può comprimere
il diritto di difesa del contribuente, si dovrebbero perciò utilizzare tutte le dovute cautele: se da
un lato sembra eccessivo dichiarare nullo, in ragione del mancato rispetto di una regola formale, un atto che nel merito potrebbe risultare fondato, dall’altro sancire la sanabilità dell’atto impositivo senza che il contribuente abbia potuto
esprimere il proprio punto di vista appare un
meccanismo che svuota di significato la previsione dello Statuto.
In ogni caso, davanti ad una violazione formale,
la difficoltà dei giudici (compresi i giudici di legittimità) sta nel chiedersi in che cosa il contenuto dell’atto sarebbe stato diverso se il privato
avesse partecipato al procedimento di formazione del provvedimento.
La risposta a questa domanda potrebbe aprire ad
una soluzione intermedia rispetto a quelle adottate dalla giurisprudenza, che oscillano tra la declaratoria di nullità del provvedimento emesso
in violazione di obblighi formali e l’assoluta indifferenza per il rispetto del termine dilatorio.
Si potrebbe, cioè, optare per una soluzione che
elimini il segmento istruttorio che consegue alla
violazione formale e che consenta la rimessione
in termini del privato, consentendogli di controargomentare rispetto ai rilievi espressi in sede
di ispezione o verifica. Si tratta di una strada (9)
per certi profili indicata anche dall’art. 21-nonies sulla possibilità di annullamento d’ufficio e
quindi di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole.
Si tratterebbe di una «terza via di compromesso»
tra certezza del diritto (e dei rapporti tra privato
e Amministrazione - in questo caso fiscale) e salvezza dell’attività di accertamento sostanziale
che gli altri rami del diritto amministrativo non
faticano a riconoscere ma che, come sottolineato
nel pezzo che precede, nell’ambito del diritto tributario, evidentemente pare non trovare posto.
Note:
(8) L’obiezione in esame è liquidata dalla Cassazione, che pure
non menziona l’art. 21-octies, né la legge generale sul procedimento amministrativo, nel passaggio in cui afferma che «è vano
addurre il preteso carattere “vincolato» dell’avviso di accertamento rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa» (tesi, almeno se riferita - per quanto qui interessa - al contenuto del
provvedimento, chiaramente infondata).
(9) Già indicata, per altri versi, da M.R. Silvestri, RL, «La trappola
dei vizi formali si ritorce contro il contribuente: dalla decadenza
alla prescrizione?», in Dialoghi Tributari n. 3/2013, pag. 350.
Contraddittorio anticipato, «norme di principio» e pedagogia legislativa
Dario Stevanato
Le riflessioni sul carattere relativistico dei «valori»
o dei «principi», carattere che esprime l’esigenza
di contemperare ognuno di essi con altri «valori» e
«principi», sono certamente condivisibili. Come
pure è condivisibile l’esigenza di non irrigidire i
valori all’interno di rigide regole meccanicistiche.
394
4/2013
Le regole scritte, come quella sull’accertamento
prematuro (il dovere per l’Ufficio finanziario di
attendere sessanta giorni prima di emettere l’accertamento, al fine di consentire al contribuente
di controdedurre all’interno del procedimento),
sono però una cosa diversa dai principi: questi
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
ultimi a rigore non abbisognano di enunciazioni
espresse, essendo ricavabili da un sistema di valori condiviso; alcune norme scritte sono tuttavia espressione di un principio generale, che non
viene per questo solo fatto, cioè per aver in
qualche modo «ispirato» il legislatore, irrigidito
per sempre in quella norma. Anche quando una
norma è espressione di un principio, quest’ultimo continua ad operare come tale. L’ultimo
comma dell’art. 12 dello Statuto non incide insomma sulla valenza del principio del contraddittorio, che preesisteva rispetto alla sua enunciazione in quella particolare fattispecie, e mantiene la sua capacità espansiva e di indirizzo in
altri contesti.
Per chi tende a ridurre il diritto alla legislazione,
l’ultimo comma dell’art. 12 andrebbe considerato alla stregua di una eccezione rispetto ad un sistema che non prevede il contraddittorio endoprocedimentale tra Uffici finanziari e contribuenti. Se invece si ammette, come mi sembra
preferibile, l’operare di principi non scritti, se
vogliamo di «valori» dotati di astrattezza, la
norma dello Statuto potrebbe essere vista come
la puntuale applicazione, in un particolare contesto, del principio del contraddittorio, che dunque assume una portata più generale, che travalica l’ambito in cui lo Statuto lo ha codificato e
non si esaurisce in esso.
Non mi sembra dunque che si possa addebitare
allo Statuto di aver assecondato la tendenza ad
appiattire il diritto sulla legislazione, sclerotizzando il buon senso e i «valori» in anguste e rigide regole scritte. Il legislatore non ha infatti questo potere, posto che i principi preesistono alle
regole scritte e sopravvivono alla loro emanazione. Piuttosto, ci si dovrebbe chiedere se il principio del contraddittorio si sarebbe affermato, come sta un po’ alla volta faticosamente avvenendo, senza quei «baluardi avanzati» costituiti da
norme come l’art. 12, comma 7, quella sulla richiesta di chiarimenti nella norma antielusiva, od
altre ancora. Dopodiché, difficilmente il legislatore potrà incidere sull’atteggiamento complessivo della nostra Amministrazione finanziaria, e
sulla ritrosia, che connota un po’ tutte le Pubbliche amministrazioni di questo Paese, ad assumersi responsabilità ed a «decidere» senza scaricare il relativo onere ad altri soggetti. Di fronte
alle immani forze inerziali presenti nella società
e nelle istituzioni, i legislatori possono poco e
niente. Quel poco che poteva, tuttavia, lo Statuto
ha cercato di farlo, anche attraverso la norma sul
contraddittorio necessario al termine della verifica fiscale, che va nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli Uffici nel confezionamento delle pretese fiscali, che è nell’interesse
generale vengano emanate solo se effettivamente
dotate di un fondamento.
Possiamo a questo punto chiederci se sia opportuno che norme come quelle statutarie codifichino «principi» e «valori» giuridici; in particolare,
se così facendo si corra il rischio di irrigidire
delle direttive tendenziali facendo perdere flessibilità al sistema fino al punto di farne derivare
soluzioni meccanicistiche, come quella della
«nullità» dell’accertamento prematuro.
Ora, mi sembra anzitutto che proprio nell’ambito di una materia - come quella tributaria - in cui
la tendenza a confondere il diritto con la legislazione è molto accentuata, ed in cui si lamenta
continuamente la mancanza di «principi», non
possano affatto essere aprioristicamente considerati inutili o controproducenti i tentativi di
scrivere, se così si può dire, delle «norme di
principio», cioè disposizioni scritte che, pur fatalmente connotate da una struttura tendenzialmente rigida, come è caratteristica di tutte le regole giuridiche codificate, costituiscono una
espressione tangibile dell’esistenza di quei
«principi», come quello del contraddittorio procedimentale, che stentavano e stentano tuttora
ad affermarsi (come dimostra ad esempio la vicenda del contraddittorio precedente all’emissione di un accertamento basato sulla figura dell’abuso del diritto).
Mi sembra insomma difficile biasimare il legislatore dello Statuto, che si è assunto l’onere di
provare ad accompagnare gli operatori e gli interpreti nel riconoscere l’esistenza di principi
quali il contraddittorio anticipato, la collaborazione, la buona fede, la tutela dell’affidamento,
e via discorrendo.
Venendo alla specifica questione della «sanzione» applicabile in ipotesi di violazione della regola del contraddittorio endoprocedimentale, va
anzitutto rilevato che lo Statuto non l’ha nemmeno indicata, dunque non mi pare che dallo
4/2013
395
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
stesso derivi necessariamente una soluzione obbligata o meccanicistica. Continuo peraltro a ritenere, come rilevato in altre occasioni, che tale
«sanzione» sia ricavabile in via indiretta, cioè
desumendola dall’obbligo di motivazione che
assiste gli avvisi di accertamento: se gli Uffici
sono tenuti ad ascoltare il contribuente, ed a motivare in ordine all’accoglimento o ad al rigetto
delle sue argomentazioni difensive, va da sé che
l’emissione dell’avviso effettuata anzitempo si
traduce in un vizio della motivazione, di cui andrà accertata la gravità alla luce delle successive
vicende ed allegazioni processuali.
È evidente che ad essere vulnerato, nel caso di
accertamento prematuro, non è in sé il diritto di
difesa, e sotto questo aspetto non hanno senso, a
mio avviso, le difese erariali secondo cui l’avvenuta impugnazione dell’atto di accertamento, e
la difesa nel processo, avrebbero l’effetto di superare e sanare eventuali vizi del procedimento
e dell’atto accertativo. Ancor più assurde sono
poi quelle difese in cui gli Uffici fanno presente
che il contribuente, nonostante l’emissione anticipata dall’avviso di accertamento, ha comunque potuto successivamente presentare le sue
deduzioni nei sessanta giorni, non capendo così
(o fingendo di non capire) che il diritto del contribuente può essere reso effettivo soltanto se
dall’altra parte vi è una Pubblica amministrazione disposta ad ascoltarlo.
Il punto non è, infatti, se l’accertamento prematuro abbia leso il diritto alla difesa del contribuente nella sua dimensione processuale, bensì
se l’emanazione anticipata dell’accertamento rispetto ad una determinata «risultanza dell’istruttoria», pretermessa nel confezionamento dell’atto, ne abbia indebolito il contenuto motivazionale. Si potrebbe peraltro così recuperare una maggiore effettività alla previsione statutaria, non riducendola ad un «mero rituale», in cui l’Ufficio
attende i sessanta giorni, acquisisce le controdeduzioni del privato, e le «confuta» con formule
stereotipe e di stile, sanzionando - attraverso lo
scrutinio della motivazione - anche le ipotesi in
cui l’Ufficio non ha motivato o ha motivato in
modo solo apparente sulle puntuali deduzioni
del privato, in modo da far ritenere a posteriori
che, se lo avesse fatto, il contenuto dell’atto sarebbe stato verosimilmente diverso.
396
4/2013
Il valore tutelato dalla norma è insomma quello
ad un effettivo contraddittorio anticipato, al fine
di un migliore svolgimento dell’azione pubblica,
con una maggiore responsabilizzazione degli
Uffici ed il diritto dei privati a veder seriamente
valutate le proprie ragioni senza essere costretti
ad intraprendere una via processuale che appare
a tutti come largamente insoddisfacente.
Anche sotto altri aspetti, la previsione statutaria
appare poi ispirata a quelle esigenze di flessibilità precedentemente invocate, come nella parte
in cui ammette l’emissione anticipata dell’avviso laddove sussistano «casi di particolare e motivata urgenza». Si tratta di una formula che
contempera adeguatamente gli interessi ordinamentali diversi da quelli al contraddittorio, evitando di comprimere il potere di accertamento,
espressione della funzione tesa al recupero
dell’evasione, quando venga dimostrata l’urgenza, con conseguente compressione dell’interesse
al contraddittorio. Urgenza che non dovrà però
dipendere da inerzie e negligenze degli Uffici finanziari, ma da situazioni oggettive e da comportamenti incolpevoli.
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
La sentenza
Cassazione, SS.UU. civ., Sent. 29 luglio 2013 (14 maggio 2013), n. 18184 - Pres. Luccioli - Rel. Virgilio
Ritenuto in fatto
1. Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 17 settembre 2004 dai funzionari
dell’Agenzia delle entrate di ..., venne emesso a
carico della società C.B.G. s.a.s. di B.F.P. e C., e
notificato in data 12 ottobre 2004, un avviso di recupero relativo a credito d’imposta che l’Ufficio
asseriva essere stato indebitamente utilizzato per
investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell’art.
8 della legge n. 388/2000.
La società contribuente impugnò l’avviso, contestando la legittimità dell’atto innanzitutto per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto lo stesso era stato
emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo
verbale di constatazione; lamentò, poi, errori di
calcolo nella determinazione dell’importo indicato
in recupero.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo
accolse il ricorso, rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato dopo soli venticinque
giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione e che non era stata in alcun modo indicata la particolare e motivata urgenza che avrebbe
potuto giustificare la notifica dell’atto impugnato
prima del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000.
L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate è
stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Il giudice d’appello ha rilevato, innanzitutto, a
fondamento della decisione, che l’avviso di recupero del credito d’imposta è «un tipico atto di accertamento», in quanto le attività di accertamento
sono qualificabili come «quel complesso di attività
poste in essere dall’Amministrazione finanziaria
per controllare il verificarsi o meno della fattispecie legale», e nel caso in esame l’Ufficio aveva effettuato una fase ispettiva tendente ad accertare la
sussistenza dei presupposti voluti dalla legge perché il contribuente fruisca del diritto al credito.
Ha poi osservato che, dal testo dell’art. 12, comma
7, della legge n. 212/2000, «possono individuarsi
tre distinte posizioni soggettive: 1) diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste;
2) obbligo degli Uffici di valutare le osservazioni
e richieste comunicate dal contribuente; 3) obbligo
degli stessi Uffici di motivare l’avviso di accertamento con specifico riferimento alle osservazioni
e richieste comunicate dal contribuente con conseguente nullità dello stesso in caso di omessa motivazione». Ha aggiunto che la disposizione citata
prevede un contraddittorio anticipato al fine di fornire non solo maggiori garanzie al contribuente,
ma anche maggiore efficacia all’accertamento tributario, e che essa, come tutte le altre previsioni
normative contenute nella legge n. 212/2000, viene elevata a principio generale dell’ordinamento
tributario dall’art. 1, comma 1, del medesimo testo
normativo.
Ha concluso che l’emissione dell’atto impositivo
prima del decorso di sessanta giorni dalla fine delle operazioni ispettive «ha palesemente violato il
diritto del contribuente a difendersi, privandolo di
un grado di valutazione delle sue ragioni, senza
che ne ricorressero validi motivi».
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un
unico motivo.
3. La C.B.G. s.a.s. di B.F.P. e C. ha resistito con
controricorso.
4. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio
del 27 marzo 2012, la V Sezione civile (tributaria),
con ord. n. 7318, depositata l’11 maggio 2012, ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite, osservando che il
tema degli effetti del mancato rispetto del termine
dilatorio in esame ha dato luogo a decisioni difformi nella giurisprudenza della Sezione.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’odierna
udienza.
5. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità
della memoria dell’Agenzia delle entrate, depositata il 10 maggio 2013, quindi oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c.
2. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente formula il quesito «se ha violato l’art. 12, comma 7,
della legge n. 212/2000, la Commissione tributaria
regionale di Palermo che ha ritenuto che la notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere
del termine di sessanta giorni ne determini ipso iure la nullità».
4/2013
397
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
Su tale questione la giurisprudenza della V Sezione ha dato luogo, come puntualmente rilevato
nell’ordinanza di rimessione al Primo Presidente,
ad orientamenti variegati.
In estrema sintesi, si è infatti ritenuto che l’avviso
di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla norma in
esame:
a) è in ogni caso valido, per il principio di tassatività delle nullità, «sanzione» non comminata dalla
norma (e che, anzi, era prevista nel testo originario
del disegno di legge e poi fu soppressa); per la natura vincolata dell’atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda; perché il contribuente ha comunque altri strumenti a disposizione (accertamento con adesione, istanza di autotutela,
ecc.); perché è errato riferire la nullità al difetto di
motivazione sull’urgenza, in quanto le norme sulla
motivazione degli atti tributari attengono al contenuto della pretesa, non ai tempi di emanazione
dell’atto; perché, infine, la nullità costituirebbe
una conseguenza sproporzionata rispetto agli interessi costituzionali contrapposti (in tali sensi, sia
pure con differenti sottolineature, cfr. Cass. n.
19875 del 2008; n. 3988, n. 18906 - la quale, tuttavia, conclude in senso opposto, in ossequio all’orientamento all’epoca prevalente e quindi al criterio interpretativo della conformità ai precedenti - e
n. 21103 del 2011; n. 16992 del 2012);
b) è invalido solo in assenza di motivazione dell’urgenza che ne ha determinato l’adozione ante
tempus: tale indirizzo, in applicazione di quanto
affermato da Corte cost. n. 244 del 2009, appunta,
quindi, l’invalidità dell’atto al difetto di motivazione sulle ragioni dell’urgenza di provvedere, vizio sanzionato, in generale, dall’art. 21-septies
della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n.
15/2005) e, in materia tributaria, dall’art. 7 della
legge n. 212/2000, e dal D.Lgs. n. 32/2001 (Cass.
n. 22320 del 2010; n. 10381 e n. 14769 del 2011;
n. 4687, n. 11347 e n. 16999 del 2012);
c) è invalido in mancanza di motivi di urgenza,
poiché il mancato rispetto del termine sacrifica un
diritto riconosciuto al contribuente, con conseguente illegittimità dell’accertamento, senza bisogno di specifica previsione (Cass. n. 5652 e n.
6088 del 2011); in particolare, inoltre, poiché la
norma impone un termine per l’esercizio dell’azione impositiva piuttosto che un obbligo di motivazione circa il requisito dell’urgenza (obbligo che
non rientra nella previsione dell’art. 7 della legge
n. 212/2000), l’esistenza di quest’ultimo opera ex
se, senza che, ai fini dell’esonero dall’osservanza
398
4/2013
del termine, sia necessario che il fatto che determina l’urgenza sia enunciato nell’atto impositivo
(Cass. n. 11944 del 2012).
3.1. L’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), rubricato «Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali», dispone, al comma 7, che: «Nel rispetto del principio di
cooperazione tra Amministrazione e contribuente,
dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di
controllo, il contribuente può comunicare entro
sessanta giorni osservazioni e richieste che sono
valutate dagli Uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374» (l’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art.
92 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n.
27/2012).
La questione sottoposta all’esame delle Sezioni
Unite consiste nello stabilire se l’inosservanza del
termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti
sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una
verifica nei locali destinati all’esercizio della propria attività (art. 12, comma 1), della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni - costituisca, nel silenzio della norma, una mera irregolarità sostanzialmente priva di conseguenze
esterne, ovvero dia luogo, ad eccezione di casi di
«particolare e motivata» urgenza, ad un vizio di
legittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, che può essere fatto valere dal contribuente al
fine di ottenere, per ciò solo, in sede contenziosa,
l’annullamento dell’atto stesso.
Il Collegio ritiene di dover adottare la seconda soluzione, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
3.2. Va, innanzitutto, attribuito il dovuto rilievo
già al solo fatto che la norma in esame è inserita
nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n.
212/2000, cit.), il cui art. 1, com’è noto, stabilisce,
al comma 1, che «le disposizioni della presente
legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97
della Costituzione, costituiscono principi generali
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».
Anche se è consolidato il principio secondo il quale alle norme statutarie non può essere attribuito,
nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla
legge ordinaria (e quindi esse non costituiscono,
neppure come norme interposte, parametro idoneo
a fondare il giudizio di legittimità costituzionale)
(da ultimo, Corte cost., ord. n. 112 del 2013; Cass.
n. 8254 del 2009, n. 8145 del 2011), tuttavia alla
specifica «clausola rafforzativa» di autoqualificazione delle disposizioni stesse come attuative delle
norme costituzionali richiamate e come «principi
generali dell’ordinamento tributario» non può non
essere attribuito un preciso valore normativo: quest’ultima espressione, in particolare, e per quanto
qui interessa, deve essere intesa nel significato di
«principi generali del diritto, dell’azione amministrativa e dell’ordinamento tributari» e si riferisce
evidentemente, in primo luogo, a quelle disposizioni statutarie che dettano norme volte ad assicurare la trasparenza e il buon andamento dell’attività amministrativa e ad orientare in senso garantistico tutta la prospettiva costituzionale del diritto
tributario (Cass. n. 17576 del 2002). A buona parte
di dette disposizioni va attribuito il ruolo di
espressione di principi immanenti nell’ordinamento tributario, già prima dell’entrata in vigore dello
Statuto, e quindi di criteri guida per orientare l’interprete nell’esegesi delle norme, anche anteriormente vigenti (oltre a Cass. n. 17576 del 2002,
cit., cfr. Cass. n. 7080 del 2004, n. 9407 del 2005,
n. 21513 del 2006, n. 9308 del 2013).
3.3. Nell’ambito delle norme statutarie, l’art. 12
assume una rilevanza del tutto peculiare, in ragione del suo oggetto («Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali») e delle finalità perseguite.
L’incipit del comma 7, in particolare, nel richiamare il «rispetto del principio di cooperazione tra
Amministrazione e contribuente», qualifica chiaramente la norma come espressiva dei principi di
«collaborazione» e «buona fede», i quali, ai sensi
del precedente art. 10, comma 1, devono improntare i rapporti tra contribuente e fisco e vanno considerati (analogamente al principio di tutela dell’affidamento, più specificamente contemplato
nello stesso art. 10, comma 2) quali diretta applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97
Cost.), di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza
(art. 3), e quindi, in definitiva, come fondamenti
dello Stato di diritto e canoni di civiltà giuridica
(cfr., tra le altre, oltre a quelle già indicate, Cass.
n. 24217 del 2008, n. 3559 e n. 25197 del 2009, n.
21070 del 2011, n. 6627 del 2013).
La norma, poi, introduce nell’ordinamento una
particolare e concreta forma di «collaborazione»
tra Amministrazione e contribuente, attraverso la
previsione di un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, prima della cui scadenza, e salvo le eccezioni di cui
si dirà, l’atto impositivo - come la norma prescrive
con espressione «forte» - «non può essere emanato»: tale intervallo temporale è destinato a favorire
l’interlocuzione tra le parti anteriormente alla
(eventuale) emissione del provvedimento, e cioè il
contraddittorio procedimentale.
Quest’ultimo è andato assumendo, in giurisprudenza e in dottrina (e nella stessa legislazione),
proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente,
ma anche ad assicurare il migliore esercizio della
potestà impositiva, il quale, nell’interesse anche
dell’ente impositore, risulterà tanto più efficace,
quanto più si rivelerà conformato ed adeguato proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso
possibile - alla situazione del contribuente, con
evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor prima, nel
senso di indurre l’Amministrazione ad astenersi da
pretese tributarie ritenute alfine infondate).
In ambito giurisprudenziale è sufficiente ricordare
le seguenti pronunce:
a) Corte giust. UE, sent. 18 dicembre 2008, causa
C-349/07, «Sopropè», con la quale, sia pure in
materia di tributi doganali, ma con evidenti riflessi
di ordine generale, è stato valorizzato il principio
della partecipazione del contribuente - il quale
«deve essere messo in condizione di far valere le
proprie osservazioni» - a procedimenti in base ai
quali l’Amministrazione si proponga di adottare
nei suoi confronti un atto di natura lesiva;
b) Cass., SS.UU., n. 26635 del 2009, con la quale,
in materia di accertamento «standardizzato», è stato affermato che «il contraddittorio deve ritenersi
un elemento essenziale e imprescindibile (anche in
assenza di un’espressa previsione normativa) del
giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa» (la Corte è così pervenuta ad affermare
la nullità - non esplicitamente comminata - degli
avvisi di accertamento emessi con il metodo dei
«parametri» o degli studi di settore, in assenza di
4/2013
399
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
previa attivazione del contraddittorio con il contribuente);
c) Cass. n. 28049 del 2009, nella quale, con riguardo alla norma che prevede l’invio di un questionario al contribuente sottoposto ad accertamento (art. 32, primo comma, n. 4, del D.P.R. n.
600/1973), si afferma che essa, così come quella
che prevede la comparizione personale del contribuente (art. 32, primo comma, n. 2), si prefigge «il
meritorio scopo (...) di favorire il dialogo e l’intesa tra Fisco e cittadino - rapporti che debbono essere «necessariamente improntati a lealtà, correttezza e collaborazione, in quanto siano in gioco
obblighi di solidarietà come quello in materia tributaria» (Corte cost., sent. n. 351 del 2000) - e di
evitare, per quanto possibile, il ricorso a procedure
contenziose»; nonché, recentemente, Cass. n. 453
del 2013, la quale, riprendendo il precedente ora
citato, ha ritenuto, sulla base del «canone di
lealtà» che trova fondamento negli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, che l’omissione dell’avvertimento - prescritto dalla norma a carico
dell’Ufficio - in ordine alle conseguenze derivanti
al contribuente dalla mancata risposta al questionario, e cioè l’inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa di dati e notizie non addotti,
comporta l’inoperatività di tale preclusione.
3.4. Le considerazioni sin qui svolte consentono di
giungere ad una prima conclusione: l’inosservanza
del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma
7, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non
può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente, quale effetto
del vizio del relativo procedimento, costituito dal
non aver messo a disposizione del contribuente
l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento
stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che
l’Ufficio è tenuto a valutare, come la norma prescrive), cioè di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale.
La «sanzione» dell’invalidità dell’atto conclusivo
del procedimento, pur non espressamente prevista,
deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale,
comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo (non certo innocua o
di lieve entità - non paragonabile, ad esempio,
all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da nullità per le
cartelle di pagamento: Cass., SS.UU., n. 11722 del
2010 - bensì) di particolare gravità, in considera-
400
4/2013
zione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma
stessa assolve - sopra delineata - e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante.
A fronte di ciò, è vano addurre sia il preteso carattere «vincolato» dell’avviso di accertamento rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa
(tesi, almeno se riferita - per quanto qui interessa al contenuto del provvedimento, chiaramente
infondata), sia l’esistenza di ulteriori strumenti di
tutela per il contribuente (istanza di autotutela, accertamento con adesione, ecc.), rilievo che, a prescindere dalle considerazioni attinenti al momento
in cui tali mezzi sono esperibili, si rivela in ogni
caso inidoneo ad escludere autonoma rilevanza alla portata precettiva della norma in esame.
4.1. Si tratta ora di precisare come opera, in relazione al vizio di legittimità dell’atto emesso ante
tempus, la deroga prevista per i «casi di particolare
e motivata urgenza», in presenza dei quali l’Ufficio è esonerato dal rispetto del termine dilatorio.
La norma, infatti, come detto, dopo aver stabilito
l’obbligo dell’Amministrazione, per le ragioni sopra ampiamente esposte, di attendere almeno sessanta giorni dalla fine delle operazioni di verifica
prima di procedere all’emanazione dell’atto (obbligo, va rilevato, di agevole osservanza con l’uso
della minima diligenza), ha, poi, adottando un bilanciamento del tutto ragionevole dei valori in
campo, introdotto l’eccezione derivante dall’urgenza di provvedere.
4.2. Premesso che spetta all’interprete il compito
di delineare l’oggetto e i confini di un’ipotesi di
invalidità introdotta per via ermeneutica, ritiene il
Collegio di dover preferire l’orientamento che fa
derivare l’illegittimità non già dalla mancanza,
nell’atto notificato, della motivazione circa la ricorrenza di un caso di urgenza, bensì dalla non
configurabilità, in fatto, del requisito dell’urgenza.
Deve, infatti, condividersi l’osservazione (presente in più pronunce di questa Corte, sopra citate,
anche se poi pervenute ad esiti diversi) secondo
cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari, assistito da sanzione di nullità in caso di inottemperanza, è quello che ha ad oggetto il contenuto sostanziale della pretesa tributaria, cioè «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche» che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione (art.
7, comma 1, dello Statuto, seguito, in relazione alle singole imposte, dal D.Lgs. n. 32/2001), non essendo, invece, necessario dar conto, in quella sede
(e, comunque, non a pena di invalidità, salvo ecce-
Accertamento
Cass., SS.UU., 29 luglio 2013, n. 18184
zioni espresse), del rispetto di regole procedimentali, quali, come nella specie, quelle attinenti al
tempo di emanazione del provvedimento: l’osservanza delle regole del procedimento, infatti, ove
contestata, sarà oggetto di dibattito e di valutazione nelle sedi stabilite (amministrativa in caso di
istanza di autotutela, contenziosa in caso di ricorso
al giudice tributario).
Né, in senso contrario, è condivisibile la tesi secondo la quale, nella norma in esame, la motivazione dell’urgenza è esplicitamente prescritta.
In primo luogo, l’espressione «salvo casi di particolare e motivata urgenza» non appare in sé decisiva, poiché non individua con certezza nell’atto
impositivo la (unica) sede in cui la «motivata urgenza» deve essere addotta dall’Ufficio: l’uso del
termine «motivata» non implica, infatti, necessariamente il richiamo alla motivazione dell’avviso
di accertamento.
In secondo luogo, e comunque, deve ritenersi che
risponda a criteri di equilibrio degli interessi coinvolti e di ragionevolezza far dipendere la validità
o meno dell’atto emesso ante tempus dalla sussistenza o meno, nella realtà giuridico-fattuale, del
requisito dell’urgenza, anziché dalla circostanza
(avente valore del tutto secondario) che tale requisito sia, o no, enunciato nell’atto: ciò che conta, in
definitiva, ai fini dell’esonero dell’Ufficio dall’osservanza del termine dilatorio, è unicamente il fatto che la particolare urgenza di provvedere effettivamente nella fattispecie vi sia stata.
Ne deriva che la questione si sposta in sede contenziosa, nel senso che, a fronte di un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine de quo e privo dell’enunciazione dei motivi di
urgenza che lo legittimano, il contribuente potrà,
ove lo ritenga, anche limitarsi ad impugnarlo per il
solo vizio della violazione del termine (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 16412 del 2007 e n. 5791 del 2008, in
tema di mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista per la formazione della pretesa
tributaria): spetterà, quindi, all’Ufficio l’onere di
provare la sussistenza (all’epoca) del requisito
esonerativo dal rispetto del termine e, dunque, in
definitiva, al giudice, a seguito del dibattito processuale (e senza, perciò, che il contribuente subisca alcuna menomazione del diritto di difesa), stabilire l’esistenza di una valida e «particolare» cioè specificamente riferita al contribuente e al
rapporto tributario in questione - ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento.
5. In conclusione, deve essere enunciato il seguen-
te principio di diritto: «In tema di diritti e garanzie
del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,
l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.
212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni
per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei
cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale
di chiusura delle operazioni - determina di per sé,
salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante
tempus, poiché detto termine è posto a garanzia
del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione
dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace
esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve
essere provata dall’Ufficio».
6. In applicazione dell’anzidetto principio, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere rigettato.
Come detto in narrativa, infatti, il giudice di merito ha accertato che nella specie l’emanazione anticipata dell’atto impugnato non è stata sorretta da
validi motivi di urgenza, mai addotti dall’Ufficio.
7. L’esistenza del contrasto giurisprudenziale che
ha dato luogo all’intervento delle Sezioni Unite induce a disporre la compensazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese.
4/2013
401
Redditi
d’impresa
Sulla deducibilità di ritenute fiscali
inizialmente omesse e versate
a seguito di accertamento
di Simone Covino, RL
La scoperta, da parte del Fisco, di pagamenti «in nero» a dipendenti e il successivo pagamento
dei relativi oneri fiscali e previdenziali (contributi e ritenute) induce a investigare la deducibilità
fiscale di tali importi, che a prima vista appare intuitiva. C’è tuttavia da contestualizzare una disposizione legislativa in proposito, contenuta nell’art. 99 del T.U.I.R. (sulla «indeducibilità delle
imposte per cui è prevista la rivalsa»); la norma non può riferirsi a queste ipotesi «patologiche»
dove a rigore 1) o si tratta di contributi e non di imposte, ovvero 2) viene meno un credito verso i beneficiari dei pagamenti «in nero». Si tratta quasi sempre di crediti irrecuperabili, per varie
ragioni economico gestionali da esaminare caso per caso, che legittimano la deduzione della relativa perdita.
Ritenute e contributi pagati a seguito di accertamento e deduzione
fiscale
Simone Covino
Il «contribuente di diritto» tra due fuochi
L’accertamento di erogazioni «in nero» non è frequentissimo, rispetto alla ricorrenza del fenomeno. In questo caso il sostituto d’imposta si trova
per certi versi tra due fuochi: da un lato c’è la
pretesa del Fisco (e dell’INPS) in relazione alle
omesse ritenute, dall’altro ci sono i beneficiari,
verso cui è spesso difficile esercitare la rivalsa.
Qualche volta possono essere non più rintracciabili, ormai lontani, ed altre volte possono essere
sin troppo vicini, come i dipendenti, verso i quali
è oggettivamente complesso, e per certi versi imbarazzante, avviare pratiche di recupero per importi individualmente spesso modesti, con una
prospettiva notevole di litigiosità e di pregiudizio
delle relazioni industriali interne all’azienda.
Sarebbe perciò arduo, per il sostituto, recuperare
le ritenute versate in sede di accertamento: resta
solo la strada della deduzione delle stesse, ma a
quale titolo?
In effetti le somme per cui è prevista la rivalsa
non fanno carico al datore, bensì al beneficiario; si tratta cioè di un costo in funzione del
402
4/2013
rapporto sottostante (ad esempio di lavoro), non
della deduzione dell’imposta in sé. In altri termini, le somme in discorso sono riconducibili al
costo del lavoro dipendente, ed è pertanto sostenibile che le singole ipotesi di rivalsa siano
riqualificabili come crediti verso dipendenti,
che la società non sarà in grado di recuperare
(1). Non verrebbero quindi dedotte le ritenute
IRPEF a suo tempo non versate, bensì una perdita su crediti verso i beneficiari, pari alla ritenuta rideterminata (in genere forfettariamente)
dal Fisco. Siamo autorizzati a parlare di perdita
proprio per il fatto che, per le cennate ragioni
giuridiche e di opportunità aziendale, il datore
Simone Covino - Dottore di ricerca in Diritto tributario presso l’Università di Roma «Tor Vergata» e Avvocato in Roma. Fondazione Studi
Tributari
Nota:
(1) Questa soluzione potrebbe essere confortata sotto molti
profili anche dalla nuova disciplina delle perdite su crediti riguardante crediti scaduti di modesta entità (prevista dall’art. 101,
comma 5, del T.U.I.R. come emendato dall’art. 33, comma 5, del
D.L. n. 83/2012).
Redditi
d’impresa
di lavoro non è in condizione di recuperare i
crediti in esame.
In sé, la fattispecie è per molti versi analoga a
quella in cui un istituto di credito ometta di applicare l’imposta di bollo ad una serie di documenti bancari: non essendo praticabile una reimputazione analitica in capo a numerosissimi
clienti, anche in tale caso la banca dedurrà una
perdita sul credito correlato alla rivalsa coattivamente operata ex post dal Fisco. Ancora, la stessa cosa accade per un creditore IVA che abbia
indicato un’aliquota inferiore a quella effettivamente dovuta e che non sia in condizione di coltivare il credito nei confronti della platea dei
suoi clienti: ciò che verrà dedotto non è l’IVA,
bensì la perdita su quello che a quel punto è un
normale credito verso una molteplicità indeterminata di clienti.
L’indeducibilità delle imposte
per cui è prevista la rivalsa
L’ipotesi così delineata, come vedremo subito,
non rientra peraltro nell’ambito di applicazione
del logico principio di indeducibilità delle imposte per cui è prevista la rivalsa anche facoltativa;
tale concetto (formulato all’art. 99 del T.U.I.R.)
è infatti rivolto a situazioni fisiologiche ove:
– la rivalsa è effettuata e la voce di costo «imposta» è già compresa nella voce di costo «lavoro
dipendente»: non può quindi essere dedotta addebitandola allo Stato, come correttamente ribadisce la norma;
– oppure, nelle imposte sui consumi, la facoltatività della rivalsa si riferisce a casi molto particolari come quello dei beni in omaggio (dove
sarebbe oggettivamente sconveniente richiedere
l’IVA al donatario). Si prevede, anche in tal caso, che, l’imposta non sia deducibile perché legata ad un atto di liberalità.
A ben vedere, il perimetro di applicazione dell’art. 99 appare già molto ristretto, riferendosi
solo alle fattispecie di rivalsa giuridica, dove
cioè vi è una correlazione diretta tra imposta e
rivalsa; tutti casi in cui, in altri termini, esiste
un’entità globale, come il corrispettivo IVA al
dettaglio, o il salario lordo, nel quale coesiste
anche il tributo da versare al Fisco. Ma già dove
la rivalsa è meramente economica, perché l’azienda che si rivale è debitrice in proprio, la
norma non si applica più: è il caso, ad es., delle
imposte di bollo, ribaltate dagli istituti di credito
sui correntisti all’interno della voce generica
«spese di tenuta conto» (2).
Ora, se l’art. 99 merita un’applicazione restrittiva già in fattispecie che rientrano nella «fisiologia» dei rapporti, a maggior ragione sarebbe difficile invocarlo nella fattispecie in discorso, che
vede invece la rivalsa come successiva all’intervento del Fisco. Quest’ultimo infatti riqualifica
certi rapporti o li fa emergere dal «nero». Qui la
rivalsa successiva è obiettivamente molto difficile, per il trascorrere del tempo, e verosimili vicende sopravvenute, a partire dal venir meno
della possibilità di esercitare la rivalsa mediante
ritenuta; l’esercizio di un diritto di credito verso
il beneficiario è molto difficile in pratica, perché
potrebbe esser venuto meno il contatto col beneficiario medesimo, o sussisterebbero oggettive
difficoltà probatorie nel far valere il diritto di rivalsa. Lo stesso accade per tutti i tributi dovuti
su ricchezza riferibile a terzi, compresa l’IVA su
incassi in nero. In tal caso la deduzione avviene
in modo implicito, scorporando dall’incasso
stesso l’importo dell’IVA. In pratica, su di un incasso di 100, 84 verranno ripresi come imponibile e 16 costituiranno l’IVA. La deduzione in
questo caso è perciò implicita nelle modalità di
calcolo dell’imposta, e se viene riconosciuta
nell’avviso di accertamento, sarebbe forzato
pretendere di dedurla separatamente, in pratica
una seconda volta.
Una perdita su di un credito «virtuale»,
per scongiurare una sanzione impropria
L’art. 99 sulla deduzione di imposta non pare
quindi utilizzabile per escludere la deduzione di
somme che non nascono affatto come imposte
bensì come diritti di credito «virtuali», nel senso
che nascono e contestualmente muoiono, per la
già indicata impossibilità/inopportunità «giuridico economica» di esazione. Non ci sono del reNota:
(2) Si veda sul tema la Relazione del SECIT del 1° giugno 2000.
Anche per l’imposta sulle assicurazioni manca la correlazione diretta di cui sopra: pur essendoci un addebito specifico sul premio
per l’assicurato, le società assicurative non pagano l’imposta RCA
dei singoli assicurati con singole operazioni, ma effettuano un
versamento unico.
4/2013
403
Redditi
d’impresa
sto altri motivi che potrebbero legittimare la
mancata deduzione di queste somme. Non siamo
di fronte ad atti estranei all’attività d’impresa o
ad un esercizio «deviato» della medesima (come
ad es. nelle sanzioni antitrust): l’inerenza rispetto all’attività d’impresa è anzi sancita in questi
casi dalla stessa Amministrazione finanziaria,
che richiede una maggiore imposta a titolo di
cessioni o pagamenti non registrati. Si tratta pur
sempre però di ipotesi patologiche, nel senso
che in esse si rinviene della ricchezza «non registrata», ed ecco perché - lo si ribadisce - siamo
fuori dall’ambito applicativo dell’art. 99 del
T.U.I.R. Diversamente, si finirebbe con l’ampliare il debito del sostituto, con un fortuito effetto sanzionatorio, che va al di là delle sanzioni
formali specificamente previste, in spregio oltretutto al principio di legalità delle sanzioni.
La mancata effettuazione della rivalsa, nella fi-
siologia dei rapporti economici dove non sorgono dubbi sui regimi fiscali applicabili né c’è la
volontà di nascondere alcunché al Fisco, si ricollega di solito ad un atto di una liberalità, e
per questo ne è prevista l’indeducibilità fiscale,
derivante da una pregressa vicenda giurisprudenziale, su cui si soffermerà Lupi. Nelle ipotesi
patologiche appena descritte, la deduzione di
una rivalsa verso clienti che non sono in grado
di identificare (o, per stare all’esempio, di dipendenti non più reperibili o che comunque contestano cifre e modalità del rapporto di lavoro
precedente) non va confusa con la deduzione di
imposta, vietata dall’art. 99 più volte citato. La
deduzione dell’importo delle ritenute versate in
sede di accertamento è assolutamente logica sul
piano economico, ed evita che il contribuente
sia afflitto da una sanzione ulteriore rispetto a
quella prevista per omessa ritenuta.
Gli strascichi di una remota giurisprudenza
RL
Anche davanti all’art. 99 del T.U.I.R., come per
tutte le disposizioni normative, occorre porsi un
problema logico-funzionale, ed effettuare una
contestualizzazione; si tratta di invertire una pigrizia metodologica dominante, secondo cui le
questioni nascerebbero con le disposizioni normative, e non preesisterebbero alla loro introduzione. L’art. 99 trova origine in un remoto precedente giurisprudenziale sull’imposta di Ricchezza Mobile, e precisamente la sentenza 12 gennaio 1967, n. 125, in cui una banca pretendeva
di dedurre una ritenuta su interessi passivi obbligazionari, con facoltà di rivalsa, che aveva regolarmente versato al Fisco, ma senza effettuare la
suddetta rivalsa facoltativa sui percettori. Ricostruiremo i passaggi logici della sentenza in un
prossimo numero di Dialoghi, ripubblicandola e
riflettendoci. Per ora appare chiaro che essa non
ha nulla a che vedere col caso dell’erogazione di
compensi «in nero», dove la mancata deduzione
fiscale delle ritenute, sub specie di perdita su
crediti, come ritiene giustamente Covino, avrebbe solo la funzione di sanzione impropria, pasticciata e stravagante. Perché è vero che i pro-
404
4/2013
blemi preesistono alle norme e permangono anche dopo la loro abrogazione. Però le norme, soprattutto quando da loro si pretende troppo, ci si
appiattisce e si smette di riflettere, creano anche
problemi ulteriori e del tutto inutili.
Ostacolando, nel caso in esame, quello che economicamente è un palese onere per la remunerazione del personale. Su cui nessun dubbio dovrebbe sorgere.
Redditi
CTR Toscana n. 73 del 2005 e Cass. n. 22564 del 2012
d’impresa
Interessi passivi su debiti contratti
per pagare dividendi: il principio è salvo
di Raffaello Lupi
Con questa nota chiudiamo un discorso aperto su Dialoghi sette anni fa, a proposito di una
sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che negava la deduzione di interessi passivi su debiti contratti, con la capogruppo, a tasso di mercato, per pagare dividendi alla
capogruppo medesima. Sul piano teorico, che è quello cui tiene Dialoghi, la sentenza metteva in
discussione la libertà delle aziende di indebitarsi per pagare dividendi e costituiva un ulteriore
motivo di confusione tributaria nelle decisioni imprenditoriali. A distanza di alcuni anni la Corte
di cassazione, con la sentenza n. 22564 del 2012, tiene ferma la sentenza impugnata, ma non ne
riconosce il principio, senza neppure menzionarlo, avallandola per motivi «di rito» (connessi ad
alcune peculiarità del caso di specie); l’importante però, sul piano ricostruttivo, è che la legittimità del comportamento generale sottostante (cioè indebitarsi per pagare dividendi) non sia
stata messa in discussione dalla Suprema Corte.
Su Dialoghi n. 4/2006 avevamo pubblicato una
sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana (1), ripubblicata qui di seguito,
che negava la possibilità di dedurre interessi
passivi su debiti contratti per pagare dividendi.
Riportiamo ora anche la pronuncia della Corte
di cassazione sul ricorso presentato dal contribuente (2), respinto per asserite ragioni di rito.
La sentenza della Cassazione non ha quindi provocato altre confusioni sul piano generale, non
ha affermato che «indebitarsi per pagare dividendi comporta l’indeducibilità degli interessi
passivi». Anche perché questo principio sarebbe
andato parzialmente in controtendenza rispetto a
sentenze della stessa Corte, sulla deducibilità
degli interessi passivi; non erano sentenze relative al debito assunto per la distribuzione di dividendi, ma al giudizio di inerenza sugli interessi,
come le sentenze nn. 2440/2010 e 12246/2010
(3).
Però dall’altra parte non se l’è sentita di accogliere il ricorso, forse perché si trattava anche di dividendi a fronte dei quali era stato ottenuto, a quanto risulta anche dalla sentenza, il rimborso del credito di imposta in base alla Convenzione con lo
Stato di residenza del socio percettore (4).
La Corte di cassazione si sofferma su aspetti
processuali, come la mancata contestazione delle argomentazioni un po’ surreali della Commis-
sione tributaria regionale e la fantomatica «mancanza di causa», che la giurisprudenza della
stessa Corte di cassazione aveva inizialmente
utilizzato per contrastare l’abuso del diritto in
materia di dividend washing (5). Era chiarissimo
che l’espressione «mancanza di causa», nella
sentenza impugnata, non si riferiva alla causa
giuridica del codice civile, ma alla motivazione
economica dell’operazione, alla «ragione economico tributaria», all’apprezzabile motivazione
sostanziale. La difficoltà di discutere in giudizio
«simmetrie concettuali» complesse, tra contribuenti e periodi di imposta diversi, conferma le
perplessità di chi scrive sulla «via processuale»
alla determinazione giuridica della ricchezza
Note:
(1) Comm. trib. reg. Toscana, 22 ottobre 2005, n. 73, in Dialoghi
Tributari n. 4/2006, pag. 532, sulla quale cfr. G.B. Palumbo, A. Vignoli, «Sulla deducibilità degli interessi passivi su prestiti contratti
per pagare dividendi», ivi pag. 523.
(2) Cass., 11 dicembre 2012, n. 22564.
(3) Entrambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(4) È un profilo su cui la Corte di cassazione si è pronunciata negativamente nelle sentenze 20 febbraio 2013, n. 4164 e n. 4165
(entrambe in Banca Dati BIG Suite, IPSOA), su cui varrebbe la pena di fare una riflessione su Dialoghi.
(5) Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398, in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA e in Dialoghi Tributari n. 12/2005, pag. 1670. Cfr. anche R.
Lunelli, RL, «Nullità civilistica ed elusione fiscale: un incidente di
percorso?», ivi n. 12/2006, pag. 1607.
4/2013
405
Redditi
d’impresa
CTR Toscana n. 73 del 2005 e Cass. n. 22564 del 2012
(6). È un richiamo alla necessità di adottare una
concezione del diritto tributario basata sul diritto amministrativo e sull’economia, anziché sul
diritto civile e sul processo (7).
Sulla via giurisdizionale al diritto tributario
d’impresa, ed alle sue questioni di diritto, cui si
dirigono le «contestazioni interpretative», aleggia una serie di incomprensioni, che non si riescono a chiarire in un contesto ad interlocuzione
limitata, come quello processuale. Dove legittimamente il giudice, anche su questioni di diritto
dove nulla è stato nascosto e che gli appaiono
chiare, non può fare a meno di porsi la domanda: «ma se il contribuente ha ragione, allora perché l’Ufficio non gliela concede? Vuoi vedere
che mi è sfuggito qualcosa?».
È un riflesso della ineliminabile matrice impugnatoria del processo tributario, in cui la domanda vera non è l’ammontare dell’imposta, ma l’esistenza di un errore dell’Amministrazione. Questa matrice amministrativa porta dritto dritto a risolvere le situazioni di stallo rigettando i ricorsi
dei contribuenti. Pur non potendo leggere nella
testa dei giudici, il loro comportamento è fondatamente ricostruibile attraverso indizi molteplici,
che sono poi il vero oggetto delle scienze sociali;
a forza di parlare con gli individui che ne fanno
parte, e di leggerne gli scritti, uno studioso sociale riesce a scomporre con buona approssimazione il comportamento delle relative istituzioni
fatte di esseri umani. Forse, personalmente, se
fossi al loro posto mi comporterei esattamente
nello stesso modo. Come mi comporterei allo
stesso modo dell’Avvocatura di Stato, che evidentemente ha fatto leva sul tema del rimborso
del credito di imposta sui dividendi, unito alla
deduzione degli interessi passivi che hanno gravato il conto economico della società italiana.
Tutte cose normalissime, lecite dal punto di vista
normativo e soprattutto del tutto conformi alla
(complessa) logica del sistema tributario. In
quanto, se la società ha dedotto gli interessi, riducendo il proprio imponibile, il socio ha pagato
le imposte ad aliquota piena nel suo Paese di residenza. In un processo sbrigativo e impugnatorio come quello tributario basta questo per disorientare, e far pensare che, «sotto sotto», la contestazione fiscale meriti di essere confermata. In
questi casi scatta forse un meccanismo che meriterebbe ampia trattazione teorica, cioè quello in
406
4/2013
cui la decisione viene presa per un motivo tecnico, su cui però non ci si sente abbastanza sicuri
per motivare con fiducia, e allora si motiva in un
altro modo, un po’ meno rispondente alle convinzioni dell’estensore, ma più facilmente formulabile e meno attaccabile, magari perché qualche volta un po’ stereotipo. È un atteggiamento
utilizzato in perfetta buona fede, persino quando
ci sono di mezzo complesse questioni di fiscalità
di impresa, in modo «bidirezionale», cioè anche
a favore del contribuente (quantunque più raramente, stando ai repertori). Questa prevalenza,
sulle questioni complesse, delle soluzioni pro fisco è un riflesso della natura amministrativa del
processo tributario, in quanto è normale, come
già rilevato, dare ragione all’Amministrazione
quando non ci si sente sicuri ed è ormai troppo
tardi per ripetere l’istruttoria. Anche sulle questioni di diritto, come questa, l’oggetto del processo non è la determinazione dell’imposta, ma
la correttezza di un comportamento amministrativo. Se non si è sicuri che l’Amministrazione
sbagli, si hanno parecchie remore a vanificarne il
comportamento, ed è comprensibile. Se questo
serva o meno all’interesse generale del Paese, alla «lotta all’evasione», all’efficienza dell’attività
amministrativa, oppure assecondi pretese fiscali
«fuori bersaglio» (8), è altra questione, su cui
dovremo tornare.
Dopotutto il mestiere del giudice è quello di distribuire le ragioni e i torti, non quello di dare
una sistemazione ai concetti e ai principi, spiegando la differenza tra ricchezza non registrata e
maggiore imposta accertata riqualificando circostanze dichiarate. Se queste distinzioni non vengono dagli studiosi è inutile attendersi supplenze dai giudici. Per i quali è meglio una sentenza
corretta nella sostanza, ma motivata male, che
una sentenza dottissima ed elegante, ma che a
loro avviso, nel loro «foro interno», non rende
giustizia. In un settore, disorientato e confuso
Note:
(6) È un filo conduttore generale di Dialoghi, su cui tra gli altri R.
Lupi, D. Stevanato, «Processare meno, processare meglio: gli inconvenienti dell’impostazione panprocessualistica del diritto tributario», in Dialoghi Tributari n. 3/2009, pag. 237.
(7) Vedi in proposito R. Lupi, Diritto amministrativo dei tributi, par.
6.7, scaricabile liberamente sul sito www.fondazionestuditributari.com, alla voce «pubblicazioni».
(8) Cioè contestazioni interpretative, mentre il problema è la ricchezza non registrata.
Redditi
CTR Toscana n. 73 del 2005 e Cass. n. 22564 del 2012
per ragioni teoriche (in gran parte connesse a
metodologie scientifiche piattamente imitative
delle scienze fisiche) l’importante per l’attività
giurisdizionale (purtroppo frenetica) è «non
scardinare i principi». In questo caso i criteri di
d’impresa
deduzione degli interessi passivi in presenza di
debiti contratti per pagare dividendi non sono
stati pregiudicati. Questo è già abbastanza per
contribuire indirettamente ad una corretta determinazione tributaristica della ricchezza.
La sentenza
Commissione tributaria regionale Toscana, Sent. 22 ottobre 2005, n. 73 (stralcio)
(Omissis)
Risulta dal libro giornale, in uso dal ‘95 alla Società XXXXX s.p.a. e dalle scritturazioni che vi sono riportate come accertato nel corso dei controlli
effettuati da funzionari dell’Amm.ne Finanziaria
che nello stesso giorno 16/10/95 è entrato ed uscito
il finanziamento di venti miliardi di lire tramite un
medesimo conto aperto presso la ... (una banca italiana - N.d.R.) per distribuire i dividendi corrispondenti al prestito ricevuto alla Società controllante
(«YYYY» Ltd detentrice al 99.96 per cento del
pacchetto azionario della controllata (XXXX
s.p.a.). Tale coincidenza evidenzia la mancanza di
causa del finanziamento. È da ritenere pertanto che
la stessa operazione posta in essere sia stata finalizzata a realizzare un notevole beneficio economico
nell’interesse della controllante estera senza una
giustificazione razionale della propria scelta determinando di conseguenza, per la società controllata
italiana un aggravio non ragionevole di costi.
La rilevata coincidenza temporale, unitamente alla
coincidenza del soggetto erogatore del finanziamento ed il soggetto percettore della stessa somma a titolo di dividendi (unico soggetto), costituisce un elemento che determina la non sussistenza
di causa nel contratto di finanziamento con la conseguenza della mancanza di causa nel pagamento
degli interessi passivi, oggetto di rettifica, e, quindi, l’indeducibilità del relativo costo. Ed ancora, a
sostegno di questa decisione, è da rilevare come la
mancanza di causa derivi dall’essere il finanziamento erogato non nell’interesse della società finanziata bensì esclusivamente nell’interesse della
società finanziatrice, che, mediante il finanziamento, ha avuto il beneficio della contestuale distribuzione e pagamento dei dividendi per un importo equivalente al finanziamento stesso ed il diritto a richiedere il rimborso del relativo credito
d’imposta. Da tale operazione è, quindi, unicamente derivato alla società finanziata un nuovo
debito ed una riduzione di patrimonio. Quindi,
non solo nessun vantaggio, bensì una riduzione di
patrimonio della quale si è avvantaggiata la società finanziatrice. Il negozio finanziamento, per
tali aspetti, può anche assumere rilevanza ai fini
della simulazione (relativa) che ricorre quando si
vuole porre in atto un negozio giuridico (distribuzione di utili) e la parti dichiarano, invece, di volerne fare un altro (finanziamento). In questo caso
la simulazione si evidenzia sostanzialmente nell’analizzare l’operazione posta in essere nel suo
insieme stante la contestuale restituzione della
somma alla società finanziatrice effettuata dalla
società finanziata, non con mezzi finanziari propri, bensì con mezzi finanziari messi a tal fine a
disposizione della società beneficiaria dei dividendi. Significativo l’orientamento della Suprema
Corte di Cassazione (sentenza n. 10802 del
23/07/02 e n. 11240/2002) per il quale «è necessario accertare, in modo incontrovertibile, se l’intenzione dell’imprenditore fosse quella di raggiungere comunque risultati che comprendessero a criteri
di logica economica ... che deve essere funzionale
ai meccanismi di mercato e di regimi di libera
concorrenza».
(Omissis)
La sentenza
Cassazione, Sez. trib., Sent. 11 dicembre 2012 (10 ottobre 2012), n. 22564 - Pres. Cappabianca Rel. Sambito (stralcio)
Svolgimento del processo
Con tre distinti avvisi d’accertamento relativi ad
IRPEG ed ILOR per gli anni 1996, 1997, ed IR-
PEG, IRAP ed IVA, per l’anno 1998, l’Agenzia
delle entrate di Carrara rettificava il reddito dichiarato dalla Alfa s.p.a. contestando, per quanto
4/2013
407
Redditi
d’impresa
CTR Toscana n. 73 del 2005 e Cass. n. 22564 del 2012
ancora interessa, per tutte e tre le annualità, l’indebita deduzione degli interessi passivi sostenuti a
fronte di un finanziamento fruttifero erogato dalla
Società controllante ... Ltd., e, … In relazione a tali riprese, i ricorsi della contribuente sono stati accolti dalla CTP di Massa Carrara, e gli appelli dell’Ufficio, dopo esser stati riuniti, sono stati, in parte, accolti dalla CTR della Toscana, che, con sentenza n. 73/25/2005, depositata il 22 ottobre 2005,
ha ritenuto fondato il primo rilievo dell’Ufficio ed
illegittime le altre contestazioni.
Per la cassazione della sentenza, hanno proposto
ricorso, in relazione alle statuizioni che le hanno
viste soccombenti, in via principale, la contribuente, ed, in via incidentale, l’Agenzia delle entrate.
La Società ha resistito con controricorso, ed inoltre, ha depositato memorie e note d’udienza.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5,
c.p.c., la Società contribuente afferma che l’indeducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento era stata sostenuta dall’Ufficio con
riferimento all’art. 75 del T.U.I.R. ed al principio
di inerenza, in esso contemplato. Ritenendo il predetto negozio privo di causa o simulato, prosegue
la ricorrente, la CTR ha violato il principio sancito
dall’art. 112 c.p.c., e, per di più, lo ha fatto in modo confuso e contraddittorio, ed omettendo, pure,
di spiegare come le argomentazioni utilizzate potevano porsi in collegamento con il sindacato di
inerenza, cui si riferiva la contestazione dell’Ufficio.
Il motivo è infondato. Dopo aver esposto i dati fattuali relativi all’operazione (pag. 2 del ricorso: ricezione del finanziamento fruttifero di L.
20.000.000.000, in data 16.10.1995, e pagamento,
in pari data, di L. 19.999.062.000, a titolo di distribuzione dei dividendi), la ricorrente riferisce
esser pacifico che la società controllante estera
aveva, così, finanziato il pagamento dei dividendi
e che, per tale ragione, l’Ufficio aveva ritenuto indeducibili gli interessi passivi maturati sul finanziamento.
La contribuente espone, ancora, che la sua impugnazione era stata accolta dalla CTP perché il diritto alla deduzione degli interessi andava riconosciuto, ex art. 75, comma 5, del T.U.I.R., senza alcuna valutazione del giudizio d’inerenza (col limite, non superato, di cui al precedente art. 63) e
408
4/2013
che, con l’appello, l’Ufficio aveva sostenuto che:
a) la deducibilità degli interessi non poteva considerarsi immune da un giudizio sull’an; b) anche
aderendo ad una tesi restrittiva, l’operazione finanziaria era pur sempre disconoscibile dal Fisco;
c) il recupero degli interessi passivi, doveva ritenersi autorizzato, ai sensi della disciplina dei trattati internazionali (artt. 9 e 11 del Modello OCSE).
La sentenza d’appello ha, quindi, affermato che il
finanziamento, cui afferivano gli interessi passivi,
oggetto della contestazione, era carente di causa,
in quanto il relativo importo era «entrato ed uscito
... tramite il medesimo conto» nello stesso giorno,
sicché l’intera operazione doveva ritenersi conclusa nell’interesse della Società finanziatrice estera
«che mediante il finanziamento ha avuto il beneficio della contestuale distribuzione dei dividendi
per un importo equivalente al finanziamento stesso
ed il diritto a richiedere il rimborso del relativo
credito d’imposta», senza giustificazione per la
posizione della contribuente, per la quale residuava, solo, un aggravio irragionevole dei costi; caratteristiche per le quali il finanziamento assumeva
rilevanza ai fini della simulazione relativa, in
quanto il negozio effettivamente voluto era, invece, la distribuzione degli utili della Società finanziatrice. Ora, l’assunto della ricorrente, secondo
cui tali argomenti, relativi a temi non dedotti dalle
parti, inficierebbero la sentenza per violazione del
principio sancito dall’art. 112 c.p.c., in ossequio al
quale la CTR avrebbe dovuto limitarsi a confermare o a negare la deducibilità degli interessi, a norma degli artt. 75 e 63 del T.U.I.R. (nel testo applicabile ratione temporis), non è fondato. Anzitutto,
la ricorrente non enuncia, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, le ragioni per le quali, in sede d’appello, l’Ufficio aveva affermato che «l’operazione finanziaria messa
in atto dalla società era pur sempre disconoscibile
dal Fisco» (punto b sopra enunciato); al contrario,
la controricorrente riporta passi del suo atto d’appello con i quali si collegava la disconoscibilità
dell’operazione alla sua natura «meramente cartolare», potendosi, con ciò, inferire che la questione
della deducibilità degli interessi passivi non era
stata sottoposta al giudice d’appello, solo, in relazione ai parametri normativi richiamati dalla contribuente. Né, del resto, a tale questione può dirsi
limitata la contestazione mossa dall’Ufficio con
l’atto impositivo. Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui, anche nel giudizio tributario, il
cui ambito va delimitato entro i confini posti dalle
ragioni poste a base dell’atto impositivo, il giudice
Redditi
CTR Toscana n. 73 del 2005 e Cass. n. 22564 del 2012
ha il potere - connaturale all’esercizio stesso della
giurisdizione - di operare, a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, una qualificazione
giuridica autonoma della fattispecie concreta che
ha dato luogo all’esercizio della pretesa fiscale
sottoposta al suo esame, non potendo ritenersi che
i poteri del giudice tributario siano più limitati di
quelli esercitabili in qualunque processo di impugnazione di atti, come quello amministrativo di legittimità (cfr. Cass. n. 20398 del 2005; n. 10585
del 2011; n. 7393 del 2012).
L’esplicazione dei siffatti poteri non può non dispiegarsi, anche, con riferimento al tema relativo
all’esistenza, alla validità e all’opponibilità all’Amministrazione finanziaria del negozio dal
quale si assume che derivi una data componente
negativa del reddito, tema che deve ritenersi acquisito al processo, per effetto dell’allegazione da
parte del contribuente, gravato dell’onere di provarne i relativi presupposti. Con la conseguenza
che eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, anche in considerazione
dell’indisponibilità della pretesa tributaria, ben
possono essere rilevate dal giudice tributario, anche d’ufficio. (Cass., SS.UU., n. 30055 del 2008).
Così convenendo, resta esclusa la dedotta violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., ed assorbito il relativo vizio motivazionale, che, peraltro, riguardando profili in diritto - relativi, in tesi,
all’attinenza delle argomentazioni svolte dai giudici d’appello, rispetto al thema decidendum - non
sarebbe stato, comunque, idoneo a provocare la
cassazione della sentenza.
Col secondo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 75 e 63 del T.U.I.R.
(vecchia numerazione), oltre che vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,
c.p.c. affermando che l’impugnata sentenza, pur
non riferendosi alle norme invocate, finisce col
violarle, dato che dette disposizioni non pongono
limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi,
in presenza di proventi esenti, per la fungibilità
del denaro che rende impossibile riferire analiticamente i primi ai secondi. Esisteva, peraltro, un
preciso collegamento tra il finanziamento e l’attività d’impresa, tenuto conto che il pagamento dei
dividendi attiene alla struttura finanziaria propria
di una società per azioni e non è equiparabile al
caso della distrazione delle risorse societarie per
soddisfare interessi «egoistici» ed impropri dei soci. La CTR aveva, inoltre, omesso di motivare che,
per effetto del finanziamento ricevuto, era stato ridotto il più oneroso indebitamento nei confronti
d’impresa
del sistema bancario. Anche questo motivo va rigettato. La dedotta violazione di legge è, infatti,
priva di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, che, come si è esposto, ha ritenuto legittima la ripresa, affermando nulla, per mancanza di causa, o simulata l’operazione di finanziamento, senza soffermarsi, in alcun modo, sulla
questione della deducibilità degli interessi in riferimento ai parametri normativi invocati. La ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, censurare le autonome ragioni espresse a sostegno della decisione
impugnata (ed, in concreto, indicare, sotto il profilo della violazione di legge, qui in rilievo, le norme o i principi di diritto violati con l’affermata carenza di causa del contratto o simulazione relativa), ma non poteva, di certo, sottoporre a critica
argomenti che la sentenza non aveva esposto.
Deve, infatti, ribadirsi il principio (Cass. n. 17125
del 2007; n. 4036 del 2011), secondo cui il ricorso
per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, (id
est: esatta individuazione del capo di pronunzia
impugnata ed esposizione di ragioni che illustrino
le dedotte violazioni di norme o principi di diritto,
ovvero le carenze della motivazione) restando
estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi statuizioni che non hanno formato oggetto della sentenza impugnata. La censura motivazionale dedotta nell’ambito del motivo
resta assorbita, in quanto afferente alla violazione
di legge con esso denunciata: la circostanza che il
finanziamento sia stato «erogato dal gruppo cui
appartiene la società» valorizzata nel l’impugnata
sentenza (insieme alla coincidenza temporale in
cui si è avuto passaggio di denaro) per affermare
la mancanza di causa del finanziamento e la sua
simulazione è, infatti, ritenuta «del tutto irrilevante» (testualmente, nella parte finale e riassuntiva
del motivo) dalla ricorrente, proprio, in ragione
dell’affermata piena deducibilità degli interessi
passivi a prescindere da ogni giudizio d’inerenza
all’attività d’impresa, secondo la disciplina di cui
agli artt. 75, comma 5, e 63 del D.P.R. n. 917/1986
(vedi, pure, memorie depositate e note d’udienza).
(Omissis)
In considerazione della reciproca soccombenza, le
spese del presente giudizio di legittimità vanno,
interamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.
4/2013
409
Redditi
d’impresa
Cessione contro rendita vitalizia:
la continuità dei valori fiscali
esclude la doppia tassazione
di Gaudenzio Albertinazzi, RL, DS
Sul precedente numero 3 avevamo parlato di rendite vitalizie e di doppia tassazione, a proposito delle quali un attento lettore, di cui concordemente pubblichiamo la missiva, ci stimola a
nuove riflessioni, che portano avanti il discorso. Il criterio di attualizzazione della rendita al momento della cessione del bene sembra introdurre nella determinazione della ricchezza un elemento aleatorio, cui si collegherebbe la tassazione dell’interesse implicito nella rendita, che dovrebbe essere quindi irrilevante nel momento in cui maturano le rate, venendo via via a scadenza. Se invece valorizziamo fiscalmente il «credito» da attualizzazione della rendita, la percezione
delle rate deve essere confrontata con la eliminazione dell’attività rappresentata dal credito, il
che esclude la doppia tassazione. Salvo che l’impresa cessi, nel qual caso dovremo approfondire
le osservazioni di DS.
Rendita vitalizia e doppia tassazione
Gaudenzio Albertinazzi
Carissimi Dario e Raffaello, ho letto i vostri articoli «Rendita vitalizia, reddito d’impresa e
doppia tassazione» apparsi sul n. 3/2013 di Dialoghi, rivista che «divoro» con interesse e passione.
Non sono d’accordo che vi sia doppia tassazione
tra tassazione della plusvalenza e tassazione della rendita.
Mi spiego con un esempio numerico.
Esempio
Valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda ceduta:
80, termine iniziale per il calcolo della plusvalenza.
Corrispettivo di cessione di azienda:
rendita con durata di un anno con pagamento di unica
rata posticipata di 105.
Valore attuale della rendita al tasso del 5%:
100.
Plusvalenza calcolata al momento dell’attualizzazione:
100 - 80 = 20 tassata come reddito d’impresa
410
4/2013
La scrittura sarà:
credito 100 a azienda 80
plusv. 20
Si registra quindi nell’attivo patrimoniale un elemento
attivo di 100, a seguito dell’attualizzazione.
Rimanendo nell’ambito del reddito d’impresa, al momento dell’incasso della rendita, la scrittura sarà:
cassa 105 a credito 100
interessi 5
Quindi è corretto che gli interessi siano tassati
nell’ambito del reddito di impresa, perché alla
fine la tassazione avviene una volta sola. Il fatto
che al momento del conseguimento della plusvalenza si sia già tenuto conto della rendita attualizzata non esclude che al momento dell’incasso della rata la componente finanziaria di interesse della rendita venga tassata. Non condivido quindi l’affermazione di pag. 292 per cui
«nella determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda, il corrispettivo
(ovvero il valore attuale della rendita vitalizia) è
dunque già comprensivo dei futuri rendimenti
Redditi
d’impresa
finanziari». Lo sarà «economicamente», in
quanto la rendita è stata tenuta in considerazione
per calcolare la plusvalenza, ma non lo è ancora
contabilmente e quindi tributariamente.
Quanto sopra vale anche nel caso della rendita
vitalizia: al momento dell’incasso della rata,
questa dovrà essere scissa nella componente di
capitale, da stornare dal credito contabilizzato, e
nella parte finanziaria/attuariale, da imputare a
reddito. Nell’ambito del reddito d’impresa tale
scomputo deve essere fatto analiticamente rideterminando il nuovo valore attuale della rendita
che sarà iscritto come credito dopo l’incasso
della rata, non applicandosi la regola dell’abbattimento del 40% prevista solo fuori dal reddito
d’impresa. Comunque anche nel reddito d’impresa, l’incasso della rata determina sempre la
tassazione di una parte della rendita stessa.
Se il credito derivante dalla cessione dell’azienda pari alla rendita vitalizia attualizzata
viene trasferito dalla sfera imprenditoriale alla
sfera personale per effetto della cessazione dell’attività di impresa, l’incasso della rendita determinerà ancora la parziale tassazione della
stessa, ma non più con il metodo analitico,
bensì con l’abbattimento forfetario del 40%
previsto dalla legge. Si potrà discutere se tale
abbattimento forfetario è ragionevole o meno
(e credo che lo sia solo in presenza di alti tassi
di interesse come quelli vigenti fino agli anni
‘90), ma concettualmente non si tratta di una
doppia tassazione.
Un caro saluto e complimenti vivissimi per
quanto state facendo nel diritto tributario.
Il credito da rendita attualizzata (anche solo fiscale) esclude la doppia
tassazione
RL
Le riflessioni dei lettori sono sempre molto utili
per mettere a fuoco le questioni, ed in effetti, almeno nel reddito di impresa, la valorizzazione
come attività patrimoniale del credito per flusso
futuro di rate di rendita risolve il problema della
doppia tassazione. Al momento dell’attualizzazione della rendita, infatti, si registra il valore
fiscalmente riconosciuto di una componente dell’attivo patrimoniale, come «credito da rendita».
Al momento dell’incasso della rendita non c’è
una nuova sua tassazione, bensì uno stralcio del
suddetto elemento patrimoniale, ed una nuova
tassazione solo sulla differenza. Alla fine, quindi, nell’esempio di Albertinazzi, la rendita con-
corre come elemento imponibile (per 105) senza
nulla perdere né accrescere per strada, e viene
confrontata col valore fiscalmente riconosciuto
del bene ceduto (per 80). Anche qualora non ci
fosse la scrittura contabile di attualizzazione, e
la rendita venisse valorizzata solo ai fini fiscali,
ci sarebbe comunque un «asset fiscale» da valorizzare, e la tassazione delle successive rate di
rendita avverrebbe solo al netto della corrispondente proporzionale eliminazione di questo elemento dell’attivo (sia pure solo fiscale).
Ringraziamo il lettore per gli apprezzamenti.
Ne abbiamo bisogno.
Se però cessa l’impresa la doppia imposizione c’è
DS
È abbastanza frequente che la cessione dell’azienda con costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente avvenga in ipotesi di cessione
dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale. In tal caso, la determinazione della
plusvalenza nell’ambito del reddito di impresa
4/2013
411
Redditi
d’impresa
viene effettuata mediante l’attualizzazione della
rendita, però l’incasso delle rate, anziché stornare via via il credito iscritto a bilancio (con rilevazione dell’interesse a conto economico), avviene nell’ambito di una sfera extraimprenditoriale: è qui che si pone con particolare evidenza
il problema della doppia imposizione, cioè allorché si pretende di tassare la percezione delle rate in capo all’ex imprenditore, che aveva già pagato le imposte al momento della cessione, sulla
plusvalenza calcolata come sopra. Non mi sembra allora corretto affermare che la tassazione
delle rate di rendita nell’ambito dei redditi di la-
412
4/2013
voro dipendente serve a attrarre a tassazione una
componente finanziaria non già tassata al momento della cessione: si tratta invece di una imposizione che insiste palesemente su una materia imponibile già oggetto di tassazione al momento del calcolo della plusvalenza. Tanto più
che non opera nemmeno più l’abbattimento forfetario al 40%. I 105 dell’esempio riportato dagli Autori che mi hanno preceduto, oltre a costituire il «corrispettivo» utilizzato per il calcolo
della plusvalenza, verrebbero interamente tassati
una seconda volta al momento della percezione
delle rate da parte dell’ex imprenditore.
Redditi
fondiari
Reddito figurativo
degli immobili non locati
tra «socio-matematica»
e manovre finanziarie
di Alessandro Santoro, RL
Il progetto ministeriale per reintrodurre la tassazione figurativa IRPEF sugli immobili non locati
è stato presentato, quindi ritirato, davanti a varie forme di proteste, poi riproposto. Non c’è stata però una discussione in merito alla sua razionalità sotto il profilo della determinazione tributaristica della ricchezza, che sul piano reddituale appare del tutto inconsistente. Lo conferma
Alessandro Santoro, indicando come unica giustificazione una logica antievasione, equivalente a
una specie di dichiarazione di impotenza (siccome non trovo gli immobili locati «in nero» tasso
un po’ tutti gli immobili non locati), o di uso extrafiscale dell’imposta per sostenere le locazioni.
Tolto questo assurdo, si tratterebbe di una strana tassazione patrimoniale legata al reddito.
Il diritto tributario, la «socio-matematica» e le leggi di stabilità:
una relazione complessa (o no?)
Alessandro Santoro
Leggi di stabilità
tra «socio-matematica» e diritto
Una delle ragioni per cui il dibattito sui temi fiscali nel nostro Paese sembra costantemente avvilupparsi sugli stessi nodi è certamente la perdita di contatto con la realtà che caratterizza il
nostro mondo accademico. Da un lato, i cultori
del diritto tributario sembrano, con le dovute eccezioni, essere interessati esclusivamente a sviluppare le proprie abilità retoriche per trovare i
punti deboli (invero, numerosi) delle leggi tributarie e argomentare in difesa della legalità, e,
possibilmente, dei propri clienti. Dall’altro lato,
gli economisti pretendono di spiegare i comportamenti dei contribuenti sulla base di astratti
modelli matematici, in cui postulano concetti
inesistenti nella realtà come l’assoluta razionalità e onniscienza e ignorano completamente il
dato normativo e la realtà in cui il contribuente
prende le sue decisioni. Questa astrattezza giustifica la definizione di «socio-matematica» che
Raffaello Lupi dà dell’economia, con ciò ben
rappresentando l’involuzione della nostra disciplina da scienza sociale a scienza (auto-definitasi) esatta. Si potrebbe archiviare questo conflitto
come un’(ennesima) dimostrazione della superfluità dell’accademia se non fosse che, «in mezzo a e per mezzo di» questo conflitto, rimane
l’amara realtà, che è caratterizzata da un continuo e caotico affollarsi di discussioni su materie
tributarie, dove si accumulano in modo disordinato argomenti «suppostamente» giuridici e ragionamenti definiti come «economici». È evidente che così posta la questione è troppo ampia
per poter essere trattata in un breve articolo
scritto, per di più, da un economista. I lettori di
Dialoghi (e i frequentatori dei blog che vi sono
connessi) conoscono già numerosi esempi di
quella che si può definire la degenerazione avvocatesca del diritto tributario nel nostro Paese.
Sono forse meno chiare a questi lettori, invece,
Alessandro Santoro - Professore associato di Scienza delle finanze presso l’Università di Milano-Bicocca
4/2013
413
Redditi
fondiari
le relazioni che intercorrono, da un lato, tra il
diritto tributario e l’economia (o la «socio-matematica» che dir si voglia) e, dall’altro lato, tra
queste due discipline e la ragioneria delle leggi
di stabilità. Ad un chiarimento, per necessità limitato ad alcuni ambiti esemplificativi, di queste relazioni è dedicato questo articolo.
Immobili non locati e tassazione forfetaria
Analizziamo innanzitutto la recente questione
del riordino della tassazione sugli immobili, nell’ambito della quale il Governo (e segnatamente
il Ministro del Tesoro nel suo studio pubblicato
on line) aveva prospettato, insieme con il superamento parziale o totale dell’IMU, la re-inclusione nel reddito complessivo ai fini IRPEF di
quello imputato alle abitazioni tenute a disposizione, ovvero le seconde case non date in locazione. Su Dialoghi la questione è stata analizzata dal punto di vista dei principi del diritto tributario (1). È difficile negare che, così ragionando,
la re-inclusione del reddito figurativo degli immobili nella base imponibile IRPEF non ha senso. In vigenza di un’imposta sul patrimonio (prima l’IMU e in futuro, forse, la Service tax) nella
base imponibile dell’IRPEF dovrebbero rientrare i soli redditi effettivamente ottenuti, e, quindi,
i canoni di locazione. L’obiezione che l’economia (qui più socio che matematica) può opporre
a questo ragionamento è che l’esclusione dall’IRPEF del reddito presunto sugli immobili tenuti a disposizione rappresenta un ulteriore incentivo all’evasione. Infatti, il proprietario che
dichiari di tenere a disposizione un immobile,
quando invece lo dà in locazione, a parità di
IMU, paga meno IRPEF. Continuando su questa
linea di ragionamento, si potrebbe concludere
che se questo risparmio non ci fosse, una parte
delle motivazioni che spingono il proprietario a
non dichiarare il canone di locazione verrebbe
meno. Tuttavia, questa argomentazione è solo
relativamente convincente. Per comprendere
perché analizziamo una vicenda affine, anche se
non identica. La cedolare secca è stata introdotta
sulla base di un ragionamento simile a quello
appena esposto: poiché sulle seconde case date
in locazione l’aliquota IRPEF è normalmente
molto elevata, per ridurre l’evasione viene introdotta un’aliquota fissa piuttosto bassa. In condi-
414
4/2013
zioni normali, ciò avrebbe dovuto indurre i contribuenti a dichiarare le locazioni, visto che il risparmio ottenuto grazie all’evasione si riduce
fortemente. Questa logica era alla base delle
previsioni di gettito, invero mirabolanti, formulate sulla cedolare secca al tempo della sua introduzione. Per schematizzare, la ragioneria della legge di stabilità (allora: legge finanziaria) si
basava sulla «socio-matematica» (nella versione, invero rozza, esposta in precedenza) e questa
alleanza faceva premio sui principi giuridici (ad
esempio, quello dell’equità verticale e della progressività). Tuttavia, i numeri effettivi, cioè
quelli che fotografano l’impatto reale della cedolare secca sono affatto diversi (2). Evidentemente, il fatto che il risparmio derivante dall’evasione si sia ridotto non ha cambiato le decisioni di molti proprietari che hanno continuato
ad affittare in nero gli immobili. Similmente, reincludere l’IRPEF sulle case dichiarate a disposizione non avrebbe l’effetto di ridurre l’evasione, ma, e qui con un puro effetto ragioneristico
non apprezzabile su altri piani, produrrebbe
esclusivamente gettito aggiuntivo.
Perché il ragionamento precedente, apparentemente economico, non si è rivelato fondato? La
risposta, in effetti, è semplice: non conta solo il
guadagno atteso, ma anche la probabilità di
(non) conseguirlo. A prescindere dalle aliquote,
la probabilità che il proprietario di un immobile
fittiziamente tenuto a disposizione, ma in realtà
dato in locazione, sia scovato dall’Amministrazione nel nostro Paese è molto bassa. E questo
ha a che fare con il fatto che (ancora: Raffaello
Lupi docet) questo tipo di transazione (la locazione) non transita per l’impresa e quindi non si
avvale di quel potente strumento che è la tassazione attraverso l’impresa. Come già sottolineato in un altro articolo su Dialoghi (3) la versione
Note:
(1) R. Lupi, «“Seconde case a disposizione”: l’eliminazione della
tassazione reddituale “virtuale” di cespiti infruttiferi», in Dialoghi
Tributari n. 3/2013, pag. 241.
(2) Cfr. C. Dettori, G. Spaziani Testa, R. Lupi, «Cedolare secca e
contrasto di interessi “inquilino-proprietario”: un primo bilancio
di due provvedimenti da non confondere», in Dialoghi Tributari n.
1/2013, pag. 53.
(3) R. Lupi, A. Santoro, «Le cause dell’evasione: dal senso civico al
“third party reporting”», in Dialoghi Tributari n. 2/2012, pag. 121.
Redditi
fondiari
più moderna della «socio-matematica» è in
realtà pienamente consapevole della cruciale
differenza tra redditi su cui l’Amministrazione
detiene l’informazione proveniente da terze parti non interessate (ad esempio: i redditi da risparmio) e quelli su cui non possiede questa
informazione (come, appunto, il caso dei redditi
da locazione). Lo stesso tipo di ragionamento
porta a prevedere che le imprese non strutturate
e di piccola dimensione mostrino una compliance minore rispetto alle imprese strutturate e di
grande dimensione, che sul territorio sono visibili e monitorabili in molti modi (e che hanno
dei costi derivanti dalla perdita degli strumenti
di controllo della contabilità cui l’evasione è
connessa). Insomma, quando si considera, da un
lato, un ragionamento para-giuridico che tiene
in considerazione le caratteristiche dell’organizzazione di impresa oppure, dall’altro lato, un ragionamento economico che ingloba il contesto
informativo in cui si colloca la relazione tra i
contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, si
giunge a conclusioni non dissimili. Tuttavia, a
questa corrispondenza si perde qualsiasi collegamento con la ragioneria delle leggi di stabilità. Nei ripetuti tentativi di produrre gettito attraverso l’incremento della «lotta all’evasione»
per mezzo di aumenti di sanzioni e di assunzioni
di personale da parte dell’Agenzia, l’algebra che
compare nelle Relazioni tecniche è del tutto rozza (della serie: per ogni incremento di assunzione o per ogni funzionario in più si stima «prudentemente» un aumento della compliance
dell’x%) e autoreferenziale.
sati ad aliquota ordinaria. Tuttavia, la realtà si è
dimostrata ben diversa: in un periodo di forte
crisi, l’aumento dell’aliquota non poteva non
avere effetti negativi sulla compliance e questo
spiega sicuramente il cattivo gettito dell’IVA del
2011 e dell’ultima parte del 2012. Ci sarebbe almeno da sperare che questa mera constatazione
algebrica consigliasse moderazione sull’ulteriore aumento di aliquota previsto per il prossimo
futuro, ma ciò non accade. La ragioneria trionfa,
e il Governo si avviluppa intorno ad una discussione su come recuperare un gettito che, almeno
in parte, è del tutto ipotetico.
Per concludere, la relazione tra diritto tributario,
economia e ragioneria delle leggi di stabilità
sembra complessa, perché la sua geometria varia
a seconda degli esempi considerati. Ma, a ben
pensarci, almeno in questo caso la complessità
si può risolvere facilmente: quando l’economia
semplifica eccessivamente la realtà, fornisce le
basi per la ragioneria delle leggi di stabilità, ma
poi lascia l’eredità dei «buchi di bilancio».
Quando l’economia, per quanto matematica,
cerca di cogliere la complessità della realtà, allora la ragioneria delle leggi di stabilità perde
ogni fondamento e diventa inutile chiacchiericcio da talk show televisivo, fine a se stesso.
«Post scriptum» su stime di gettito
«ex ante»: il caso dell’aumento dell’IVA
Questa polarizzazione trova poi un ulteriore, ed
ultimo, esempio nella vicenda relativa all’IVA.
Qui la rozzezza della ragioneria delle leggi di
stabilità ha raggiunto vertici notevoli. Nella stima degli effetti dell’incremento dell’aliquota ordinaria dell’IVA (con il passaggio dal 20 al
21%) gli effetti sul comportamento dei contribuenti sono stati pressoché totalmente ignorati.
La Relazione tecnica ha quindi stimato un incremento previsto di circa 4 miliardi di euro, derivante dalla mera applicazione del punto percentuale in più al volume dei beni e dei servizi tas4/2013
415
Redditi
fondiari
Un’imposta patrimoniale in chiave reddituale?
RL
Abbiamo già scritto ripetutamente che la tassazione figurativa della rendita catastale degli immobili sfitti è un nonsenso logico, sul piano della determinazione della ricchezza, anche se può
avere altre finalità. Ricordiamo che la ragione
della tassazione forfetaria, tipica dei redditi fondiari, è la redditualità dell’immobile e la utilizzazione generale di un criterio forfetario. La determinazione analitica, in base a criteri di effettività, tipica della tassazione attraverso le aziende, declinata per gli immobili con la tassazione
del canone di locazione realmente pattuito,
spiazza queste forme di tassazione per l’immobile «sfitto» o usato dal proprietario. Solo in
quell’epoca si poteva dire, con Luigi Einaudi,
che «il proprietario della prima casa è allo stesso tempo un inquilino che paga un affitto a se
stesso, in luogo di pagarlo ad altri. Non tassare
in qualche forma la prima casa sarebbe quindi
contrario al canone dell’uguaglianza, perché
mentre il proprietario di una seconda casa dovrebbe pagare un’imposta sull’affitto, il proprietario di una prima casa non dovrebbe pagare
nulla col pretesto che il reddito lo percepisce da
se stesso» (4). Abbiamo già indicato l’assurdità
di tassare, in un contesto di tassazione analitica
del reddito effettivo, un utilizzo diretto dei beni.
La fragilità della (parzialmente abortita) proposta di reintrodurre una tassazione della rendita
catastale degli immobili sfitti si vedeva anche
dalla sua timidezza, riguardando solo il 50%
della rendita catastale. La giustificazione basata
sulla possibilità di evasione è in un certo senso
patetica per le capacità pubbliche di controllo
del territorio, perché presuppone l’incapacità di
controllare gli affitti in nero, ripiegando sulla
soluzione di seconda scelta, basata sulla tassazione di tutti gli immobili sfitti, almeno per un
pochino. Allora, già che ci siamo, mi chiedo
perché non tassare almeno per un pochino anche
le prime case, sul presupposto dell’impossibilità
di controllare chi, mantenendovi la residenza,
affitta una stanza a uno studente. In realtà l’unica giustificazione del provvedimento era forse
un inasprimento di tassazione patrimoniale, pro-
416
4/2013
pinata in forma reddituale. La seconda casa viene tenuta sfitta solo per passarci un mese d’estate? Oppure perché la si vuole vendere o non ci
si mette d’accordo tra gli eredi, oppure perché
vi risiedono i suoceri (5)? Bene, allora sei ricco,
e quindi puoi pagare una imposta patrimoniale,
cosa che già avviene con la stratosferica aliquota ordinaria IMU. Ma non basta, perché aggiungiamo un’ulteriore tassazione del 50% della
rendita catastale ai fini IRPEF. È bene che il
provvedimento, all’inizio, sia abortito, ma con
le proposte estemporanee che girano, come
quella commentata da Muraro su Lavoce.info,
di tassazione ICI delle prime case con oltre 750
euro di rendita (6), non c’è da stare tranquilli.
La fame di gettito è tanta, ed è comprensibile,
ma deve essere soddisfatta attraverso aliquote e
detrazioni, non alterando la logica della determinazione della ricchezza ai fini tributari. La
strada maestra per la razionalizzazione del settore non è la Service tax, che pare una scatola
vuota per prendere tempo, ma la reintroduzione
dell’IMU prima casa, con un aumento delle detrazioni, che era la soluzione più logica, sin dall’inizio, per tener conto della doppia natura della prima casa, come bene di investimento e come bene di uso personale. La strada maestra è
l’aumento della franchigia «prima casa» per tener conto in modo più sostanzioso della componente di autoconsumo, rispetto a quella di investimento patrimoniale, che tuttavia sussiste. Dopodiché, se per una sudditanza politica agli slogan, la tassazione della prima casa, sia pure con
i correttivi suddetti, è un tabù, il legislatore può
Note:
(4) L. Einaudi, Corso di Scienza della Finanza, 1916, Terza Edizione, Edizione della rivista «La Riforma Sociale», Torino, pagg. 380381, citato da Liberati Gastaldi, Il pasticcio della tassazione immobiliare, in ww.lavoce.info.
(5) Si ricordi che anche questa è una seconda casa, nella demenziale definizione IMU sul punto. Che in questo momento la legge
di stabilità si propone di rivedere. Ci riserviamo di approfondire
in che modo.
(6) Con l’effetto di far pagare «su tutto», sia pure con la detrazione, chi avesse una rendita di un euro maggiore. Vedi G. Muraro, «Se il PD propone una ingiustizia», in www.lavoce.info.
Redditi
fondiari
anche ricorrere a mezzucci come quello per ora
abortito. Cioè la tassazione figurativa reddituale
della rendita catastale. Noi però, sul piano della
determinazione della ricchezza, siamo liberi di
definirla concettualmente come «imposta patrimoniale» in chiave reddituale.
Dove cioè il carico tributario è maggiore per chi
ha redditi IRPEF più elevati.
La soluzione che per ora si profila va oltre, in
quanto vi si inserisce un «sostegno alle locazioni di immobili urbani», attraverso una penalizzazione di chi tiene sfitti appartamenti che, collocandosi nel suo Comune di residenza, non sono verosimilmente «tenuti a disposizione». Abbiamo già indicato che i veri modi per rilanciare
le locazioni passano attraverso la tutela effettiva
del diritto di proprietà. L’aspetto fiscale è tutto
sommato secondario, ma ne riparleremo.
4/2013
417
IPSOA ti offre il più completo, prestigioso e aggiornato catalogo in materia di revisione:
libri, e-book e corsi e-learning accreditati per commercialisti e per revisori degli enti locali.
Per affrontare con sicurezza e semplicità la tua professione grazie all’autorevolezza
dei migliori esperti e all’approccio operativo basato su:
Check list
Formule
Y77EF FI
Dalla revisione legale dei conti
alla revisione per gli enti locali
Schemi e tabelle
Ecco alcuni esempi del catalogo editoriale:
Libri
Il revisore
r
degli enti locali di Pozzoli, Borghi
Manuale del revisore
r
legale di Pesenato
Sindaco e revisore di società di Traversi, Bompani, Dei, Sorignani
E-book
Verbali per il controllo e la revisione legale
Revisione legale le novità
E per la tua formazione…
un ricco catalogo
di corsi E-learning
Contattaci per saperne di più:
www.shopwki.it/tuttorevisione
www.ipsoa.it/agenzie
02 82476794
Operazioni
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
straordinarie
Conferimenti di partecipazioni
da persone fisiche e neutralità fiscale:
la «continuità» non è agevolativa
di Valentina Perrone, Raffaello Lupi
La mancanza di ragioni sistematiche per considerare redditualmente rilevanti le partecipazioni
ricevute in cambio di conferimenti viene confermata - sul piano teorico sistematico, che interessa a Dialoghi - dalle modificazioni normativo-interpretative sugli «scambi di azioni» (art. 177
del T.U.I.R.). Tali disposizioni, pur rivelatrici di un principio generale nella determinazione della
ricchezza, non hanno forza espansiva rispetto all’(ingiustificato) principio di realizzazione dell’art. 9 del T.U.I.R., ma neppure possono essere interpretate restrittivamente, seguendo imprecisate fobie antielusive, come inizialmente aveva fatto l’Agenzia delle entrate, con una risoluzione
a suo tempo commentata su Dialoghi, poi revocata, senza neppure farne menzione, dalla successiva circolare in commento. È quindi distorsivo elevare a criterio sistematico il realizzo a valore
normale rispetto alla «continuità» di cui all’art. 177. Il cd. regime del «realizzo controllato» non
riguarda finalità extrafiscali del tributo, ma un aspetto strutturale della determinazione della ricchezza, altrimenti tassata prematuramente, ad uno stadio «potenziale».
La strada verso la (incompleta) neutralità dei conferimenti partecipativi
qualificati tra persone fisiche
Valentina Perrone
Di neutralità siamo abituati a parlare per operazioni intercorse «tra imprese», anche se i problemi concettuali di tassazione di «ricchezza non
monetizzata», in assenza di variazioni del valore
fiscale dei beni, possono emergere anche per
operazioni poste in essere da persone fisiche. Ivi
compreso il capitalismo familiare italiano (1),
per le operazioni effettuate da soci di riferimento
di aziende costituite in forma di società di capitali. Spesso, infatti, la razionalizzazione e la riorganizzazione degli assetti proprietari nell’ambito
delle famiglie e dei passaggi generazionali possono richiedere che la circolazione dei pacchetti
azionari avvenga a livello superiore, ovvero «lavorando da sopra»: quando il socio persona fisica, senza monetizzare la partecipazione, ne effettua una (ri)allocazione in altra struttura proprietaria, si pongono problemi del tutto analoghi a
quelli descritti a proposito della neutralità nell’ambito dei conferimenti effettuati tra imprese.
Per diverso tempo, tuttavia, tali aspetti non hanno trovato esplicita regolamentazione in quanto
la riforma delle operazioni di riorganizzazione
societaria, realizzata con il D.Lgs. n. 358/1997,
era stata originariamente prevista per le sole
operazioni poste in essere tra imprese.
Occorre infatti rilevare in proposito come l’intero impianto del D.Lgs. n. 358/1997 sia nato per
dare attuazione ai principi e criteri direttivi di
una legge delega (la n. 662/1996) che si proponeva di disciplinare con norme tendenzialmente
di favore l’intero settore delle vicende straordinarie dell’impresa. In tale contesto, le implicazioni sulla fiscalità dei soci, coinvolti solo di riflesso in tali operazioni, non hanno costituito
Valentina Perrone - Dottore di ricerca in Diritto tributario presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma e Avvocato in Roma
Nota:
(1) Cfr. R. Lupi, Manuale giuridico di scienza delle finanze, DIKE,
2012, cap. 6, pag. 226 ss.
4/2013
419
Operazioni
straordinarie
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
oggetto di apposita regolamentazione da parte
del legislatore delegato, verosimilmente anche
per via della contestuale presenza di un’altra
specifica delega in materia di riordino della tassazione dei redditi diversi e dei capital gains,
che avrebbe dovuto trovare attuazione in sede di
emanazione del relativo decreto legislativo.
Tanto è vero che il cd. scambio di azioni tramite
conferimento, inizialmente disciplinato dall’art.
5 comma 2, del D.Lgs. n. 358/1997 e le cui disposizioni sono state poi integralmente recepite
dall’art. 177, comma 2, del T.U.I.R., non riguardava in un primo momento chi agiva a titolo
«privato».
Solo successivamente l’ambito applicativo del
suddetto regime è stato esteso - ad opera del
D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 - anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori, allo scopo di rimuovere la divergenza
esistente tra normativa domestica e normativa
comunitaria, che non prevedeva alcuna limitazione quanto allo status (di imprenditore o meno) dei soci scambianti. Sono state in tal modo
accolte le argomentazioni di quell’attenta dottrina che, nel rilevare l’ingiusta penalizzazione derivante dall’originaria formulazione dell’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. n. 358/1997 per i soci non
imprenditori, ne aveva caldeggiato l’applicazione analogica anche nei confronti di tali soggetti
(2). Applicazione analogica che appariva pienamente giustificata sul piano concettuale in forza
della considerazione, sulla quale torneremo più
diffusamente in seguito, per cui il fatto che gli
scambi di partecipazioni potessero avvenire in
neutralità (rectius senza generare alcuna differenza imponibile in capo al conferente e senza
implicare il riconoscimento in capo alla conferitaria di valori fiscali più elevati) non rispondeva
ad alcuna logica agevolativa, qualificandosi,
piuttosto, come un fenomeno strutturale, in
quanto conseguenza immediata e diretta, sul piano della determinazione della ricchezza, della
simmetria tra la posizione fiscale della conferitaria e quella della conferente. Simmetria peraltro
esplicitamente avvalorata dalla possibilità per la
conferente di dedurre le minusvalenze eventualmente realizzate a seguito dello scambio.
L’art. 177, comma 2, del T.U.I.R., com’è noto,
delinea un regime fiscale ad hoc per gli scambi
420
4/2013
di partecipazioni domestici, vale a dire per quelle operazioni tramite cui la società conferitaria
acquisisce il controllo di diritto, ex art. 2359,
comma 1, n. 1, c.c., della società le cui partecipazioni sono «scambiate».
Il «realizzo controllato»
per la valorizzazione delle partecipazioni
ricevute a seguito del conferimento
Più nel dettaglio, in base all’art. 177, comma 2,
ove ricorrano specifici requisiti, le azioni o quote
ricevute in cambio dal conferente sono valutate
(ai fini della determinazione del reddito di tale
soggetto) in base alla corrispondente quota delle
voci di patrimonio netto formato dalla società
conferitaria a seguito del conferimento medesimo.
A rigore, dunque, la norma in esame, più che
prevedere un regime di neutralità, introduce in
realtà un peculiare criterio per la valorizzazione
delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento; si tratta di un sistema di «realizzo controllato», attraverso cui è possibile «manovrare»
l’aumento di capitale del conferitario, che costituisce figurativamente il corrispettivo del «conferimento realizzativo». Laddove, infatti, il valore della partecipazione iscritto dal conferitario
risulti superiore all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata, generando un incremento di patrimonio netto, l’operazione in esame comporterebbe l’emersione
di una plusvalenza in capo al conferente; viceNota:
(2) Per un’ampia riflessione sul tema cfr. D. Stevanato, «Il regime
dei soci non imprenditori negli scambi azionari domestici tra incuria del legislatore ed interpretazione analogica», in La fiscalità
delle operazioni straordinarie d’impresa, Milano, 2002, pag. 346 ss. A
sostegno dell’interpretazione analogica, in particolare, l’Autore
ha osservato, da un lato, l’impossibilità di qualificare l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 358/1997 come norma agevolativa in senso
tecnico, giacché non sottraeva gli scambi di partecipazioni domestici realizzati tramite conferimento dal novero dei conferimenti
suscettibili di originare plusvalenze tassabili, né disponeva un regime eventualmente più mite per le plusvalenze eventualmente
realizzate a titolo oneroso, e ha segnalato, dall’altro, come dalla
stessa relazione governativa al D.Lgs. n. 358/1997 emergesse che
l’esclusione dei soggetti non imprenditori dal regime dello scambio di partecipazioni (tramite conferimento) non fosse ancorata
ad alcuna ragione di ordine sostanziale, ma fosse dipesa, piuttosto, da formalistiche esigenze di tecnica legislativa (ovvero dalla
circostanza che il trattamento fiscale dei soggetti non esercenti
attività d’impresa era oggetto di specifica delega e sarebbe stato
affrontato in sede di emanazione del relativo decreto legislativo).
Operazioni
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
straordinarie
versa, si realizzerebbe contabilmente una minusvalenza nell’ipotesi in cui, per effetto del conferimento, il conferitario aumenti il proprio patrimonio netto ma per un ammontare inferiore al
valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita.
L’operazione contabilmente non è destinata a
generare alcuna plusvalenza o minusvalenza solo qualora l’incremento di patrimonio netto effettuato dal conferitario risulti pari all’ultimo
valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite presso il conferente. Il conferitario rimane quindi in una certa misura «arbitro»
del realizzo controllato: gli scambi di partecipazioni possono allora avvenire in neutralità, vale
a dire, come sopra detto, senza l’emersione di
alcuna differenza imponibile in capo al conferente e senza implicare il riconoscimento in capo al conferitario di valori fiscali più elevati rispetto a quelli esistenti presso il conferente (3).
Tale neutralità, è bene ribadirlo, non assume tuttavia alcuna valenza agevolativa ma, garantendo
una perfetta simmetria tra la posizione fiscale
del conferente e quella del conferitario, denota
piuttosto carattere tipicamente strutturale.
Che si tratti di un fenomeno strutturale appare
evidente ove si consideri che il sistema del «realizzo controllato» rende possibile l’identità tra
«valori fiscali» e «valori civili», mentre nel conferimento neutrale di aziende questa divaricazione «civile-fiscale» tendenzialmente si verificava. Qui invece il valore civilisticamente iscritto dal conferitario diventa il parametro di determinazione della componente reddituale realizzata dal conferente. Si tratta, dunque, di operazioni più «simmetriche» che «neutrali», come confermano, da un lato, la simmetria tra l’assoggettamento ad imposizione di una plusvalenza da
conferimento e il riconoscimento in capo al conferitario di maggiori valori delle partecipazioni
ricevute, suscettibili di generare maggiori deduzioni future, e dall’altro, la simmetria tra la
mancata tassazione della suddetta plusvalenza in
capo al conferente e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti presso il conferitario.
sente di sgombrare il perimetro concettuale nel
quale ci muoviamo da un equivoco di fondo, e
cioè dalla tesi secondo cui il conferimento in società sarebbe un’operazione ontologicamente
«realizzativa», che trae origine, verosimilmente,
da una non troppo comprensibile assimilazione
(peraltro in larga parte attualmente superata) del
conferimento con la cessione a titolo oneroso.
Valorizzando la sostanza economica del conferimento di partecipazioni, infatti, salta agli occhi
che il conferente non monetizza nulla e neppure
ottiene beni dotati di un proprio valore intrinseco: riceve, invero, non un aliud pro alio, ma
«pezzi di carta» (i titoli azionari o partecipativi)
rappresentativi a loro volta di un differente bene: il patrimonio della conferitaria (4).
È appena il caso di evidenziare che tali considerazioni valgono, a maggior ragione, se l’operazione viene posta in essere all’interno di un
gruppo preesistente: è infatti evidente come in
un contesto di questo tipo il conferimento si riduca ad una mera riorganizzazione sul piano
giuridico-contabile, ad una razionalizzazione
degli assetti proprietari ed organizzativi, a fronte
delle quali appare quantomeno incongruo ravvisare la formazione di nuova ricchezza da assoggettare a imposizione.
Così stando le cose, non sembrano sussistere ragioni, sul piano sistematico, per attribuire rilevanza reddituale alle partecipazioni ricevute in
cambio per effetto di conferimenti, laddove tali
operazioni avvengano in continuità dei valori.
Non pare revocabile in dubbio, infatti, che l’assenza di rivalutazioni, oltre a garantire il rispetto
del principio di simmetria, esclude categoricamente il rischio di salti di imposta.
L’inesistenza di ricchezza reale tassabile
nel conferimento di società
L’approccio interpretativo appena delineato con-
Note:
(3) In tal senso cfr. D. Stevanato, «Scambi di partecipazioni ed elusione tributaria», in Corr. Trib. n. 2/2009, pag. 148.
(4) Cfr. R. Lupi, Profili tributari della fusione di società, Padova, 1989.
Il «realizzo controllato»
come regola di carattere generale
Si può allora fondatamente ritenere, coerentemente con le considerazioni che precedono, che
il «realizzo controllato» dovrebbe rappresentare
una regola di carattere generale per tutti i tipi di
conferimento - compresi quelli posti in essere da
persone fisiche - quale soluzione atta a ripristi-
4/2013
421
Operazioni
straordinarie
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
nare l’identità dei valori fiscalmente riconosciuti
in capo al conferitario con quelli da riconoscere
in capo al conferente, salvaguardando nel contempo la libertà di quest’ultimo di iscrivere le
partecipazioni ricevute in base ai loro valori correnti (5); tale criterio tuttavia ha trovato espresso recepimento sul piano normativo solo in relazione agli scambi di partecipazioni di cui all’art.
177, comma 2, del T.U.I.R., le cui disposizioni ancorché espressive di un principio generale sul
piano della determinazione della ricchezza - risultano però prive di forza espansiva rispetto al
principio di realizzo ex art. 9 del T.U.I.R.
Al riguardo non può non osservarsi come proprio tale ultima norma, nel sancire la regola del
realizzo al valore normale, implichi in buona sostanza l’assoggettamento a imposizione di una
ricchezza meramente potenziale: la plusvalenza
da conferimento parametrata al valore normale,
infatti, è indice di una capacità economica solo
virtuale talché, per far fronte all’onere impositivo derivante dall’operazione, il conferente (che,
come detto, si limita a ricevere «pezzi di carta»
in cambio delle partecipazioni conferite) dovrebbe necessariamente attingere alle proprie risorse economiche preesistenti (6).
Appare quindi di tutta evidenza come il meccanismo impositivo delineato dall’art. 9 del
T.U.I.R., comporti un’anticipazione della tassazione rispetto ai ritmi naturali che dovrebbero
contraddistinguerla, e che imporrebbero di assoggettare a prelievo solo la ricchezza che è stata effettivamente monetizzata, in occasione di
fattispecie realizzative.
Questa circostanza, se opportunamente valorizzata, non può che indurre a riconoscere come la
scelta di porre in essere uno scambio di partecipazioni mediante conferimento, con conseguente applicabilità dell’art. 177, comma 2, del
T.U.I.R., non implichi alcun aggiramento di un
principio sovraordinato di tassazione al valore
normale della partecipazione conferita, costituendo il regime previsto da tale ultima norma e
quello di cui all’art. 9 del T.U.I.R., soluzioni alternative di pari grado.
Sarebbe quindi del tutto fuorviante, sul piano
della determinazione della ricchezza, elevare
l’art. 9 a criterio sistematico, mortificando la valenza della regola di cui all’art. 177, comma 2,
422
4/2013
del T.U.I.R., e relegandola a norma «derogatoria» e dunque eccezionale, posto che quest’ultima - per quanto appena detto - dovrebbe invece
trovare applicazione in via naturale.
La norma sullo scambio di partecipazioni, in altri termini, accogliendo esplicitamente il criterio
del realizzo fondato sull’incremento del patrimonio contabile deliberato dal conferitario, non
è catalogabile come norma agevolativa in senso
tecnico, posto che né sottrae queste operazioni
dal novero dei conferimenti suscettibili di generare plusvalenze imponibili, né tantomeno introduce un più mite regime impositivo per le plusvalenze eventualmente realizzate.
In linea con tale ricostruzione, non possono che
ritenersi condivisibili le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate nella circolare 17
giugno 2010, n. 33/E (7) con la quale non solo
ha fornito, superando il precedente orientamento,
una diversa interpretazione dell’ambito applicativo soggettivo della disciplina di cui all’art. 177,
comma 2, del T.U.I.R., ma ha altresì prospettato
una rivisitazione del rapporto intercorrente tra
quest’ultima norma e il regime del realizzo al valore normale di cui all’art. 9 del T.U.I.R.
In particolare, quanto al primo aspetto, si rammenta che in base alla precedente impostazione
(8), peraltro non supportata dalla lettera della
norma né - tantomeno - sul piano sistematico, le
azioni ricevute in cambio dal conferente la partecipazione non avrebbero potuto essere sempre fiscalmente valorizzate in base all’importo iscritto
dalla conferitaria, ma avrebbero potuto esserlo
solo in presenza di aggregazioni tra compagini
sociali non appartenenti al medesimo gruppo societario, posto che altrimenti siffatte operazioni
sarebbero state elusive per violazione di un ineffabile spirito «di realizzatività dei conferimenti»
Note:
(5) Cfr. in tal senso R. Lupi, «Conferimenti in natura senza regole,
tra salti d’imposta e doppie imposizioni», in Rass. Trib., 1995, pag.
1224 ss.
(6) Sul punto si veda D. Stevanato, «Scambi di partecipazioni ed
elusione tributaria», cit., loc. cit., pag. 151.
(7) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(8) Espressa dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 22 marzo
2007, n. 57/E, in Dialoghi dir. trib. n. 3/2007, pag. 346, con commenti di A. Bampo, D. Stevanato, A. De Pra e in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA e poi confermata anche nella risoluzione 18 novembre
2008, n. 446/E, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
Operazioni
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
oltre che della presunta ratio dell’art. 177, comma 2, del T.U.I.R., individuata dall’Agenzia
nell’intento di favorire le aggregazioni tra entità
societarie diverse. Nella più recente pronuncia
del 2010, invece, l’Amministrazione finanziaria
ha riconosciuto l’applicabilità del regime di realizzo controllato «tanto tra soggetti indipendenti
quanto all’interno di gruppi societari», legittimandone a pieno titolo l’utilizzo anche in un’ottica esclusivamente riorganizzativa, oltre che al
fine di promuovere nuove acquisizioni.
Tale ultima risoluzione, in realtà, più che testimoniare un’estensione dell’ambito applicativo
della norma, ha sancito la rimozione di una limitazione palesemente ingiustificata e pare avallare, nel contempo, la tesi sopra prospettata secondo cui il realizzo controllato costituirebbe il criterio ordinario deputato a presidiare la neutralità
«indotta» di tutti i conferimenti, anche delle persone fisiche (l’applicabilità nei confronti delle
quali - è bene precisarlo - è stata peraltro espressamente sancita dalla medesima circolare, seppure in un altro passaggio).
Quanto al secondo aspetto, strettamente collegato al primo, è stato apertamente riconosciuto
dall’Agenzia delle entrate come l’art. 177, comma 2, del T.U.I.R. delinei una peculiare disciplina che proprio in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere riorganizzativo si pone
su un piano di pari dignità con la disciplina di
cui all’art. 9 del T.U.I.R., trovando applicazione
alternativa rispetto ad essa ove ricorrano i presupposti di legge.
Tale apertura va accolta con favore soprattutto
alla luce delle implicazioni che essa comporta,
in termini generali, sul piano della corretta determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Da un lato, infatti, essa denota una presa di distanza «ufficiale» (provenendo dai competenti
organi dell’Amministrazione finanziaria) da
un’imprecisata idea di realizzatività dei conferimenti che si trascina da decenni senza che si
comprendano le ragioni su cui si basa e, dunque,
l’acquisita consapevolezza dell’inesistenza di
nuova ricchezza da assoggettare ad imposizione;
nel contempo risulta in linea anche con la tendenza evolutiva in punto di disciplina legislativa
dei conferimenti, i quali (9) permangono in linea
generale nel campo della neutralità (id est della
straordinarie
non emersione di materia imponibile), seppure
subordinatamente al ricorrere di determinate
condizioni variamente delineate dal legislatore a
seconda del tipo di conferimento posto in essere.
Dall’altro lato, inoltre, questa lettura appare
coerente anche con quella che è la sostanza economica dell’operazione la quale, si ribadisce,
lungi dal generare nuova ricchezza, consente di
mantenere le plusvalenze sulle partecipazioni in
uno stato di latenza, inidonee ad essere autonomamente apprezzate fino a quando non divengono oggetto di un successivo atto di conversione
in denaro.
Ciò dimostra come, semmai, possa ravvisarsi
«sistematicità» nella neutralità, seppure indotta
(perché condizionata alle scelte contabili del
conferitario), piuttosto che nella realizzatività di
cui all’art. 9 del T.U.I.R.
Ripristinato correttamente il rapporto tra il regime di cui all’art. 177, comma 2, del T.U.I.R. e
quello di cui all’art. 9 del T.U.I.R. in chiave paritetica, vale la pena aggiungere un’ulteriore considerazione sul tema in esame. Si ritiene, infatti,
che una volta rimossa la dicotomia tra norma di
sistema e norma agevolativa/derogatoria (rispetto ad un diverso criterio altrimenti operante), appaiono facilmente superabili anche eventuali
censure di elusività in relazione ad operazioni di
scambi di partecipazioni ai sensi dell’art. 37-bis
del D.P.R. n. 600/1973, la cui applicabilità è stata peraltro evocata dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 33/E del 2010 quale strumento per disconoscere vantaggi indebiti eventualmente conseguiti attraverso tali operazioni.
Va da sé, infatti, che se il regime del realizzo
controllato rappresenta solo un differente modello fiscale per la valorizzazione dei conferimenti e, come tale, una scelta assolutamente legittima, al punto che l’opzione per tale disciplina viene ad assumere un carattere del tutto fisiologico, il conseguimento di un vantaggio fiscale
indebito debba essere escluso in radice, a prescindere da qualsivoglia analisi sulle finalità
perseguite dal contribuente.
Nota:
(9) A partire dall’attuazione della legge delega n. 662/1996 e,
quindi, dapprima con il D.Lgs. n. 358/1997 e poi successivamente
con le modifiche apportate al T.U.I.R. dal D.Lgs. n. 344/2003, che
ne ha in linea di massima confermato l’impianto.
4/2013
423
Operazioni
straordinarie
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
Dallo scambio di azioni una conferma: la neutralità non è agevolativa
Raffaello Lupi
L’eliminazione di una penalizzazione
ingiustificata non è una «apertura»
È un’altra questione di diritto, sul regime di ricchezza palese o comunque registrata, che assorbe tempo e genera patemi d’animo, mentre resta
uccel di bosco quel 20% di prodotto interno lordo occulto, che sfugge alla tassazione attraverso
le aziende, e dovrebbe essere valutato attraverso
l’intervento degli Uffici. Sono passati tre anni
dalla circolare 17 giugno 2010, n. 33/E, ma Dialoghi non è una rivista di novità normative,
quanto di sistematizzazione dei concetti, e ci pare che il suo valore concettual-sistematico, cioè
la neutralità delle operazioni di conferimento
dovesse essere ancora messo in risalto. La circolare comporta, senza fare troppo clamore (10),
una sostanziale revoca della precedente risoluzione del 2007, già commentata criticamente su
Dialoghi, secondo cui la neutralità degli scambi
di partecipazioni avrebbe avuto carattere agevolativo, in un’ottica di circolazione delle partecipazioni societarie, per la modifica delle compagini azionarie, e quindi sarebbe stato elusivo un
conferimento neutrale di partecipazioni all’interno della medesima compagine societaria. Era
stato quindi, consapevolmente o inconsapevolmente, scambiato per «agevolativo» un regime
strutturale di realizzo controllato, che si poneva
invece a monte, cioè ancora sul piano della determinazione della ricchezza ai fini tributari. La
revoca di queste precedenti posizioni viene fatta
passare, come indicato da Valentina Perrone, come una «precisazione», nel quadro di una «apertura» alle esigenze di mobilità della ricchezza
(vedi il comunicato stampa pubblicato anch’esso
in calce), che invece riguarda solo la coerenza
logica nella determinazione dei presupposti di
imposta. Non si tratta cioè di un intervento diretto a conseguire un obiettivo economico di politica tributaria, ma semplicemente a realizzare
una determinazione degli imponibili logicamente corretta quanto a momento impositivo. Sotto
certi profili, l’eliminazione di una chiusura ad
una corretta determinazione della ricchezza viene fatta passare come «apertura» alle esigenze
424
4/2013
della società, sul piano degli assetti proprietari e
della circolazione delle partecipazioni. In particolare, la presunta «elusività» del realizzo controllato in presenza di una pluralità di soci ostacolava le operazioni di passaggio generazionale,
costringendo a creare nuovi contenitori societari
«verso il basso», cioè conferendo l’azienda dalla
società, diciamo così «di famiglia», in una nuova società da lei posseduta. Erano invece precluse le creazioni di nuovi contenitori societari
«verso l’alto», con il socio che conferiva la partecipazione in una nuova società; c’era quindi
un ostacolo fiscale alla creazione, con meno ripercussioni sulla società operativa, di un nuovo
filtro intermedio rispetto alla proprietà tra l’azienda, la società operativa e la sua persona.
Si trattava di un caso in cui una disposizione, ed
una interpretazione amministrativa, erronea sotto il profilo della determinazione della ricchezza, non giovava al Fisco, ma nuoceva al sistema
economico sotto il profilo extratributario. La rimozione di questo ostacolo non è stata, quindi,
«una apertura», come la definisce il comunicato
stampa, ma l’eliminazione di una chiusura.
L’occasione ci ricorda così la distinzione tra le
disposizioni sulla determinazione della ricchezza, concettualmente precedenti, e quelle agevolativo-punitive, concettualmente successive. Per
comprendere la distinzione qualche volta occorre fare degli sforzi, in quanto il legislatore, nel
suo pragmatismo politico, può distorcere la determinazione della ricchezza con una finalità
agevolativa, non apertamente confessabile. È
una sorta di ipocrisia normativa, in cui una agevolazione viene mascherata con una giustificazione logico-sistematica, condita poi da riferimenti di politica tributaria.
Nota:
(10) Anzi, affermando che la soluzione viene indicata «a maggior
precisazione» di quanto indicato nelle interpretazioni sostanzialmente revocate. È un riflesso della tendenza fisiologica delle istituzioni a mantenere una coerenza di fondo, anche quando nella
sostanza giustamente smentiscono precedenti interpretazioni
non difendibili sul piano logico.
Operazioni
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
Un altro colpo al feticcio
della realizzatività dei conferimenti
Sul piano della determinazione della ricchezza,
il principio base è quello dell’effettività, secondo cui non si dovrebbe imporre al contribuente
di indebitarsi per pagare le imposte. L’esigenza
di pagare queste ultime solo quando si sono avute a disposizione le risorse economiche per farlo
si porta dietro il principio di cassa, che però deve essere contemperato con esigenze di precisione, espresse soprattutto dal principio di competenza nel reddito di impresa, dove si presuppone
che ricavi e costi non monetizzati si compensino, e che siano trascurabili le situazioni in cui i
primi siano prevalenti (si pensi ai crediti immobilizzati verso la PA), con un reddito positivo,
ma senza liquidità per pagare le imposte. Una
tassazione di redditi «non monetizzati», e neppure realizzati, si giustifica per esigenze di coerenza logica. Ad esempio, l’esigenza di evitare
vuoti di imposta giustifica la tassazione sulle
plusvalenze d’impresa in caso di perdita della
residenza in Italia, o di perdita dello status di
impresa (trasformazione in società semplice).
Anche la possibilità, per la società beneficiaria
di beni conferiti in natura, di valorizzarli fiscalmente al relativo valore normale, giustifica una
plusvalenza o minusvalenza in capo alla conferente, ma il venir meno dei valori riconosciuti
alla conferitaria giustifica la continuità di valori
fiscali in capo alla conferente. Per questo la neutralità dovrebbe essere la regola in materia di
conferimenti, e ci si deve chiedere perché resista
il feticcio del realizzo a valore normale secondo
l’art. 9 del T.U.I.R.
Vediamo di capire, sul piano teorico, quali forze
di inerzia si collocano dietro una resistenza ultradecennale ad un criterio così intuitivo come
quello della neutralità. Fino al punto da farlo
sembrare, alle prime risoluzioni ministeriali riportate in calce, addirittura come un criterio
agevolativo.
Il feticcio del bilancio
e il realizzo a valore normale
Nella dottrina tributaristica la natura non realizzativa dei conferimenti è affermata in modo sostanzialmente omogeneo, anche se si rivolgono
critiche al regime di «realizzo controllato», che
straordinarie
tassa la conferente nella misura in cui la conferitaria ottiene valori fiscalmente riconosciuti più
elevati (11). Dietro c’è piuttosto una tendenza
verso l’uguaglianza tra valori fiscalmente riconosciuti e valori di bilancio, ed una ritrosia ancestrale ad accettare una divaricazione tra le due
cifre. Siccome la conferitaria deve iscrivere, secondo tale prospettiva, i valori ricevuti ai valori
correnti, questi valori devono esserle riconosciuti anche agli effetti tributari. Da qui deriva
l’esigenza sistematica di tassare la società conferente in base al valore normale dei beni conferiti, e da qui nasce la rilevanza reddituale delle
plusvalenze e minusvalenze da conferimento.
Cioè il feticcio di cui abbiamo parlato nel titolo
di questo paragrafo.
I sostenitori di questa tesi sapevano bene di
esporsi all’obiezione secondo cui la conferente,
non avendo monetizzato alcunché, deve indebitarsi per pagare le imposte. La risposta è stata,
negli ultimi decenni del secolo scorso, l’auspicio
di normative «di favore» basate sostanzialmente
su rivalutazioni in franchigia di imposta, come
quella contenuta nella legge n. 576/1975, poi prorogata e successivamente riproposta in varie forme. Appare chiara, quindi, la strumentalità della
concezione tecnica, per chiedere una agevolazione in sede politica. Un regime strutturale irrazionalmente penalizzante, e non utilizzato da alcuno,
era il presupposto per richiedere disposizioni altrettanto irrazionalmente agevolative (12).
Si era creato quindi un impasse, che distorceva
la determinazione della ricchezza ai fini tributari, in cui i conferimenti di beni fortemente plusvalenti comportavano il realizzo delle plusvalenze latenti, oltretutto in modo incontrollato
(vista la stima in base al valore normale). Per
questo nessuno poneva in essere conferimenti,
ed ancora nessuno ne pone in essere, ove non riNote:
(11) Su queste critiche cfr. G. Corasaniti, Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società, Padova, 2008, pag. 237 ss.
(12) Accampando anche inesistenti rischi di «doppia tassazione»,
la cui inesistenza emergeva già chiaramente in R. Lupi, D. Stevanato, La fiscalità delle operazioni straordinarie di impresa, Milano, 2002,
pag. 48 ss. È passato quasi un quarto di secolo da quando, in base
al mito della uguaglianza tra valori fiscali e valori di bilancio, si
cercò di far passare la rivalutazione gratuita a fronte dei disavanzi
da concambio. Per la relativa storia vedasi R. Lupi, Profili tributari
delle fusioni di società, Padova, 1989, pag. 222 ss.
4/2013
425
Operazioni
straordinarie
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
guardino aziende o partecipazioni, rientranti nel
regime specifico del D.Lgs. n. 358/1997, poi
trasfuso nel T.U.I.R.
Anche se il «realizzo controllato» di cui allo
scambio di azioni è per certi versi un ibrido
(13), esso pragmaticamente consente di effettuare i conferimenti «gestendo» la variabile fiscale,
senza essere ostaggio di imprevedibili accertamenti di valore sulla conferente. Il regime di
realizzo controllato conferma che l’unica giustificazione tributaria alla tassazione della conferente è il riconoscimento di maggiori valori fiscali alla conferitaria. Se si vuole, il realizzo
controllato è una concessione al preconcetto secondo cui i valori di bilancio a seguito del conferimento dovrebbero essere ripresi anche ai fini
fiscali. Il «realizzo pilotato» è una possibilità,
concessa a chi proprio tenga a questa uguaglianza; all’interno dei margini di stima del bene conferito è in questo modo possibile soddisfare al
tempo stesso esigenze civilistiche e fiscali con
un «realizzo controllato».
Incertezze sui conferimenti
e imposta sostitutiva: una diversa «ratio»
Le discussioni indicate al paragrafo precedente,
sulla «eccessiva onerosità» della tassazione ordinaria dei conferimenti e delle operazioni
straordinarie d’impresa, erano durate decenni,
ed avevano fatto da apripista a una imposta sostitutiva, dapprima eliminata con la riforma del
2004, e poi reintrodotta nel 2007. Quest’ultima
imposta ha invece una diversa spiegazione
nell’asimmetria temporale esistente, in tutte le
vendite di complessi aziendali, partecipazioni di
controllo o anche beni strumentali singoli, tra
imponibilità per il venditore e deduzioni fiscali
per i compratori, differite nel tempo su un arco
temporale più o meno lungo. L’imposta sostitutiva, con una aliquota ridotta rispetto a quella
ordinaria, serve a controbilanciare questa asimmetria tra l’esborso immediato (che grava sulla
vendita) ed il recupero di imposta futura (che
spetterà invece all’acquirente).
Alla stessa logica risponde la tassazione «rateizzata» delle plusvalenze, attualmente disciplinata
dall’art. 86 del T.U.I.R., che consente di suddividere le plusvalenze su beni strumentali in cinque quote costanti, da imputare nell’anno di realizzo e nei quattro successivi. Il requisito del
possesso triennale dell’azienda o dei beni ceduti
è una cautela antielusiva, che serve ad evitare
«cessioni a catena», a seguito delle quali l’intero
utile, tra società diverse, sarebbe soggetto alle
imposte sostitutive anziché alle ordinarie.
Nota:
(13) Come osserva G. Corasaniti, op. cit.
La risoluzione
Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, Risoluzione 22 marzo 2007, n.
57/E (stralcio)
(Omissis)
Fattispecie rappresentata
I Signori Omega Uno, Omega Due, Omega Tre e
Omega Quattro possiedono ciascuno una partecipazione del 25 per cento nella Holding di famiglia
ALFA S.p.a., società con sede legale in … e regolarmente iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 113 del D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.
La società istante detiene, a sua volta, una partecipazione del 28,9131 per cento nel capitale sociale
della Beta S.p.a., società con sede legale in ….,
426
4/2013
esercente l’attività di produzione e commercializzazione di compound di PVC.
La restante parte del capitale sociale della Beta
S.p.a. È suddivisa tra i quattro fratelli Omega, ciascuno con una partecipazione pari al 10,1087 per
cento, e altre persone fisiche, che complessivamente detengono una partecipazione pari al
30,6521 per cento.
(Omissis)
Soluzione interpretativa
In merito alle conseguenze fiscali dell’operazione,
gli interessati ritengono che il caso prospettato
Operazioni
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
rientri nella previsione di cui all’art. 177, comma
2, del T.U.I.R., per effetto del quale «le azioni o
quote ricevute a seguito di conferimenti in società,
mediante i quali la società conferitaria acquisisce
il controllo di una società ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono
valutate, ai fini della determinazione del reddito
del conferente, in base alla corrispondente quota
delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
Alla luce di ciò l’istante sostiene che, nella misura
in cui, a seguito di ciascun conferimento di azioni
della Beta S.p.a. nella conferitaria Alfa S.p.a., il
corrispondente incremento delle voci di patrimonio netto di quest’ultima sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle azioni BETA S.p.a. in capo ad ognuno dei soggetti conferenti:
a) l’operazione non determinerebbe emersione di
alcun reddito imponibile in capo ai soggetti conferenti;
b) il valore fiscale delle azioni della Alfa S.p.a. ricevute in cambio da ciascun soggetto conferente
sarebbe pari a quello delle azioni della Beta S.p.a.
dagli stessi conferite;
c) le azioni della Beta S.p.a., iscritte nell’attivo patrimoniale dalla conferitaria Alfa S.p.a., manterrebbero il medesimo valore fiscale originariamente riconosciuto in capo a ciascun soggetto conferente.
Inoltre, la società conferitaria precisa che, ricevuti
i conferimenti di azioni della Beta S.p.a., intende
aumentare il proprio capitale sociale ed iscrivere
una riserva sovrapprezzo azioni nel proprio patrimonio netto, previa relazione giurata ex art. 2343
del codice civile.
In conclusione, la società istante ritiene che l’operazione che intende porre in essere non comporta
l’emersione di alcun reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Parere dell’Agenzia delle entrate
(Omissis)
In riferimento all’istanza in esame si esprime il seguente parere.
Il comma 2 dell’art. 177 del T.U.I.R. stabilisce
che, qualora lo scambio di partecipazioni avvenga
a seguito di conferimenti in società, mediante i
quali la società conferitaria acquisisce il controllo
di diritto di un’altra, il reddito del soggetto conferente è determinato attribuendo alle azioni o quote
ricevute in cambio una valutazione in base alla
corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formate dalla società conferitaria per effetto del
conferimento stesso.
straordinarie
La norma in oggetto considera, quindi, lo scambio
di partecipazioni mediante conferimento come atto
realizzativo, facendo dipendere l’emersione di una
plusvalenza in capo al soggetto conferente dall’effettiva iscrizione da parte della società conferitaria
di un maggior valore rispetto all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
A differenza di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 177 del T.U.I.R. per lo scambio di partecipazioni tramite permuta, la disciplina recata dal comma 2 non costituisce un regime di neutralità fiscale, bensì un criterio di valutazione, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente,
delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento.
L’adozione di tale criterio può, tuttavia, comportare la non emersione di alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante qualora l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria
coincida con l’ultimo valore fiscale presso il soggetto conferente delle partecipazioni conferite.
La sostanziale neutralità fiscale delle operazioni di
cui al comma 2 dell’art. 177 del T.U.I.R. È, dunque, condizionata al comportamento contabile
adottato dalla società conferitaria.
Con modifica apportata dal decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 344/2003, il regime previsto dal comma 2 dell’art. 177 del T.U.I.R. È stato
esteso anche ai conferimenti effettuati da persone
fisiche non imprenditori e, pertanto, la società
istante ritiene che la fattispecie rappresentata ricada nell’ambito di applicazione della norma in oggetto.
In tal modo, procedendo la società conferitaria Alfa S.p.a. a un aumento del patrimonio netto in misura pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite, non si darebbe luogo all’emersione di alcuna plusvalenza fiscalmente imponibile in capo alle persone fisiche conferenti.
Si deve, però, osservare come il regime fiscale
previsto dal comma 2 dell’art. 177 si pone come
un una disciplina speciale rispetto alla disciplina
ordinaria di cui all’art. 9 del T.U.I.R. in base alla
quale i conferimenti in società devono essere valutati al valore normale.
La ratio della disposizione in commento è, tuttavia, quella di prevedere un regime agevolato per i
conferimenti che consentano alla società conferitaria di acquisire il controllo di un’altra società ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
Nella fattispecie rappresentata, si può osservare
4/2013
427
Operazioni
straordinarie
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
che il conferimento delle azioni della Beta S.p.a.
viene effettuato da quattro soci persone fisiche che
sono anche i soci della società conferitaria Alfa
S.p.a.
Non si ravvedono, quindi, le valide ragioni economiche in un’operazione che, secondo quanto prospettato nell’istanza, viene posta in essere al solo
scopo di consentire alla Holding di famiglia di acquisire il controllo della Beta S.p.a., essendo, di
fatto, tale controllo riconducibile, già prima dell’effettuazione del conferimento, ai quattro fratelli
Omega.
In altri termini, nella fattispecie de qua risulta violato lo spirito della norma di cui al comma 2 dell’art. 177 che è quello di favorire le aggregazioni
aziendali da parte della conferitaria allorquando la
stessa assuma ex novo il controllo della società
target.
L’operazione in oggetto appare, dunque, posta in
essere al solo fine di consentire ai quattro fratelli
Omega di effettuare il conferimento delle azioni
della Beta S.p.a. senza l’emersione di alcuna plusvalenza fiscalmente imponibile, sfuggendo così
alla tassazione a valore normale in aggiramento
della norma di cui all’art. 9 del T.U.I.R.
Sulla base delle suddette considerazioni il descritto conferimento, realizzato secondo le modalità illustrate, presenta, pertanto, evidenti profili elusivi
in quanto privo di valide ragioni economiche e posto in essere al solo fine di conseguire un indebito
risparmio fiscale disapprovato dal sistema.
Il testo integrale della risoluzione
oltre a essere disponibile
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA
si può richiedere a
[email protected]
www.ipsoa.it/dialoghionline
La circolare
Agenzia delle entrate - Direzione centrale entrate, Circolare 17 giugno 2010, n. 33/E
1. Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti
in merito alla disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, recata dall’art.
177, comma 2, del T.U.I.R.
2. Lo scambio di partecipazioni
mediante conferimento
L’art. 177, comma 2, del T.U.I.R. (1), disciplina lo
scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento attraverso cui la società conferitaria acquisisce (ovvero integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1, del
codice civile, della società le cui quote partecipative sono «scambiate».
Più in particolare, ricorrendo specifici requisiti, le
azioni o quote ricevute (in cambio dal soggetto
conferente) a seguito dei predetti conferimenti di
partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente stesso)
in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria
per effetto del conferimento medesimo.
La disciplina in commento (a differenza del modello degli scambi intracomunitari) non delinea un
428
4/2013
regime di neutralità fiscale delle operazioni di
conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. «regime a realizzo controllato»).
Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente
sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (i.e., aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto del conferimento).
In altre parole, l’aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria - connesso, a sua
volta, al valore di iscrizione della partecipazione da
parte della conferitaria medesima - per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in
Nota:
(1) «Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1,
del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale
o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in
base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto
formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».
Operazioni
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
capo al conferente, della partecipazione conferita,
comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria (i.e., l’aumento di patrimonio netto operato dalla medesima) e
l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata. Viceversa, nell’ipotesi in
cui la conferitaria iscrivesse la partecipazione ad
un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso il conferente (aumentando, pertanto, il
proprio patrimonio netto per un ammontare inferiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al
conferente, della partecipazione conferita), il conferente medesimo realizzerebbe una minusvalenza.
Applicando tale criterio può, quindi, non emergere
alcuna plusvalenza o minusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto,
l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla
società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore
fiscale - presso il socio conferente - delle partecipazioni conferite (cd. «neutralità indotta»).
L’imponibilità ovvero la sostanziale neutralità fiscale, in capo al conferente, delle operazioni di
conferimento disciplinate dal comma 2 dell’art.
177 del T.U.I.R. È, dunque, connessa al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
La norma in commento riproduce in buona parte la
disciplina contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 (abrogato dal D.Lgs. 12 dicembre
2003 n. 344), salvo le necessarie integrazioni dovute al coordinamento con i nuovi istituti della
riforma fiscale del 2004 (in particolare, con l’istituto della participation exemption) e l’estensione ad opera del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (cd.
«decreto correttivo IRES») - della disciplina in
commento ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori, al fine di eliminare la divergenza precedentemente esistente - per quanto
riguarda l’ambito soggettivo di riferimento - tra
normativa domestica e normativa comunitaria.
In riferimento all’estensione dell’ambito soggettivo, la relazione illustrativa al citato provvedimento legislativo del 2005 precisa che «in particolare,
con riguardo alle disposizioni che hanno, invece,
effetti sostanziali, si evidenzia la modifica introdotta all’art. 177, comma 2, che intende eliminare
la divergenza esistente, per quanto riguarda l’ambito soggettivo, tra normativa domestica e normativa comunitaria in tema di scambio di partecipazioni mediante conferimenti. Perseguendo tale
obiettivo, viene estesa la possibilità di effettuare
scambi domestici con i criteri di cui al citato comma 2 anche ai soggetti conferenti non esercenti at-
straordinarie
tività d’impresa, così come previsto dalla normativa concernente gli scambi comunitari».
La disciplina domestica, nel recepire quella comunitaria, non statuisce un regime di piena neutralità
per gli scambi azionari attuati mediante conferimento (a differenza di quelli attuati mediante permuta, disciplinati dal comma 1 del medesimo art.
177, del T.U.I.R.), bensì considera questi come atti
realizzativi, prevedendo un particolare criterio di
determinazione del «valore di realizzo» in capo al
conferente.
Tale differente trattamento trova la relativa spiegazione nella relazione illustrativa all’art. 5 del
D.Lgs. n. 358/1997, che così motiva l’impostazione prescelta con riferimento allo scambio attuato
tramite conferimento: «Con il comma 2, vista la
difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il
conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto
dalla conferitaria. La plusvalenza per il soggetto
conferente sarà conseguentemente determinata in
base alla differenza tra tale valore e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote».
In proposito, si osserva che sia la lettera della norma che la ratio della stessa [di matrice comunitaria (2)] si disinteressano degli eventuali rapporti
partecipativi o di gruppo sussistenti tra soggetti
conferenti e società conferitaria, con la conseguenza che - al ricorrere dei requisiti previsti - la disciplina recata dal comma 2, dell’art. 177 del
T.U.I.R. appare destinata tanto alle operazioni di
scambio che attuino un’aggregazione di imprese
tra soggetti terzi quanto alle operazioni realizzate
all’interno dello stesso gruppo per modificare gli
assetti di governance.
Infatti, giova osservare come con l’operazione di
scambio di partecipazioni in questione - al pari
delle altre operazioni di riorganizzazione aziendale - non si realizzi alcun salto d’imposta e venga
sempre rispettato il principio generale di simmetria tra le posizioni dei conferenti e quella della
conferitaria, da un lato, e quello di continuità dei
valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti
coinvolti, dall’altro, anche nell’ipotesi in cui la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio
netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso i soggetti conferenti.
Nota:
(2) Cfr. Direttiva 90/434/CEE, modificata dalla Direttiva
2005/19/CE.
4/2013
429
Operazioni
straordinarie
Agenzia delle entrate, Ris. n. 57/E del 2007 e Circ. n. 33/E del 2010
In tale ultima ipotesi, infatti, i soggetti conferenti,
a fronte delle partecipazioni detenute nella società
scambiata, trasferite mediante conferimento, ottengono partecipazioni della società conferitaria
aventi il medesimo valore fiscale delle prime.
Tutto ciò premesso, a maggior precisazione di
quanto espresso con le risoluzioni n. 57/E del 22
marzo 2007 e n. 446/E del 18 novembre 2008, si
ritiene che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e «speciale»
disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere «riorganizzativo»
(i.e., consentire ad una società di acquisire - ovvero
incrementare in virtù di un obbligo legale o di un
vincolo statutario - il controllo di un’altra società),
rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo
societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o «familiari».
Ne deriva, pertanto, che il regime disciplinato dal
più volte nominato art. 177, comma 2, è posto su
un piano di pari dignità con la disciplina di cui
all’art. 9 del T.U.I.R. rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti
di legge.
Naturalmente - in presenza di operazioni strumentalmente realizzate al precipuo fine di ottenere un
vantaggio fiscale da considerarsi indebito - resta
impregiudicato, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R.
n. 600/1973, ogni potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se l’operazione di conferimento ed eventuali altri atti, fatti
o negozi ad essa collegati s’inseriscano in un più
ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.
Il comunicato stampa
Agenzia delle entrate, Comunicato stampa 17 giugno 2010
Conferimenti di ampie vedute
Il «realizzo controllato» apre
ai gruppi societari e familiari
Applicabilità ad ampio raggio per la speciale disciplina tributaria sullo scambio di partecipazioni
da conferimento quando un vincolo legale, o statutario, impone il controllo della società conferitaria.
In virtù della matrice comunitaria della norma, infatti, e in accordo con le sue specifiche finalità
«riorganizzative», la disciplina appare destinata
tanto ad attuare un’aggregazione di imprese tra
soggetti terzi quanto all’interno dello stesso gruppo, svincolandosi di fatto dall’ambito meramente
soggettivo. Lo chiarisce la circolare n. 33/E dell’Agenzia delle entrate diffusa oggi.
Sui gruppi societari effetto governance - In questo caso, quindi, l’operazione da conferimento, distinta per la presenza d’un vincolo legale o statutario, acquisisce un carattere rilevante, come spiega
il documento di prassi, fino a incidere sugli assetti
del controllo societario, anche all’interno di gruppi
societari e/o «familiari», ridisegnandone di fatto la
governance.
Corrispettivi e guadagni, spazio al «realizzo
controllato» - Per determinare le variazioni reddituali in capo al soggetto conferente, a seguito del
conferimento, trova quindi applicazione il criterio
del «realizzo controllato». In pratica, l’entità di
eventuali corrispettivi o guadagni, o perdite, di-
430
4/2013
pende dal comportamento contabile adottato dal
soggetto conferitario che, tradotto in termini numerici, corrisponde alla quota delle voci di patrimonio netto che risultano formate per effetto del
conferimento.
Conferitaria arbitra nel calcolo del «realizzo
controllato» - A questo punto, tre sono le opzioni
sul tavolo per il calcolo di eventuali guadagni, o
perdite, in capo alla società conferente. Innanzitutto, si realizzerà una plusvalenza qualora il valore
della partecipazione iscritto dalla conferitaria risulti superiore all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, azioni o quote,
scambiate. Viceversa, si realizzerebbe una minusvalenza nell’ipotesi in cui, per effetto del conferimento, la società conferitaria aumentasse il proprio patrimonio netto ma per un ammontare inferiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al
conferente.
Il caso della neutralità fiscale «indotta» - Qualora, invece, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risultasse pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite, si concretizzerebbe l’eventualità d’una neutralità fiscale «indotta» che comporta l’esclusione sia
di plusvalenze che di minusvalenze. Comunque,
anche in questo caso è la società conferitaria a far
da arbitro, indirizzando il calcolo finale in relazione al suo comportamento contabile.
Contenzioso
tributario
Diritto tributario, giudici e processo
di Massimo Basilavecchia, Raffaello Lupi
Prendiamo spunto da un recente volume di Massimo Basilavecchia (Amministrazione dei tributi
e forme di tutela), cortesemente presentato dall’Autore, per proseguire le riflessioni sulla matrice amministrativistica del diritto tributario, la natura del processo e la sua natura che dovrebbe essere «normalmente eccezionale». Mentre è inconcepibile un diritto civile senza giudici indipendenti, un’azione amministrativa «senza giudice» è la normalità, e resta pur sempre giuridica; la pubblica autorità deve infatti rispettare valori e regole, la cui violazione, anche senza giudici, può essere fatta rilevare anche in sede «gerarchico-politica», come è avvenuto per secoli in
materia tributaria, in periodi che sono stati anche più sereni dei nostri. La processualizzazione
del diritto tributario ha finito per deresponsabilizzare l’attività amministrativa, e per far perdere
di vista la funzione del processo. Dove, come rileva anche Basilavecchia, la determinazione della
ricchezza è strumentale a stabilire la correttezza dell’attività amministrativa. Anche se questa
prospettiva, in punto di fatto, coincide spesso con quella dominante, sistematizzarla è una premessa indispensabile alla serenità del settore.
Il processo tributario come controllo sull’esercizio del potere
Massimo Basilavecchia
Più ragioni concorrenti hanno ispirato l’idea di
un volume, a metà strada tra didattica e monografia, dedicato alle procedure tributarie, al processo, e alle reciproche interrelazioni.
La trattazione dei singoli argomenti traduce il
contenuto di una didattica ultraventennale, e
composita: fatti di corsi universitari, di laurea e
post lauream, ma anche di una grande quantità
di incontri formativi con professionisti operanti
nel processo tributario. Parallelamente, una parte dell’attività scientifica dalla fine degli anni
novanta è stata riservata costantemente all’analisi dei materiali giurisprudenziali, annotando e
commentando una giurisprudenza di cassazione
che, con l’istituzione della Sezione quinta civile
(dedicata come noto alla materia tributaria), si
faceva sempre più densa di implicazioni e numericamente assai nutrita.
Maturava dunque una visione degli intrecci tra
procedure e processo, che, ancorché ancorata al
limite del dato legislativo esistente, appariva ad
un certo punto omogenea, e in grado di dare una
risposta coerente alla legittima domanda di sistemazione delle diverse forme di tutela offerte
al contribuente.
L’asse portante di questa visione era costituita
dall’idea che, come negli altri settori di diritto
pubblico, il confronto tra cittadino e parte pubblica in sede giudiziale (ma anche prima e dopo)
non può prescindere dal controllo sull’esercizio
del potere, da parte dell’Amministrazione; è una
riflessione che mi sembra valida non solo a legislazione esistente, ma probabilmente si tratta di
un dato strutturale, di carattere generale, che
difficilmente potrebbe essere eluso anche in un
sistema diverso.
Questa mia sensazione si è rafforzata nel 2006,
in occasione del volume dedicato dagli studiosi
di diritto tributario alla Corte costituzionale, dove pubblicai un contributo sull’idea portante di
cui sopra, anche alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 2004; quest’ultima aveva fissato la specificità del giudice amministrativo nel suo essere giudice nell’amministrazione, e non dell’amministrazione; anche in
diritto tributario la specialità del giudice, rispetto all’ordinario, è data dal suo essere in grado di
Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di Diritto tributario
presso l’Università di Teramo, Avvocato in Pescara
4/2013
431
Contenzioso
tributario
fornire una tutela ricca che, comunque la si classifichi, non può fare a meno di avere come parte
essenziale la verifica della legalità dell’esercizio
del potere. Quindi, probabilmente, più interesse
legittimo che diritto soggettivo, ma in ogni caso,
concorso delle diverse situazioni giuridiche soggettive a delineare una giurisdizione che non
può prescindere dal potere amministrativo come
oggetto principale.
Qui sta il punto.
Recuperare la matrice amministrativistica della
disciplina, come sostiene spesso Lupi, anche su
Dialoghi, è il passaggio che consente di dare risposte al conflitto tra poteri e tutela. Troppo
spesso, infatti, l’insistenza sulla vincolatezza
dell’attività amministrativa, la sopravvalutazione della fonte legale dell’obbligazione, soprattutto il pregiudizio che la tutela più intensa (potremmo dire «di serie A») sia garantita solo
nell’ambito di un processo su diritti soggettivi,
hanno creato presupposti per un inadeguato approccio ai singoli problemi e alla migliore sistemazione complessiva della tematica. Che l’Amministrazione finanziaria non debba usare di poteri discrezionali è verità (relativa, peraltro) che
non può far dimenticare quanto l’azione amministrativa condizioni l’applicazione del tributo.
Nonostante infatti la - ormai insostenibile - delega alle aziende delle principali forme di attuazione del tributo (1), è l’azione (o la mancata
azione) dell’Amministrazione a condizionare le
sorti dell’accertamento, della riscossione, dei
rimborsi, delle sanzioni. Se in un master professionale si sostenesse che il potere dell’Amministrazione finanziaria non esiste, o è in larga parte irrilevante, l’uditorio resterebbe disorientato;
sarebbe - come dicono gli economisti - un’affermazione «controintuitiva»; così come, ed anche
questo equivoco assai diffuso ostacola la comprensione, non si capirebbe una ricostruzione in
cui i poteri di indagine siano considerati del tutto slegati dalla emanazione del provvedimento
impositivo, quasi si trattasse di fasi distinte e indifferenti.
Negare il potere e l’attività amministrativa, o
comunque sminuirla, significa anche porre le
premesse per non saperla controllare in sede di
tutela, o per approdare ad una tutela che finisce
con lo svilire le regole poste all’Amministrazione. Posto al centro del sistema il potere, diventano centrali sia le norme che ne regolano lo sviluppo e ne consentono il controllo, sia quelle
che separano l’Amministrazione dal Giudice,
imponendo a quest’ultimo di astenersi dal completare l’azione amministrativa, sanzionandola
ogni volta che ravvisi la difformità - non meramente formale - tra regole e agire concreto.
Ecco perché il libro ha una struttura circolare: il
processo nasce dall’azione amministrativa, e i
problemi generali della tutela, una volta trattati in
generale, debbono essere verificati nella loro
adeguatezza rispetto alle singole procedure. Dal
processo, peraltro, si torna all’azione amministrativa, come forma di estinzione «conciliativa»
della controversia, come esecuzione della sentenza, come conformazione dell’azione alla sentenza, ovvero, come nell’autotutela (totale o «condivisa»), come succedaneo della tutela processuale.
Nota:
(1) È intuitivo il riferimento a quanto si scrive su Dialoghi sulla
tassazione attraverso le aziende.
Un diritto senza giudici: non desiderabile, ma possibile
Raffaello Lupi
Eccesso di processo e sua confusionaria concezione civilistica, come se si trattasse di due parti che
litigano, col giudice che decide a chi dare ragione.
Queste premesse, non tanto sbagliate, quanto prive
di senso, hanno ridotto la tassazione italiana a una
specie di incubo, in cui Massimo Basilavecchia,
col suo volume, indaga meglio di Dylan Dog.
432
4/2013
Io aggiungerei che la vera ragione di tanto
sconquasso non sta «nel processo», visto che i
processi (2) sono pochissimi rispetto alla quantità di ricchezza non registrata, ed anzi si risolNota:
(2) Ancorché numerosi in assoluto.
Contenzioso
tributario
vono quasi sempre, in questi casi, con la vittoria dell’Amministrazione. La vera ragione dello
sconquasso sta nella paralisi che la degenerazione processuale comporta, rispetto alla serenità, alla snellezza e alla sistematicità dell’azione amministrativa. Far decidere al giudice sottrae infatti dal timore di prendere decisioni,
spinge ad avallare rideterminazioni della ricchezza frequentemente fiscalistiche, contrarie a
principi di buonsenso e di ragionevolezza. Insomma, la deriva processuale del diritto tributario è la maggiore fonte della deresponsabilizzazione amministrativa, all’insegna del noto adagio «lei ha ragione, ma faccia ricorso». In questo modo non ci si prendono responsabilità che,
diciamolo una volta per tutte, non sono amministrative, con buona pace dell’immancabile evocazione della Corte dei conti. Si tratta piuttosto
di responsabilità genericamente «ambientali»,
connesse alle schermaglie che caratterizzano la
vita in tutti gli uffici, pubblici e privati, ed alla
cultura del sospetto che attanaglia gli Uffici tributari (3). La tendenza a «far decidere il giudice» (4) assorbe buona parte dell’attività amministrativa, le toglie sistematicità, spinge ad uno
scaricabarile e ad un formalismo devastanti, dove le pratiche si autoalimentano, neppure fossero dotate di vita propria. Per questo i processi
tributari italiani sono centinaia di volte più numerosi di quelli di altri Paesi europei, come la
Germania, la Francia o la Gran Bretagna, con
un circolo vizioso che li rende sbrigativi e insoddisfacenti. La via giurisdizionale alla tassazione ha soffocato quella amministrativa (5),
per poi fallire lei stessa. Ci sono sentenze ben
fatte, scrupolose, ovviamente, ci mancherebbe
altro. Ma così come basta un piccolo versamento di materiale inquinante per rendere torbido
un fiume, non serve che le sentenze casuali, gli
infortuni giurisprudenziali, siano la maggioranza per togliere credibilità all’intero sistema. Ne
basta una apprezzabile minoranza per delegittimare l’intero contenzioso tributario. Se mi si
consente una metafora, per considerare un quartiere infestato dalla criminalità non serve essere
scippati ogni volta che si va a fare la spesa. Una
volta su dieci è sufficiente. Credo che percentualmente, sulle controversie di una certa complessità, la percentuale di sentenze «infelici»
nel processo tributario sia notevolmente superiore a un 10%.
La mancanza, in capo ai giudici, di sensibilità
sulla tassazione attraverso le aziende non può
essere certo affrontata con una scolarizzazione
di massa, rimandando sui banchi di scuola giudici con un’età media di 60 anni, per sentirsi
spiegare la pex o l’IVA intracomunitaria.
La chiave di volta è assumersi responsabilità
amministrativa, decidere la maggior parte delle
controversie in quella sede, e finalmente «processare meno, processare meglio», come scrivevamo su Dialoghi quattro anni or sono (6). Per
arrivare a questo obiettivo è indispensabile capire, come scrive Basilavecchia, che la vera domanda del giudice è «in che cosa ha sbagliato
l’amministrazione». Perché è quest’ultima ad
assicurare la giuridicità del diritto tributario, in
termini istituzionali. Il giudice potrebbe anche
mancare, e spesso, sulle controversie particolarmente complesse, bisogna far finta che non ci
sia. La giuridicità del diritto tributario, come
tutti i settori del diritto amministrativo, non deriva dalla presenza di un giudice indipendente
(7), come accade nel diritto dei privati. La pubblica autorità deve infatti rispettare valori e regole ed in questo senso è giuridica; essa resta
giuridica anche se la sanzione è «gerarchico politica», come è avvenuto per secoli in materia
tributaria, in periodi anche più sereni dei nostri.
Riservandoci di tornare su questo passaggio,
teoricamente fondamentale, poniamo questo
Note:
(3) Vedi in proposito A. Ragno, R. Lupi, «I timori di corruzione come ostacolo alla valutazione della ricchezza non determinata attraverso le aziende», in Dialoghi Tributari n. 3/2013, pag. 272.
(4) Alimentata anche dai noti concetti immobilistici citati da M.
Basilavecchia, come la legalità del prelievo, l’indisponibilità del
credito tributario, l’equivoca vincolatezza dell’attività degli Uffici,
ecc.
(5) Sulla matrice amministrativistica del diritto tributario cfr. D.
Nolè, RL, «Processo tributario e processo amministrativo: il senso dell’impugnazione-merito», in Dialoghi Tributari n. 2/2013, pag.
72. Analogamente, sotto il diverso profilo della prova, A. Leo, M.R.
Silvestri, RL, «Onere della prova: un meccanicismo da superare?»,
ivi pag. 76.
(6) R. Lupi, D. Stevanato, «Processare meno, processare meglio: gli
inconvenienti dell’impostazione panprocessualistica del diritto
tributario», in Dialoghi Tributari n. 3/2009, pag. 237.
(7) Dove l’indipendenza si riferisce agli interessi in conflitto, come indicato anche alla nota successiva.
4/2013
433
Contenzioso
tributario
punto fermo: per i contribuenti l’importante, più
che avere un giudice indipendente (8), ma poco
attento e poco competente sui contenuti, è avere
un organo di riesame che dia loro soddisfazione.
E ben venga se fosse un organo di riesame amministrativo solido, con autonomia di giudizio e
senso del dovere, cioè disponibilità ad assumersi
responsabilità. Per questo, il diritto tributario è
giuridico anche senza giudice, oppure con organi paragiurisdizionali, forme di arbitrato paritetico e via enumerando. La giuridicità senza giudice viene dal coinvolgimento di istituzioni, di
una organizzazione sociale, di un potere legislativo, di uffici amministrativi. Le istituzioni restano tali anche se manca il controllo su di esse
di un giudice indipendente, visto che i relativi
errori saranno rilevabili in via «gerarchico-politica». In un’ottica istituzionalista, ed anche ad
una pacata riflessione, solo nel diritto dei privati
è davvero indispensabile un giudice, perché possa svolgersi la funzione pubblica di giustizia. Il
resto delle Pubbliche amministrazioni non hanno funzione di giustizia, ma di difesa, di istru-
434
4/2013
zione, di sanità, di cura, di ordine pubblico, sicurezza, ambiente, determinazione della ricchezza ai fini tributari e via enumerando. Se è
vero, come ritengo, che tutto il diritto è amministrativo ed il giudice civile è un funzionario preposto alla soluzione delle controversie, l’indipendenza rispetto ai litiganti è una premessa per
l’esercizio della funzione. Per le altre Amministrazioni pubbliche, il controllo del giudice, nei
fatti, è utile, ma non indispensabile. Certo, il
giudice può essere uno strumento per migliorare
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. Se però il giudice è un pretesto per innescare comportamenti opportunistici e deresponsabilizzati, allora proporre di comportarsi come
se non ci fosse è qualcosa di più di una provocazione.
Nota:
(8) Indipendente dalle parti, mentre l’indipendenza dal potere politico è una fictio contingente, di matrice liberaldemocratica, cui
tutti siamo affezionati, ma che non è strutturale.
Reati
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
tributari
Gli interposti, gli imprenditori
e le aziende (tra caso Mediaset
e tutoraggio fiscale)
di Raffaello Lupi
La nota vicenda sui diritti televisivi acquisiti tramite società interposte conferma che «le aziende
non evadono», ma possono evadere i loro titolari, che scavalcano a proprio uso e consumo le
procedure aziendali (cd. «management overriding»). Non ci interessa la veridicità dei fatti, peraltro stando alla sentenza molto verosimili. Aggiungiamo che gli imputati avrebbero potuto smentire l’accusa mostrando l’impiego di quanto era rimasto ai soggetti interposti. Gli importi contestati, compresi quelli prescritti, sono rilevanti in assoluto, ma tutto sommato secondari rispetto
alle dimensioni economiche del gruppo coinvolto, a conferma che «la tassazione attraverso le
aziende funziona», anche quando il proprietario, come sembra, mette via somme ingenti per sé.
Viene da chiedersi quanto siano frequenti questi fenomeni, al di là di quelli che emergono per liti
familiari o esposizione giudiziaria dei personaggi coinvolti, come nel caso in esame.Viene da chiedersi anche in quale misura il tutoraggio fiscale sulla grande impresa, tutto sbilanciato sul regime
del dichiarato, non finisca per proteggere la ricchezza nascosta dal titolare «attraverso l’azienda».
Tra le varie sentenze penali sui diritti televisivi
Mediaset decidiamo di pubblicare quella in primo grado (1), debitamente stralciata nei passaggi puramente processuali ed in quelli comprensibili solo attraverso la conoscenza degli atti. Abbiamo messo in evidenza perciò i passaggi rispondenti allo schema teorico generale dell’interposizione di «società schermo», gestite da fiduciari, prive di funzioni economiche ed aventi
un obiettivo di management overriding, cioè di
scavalcamento delle procedure aziendali a beneficio del vertice aziendale, nel caso di specie
coincidente con il proprietario-fondatore.
È da notare che quest’ultimo, almeno dal momento della quotazione in borsa della società,
non disponeva più solo del proprio patrimonio, e
dunque, seguendo il ragionamento svolto nella
sentenza, inevitabilmente depauperava, oltre che
il Fisco, anche i numerosi azionisti di minoranza; a tutela dell’interesse di questi ultimi non
sembra si siano per ora mosse le associazioni di
consumatori e risparmiatori, in genere molto
sollecite su analoghe tematiche. E ciò è riconducibile all’imbarazzo mediatico comunicazionale
suscitato da questa vicenda, che è un raro caso
in cui la «grande evasione» non riguardava solo
«maggior imposta accertata», per questioni di
diritto spesso forzate da equilibrismi e polveroni
giuridico-intepretativi. Qui, come si suol dire,
«c’è sostanza», cioè, come diceva un alto dirigente dell’Agenzia delle entrate, «qualcuno che
si è messo in tasca i soldi». Leggendo la sentenza si percepiscono proprio quegli schemi che
qualche mese prima ipotizzavamo su Dialoghi a
proposito di interposizioni analoghe nell’acquisto di materie prime da parte di fornitori di grandi dimensioni, realizzati utilizzando - stando a
quello che è desumibile dai giornali - società
probabilmente riconducibili ad un fiduciario del
socio della società acquirente (2).
Note:
(1) Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956, il cui testo è riportato
a seguire.
(2) Vedi in proposito Fondazione Studi Tributari, «Capitalismo familiare e ricchezza nascosta: leggendo i giornali sul caso Menarini», in Dialoghi Tributari n. 6/2010, pag. 594. Un seguito della vicenda può essere letto sul sito www.fiscoequo.it il post «Menarini:
Aleotti si arrende al fisco e versa 330 milioni».
4/2013
435
Reati
tributari
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
È difficile, per uno studioso di comportamenti
sociali, trovare riscontri adeguati delle proprie
ipotesi sulla ricchezza fiscalmente non registrata.
I resoconti giornalistici, come quelli da cui abbiamo preso le mosse anche in altri casi descritti
sui siti della Fondazione Studi Tributari
(www.fondazionestuditributari.com), sono spesso generici, confondono la «maggiore imposta
accertata» con la «ricchezza non registrata», l’evasione interpretativa con l’evasione da occultamento, le frodi carosello con l’appropriazione
indebita dell’intero importo dell’IVA. Insomma,
la stampa è un mezzo ottimo per capire che è
successo qualcosa, ma non per contestualizzare
in schemi teorici «cosa è successo».
Quindi, ai fini della ricerca scientifica, di cui
questi comportamenti sono dopotutto l’oggetto,
bisogna procedere per ipotesi di verosimiglianza, oppure auspicare che i professionisti o i funzionari del Fisco direttamente coinvolti spieghino meglio «come stavano le cose» (3).
La sentenza in rassegna dunque è un bellissimo
caso di scuola su ipotesi che probabilmente sono
molto diffuse. Essa rappresenta uno spaccato
molto interessante di come potesse conciliarsi
una gestione imprenditoriale «ripetitiva», caratterizzata da adempimenti contabili e organizzazione burocratica, con una struttura parallela di
fiduciari del titolare. È interessante leggere, nella
sentenza, il parallelismo tra la gestione aziendale
ordinaria, relativa alla programmazione televisiva delle opere acquistate, ai palinsesti, ai limiti
di utilizzazione dei telefilm, ma che non doveva
sapere nulla dei prezzi effettivi di acquisto all’esterno del gruppo, e la gestione «esterna» all’azienda, svolta tramite una serie di soggetti interposti, che in modo «riservato» conduceva le politiche dei prezzi di acquisto dei diritti televisivi.
La verosimiglianza dell’accusa è confortata anche da una riflessione che riportiamo nell’abstract, cioè che sicuramente le società interposte
erano nella disponibilità del gruppo e del suo titolare, i quali avrebbero avuto modo di documentare l’impiego delle relative risorse, compreso quello avvenuto per fini aziendali. Quindi, se
da un lato è vero che l’accusa non è stata accompagnata dalla prova documentale che le risorse
finanziarie accumulatesi in vari paradisi fiscali
per effetto dell’arbitraggio sui diritti televisivi
436
4/2013
fossero finite nelle tasche del socio di riferimento o di suoi fiduciari, dall’altro lato è pure vero
che questi ultimi sapevano dove erano finiti i
soldi, e se questi avessero avuto una destinazione
diversa avrebbero potuto facilmente dimostrarlo.
Sono queste le ipotesi di «grande evasione» fiscale presenti nell’immaginario collettivo; non
si può dire che frequentemente, a quanto si legge sulla stampa e sui comunicati stampa delle
istituzioni, siano scoperte interposizioni e frodi
di questo tipo.
Come abbiamo scritto in altre sedi, il capitalismo italiano, prevalentemente a base familiare,
contiene circa 4.000 «grandi contribuenti»; togliendo le società a partecipazione pubblica,
quelle facenti parte di gruppi esteri e le poche a
proprietà frazionata (public companies, cooperative, banche e simili), restano probabilmente almeno migliaia di situazioni dove esiste un titolare in grado di compiere uno «scavalcamento manageriale» analogo a quello descritto nella sentenza in esame. Non è certo qui che si annidano
i 120 miliardi di euro di imposte, secondo me
sottostimate, che corrispondono alla ricchezza
non registrata. Però è qui, manovrata dai titolari,
che potrebbe annidarsi la «grande evasione», intesa come «ricchezza non registrata», che ha un
grande valore simbolico sulla pubblica opinione.
Si è creato invece un equilibrio strano che rientra nella dialettica tra «inferno della ricchezza
palese» e «paradiso della ricchezza nascosta». I
controlli del tutoraggio fiscale si incentrano, non
già su quello che forse la proprietà aziendale nasconde, ma sul regime giuridico di quello che
l’azienda dichiara. Alla fine fa comodo a tutti,
ma le lacerazioni ed i sospetti restano, crescono
e avvelenano il clima sociale. Per uscirne occorre anche qui una riflessione ed una consapevolezza ampia, all’interno dell’opinione pubblica e
delle classi dirigenti, sulla differenza tra gli imprenditori come persone e le aziende come organismo pluripersonale.
Che svolge obtorto collo anche il compito di
esattore del Fisco.
Nota:
(3) Anche per questo riteniamo inopportuna la tendenza avvocatesca a non scrivere su casi in cui si è stati parte. È un profilo che
dovremo riprendere in termini generali.
Reati
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
tributari
La sentenza
Tribunale di Milano, Sez. I pen., Sent. 26 ottobre 2012, n. 10956 - Pres. Est. d’Avossa - Est. Guadagnino
- Est. Lupo (stralcio)
Fatto e diritto
Premessa
(Omissis)
Cap. 1 Le origini del sistema di frode
1a Il meccanismo fraudolento
Le imputazioni originarie e quelle attualmente residue descrivono un meccanismo fraudolento di
evasione fiscale sistematicamente e scientificamente attuato fin dalla seconda metà degli anni
‘80 nell’ambito del gruppo Fininvest, connesso al
cd. «giro dei diritti televisivi».
(Omissis) i diritti di trasmissione televisiva, provenienti dalle majors o da altri produttori e/o distributori, venivano acquistati da società del comparto
estero e riservato di Fininvest e quindi venivano
fatti oggetto di una serie di passaggi infragruppo,
o con società solo apparentemente terze, per essere
poi trasferiti ad una società maltese che a sua volta
li cedeva, a prezzi enormemente maggiorati rispetto all’acquisto iniziale, alle società emittenti.
Tutti questi passaggi erano palesemente privi di
una qualche funzione commerciale, risolvendosi
esclusivamente in un’artificiosa lievitazione di
prezzi. E questo anche e soprattutto perché le società acquirenti, tramite le quali il diritto transitava
nell’area Fininvest-Mediaset, erano totalmente prive di una struttura commerciale effettiva.
La reale acquisizione dei diritti era infatti operata
direttamente dalla struttura di Reteitalia prima e di
Mediaset poi che faceva capo a C.B. ed ai suoi
collaboratori. Detta struttura riceveva le richieste
degli addetti commerciali delle reti e si avvaleva,
in particolare, della consulenza tecnica dell’imputato L. che procedeva alla trattativa per gli acquisti
con le majors o altri fornitori. Nessuna funzione,
neppure marginale era pertanto demandata alle società del comparto estero che figuravano acquirenti in prima battuta.
(Omissis)
A … Milano, venivano inviate solo le schede contenenti le informazioni utili per la programmazione, quali provenienza del diritto, numero dei passaggi, decorrenza e scadenza.
A partire dal 1995 e sostanzialmente in occasione
della quotazione in borsa di Mediaset e fino alla
fine del 1998/9, il sistema indicato veniva parzialmente modificato, nel senso che scomparivano generalmente i passaggi infragruppo, mentre i diritti
venivano fatti intermediare da società apparenti
terze e poi ceduti alla società maltese International
Media Service Ltd (di seguito per brevità IMS)
che, a sua volta, li cedeva a Mediaset, rimanendo
immutato il meccanismo di lievitazione dei prezzi.
Il tutto ha comportato un’evasione notevolissima
che, per quel che concerne il periodo residuo di
causa, si aggira intorno agli importi indicati nel
capo di imputazione (17,5 mld di L. nel 2000; 6,6
mln di Euro nel 2001; 4,9 mln di Euro nel 2002 e
2,9 mln di Euro nel 2003).
Passando adesso all’esame delle fonti di prova, appare particolarmente significativa la mail del
12.12.1994 con la quale tale D.S., un contabile
della Fox, scrive a M.K., suo superiore in posizione verticistica, dicendogli che i profitti non sono
proprio parte delle reti televisive italiane (riferito
palesemente a Fininvest) che sono state ideate per
perdere soldi.
In prosieguo ci si soffermerà ulteriormente su questa mail per gli altri aspetti rilevanti trattati nella
stessa, ma per il momento è necessario sottolineare, a dimostrazione del sistema di frode ideato con
il c.d. giro dei diritti televisivi dal gruppo Fininvest fin dagli anni ‘80, che il teste A.F.P., addetto
all’ufficio acquisti (prima di Reteitalia e poi) di
Mediaset, ha precisato di aver progressivamente
intuito l’esistenza di questo meccanismo, di averne parlato con C.B., di aver ricevuto conferma che
tale era il sistema e di essere stato espressamente
autorizzato da questi a parlarne con D.S.
A.F.P. ha confermato di aver avuto il colloquio riportato nella mail di D.S. ed ha spiegato le ragioni
di quelle dichiarazioni.
D.S., sentito come teste nel corso del dibattimento,
ha confermato che le società del Gruppo S.B. erano fortemente indebitate con la FOX; di aver inviato la mail in oggetto a M.K.; che il contenuto
del documento era conforme alle indicazioni ricevute da A.F.P.; di aver utilizzato l’espressione
«shell game» per spiegare al suo interlocutore che
«le cose Fininvest» erano nascoste a guisa del gioco citato (N.d.R.: una sorta di gioco delle tre carte)
4/2013
437
Reati
tributari
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
anche se poi ha dichiarato di non sapere quali fossero le società dove non c’era nulla.
M.K. ha confermato in dibattimento di aver ricevuto la mail in questione con riferimento alla situazione debitoria delle società di S.B. anche se
non è stato circostanziato sul punto.
Il quadro descritto da A.F.P., D.S. e M.K., in merito alla finalità di non far risultare utili (o quanto
meno di contenerli) nelle società televisive emittenti trova integrale conferma in una molteplicità
di elementi di prova orale e documentale.
Tra i primi si può anzitutto citare la deposizione di
S.C., addetta all’ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset dopo, sinteticamente ma
efficacemente riassumibile nell’espressione «picchia giù con i prezzi», rivoltale da C.B., solitamente dopo incontri ad Arcore con S.B. L’espressione «picchia giù sui prezzi» stava a significare
che la S.C. doveva dare indicazioni alla struttura
Fininvest Service di Lugano di procedere alla formazione di subcontratti, con prezzi significativamente in aumento rispetto a quelli originari, il che
era finalizzato, da un lato all’incremento dei costi
di Reteitalia e poi di Mediaset per evidenti fini di
evasione fiscale e dall’altro alla costituzione di ingenti quanto illeciti capitali esteri.
La S.C. ha, inoltre, raccontato che c’erano due tipologie di contratti, i contratti Italia, e i contratti
che provenivano dall’estero. Questi ultimi, di fatto, a Milano non venivano nemmeno visti, essendo
trasmessi attraverso una scheda (fatta dall’ufficio
di Lugano), dove era indicato il nome del fornitore, la tipologia del programma, il numero di episodi e la durata, se il programma era già doppiato,
l’epoca di consegna, la decorrenza, la scadenza dei
diritti, e il numero dei passaggi consentiti durante
lo sfruttamento, senza alcun riferimento ai dati
economici. Talvolta addirittura la parte economica
era sbianchettata.
L’arrivo dei diritti era solo virtuale, nel senso che
l’ufficio di Milano conosceva il titolo entrato nella
disponibilità del gruppo, la decorrenza, eccetera,
ma ancora il diritto non era stato formalmente acquistato dalla società italiana.
Finalmente, a un certo punto, C.B. stabiliva che
bisognava fare dei contratti di acquisto, sulla base
della decorrenza; la teste allora faceva delle stampe di tutto quello che era in decorrenza con fornitore «Est».
Ha quindi riferito la teste: «Quando io ho fatto la
stampa per sapere tutto quello che è in decorrenza
e devo comprare, la M.Ba. telefonava a Lugano e
si faceva dettare tutti i prezzi. Per cui sul tabulato
438
4/2013
a fianco di ogni titolo veniva messo il relativo costo. L’ufficio della Ca. comunicava a una delle mie
ragazze i costi che venivano scritti di fianco a ogni
titolo, così, a matita, sul tabulato, io pigliavo il
mio tabulato, andavo da C.B. il quale mi dava la
dritta: «Allora questo mese, questo trimestre dobbiamo arrivare in termine di costo a 5 milioni di
dollari, 20 milioni di dollari, eccetera. Però il costo dei diritti era di meno, sensibilmente di meno»
(e in questa fase si inseriva quindi quel «picchia
giù sui prezzi», di cui si è già detto).
Anche altri testi sentiti sul punto hanno integralmente confermato quanto sopra accennato in merito alla distinzione tra master e subcontratti, alle
modalità di redazione delle schede ed alla segretezza del prezzo originario.
La teste M.Ba., addetta all’ufficio gestione e contratti di Reteitalia prima e Mediaset dopo, ha dichiarato che, tendenzialmente fin dal 1985, si era
occupata della redazione dei subcontratti, confermando l’esistenza dei master, dei sub e del non
inoltro dei contratti a Milano.
Il teste D.B. dipendente di Fininvest Service di
Lugano, ha riferito di essersi occupato della predisposizione delle schede sulla base dei contratti di
acquisto dei diritti, precisando che la scheda contenente la parte economica veniva consegnata alla
Ca. (successivamente alla Ga.) per l’amministrazione, mentre la parte contenente tutti gli altri dati
contrattuali veniva spedita a Milano.
Alla domanda del PM: «Questo fatto di non trasmettere a Milano anche la parte della scheda relativa ai costi era una decisione sua o le era stato detto da qualcuno?», D.B. ha risposto: «No, mi era
stato detto per una ragione, credo abbastanza semplice, di... oggi si direbbe privacy, ai tempi evidentemente si dava a Milano quello di cui Milano aveva bisogno, quindi alla ragazza, che poi a sistema
ed a terminale avrebbe imputato i valori del film o
della serie televisiva, interessava sapere quanti passaggi: quando cominciavano i diritti e quando finivano, ma non credo certo quanto fosse costato.
PM: Questa è una giustificazione che le è stata data da qualcuno che non c’era interesse a conoscerli? Cioè gliel’ha detto qualcuno questo?
DICH: No, ma quando sono entrato mi hanno detto: «la parte che riguarda i diritti è una parte ufficiale, invece la parte che riguarda i costi è una cosa di Fininvest Service quindi è giusto che rimanga all’interno dell’azienda».
È poi interessante evidenziare che, all’ulteriore
domanda del P.M. a proposito di chi firmasse i
contratti con le Century One e Universal One, il
Reati
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
teste ha dichiarato: «Per quello che riguarda noi
C.B.», evidentemente sul presupposto che le due
«One» fossero un qualcosa di esterno al Gruppo, e
poi ha ribadito che a lui interessava chi avesse firmato per loro per una garanzia di validità del contratto mentre non gli interessava chi fosse dall’altra così come non gli interessava chi avesse potere
di firma alla Warner Bros piuttosto che ad un qualsiasi altro fornitore.
(Omissis)
Il teste ha poi spiegato il meccanismo di cessione
infragruppo, confermando in sostanza quanto già
riportato circa la lievitazione dei prezzi senza giustificazione.
Anche questo teste, presa visione di una scheda,
ha riconosciuto che Principal Network Communication aveva acquistato nel 94 per 64 milioni di $
e rivenduto a 170 milioni di $ a Mediaset International. (Omissis)
Il teste ha poi precisato che questo meccanismo risaliva sin dalla metà degli anni 1980.
Più in dettaglio il teste, alla contestazione del P.M.
delle precedenti dichiarazioni:
PM: «Il contratto originario, che prevedeva una
certa durata dell’esclusiva e un certo numero di
passaggi, veniva effettivamente, come Lei mi
chiede, convenzionalmente denominato master. I
contratti finali con i clienti nei singoli paesi, in
Italia prima Rete Italia e poi Mediaset, contemplavano in genere solo una frazione del periodo di
utilizzo. (Omissis)».
A completamento di quanto sin qui riportato, meritano di essere richiamate le dichiarazioni rese da
F.T., Amm. Del. Di Fininvest nel 93/94, il quale ha
ricordato che lui aveva avuto una conoscenza solo
indiretta dell’area diritti, pur trattandosi di un’area
molto rilevante, in quanto la responsabilità era di
C.B.
E questo ancorché la sua priorità, concordata con
l’azionista, fosse di concentrarsi sulla riduzione
dei costi. Ha precisato il teste, a contestazione del
PM:
PM: Perché Lei ha dichiarato sul punto, sempre
nello stesso verbale, a foglio 2 in fondo: «Era
un’area di attività» - le modalità di acquisizione
dei diritti - «assolutamente chiusa ed impenetrabile...»
DICH: Eh, abbastanza, quello sì.
PM: ... gestita a livello più alto da C.B. che dava
conto della sua attività direttamente a S.B. e non
riferiva al consiglio di amministrazione». È vera
questa dichiarazione?
DICH: è vera ...
tributari
(Omissis)
Da tutte le deposizioni emerge dunque che l’unica
trattativa reale sull’acquisto dei diritti era quella
operata da L. con il fornitore estero e con sottoposizione della decisione finale a C.B.
Viceversa nessuno, nel processo, ha riferito di una
logica commerciale dei passaggi tra le varie società del gruppo, né di una trattativa né di un qualsiasi altro scopo che non fosse quello già evidenziato dell’aumento dei costi.
Coerente con questo sistema era la segretezza in
Italia del prezzo di acquisto del prodotto atteso
che le schede non contenevano tale dato.
(Omissis)
Tutto ciò ha comportato che la società gestore delle reti televisive ha corrisposto per l’acquisto dei
diritti somme enormi non corrispondenti al loro
reale prezzo nel momento in cui venivano acquistati da parte del gruppo.
Questa conclusione non discende da una valutazione economica del valore dei diritti, non di competenza di questo Collegio, ma semplicemente dalla constatazione che i prezzi hanno subito un ricarico rispetto al momento dell’acquisto dal fornitore in alcun modo giustificato. (Omissis)
In verità nel prospetto informativo per la quotazione in borsa di Mediaset, al capitoletto «Ruolo delle società off-shore del Gruppo Fininvest» si tende
a fornire una spiegazione del meccanismo fin qui
descritto. Si afferma quindi sul punto:
«In considerazione della partecipazione degli anni
passati in televisioni in Spagna, in Francia e in
Germania, le società off-shore fungevano da centrali di acquisto dalle major, da produttori indipendenti e da distributori di diritti televisivi spesso in
anticipo rispetto alla possibilità di sfruttamento televisivo. Le società italiane acquisivano dalle sopra citate società off-shore il diritto, relativo al territorio italiano, solo al momento della disponibilità
del diritto stesso ad un prezzo di volta in volta
concordato tra le parti senza alcun specifico riferimento a valutazioni operate da terzi, atteso il momento temporale di validità normalmente differito
- e la configurazione, talora diversa dei diritti
compravenduti. Tali diritti fanno parte, al netto degli ammortamenti nel frattempo effettuati, della library del Gruppo Mediaset al 31 dicembre 1995
che ha evidenziato un valore significativamente
superiore al valore complessivo di bilancio».
Come può notarsi dalla lettura del passaggio appena riportato e pur sostenendosi che, in ogni caso, i
diritti acquistati hanno un valore significativamente superiore al valore riportato in bilancio Media4/2013
439
Reati
tributari
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
set, con questo passaggio, tende ad accreditare la
tesi che tutto il meccanismo fin qui descritto sia
integralmente lecito sul presupposto che le società
off-shore avrebbero svolto una reale funzione
commerciale di centrale acquisti per l’intero Gruppo. Detto presupposto, come si è già visto, è integralmente falso.
Infatti il prospetto omette di riferire che le c.d.
centrali di acquisto che risultano parti nelle catene
di acquisto dei diritti non sono solo off-shore ma
sono state spesso anche occulte, gestite da fiduciari esteri e non comprese nei bilanci del Gruppo.
Le società off-shore erano in sostanza dei c/c di
transito, prive di una reale struttura, che, come si è
visto, era invece presente e operativa nella società
emittente. (Omissis)
Nessuno dei testi sentiti ha parlato di trattative intercorse tra le società off-shore e dei criteri di volta in volta utilizzati per la determinazione dei
prezzi; (Omissis)
1b Il comparto estero di Fininvest
Il sistema in precedenza illustrato presupponeva
necessariamente la creazione di società off-shore,
situate in Paesi come le BVI, il Jersey, e le Bahamas, e comunque non immediatamente riferibili al
gruppo Fininvest, sui conti delle quali, spesso intestati fiduciariamente senza indicazione dei beneficiari owner, far transitare il denaro corrispondente
ai maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei diritti
da Reteitalia prima e da Mediaset poi.
L’esistenza di tali società oltre ad essere documentalmente provata è stata confermata da vari testimoni.
In particolare la teste Ma., responsabile dei servizi
aziendali di CMM, società fiduciaria londinese facente capo a Mi., ha dichiarato in dibattimento di
aver effettuato una suddivisione tra società FININVEST molto note al pubblico e le altre.
Alla domanda del P.M.:
«E queste “group B” invece non erano note al pubblico? Che caratteristiche avevano queste società
group B?»
La Ma. ha risposto:
«Ho fatto io questa classificazione in società B,
perché avevo capito che praticamente erano, in un
modo o in un altro, connesse a Fininvest, ma non
erano necessariamente società di cui si potesse,
come dire, liberamente parlare allo staff piuttosto
che alle persone».
Tra le società del gruppo B), vanno in specifico
evidenziate le già citate Century One e Universal
440
4/2013
One, che si è visto essere state particolarmente attive nell’acquisto dall’estero dei diritti televisivi.
Le suddette società erano gestite dalla fiduciaria
Arner di Lugano, i cui amministratori avevano un
potere di firma sui c/c di tali società. La teste indicava come beneficiari economici di tali società
C.B., Gi. e «forse anche» S.B.
S.A.R. - direttore esecutivo di Edsaco - ha riferito
testualmente all’udienza del 10,6.2008:
«per quello che ne sappiamo noi le società del
Gruppo A erano di proprietà diretta di Fininvest
italiana, mentre le società del gruppo B non lo erano ed erano possedute da società che il signor Mi.
aveva istituito. Entrambe le (categorie di) società
erano di proprietà di S.B. anche se non direttamente quelle del gruppo B» (vedi anche memo del
27.11.1995 a firma Mi. esibito al teste).
(Omissis)
«(Omissis) Con riferimento all’addebito relativo al
fatto di avere Mi. celato l’identità della proprietà
delle società offshore del cosiddetto “Gruppo Fininvest B”, la sentenza emessa nel processo Arces
ed altri aveva accertato in maniera definitiva che la
Guardia di Finanza era stata corrotta affinché non
venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse
la reale proprietà, pur non essendo stato ritenuto
certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e S.B., collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest. S.S.,
responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.
(Omissis)».
(Omissis)
«(Omissis) consentendo anche, in tal modo, il
mantenimento di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero e la destinazione di una parte degli stessi a M. e P.S.B.».
(Omissis)
Il penultimo anello dei passaggi infragruppo riguardava la cessione costante ad una società maltese (nel tempo AMT, Mediaset International, Lion
e IMS) che provvedeva poi, con un ulteriore aumento del prezzo del diritto tendenzialmente intorno al 7/8%, a cedere l’utilizzazione dei diritti alle
società emittenti. Come ha riferito il teste N.B.,
uno dei soci di Arner, la costituzione di AMT era
stata suggerita da Del.B. e lo stesso N.B. aveva assunto, pur ignorando quale fosse il cliente, la veste
di beneficiario economico.
Il ruolo di mero transito assunto dalle società maltesi è dimostrato dal fatto che esse (ufficialmente)
sono state costituite unicamente per meri fini di ri-
Reati
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
sparmio fiscale così come ha riferito il già citato
teste N.B. e come è pacifico in causa.
Indipendentemente dalla pacifica non correttezza del
passaggio per le società maltesi, se non altro perché
non si verifica alcun effettivo passaggio di diritti, essendo le suddette società prive di reale struttura (in
sostanza delle vere e proprie cartiere), va qui evidenziato che il paravento fiscale delle società maltesi era in realtà indispensabile per occultare il diretto
rapporto tra le società italiane emittenti e le varie intermediarie dei diritti, e ciò sia sotto il profilo contrattuale, che sotto il profilo dei flussi finanziari.
(Omissis)
Cap. 2 L’attuale imputazione
di dichiarazione fraudolenta
2a La quotazione in borsa di Mediaset
ed i suoi effetti sul sistema di frode
Ovviamente con il progetto di quotare in borsa
Mediaset il sistema escogitato fino a quel momento ha dovuto essere parzialmente modificato, prospettandosi necessario eliminare tutti quei rapporti
poco trasparenti e comunque tali da non essere
presentabili alla Consob e ai nuovi investitori.
Tutte le entità fin qui esaminate, infatti, non erano
commercialmente proponibili, attese la loro collocazione, la gestione ad opera di fiduciari, l’assenza
di una reale struttura operativa, anche solo apparente, per cui diveniva indispensabile procedere ad
una riorganizzazione del meccanismo di frode.
Scomparivano di scena le «One», mentre le «Principal» venivano vendute, nel luglio 1995, con contratti con effetto retroattivo alla data dell’1.1.1994
e IMS veniva inserita nel consolidato.
Parallelamente però entravano in scena altri soggetti, dei quali alcuni caratterizzati dall’assoluta
mancanza di esperienza nel settore dei diritti televisivi: circostanza questa che dimostra la fittizietà
delle operazioni intraprese con tali soggetti, trattandosi di un settore che, per quanto riferito da tutti gli esperti del ramo nel corso del processo (e per
quanto rientra nelle nozioni di comune esperienza
e sapere), richiede conoscenze approfondite e soprattutto un radicato inserimento nell’ambiente.
Per altro verso va evidenziato - e la circostanza
non è di poco conto a dimostrazione della prosecuzione dell’attività delittuosa - che la lievitazione
dei prezzi realizzata nel secondo periodo trae comunque le sue radici già nel precedente periodo
quando erano funzionanti e funzionali le società
del comparto B).
(Omissis)
tributari
2b Film Trading
(Omissis)
La teste A. ha dichiarato di aver incontrato C.B., la
Ca. e la Ga. di Fininvest/Mediaset e nessuno di
IMS. Sapeva che IMS comprava per Mediaset e
quindi che fosse la stessa cosa. Ricevevano i contratti - secondo una prassi che si è già vista in altri
casi - tramite corriere speciale.
(Omissis) va rilevato come sia assolutamente inverosimile che Gg., privo di conoscenze nell’ambiente, riuscisse immediatamente a proporsi come
interlocutore capace e affidabile, tale da poter realizzare i volumi di fatturato indicati in precedenza.
Ma ancor più inverosimile è che Mediaset, già società leader del settore con uomini di provatissima
esperienza e introduzione quali erano L. e C.B.,
avesse bisogno di un pur affermato commerciante
di carni di Montecarlo per poter incrementare la
sua library.
A questo proposito va anche evidenziato come le
difese che, pur si sono lungamente soffermate sulla pretesa incompetenza della d.ssa Ch. a svolgere
la CT affidatale dal P.M., siccome non esperta del
settore, non abbiano saputo trarre le medesime
conseguenze per la vicenda di Film Trading.
E ciò appare davvero poco logico, considerato che
la d.ssa Ch. si è occupata sostanzialmente di conteggi, mentre Gg. si sarebbe occupato di vera e
propria commercializzazione dei diritti.
C’è da aggiungere che sono addirittura incomprensibili anche le ragioni commerciali della cessazione della suddetta attività, tenuto conto dei rilevantissimi guadagni apparentemente conseguiti dal
Gg., per cui nella ricostruzione difensiva rimangono privi di spiegazione non solo l’inizio, ma anche
la fine dell’attività.
In definitiva non possono sussistere dubbi sulla
fittizietà dei contratti stipulali tra Film Trading e
IMS e quindi sulla inesistenza dei relativi costi.
Si può quindi ritenere che gli importi incassati da
R., S. e W., ma anche presumibilmente parte di
quelli percepiti dallo stesso Gg., attesa la loro entità e la mancanza di un reale titolo per il pagamento, costituiscano la restituzione di quanto erogato da IMS a fronte delle fittizie transazioni intervenute tra la mdesima IMS e la Film Trading.
In definitiva Film Trading va considerata una mera
cartiera, per cui rientra a pieno titolo nel meccanismo di frode in esame.
2c Green Comunication
(Omissis)
4/2013
441
Reati
tributari
Trib. Milano, 26 ottobre 2012, n. 10956
Valgono, in definitiva, per Green le medesime considerazioni per quel che attiene alla mancanza di
struttura della società, di capacità tecnica ed esperienza del settore da parte dei suoi amministratori,
nonché alla non intellegibilità dei motivi per cui
Mediaset avrebbe dovuto trattare con un simile intermediario per l’acquisto di diritti televisivi.
Ed infatti, alla pochezza della struttura di tale intermediario fungeva da anomalo contraltare l’enormità dei guadagni conseguiti dallo stesso in
tempi limitatissimi, specie tenendo conto che si
tratta di imprenditore alla prima esperienza nel
settore.
(Omissis) per il momento è sufficiente dire che
senza dubbio alcuno l’intermediazione di Green è
stata attuata nella consapevolezza di C.B. e non
già in frode al predetto.
(Omissis)
Cap. 4 Le singole responsabilità
(Omissis)
II risarcimento del danno alla parte civile
Agenzia delle Entrate
Dall’affermata responsabilità penale di Ag., S.B.,
Ga. e L. consegue l’obbligo risarcitorio a favore
della costituita parte civile Agenzia delle entrate
ex art. 185 c.p.
Quanto al danno patrimoniale, lo stesso ovviamente non coincide solo con l’importo del tributo evaso che tutt’al più può costituire la base per la sua
concreta valutazione.
Il danno risarcibile è infatti costituito altresì dallo
sviamento e turbamento dell’attività della pubblica
amministrazione diretta all’accertamento tributario.
Tale danno ulteriore rispetto a quello costituito
dall’imposta non assolta è, dunque, il danno funzionale all’attività dell’agenzia, danno che nel caso di specie è particolarmente significativo.
Infatti, l’attività criminosa in questione diretta
all’evasione di imposta è stata attuata utilizzando
sistemi criminali raffinati, attraverso la creazione
di un arcipelago variegato di enti con sede in paradisi fiscali funzionali all’artificioso incremento di
passività al fine di evadere le imposte.
Come si è ampiamente spiegato, infatti, l’acquisizione dei diritti dalle majors era interamente programmata in Italia dove poi i diritti venivano utilizzati, ma transitava attraverso società fittizie poste in paradisi fiscali, il tutto per conseguire la duplice utilità di far confluire i ricavi relativi alla
commercializzazione all’estero e di esporre nelle
442
4/2013
dichiarazioni dei redditi passività inesistenti attraverso l’incremento artificioso dei costi, fatto questo che dà luogo alla contestazione fiscale.
Ed è chiaro che quando il progetto di evasione si
esplica in un arco temporale così ampio, in un ambito territoriale così vasto, e con modalità così raffinate, l’attività funzionale dell’Agenzia delle entrate risulta ancor più pregiudicata in termini di risorse umane impegnate, spese vive e sviamento da
altre attività delle funzioni che la stessa ha dovuto
attivare in seguito alla consumazione del reato.
Oltre al danno patrimoniale la parte civile ha chiesto e le va riconosciuto il risarcimento del danno
non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Sul punto si osserva che non è controversa in giurisprudenza la risarcibilità del danno all’immagine
subito da enti preposti al controllo del corretto
esercizio di attività (economiche e non) a seguito
della commissione di reati connessi all’espletamento di tali attività (cfr. Cass. 35868/02).
Nella fattispecie sub iudice, la disinvolta condotta
degli imputati connotata da una assoluta indifferenza delle regole, nonché dalla capacità di creare
in modo professionale e sistematico entità fittizie
in grado di frodare il fisco, è idonea a ingenerare
nella collettività la percezione di un’amministrazione finanziaria inefficiente nel disimpegno delle
proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutile.
A ciò si aggiunga che tale percezione si dilata a dismisura con danno esponenziale per l’amministrazione finanziaria a causa della notorietà e del rilievo anche istituzionale dei soggetti che realizzano
l’evasione fiscale.
In sostanza, l’evasione fiscale ancor più se per importi cospicui e di particolare visibilità, destabilizza la credibilità del nostro sistema tributario, sia
nell’ambito interno che in quello internazionale,
alterando, attraverso l’indebito vantaggio, la normale concorrenza societaria.
Premesso quanto sopra, l’esistenza dei danni patrimoniali e non risulta certamente provata nell’an,
ma non esattamente determinabile nel quantum.
(Omissis)
Il testo integrale della sentenza
oltre a essere disponibile
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA
si può richiedere a
[email protected]
www.ipsoa.it/dialoghionline
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
Sull’applicabilità d’ufficio
delle mitigazioni sanzionatorie
previste «ex lege»
dopo l’introduzione del giudizio
di Alessia Vignoli, RL
Proponiamo un interessante riflesso teorico di una vicenda in sé limitata, relativa ad alcune disposizioni sull’anticipazione, di pochi giorni, del versamento dell’accisa sul gas metano, evidentemente sfuggite alle procedure interne di alcune aziende municipalizzate, che avevano effettuato i
versamenti nei termini ordinari precedenti, cioè tardivi di pochi giorni. A fronte del ritardo era
stata inflitta la sanzione ordinaria del 30%, palesemente abnorme rispetto al danno erariale effettivo, contestata per vari motivi, spesso riconosciuti nei gradi di merito. Nel 2011, a contenziosi in corso, è stata introdotta una disposizione generale che, in quanto più favorevole al trasgressore, è estranea al processo e deve essere applicata non «d’ufficio dal giudice», ma «d’ufficio dall’Ufficio».
Sull’applicabilità d’ufficio della norma sanzionatoria più favorevole
al trasgressore
Alessia Vignoli
Nell’applicazione dello ius superveniens il giudice può legittimamente astenersi da ogni pronuncia dal momento che la rideterminazione
della sanzione, applicando il più favorevole trattamento sanzionatorio sopravvenuto all’adozione della pretesa impositiva, resta comunque una
prerogativa dell’Ufficio fiscale.
Tale conclusione trova conforto in due decisioni
della Suprema Corte di cassazione sul tema della irrogazione delle sanzioni per il tardivo versamento della rata di acconto per l’accisa dovuta
sul gas metano (1).
In particolare, nella sentenza n. 9285 del 2013 la
contribuente contestava l’interpretazione - su
cui si fonda la pretesa fiscale - secondo cui l’art.
28, comma 8, della legge n. 388/2000 (che anticipava la data di versamento al 27 dicembre di
ciascun anno) (2) avrebbe definitivamente modificato la data del versamento originariamente
fissata entro la fine di ciascun mese (in base
all’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 504/1995).
Nel caso di specie la Suprema Corte ha considerato tardivo il versamento effettuato dalla contribuente (convinta che la scadenza fosse sempre
la fine del mese) in data 30 dicembre anziché il
27, con la conseguente irrogazione di sanzioni
nella misura stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. n.
472/1997 che si aggiunge all’indennità di mora
Alessia Vignoli - Ricercatrice presso l’Università di Roma «Tor Vergata»
Note:
(1) Cass., 19 aprile 2013, n. 9565; Id., 17 aprile 2013, n. 9285. Il testo delle sentenze è riportato a seguire.
(2) Si trattava in particolare dell’art. 28 della legge Finanziaria del
2000 per il 2001 (legge n. 388/2000) secondo cui: «Per i tributi
previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa
sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui
all’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonché per l’imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e
sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27
dello stesso mese».
4/2013
443
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
dovuta in applicazione del D.Lgs. n. 504/1995
(Testo Unico Accise - TUA).
Nella sentenza n. 9565 del 2013 si discuteva, invece, della possibilità di cumulare l’indennità di
mora prevista nel D.Lgs. n. 504/1995 con la
sanzione generale in tema di tardivi versamenti
comminata nell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
I temi affrontati nelle sentenze richiamate, al di
là dei singoli giorni di ritardo e della soluzione
interpretativa adottata dalla Suprema Corte, interessano la generalità delle municipalizzate che
in Italia si occupano della fornitura del gas metano e rappresenta un’ottima occasione per soffermarsi sulla distinta questione, anch’essa
emersa nel corso di entrambi i giudizi, dell’applicabilità dello ius superveniens intervenuto in
pendenza di giudizio con riferimento al trattamento sanzionatorio applicabile al contribuente.
Infatti, dopo che entrambi i giudizi erano stati incardinati (3), è intervenuto il comma 31 dell’art.
23 del D.L. n. 98/2011 che ha esteso (4) la riduzione delle sanzioni pari ad un quindicesimo per
ogni giorno di ritardo a tutti i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni; la
sopravvenuta modifica normativa, come è evidente, essendo intervenuta in pendenza di giudizio, rileva in entrambi i casi in applicazione di
quanto disposto in via generale dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 secondo cui secondo cui «Se la legge in vigore al momento in cui è
stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica
la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo».
I giudici della Suprema Corte hanno però un atteggiamento completamente diverso rispetto alle
due fattispecie; in un caso (5) i giudici, senza
che la contribuente avesse minimamente sollevato la questione, evidenziano la rilevabilità «ex
officio dello ius superveniens costituito dal D.L.
6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, che, disponendo l’espunzione dal
testo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, del riferimento ai “crediti assistiti integralmente da
forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”, ha determinato la riduzione della
sanzione ad un importo pari ad un quindicesimo
444
4/2013
per ogni giorno di ritardo in relazione a tutte le
ipotesi di versamenti operati con un ritardo non
superiore a quindici giorni».
Nell’altra fattispecie, invece, nonostante la contribuente avesse specificamente (6) eccepito tale
circostanza, i giudici della Suprema Corte hanno
completamente trascurato di pronunciarsi sulla
questione.
Cosa cambia? Assolutamente nulla perché, come
già rilevato su questa stessa Rivista in altra occasione (7) e come pacificamente ammesso (8) dai
numerosi Autori che si sono nel tempo occupati
del problema, il giudice tributario valuta più che
l’ammontare dell’imposta in sé, la correttezza
dell’azione amministrativa al momento dell’emissione dell’atto, compiendo un giudizio sull’atto e non sul rapporto tributario che comunque
è e resta nelle mani degli Uffici fiscali nell’esercizio del potere amministrativo. Se un appunto
può farsi alla Suprema Corte è quello di essersi
pronunciata (o non pronunciata in uno dei due
casi) sullo ius superveniens, che era fuori dall’oggetto del processo tributario. Certo, nessuno
avrebbe avuto da ridire se in entrambe le decisioni la Corte di fosse limitata a menzionare la questione precisando espressamente che l’applicazione dello ius superveniens avrebbe dovuto essere valutata dall’Ufficio in sede amministrativa.
Quello che stupisce è il diverso atteggiamento
dei giudici di fronte ad una fattispecie analoga;
in una sentenza, quantunque a fin di bene, la
Corte si arrampica in difficilmente afferrabili diNote:
(3) Non si è quindi formato il giudicato sul punto, operando quest’ultimo quale ostacolo al potere dell’Ufficio fiscale di agire in
autotutela.
(4) Eliminando l’inciso contenuto nell’art. 13 del D.Lgs. n.
471/1997 che limitava il beneficio della riduzione alla specifica
fattispecie dei crediti assistiti da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’Amministrazione finanziaria.
(5) Punto 16 della sentenza n. 9565 del 2013.
(6) Siamo certi dell’inserimento della questione in memoria perché ci è stata gentilmente concessa la consultazione delle carte
processuali.
(7) D. Nolè, R. Lupi, «Processo tributario e processo amministrativo: il senso dell’impugnazione-merito», in Dialoghi Tributari n.
1/2013, pag. 72 ss.
(8) G.M. Cipolla, «Processo tributario e modelli di riferimento:
dall’onere di impugnazione all’impugnazione facoltativa», in Riv.
dir. trib., 2012, I, pag. 959 ove ampia bibliografia.
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
vagazioni sulla «rilevabilità d’ufficio» dello ius
superveniens, ed in un’altra - invece di dire (cor-
rettamente) che la rilevazione dello ius superveniens spetta all’Ufficio - tace del tutto.
Una «deroga» alla necessità di «autopunizione» del ravvedimento
operoso
RL
Le disposizioni generali sul «ravvedimento operoso» (art. 13 del D.P.R. n. 472/1997 sulle sanzioni tributarie) esasperano la logica della «autotassazione»; non solo infatti il contribuente
deve autodeterminare ed autoliquidare il tributo,
ma anche «autosanzionarsi» e liquidare eventuali interessi, per beneficiare di sanzioni più miti
di quelle ordinarie. È un altro riflesso dell’esternalizzazione della tassazione sui contribuenti
(9), e del «passo indietro» compiuto dagli Uffici
tributari. La assurdità dell’istituto è quella di
sanzionare nello stesso modo chi adempie tardivamente, ma non si «autosanziona» rispetto a
chi non adempie affatto, e viene individuato in
sede di controllo, magari senza neppure immaginare di aver commesso una violazione per cui
ravvedersi. Il ritardo inconsapevole, proprio in
quanto inconsapevole, e nel caso in esame di 4
giorni, viene assurdamente equiparato all’omissione, senza una precisa volontà dietro, ma solo
per intrecci legislativi che si autoproducono e
oggettivamente soffocano il buonsenso. Nel caso di specie fu molto opportuna la disposizione
del 2011, di portata generale, e secondo cui il
versamento tardivo comporta una sanzione giornaliera dell’1%, anche a prescindere dalla suddetta «autopunizione» del «ravvedimento operoso», che le società interessate, convinte di essere
nel giusto, o per disattenzione, non avevano attivato in tempo. Come giustamente rileva Vignoli,
la legge più favorevole al trasgressore è applica-
bile de plano in base all’art. 3 del D.Lgs. n.
472/1997; secondo i principi generali dell’intangibilità delle situazioni giuridiche definite, sul
piano del diritto transitorio, la disposizione è applicabile alle violazioni anteriori al 2011 che
non si fossero rese definitive al momento dell’entrata in vigore della modifica; è un principio
generale, ribadito dalla circolare n. 41/E del
2011 dell’Agenzia delle entrate di cui si riporta
il relativo stralcio (10). La sentenza n. 9565 del
2013 arriva a questa conclusione, ma in modo
indiretto, con riferimento a precedenti in materia
di «danno da occupazione illegittima» (?). Doversi sforzare per un ragionamento così ovvio
conferma le disfunzioni della «via giurisdizionale» al diritto tributario (11).
Note:
(9) Derivante dalla «tassazione attraverso le aziende», di cui parliamo sempre su Dialoghi.
(10) Circolare 5 agosto 2011, n. 41/E (in Banca Dati BIG Suite,
IPSOA): «La nuova previsione, in virtù del principio sancito dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo».
Basta un minimo di buonsenso per accorgersi che la definitività
del rapporto va vista al momento di entrata in vigore della legge
del 2011, non successivamente, qualora il giudice abbia accolto la
tesi delle Dogane, senza menzionare - per palese negligenza - lo
ius superveniens.
(11) Che deresponsabilizza gli Uffici e progressivamente paralizza, sotto i nostri occhi, l’attività della macchina pubblica, amministrativa, e indirettamente giurisdizionale.
La sentenza
Cassazione, Sez. trib., Sent. 19 aprile 2013 (11 marzo 2013), n. 9565 - Pres. Pivetti - Rel. Conti
Svolgimento del processo
1. L’UTF di Milano evidenziava che la AMGA Legnano aveva effettuato in ritardo di quattro giorni
rispetto al termine legale - sancito dalla legge n.
388/2000, art. 28 - il pagamento della rata di acconto di dicembre 2002 dell’accisa dovuta sul gas
metano, per di più utilizzando il modello F24, in
violazione del D.M. 27 novembre 2002, art. 2.
4/2013
445
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
2. Detto Ufficio contestava a tale società le sanzioni dovute rispettivamente in forza del D.Lgs. n.
471/1997, art. 13, comma 1, e D.Lgs. n. 504/1995,
art. 50 richiedendo, successivamente, il pagamento
di interessi ed indennità di mora.
3. Di seguito l’Ufficio emetteva, ai sensi del
D.Lgs. n. 472/1997, art. 16, un atto di contestazione per ciascuna delle violazioni riscontrate, irrogando le relative sanzioni.
4. La società contribuente proponeva ricorso alla
CTP di Milano che confermava la legittimità
dell’atto di irrogazione della sanzione, ritenendo la
portata generale dell’art. 13 D.Lgs. cit.
5. La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente innanzi alla CTR della Lombardia che,
con sentenza depositata il 29 marzo 2010, rigettava il ricorso.
6. Il giudice di appello, premesso che dovevano ritenersi proposte per la prima volta in fase di appello le questioni relative all’inapplicabilità del
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 in caso di tardivo pagamento, alla non applicabilità delle sanzioni in
ragione della legge n. 212/2000, artt. 2 e 10, alle
obiettive condizioni di incertezza sulla portata della legge n. 388/2000, art. 28 e all’assenza di danno
in capo all’Erario(alla stregua del D.Lgs. n.
472/1997, artt. 5 e 6), osservava che malgrado l’inammissibilità di tali eccezioni, le stesse erano comunque infondate nel merito.
6.1 Quanto alla prima, infatti, osservava che non
potevano esservi dubbi in ordine alla portata precettiva dell’art. 28 cit., anche considerando il tempo trascorso dall’entrata in vigore della stessa.
6.2 Aggiungeva, poi, quanto al D.Lgs. n.
472/1997, art. 6, che la violazione contestata era
frutto di disattenzione o non adeguata organizzazione da parte della contribuente. Nemmeno potevano prospettarsi situazione di incertezza circa la
portata della norma sanzionatoria, negligenza, imprudenza ed imperizia.
7. La società contribuente ha proposto ricorso per
Cassazione, affidato a quattro motivi, al quale ha
resistito l’Agenzia delle Dogane con controricorso. La società contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
8. Con il primo motivo la società contribuente ha
dedotto violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 57,
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta che la CTR aveva dichiarato inammissibili
le eccezioni che la stessa aveva formulato fin dal
ricorso introduttivo con riferimento alla chiesta disapplicazione della sanzione ed all’iniquità del
446
4/2013
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 rispetto all’equiparazione fra ritardo ed omissione del versamento di
quanto dovuto a titolo d’imposta.
8.1 Analoghe considerazioni occorreva fare rispetto alla dedotta buona fede del contribuente, all’assenza di danno erariale ed alla sproporzione manifesta tra entità del tributo e sanzione, già entrambe
prospettate nel corso del giudizio di primo grado.
Ragion per cui doveva escludersi che vi fosse stata
una modifica del petitum come ritenuto dalla CTR.
9. Con il secondo motivo la società contribuente
deduce la violazione del D.Lgs. n. 471/1997, art.
13. Lamenta, in particolare, che la CTR aveva ritenuto di fare applicazione dell’art. 13 ult. cit. ancorché essa società avesse ritardato di soli 4 giorni
il versamento dovuto, provvedendo altresì al pagamento degli interessi e dell’indennità di mora,
equiparando il mancato adempimento all’ipotesi,
ricorrente nel caso concreto, di mero ritardo nel
pagamento.
10. Con il terzo motivo la società contribuente ha
dedotto l’omessa o insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta
che la CTR non aveva adeguatamente considerato
la sussistenza delle cause di non punibilità sancite
dal D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6, omettendo di
prendere in considerazione gli argomenti esposti a
sostegno dell’esclusione della sanzione, della buona fede della contribuente e dell’assenza di pregiudizio erariale.
11. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di
omessa motivazione, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR, rispetto alla dedotta sproporzione fra entità del tributo evaso e sanzione, non aveva ritenuto di applicare il D.Lgs. n.
472/1997, art. 7, valutando come insussistenti i
presupposti per la riduzione della sanzione. Così
facendo aveva tralasciato di considerare gli elementi di fatto puntualmente allegati ed invece non
adeguatamente ponderati dal giudice di appello.
12. L’Agenzia delle Dogane, nel controricorso, ha
dedotto l’infondatezza del primo motivo di ricorso, risultando che la società contribuente solo in
appello aveva prospettato l’applicazione del
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5 e 6.
12.1 Quanto al secondo motivo, l’Agenzia evidenziava che questa Corte, con sentenza n.
23517/2008, aveva definitivamente chiarito che
l’indennità di mora a carico del contribuente persegue finalità diversa da quelle attuate attraverso
l’irrogazione della sanzione.
12.2 Evidenziava, inoltre, che la motivazione della
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
sentenza impugnata aveva adeguatamente esposto
le ragioni che giustificavano il rigetto delle eccezioni sollevate dalla società contribuente in ordine
alla ricorrenza della buona fede ed alla sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicata.
13. La prima censura è fondata.
13.1 Ed invero, la parte ricorrente ha documentato
- v. pag. 27 del ricorso che riporta le pagg.8-9 del
ricorso introduttivo - di avere esposto, fin dall’atto
introduttivo, le questioni concernenti l’applicabilità del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, nonché quelle
relative alla rilevanza, nel caso di specie, del
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7, comma 4, ed alla condizione di buona fede della società contribuente v. pag. 35 del ricorso che riproduce le pagg. 9-12
del ricorso introduttivo-.
13.2 Tanto è sufficiente per escludere la modifica
del petitum in grado di appello allorché la società
anzidetta ha formulato specifiche censure alla decisione di prime cure fondate sull’asserita violazione delle disposizioni normative appena ricordate. Senza dire che lo stesso giudice di appello ha
poi ritenuto di esaminare nel merito le censure
prospettate, rigettandole.
14. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
14.1 Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema
di violazioni amministrative tributarie, il D.Lgs. n.
471/1997, art. 13 ha una portata generale, applicandosi come espressamente indicato nel secondo
comma, ad «ogni ipotesi di mancato pagamento di
un tributo o di una frazione nel termine previsto».
Pertanto tale sanzione è applicabile anche nell’ipotesi di mancato o tardivo versamento delle accise mentre deve escludersi che possa determinarsi
un’ipotesi di cumulo di sanzioni ove sia stata richiesta anche l’indennità di mora e gli interessi in
concorso con la sanzione, ai sensi del D.Lgs. n.
504/1995, art. 3, comma 4, trattandosi di imposizioni di pagamento assolutamente infungibili rispetto alle pretese sanzionatorie perché giustificate
da natura e funzione esclusivamente e rispettivamente risarcitoria e reintegrativa (cfr. Cass., Ord.
14 aprile 2011, n. 8553; Cass., Ord. 4 agosto 2010,
n. 18140; Cass., 19 giugno 2009, n. 14303; Cass.,
12 settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise).
15. Il terzo ed il quarto motivo che vanno esaminati congiuntamente, involgendo entrambe le censure postulati deficit motivazionali della sentenza
impugnata con riguardo alla mancata applicazione
del D.Lgs. n. 472/1997, artt. 5, 6 e 7, sono infondati.
15.1 Entrambe le doglianze muovono dalla rile-
vanza della situazione di buona fede della società
contribuente rispetto al ritardato pagamento dell’accisa che avrebbe confidato sul termine di scadenza del 31 dicembre. Nemmeno la CTR aveva
considerato l’occasionalità dell’inadempimento e
l’assenza di danno, non adeguatamente motivando
il rigetto delle eccezioni.
15.2 Orbene, di alcun pregio è, anzitutto, la questione relativa alla occasionalità del ritardo, in relazione al D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, che la società
contribuente richiama deducendo erroneamente
l’omessa motivazione del giudice di appello, una
volta che la sanzione applicata alla stessa prescindeva totalmente dal grado di colpa - lieve o grave
-.
15.3 Nemmeno coglie nel segno la dedotta omessa
motivazione in ordine agli ulteriori profili di cui al
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, se è vero che lo stesso
giudice ha escluso l’operatività di detta disposizione con riguardo alla asserita situazione di incertezza del quadro normativo ritenendo, senza commettere alcun vizio di legge né di congruità logica,
che la violazione ascritta alla società era conseguenza di insufficiente attenzione o da inadeguata
organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge fiscale.
15.4 Anche rispetto all’assenza di danno la CTR
ha evidenziato che in realtà la disposizione di cui
all’art. 13 cit., prevedendo una sanzione commisurata al 30% del tributo non versato, aveva equiparato il ritardato pagamento all’omesso versamento,
ritenendo non irragionevole tale previsione normativa, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte costituzionale (Ord. n. 2249/2008). Senza dire che la
vicenda esaminata dal giudice di appello integrava, come mostra di avere ritenuto implicitamente
il giudice di appello, ex sé il danno per il mancato
versamento del tributo nel termine previsto e, dunque, per la mancata disponibilità delle somme da
parte dell’Amministrazione nel termine normativamente fissato.
15.5 Del pari destituito di fondamento appare il
dedotto vizio motivazionale con riguardo al
D.Lgs. n. 472/1997, art. 7 ed all’omessa valutazione delle circostanze eccezionali che avrebbero dovuto giustificare la riduzione della sanzione in relazione alla manifesta sproporzione tra l’entità del
tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.
15.6 Correttamente, infatti, il giudice di appello ha
evidenziato che a sostegno di tale eccezione la società contribuente aveva posto la situazione di
buona fede in ordine al ritardato pagamento, che
lo stesso giudice aveva ritenuto insussistente, non
4/2013
447
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
allegando ulteriori ragioni in fatto per ritenere provata la dedotta sproporzione.
15.7 La motivazione della sentenza impugnata appare dunque idonea a descrivere l’iter seguito dal
giudice di appello per disattendere le argomentazioni difensive esposta dalla società contribuente
e, pertanto, si sottrae alle critiche esposte nelle due
censure qui esaminate.
16. Occorre tuttavia evidenziare che va applicato
ex officio lo ius superveniens costituito dal D.L. 6
luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 31, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, che, disponendo l’espunzione dal testo del
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13 del riferimento ai «crediti assistiti integralmente da forme di garanzia
reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria», ha determinato la riduzione della sanzione ad un importo pari
ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo in
relazione a tutte le ipotesi di versamenti operati
con un ritardo non superiore a quindici giorni.
L’applicabilità di tale modifica normativa (la quale, incidendo favorevolmente sull’entità della sanzione, coinvolge il presente giudizio, giusta il
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3, comma 3), difatti, successiva alla proposizione del ricorso, è mediata
dalla formulazione dei motivi tre e quattro, direttamente attinenti alla quantificazione della sanzione,
giusta la precisazione, di carattere generale, resa
dalla Corte in controversia similare (vedi, in particolare, Cass., 13 maggio 1997, n. 4182, secondo
cui nel giudizio di cassazione, in cui i motivi del
ricorso esplicano una funzione determinativa e limitativa dell’oggetto del giudizio, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima cosiddetta appropriativa, prevedendone l’applicabilità anche nei procedimenti in corso, non può trovare applicazione, quale ius superveniens, se i motivi di ricorso non valgono a porre in discussione
la quantificazione, compiuta dal giudice di merito,
del risarcimento del danno).
17. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettati i restanti, la sentenza impugnata
va cassata.
18. Non occorrendo accertamenti di fatto, la causa
deve essere decisa nel merito, con il parziale accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta dalla società, mediante l’applicazione della
riduzione della sanzione ad un importo pari ad un
quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
19. Le particolarità della controversia comportano
la compensazione di tutte le voci di spesa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e respinge i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara ridotta la sanzione irrogata in applicazione dei parametri fissati dal D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, art. 23, comma 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Compensa tutte le voci di spesa.
La sentenza
Cassazione, Sez. trib., Sent. 17 aprile 2013 (12 marzo 2013), n. 9285 - Pres. Pivetti - Rel. Conti
Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 22 luglio 2010 la
Commissione Tributaria regionale del Piemonte
confermava la decisione resa dalla CTP di Alessandria che, in accoglimento del ricorso proposto
dalla CTV srl in liquidazione, già Chiara Gaservizi
s.r.l., aveva dichiarato l’illegittimità degli atti con i
quali l’Ufficio delle dogane di Alessandria aveva
richiesto il pagamento di interessi legali, indennità
di mora e sanzioni per il ritardato pagamento delle
rata di acconto dell’accisa dovuta sul gas metano
per il mese di dicembre 2005.
2. Osservava la CTR che in relazione al contenuto
448
4/2013
dispositivo del D.Lgs. n. 504/1995, art. 26, comma
8 e legge n. 388/2000, art. 28, comma 6 risultava
evidente come la fissazione del termine di pagamento al 27 dicembre per le accise relative al gas
metano riguardava soltanto l’anno 2001, essendo
stata introdotta per rendere più agevole il passaggio all’Euro a decorrere dall’anno 2002 e non poteva, quindi, ritenersi applicabile per i versamenti
dovuti per gli anni successivi, non essendo peraltro mai stata disposta analoga disposizione all’interno del testo unico accise.
3. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
ha resistito la società contribuente con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
4. Con un unico motivo l’Agenzia delle dogane
prospetta violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 6 e legge n.
388/2000, art. 28, comma 6, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la
CTR aveva errato nel ritenere inoperante il termine del 27 dicembre fissato dal comma 6 dell’art.
28 cit. detta disposizione, infatti conteneva una
previsione avente valenza generale, non limitata
all’anno 2001, collegata alla contestuale introduzione della modalità di pagamento a mezzo F24
disposta con la legge finanziaria 2001 e non già all’entrata in vigore dell’Euro, come opinato dal
giudice di appello.
5. La società controricorrente ha dedotto l’infondatezza della censura, evidenziando in ogni caso la
ricorrenza di obiettive incertezze normative, correlate alla doppia conforme rappresentata dalle decisioni dei due gradi di giudizio che avevano accolto
il ricorso, tali da escludere la sanzione irrogata.
6. La censura è infondata.
6.1 Occorre rammentare che ai sensi dell’art. 26,
comma 8, T.U.A., nella versione ratione temporis
applicabile anche all’accisa relativa al gas metano,
stabiliva che «il pagamento dell’accisa deve essere
effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di
ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell’anno precedente».
6.2 A tale disciplina si è aggiunta quella introdotta
dalla legge n. 388/2000, art. 28, comma 6, a cui tenore «Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni i versamenti per i quali la
scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere
effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.».
6.3 Peraltro, l’art. 3, comma 4 TUA cit., nel testo
modificato dal D.L. n. 209/2002, art. 3 conv. nella
legge n. 265/2002, dopo avere premesso, in via
generale, che i termini e le modalità di pagamento
dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, ha aggiunto che ... Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al
15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stes-
so mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, art. 17. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a
quelli fissati nel periodo precedente.
6.4 Orbene, reputa la Corte che la lettura composita delle disposizioni normative sopra riportate lascia chiaramente intendere che per le accise disciplinate dal TUA la scadenza del termine previsto
per il versamento dell’accisa non può che coincidere con il 27 dicembre di ogni anno, in assenza di
un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disponga diversamente.
6.5 Ed è proprio l’analisi sistematica delle disposizioni suindicate ad escludere che alla legge n.
388/2000, art. 28, comma 6, possa attribuirsi efficacia temporale limitata alle imposte dovute per
l’anno 2001 per come prospettato dalla CTR, non
ravvisandosi alcuna plausibile ragione, ad onta di
quanto diversamente postulato dalla società controricorrente, per individuare, quale ratio della disposizione anzidetta, l’entrata in vigore dell’Euro
e, soprattutto, per delimitarne l’efficacia temporale
in assenza di un’esplicita indicazione in tal senso,
semmai individuandosi un’opposta esigenza, chiaramente espressa dal legislatore di fissare in via
generale nel termine del 27 il dies ad quem entro il
quale effettuare i relativi versamenti delle accise.
6.6 Né sembrano giocare in senso favorevole alla
tesi esposta dalla società contribuente i decreti ministeriali che, a partire dall’anno 2003, hanno individuato espressamente i termini per il versamento
delle accise, richiamando la scadenza del 27 dicembre ed espressamente non regolando l’imposta
sul gas metano - specificamente D.M. Finanze 13
dicembre 2005, - dovendosi per quest’ultimo applicare la regola generale contemplata dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4 T.U.A. cit., della legge n. 388/2000, art. 28, comma 6.
Norma, quest’ultima, mai abrogata né derogata da
diverse determinazioni ministeriali, le quali, come
detto, non avrebbero peraltro posticipare il termine
di versamento alla data del 27 dicembre.
6.7 La decisione impugnata che non è si conformata a tali principi, muovendo da un’interpretazione parcellizzata della legge n. 388/2000, art. 28,
comma 6, e nemmeno agganciata a solide basi argomentative quanto alla limitata portata temporale
dallo stesso giudice affermata in modo apodittico è
incorsa nel vizio di violazione di legge prospettato
dalla parte ricorrente.
7. La sentenza impugnata va dunque cassata.
4/2013
449
Sanzioni
Cass. n. 9565 e n. 9285 del 2013
8. La causa può essere decisa nel merito, non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto,
essendo il caso di evidenziare che la società contribuente non ha documentato di avere riproposto
in grado di appello né l’eccezione relativa all’insussistenza dei presupposti per applicare la sanzione in relazione all’incertezza obiettiva della legge
- peraltro infondata alla stregua dei consolidati
principi espressi da questa Corte - per cui v. Cass.
n. 8825/2012, né le eccezioni che la controricorrente richiama sbrigativamente nel controricorso e
per le quali ha chiesto, in caso di accoglimento del
ricorso, che sia il giudice del rinvio a statuire. In
definitiva, la parte contribuente, sulla quale incombeva il relativo onere, non si è curata di indicare i termini esatti in cui le eccezioni era state
sottoposte al giudice di appello, ragion per cui le
450
4/2013
stesse devono ritenersi abbandonate - cfr. Cass. n.
14925/2011; Cass. n. 5970 del 14 marzo 2011.
9. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico
della società contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della società contribuente
Compensa le spese della fase di merito.
Pone a carico della società contribuente le spese
del giudizio di legittimità che liquida in Euro
12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a
debito.
Fiscalità
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
internazionale
Le due anime dei costi «black list»
tra ricchezza non registrata
(retrocessione occulta)
e «transfer pricing rinforzato»
di Fabio Gallio, Valentina Perrone, Raffaello Lupi
La diffidenza verso l’estero, come zona estranea al potere impositivo, aumenta quando si tratta
di «parti correlate» e di Paesi con regimi fiscali più favorevoli: nel primo caso c’è il sospetto di
corrispettivi palesi guidati dalla convenienza tributaria («tranfer pricing»), nel secondo il sospetto di una retrocessione occulta di parte delle risorse finanziarie movimentate in modo palese. Su queste premesse riprendiamo il discorso sui costi «black list», in cui coesistono due
anime, una originaria di «transfer price» e una «antifrode» connessa al sospetto che parte del
corrispettivo venga retrocessa «sottobanco» al cliente. Siccome è difficilissimo dimostrare direttamente la retrocessione, si è tentato di fronteggiare alla meglio questo sospetto in via legislativa, rendendo necessarie valutazioni sull’organizzazione sia del cliente, sia del fornitore, sia
sulla tipologia di servizio, sull’ammontare del corrispettivo, sull’eventualità che il fornitore
«black list» sia a sua volta emanazione di un fornitore reale, per evadere le imposte del suo
Paese, senza alcun pregiudizio per la fiscalità italiana. Sono valutazioni concettualmente analoghe a quelle sulla vicenda dell’interposizione nei diritti televisivi, che cerchiamo di riprendere e
generalizzare.
I costi «black list» tra evasione interpretativa e ricchezza non registrata
Fabio Gallio
I costi black list si discostano dal tema dell’inerenza, in quanto apparentemente sono relativi all’ordinario esercizio dell’attività di impresa, e raramente sono contestabili sotto il profilo dell’attribuzione all’impresa di consumi personali e familiari, tipo viaggi, autovetture, telefoni, residenze secondarie, imbarcazioni, ecc. I motivi di
sospetto sono altri, mentre in genere i costi black
list, in quanto riguardano spese strumentali all’attività dell’impresa, e non già esborsi riconducibili alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo, superano il test di inerenza, intesa come nozione strutturale alla determinazione della ricchezza, legata
all’idea del reddito come entità calcolata al netto
dei costi sostenuti di produzione.
Su questa premessa, di riconducibilità del costo
all’esercizio dell’impresa, l’inerenza non può
essere disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria, come sancito dalla Suprema Corte di
legittimità (1) e, anche nel caso della maggior
parte dei costi black list, incomberebbe sugli accertatori l’onere di dimostrare che il componente negativo di reddito non può essere dedotto,
trovando prove per dare concretezza ai sospetti
di retrocessione indicati nell’abstract del presente articolo e di cui diremo più avanti.
Fabio Gallio - Cultore di Diritto tributario presso l’Università degli
Studi di Trieste, Avvocato, Dottore commercialista e Revisore legale in
Padova, Studio Terrin e Associati, Padova e Milano
Nota:
(1) Tra le altre, cfr. Cass., 12 febbraio 2013, n. 3340, in Banca Dati
BIG Suite, IPSOA.
4/2013
451
Fiscalità
internazionale
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
Al di là di tante fumose contestazioni, anche di
fiscalità domestica, il Fisco non ha il potere di
sostituirsi all’imprenditore accampando la mancanza di contratti scritti, o la non necessità della
spesa, salvo utilizzare questi argomenti come indizio di fittizietà dell’operazione. Se però quest’ultima è «effettiva» il Fisco non può entrare
nel merito delle scelte imprenditoriali, salvo che
l’«antieconomicità» non sia un indizio di fittizietà, tale da invertire l’onere della prova a carico del contribuente (2).
Subentrano, quindi, per rafforzare la posizione
dimostrativa del Fisco, altre normative che devono essere rispettate come quella sui costi
black list. I sospetti di trasferimenti di ricchezza
tra parti a prima vista indipendenti si innestano
su quelli di illecita pianificazione tra soggetti
correlati. Su questo sfondo si inserisce l’indeducibilità dei costi black list, temperata dalle due
«esimenti» sulla prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva (cd. prima esimente), ovvero che
le operazioni poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione (cd. seconda
esimente).
Quello che il legislatore vorrebbe evitare è che
un operatore economico (imprenditore o professionista), che intrattiene rapporti commerciali o
di lavoro con soggetti che pagano imposte inferiori o addirittura non le pagano, abbia la tentazione di corrispondere prezzi di acquisto maggiori rispetto a quelli di mercato e concordare
con il proprio fornitore che tale eccedenza venga retrocessa. È un comportamento molto spesso
inverosimile, vista la tipologia di soggetti coinvolti, ma possibile, e che esprime la ratio dell’intervento normativo.
Con tale operazione, il soggetto nazionale riceve
una provvista «esentasse» in quanto deduce i
costi in Italia, con conseguente abbattimento del
suo reddito imponibile.
Naturalmente, per potere portare a termine tale
disegno, deve esserci un accordo fiduciario tra i
due operatori.
Infatti, il soggetto estero che attribuisce sottobanco le risorse finanziarie deve essere un soggetto ben conosciuto dall’operatore italiano, ed
in cui egli ripone fiducia. In caso contrario, l’o-
452
4/2013
peratore italiano, oltre ad essere soggetto a ricatti, potrebbe anche non ricevere quanto concordato, in quanto il fornitore, appena ricevuta la
provvista, potrebbe chiudere i battenti e sparire.
Pur comprendendo la finalità della norma, ed
anche la sua utilità, essa va applicata cum grano
salis, tenendo conto dei casi in cui l’utilizzazione del paradiso fiscale dipende dalle circostanze, dal mercato o dalle scelte del fornitore. Si
tratta, insomma, di valutare le circostanze economiche che fanno svanire i sospetti indicati sopra, ed è questo lo scenario in cui interpretare le
due esimenti.
La verosimiglianza delle retrocessioni occulte
nelle aziende a «conduzione familiare»
Partiamo dal presupposto secondo cui le patologie che legittimano i sospetti possono essere addottate solamente da quelle strutture societarie
dove è il socio imprenditore che comanda e gestisce l’impresa, e quindi ha la possibilità di accordarsi con la controparte, direttamente o tramite suoi fiduciari (3).
Solo in questo caso l’effettivo beneficiario si
sente fiducioso di scavalcare le procedure amministrative della propria azienda (management
overriding all’italiana) per proprie finalità personali, confidando di poter gestire i relativi rischi. Generalmente, ciò si verifica nelle strutture
societarie a «conduzione familiare».
Qualora tale interesse diretto manchi, difficilmente può ipotizzarsi la patologia presupposta
dalla norma. Si pensi, ad esempio, alle complesse strutture societarie dei maggiori gruppi multinazionali, dove ci sono numerosi soci e figure
apicali. In questo caso, l’operatore, che ha rapporti con il fornitore estero (si pensi al responsabile acquisti), agisce all’interno di un ambiente
di lavoro complesso con procedure rigide (basti
pensare a quelle relative al modello previsto dal
D.Lgs. n. 231/2001), dove si ha l’obbligo di giuNote:
(2) O per meglio dire, seguendo l’impostazione di Lupi sull’improprietà del riferimento all’onere della prova in materia amministrativistica, per «legittimare prima facie l’emanazione dell’atto di
accertamento».
(3) Cfr. la sentenza sui diritti televisivi esaminata da R. Lupi, «Gli
interposti, gli imprenditori e le aziende (tra caso Mediaset e tutoraggio fiscale)», in questa Rivista, pag. 435.
Fiscalità
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
stificare il proprio operato, non solo ai propri
superiori e/o alle altre figure apicali, ma anche,
in termini di risultato, ai soci che molte volte
non si conoscono (si pensi alle società quotate o
con azioni diffuse tra il pubblico).
Conseguentemente, l’operatore avrebbe interesse diretto nel richiedere al fornitore estero di applicare maggiori costi solo se riuscisse a distrarre l’eccedenza su suoi conti personali, rendendo
la società una vittima della frode di un suo amministratore, come del resto è parzialmente avvenuto nel caso dei diritti TV, relativi a società
quotate, in cui erano presenti (oltre al dominus)
soci di minoranza.
Oltre ad essere smascherati dai controlli interni
della struttura, questi comportamenti potrebbero
anche essere fonte di ricatto, sul piano negoziale
futuro, da parte del fornitore compiacente. Solamente nel caso in cui tutta la struttura del gruppo (soci, amministratori, e altre figure apicali)
fossero a conoscenza (e d’accordo) nello sfruttare tali opportunità, l’operazione potrebbe essere
effettuata. Ma ciò è veramente impensabile nei
gruppi strutturati che non hanno come socio di
riferimento una famiglia o un imprenditore, che
può intervenire direttamente nella trattativa con
il soggetto terzo.
L’intreccio «black list» e «transfer pricing»
Del tutto diverse, e questa è la seconda anima
della norma sui costi black list, sono le operazioni di fornitura all’interno dello stesso gruppo.
In questo caso, infatti, l’interesse dei contribuenti consisterebbe nello spostare materia imponibile in Paesi a bassa fiscalità e ridurre, conseguentemente, il carico fiscale complessivo.
Codesto comportamento, però, è già contrastato
dalla normativa sul transfer pricing, che deve
essere quindi coordinata con da quella relativa
ai Paesi black list.
La differenza tra le due discipline è sostanziale,
anche con le sovrapposizioni di cui diremo.
Il transfer pricing, come noto, ha lo scopo di
contrastare fenomeni elusivi di trasferimento
di base imponibile da un Paese all’altro, presupponendo che l’operazione è stata effettivamente effettuata. In tale caso, la ricchezza rimarrebbe all’interno del gruppo, ma si incrementerebbe a causa del minor carico fiscale
internazionale
complessivo ottenuto attraverso precise politiche dei prezzi di trasferimento. Infatti, se le
transazioni venissero effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo non a valore di
mercato, l’Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a disconoscere i maggiori costi
rispetto a quelli che si sarebbe sostenuti (e dedotti) se la fornitura fosse stata portata a termine da un soggetto terzo.
Per effettuare tale verifica sono stati elaborati
alcuni criteri per la determinazione dei prezzi di
trasferimento, i quali, però, devono essere adattati alla realtà aziendale specifica, e la correttezza della loro applicazione è soggettivamente valutabile.
Pertanto, il fenomeno, che la normativa sul transfer pricing vuole contrastare, si può definire come «evasione interpretativa», la quale presuppone che l’operazione è stata effettuata, anche se
ad un valore non coerente con quello normale.
In altri termini, non viene messo in dubbio che
la transazione sia stata effettuata o che il soggetto che ha effettuato la fornitura sia esistente o
meno. Se ciò si verificasse, l’operazione per definizione non avrebbe valore e, quindi, l’intero
costo sarebbe indeducibile.
Oggetto di rettifica è solamente il valore dato
dalle parti al trasferimento del bene o del servizio.
Conseguentemente, se la fornitura all’interno di
un gruppo venisse portata a termine da un soggetto residente in un paradiso fiscale al suo valore normale, nessuna contestazione potrebbe
essere avanzata dall’Amministrazione finanziaria in termini di deducibilità, in quanto, non solo
sarebbe evidente l’esistenza dell’operazione e
della controparte (in caso contrario, il valore
dell’operazione sarebbe nullo), ma anche sarebbe indiscutibile l’interesse ad effettuarla (in caso
contrario, non si farebbe riferimento ai valori di
mercato, ma a quelli fuori dallo stesso).
Resta il coordinamento con la disciplina sulla
indeducibilità dei costi black list, che si riferì
per molto tempo solo ai rapporti infragruppo,
con le sovrapposizioni di cui dicevamo e su cui
si soffermeranno anche gli Autori che seguono.
Una ragione è che, ai fini del transfer pricing, si
presuppone una trasparente rappresentazione dei
rapporti intercompany, mentre nel caso dei Paesi
4/2013
453
Fiscalità
internazionale
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
black list si sospetta anche un artificio, tendente
a esagerare il contenuto delle prestazioni ricevute, magari con funzioni più apparenti che reali,
dirette a legittimare la deduzione di un costo più
elevato. Per questi motivi è ragionevolmente
ipotizzabile che, per molti costi con parti corre-
late ubicate in Paesi black list, non basti il rispetto del valore normale nella determinazione
dei prezzi di trasferimento, ma possano essere
chiesti, a seconda dei singoli casi, anche requisiti più stringenti, di cui parleranno gli Autori che
seguono.
L’indeducibilità dei costi «black list» e il suo coordinamento
col «transfer pricing»
Valentina Perrone
Le riflessioni svolte su questo numero di Dialoghi a proposito della sentenza sui diritti televisivi Mediaset hanno ricadute sul rapporto tra le
condizioni di deducibilità dei costi sostenuti verso soggetti localizzati in Paesi black list, delineate dall’art. 110, comma 10, del T.U.I.R. e la
disciplina dei prezzi di trasferimento, contenuta
nel comma 7 del medesimo articolo.
In tutti e due i casi ritroviamo la diffidenza verso i rapporti con l’estero alimentata dal timore,
da un lato, che materia imponibile venga sottratta al Fisco italiano per essere dirottata verso
Paesi a regime fiscale privilegiato e, dall’altro,
che costi fittizi vengano attribuiti ad aziende residenti da parte di fornitori operanti in Paesi a
bassa fiscalità. A destare sospetto, in altre parole, sono tanto le modalità per nascondere al Fisco la ricchezza con le retrocessioni occulte di
cui parlava Gallio, sia quelle per canalizzare
apertamente ricchezza verso regimi più convenienti; infatti - come peraltro già rilevato da
Raffaello Lupi in altro contributo su un numero
precedente di questa Rivista (4) - nelle disposizioni antiparadisi spesso questi due profili tendono a confondersi e sovrapporsi.
Anche se la sovrapposizione, anticipata da Gallio, resta, è possibile coordinare gli ambiti applicativi delle due discipline.
Le disposizioni in materia di transfer pricing,
infatti, si collocano nel mondo della ricchezza
registrata in quanto preordinate a contrastare fenomeni di pianificazione fiscale tra parti correlate e sono destinate ad operare qualunque sia il
Paese in cui la controparte risieda, non necessariamente ed esclusivamente, quindi, con riguardo a transazioni intercorse con soggetti residenti
454
4/2013
in un paradiso fiscale. In questi casi, poiché la
ricchezza giunge in modo palese nello Stato o
territorio in cui è localizzata la controparte, essendo dichiarato che si tratta di una società controllata, o comunque correlata, non può ravvisarsi alcuna ricchezza «nascosta». È quindi corretto affermare che le norme dettate dall’art.
110, comma 7, del T.U.I.R. tendono a colpire come detto anche da Gallio - quella che su questa Rivista è generalmente chiamata «evasione
intepretativa».
Per contro, l’applicazione più frequente delle
norme che limitano la deducibilità dei costi con
Paesi a regime fiscale privilegiato, contenute
nell’art. 110, comma 10, del T.U.I.R., è essenzialmente con soggetti apparentemente indipendenti; la giustificazione logica, sul piano della
determinazione della ricchezza, è quindi nel sospetto di una «finta indipendenza» della controparte oppure della retrocessione occulta indicata
sopra e anche da Gallio. Nella «finta indipendenza» possiamo trovare entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo, ma comunque in
grado di sfuggire al perimetro di controllo e
comportarsi come farebbe un soggetto interposto.
Tali disposizioni devono essere contestualizzate
rispetto alle molteplici forme di evasione internazionale ad esse preesistenti, al fine di comValentina Perrone - Dottore di ricerca in Diritto tributario presso
l’Università LUISS Guido Carli di Roma e Avvocato in Roma
Nota:
(4) Cfr. R. Lupi, «Paradisi fiscali tra prezzi di trasferimento e occultamenti di corrispettivi», in Dialoghi Tributari n. 6/2010, pag.
690.
Fiscalità
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
prenderne il contenuto e la funzione che intendono assolvere. Va evidenziato, in particolare,
come queste forme di evasione possano estrinsecarsi in molteplici comportamenti, solo alcuni
dei quali sono coperti dal relativo ambito applicativo, diversamente da altri che ne risultano invece del tutto trascurati. In particolare, l’art.
110, comma 10, del T.U.I.R. non offre alcuna
copertura all’uso dei paradisi dal lato dei ricavi.
Cioè all’ipotesi in cui l’operatore economico residente venda a prezzi notevolmente inferiori al
valore normale ad un soggetto ubicato in un
Paese a fiscalità privilegiata, in modo tale che i
suoi ricavi risultino inferiori a quelli effettivi,
con conseguente abbattimento del suo reddito in
Italia, mentre la differenza rispetto ai ricavi a
prezzo pieno rimarrebbero in capo ai soggetti
paradisiaci consentendo così la costituzione di
fondi occulti all’estero e l’evasione delle relative imposte, sempre in Italia. Questo caso è coperto con le disposizioni sul transfer pricing,
ma, ove la relazione di controllo sia tenuta nascosta, l’apparato normativo è privo di difese.
Pertanto, per capire la reale portata della disciplina limitativa della deducibilità dei costi black
list, è opportuno valutarne l’effettiva capacità
espansiva, individuando la prassi possibile che
essa mira a colpire ed esaminandone i potenziali
risvolti applicativi, sia con riguardo all’utilizzo
di parti correlate (cui era originariamente diretta
la disciplina), sia in relazione all’impiego di
soggetti non legati da vincoli di gruppo e, quindi, come detto, apparentemente indipendenti, ma
fiduciariamente condizionati.
Quando si vuole occultare materia imponibile,
infatti, un Paese a fiscalità privilegiata diviene
un polo di attrazione per i ricavi costituenti la
contropartita di costi deducibili in un Paese a fiscalità onerosa; i soggetti ubicati nel paradiso fiscale non hanno infatti generalmente problemi a
dichiarare entrate più elevate rispetto a quelle
effettive.
Questo meccanismo di solito presuppone che
vengano conclusi accordi di natura fiduciaria
con i predetti soggetti affinché si applichino
maggiorazioni dei prezzi, per poi retrocedere
estero su estero l’intero corrispettivo, ovvero la
differenza necessaria a coprire i costi effettivamente sostenuti, al cliente residente oppure a
internazionale
soggetti che presentino con quest’ultimo un
qualche collegamento. Ecco dunque che la disciplina sui costi black list verrebbe ad assolvere
una funzione anti-evasiva, proprio perché presuppone il sospetto di una patologica retrocessione parziale dei corrispettivi ricevuti, tale da
consentire la formazione di «fondi neri», cioè di
risorse sottratte a imposizione, suscettibili di essere utilizzate per molteplici finalità, di solito
estranee all’attività imprenditoriale, oppure destinate a fini imprenditoriali, ma inconfessabili
(corruzione, acquisto di segreti industriali, sabotaggio, finanziamento di movimenti insurrezionali, ecc.).
Per capire se questo sia o meno ragionevolmente
ipotizzabile non si può prescindere dall’analisi
di molteplici indizi, da valutare in modo contestuale e simultaneo. Nei paragrafi successivi li
raggrupperemo tra soggettivi, con riferimento
all’acquirente, e oggettivi, con riferimento alla
prestazione.
Gli indizi soggettivi sulla plausibilità
di una retrocessione occulta
Gallio ha già preannunciato che le retrocessioni
occulte in esame rappresentano un caso di management overriding, cioè di scavalcamento delle procedure aziendali tipiche. È quindi decisamente poco plausibile ipotizzare che accordi fiduciari di retrocessione possano essere conclusi
all’interno di strutture societarie spersonalizzate, magari quotate in borsa o comunque soggette
all’applicazione di rigide procedure (come quelle afferenti al modello previsto dal D.Lgs. n.
231/2000). Ciò essenzialmente in quanto - come
messo in evidenza anche da Gallio - spesso in
contesti di questo tipo il soggetto che ha direttamente rapporti con il fornitore estero potrebbe
non avere alcun interesse diretto a richiedere ed
ottenere l’applicazione di maggiorazioni di
prezzi ai beni e servizi acquistati, se non altro
perché comunque non beneficerebbe di alcun
vantaggio né in termini di riduzione del proprio
reddito - posto che a ridursi sarebbe solo l’imponibile della società per cui lavora - né tantomeno sottoforma di restituzione parziale sottobanco dei corrispettivi pagati, se, come di solito
accade, deve rispondere del proprio operato e
delle proprie performance, non solo ai propri su4/2013
455
Fiscalità
internazionale
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
periori, ma anche ad una platea di soggetti talvolta sconosciuti (come avviene nel caso di società quotate).
Maggiori margini per fenomeni di questo tipo
sono riscontrabili nel contesto del nostro capitalismo familiare, in cui le strutture imprenditoriali sono tendenzialmente contraddistinte dalla
presenza di figure apicali che si intromettono
nella gestione; qui, più che management overriding, c’è un ownership overriding, dove l’owner
è anche il manager, di diritto o di fatto. Costoro
sono infatti nella posizione di trarre vantaggio
dalla retrocessione occulta, perché acquisirebbero la disponibilità dei fondi occulti creati con i
meccanismi sopra descritti. Anche in questi casi,
comunque, è bene ribadirlo, la componente fiduciaria, e quindi la possibilità di fare affidamento
sulla complicità della controparte, assume un
ruolo fondamentale affinché la prassi che la norma intende contrastare possa trovare applicazione, posto che difficilmente anche lo stesso capitalista familiare, ove goda di una certa rispettabilità sul palcoscenico economico, deciderebbe
di concludere operazioni che potrebbero rivelarsi fonte di ricatto incontrollabile per un indeterminato tempo a venire. Per questo è ragionevole
l’assunzione di determinate cautele, come l’inserimento di un «filtro» tra la società acquirente
e il fornitore reale. Quest’ultimo, se strutturato,
potrebbe avere remore a restituire «sottobanco»
parte dei corrispettivi ricevuti. Inoltre, verosimilmente, la conclusione di accordi di retrocessione occulta con i fornitori effettivi potrebbe
esporre il cliente residente al rischio perenne di
essere tradito o ricattato qualora questi decidesse, per esempio, di non richiedere ulteriori forniture ovvero di non consentire per le nuove commesse l’applicazione di prezzi maggiorati.
Ecco perché, versomilmente, con conferme attraverso casi reali di cui si è avuta notizia, si ricorre ad un fiduciario interposto o comunque a
un soggetto con il quale l’acquirente dei beni o
servizi intrattiene un rapporto tale da garantirlo
contro rischi di questa natura. Un soggetto, dunque, non appartenente al medesimo gruppo di
cui fa parte l’acquirente, ma apparentemente indipendente, comunque compiacente o manovrabile, disposto a effettuare i suddetti ristorni con
sufficiente riservatezza e fiducia.
456
4/2013
Si trattava di profili non facili da cristallizzare
in norma, ed infatti le esimenti a prima vista riguardano i profili oggettivi, di cui diremo nel
prossimo paragrafo.
Gli indizi «oggettivi»:
prezzo, tipologia di prestazione, ecc.
Sul piano oggettivo, dell’analisi della prestazione acquistata, possono essere molteplici le ragioni, totalmente estranee all’ottenimento di una
convenienza fiscale, almeno per quanto attiene
all’acquirente: si pensi all’eventualità di beni
suscettibili di essere acquistati solo in Paesi a fiscalità privilegiata (come il petrolio), oppure
all’ipotesi in cui sia stato lo stesso fornitore a
decidere di farsi remunerare attraverso una sua
società posizionata in un Paese a fiscalità privilegiata per una prestazione effettivamente svolta, come un servizio tecnico o il noleggio di un
aeroplano. Come peraltro già osservato in altro
contributo su questa stessa Rivista (5), in casi
come questo, laddove il fornitore imponga che
la relativa fattura venga emessa da una società
che è una sua diretta emanazione ed è localizzata in un territorio black list, perché magari in
questo modo ha la possibilità di praticare condizioni economiche più vantaggiose rispetto ad altri fornitori, il cliente non può rifiutarsi di pagarla, né tantomeno di obiettare alcunché. In
questo caso, anzi, quando la prestazione comporta un’organizzazione di impresa, ancorché
non localizzata nel Paese black list, ma facente
capo alla società black list, deve ritenersi configurabile la «prima esimente».
Anche il prezzo è un parametro potenzialmente
importante. Infatti, laddove l’operazione sia stata effettivamente realizzata ad un prezzo tendenzialmente analogo a quello di mercato, difficilmente potrà sostenersi che il soggetto posizionato nel paradiso fiscale retroceda all’acquirente
del bene o del servizio una parte del corrispettivo proprio, per una prestazione effettiva: in questo caso, invero, non si vede in base a quale ragione economicamente apprezzabile il venditore
Nota:
(5) A. Vignoli, F. Gallio, R. Lupi, «Costi “black list” deducibili se il
beneficiario del pagamento è un’emanazione del fornitore materiale», in Dialoghi Tributari n. 4/2012, pag. 449.
Fiscalità
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
dovrebbe restituire al compratore una parte di
quello che sembra essere un corrispettivo proprio, stante il suo ammontare coerente con il valore normale.
Va evidenziato che in queste ipotesi la coerenza
del prezzo pagato con il valore di mercato della
prestazione consente ragionevolmente di escludere il rischio di sovrafatturazioni e quindi rende tendenzialmente inapplicabile nei confronti
del soggetto acquirente la disciplina limitativa
delle deduzioni dei costi di cui si discute. Come
sottolineato anche da Lupi in altro contributo su
un numero precedente di questa Rivista (6), la
rispondenza dell’operazione a criteri di economicità rappresenta quindi il punto da cui muovere per comprendere il ruolo del paradiso fiscale
e contrastarne efficacemente l’utilizzo.
La sovrapposizione con la disciplina
sui prezzi di trasferimento
Quanto indicato ai paragrafi precedenti presuppone una spiegazione «antievasiva», che è la
più frequentemente utilizzata per la disposizione sui costi black list. Resta però, come rilevava
Gallio, un originario riferimento della disposizione in esame solo ai rapporti infragruppo.
Questo rende difficile sostenere che il rispetto
del valore normale soddisfi sempre e comunque,
anche nei rapporti infragruppo, le condizioni
previste per la limitazione alla deducibilità dei
costi verso paradisi fiscali. Non è quindi sostenibile, in modo meccanico, che il rispetto del
valore normale cauteli l’acquirente residente da
eventuali disconoscimenti della deducibilità dei
relativi costi da parte dell’Amministrazione finanziaria. In altri termini, il rispetto del valore
normale non esclude l’applicabilità del regime
limitativo della deducibilità dei costi con Paesi
black list, venendo meno la necessità, infragruppo, di retrocessioni occulte dei corrispettivi applicati. Una sovrapposizione parziale di discipline, insomma, esiste e si spiega con una particolarità dei rapporti infragruppo con entità residenti in paradisi fiscali rispetto alla generalità
dei controlli in base al valore normale delle
operazioni con parti correlate. Il controllo a valore normale, infatti, salvaguarda la sfera impositiva degli Stati a prescindere dal pagamento di
tributi nello Stato dove è residente la contropar-
internazionale
te; da questo derivano le possibilità di conflitti
tra pretese impositive di Stati diversi, dell’alienante e dell’acquirente, che determinano differentemente il valore normale (7). Il possibile
pagamento di imposte nel Paese a fiscalità ordinaria della controparte contiene quindi il rischio
di determinazioni strumentali al fine di risparmio di imposta, che sono invece maggiormente
sospette nel caso di parti correlate ubicate in
Paesi a fiscalità privilegiata; in questo caso è infatti più forte il rischio di operazioni infragruppo prive di sostanza economica effettiva, giustificate in modo stereotipo, anche per corrispettivi molto modesti e come tali suscettibili di superare il test del valore normale. Al quale si dovranno quindi aggiungere le condizioni probatorie tipiche dei costi black list, anche se in questo
caso, per definizione, mancano le retrocessioni
occulte, necessarie nei rapporti tra parti indipendenti.
Note:
(6) Cfr. R. Lupi, «Paradisi fiscali tra prezzi di trasferimento e occultamenti di corrispettivi», cit., loc. ult. cit.
(7) Si pensi alle procedure amichevoli tra Stati contraenti di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
4/2013
457
Fiscalità
internazionale
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
Il rischio di una prova impossibile
Raffaello Lupi
Molte delle riflessioni svolte dagli Autori che
precedono girano attorno alla tendenza generale
ad «amministrare per legge», anche rispetto a
una questione «di fatto», come la possibile retrocessione occulta dei corrispettivi da controparti
ubicate in Paesi black list. È un riflesso del pregiudizio dell’onnipotenza legislativa, che comporta una certa farraginosità amministrativa,
ostacolando lo spirito di iniziativa e l’assunzione
di responsabilità nei casi singoli. Criteri di senso
comune, nel quadro del naturale empirismo probabilistico delle questioni dimostrative, avrebbero legittimato molte rettifiche su «costi black list» anche senza interventi legislativi. Che invece
finiscono per legittimare rilievi fiscali incomprensibili e ingiustificati, su situazioni in cui
mancano palesemente i presupposti economicogiuridici indicati dagli Autori che precedono, e
cioè la correlazione tra le parti (operazioni intragruppo) e il sospetto di retrocessioni occulte. Società italiane spersonalizzate, con controlli interni proceduralizzati, senza un socio di riferimento
che possa scavalcarli, si sentono rivolgere fuochi
di sbarramento di contestazioni stereotipe anche
a fronte di acquisti dove è palesemente il fornitore non residente a farsi scudo del paradiso fiscale. È il caso di cui alla sentenza in rassegna (8),
dove il fornitore greco di una società italiana fortemente managerializzata, quotata in borsa, si era
schermato dietro una società ubicata in un paradiso fiscale, il corrispettivo era in linea con quello riconosciuto a tutti i fornitori di servizi similari, in altri Paesi, e quindi si poteva escludere
ogni retrocessione occulta. Eppure in casi come
questo giungono accertamenti intrisi di resoconti
di fatti pacifici e innocui, enunciati in modo non
falso, ma insinuante, potremmo dire «tendenzioso», accompagnati da trasposizioni legislative,
precedenti giurisprudenziali enunciati come se
fossero pertinenti. È un insieme che tende a «fare volume», con discorsi apparentemente in tema, ma sostanzialmente privi di un filo conduttore, tecnicamente «non smentibili», in quanto né
giusti né sbagliati, secondo la metodologia avvocatesca indicata sul numero precedente (9). È un
458
4/2013
polverone in cui gli Uffici legittimamente rivoltano, contro coloro che l’hanno elaborata, l’impostazione processual-avvocatesca del diritto tributario, presentandosi come parti, senza tuttavia
perdere la credibilità dei Pubblici uffici. Questi
ultimi chiedono ossessivamente «la prova», respingendo al mittente tutte le riflessioni di verosimiglianza e credibilità che loro stessi giustamente utilizzano negli accertamenti induttivi e
nei rilievi sull’antieconomicità. Sembra quindi
che sui costi black list il contribuente debba dare
l’impossibile prova negativa di non aver ottenuto
le retrocessioni in nero indicate dagli Autori che
precedono. È normale, in un processo obiettivamente impugnatorio (10), che il connesso disorientante polverone induca i giudici a respingere
i ricorsi, come avvenuto per altre sentenze pubblicate su Dialoghi in tema di costi black list.
Il coordinamento col «transfer pricing»
Sono perfettamente d’accordo, con gli Autori che
precedono, sull’applicabilità teorica della disciplina sui costi black list anche in caso di rispetto
dei criteri del valore normale ai fini dei prezzi di
trasferimento, per le operazioni infragruppo. Ci
sono anche giustificazioni ulteriori rispetto a
quelle indicate dagli Autori che precedono, nel
senso che il transfer pricing è normalmente una
questione di fatto, attinente alla stima di eventi
registrati (per molti versi simile all’evasione interpretativa ancorché questione di fatto). Qualche
volta però c’è anche di più. Mi riferisco ai casi in
cui non ci si limita a far leva sul valore normale
della prestazione, manipolando invece la natura
stessa della prestazione, cioè calcando la mano su
prestazioni effettive per addebitare anche corriNote:
(8) Comm. trib. prov. di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83, il cui testo
è riportato a seguire.
(9) R. Lupi e M.R. Silvestri, «Lo smarrimento del senso comune
nel diritto tributario (a proposito del “principio di sensatezza”
delle scienze sociali applicato al diritto)», in Dialoghi Tributari n.
3/2013, pag. 246.
(10) Come confermiamo con Massimo Basilavecchia in questo
numero, «Diritto tributario, giudici e processo», pag. 431.
Fiscalità
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
spettivi a fronte di prestazioni semplicemente verosimili, visto il contesto, ma non effettive. Abbiamo avuto casi, di rilevanza penale, in cui la
stampa ha riportato l’attribuzione a società di un
certo Paese, da parte di gruppi societari, di funzioni in realtà rese da società ubicate in Paesi di-
internazionale
versi. È normale, quindi, che quando la società
del gruppo è ubicata in Paesi a bassa fiscalità, si
accompagni qualche ulteriore cautela a quella basata sui prezzi di trasferimento. Tanto più che, ab
initio, la normativa sui costi black list si riferiva
proprio alle operazioni con parti correlate.
La sentenza
Commissione tributaria provinciale di Venezia, Sez. VI, Sent. 8 ottobre 2012 (11 giugno 2012),
n. 83 - Pres. Ticozzi - Rel. Crovato
La Bencom S.r.l. a partire dal periodo di imposta
2004 in qualità di consolidata aveva optato in qualità di consolidata, per il regime del «consolidale
fiscale nazionale» con la consolidante E. H. s.p.a.
fusa per incorporazione nella E. s.r.l.
Le due società (B. s.r.l. e E. s.r.l.) con ricorsi separati, contraddistinti dai numeri …, si opponevano
alla contestazione di indeducibilità dei costi derivanti da separazioni economiche intraprese da B.
con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (costi c.d. black list), nella specie l’indeducibilità delle provvigioni corrisposte da B. alla società L. ltd. e M. F. ltd. in forza di contestati contratti di agenzia, accertata dall’Agenzia delle entrate di Venezia con separati avvisi di accertamento di primo e secondo livello.
Riuniti preliminarmente i ricorsi osserva la Commissione che gli accertamenti in esame riguardano
gli anni 2005 e 2006 mentre l’avviso per l’anno
2004 è già stato esaminato dalla Commissione
provinciale di Venezia.
Talché la Commissione, essendo rimasti invariati i
presupposti non ritiene di dover modificare l’orientamento espresso che viene integralmente ripreso.
Come risulta dal processo verbale di accertamento
la questione di fatto è sostanzialmente pacifica e
verte sulla utilizzazione da parte delle società di
agenti greci e irlandesi di 2 società schermo dell’isola di Man per fatturare e riscuotere le provvigioni
loro spettanti a carico della ricorrente. La contestazione da parte dell’ufficio trova il suo fondamento
nell’art. 110, comma 10, del T.U.I.R. che in tema di
costi da Paesi black list dispone quale regola generale che «Non sono ammessi in deduzione le spese
e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in stati o territori non appartenenti all’unione europea aventi regimi fiscali privilegiati». II successivo comma 11 stabilisce la inap-
plicabilità del divieto in esame solo quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le
imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero quelle operazioni
poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. L’art. 110, comma 10, prevede in altri
termini una presunzione legale relativa di indeducibilità dei costi provenienti dai Paesi black list con
la conseguenza che a dimostrare l’interesse realizzato dall’operatore nazionale deve essere la stessa
parte ai fini di legittimare il recupero del relativo
costo. Questa presunzione peraltro non troverà applicazione solo qualora la società italiana sia in grado di dimostrare il ricorrere di almeno una delle
circostanze esimenti previste dal comma 11, ovvero: 1) che l’impresa estesa svolge prevalentemente
un’attività commerciale effettiva; 2) che le operazioni poste in essere rispondono un effettivo interesse economico dell’imprenditore italiano e hanno
avuto concreta esecuzione. I presupposti probatori
indicati da tale comma sono alternativi con la conseguenza che il contribuente può limitarsi a fornire
elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza anche di uno solo di essi. L’attività di agenzia è stata
svolta non tanto dalle società siti nell’isola di Man
che non hanno alcuna struttura organizzativa bensì
per i territori irlandesi per il tramite della società B.
ltd. con sede in Dublino e per i territori di Cipro e
di Grecia dalla società B. con sede ad Atene. Da un
punto di vista sostanziale in entrambi i casi si tratta
di prestazioni di agenzia della cui veridicità e materiale esecuzione non sussiste alcun dubbio e contestazione nel senso che le prestazioni sono state effettivamente rese. Afferma la società ricorrente in
proposito che è del tutto irrilevante che il soggetto
legato da un contratto di agenzia e deputato a emettere le fatture sia la società black list mentre ad effettuare l’esecuzione dei rapporti commerciali nei
4/2013
459
Fiscalità
internazionale
CTP di Venezia, 8 ottobre 2012, n. 83
territori di loro competenza sia un soggetto terzo a
cui è stato affidato tale compito sulla base di un
contratto di sub agenzia poiché quel che rileva è
che sussista la prova attestante la concreta esecuzione delle prestazioni ricevute e la concreta esecuzione. Afferma la società ricorrente che anche la
contestata antieconomicità dei costi sostenuti è priva di fondamento poiché da un lato non aveva alcuna possibilità di scelta tra le due strutture non potendo interferire sulle modalità operative e organizzative della loro attività e dall’altra il costo effettivo del servizio è unicamente il costo sostenuto nei
confronti delle proprie controparti contrattuali con
sede nell’isola di Man mentre nessun rilievo assumono le valutazioni economiche effettuate dall’Agenzia che riguardano le modalità con le quali i
gruppi di società fornitrici il servizio articolano i
compensi alloro interno: le due società localizzate
nell’isola di Man sono soggetti esclusivamente incardinati nella struttura organizzativa degli agenti
esteri, struttura che la ricorrente non ha in un modo
determinato e ha contribuito a determinare e rispetto alla cui organizzazione non ha alcuna influenza.
Ritiene questa commissione che il punto decisivo
della controversia sia quello della effettività delle
operazioni sottostanti, verifica che va fatta con riferimento al secondo requisito richiesto dal comma
11 ai fini della sussistenza della esimente, verifica
da compiere con riferimento ai rapporti che la società ricorrente ha avuto sia con le due società
agenti ubicati nell’isola di Man sia con le società
subagenti operanti nei territori irlandesi e greci senza che sia a questo proposito necessaria una coincidenza tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento e
il soggetto che ha erogato la prestazione in forza
del contratto di subagenzia. A questo proposito non
si può ignorare il rapporto economico giuridico tra
tali entità e cioè che erano le società dell’isola di
Man ad essere emanazioni dei reali operatori greci
e irlandesi i quali erano i diretti destinatari dei vantaggi fiscali derivanti da tale rapporto. E non è contestabile che le operazioni siano state poste in essere dall’organizzazione che l’agente ha inteso in tal
modo costituire a suo vantaggio realizzando altresì
un effettivo interesse economico per la società ricorrente. Quindi va ritenuto che possa essere applicabile ai fini della deducibilità dei costi la formulazione della seconda esimente secondo cui nessun limite può essere posto alla deduzione quando le
operazioni poste in essere rispondono a un effettivo
interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione. In proposito sussiste anche un
precedente amministrativo richiamato da parte ri-
460
4/2013
corrente costituito dal parere reso in data 28 luglio
2004 dal comitato consultivo per la applicazione
delle nonne anti elusive; in tale parere si riconosce
la legittimità del fenomeno della subagenzia e quindi l’affermazione che l’agente può valersi nella
propria e autonoma organizzazione dell’impresa di
propri collaboratori e nel caso esaminato le provvigioni di agenzia corrisponde ad altro soggetto in
territorio black list a seguito della modifica delle
condizioni contrattuali tra l’agente e il soggetto terzo sono state ritenute irrilevanti ai fini della deducibilità. Il caso esaminato è sovrapponibile a quello
in discussione dove le provvigioni di agenzia corrisposti alle due società agenti dell’isola di Man traggono origine dall’attività svolta dalle due società
sub agenti con le quali la società ricorrente di fatto
intratteneva ogni rapporto operativo e organizzativo. Ad avviso di questa commissione pertanto non
è necessario che vi sia coincidenza tra il soggetto
che ha posto in essere l’operazione in concreto e il
soggetto situato nello Stato a tassazione privilegiata: non condividendosi pertanto l’orientamento
espresso nella sentenza depositata in atti della
Commissione tributaria regionale relativa al periodo d’imposta 2003 tra le stesse parti dove si afferma che lo sdoppiamento che si verifica tra un soggetto che fornisce un determinato servizio in un
certo luogo con la sua organizzazione di mezzi e un
soggetto del tutto estraneo a tale attività che realizza il profitto di tale cessione esclude la possibilità
di ritenere deducibili i costi. In proposito non si
può non obiettare che sostenere la necessità che vi
sia coincidenza fra il soggetto che ha ricevuto il pagamento e il soggetto che ha erogato la prestazione
significa annullare la applicazione della seconda
esimente e ritenere quindi applicabile solo la prima
esimente ove si pretende che vi sia coincidenza tra
il soggetto destinatario della fatturazione e il soggetto che ha erogato il servizio che è espressione
della presunzione di relativa inaffidabilità dei rapporti economici che vedono coinvolti soggetti
aventi sede in un paradiso fiscale che tuttavia può
essere vinta e superata dalla dimostrazione della effettività della esecuzione del rapporto e delle operazioni. I ricorsi che sono stati riuniti vanno pertanto
accolti mentre le spese seguono la soccombenza e
vengono liquidate complessivamente in euro … oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Condan-
na l’Ufficio alla rifusione delle spese liquidate in
complessivi euro … oltre accessori di legge.
Fiscalità
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
internazionale
Esterovestizione societaria:
conferme della lettura «anti-abuso»,
nei limiti dell’evasione interpretativa
di Simone Covino, RL
I rilievi sulla residenza societaria - di cui ci siamo occupati da ultimo nel n. 1/2013 - sono un tipico caso di contestazioni interpretative, dove l’Amministrazione finanziaria riqualifica circostanze registrate o comunque tracciabili, con l’effetto di «ricollocare» la residenza di una società
estera in Italia. Tolto il caso limite di strutture societarie di mero artificio (da disconoscere a
prescindere da quanti elementi esteriori si siano approntati per darvi credibilità), le sentenze in
esame rafforzano una tendenza ad affrontare la questione senza sradicamenti «in blocco» della
società, ma in modo più personalizzato. Secondo la strada dell’abuso del diritto, cioè del disconoscimento dei (soli) vantaggi fiscali indebiti connessi all’uso strumentale della residenza per finalità di convenienza tributaria.
Dall’appiattimento sul socio alla verifica di condotte abusive
Simone Covino
Torniamo sul tema delle contestazioni sulla residenza di società «senza azienda» (holding) (1)
per valorizzare e contestualizzare una presa di
posizione giurisprudenziale su «residenza e abuso del diritto». Senza esagerare il valore delle
sentenze, che risolvono casi anziché sistematizzare concetti, l’impostazione dell’esterovestizione in termini di abuso del diritto, già segnalata
su Dialoghi, (2) esce rafforzata dagli episodi
esaminati nelle sentenze il cui testo si riporta a
seguire (3).
In particolare, l’impressione è che si intenda
mettere da parte la solita querelle formalistica,
giocata su nazionalità degli amministratori, biglietti aerei da/per l’estero, utenze, bollette e dipendenti fantasma (4) pagati all’estero, per ragionare in un quadro di evasione interpretativa.
Ossia, di riqualificazione giuridica pro fisco di
circostanze comunque palesi, cioè rappresentate
o dichiarate dal contribuente; questa rappresentazione, trattandosi di esterovestizione, non è
chiaramente «tributaria» (l’esterovestito non
presenta dichiarazioni e quindi appare come un
evasore totale per definizione), ma societaria,
Simone Covino - Dottore di ricerca in Diritto tributario presso l’Università di Roma «Tor Vergata» e Avvocato in Roma. Fondazione Studi
Tributari
Note:
(1) Dopo l’intervento di S. Covino, R. Lupi, «Esterovestizione e
società di mera detenzione di beni (“holding”, immobiliari, ecc.)»,
in Dialoghi Tributari n. 1/2013, pag. 99.
(2) Nonché in A. Amatucci, R.Lupi, «Per la residenza rileva l’attività della società, del socio, o del “gruppo”?», in Dialoghi Tributari
n. 6/2011, pag. 685. È un tema peraltro tenuto sotto osservazione
su Dialoghi a partire dal 2006: v. S. Covino, «La gestione attiva come criterio riferibile anche alle holding di mera detenzione», in
Dialoghi dir. trib. n. 1/2006, pag. 82; A. Donesana, S. Covino, A. Manzitti, «Sede amministrativa e residenza delle “holding”», in Dialoghi Tributari n. 2/2010, pag. 224; G. Marino, M. Marzano, R. Lupi, «La
residenza delle società e controllo tra schemi OCSE ed episodi
giurisprudenziali interni», ivi n. 3/2008, pag. 91; A. Manzitti, «L’eterodirezione presunta sposta la residenza?», ivi n. 5/2010, pag. 534.
(3) Comm. trib. reg. Lombardia, 18 aprile 2013, n. 59; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2869.
(4) Queste circostanze esteriori vengono di solito invocate (e
preordinate) dai contribuenti per dimostrare la genuina residenza all’estero delle società da loro possedute; specularmente, il Fisco non di rado va alla ricerca di corrispondenza cartacea o elettronica per dimostrare che gli impulsi volitivi della società, dopotutto, promanano dall’italianissimo socio-amministratore occulto.
Su questa dialettica (che talvolta assume i contorni di un curioso
«gioco delle parti») si veda appunto S. Covino, R. Lupi, «Esterovestizione e società di mera detenzione di beni (“holding”, immobiliari, ecc.)», in Dialoghi Tributari n. 1/2013, pag. 99.
4/2013
461
Fiscalità
internazionale
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
aziendalistica, giuridica, magari «giornalisticomediatica».
Criteri di identificazione
della residenza societaria e rischi
di appiattimento sulla residenza del socio
Nello specifico, rimandiamo a quanto già esposto (5) circa il fatto che tutte le società sono a
ben vedere accordi giuridici, rispetto a cui assume oggettiva rilevanza la sede legale - che non è
un mero dato formale, ma è la sede del «patto» e
dell’«istituzione riconosciuta» cui fanno riferimento gli accordi tra i soci, con riferimento alla
quale si dispone dei beni. Questa sostanza giuridica, che consente di non scavalcare direttamente la società, passando ai soci, non può essere
sopravvalutata. La facilità di manipolazione di
tale elemento potrebbe essere usata strumentalmente per collocare strutture societarie effettive
in funzione di convenienza fiscale, scontrandosi
però col divieto generale di condotte tacciabili
di abuso del diritto.
Occorre quindi utilizzare anche altri consueti
parametri, come l’oggetto principale della società, cioè l’ubicazione del relativo patrimonio;
è un primo, tradizionale argine ai vantaggi fiscali indebiti, in quanto «storica sedimentazione
sulla residenza di generali principi antiabuso
pregressi, che oggi vengono allo scoperto come
tali, anche in termini generali» (6).
È invece più problematico il criterio della sede
dell’amministrazione o sede effettiva (place of
effective management nel frasario OCSE); questo
criterio è palesemente ideato avendo in mente un
conflitto di attività economiche, con organizzazioni aziendali che coprano due (o più) Stati contraenti. Talvolta, però, si tratta semplicemente di
una (apparente) discrasia tra la «direzione aziendale» effettuata in uno Stato e l’inevitabile influenza esercitata da un socio, eventualmente residente in un altro Stato. Inoltre è difficile ipotizzare una situazione di conflitto per una società di
mero godimento di beni, come una immobiliare,
o una holding, dove l’operatività è ridotta alla
gestione «condominiale» o «di adempimenti societari». A queste ultime operatività aziendali bisogna comunque fare riferimento, non alla proprietà della società: ai fini dell’individuazione
della residenza societaria prevale quindi la dire-
462
4/2013
zione aziendale, a pena di appiattire arbitrariamente la società sul socio, secondo la deprecabile tendenza alla «antropomorfizzazione» delle
persone giuridiche - spesso portata avanti per
contrastare i vantaggi fiscali ricollegati alla residenza estera della società, in modo indiscriminato, pretestuoso e penalizzante.
Il rischio, scongiurato nelle sentenze,
di sanzionare società radicate all’estero
per adempimenti asseritamente omessi
in Italia
L’ottica antiabuso con cui, come accennato in
esordio, la Corte di cassazione (7) affronta il tema dell’esterovestizione emerge in maniera evidente da alcuni incisi: «Si tratta di un tipico fenomeno di abuso del diritto (…) che trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei
principi costituzionali di capacità contributiva e
di progressività dell’imposizione»; l’obiettivo è
dunque quello di sanzionare «costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica
e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli
utili generati da attività svolte sul territorio nazionale». Citando un consolidato orientamento
della giurisprudenza comunitaria (8), la Cassazione riconosce doversi ravvisare esterovestizione solo dove «l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che
non riproduce una corrispondente e genuina
realtà economica».
Anche la sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia (9) dà ragione al contribuente sulla base di argomentazioni simili:
«elemento fondamentale del concetto di esterovestizione è l’obiettivo di conseguire un vantaggio fiscale attraverso la costruzione di un puro
artificio avente lo scopo di riferire fittiziamente
Note:
(5) S. Covino, R. Lupi, «Esterovestizione e società di mera detenzione di beni (“holding”, immobiliari, ecc.)», cit., loc. ult. cit.
(6) S. Covino, R. Lupi, op. loc. cit., pag. 107.
(7) Cass., 7 febbraio 2013, n. 2869, il cui testo è riportato a seguire.
(8) Sentenza della Corte di giustizia CE, 12 settembre 2006, C196/04, «Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas»,
in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.
(9) Comm. trib. reg. Lombardia, 18 aprile 2013, n. 59, il cui testo è
riportato a seguire.
Fiscalità
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
all’ente straniero attività in realtà condotte nel
territorio dello Stato»; i giudici tributari regionali non ritengono provata tale circostanza ed è
questo l’elemento cardine della decisione favorevole al contribuente (più che gli «altri elementi riferibili alla residenza estera della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, alla
imposizione fiscale a cui la società è sottoposta
in Lussemburgo»).
Si vede bene che questa impostazione delle controversie sull’esterovestizione rinuncia ad inseguire luoghi di c.d.a., biglietti aerei, utenze telefoniche ed altri elementi esteriori e tutto sommato superficiali, manovrando i quali paradossalmente i contribuenti potrebbero legittimare
vantaggi fiscali del tutto indebiti.
Soprattutto, il fatto di considerare le contestazioni
sulla pretesa esterovestizione societaria in termini
di evasione interpretativa e di contrasto all’abuso
del diritto permette di salvaguardare tutte quelle
situazioni ove non ci sono stati vantaggi fiscali
indebiti, ma che potrebbero essere attaccate per
profili meramente formalistici, una volta che la
società sia stata «riportata di forza» in Italia. Segnaliamo qui, a mo’ di esempio, l’asseritamente
omessa dichiarazione o l’asseritamente omessa
fatturazione di operazioni già fatturate da altri,
per arrivare all’asseritamente omessa regolarizzazione ai fini IVA da parte dei fornitori, i quali
avrebbero dovuto considerarne la residenza in
Italia ai fini della fatturazione IVA.
Insomma, ragionare in termini di abuso del dirit-
internazionale
to ha il vantaggio di scongiurare punizioni indebite, magari per un’imposta che non sarebbe dovuta neanche in Italia. In presenza di una imputazione effettiva dei cespiti alla società estera, in
cui la gestione dei beni passa realmente per un
soggetto amministratore ed una strumentazione
giuridica radicati nel Paese della sede legale, sarebbe troppo sbrigativo spostare la sede della
società in relazione alla residenza del socio, dicendo «che tanto comanda lui». Secondo un simile approccio, del resto, le nostre «multinazionali tascabili» si troverebbero inopinatamente a
risiedere nel Comune italiano dove il socio ha il
domicilio fiscale!
In conclusione, le sentenze in commento confermano il farsi strada di un approccio sostanzialistico sul tema: laddove l’intestazione reale ad
una società estera sia ispirata all’ottenimento di
arbitraggi fiscali, questi dovranno essere disconosciuti a prescindere dalle ricordate circostanze
esteriori (biglietti, utenze, ecc.). Se viceversa
non sono rinvenibili vantaggi fiscali indebiti,
non avrebbe comunque senso la contestazione
della esterovestizione della società sulla base
della residenza del socio.
L’altra alternativa resta il disconoscimento delle
società interposte come puro artificio messo in
piedi per occultare la reale titolarità di un cespite: in tal caso, nessun dubbio che la società fittiziamente interposta debba essere ignorata dal
Fisco, imputando direttamente gli effetti giuridici e tributari del caso al socio interponente.
Tra il «salto» e il vantaggio fiscale indebito
RL
Il salto, di cui parlo nel titolo, si riferisce al socio, e riguarda le strutture di puro artificio: dove
la mera interposizione, sostanzialmente fittizia,
come afferma Covino, è facile da scavalcare imputando la ricchezza direttamente al beneficiario
effettivo.
In altri casi però la ricchezza è effettivamente
detenuta attraverso il tramite di un veicolo societario estero, con i suoi organi, le sue assemblee, le sue intestazioni di beni, i suoi conti bancari, i suoi procuratori. Qui il puro e semplice
scardinamento dall’estero all’Italia, ora per allora, potrebbe avere conseguenze paradossali, che
travalicano il recupero del vantaggio fiscale indebito. Il grimaldello per effettuare questo scardinamento è individuare la volontà della società
in base alla volontà del socio.
Le contestazioni in esame non possono essere
esorcizzate attraverso la scorciatoia di qualche
viaggetto, con ricevute alberghiere e biglietti aerei, ma occorre riportare le contestazioni di esterovestizione tra quelle interpretative. Anzi, i bi4/2013
463
Fiscalità
internazionale
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
glietti aerei, le ricevute di ristoranti e le sale riunioni in alberghi dovrebbero essere considerati
come un’astuzia professionale abbastanza furbesca per legittimare esteriormente vantaggi fiscali
indebiti. Questi ultimi, se davvero indebiti e
consistenti, non possono essere «comprati» a
prezzo di una «location» (come si dice in orrido
aziendalese), una segretaria e un impiegato che
«danno colore» alla società estera. D’altra parte,
però, appaiono pretestuose contestazioni fiscali
che riportano in Italia «a corrente alternata» situazioni estere in cui l’Erario non ha subito alcun pregiudizio. Il disconoscimento dei vantaggi
fiscali indebiti, già in sede amministrativa, appare quindi la strada giusta. Speriamo che venga
confermata.
La sentenza
Commissione tributaria regionale Lombardia, Sez. XXXII, Sent. 18 aprile 2013 (20 marzo 2013),
n. 59 - Pres. Luglio - Rel. Cordola
Trattasi di avviso di accertamento per IRES e
IRAP per l’anno 2004 notificato alla Azelis Holding SA (di seguito breviter la società) con sede in
Lussemburgo per ⇔ 600.763,00 oltre interessi, in
quanto ritenuta esterovestita.
Impugnava l’avviso la società e la Commissione
Tributaria provinciale accoglieva il ricorso, condannando l’Agenzia delle entrate alle spese, sul presupposto della carenza dei requisiti caratteristici e tipici
di società esterovestite. In particolare perché la
maggioranza dei componenti del C.d.A. non risiede
in Italia; la documentazione fiscale della Holding è
depositata in Lussemburgo; la società adempie ai
propri obblighi tributari imposti dal Paese estero.
Obblighi più gravosi di quelli italiani. Conseguentemente la Commissione aveva ritenuto affetta da
nullità (e non da inesistenza) la notifica dell’avviso
effettuata presso la Azelis Italia e non presso la sede
estera di Azelis Holding SA, in quanto è incontestabile che la sede di questa società sia all’estero. Pertanto, deve ritenersi che la notifica effettuata abbia
raggiunto il suo scopo, considerato che la società ha
potuto ritualmente proporre il ricorso avverso l’avviso di accertamento.
Propone appello l’Agenzia delle entrate sulla base
dei seguenti motivi:
– Violazione e falsa applicazione del combinato
disposto di cui all’art. 25 della legge n. 218/1995
ed artt. 5, comma 3, lettera D, e 73, comma 3, del
T.U.I.R.;
– Erronea valutazione del dato fattuale e probatorio;
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, penultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973;
– Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa i fatti decisivi e controversi.
464
4/2013
Chiede, quindi, la riunione di questo giudizio a
quelli concernenti gli anni 2005 e 2006 per connessione.
La riforma della sentenza impugnata con l’accoglimento dell’appello.
Vinte le spese.
Si costituisce con controdeduzioni la società appellata per contestare analiticamente le motivazioni dell’Agenzia, chiedendo il rigetto dell’appello;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell’appello, dichiarare la totale o parziale illegittimità e/o infondatezza dell’avviso impugnato e, per
l’effetto annullato totalmente o in parte.
Vinte le spese.
Fra l’altro produce il certificato di residenza rilasciato dall’Amministrazione finanziaria lussemburghese il 10 febbraio 2012.
Con ulteriore memoria difensiva depositata 1’8
marzo 2013 la società ha contestato la mancata
produzione da parte dell’Agenzia dei DVD contenenti la maggior parte della documentazione rilevata in sede di processo verbale di constatazione
24 gennaio 2008, con conseguente mancanza di
prova dei fatti addotti dall’Amministrazione finanziaria.
Motivi della decisione
Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha una sua attività di fatto o
persegue il suo oggetto sociale in Italia.
L’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 regola l’applicazione della legge italiana alle società
ed enti non residenti che, appunto, abbiano in Italia la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto
principale.
Fiscalità
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
L’art. 73 del T.U.I.R., a sua volta, indica i criteri
per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche ed il comma 5-bis del medesimo articolo,
in vigore dal primo gennaio 2008, prescrive che,
salvo prova contraria, si considera residente nello
Stato l’ente controllato da soggetti residenti o amministrati da un Consiglio di Amministrazione, o
equivalente, i cui membri siano in prevalenza residenti nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle entrate, qui appellante, lamenta,
in diritto, la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 25 della legge
n. 218/1995, 5, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n.
917/1986 e 73, comma 3, del medesimo decreto.
Si tratta di contestazione che verte sull’assunto
che la società abbia la sede dell’amministrazione o
l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La
dimostrazione dell’assunto, nel caso in esame che
riguarda redditi del 2006, resta a carico della società contribuente, avendo il legislatore introdotto
le disposizioni che prevedono l’inversione dell’onere della prova con l’art. 35, comma 13, del D.L.
4 luglio 2006, n. 223, aggiungendo all’art. 73 i
commi 5-bis e 5-ter. La disposizione di cui al citato comma ha avuto effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 223/2006, ma resta pur sempre una presunzione di natura relativa.
La normativa introdotta dal decreto del 2006 veniva incontro all’esigenza di sollevare l’Amministrazione finanziaria dalla difficile ed ostica necessità di provare l’effettiva sede dell’amministrazione o l’effettivo luogo di svolgimento dell’oggetto
principale degli affari di società che, per la loro attività, presentano molteplici e significativi elementi di collegamento con il territorio dello Stato,
ma non una struttura amministrativa evidentemente e palesemente residente. Fino all’ottobre 2007
la holding del gruppo è stata la società di diritto
lussemburghese successivamente incorporata nella
Azelis Holding SA, anch’essa con sede in Lussemburgo. L’attività esercitata dalla holding è stata
sempre e comunque quella di gestione amministrativa delle partecipazioni possedute nelle controllate estere e nell’esercizio dell’attività di direzione.
Tanto premesso in punto, si deve qui rilevare come
questo onere non sia stato sufficientemente assolto
dall’Ufficio.
Come giustamente rilevato dai precedenti giudici,
elemento fondamentale del concetto di estero vestizione è l’obiettivo di conseguire un vantaggio
fiscale attraverso la costruzione di un puro artificio avente lo scopo di riferire fittiziamente all’ente
internazionale
straniero attività in realtà condotte nel territorio
dello Stato.
La fittizia collocazione della residenza fiscale all’estero per poter beneficiare di un regime fiscale
più favorevole è, dunque, elemento tipico che l’onerato della prova non può trascurare, pena il
mancato assolvimento del relativo obbligo.
L’Ufficio non manca di segnalare precisi e concordanti indizi sulla provenienza delle direttive dall’Italia, in particolare dal Direttore amministrativo di
Azelis Italia, attraverso il richiamo alla numerosa
corrispondenza a lui intestata, ai rapporti con banche e assicurazioni, a fatture emesse ed a documentazione contabile, ma trascura di evidenziare
quale sarebbe il vantaggio fiscale della presunta
esterovestizione. Di più, nel caso in esame, l’Ufficio non sostiene neppure che la residenza all’estero della Azelis SA sia dovuta unicamente a finalità
di evasione o elusione fiscale.
Il fatto che alcuni servizi amministrativi venissero
svolti in Italia è consuetudine amministrativocommerciale giustificata dal rapporto tra la holding e la controllata, né è elemento sufficiente a
dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività nel
territorio.
Ed, infatti, la società residente sviluppa una comprovata e indiscussa attività produttiva e commerciale nel nostro Stato, attività soggetta a regolare
tassazione nel territorio. Il ritrovamento di documentazione di natura amministrativa da riferirsi alla capogruppo, oltre che sporadica e discontinua,
in assenza di un palese vantaggio fiscale, appare
insufficiente a dimostrare la esterovestizione.
Altri elementi, riferibili alla residenza estera della
maggioranza dei consiglieri di amministrazione,
alla imposizione fiscale a cui la società Azalis è
sottoposta in Lussemburgo, sostengono la tesi dell’effettivo svolgimento all’estero dell’oggetto sociale.
Per i motivi appena esposti, non può essere dunque accolta l’eccezione di erronea valutazione del
dato fattuale e probatorio che l’Ufficio solleva.
Allo stesso modo deve essere rigettata l’eccezione
di violazione dell’ultimo e penultimo comma
dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, atteso che la
documentazione che si pretende mancare agli atti
riguarda file in formato elettronico la cui mancata
allegazione viene contestata da parte resistente.
Ritiene questa Commissione che la sede della Azalis SA deve dunque reputarsi all’estero e che nessuna costruzione fittizia sia stata posta in essere
per ottenere un migliore trattamento fiscale, presupposto della esterovestizione.
4/2013
465
Fiscalità
internazionale
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
Ciò non di meno, ai fini della contestazione in tema di notifica, devesi confermare quanto sentenziato dal precedente giudice, atteso che, ai sensi
degli artt. 156 e 157 del c.p.c., la notifica dell’atto
in Italia ha raggiunto il suo scopo e la ricorrente
ha potuto tempestivamente e regolarmente produrre la propria difesa attraverso il ricorso che sana il
vizio denunciato.
L’avviso di accertamento deve essere ritenuto illegittimo e la sentenza impugnata deve trovare conferma, con rigetto dell’appello.
Per il principio della soccombenza, questa Commissione condanna l’Ufficio alla rifusione delle
spese del presente grado, liquidate in € 5.000,00,
oltre oneri come per legge.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello dell’Ufficio,
confermando l’impugnata sentenza.
Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in complessivi €
5.000,00 (cinquemila) oltre gli oneri di legge.
La sentenza
Cassazione, Sez. trib., Sent. 7 febbraio 2013 (17 ottobre 2012), n. 2869 - Pres. Pivetti - Rel. Virgilio
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale,
rigettando gli appelli riuniti dell’Ufficio, è stata
confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della CIN S.A., società
lussemburghese di partecipazione finanziaria, per
omessa presentazione della dichiarazione ai fini
dell’IRPEG e dell’ILOR (o dell’IRAP) per gli anni
dal 1995 al 1999: la tesi dell’Ufficio si basava sull’assunto che la società, sebbene avesse sede legale in Lussemburgo, fosse da considerare fiscalmente residente in Italia, in quanto qui doveva individuarsi la sua sede effettiva, cioè il luogo in cui
veniva svolta l’attività di amministrazione e direzione dell’impresa.
Il giudice d’appello, dopo una lunga disamina della normativa, civilistica e tributaria, e della giurisprudenza in tema di residenza fiscale delle società, ha testualmente affermato che, «relativamente agli atti sporadici dedotti dagli accertatori
della G. di F., questa Commissione non riscontra,
ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 25, elementi
tali da ritenere la sede reale della CIN in Italia»,
per cui «la reclamata dall’Ufficio esterovestizione
della residenza fiscale della CIN non si è verificata»; ha aggiunto che «né ai sensi dell’art. 87, comma 3, del T.U.I.R., né in relazione all’art. 112,
comma 1, del medesimo Testo unico, né ai sensi
del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, è possibile
convalidare la tesi dell’Ufficio», poiché, «in sintesi, secondo il criterio generale, la sede legale-am-
466
4/2013
ministrativa della CIN non è in Italia e, pertanto,
decade ogni criterio sussidiario, configurato secondo l’ordine di priorità proposto dall’Ufficio,
nel senso che non potranno invocarsi i secondi
qualora l’utilizzazione del primo criterio abbia risolto l’antinomia».
2. La società contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87 (nella vecchia numerazione, applicabile nella fattispecie; ora, art.
73).
Premesso che la CIN S.A. È una società di partecipazione finanziaria costituita in Lussemburgo ai
sensi della locale legge del 31 luglio 1929 (cd.
«holding 1929 esenti» il cui regime fiscale è stato
ritenuto un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune con decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2006) e che ha operato in tale
forma giuridica fino all’agosto del 1998, quando si
è trasformata in società di partecipazione finanziaria di diritto comune (cd. «Soparfi»), l’Agenzia sostiene che fino alla data anzidetta devono trovare
applicazione soltanto i criteri di determinazione
della residenza stabiliti dal diritto interno e non
quelli dettati dalla Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni del 3 giugno 1981 - ratificata e resa esecutiva con L. n. 747
del 1982 -, come stabilito espressamente dall’art. 1
del relativo protocollo addizionale; ne deriva, ad
avviso della ricorrente, che il giudice d’appello,
Fiscalità
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
nell’escludere che «la sede legale-amministrativa
della CIN» sia in Italia, con decadenza di «ogni
criterio sussidiario», ha disapplicato i criteri di collegamento - «sede legale», «sede dell’amministrazione», «oggetto principale» - previsti, in via alternativa, dal citato art. 87, comma 3, del T.U.I.R. per
considerare residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti elencati nel comma 1.
2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 4, paragrafi 1 e 3, della menzionata
Convenzione Italia-Lussemburgo, in relazione al
periodo successivo all’agosto 1998 (per il quale si
è resa applicabile in base alle ragioni sopra esposte), per avere il giudice a quo, anche in questo caso, erroneamente applicato la disciplina pattizia,
non avendo verificato se la CIN fosse fiscalmente
residente in Italia secondo la normativa italiana
(criterio generale: par. 1), né, in ipotesi di residenza in entrambi gli Stati contraenti in base al detto
principio generale, accertato in quale Stato fosse
la «sede della sua direzione effettiva» (criterio
sussidiario: par. 3).
3. Con la terza censura, l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992,
art. 36, comma 2, n. 4: poiché, ad avviso della ricorrente, «la laconicità della motivazione...non
consente di escludere che il rigetto dell’appello
dell’Ufficio si fondi su una valutazione di fatto,
per avere i giudici d’appello ritenuto che la sede
dell’amministrazione di CIN S.A., oltre che la sede statutaria e la sede dell’oggetto principale
dell’attività, fosse situata in Lussemburgo», si
configurerebbe una totale assenza di motivazione,
non rinvenendosi nella sentenza alcuna argomentazione a sostegno di detto apprezzamento di fatto.
4. Infine, con il quarto motivo, è lamentata, in via
logicamente subordinata, l’omissione o l’insufficienza della motivazione, là dove il giudice d’appello si limita a fare riferimento al carattere «sporadico» degli atti dedotti dagli accertatori, inidonei, dunque, a far ritenere la sede reale della CIN
in Italia: una tale valutazione si rivela, secondo la
ricorrente, del tutto inadeguata a costituire una
sufficiente motivazione del rigetto dell’appello, sia
perché la sporadicità di un atto non è di per sé indice della sua scarsa concludenza sul piano probatorio, sia perché l’Ufficio aveva dedotto varie circostanze di fatto (la detentrice del 99,9% del capitale della CIN era la Candy Elettrodomestici s.r.l.,
stabilita in Italia; qui risiedevano due membri, su
tre, del consiglio di amministrazione; più volte le
delibere del c.d.a. ed altre decisioni di rilievo venivano prese in riunioni tenutesi in Italia e non in
internazionale
Lussemburgo, ecc.) non oggetto di disamina in
sentenza.
5.1. Per esterovestizione, com’è noto, si intende la
fittizia localizzazione della residenza fiscale di
una società all’estero, in particolare in un Paese
con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al
più gravoso regime nazionale.
Si tratta di un tipico fenomeno di abuso del diritto,
il cui divieto può dirsi ormai pacificamente riconosciuto come principio generale nel diritto tributario Europeo (che oltrepassa i confini delle imposte armonizzate) e va, di conseguenza, riconosciuto, almeno in via tendenziale, come principio generale anche nel diritto dei singoli Stati membri
(cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 30055 del 2008,
secondo la quale il divieto di abuso del diritto si
traduce in un principio generale antielusivo che
trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione).
Con particolare riferimento al fenomeno della localizzazione all’estero della residenza fiscale di
una società, la sentenza della Corte di giustizia del
12 settembre 2006, C-196/04, «Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas», ha affermato, in tema di libertà di stabilimento, che la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato
membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale
libertà; tuttavia, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio
finalizzate ad eludere la normativa dello Stato
membro interessato.
L’obiettivo della libertà di stabilimento è quello di
permettere a un cittadino di uno Stato membro di
creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le sue attività e di partecipare così, in maniera stabile e continuativa, alla
vita economica di uno Stato membro diverso dal
proprio Stato di origine e di trarne vantaggio. La
nozione di stabilimento implica, quindi, l’esercizio
effettivo di un’attività economica per una durata di
tempo indeterminata, mercè l’insediamento in
pianta stabile in un altro Stato membro: presuppone, pertanto, un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l’esercizio quivi di un’attività economica reale. Ne
consegue che, perché sia giustificata da motivi di
lotta a pratiche abusive, una restrizione alla libertà
di stabilimento deve avere lo scopo specifico di
ostacolare comportamenti consistenti nel creare
4/2013
467
Fiscalità
internazionale
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale
imposta sugli utili generati da attività svolte sul
territorio nazionale.
In definitiva, deve ritenersi che quel che rileva, ai
fini della configurazione di un abuso del diritto di
stabilimento, non è accertare la sussistenza o meno
di ragioni economiche diverse da quelle relative
alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l’operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial
arrangement), consistendo nella creazione di una
forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.
I concetti esposti sono stati ribaditi dalla sentenza
della Corte di giustizia 28 giugno 2007, C-73/06,
«Planzer Luxembourg Sarl», la quale, nell’interpretare l’ottava e la tredicesima direttiva in materia di IVA (rispettivamente, 6 dicembre 1979,
79/1072/CEE, in tema di rimborso dell’imposta ai
soggetti passivi non residenti all’interno del paese,
e 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in tema di rimborso ai soggetti passivi non residenti all’interno
della Comunità), premesso che gli interessati, secondo la costante giurisprudenza, non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario, ha affermato che ciò accadrebbe se
un soggetto passivo intendesse fruire del sistema
di rimborso alle condizioni enunciate dalle citate
direttive, quando l’indirizzo dell’impresa non corrisponde ad alcuna realtà economica, cioè né alla
sede dell’attività economica del soggetto, né ad un
centro di attività stabile dal quale quest’ultimo
svolge le sue operazioni.
5.2. Per quanto riguarda la fattispecie in esame, la
normativa applicabile, in quanto vigente ratione
temporis, è costituita essenzialmente dal D.P.R. n.
917/1986, art. 87, comma 3 (poi divenuto, con la rinumerazione operata dal D.Lgs. n. 344/2003, art. 73,
comma 3), ai sensi del quale «ai fini delle imposte
sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo d’imposta
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato».
Viene in rilievo anche, per il periodo successivo
alla (incontestata) trasformazione della CIN in società di partecipazione finanziaria di diritto comune, la Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la
frode e l’evasione fiscali, firmata il 3 giugno 1981
e ratificata e resa esecutiva con la legge 14 agosto
1982, n. 747: l’art. 4, in particolare, prevede, al
468
4/2013
comma 1, come criterio principale, che, ai fini della Convenzione, «l’espressione - Presidente di uno
Stato contraente designa ogni persona che, in virtù
della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad
imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga»; e,
al comma 3, come criterio sussidiario per le persone giuridiche, che, «quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona diversa da una
persona fisica è considerata residente di entrambi
gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente
dello Stato contraente in cui si trova la sede della
sua direzione effettiva».
Le due discipline, quella interna e quella pattizia,
a ben vedere, sono sostanzialmente equivalenti,
perché la seconda rinvia, come criterio generale,
alla legislazione interna ed assume, poi, come criterio sussidiario nel caso di accertata doppia residenza, quello della sede «effettiva» della società,
che non è altro che il criterio decisivo anche per la
norma interna, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di questa.
La nozione di «sede dell’amministrazione», infatti, in quanto contrapposta alla «sede legale», deve
ritenersi coincidente con quella di «sede effettiva»
(di matrice civilistica), intesa come il luogo ove
hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente
utilizzato, per l’accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari
in vista del compimento degli affari e dell’impulso
dell’attività dell’ente (ex aliis, Cass. nn. 3604 del
1984, 5359 del 1988, 497 del 1997, 7037 del
2004, 6021 del 2009). Analogo principio è stato
affermato, con specifico riferimento al vigente art.
73, comma 3, T.U.I.R., dalla sentenza della terza
sezione penale di questa Corte n. 7080 del 2012.
Infine, la sopra citata sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2007, «Planzer Luxembourg
Sarl», ha affermato che la nozione di sede dell’attività economica, ai sensi dell’art. 1, punto 1, della
tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre
1986, 86/560/CEE (in materia di rimborsi IVA a
soggetti passivi non residenti nel territorio della
Comunità), indica il luogo in cui vengono adottate
le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni
di amministrazione centrale di quest’ultima (punto
60). La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa
in considerazione di un complesso di fattori, al
Fiscalità
CTR Lombardia n. 59 del 2013 e Cass. n. 2869 del 2013
primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il
luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di
riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale
di tale società.
Possono essere presi in considerazione anche altri
elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti,
il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di
svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61). Di
conseguenza un insediamento fittizio, come quello
caratterizzante una società «casella postale» o
«schermo», non può essere definito sede di un’attività economica ai sensi dell’art. 1, punto 1, della
tredicesima direttiva (punto 62).
6.1. Passando ora all’esame dei motivi di ricorso,
deve escludersi che la sentenza impugnata si sia
discostata dai principi di diritto fin qui esposti.
L’ampia disamina, compiuta dal giudice a quo,
della normativa fiscale, civilistica e pattizia - in tema di residenza fiscale delle società e della relativa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale
appare, infatti, corretta, là dove, in sintesi, egli
giunge alla conclusione della assimilazione del
concetto (fiscale) di «sede dell’amministrazione»
(qualificato come uno dei criteri «alternativi» indicati nell’art. 87, comma 3, del T.U.I.R.) a quello
(civilistico) di «sede effettiva» della società ed intende quest’ultima, in sostanziale conformità ai
principi sopra enunciati, come il luogo in cui si
svolge in concreto la direzione e la gestione dell’attività d’impresa e dal quale promanano le relative decisioni.
Ne deriva che anche la parte finale della motivazione, dove si afferma che «secondo il criterio generale, la sede legale-amministrativa della CIN
non è in Italia e, pertanto, decade ogni criterio sussidiario», non può che essere interpretata - come
in definitiva ammette anche la stessa Agenzia ricorrente - alla luce dei principi esposti immediatamente prima, cioè nel senso che, ad avviso della
CTR, la sede effettiva («amministrativa») della società coincide con quella legale lussemburghese
(oltre che con il luogo dell’oggetto principale
dell’attività, che l’Ufficio non ha mai contestato
che sia in Lussemburgo), con ciò escludendosi la
configurabilità in concreto della residenza fiscale
in Italia in base alla norma interna citata - e quindi
l’ipotesi della esterovestizione -, con assorbimento
di ogni altra indagine.
I primi due motivi di ricorso vanno, pertanto, rigettati.
internazionale
6.2. Anche il terzo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti,
non può essere considerata tale, nel suo complesso, da risultare apparente (e quindi nulla ex D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), cioè consistente in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare le ragioni poste a fondamento della decisione (come, del resto, si è detto al paragrafo precedente).
6.3. È, invece, fondato il quarto motivo (il quale,
contrariamente a quanto eccepito nel controricorso, è ammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.,
rinvenendosi nell’ultimo periodo del motivo la
sintesi delle ragioni della inidoneità della motivazione a giustificare la decisione).
L’accertamento della assenza della sede effettiva
della CIN in Italia (e cioè della esclusione della
esterovestizione della società) è sorretto esclusivamente dalla pura e semplice qualificazione come
«sporadici» degli «atti dedotti dagli accertatori».
Si tratta di una motivazione apodittica o, comunque, chiaramente non esaustiva, in assenza di
qualsivoglia argomentazione sia in ordine alle ragioni in virtù delle quali il giudice è pervenuto ad
una tale definizione, sia in merito alla natura ed alla connessa valenza probatoria degli atti medesimi, laddove, come si è detto in precedenza (v. par.
5.2), e come lo stesso giudice ha affermato nella
premessa in diritto, l’individuazione del luogo della «sede effettiva» di una società richiede un’indagine esaurientemente motivata in relazione a vari
elementi indizianti, alcuni dei quali erano stati
specificamente dedotti dall’Ufficio (come risulta
nel ricorso con puntuali richiami agli atti di causa), spettando ad esso l’onere della prova in base
alla disciplina ratione temporis applicabile (anteriore alla introduzione, nel 2006, dei commi 5-bis
e 5-ter dell’art. 73 del nuovo T.U.I.R.).
7. In conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata deve essere
cassata in relazione al motivo accolto e la causa
rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale deve provvedere in ordine alle spese
anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche
per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Lombardia.
4/2013
469
Riflessioni operative e sistematiche sulla tassazione attraverso le aziende
Coordinamento editoriale
Raffaello Lupi, Dario Stevanato
Comitato di revisione:
Massimo Basilavecchia, Mauro Beghin, Luigi Arturo Bianchi (*), Cesare Cavallini (**), Daria Coppa, Francesco d’Ayala Valva,
Lorenzo del Federico, Guglielmo Fransoni, Maria Cecilia Fregni, Salvatore Muleo, Luciano Pezzolo (***), Salvatore Sammartino,
Giuseppe Zizzo
Comitato di redazione:
Claudio Carpentieri, Leda Rita Corrado, Mario Damiani, Mauro Franchi, Giuseppe Ingrao, Raffaello Lupi, Andrea Manzitti,
Giuseppe Molinaro, Alessandro Santoro, Dario Stevanato, David Terracina
Ufficio Studi Fondazione Studi Tributari:
Fiorella Bianchi, Stefania Capitani, Emiliano Covino, Simone Covino, Maria Rita Silvestri
(*) Diritto commerciale
(**) Diritto processuale civile
(***) Storia della tassazione
Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Assago (Mi)
http://www.ipsoa.it.
Direttore responsabile Giulietta Lemmi
Redazione Valeria Ruggiero
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 68 del 29 gennaio 2008
Iscritta al R.O.C. n. 1702
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in
data 31 luglio 1991
Realizzazione grafica
Ipsoa
Fotocomposizione
Sinergie Grafiche s.r.l. - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422
Stampa
GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (Mi)
Pubblicità
db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: [email protected]
www.db-consult.it
Distribuzione
Vendita esclusiva per abbonamento
Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling 12
mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta
da comunicarsi entro 60 gg. dalla data di di scadenza a mezzo raccomandata
A.R. da inviare presso la sede del Produttore.
Servizio Clienti: tel. (02) 824761
e-mail: [email protected]
Italia
abbonamento annuale: € 186,00
Estero
abbonamento annuale: € 372,00
Modalità di pagamento
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer
Italia s.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di
abbonamento.
Prezzo copia: € 40,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA
assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.
Redazione
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o
telefonare a:
IPSOA, Redazione Dialoghi Tributari,
Casella postale 12055 - 20120 MILANO
Telefono (02) 82476.018 - Telefax (02) 82476.600
Amministrazione
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d’indirizzo,
ecc. scrivere o telefonare a:
IPSOA, Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. (02) 82 47 61 - Fax (02) 82 47 6.799
Servizio risposta automatica Tel. (02) 82476.999
Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che
i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di
Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i
dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti
postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi
dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento
dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters
Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
LA STABILE ORGANIZZAZIONE
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
La stabile organizzazione è un fenomeno di grande interesse ed
attualità principalmente per effetto della ricerca, da parte delle
Amministrazioni finanziarie, di base imponibili “occultate” nelle loro
giurisdizioni.
Ciò richiede un’attenta disamina dei requisiti di configurabilità di una
stabile organizzazione, “materiale” o “personale”, e delle modalità
attraverso cui procedere alla determinazione del reddito attribuibile
ad una stabile organizzazione, tenuto conto sia del quadro normativo
interno sia dei principi sviluppati sul tema dall’OCSE, per i quali si
pone, inoltre, il problema della loro compatibilità con le norme italiane.
Particolari problematiche si pongono, poi, con riferimento alle stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e alle operazioni straordinarie, per effetto delle quali possono “nascere” o “morire” stabili
organizzazioni.
La nozione di stabile organizzazione trova, infine, una specifica declinazione e limiti applicativi nell’ambito della legislazione IVA e doganale, in cui le regole seguono canoni autonomi e distinti dalle regole
in materia di imposte dirette. Anche il tema dell’accertamento nei
confronti delle stabili organizzazioni italiane pone delicate questioni.
a cura di Siegfried Mayr,
Benedetto Santacroce
pagg. 672 - 70,00
Compili subito il coupon, e lo invii via fax allo 02.82476403. Può acquistare anche on line su www.shopwki.it
oppure può contattare l’Agenzia della sua zona (www.ipsoa.it/agenzie) o rivolgersi alle migliori librerie della Sua città.
Cognome e Nome
Azienda/Studio
Via
CAP
Città
Tel.
Fax
e-mail (obbligatoria):
Cod. cliente
Partita IVA
C.F.
q (1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura
q Addebitare l'importo di € .................... sulla mia carta di credito:
q Mastercard (16 cifre)
q American Express (15 cifre)
n°
Nome e indirizzo titolare carta di credito
Timbro e firma
Y01ED_FI.indd 1
q VISA (16 cifre)
q Diners (14 cifre)
Data di scadenza
Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i
suoi dati personali saranno registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Pal.
F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e
saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che
La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma
4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco
aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un
Fax al numero: 02.82476.403.
Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi
dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte
del cliente senza che questi abbia comunicato con
raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia
S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile confermati
con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la
propria volontà di recesso, la proposta si intenderà
impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In
caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso
termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene
dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver
Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090
Assago (MI) - telefax 02.82476.799.
Y01ED FI
(00138633) Si, desidero acquistare il volume La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali
a cura di Siegfried Mayr, Benedetto Santacroce a € 70,00.
(00138633) Si, desidero acquistare l'eBook La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali
a cura di Siegfried Mayr, Benedetto Santacroce a € 49,00.
04/09/13 14:25
NOVITÀ
La soluzione
professionale
che capisce il
tuo linguaggio.
Cerca tutto ciò che vuoi
come vuoi, naturalmente.
IPSOA ti risponde.
www.fare.it
BIGSUITE significa innovazione, perché è
la prima soluzione professionale che capisce
subito quello che vuoi sapere.
Y08EE_FI
Con BIGSUITE puoi inserire le parole che usi
tutti i giorni e con la nuovissima ricerca
intelligente, basata sul linguaggio naturale,
ottieni risultati impensabili fino ad oggi.
Con una velocità e una precisione
sorprendenti hai vantaggi concreti:
• Risultati mirati
• Facilità di utilizzo
• Risparmio di tempo
• Trovare tutto sull’argomento ricercato
Solo IPSOA è in grado di offrirti una
soluzione così! Scopri subito la differenza.
SCEGLI IPSOA, IL MEGLIO
PER LA TUA PROFESSIONE.
Scoprila su www.ipsoa.it/bigsuite
Diventa fan
del linguaggio naturale
su www.facebook.com/bigsuite