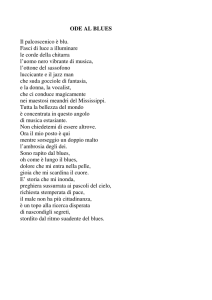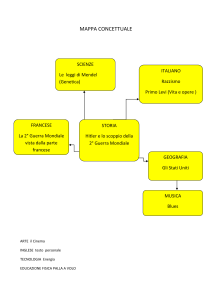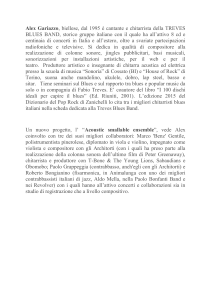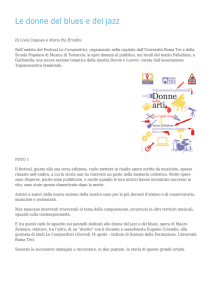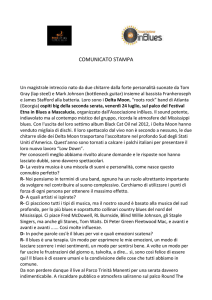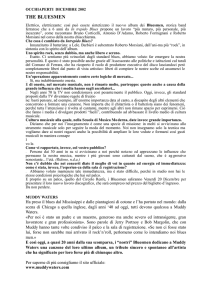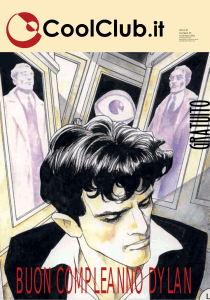Domenica
La
di
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
Repubblica
il reportage
Il cimitero delle regine del mare
RAIMONDO BULTRINI
il racconto
I fantini del Palio, servi e padroni
ADRIANO SOFRI
I soldati
bambini
di Putin
Hanno dai 10 ai 18 anni,
ogni giorno dopo la scuola
si allenano alla guerra
Repubblica Nazionale 27 07/08/2005
Il nuovo orgoglio russo punta
anche su questa baby-armata
FOTO F. DIMIER/LIBREARBITRE
GIAMPAOLO VISETTI
L
ZHUKOVSKIJ
e raffiche di kalashnikov, secche come frustate taglienti, si perdono tra boschetti di betulla e campagne a grano. Da uno stagno, tra una colonia di rane che asciugano sopra ninfee giganti, emergono
figure minute grondanti di fango. Indossano la mimetica dei
reparti d’assalto, hanno l’elmetto calato sugli occhi, calzano
anfibi fino al ginocchio. Qualcuno, con gesto da veterano, accosta alla bocca la borraccia di alluminio verde. In fondo al prato, dove si immerge un pezzo di sole color ciliegia, vanno all’attacco di un nemico inesistente. I soldati-bambini giocano
alla guerra e sognano di sfondare trincee: ma si preparano a
combattere, o a non essere uccisi in battaglia, quando saranno
adulti.
Tra i poderi di Zhukovskij, un’ora di corriera a sud di Mosca,
dopo la scuola si radunano in 183. Tre ore di allenamento al
giorno, dal lunedì al venerdì, per accedere all’esercito volontario dei piccoli che non vogliono aspettare di diventare grandi.
Dalle sei alle nove di sera fanno vita militare, come fossero professionisti. Hanno tra i dieci e i diciotto anni e la prima cosa che
imparano è attraversare i pantani senza bagnare le armi. Apprendono il segreto di infilare una maschera antigas senza sospendere la corsa né interrompere gli spari. Accedono alle
istruzioni per difendersi da un attacco nucleare, o batteriologico. Adeguano il passo a lunghe marce, appesantite dai vecchi zaini dismessi dall’Armata Rossa. Assemblano e smontano
armi come consumati guerriglieri: l’imbrunire è celebrato dai
tornei di tiro alla bottiglia.
Il loro campo patriottico-militare, “Kaskad”, è privilegiato.
Il poligono tra le paludi non è battuto dal vento e le autorità passano gratis il liquido per sopravvivere all’unico avversario reale: zanzare grasse come libellule, che si tuffano sotto gli indumenti con l’ingordigia del sorcio. Negli altri sessanta centri
d’addestramento bellico per bambini, sparsi ormai ad ogni angolo dell’immensità russa, i morsi degli insetti mietono d’estate più vittime del gelo invernale.
I piccoli soldati dell’armata di Vladimir Putin, in quattro anni, sono diventati dodicimila. Hanno aderito al “Programma di
educazione e di promozione del patriottismo”, caldeggiato dal
Cremlino per restituire vigore alla formazione paramilitare dei
giovani russi.
(segue nelle pagine successive)
con un servizio di GUIDO RAMPOLDI
i luoghi
Tremiti, il confino a cinque stelle
ATTILIO BOLZONI
cultura
Così Hugo Pratt diventò Corto Maltese
UMBERTO ECO
spettacoli
Muddy Waters e le strade del Blues
ERNESTO ASSANTE
i sapori
Vini d’estate, anche il rosso piacefresco
LICIA GRANELLO e ENZO VIZZARI
28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
la copertina
Scuole
di violenza
Sono diventati 12mila, in quattro anni,
i piccoli fanti dell’armata segreta
di Putin. Siamo andati a visitare uno
dei centri dove ogni giorno, dopo le lezioni
in classe, i ragazzini imparano a sparare,
a obbedire agli ordini, a difendere
la patria. Anche a costo della propria vita
GIAMPAOLO VISETTI
(segue dalla copertina)
I
Repubblica Nazionale 28 07/08/2005
stituito da Stalin, soppresso da
Krusciov, blandamente riscoperto da Breznev, il “Piano di educazione alla guerra” è stato tenacemente rilanciato dall’ex spia del
Kgb diventata presidente. «Invece di abbandonarli a perverse tentazioni — spiega Ghennadij Korotaev, comandante del “Centro militare-sportivo” alle porte della capitale — costruiamo cittadini più puri e più morali».
Terminati i compiti, i soldati-bambini non raggiungono i compagni per la
partita di hockey, o di basket. Rispondono all’appello di generali in pensione e
mandano a memoria il sincronismo
dello schieramento. Campi ed uscite sono facoltativi, ma i nomi di chi partecipa
vengono segnalati a professori, ministero della Difesa, servizi segreti. Sarà più
facile accedere gratis all’università, entrare nelle accademie più esclusive,
iscriversi al partito presidenziale. La
Russia, alle prese con lo sfascio del suo
esercito e con la fuga dalla leva, torna a
puntare su una società fondata sulla cultura militare. «Ogni centro — dice Oleg
Rozhkov, presidente dell’Unione della
gioventù russa — non accoglie più di
duecento ragazzi. Meno che ai tempi
dell’Urss, ma più che negli anni Novanta, quando si cercò di soffocare questa
tradizione. I bambini cominciano a capire che si può fare qualcosa di meglio
che vendere mughetti ai semafori».
L’iniziazione militare
Anche perché, dal 2001, l’iniziazione
militare obbligatoria è rientrata a scuola. Dall’ottavo all’ultimo anno, femmine comprese, un’ora alla settimana è riservata all’“Addestramento militare nazionale”. I più piccoli studiano le armi su
modelli di legno; ma dopo i quattordici
anni imbracciano fucili automatici veri.
Il diploma finale di “difensore della patria”, presuppone la conoscenza di
uniformi, distintivi, gradi e sezioni dell’esercito. «Il dramma — dice Valentina
Melnikova, leader dell’Unione dei comitati delle madri dei soldati — è che
educhiamo i bambini a un’esistenza armata. Imparano che la forza è un valore,
la violenza un vantaggio, il mitra un’assicurazione: e quando
vengono spediti in
guerra
davvero,
muoiono prima di
aver capito dove sono
e per fare cosa».
Ai bambini-soldato della nuova Russia
capita in realtà di non
tornare a casa anche
prima di svegliarsi tra
le montagne della Cecenia. Due mesi fa, un
sedicenne è morto
d’infarto durante la
“corsa con equipaggiamento pieno” di
tre chilometri. Poco
prima aveva coperto i
cento metri, con gli
scarponi, in 13,4 secondi. Nel 2003, in Siberia, un quindicenne è stato soffocato
dal suo vomito, che
aveva otturato la maschera antigas. L’istruttore aveva imposto una marcia di dieci chilometri appena
mangiato. «Chi tiene i corsi di addestramento per ragazzi — spiega Pavel
Felgenhauer, esperto di problemi militari — non è preparato. Sono soldati
in congedo, non hanno mai lavorato
con i bambini, agiscono come se si trovassero in una caserma. Non trovo nulla di buono nella reintroduzione dei
corsi di guerra».
Associazioni non governative e circoli di intellettuali democratici, denunciano il pericolo di riprodurre
un’adolescenza militarizzata. «Abbiamo milioni di abbandoni scolastici
precoci — dice il liberale Boris Nemtsov — ma il governo si preoccupa di insegnare ai bambini come ammazzare
un uomo a duecento metri di distanza».
La guerra di Andrej
baby-soldato
della nuova Russia
GIOCHI DI GUERRA
Sopra, un bambino
soldato si esercita
alla sbarra
in un centro
“militare-sportivo”
russo. Accanto
da sinistra,
diverse fasi
dell’allenamento.
Dal 2001
il Cremlino
ha reintrodotto
nelle scuole un’ora
a settimana
di educazione
militare
Le indicazioni del Cremlino però non
cambiano. Il ministro della Difesa Serghei Ivanov, compagno di Putin nel
Kgb, ha appena inaugurato Stella, un
canale televisivo “patriottico” rivolto
alle forze armate e ai giovani. Stipendi
da fame, alloggi fatiscenti, mezzi in rovina, arsenali abbandonati vengono
fatti dimenticare con documentari di
guerra, apologetici film sulla gloria militare russa, interviste a obesi generali.
«Dobbiamo mostrare l’aspetto migliore della patria — ha chiarito Ivanov alla
presentazione — se vogliamo smetterla di trasformare le persone in idioti».
Una campagna che nasconde l’agghiacciante realtà. Secondo il procuratore militare Aleksandr Savenkov, nel
2004 si sono suicidati 246 giovani di leva. In marzo, a Saratov, quattro giovani
reclute si sono impiccate assieme. Il
nonnismo nelle caserme dilaga. In un
anno gli abusi sono aumentati del 25
per cento, dal 1946 ad oggi i morti sono
stati oltre 150mila, 323 solo lo scorso
anno. «Reduci dalle guarnigioni di
bambini — dice Lev Ponomariov, attivista dei diritti umani — i ragazzi di leva considerano i maltrattamenti una
tradizione. Violenze e torture nascondo però veri e propri regolamenti di
conti criminali, o scontri etnici consumati nel silenzio dei reggimenti».
Accade così, a diciotto anni, di essere
sbattuti dal colonnello a fare i manovali in nero. L’estate scorsa è toccato a
Oleg, baby-soldato di Tula finito in un
cantiere a Tver. «Il capo — racconta —
mi ha detto che per due mesi non dovevo più raggiungere il campo di addestramento volontario. Mi sarebbe passato a prendere un furgone: altrimenti
era meglio che non mi presentassi più».
Dalla guerra simulata alla costruzione,
gratis, della casa di un generale. Assieme a lui, altri venti ragazzini. Costo zero, dieci ore al giorno, tangente incassata dai superiori. Fino al pomeriggio
in cui un bambino-soldato-operaio di
dodici anni è precipitato da un’impalcatura ed è morto. «La sera — dice Oleg
— eravamo di nuovo sull’attenti a
smontare e rimontare il nostro kalashnikov, come nulla fosse».
Un esercito alla deriva
Dietro ai nuovi centri patriottico-militari per ragazzi emerge così la tragedia
di un’armata alla deriva. Due milioni di
effettivi, tra soldati e civili, poco meno
di 1.500 morti ufficiali all’anno, duemila generali privi di incarico, 300mila militari messi a riposo forzato, 600mila
cosacchi appena riaccorpati alle forze
armate. Cifre da Sud America, una frustrazione che rende i vertici feroci. «So-
lo in Cecenia — ricorda Valentina Melnikova — in dieci anni di guerra la Russia ha perso 30mila uomini. Oltre 60mila sono stati feriti e resteranno invalidi.
A livello ufficiale però le vittime non arrivano a cinquemila. Invece di promuovere una politica di pace, il Cremlino premia i bambini che indossano la
mimetica e nasconde i caduti».
Come Andrej. Ha dodici anni ed è entrato nel mini-esercito di Zhukovskij da
otto mesi. Il mitra che porta a tracolla è
più alto di lui, così che deve tenerlo inclinato. Suo padre, quarant’anni, è saltato su una mina in Daghestan. Ha giurato che un giorno lo vendicherà. «Devo imparare — dice mentre pulisce la
canna del fucile — ad essere il più rapido. Con il piede ormai sento un sasso
anche sotto un metro di sabbia. So
orientarmi in un deserto e in una notte
senza stelle. Ultimata l’undicesima
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29
ARRUOLATI E COMBATTENTI
I minori che nel mondo partecipano
alle guerre sono stimati intorno
ai 180mila. Ma secondo la coalizione
internazionale di Ong “Stop Using
Child Soldiers” quelli arruolati
nelle forze armate sono oltre 300mila
Il confine sottile
carnefice-vittima
GUIDO RAMPOLDI
Repubblica Nazionale 29 07/08/2005
FOTO F. DIMIER/LIBREARBITRE
S
classe chiederò di essere inviato nel
Caucaso». Assicura di essere pronto ad
uccidere e lo dice come se affermasse di
poter rubare un pugno di nocciole.
«Belle parole — riconosce a tarda sera il vecchio comandante Korotaev —
ma questi campi di educazione patriottica sono solo un espediente per coprire i furti dei burocrati. Per ottenere i
fondi, stanziati da Difesa e Istruzione
pubblica, devi versare il cinquanta per
cento nelle tasche dei funzionari. E il
grosso dei finanziamenti non lascia
nemmeno i ministeri».
Sulla finta piazza d’armi di Zhukovskij si sono radunati i 161 soldati-bambini presenti. Alcuni sono così piccoli
che, non essendoci divise della loro misura, hanno mimetizzato con la vernice le loro stracciate tute da ginnastica.
Eseguono il presentat-arm e poi restano in attesa. I loro occhi non tradiscono
aspettative. «Se non vengono qui — dice Korotaev — finiranno al fronte senza aver mai visto una bomba a mano.
Ne ho visti a centinaia, in una vita, perdere le braccia provando il primo lancio. Più si addestrano ora e più hanno
una speranza di sopravvivenza quando
saranno inviati a combattere. Nessuno, tra i commilitoni, li aiuterà».
L’esercito dei ragazzi scioglie le righe
mentre dal bosco sale il richiamo di un
gufo. Quelli fino a quindici anni vengono riportati a Mosca sui pulmini. I
grandi si ficcano in bocca una sigaretta, saltano in bicicletta e corrono al
chiosco delle birre: anche stasera li
aspetta una cassa di Baltika quasi fresche. Bevono, come si fa al fronte.
A fine giornata
i più grandi
si mettono una
sigaretta in bocca
e corrono al chiosco
delle birre: bevono,
come si fa al fronte
ul finire del 2001, subito dopo l’ingresso a Kabul delle milizie tagiche, nella città pachistana di
Quetta cominciarono ad affacciarsi
comandanti Taliban in cerca d’un
nuovo esercito. L’emiro pagava bene,
e se il Talib finiva ucciso in combattimento garantiva una pensione alla vedova e agli orfani: non tanto, ma abbastanza per scampare alla morte per fame o per malattia. Ma il mullah Omar
era un datore di lavoro ormai prossimo
alla bancarotta: l’onnipotente aviazione americana l’avrebbe presto privato
del suo effimero regno. Allo stesso
tempo i comandanti non intendevano
rinunciare al soldo. Così lasciavano le
loro truppe sul fronte di Kandahar e
sgattaiolavano oltre il confine, per fiutare l’aria di Quetta ed essere lesti a cogliere le nuove opportunità.
I più previdenti andavano a bussare
alla casa dove vivevano in esilio i Karzai
e chiedevano di Hamid, l’afgano che di
lì a poco sarebbe tornato a Kabul come
primo ministro. Fu appunto il nipote di
Hamid, il ventiduenne Yama, che mi
presentò uno di questi comandanti
pronti a cambiare bandiera. Era un uomo sui trentacinque anni, asciutto e
cordiale. Il fatto d’essere disponibile a
cambiare fronte, tecnicamente a “tradire”, non lo imbarazzava più di quanto provi disagio un calciatore che cambia squadra. La guerra era il suo mestiere, mi disse. Non sapeva fare altro,
né a quell’età poteva reinventarsi. Ovviamente era analfabeta però poteva
smontare e rimontare un kalashnikov
ad una velocità strabiliante, e di questo
era orgoglioso. Comandava cinquanta
uomini, prima di lasciarli aveva discusso con loro sul da farsi. Decisione unanime: cercare un acquirente. Chi comprava il comandante comprava anche
la sua truppa. Il sensale, anch’egli un ex
comandante ormai sulla sessantina,
lasciava intendere che per acquistare i
cinquanta armigeri occorreva una cifra
a quattro zeri. Se gli americani fossero
stati interessati, probabilmente si poteva concludere l’affare per dieci o ventimila dollari.
Il comandante Talib aveva una storia
abbastanza tipica d’un certo genere
d’afgani. Aveva esordito nel mestiere
delle armi all’età di otto anni, durante la
guerra santa
contro i sovietici, come aiutante del cuoco
aggregato ad
una banda di
mujahiddin;
erano agli ordini di Gulbuddin
Hekmatyar, a quel
tempo nel libro-paga di pachistani e sauditi (anche
Hekmatyar ha
cambiato bandiera: ieri alleato degli americani, oggi li
combatte al
fianco del mullah Omar). Presto era uscito
dalla cucina:
entrato a quindici anni nei
ranghi dei combattenti col tempo aveva risalito la gerarchia militare. Quando i Taliban, presa Kandahar, avevano
messo insieme un piccolo esercito pashtun, comandava già una milizia propria: era un piccolo capitano di ventura. S’era unito ai Taliban con la sua
truppa personale non per convinzione
o per fede, ma per necessità. Un militare pashtun con famiglia non aveva altro
modo per esercitare il mestiere: fosse
stato un tagico, avrebbe combattuto
con l’Alleanza del nord. Certamente
aveva ucciso, probabilmente trafficato
in droga, forse razziato, torturato, rapinato. Ma non pareva un cattivo diavolo; e comunque non aveva fatto una
gran carriera come invece gli assassini
afgani più efferati: per esempio il suo
comandante in capo, quell’Hekmatyar
ricevuto come un eroico combattente
per la libertà sia da Reagan sia dalla
Thatcher.
Non è vero, come in genere si crede,
che i bambini-soldato siano sempre arruolati a forza. Questo certamente accade in alcuni conflitti africani, dove
non è raro imbattersi nell’infanzia militarizzata di cui racconta Giulio Albanese in Soldatini di piombo (Feltrinelli). Per esempio quel «Super-Soldier,
un bambino in tuta mimetica incontrato in Sierra Leone: aveva tredici anni e
da quattro imbracciava, non per sua
volontà, il fucile… Trovava il coraggio
di uccidere grazie a droghe micidiali, di
quelle che bruciano il cervello». Ma altrove non sono necessarie le droghe
per indurre un ragazzino ad uccidere,
né le minacce per costringerlo ad indossare una tuta mimetica. Anzi è probabile che dei centottantamila minorenni oggi parte attiva in eventi bellici,
i più siano spinti dalle proprie famiglie
verso l’apprendistato militare, vuoi
perché non si sa come sfamarli, vuoi
perché la guerra, dov’è endemica, finisce per diventare un mestiere non molto diverso da altri (così in Afghanistan).
Probabilmente anche i lanzichenecchi, o i capitani di ventura del Quattrocento italiano erano stati bambini-soldato come il nostro comandante Talib.
Anche per questo ci paiono un po’ retoriche le campagne contro l’impiego dei
bambini nei conflitti armati che in Occidente impegnano ong e giornali; e di
scarsa utilità quel Protocollo della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvato dall’assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, che vieta l’arruolamento di
minorenni. Tanto più perché, mancando un tribunale internazionale,
manca anche il deterrente d’una sanzione. Infine l’indignazione spesso segue uno standard bizzarro. Ci scandalizziamo tutti per le “infanterie”, i pargoli che uccidono vestendo una divisa;
ma quando i bambini vengono ammazzati da guerrieri adulti, questo ci
pare quasi nella natura delle cose. Il fatto che la ripugnante guerriglia irachena non arretri mai davanti alla probabilità di fare stragi di bambini non impedisce ai suoi fans europei di considerarla una giusta “Resistenza”. E all’opposto, le macerie di Falluja non suscitano il minimo dubbio nel nostro
giornalismo a stelle e strisce, pur così
proclive allo sdegno.
Chi vuole tenersi lontano dai moralismi degli scribi può però riflettere su un
fenomeno sinistro probabilmente tipico del Novecento. Accanto al bambino-soldato prodotto da necessità pratiche, è apparsa la figura ideologica del
bambino-militante offerto alla causa
per la quale ucciderà o si farà uccidere.
Per esempio i kamikaze minorenni impiegati dallo stragismo palestinese,
esito ovvio d’una cultura dell’assassinio che si rappresenta con le foto di infanti minuscoli bardati di dinamite,
mitra-giocattolo e sura coranica scritta
sulla fettuccia stretta intorno alla testolina. Non siamo molto lontani dai riti
antichi in cui bambini venivano scannati sull’altare d’un dio vorace.
Nessuno come Pol Pot è stato così radicale nella trasformazione del bambino in assassino. E così efficace.
Vent’anni dopo il genocidio cambogiano, lessi sul Phnom Pen Post la lettera
d’un sopravvissuto ad un campo di
“rieducazione”, di fatto un campo di
sterminio. Vibrava d’un odio mortale
verso la direttrice di quel lager. Solo
nelle ultime righe il testo precisava l’età
dell’aguzzina: dodici anni. Non era un
caso raro. Angkar, l’Organizzazione, il
nome della struttura-ombra attraverso
la quale Pol Pot esercitava il suo potere
paranoico, intendeva costruire l’Uomo nuovo partendo da chi non era stato ancora contaminato dal putrido
mondo borghese: e fosse paura o inconsapevolezza, gli adolescenti coinvolti nel progetto, in genere khmer fanatizzati e analfabeti, si mostrarono
spietati come li si voleva. «Ammazzavano con la stessa naturalezza con cui
un adulto mangia, ride, respira», mi
raccontò una sopravvissuta. Tra quanti riuscirono a scappare, molti non sono mai più tornati in Cambogia proprio
per reazione alla ferocia della generazione giovanissima: se quello è il futuro, si dissero, il Paese è spacciato. Non
si può dire che la storia cambogiana di
questi ultimi anni abbia smentito quella previsione pessimista.
30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
il reportage
Relitti industriali
È una spiaggia lunga cinque chilometri, sulla costa ovest dell’India
Si chiama Alang e fino a vent’anni fa era un paradiso
di pescherecci e sabbia bianca. Oggi è abitata da 50mila sfascianavi
che rottamano le petroliere e gli incrociatori venuti ad arenarsi qui,
da ogni parte del mondo, imbottiti di materiali inquinanti
L
o sfascianavi indiano Arjun Ransir sembra un vecchio ma non ha più di 47 anni.
Scruta col sole allo zenit il Golfo di Cambay dal quale esala una foschia tremolante per l’effetto ottico dell’insopportabile calore e per i fumi
di residui chimici lasciati bruciare a cielo aperto. «Arriva un’altra nave — dice — Un altro uomo morirà».
Arjun fuma una foglia di tendu arrotolata tra le dita sporche
di olio e corrose dagli acidi, mentre segue con gli occhi il punto lontano sul Mare Arabico dove una grande petroliera attende l’alta marea, ben oltre la baia di sabbia color ruggine e il
mare grigio come antracite di questa costa meridionale del
Gujarat. Ferma a non troppa distanza dalla leggendaria città
sommersa di Cambay, una misteriosa Atlantide indiana dell’era neolitica, la petroliera tra non molto raggiungerà Alang,
la sua ultima meta. Sfrutterà le onde alte fino a dieci metri spinta da vecchi motori in tutta la sua decrepita possanza: qualcosa come cinquantamila tonnellate di acciaio, macchinari,
mobili e, come spesso accade, dannose sostanze residue.
Sager, l’Oceano, è sorgente di vita lungo tutte le coste del
mondo. Anche ad Alang, un tempo incantevole oasi per residenti e turisti ai bordi del deserto rovente, porta soldi e un certo benessere, ma non per le perdute bellezze paesaggistiche,
né per le colorate flotte di pescherecci del passato. La manna
che da più di venticinque anni arriva ad ogni alta marea sono
gli enormi pesci d’acciaio pronti a farsi spolpare dalla testa alla coda da un esercito di gnomi che
entrano ed escono
da fori praticati
con la fiamma ossidrica lungo le alte pareti degli scafi. Un affare da miliardi di rupie, anche se solo piccole
briciole (e i grandi
rischi legati al lavoro) finiranno in
mano agli operai
come Arjun.
C’è una simbiosi inquietante tra
la sorte di questi
giganteschi vascelli e quelle degli
uomini che in tre,
quatto mesi di lavoro duro e pericoloso li fanno
scomparire: gloriose navi da guerra e da crociera,
transatlantici e petroliere che i paesi d’origine si guarderebbero bene dallo smantellare a casa propria, con tutto il loro micidiale fardello di materiali inquinanti, fibre isolanti a base di
amianto, vernici chimiche, antiossidanti, antiruggine e idrocarburi. In questo gigantesco cimitero navale lungo cinque
chilometri, il più grande al mondo, più grande di quelli di
Bombay e Chittagon in Bangladesh, lavorano tra i 40 e i 50mila shipbreakers, sfascianavi come Arjun, assoldati da 184 rottamatori autorizzati che comprano e rivendono all’asta ogni
vite della nave fatta a pezzi nel loro tratto di spiaggia chiamato enfaticamente “piattaforma”.
Gli operai vengono quasi tutti dal Bihar, ma anche dall’Uttar Pradesh, dallo Jarkhand, i più poveri tra gli stati indiani. La
sorte delle circa quattrocento navi che finiscono la loro corsa
qui ogni anno (nel 1990 erano appena cento) somiglia alla deriva degli shipbreakers: lontani dalla propria terra, consapevoli che Alang è davvero l’ultima spiaggia, un pianeta dove
amorfe forme di vita agonizzano tra deserto e risacche marine dai riverberi metallici, dove scheletri di balene meccaniche
un tempo orgoglio di armatori e capitani giacciono con le carene reclinate, lo scafo aperto orizzontalmente a mostrare in
vivisezione i desolati saloni, le stive, i ristoranti, i ponti spogli.
Così sono finite le navi immortalate dalla serie Love Boat; la
gloriosa fregata francese da guerra “Clemenceau” con le sue
22 tonnellate di amianto a bordo; i transatlantici per vacanze
di lusso come “Stella Solaris” e “Stella Oceanis”; e molti altri,
coi loro sofisticati pannelli dipinti o scolpiti, opere di Ema-
Il cimitero
delle regine
del mare
Repubblica Nazionale 30 07/08/2005
RAIMONDO BULTRINI
ALANG (Gujarat)
nuele Luzzati, Enrico Paulucci, Joseph Farcus, venduti spesso
come pezzi da rottamare, se qualche collezionista ben informato non fa in tempo a rintracciarli in una delle centinaia di
rivendite ai lati dei cantieri. Qui giacciono mobili danesi della
metà del Novecento disegnati da Kay Koerbing per la superchic “Winston Churchill”, i resti degli splendidi saloni da ballo creati da Jean Munro per la nave da crociera “Franconia”, le
sedie disegnate da Gio Ponti, saloni in stile Liberty e classicheggianti come quelli della “Apollon” che doveva ospitare a
Napoli il vertice della Nato, poi cancellato per la catastrofe
dell’11 settembre.
Proprio il crollo delle crociere transoceaniche dopo le minacce terroristiche ha accelerato il crepuscolo dei grandi transatlantici, venuti a morire a branchi sulle coste del Gujarat. Era
già successo alle petroliere, decimate dall’aumento dei prezzi del greggio e dalle nuove disposizioni seguite a disastri come la rottura delle stive della “Exxon Valdez” del ‘98, quando
fu imposto il doppio scafo per il trasporto dei combustibili.
L’ultimo cadavere galleggiante che ha fatto rotta su Alang è
l’“Eugenio C.”, ex gioiello della flotta Costa varato a Monfalcone nel 1964. Venduta e ribattezzata più volte fino a diventare “Big Red Boat” per via dello scafo ridipinto di rosso fuoco, è
partita dalle Bahamas, ha passato il Canale di Suez e il porto di
Dubai per trascinarsi con la sua celebre carena, vanto dell’ingegneria navale italiana, sulla spiaggia del Gujarat. La sua carriera di «regina dei mari» avrebbe potuto trasformarla — come proponevano molti — in un museo navale galleggiante
della marineria italiana. Ma l’impennata dei prezzi dell’acciaio (dai 150 ai 450 dollari nell’ultimo anno) ha fatto gola ai
nuovi armatori e l’ex “Eugenio C.”, arrivata ad Alang ai primi
di giugno, morirà col suo nuovo buffo nome e senza le fanfare
che l’hanno accolta per quarant’anni in tanti porti del mondo.
L’ultimo messaggio radio ha fornito al capitano e ai dodici
uomini dell’equipaggio le direttive per raggiungere il tratto di
spiaggia del rottamatore acquirente, segnalato da una bandiera e da un razzo. Poi si lascerà docilmente smantellare da
trecento sfascianavi, probabilmente a mani nude e poco equipaggiati come quelli che a grappoli stanno smembrando davanti ai nostri occhi una grande nave passeggeri della Tirrenia,
compagnia di traghetti italiana. La nave è in avanzata fase di
rottamazione presso il molo 184, l’ultimo. Le staccano i pannelli dei soffitti, dissaldano panche e oblò con la fiamma ossidrica a occhi scoperti, camminano con ciabatte e a piedi nudi
tra frammenti di vetro e isolanti termici nei vecchi compartimenti dove vacanzieri e pendolari hanno fatto per trent’anni
la spola tra Civitavecchia e Olbia.
Come un grande pesce al quale hanno tagliato la testa, la nave - Tirrenia della quale non si conosce il nome si erge con il
ventre aperto sulla battigia. Qui i motori, sbuffando a tutta forza per l’ultima volta, tre mesi fa circa l’hanno trascinata a secco per morire al suono rauco di una vecchia sirena. Gli strumenti sulla enorme plancia di comando sono ancora quasi
tutti intatti, ma il proprietario della nave deve rifarsi presto dei
180 milioni di rupie (50 milioni di euro) pagati alla compagnia
italiana, e li ha già venduti all’asta subito dopo l’attracco: il momento in cui gli acquirenti salgono a bordo per distribuirsi acciaio e legno, porte e letti, frigoriferi e suppellettili, casseforti,
divani, tazze dei water.
Uno dei sorveglianti — gli odiati muqadam — al quale siamo stati presentati come acquirenti ci mostra i vari piani della nave traghetto in gran parte del tutto bui, mentre attorno le
fiamme ossidriche rischiarano figure di ragazzi che scardinano pareti e tubi. La vista dall’alto è impressionante, aperta su
chilometri di costa disseminati di navi grandi e piccole che intere o a pezzi aspettano la fine del loro turno di smontaggio.
Nelle ultime tre settimane ne sono arrivate sedici, e la baia ha
il colore dell’olio residuo fuoriuscito o lasciato sgorgare per
poi bruciarlo di notte, così che appena fa buio le fiamme sprigionate dai liquami dei giganti marini emanano bagliori sinistri su tutta la superficie dell’Oceano.
Secondo le autorità del porto sotto il controllo del Gujarat
Maritime Board di Gandhinagar, bruciare combustibile in
mare è un provvedimento di «salvaguardia ambientale». E
non è l’unica stravaganza di questo cimitero navale, dove i
proprietari dei 184 cantieri di smantellamento e rivendita
espongono ipocriti cartelli dipinti a mano per invitare gli operai a indossare elmetti, guanti, scarponi e maschere e a non
usare fiamme vive in cabine a rischio. Ben pochi dei giovani
bihari che abbiamo visto disossare la carcassa della Tirrenia
avevano una qualche protezione, in violazione non solo delle
leggi portuali (difficile incontrare poliziotti o funzionari marittimi da queste parti) ma anche delle convenzioni internazionali come quella di Basilea che impone a tutti i paesi di neutralizzare i propri residui industriali (computer e navi incluse)
in ottemperanza delle norme ambientali, igieniche e di sicurezza sul lavoro, possibilmente a casa propria.
Da Copenaghen è arrivato di recente un operatore tv che voleva documentare lo smantellamento della “Riky”, una nave
passeggeri da 19mila tonnellate con sospetti materiali tossici
a bordo, diffidato dalle autorità danesi ma accolto da quelle indiane, nonostante esista una severa regolamentazione nazionale contro gli scarichi industriali e nocivi. Come accadde alla francese “Clemenceau”, che dovette disfarsi delle sue 22
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31
L’ULTIMO APPRODO
Sono quattrocento l’anno i transatlantici
che finiscono il loro viaggio sulle coste
del Gujarat. Tutti i demolitori (shipbreakers)
che smontano pezzo dopo pezzo le navi
(nelle foto in basso) arrivano sulla spiaggia
di Alang dalle aree più povere dell’India:
il Bihar, il Pradesh e lo Jarkhand
Repubblica Nazionale 31 07/08/2005
FOTO F.MOLERES/GRAZIA NERI
FOTO GIANLUCA PULCINI
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
tonnellate d’amianto dopo una campagna internazionale, la vicenda della “Riky” aveva fatto
scandalo e il suo attracco era stato ufficialmente negato. Ma, dicono, è bastata una trattativa via radio o
cellulare tra il capitano della “Riky” e il boss degli sfascianavi (più potente di qualsiasi comandante della polizia marittima) per risolvere il problema. Sarebbe finito tutto nel silenzio più totale se il reporter danese non fosse riuscito a mandare in onda sui telegiornali del suo paese le immagini della nave già mezza smembrata.
Né questa, né le altre sistematiche denunce di Greenpeace
contro i pericoli del cimitero navale cambieranno la situazione, anzi. Alang fornisce all’India tre milioni di tonnellate di
metalli, il quindici per cento del fabbisogno d’acciaio del paese. Ecco perché qui, alla spiaggia-cimitero, sono aumentati
sbarramenti e divieti agli estranei ma all’interno tutto continua esattamente come sempre. Su questa costa occidentale
dell’India, dove sono fiorite le civiltà della Valle dell’Indo e di
Harappan, continuano a far rotta da Oriente e Occidente i vecchi vascelli che sono riusciti a raggiungere la meta senza inabissarsi o restare preda dei moderni pirati dello Stretto di Malacca, i pronipoti tecnologizzati di Sandokan e Sir Francis
Drake che a ritmo crescente terrorizzano armatori, comandanti ed equipaggi di tutto il mondo.
Sostanze e vernici tossiche usate come antiruggine e antiaderente per molluschi e alghe sono le prime a venire grattate
via dagli scafi e vengono disperse tra mare e terra, cariche di
veleni che l’Oceano non riesce a ripulire. Sulla strada di terra
battuta che costeggia i cantieri donne dall’età incerta, coperte dai sari sgargianti, trasportano in equilibrio sul capo ceste
con fibre di lana d’amianto usate come isolanti termici sulle
navi, che ad ogni soffio di vento si levano nell’aria per restare
sospese a lungo prima di finire a terra e formare quell’impasto
marrone e fetido di idrocarburi, acidi e metalli che è oggi la
spiaggia un tempo bianca e fine di Alang. Ma quelle fibre si depositano anche nei polmoni per sviluppare rapidamente necrosi, tumori e malattie respiratorie. Ce n’è dappertutto di
questa lanetta di vetro e amianto: nei cantieri, lungo la strada,
dentro il villaggio di baracche e tende dove vivono gli operai e
le loro famiglie. Perfino attorno al bell’edificio rosa che dal
2003 doveva ospitare una clinica di pronto soccorso per fratturati e ustionati, ma che è rimasto vuoto. I feriti dei cantieri
continuano a dover percorrere un’ora e mezzo di strada dissestata fino alla vicina cittadina di Bavnagar, centro d’affari
per i compratori delle carcasse del mare.
Uno di loro si chiama, o dice di chiamarsi, Vishod, è nato e
cresciuto ad Alang, dove è entrato nel grande giro del riciclaggio di ferraglia, sebbene di affari ne porti a termine pochi, impegnato com’è a guidare militanti di Greenpeace, ambientalisti, giornalisti e perfino turisti giunti da tutto il pianeta per visitare i cinque chilometri di spiaggia che prima del 1978 erano
stati il posto magico della sua infanzia, con le nuotate e i giochi, le reti dei pescatori e i molluschi ancora vivi. Oggi — spiega — al suo stomaco non assuefatto a batteri e veleni per andare all’altro mondo basterebbe bere l’acqua dei pozzi salinizzati con cui gli operai e le loro famiglie si lavano, risciacquano il cibo e si dissetano nei tuguri di baracche e tende a ridosso dei cimiteri navali. Non sarà un caso che ad Alang le statistiche della lebbra siano dieci volte al di sopra della media
nazionale: 194 ammalati sui ventimila registrati due anni fa.
Quando alle sei di sera i maschi tornano a casa dopo nove ore
di lavoro, scuri di sporcizia e di sole, ustionati dalle fiamme perennemente alimentate da residui chimici e idrocarburi, le
donne si affacciano coi bambini sulla stretta strada polverosa
per controllare che l’uomo che aspettano sia tra quelli che hanno varcato i cancelli degli sfascianavi. Hanno già preparato una
bacinella d’acqua scaldata, sapone da sfregare e asciugamani
consunti e anneriti dall’uso, e sorridono al proprio marito, fratello, padre anche oggi scampato a una caduta, allo schiacciamento sotto una turbina, all’intossicazione da gas, all’esplosione di un container o di un serbatoio di infiammabili. Incidenti che uccidono anche trenta, cinquanta operai alla volta.
Donne e uomini sanno bene che «il morto a nave» della rudimentale statistica di Arjun non è causato soltanto dagli incidenti e che per ogni giorno di lavoro i veleni nascosti accorciano la vita di un mese. Ma gli stipendi degli sfascianavi sono quasi dieci volte più alti di quelli di un contadino del Bihar. Arjun
guadagna qui 83 rupie, un euro e mezzo al giorno, contro le 10
del suo villaggio di Nerotholam. Con 20 rupie ci compra un chilo di riso, con 30 un chilo di lenticchie. Il resto — dice — lo conserva per quando tornerà a casa da vecchio, «se sopravviverò a
parecchie navi ancora», calcola col suo sorriso sdentato.
32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
il racconto
I fantini di piazza del Campo somigliano agli avventurieri,
Ritratti d’autore
ai galeotti fondatori di città, ai militari conto terzi. Sono
i combattenti giovani e virili che, nerbo alla mano, devono secondo Machiavelli - battere e urtare la Fortuna che è donna,
volendola tenere sotto... Le foto di Marco Delogu lo mostrano
E mostrano quanto sia dura la vita di questi eroi per un giorno
Le mani sul Palio
ADRIANO SOFRI
Repubblica Nazionale 32 07/08/2005
FOTO CONTRASTO
A
dattando a Siena, che è un mondo a parte, ma fa parte di
questo mondo, la nozione di secolarizzazione, Roberto
Barzanti ha appena esortato i suoi concittadini a vivere il
Palio senza la nostalgia del Palio. Ha esposto robuste considerazioni, e tuttavia mi chiedo se la sua non sia una battaglia perduta per definizione. Uno degli effetti del mondo
dal quale gli dei se ne sono andati è la voga della venerazione superstiziosa: falsi dei, falsi eroi, falsi cavalli alati, finti settenani, leoni taroccati e
dive ritoccate. Un altro effetto è la nostalgia e, a non farne un vizio, è buono. Si abita una casa dalla quale sono stati rubati, o sequestrati per debiti, cristalli e cassetti pieni di lettere, sedie a dondolo e letti a baldacchino,
e sui muri solo rettangoli più chiari commemorano i bei quadri di una volta. Non si abita la terra oggi senza nostalgia della terra. Il Palio commemora il Palio, e però riempie ancora di vivo presente la città e la piazza.
Può permettersela, la nostalgia, a condizione di non svuotarsi delle vecchie carte e dei bei quadri e delle tende ricamate, per correre meglio incontro alla domanda. Alle televisioni, ai soldi, alla pubblicità, al sequestro della Fortuna e della Virtù da parte della Tecnica e della Potenza.
Della nostalgia e del rimpianto dei senesi fa parte adesso la sensazione di un’usurpazione dei fantini. Mercenari al servizio della festa mutati — come i pretoriani della tarda Roma, come gli autisti e le guardie del
corpo e gli odontotecnici della Roma d’oggi — nei padroni della festa e
della città. Come i capitani di ventura del Rinascimento, quando passavano dal soldo alla signoria. Il gioco fantasioso, generoso e cinico, di alleanze e tradimenti, uomini comprati e venduti, partiti fatti e sciolti e rifatti, può cedere alla corruzione qualunque, quella che regge il mondo
ordinario, le sue trame, i suoi troppi soldi, le sue troppe intercettazioni.
Ancora Barzanti, nostalgico lui stesso benché si simuli realista, ha commentato il Palio di luglio, vinto secondo ogni pronostico da Trecciolino
su Berio per il Bruco, con un amaro paradosso: ha vinto il migliore, ma il
Palio in cui vinca il migliore non è più il Palio. Il Palio è Machiavelli messo alla prova della piazza, e Machiavelli senza la Fortuna e la Disgrazia è
solo un manuale di piccineria. Del resto anche un cuore indocile di fantino, magari nato proprio in città, che serve pensando al regno, e lo conquista, sta nel conto di una festa piena di grazia e ribalderia. Aceto aveva segnato un’epoca nuova. La gara fra gli eredi non è del tutto regolata,
ma che ci sia una monarchia in palio, e che il fantino regnante regni anche sulla gara e sulla città, è una possibilità effettiva, se non un fatto compiuto. Quando fosse un fatto compiuto, si sentirebbe paragonare il Palio, non vogliano Dio e la Madonna Assunta, al torneo del Milan di Galliani e della Juventus di Moggi.
Dunque si guarderanno così, oggi, con l’occhio della nostalgia e l’augurio del rinascimento, le facce di questi cavalieri di ventura, che furono giovani e seppero nel cerchio bruciante della corsa piegare la sorte, e
consegnare ai committenti la vittoria che era loro, in cambio del soldo
convenuto e delle nerbate nemiche.
***
Si brucia in meno di un paio di minuti la corsa per il Palio, e attorno a
quell’apnea si sfoglia il calendario intero di Siena e delle sue contrade. Il
gioco di lentezza protratta e velocità di orgasmo è la qualità senese che
più seduce e inquieta, e le è confidato anche il legame incomparabile fra
le esistenze personali (anche a Siena si è individui, perfino a Siena si può
sentirsi soli) e le identità comuni. Lentezza cerimoniale e precipitazione tumultuosa evocano il binomio pace-guerra, e il lungo assedio e la
battaglia campale, o, più sottilmente, il paziente corteggiamento e il
bruciante compimento dell’amore. Il corteo sfarzoso e rallentato che
precede per ore nella Piazza del Campo la carriera, e dura fin nella dilazione imprevedibile e logorante della mossa, orgoglio di costumisti ed
esasperazione di turisti, che non vedono l’ora che sia finita e si venga al
dunque. Il corteggiamento attraversa l’anno intero, la minuziosa preparazione da un lato, dall’altro la felicità del festeggiamento o la mortificazione della sconfitta. È lo scambio complicato e mai del tutto esplicito (esplicita è la volgarità) fra maschile in carne e ossa e femminile simbolico a scandire la lunga festa, come nella giostra cavalleresca: del cittadino con la contrada e la città, del giovane ardito con la fortuna da soggiogare e domare, del figlio con la madre di cui meritarsi la grazia.
I fantini del Palio, forestieri per lo più, e dalle stesse regioni dalle quali proveniva la leva delle domestiche e delle polizie, erano tutt’altra gente che gli stranieri del calcio o di altri agonismi ricchi (ricchi di debiti, magari, che è l’ultimo grido della ricchezza). Venivano da fuori a fare lo sporco lavoro, un lavoro pressoché servile, benché col tempo, come in tutti i
posti di nobiltà invecchiata, la servitù si sia messa a spadroneggiare.
Mercenari dichiarati, e condottieri di ventura, al soldo delle contrade:
idoli di un momento, e altrimenti mero strumento di una sfida alla for-
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33
I VOLTI
I ritratti in queste pagine sono tratti dal volume “I trenta
assassini”, di Marco Delogu e Massimo Reale, edito
da Punctum. I fantini sono, da sinistra in alto e poi
in senso orario: Aceto (Andrea Degortes, 60 anni, 58
palii corsi, 14 vinti), Bazzino (Massimo Alessandri, 48
anni, 26 palii corsi, 2 vinti), Giove (Lazzaro Beligni, 75
anni, 40 palii corsi), il Pesse (Giuseppe Pes, 40 anni, 38
palii corsi, 9 vinti), Canapino (Leonardo Viti, 61 anni, 46
palii corsi, 3 vinti), Bastiano (Silvano Vigni, 48 anni, 30
palii corsi, 5 vinti), Vittorino (Giorgio Terni, morto
nel 2000 a 68 anni, 22 palii corsi, 7 vinti), Rompicollo
(Rosanna Bonelli, 69 anni, un palio corso), Marasma
(Mauro Matteucci, 45 anni, 7 palii corsi, uno vinto),
Tripolino (Tripoli Torrini, 90 anni, 20 palii corsi, 6 vinti),
Bazza (Eletto Alessandri, morto nel 2003 a 76 anni, 36
palii corsi, 6 vinti), Pel di carota (Arturo Dejana, 65 anni,
2 palii corsi). Nelle altre foto, il Palio di Siena
Repubblica Nazionale 33 07/08/2005
tuna, senza nobiltà loro, pieno invece di nobiltà il destriero che ricevono in sorte. Dev’esserci il fantino alla partenza, che ci sia il fantino all’arrivo non importa. Il cavallo che può vincere scosso, bellissima invenzione — il desiderio inconfessato e irresistibile di qualunque spettatore del
Palio — dichiara la necessità superflua, per così dire, del fantino. Il quale viene a Siena a offrirsi contro tutto: la compera e il ripudio, il sospetto
e l’intimidazione, la superstizione e il risentimento, e le botte e la cacciata, alla fine. Lo chiamano i soldi, la puntata grossa da lotteria, con cui
arrotondare o surclassare lo stento salario dell’anno ordinario. Ma soprattutto l’ambizione del trionfo di qualche ora, della gara riuscita e della folla che ti innalza sulle spalle, prima di buttarti via e riprendersi, come ogni geloso proprietario, la festa che è solo sua.
Il fantino del Palio è di quelle figure di avventuriero, di galeotto fondatore di città, di combattente del circo, di militare per conto terzi: è il
giovane e virile che, nerbo alla mano, deve servire, secondo Machiavelli, a battere e urtare la Fortuna che è donna, volendola tenere sotto. Succedeva, con quei condottieri di ventura, contadini vogliosi di promozione sociale o cadetti in vena di rivalsa, che il soldo della vittoria non gli
bastasse più, e completassero l’opera delle armi impiegate a salvare la
città volgendole dentro la città e facendosene signori. Nel petto del fantino oscuro, con una barba fosca mal curata, che la luce radente e criminale della fotografia fa sinistramente risaltare, batte un cuore da usurpatore. La città e le sue contrade devono guardarsi dalla minaccia del
servo-padrone, pena la perdita della propria delicata democrazia aristocratica, pena la democrazia plebea del tifo calcistico.
È sempre in bilico, il Palio, fra mille tentazioni di modernità e di somiglianza al resto del mondo. La resa al fantino che la signoreggia — gran
tipo, del resto, come Aceto — o il castigo delle sue pretese, la volontà orgogliosa di rimetterlo al posto suo. Da anni il brontolio contro l’invadenza dei fantini protagonisti cresce. Il fantino di una volta, quello sì,
anonimo se non per il nomignolo d’occasione, e caduco — alla lettera,
destinato a cadere e mordere la polvere del Campo. Ora, che lo si avverta o no, il rapporto della città col fantino muta anche per l’analogia col
nuovo rapporto fra la comunità e il forestiero. Il contratto specializzato
che la contrada e la città stipulavano con il capitano di ventura o col cavaliere del torneo, era la copia privilegiata del contratto ordinario che le
società nuove o stanche stipulano con l’immigrazione, che venga a fare
i lavori che i locali non possono più o non vogliono più fare. Col tempo
un’immigrazione ordinaria e deprezzata insinua il fantasma del servo
padrone fin dentro le case dei nativi ricchi e longevi e fragili, e l’ombra
della gioventù sessualmente aggressiva e prolifica dentro una demografia invecchiata e avara. E già a Siena la delega che la città assegnava al
fantino per il triplice giro vorticoso che faccia culminare il corteggiamento alla Fortuna e celebri il compimento dell’amore, sembrava riconoscere una debolezza, una estenuata raffinatezza bisognosa di sangue
nuovo da prendere a nolo e congedare — come nell’arruolamento delle truppe mercenarie del Rinascimento, come, avventuriamoci a dire, in
una fecondazione eterologa e coperta dall’anonimato. Campioni di passaggio, che abbiano la Fortuna per amica, dunque giovani, «perché sono meno respettivi, più feroci e con più audacia la comandano».
* * *
A scorrere il catalogo delle facce dei fantini — facce di gran tipi, che si
allineano alla mossa «come tanti assassini» — si può rintracciare questa
stratigrafia virile. E subito dopo buttarla via, e buttare via con un’alzata
di spalle tutte le tortuose osservazioni che ho appena compilato, perché
ognuna di quelle facce reclama di essere presa per sé, la faccia di quello
lì, col suo nome da corsa e il suo nome d’anagrafe, la sua vita di ieri e la
sua vita di domani, e, “segni particolari” nella carta d’identità, i soli che
la accomunino alle altre facce, certi solchi ai lati del naso e della bocca,
certi bagliori in fondo alle pupille, scavati e accesi in meno di due minuti di un tramonto d’estate della loro vita.
Dura e servile era la vita del fantino di Palio, fino a poco fa, e per molti
ancora. I ritratti di Marco Delogu lo mostrano. Foto di ricercati. Sceriffi
stanchi e pacifisti che furono pistoleri. Duellanti di vent’anni, come Bighino, nelle cui labbra strette si legge già il magnanimo giudice di pace
che verrà. Ritratti freddi, con una luce sinistra (si può dire così, come si dice “mettere in cattiva luce”) che aspetta al varco la barba di un giorno e i
solchi scavati da una vita, e dai due minuti della corsa. Belle facce, belle
didascalie. Messi davanti alla camera oscura, non sono i protagonisti del
Palio, o piuttosto, lo sono, ma sono anche i suoi più innocenti passanti.
Effetto di dentro, e di estraniazione: il Palio visto con gli occhi e i pensieri dei suoi fantini scossi è come la battaglia di Borodino vista con gli occhi
di una cavallina. C’è una bella frase antinapoleonica di Dario Colagè, detto il Bufera, sotto la foto stranamente glabra: «Il primo Palio che ho corso
l’ho vinto ma non chiedetemi come è andata perché non lo so». Uno corre il Palio, e magari lo vince: e pretendete pure che l’abbia visto?
FOTO FABIO MUZZI
dei servi-padroni
34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
i luoghi
Oasi d’Italia
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
Su queste cinque isole abitano stabilmente
412 persone, discendenti dei “guappi” deportati
qui un secolo e mezzo fa. Parlano e mangiano ancora
napoletano anche se vivono al largo della Puglia
E non fanno più gli agricoltori o i pescatori: ora
vendono il loro splendido mare al miglior offerente
Tremiti, il confino a cinque stelle
I
ISOLE TREMITI
n certi giorni d’inverno ce n’è una
che sprofonda, che scompare
nella tempesta. E a ogni primavera riaffiora più aspra, più rugosa.
Sulla sua roccia cresce solo l’aglio selvatico. È sperduta quell’ultima isola
che guarda la costa dalmata e dove una
volta si spingevano i pescatori più impavidi, a nord ha fondali a picco e a sud
una grande secca, non vi sono animali,
tra le sue rupi non c’è più neanche quella cisterna che salvò la vita a Domenico.
Fu tanti anni fa. «Era il 1948 o forse il
1949», ricorda lui che allora era appena
un ragazzo e non faceva ancora il guardiano del faro. Al tramonto Domenico
“Menicu” Calabrese puntò il suo gozzo
a oriente, verso la Pianosa che sta in fondo all’Adriatico.
Erano in quattro sulla barca e all’improvviso si alzò il vento, il gozzo fu scagliato in aria e poi risucchiato in un gorgo. La burrasca li trascinò sugli scogli,
trovarono riparo in una grotta. Racconta Menicu: «Per due settimane siamo
rimasti là, sopravvissuti con le aragoste
che catturavamo e con le cozze raccolte in un canalone. Per fortuna c’era acqua buona nel serbatoio di pietra che
aveva lasciato qualche navigante o
qualche pirata». È piatta l’isola che c’è
e non c’è. La sua montagna più alta sfiora i dieci metri. Sulle carte nautiche è un
puntino distante dodici miglia dalle altre quattro, tutte così vicine tra loro,
tutte così diverse.
C’è quella deserta che chiamano Capraia o Caprara e anche Capperaia o
Capperara, per l’abbondanza dei suoi
capperi. E poi, c’è San Nicola con l’imponente abbazia benedettina e quei
casermoni dove erano relegati i confinati politici e ancor prima i coatti. E di
fronte ci sono le pareti ripide di San Domino, il bosco profumato di pini d’Aleppo, cale, antri, spuntoni e acque verdi e azzurre che luccicano, i tornanti
che uno dopo l’altro si arrampicano fino al paese. In mezzo all’arcipelago, disabitata anch’essa, c’è Cretaccio che
prende il nome dalla sua argilla. Quando piove si scioglie e colora di giallo il
mare. Stagione dopo stagione cambia
forma, si arrotonda, si fa più piccola.
Mai uguale a se stessa, prima o poi sarà
inghiottita dal mare.
Figli dei “vagabondi”
Sono cinque le isole Tremiti e 412 i suoi
abitanti, quelli che discendono dai
«guappi» e dai «vagabondi» del Regno
delle Due Sicilie deportati più di un secolo e mezzo fa su questi sassi davanti alla Puglia. Parlano sempre napoletano e
anche il loro mangiare è di quell’Italia ai
piedi del Vesuvio, lingua e usanze tramandate di generazione in generazione
dalle diciotto famiglie che originariamente popolavano e ancora popolano
quest’incanto nell’Adriatico. Sono loro
le radici delle Tremiti. Sono i Santoro e i
Greco, i Calabrese, gli Attanasio, i Carducci, gli Alfarano, sono i Pica e i Napolitano. E i Lisci, i Cafiero, i Davino, i Pezzella, i Pallesca e i De Simone, i Capitelli, i De Luca, i De Martino e i Casieri.
Sessant’anni fa, erano pescatori e
agricoltori che hanno imparato a leggere e a scrivere dagli «indesiderabili» del
regime o da qualche istruito borsaiolo
spedito dai questurini al domicilio forzato. Sono diventati albergatori, hanno
aperto ristoranti e pizzerie e scuole di
subacquea, affittano barche e gommoni, accumulano denaro vendendo il loro mare al miglior offerente. Sono diventati ricchi ma non fanno il pane. Lo
portano ogni giorno con l’aliscafo da
Termoli, la città molisana più vicina.
Non c’è un forno alle Tremiti. Non c’è
più un calzolaio a San Domino, non c’è
più un fabbro a San Nicola, non ci sono
più falegnami o muratori o sarti su queste isole che sembrano aver perso la memoria. «Siamo passati da luogo di confino all’industria turistica senza neanche
accorgerci di come stava cambiando la
nostra vita», ci dice Gaetano Carducci,
l’uomo più vecchio delle Tremiti. Ha appena compiuto 91 anni. La donna più
vecchia è invece sua moglie Bianca, che
di anni ne ha 93. Gaetano è stato segretario del fascio, contabile alla colonia
penale, dipendente del Comune, presidente della Pro Loco. Scrive, dipinge, archivia ogni documento che trova sulle
vicende dell’arcipelago e lo custodisce
nella torre, pinnacolo di tufo di quel monastero che fu regno di religiosi. Prima i
benedettini, poi i cistercensi, poi ancora i canonici lateranensi.
È Gaetano che ci ha fatto da guida nell’esplorazione delle sue cinque isole, che
ci ha svelato le intimità di San Nicola e di
San Domino,
che ci ha raccontato quel vivere lento di chi
sta sempre in
mezzo al mare.
Suo padre si
chiamava Vincenzo, è ricordato ancora alle
Tremiti per
l’audacia che
ebbe un secolo
fa. Era un contadino e convinse tutti gli altri contadini a
estirpare ulivi e
mandorli per
piantare vigne.
«Conservatori
come
sono
sempre stati, gli
agricoltori in
principio lo
presero per
pazzo. Poi però
gli diedero retta e non se ne
pentirono
mai», sussurra
Gaetano mentre ci accompagna sul viale
ornato di palme e di oleandri. Un viale
che per lui è
stato il mondo.
Siamo sulla
cima di San Nicola. Giù c’è
l’antico «sbarcatoio» e il tortuoso viottolo
lungo il quale
una volta si
montava in vetta, adesso si sale con gli
ascensori scavati nella roccia, sui moli
dondolano i barconi dei “tour dell’isola”, i fuoribordo, i traghetti che vanno e
vengono dal Gargano. Ma su, su a San
Nicola quasi nulla sembra cambiato.
C’è silenzio, il sole sta calando dietro i
casermoni dove Ferdinando II di Borbone rinchiudeva i suoi galeotti. «Un
giorno ho trovato una palla di ferro, una
di quelle che i proscritti avevano al piede legata alla catena», dice Gaetano indicando il punto esatto della campagna
dove era rotolata quella palla.
Traversa delle Prigioni, via degli Abati, via della Torretta, ecco le case dove
per tanti anni vissero guappi, “politici”,
i briganti stanati sulle Madonie dal prefetto Mori. Sono sempre state terre di
confino le Tremiti. Fin dall’antichità. La
prima segregata fu Giulia, nipote dell’imperatore romano Augusto. Per i
suoi adulteri la tennero prigioniera a vita sulle isole, dove morì nell’anno 28. E
sette secoli dopo ci portarono anche
Paolo Diacono, reo di aver congiurato
contro suo suocero Carlo Magno.
Poi vennero i deportati dei Borboni e
poi ancora gli esiliati del fascismo. Dal
1940 ne passarono centinaia e centinaia di confinati da San Nicola. Parlamentari come Finzi e Ferreri e Martire,
avvocati come Brignetti e Mancinelli e
Bolli, ingegneri, medici, sindacalisti.
«Per pochi giorni è stato qui anche Sandro Pertini, trasferito per punizione da
Ponza alle Tremiti», ricorda Gaetano. Il
vecchio segretario del fascio cerca nei
suoi scaffali la “carta di permanenza”
del confinato Pertini Sandro, il regolamento di comportamento che riceveva
ogni nuovo arrivato. «Era qui, era proprio qui ma non riesco a trovarla. Pertini è rimasto comunque per un brevissimo periodo. Il suo alloggio era là in fondo», dice Gaetano mentre ci accompagna verso l’ultimo casermone di via degli Abati. Quasi di fronte dimorava invece Amerigo Dumini, uno degli
assassini di Giacomo Matteotti.
Gaetano torna indietro nel tempo,
chiude gli occhi. E bisbiglia: «Quello me
lo ricordo bene, era sempre scortato da
quattro carabinieri che temevano per la
sua vita. Era elegantissimo, al guinzaglio teneva un cane bianco. Era l’unico
confinato al
quale non censuravano la posta. Scriveva
ogni settimana
al Duce e ogni
settimana riceveva denaro da
Roma».
La sera del 25
luglio 1943 il fascismo cadde e
la triste storia
delle deportazioni alle Tremiti finì per
sempre.
Gaetano
Carducci non
era più segretario del fascio
ma un galantuomo resta
sempre un galantuomo. E
così cominciò a
lavorare in Municipio. E cominciò anche
ad assistere alla
metamorfosi
delle sue isole.
Quelli del
Touring club
italiano furono
tra i primi a scoprirle. Erano gli
Anni Cinquanta quando un
gruppo di medici milanesi
sbarcò a San
Domino. Poi il
Touring aprì il
suo villaggio a
Cala degli Inglesi, una delle
insenature più spettacolari. E proprio lì,
tra quella baia e il piccolo promontorio
denominato Punta del Vapore, un sommozzatore romagnolo ha trovato un relitto incagliato sul fondo. I resti di una
nave con una grande ruota a pale. Dicono che sia la carcassa del “Lombardo”,
una delle due imbarcazioni — l’altra era
il “Piemonte” — che il 6 maggio 1860
levò l’ancora dallo scoglio di Quarto per
far rotta su Marsala. L’impresa di Peppino Garibaldi e dei suoi Mille.
Secondo alcuni storici il “Lombardo” sarebbe affondato proprio a pochi
metri dalla Cala degli Inglesi in una
notte di bufera, tra il 19 e il 20 marzo
1864. Trasportava detenuti da Ancona
alla colonia penale. «Aspettiamo ancora conferme ufficiali dalla Soprintendenza», avverte il sindaco Giuseppe Calabrese, un’ex testa di cuoio delle nostre forze speciali che per le sue
Tremiti sogna un tunnel sottomarino
che conduca da San Domino a Cretaccio e da Cretaccio a San Nicola, un’ardita via di comunicazione sulla traccia
di quei camminamenti in legno costruiti dai benedettini, passerelle fradice di salsedine e scivolate in mare.
Ma ci vogliono tanti soldi e soldi non
ne ha molti il Comune. Con l’euro che
ogni turista versa come tassa di sbarco,
l’amministrazione si copre a mala pena
FOTO SIME
ATTILIO BOLZONI
L’arcipelago
è stato da sempre
destinazione
degli “indesiderabili”
e tra gli ospiti ha avuto
anche Sandro Pertini
I residenti: “Siamo
passati da terra
di esilio a industria
turistica senza
accorgercene”
le spese per lo smaltimento dei suoi rifiuti. Nel 2004 di turisti ne sono arrivati
360mila. Annotava Francesco Delli Muti nel suo primo libro sulle Tremiti dato
alle stampe cinquant’anni fa: «Ecco il bilancio del movimento stagionale: 1954,
turisti n. 542 dei quali 47 stranieri; 1955,
turisti 2.141 dei quali 21 stranieri...».
Sono aumentati estate dopo estate.
Ma si fermano poco. Gli aliscafi li scaricano sui moli di mattina e se li vanno a
riprendere al tramonto.
La guerra delle vacanze
Si lamentano dei prezzi troppo alti. Si
lamentano dei loro lamenti i commercianti. In molti vengono dall’Abruzzo o
dal Lazio con i torpedoni e abbinano la
giornata di mare con un pellegrinaggio
a San Giovanni Rotondo, il paese dove
visse e morì Padre Pio. Scendono a San
Domino con gli zainetti pieni di provviste. Non si comprano neanche l’acqua.
È una piccola grande guerra quella tra i
turisti pendolari e i bottegai di queste
isole che nel passato chiamarono Diomedee in onore dell’eroe della guerra
di Troia, l’inseparabile compagno di
Ulisse. La leggenda narra che Diomede
sia stato seppellito alla Tremiti. E che i
suoi amici, furono tramutati da Afrodite in uccelli di mare.
Per fortuna nel villaggio di San Domino ci sono alberghi e pensioni che
regalano ospitalità e cibo buono. C’è
“Il Gabbiano” di Gino Napolitano, un
ottantenne di grande garbo che fa anche l’assessore al turismo delle sue isole. E c’è il “Belvedere” di Giusy e Arturo, lei in cucina e lui a intrattenere i
clienti con i suoi racconti. È stato campione mondiale di pesca subacquea
alla fine degli anni ‘60, ha le foto dei
suoi trionfi alle pareti del bar. Hanno
un figlio, Arturo junior. Ha tredici anni
e fa la terza media. È in una “pluriclasse” con il mauriziano Shames, che frequenta la seconda media insieme alla
compagna Morwen. Sono i soli tre
alunni delle isole. Per “socializzare”
con gli altri ragazzi, le lezioni le fanno
in videoconferenza, collegati con un
presidio scolastico di Manfredonia. Alle elementari non ci sono studenti.
L’ultimo bimbo è nato nel 2000, il penultimo trentantacinque anni fa. Si va
a partorire a Foggia, a Termoli, a Bari.
C’è chi vuole comprare alle Tremiti.
Lucio Dalla sta acquistando l’antica farmacia, quella che sta proprio sotto la caserma dei Reali Carabinieri dell’abbazia fortezza. Diventerà la casa della fondazione Come è profondo il mare. Il cantautore ha già un rifugio qui e qui si ispira. Luna Matana è stato il suo ultimo album, Cala Matano è forse la più bella
baia di San Domino.
E c’è chi vuole vendere. Lo Stato italiano sta cedendo all’agenzia del Demanio «per la dismissione» il faro, che è
alla Punta del Diavolo. Dal 1987 è abbandonato. Nel novembre di quell’anno due mercenari svizzeri lo fecero saltare, uno morì nell’attentato e l’altro
misteriosamente sparì dopo un paio di
mesi di prigionia. Qualche giorno prima il colonnello Gheddafi aveva rivendicato il possesso delle Tremiti per alcuni deportati libici che nel 1911 vi soggiornarono, poi arrivarono i due svizzeri con le bombe. Di quell’intrigo non si
scoprì mai nulla. «E da quel novembre
io ho perso la casa dove abitavo dal
1959», ricorda Menicu Calabrese, il fanalista che dentro il faro alla Punta del
Diavolo aveva cinque stanze per i suoi
cinque figli e un piccolo orto dove coltivava peperoni e melanzane.
Il padre di Menicu faceva il guardiano del faro a San Domino. E anche suo
nonno e suo bisnonno erano fanalisti.
Ogni tanto, all’alba, Menicu si incammina ancora verso la roccia a strapiombo. E si ferma sempre là, alla Punta del Diavolo.
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35
LA NATURA. Qui sotto, una veduta dell’isola di San Domino. Nella pagina accanto, l’arco di pietra di Caprara
FOTO SIME
Repubblica Nazionale 35 07/08/2005
LE BELLEZZE. Il faro dell’isola di San Domino. Qui sotto, il castello di San Nicola e, in basso a destra, i Faraglioni di San Domino
36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
A dieci anni dalla morte la città di Siena gli dedica una mostra
di acquarelli, realizzati tra il 1965 e il 1995, intitolata “Periplo
immaginario”: una riflessione sull’opera di questo grande
artista della narrazione a fumetti, ma anche un’occasione per ammirare
i suoi straordinari nudi femminili. Figure che ricordano i quadri di Schiele
e sospingono il creatore del marinaio-zingaro nell’universo dell’alta pittura
Hugo
UMBERTO ECO
“P
Pratt
eriplo immaginario” è il titolo del sontuoso catalogo della mostra dedicata a Siena
agli acquarelli di Hugo Pratt, dal 1965 al
1995 (Lizard Edizioni, 60 euro). Anche se
Pratt fosse stato, in vita sua, soltanto l’autore di questi acquarelli, essi basterebbero
a fargli consacrare almeno un paragrafo in una storia dell’arte.
Ma il rischio è che qualcuno, affascinato dalle immagini prodigiose di questo volume, ammetta che Pratt è stato grande artista perché si è dimostrato anche buon pittore, malgrado la
sua lunga militanza «artigianale» nell’universo del fumetto.
Siccome invece Pratt è stato grande artista soprattutto in
quanto narratore a fumetti (e se a qualcuno l’espressione può
parere ancora riduttiva, «narratore verbo-visivo»), non è casuale che la mostra di Siena lo onori a dieci anni dalla sua morte, e che il saggio introduttivo del volume, di Thierry Thomas,
se pure è intitolato agli acquarelli, sia in realtà una riflessione
sull’arte di Pratt in generale, e in particolare su quel suo genio
verbo-visivo per cui si è incapaci di distinguere il disegno dalla
scrittura (nelle storie di Pratt «c’è una sola linea»)
Chi scrive la recensione di un romanzo non deve esordire
con una legittimazione della letteratura, mentre ancora oggi
chi parla al pubblico generico di fumetti deve mettere ancora,
in qualche modo, le mani avanti. Meno di un anno fa si era tenuto a Bologna, presso la Scuola Superiore di Studi Umanistici (che ospita il Fondo Enrico Gregotti, centinaia di originali di
grandi autori del fumetto), uno dei tanti convegni su questo
genere letterario che si svolgono qua e là per il mondo, a livello universitario, almeno dalla fine degli anni Cinquanta, ed ecco che un quotidiano annunciava l’evento con il titolo «Il fumetto entra all’università dalla porta d’ingresso» (come se negli ultimi cinquant’anni ne fosse stato tenuto fuori — e come
se questa inattesa promozione provocasse ancora vuoi inquietudine vuoi lieta sorpresa).
In realtà non esistono detrattori del fumetto (chi non lo ama
non lo legge, e basta, e quindi non è in grado di scriverne, sia
pure per dirne male). Esistono però i detrattori di coloro che
parlano del fumetto. Il loro argomento principe è che chi parla di fumetti ha eliminato ogni differenza tra Dante e Topolino. Si tratta ovviamente di una sciocchezza, difficilmente sostenibile con qualche ricorso testuale, ma è pur vero che gli
amanti del fumetto, dando inizio a una sua storiografia e a una
sua critica, si sono spesso comportati come uno storico della
letteratura che non distingua (in termini di valore estetico,
complessità e profondità di pensiero) tra Dante e Burchiello,
partendo dal principio che entrambi scrivono in rima.
Il discorso sul fumetto porta ancora i segni di un complesso
dei suoi «padri apologisti», quando per farsi ascoltare occorreva legittimare il genere in sé, senza perdersi in troppe distinzioni. È così sovente accaduto che in molte riviste dedicate al tema (e spesso in opere storico-critiche) non fosse chiara
la differenza tra critica delle opere e degli artisti, sociologia del
fenomeno, gusto o mania collezionistici, e occasionale cedimento alla nostalgia.
Nell’universo del fumetto la critica dovrebbe poter operare
distinzioni tra bello e brutto, originalità e manierismo, invenzione e plagio, così come avviene nei vari settori della letteratura e delle arti. Si può essere cinefili e saper distinguere tra Antonioni ed Ed Wood. È sociologicamente interessante studiare
l’impatto che sia Flash Gordon che Dick Fulmine hanno avuto
sulla generazione italiana degli anni Trenta e Quaranta — e magari ammettere di sentirsi nostalgicamente più legati a Fulmine che a Gordon, e parimenti pochi italiani nati in quell’epoca
si sentono nostalgicamente legati a Little Nemo (che aveva fatto fugaci apparizioni solo sul Corriere dei Piccoli dei loro genitori e su Topolinonel 1935), e ricordano con più tenerezza Mandrake. Ma è criticamente innegabile che Alex Raymond e Winsor McCay sono stati artisti incomparabilmente più ricchi e
complessi di Carlo Cossio e Phil Davis.
Insomma è spesso accaduto ai padri apologisti del fumetto
quello che accadeva ai cinefili marxisti del tempo andato, per i
quali ogni film sovietico era necessariamente un capolavoro.
Talora il fumetto ha determinato alcune tendenze delle arti
figurative (la pop art ne è l’esempio più ovvio) e talora delle arti
figurative ripercorre vicende anche secolari. Ora non mi pare
che si analizzino ancora con la dovuta severità i casi in cui il fumetto manifesta sindromi di dipendenza da altre arti. Non tutte le analisi mettono in luce quando e come una data tecnica
All’ultima storia capì:
Corto Maltese sono io
Quasi sempre
i disegnatori
si sono ritratti
nei loro personaggi
L’eroe-vagabondo
ha la linea del naso,
il taglio della bocca
del suo ideatore
LA FOTOGRAFIA
Un primo piano di Hugo Pratt
morto nel 1995 a 68 anni
verbo-visiva imita una precedente tecnica cinematografica e
quando invece addirittura la precede (come è stato il caso di
Crepax). A parte serie anche ben fatte che riciclano senza pudore trame letterarie o cinematografiche famose, e su questo richiamo al già noto si sostengono, vorrei citare un fumetto interessante e spiritoso come Julia, che potrebbe vivere benissimo in base alle proprie forze (e ad alcune trovate originali come l’inserzione di commenti «musicali» nel
corso del racconto) e che tuttavia, come sentendosi insicuro, ha deciso di dare alle sue due protagoniste femminili i volti di Audrey Hepburn e di Woopy Goldberg. Facile richiamo, che forse contribuisce al successo
della serie, ma perché non parlare criticamente di parassitismo?
Cosa accade invece con Pratt? Tante volte i
suoi lettori sono stati tentati di identificare Corto
Maltese con Lord Jim, o almeno di intravedere nella saga di
Corto influenze conradiane. Mi pare di ricordare che Pratt abbia ammesso i suoi debiti con Conrad (ma ha anche scritto che
il suo interesse per i mari del sud nasce da La laguna blu di de
Vere Stackpoole). Però sono del pari evidenti, e spesso espliciti
nella scelta dei temi da illustrare, i suoi riferimenti a Stevenson,
Kipling o Fenimore Cooper. Però non troviamo in Pratt alcuna
traccia di parassitismo. Egli riconosce le sue fonti ispiratrici ma
combatte bravamente la sua lotta con l’angelo, elabora e risolve, come direbbe Bloom, la sua angoscia dell’influenza, e crea
delle storie che sono soltanto e inequivocabilmente Pratt.
Lo fa persino con una strizzata d’occhio post-moderna, come si vede ad esempio quando, anziché subire un’influenza, la
ostenta con vezzo citazionistico: ed ecco che nella Ballata a un
certo punto Pandora appare dolcemente appoggiata all’opera
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37
IL CATALOGO
Le illustrazioni di queste pagine
sono tratte dal catalogo della mostra
di Siena, intitolata “Periplo immaginario”.
Appartengono originariamente al volume
“Avevo un appuntamento”,
storia dei viaggi veri e immaginari
di Pratt nel Pacifico, pubblicato
per la prima volta nel 1994
omnia di Melville, Cain — che verso la fine citerà Euripide — legge Coleridge, autore di un’altra ballata, quella del vecchio marinaio (che ha trovato in traduzione italiana a bordo di un sottomarino tedesco nella bibliotechina di Slütter, il quale lascerà
a Escondida anche un Rilke e uno Shelley) e persino un avanzo
di galera come Rasputin (anche qui una citazione, ma così scoperta e così fuori contesto, da denunciare tutta la sua dotta ironia) legge in cabina il Voyage autour du monde par la frégate du
rois La Boudeuse et la flûte L’Etoile di Bougainville.
Pratt sembra a prima vista ispirato da tutto l’orientalismo e
l’esotismo degli ultimi due secoli, ma anziché abbarbicarvisi
parassitariamente, lo critica e lo capovolge, posando uno
sguardo diverso sui suoi «selvaggi»: i suoi dancali esoterici, i suoi
indios fatti saggi da remote macumbe, i suoi indiani delle gran-
di pianure sono spesso più colti e consapevoli dei loro colonizzatori — e tanto per citarne uno, il Cranio della Ballata ha fatto
pratica legale presso un avvocato indiano di Viti Levu e discute
di mitologia maori e sociopolitica melanesiana con la sicurezza di una Margaret Mead.
Con maggiore libertà da ogni altra fonte (che non sia forse la
prima ispirazione ricevuta da Milton Caniff) Pratt gioca con
grazia ironica anche sul registro figurativo, e — come dice
Thomas nel suo saggio per il catalogo — si ha l’impressione
che gli stessi acquarelli con cui egli commentava in itinere i
suoi fumetti, permettano di capire meglio le sue strisce. «In un
acquarello, il tempo che separa lo schizzo dall’opera completa, deve ridursi il più possibile. Idealmente non c’è distinzione tra la preparazione e la realizzazione, tutto deve essere col-
to nello stesso movimento, altrimenti si rapprende e muore.
Così, nelle ultime tavole di Hugo, la fase degli abbozzi e quelle della messa in bella si confondono». Così avviene per esempio nella saga di Corto Maltese, dove il protagonista nasce con
un segno ancora tormentato nella Ballata del mare salato (come se l’autore ne cercasse la fisionomia senza riuscire ancora
a definirla) e, via via che le sue storie procedono, si essenzializza sempre più, diventa un cenno, un calligrafismo e (invenzione di un «artista dell’acqua e dell’aria») si fa alla fine liquidamente etereo diventando, in un solo lampeggiare di bianchi e neri, la citazione di se stesso.
Ma Corto Maltese è anche l’esempio di una continua ridefinizione di Pratt. Mi scuso se torno a un aneddoto che ho già raccontato almeno due volte, ma lo trovo denso di insegnamenti.
Quasi sempre i disegnatori di fumetto si sono ritratti nei loro
protagonisti, o nei deuteragonisti al massimo, e chi ha incontrato Al Capp, Feiffer, Schulz o Jacovitti, lo sa (solo Phil Davis ha
disegnato in Mandrake il volto di Lee Falk, l’autore delle storie
— ma forse era Lee Falk che a poco a poco aveva deciso di diventare Mandrake). Di Pratt non lo sospettavo. Ma un giorno,
alla presentazione di non so più quale libro o evento, l’ho incontrato alla Terrazza Martini di Milano e l’ho presentato a mia
figlia, che credo facesse ancora le elementari ma era già lettrice
delle sue storie, e lei mi ha sussurrato all’orecchio che Pratt era
Corto Maltese. Che il re sia nudo lo può dire solo un bambino.
Pratt non aveva la statura, l’astata longilineità di Corto, ma guardandolo meglio, di profilo, ho dovuto convenire che in qualche
modo era Corto: la linea del naso, il taglio della bocca, non so,
certamente Pratt non era il Corto della Ballata, ma quello più
magico delle ultime storie, quelle che Pratt non aveva ancora disegnato... Pratt si stava cercando (fantasticava con la matita
chiedendosi come avrebbe voluto essere), e cercandosi inseguiva alcuni sogni errabondi.
È in questa bruma, persino in una tecnica non ancora completamente sicura di sé, che nascono i miti, e i personaggi che
sanno uscire dai propri testi per invadere la nostra immaginazione e il nostro ricordo, così che ci capita spesso di incontrarli
in altri testi, magari venuti prima di loro, e addirittura — almeno tanto è dato ai bambini — nella vita.
Ora questa ricerca appare ancora più evidente negli acquarelli, che sfilano sotto i nostri occhi come un diario colorato e in
cui, come si diceva, l’abbozzo è talmente definitivo da diventare talora una definizione.
Siccome un acquarello è un’opera a sé, Pratt dovrebbe essere un pittore. Ma, in quanto frequentissimamente gli acquarelli riproducono o anticipano personaggi delle sue storie, Pratt sarebbe un illustratore. Qual è la differenza tra un pittore e un illustratore anche quando l’illustratore è grandissimo, come
Doré, Rackham, o Gustavino? Direi che nella pittura il soggetto
del quadro si affranca dalle circostanze che lo hanno ispirato,
così che non ci chiediamo (se non giochiamo alla Dan Brown)
chi sia la Gioconda o che cosa accada nel Concerto campestre.
Invece davanti a una illustrazione di solito non possiamo goderla appieno se non comprendiamo che cosa illustri, ovvero
se la si separa dal testo scritto da cui dipende. Naturalmente la
distinzione è trasversale rispetto alle tecniche. Molti pittori ottocenteschi che ci rappresentano, che so, i Lombardi alla prima
crociata o il doge Tal dei Tali che riceve i messaggeri del sultano
(direi in genere la pittura alla Hayez) sono in effetti illustratori,
e se il quadro non avesse la targa col titolo ci chiederemmo che
ci stanno a fare quei signori in costume in quel salone. Al contrario può accadere che alcuni schizzi nati per illustrare un libro
(per esempio i don Chisciotte di Picasso), vivano poi per conto
proprio, tanto quanto i personaggi del periodo blu.
Infine, a mezza strada tra l’illustrazione e la pittura, sta l’arabesco, il «ricercare» grafico, genere a cui si possono ascrivere
tanti disegni dei grandissimi maestri rinascimentali o barocchi.
Forse non ci presentano personaggi «universali» come la Dama
con l’ermellino o l’Uomo del guanto, ma non rimandano a nulla, vivono per grazia propria.
Ecco, negli acquarelli di Pratt ci sono spesso delle illustrazioni, che rinviano alle sue storie, vi sono molti splendidi
arabeschi e c’è pittura allo stato puro, e in particolare citerei
certi nudi femminili, per cui Thomas azzarda il riferimento a
uno Schiele meno incattivito (ma sono prodigiosi anche senza pensare a Schiele). E per invogliare qualcuno ad andarsi a
sfogliare il catalogo, direi che il ritratto ambiguo di Venexiana Stevenson, del 1994, raggiunge quel rapporto con l’universale che è proprio della grande pittura (con qualsiasi tecnica sia eseguita).
38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
Tutto cominciò nelle piantagioni di cotone del profondo Sud. Ma la grande
trasformazione avvenne negli anni Quaranta nella capitale dell’Illinois,
dove la “musica del diavolo” trovò finalmente la sua anima
Grazie all’introduzione nei ritmi afroamericani dei suoni della chitarra elettrica,
lo strumento che poi sarebbe stato l’emblema della generazione del rock. Un successo
dovuto anche alla casa discografica di due fratelli ebrei arrivati dalla Polonia
Le vie
del
FOTO MAGNUM/CONTRASTO
Blues
P
rovate a guardarvi intorno,
quello che vedrete è il blues,
ovunque. Sì, perché siete a
Chicago, la città del blues, il
luogo dove la musica del
diavolo ha trovato la sua anima. Provate a camminare lungo quello
che resta di Maxwell Street, a respirare
l’aria di Canal Street e del suo mercato,
a girare attorno al palazzo della Chess
Records, a scivolare tra i vicoli del South
Side. Provate a rivivere l’inseguimento
tra le centinaia di macchine della polizia e la “blues mobile” dei Blues
Brothers sotto ai piloni del “Loop”, la
ferrovia sopraelevata della città e a intonare le note di Sweet Home Chicago,
scritta da uno dei padri del
blues, Robert Johnson. E
se ancora non accade nulla, provate ad assaggiare
qualche cucchiaiata di
“soul food” in uno dei
molti club della capitale
dell’Illinois, dove si parla
solo la lingua del blues e
tutto vi apparirà più chiaro. E la magia di una musica antichissima e allo stesso tempo moderna vi avrà
sicuramente catturato.
Chicago è davvero un
luogo straordinario, una
delle grandi capitali della
musica americana, una
delle città che ha visto nascere il jazz, dove è fiorito
il blues, dov’è nata addirittura la techno, un luogo
dove i suoni e le culture si
sono sempre incontrati e
dove ancora oggi è possibile “respirare” la musica
ad ogni angolo, nei festival di jazz e di blues che
animano la città tra la primavera e l’autunno, nei
mille club che di notte trasformano ancora Chicago in un gigantesco jukebox
naturale, nelle strade dove, ricordan-
Dai campi a Chicago, sola andata
Nella città i suoni si “respirano”: qui sono
nati anche il jazz e, più di recente, la techno
Gli artisti continuano a darsi appuntamento
e a esibirsi nei festival, nei locali storici
e perfino agli angoli delle strade
FOTO GRAZIA NERI
ERNESTO ASSANTE
IL GRANDE INNOVATORE
Nelle foto qui sopra e in alto,
due immagini di Muddy Waters
do la tradizione, ci sono ancora decine
di musicisti che mettono alla prova dal
vivo le loro composizioni. Ed è così da
più di ottant’anni.
Nella città dell’Illinois furono realizzati i primi dischi di jazz, King Oliver incise con la New Orleans Jazz Band e
Louis Armstrong formò i suoi Hot Five
e Hot Seven. A Chicago si sviluppò l’era dello swing, così come avvenne a
New York e a Kansas City e le jazz band
fiorirono nell’illegalità del proibizio-
nismo, suonando al cospetto di Al Capone e dei suoi “ragazzi”. E anche l’avanguardia, negli anni Settanta, trovò
a Chicago il suo terreno naturale per
crescere e svilupparsi, con i grandi
principi dell’improvvisazione e i “padri” dell’Art Ensemble Of Chicago.
Ma Chicago è soprattutto la città del
blues, una sorta di naturale laboratorio permanente dove la musica afroamericana ha saputo crescere e svilupparsi: sulla scorta della lezione di artisti come Big Bill Broonzy, Ma Rainey,
Blind Lemon Jefferson, raccogliendo
la lezione del boogie woogie, il blues a
Chicago ha definito i contorni della
sua identità urbana, favorito dall’invenzione della chitarra elettrica. Il
blues urbano era una forma più agile e
violenta del blues tradizionale, i suoi
caratteri incarnavano i ritmi e le tensioni della vita e del lavoro dei neri nelle città del Nord. Per molti il blues stesso si identifica col particolare stile del
blues di Chicago, quello reso famoso
da Muddy Waters, Elmore James,
Howlin’ Wolf, un suono di chitarre
elettriche su note allungate, di armoniche a bocca amplificate dai microfoni, e un ritmo pulsante di basso
elettrico e batteria, sul quale si intrecciano i suoni di un pianoforte boogie
e voci profonde e cavernose. Chicago
ha definitivamente trasformato il
blues in una musica capace di arrivare a pubblici diversi, alle grandi platee
miste del “mass market”, uscendo definitivamente dai ghetti e influenzando intere generazioni di musicisti da
un lato all’altro dell’oceano. In un certo senso fu il trionfo del blues del Delta, trasformato e adattato allo spirito
di una grande città.
L’epicentro di questa “rivoluzione”
fu la Chess Records. Gli studi di 2120
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39
IL CANTO DEI RACCOGLITORI
Sonorità melanconiche, testi crudi e realistici, spesso conditi
con riferimenti sessuali espliciti. Il Blues — la “musica
del diavolo” — nasce alla fine dell’800 fra gli schiavi africani
nelle piantagioni di cotone del delta del Mississippi. Negli anni
Trenta segue i lavoratori di colore, diventati operai,
e si trasferisce nelle metropoli. A Chicago incontra amplificatori
e chitarre elettriche, e nasce il Blues moderno. Ma è negli anni
Settanta, in Inghilterra, che si impone all’attenzione
del pubblico bianco, influenzando tutta la musica pop (v. m.)
I MITI
CosìWatersdiedenuovavitaalgenere
Muddy, il contadino
che diventò leggenda
«M
BLIND LEMON JEFFERSON
Negli anni ’20 il Blues era ancora
considerato “musica da schiavi”.
Blind Lemon è il primo a riscuotere
un certo successo commerciale
ROBERT JOHNSON
È il primo fenomeno Blues
del dopoguerra. Incide solo 29 pezzi,
fra cui “Sweet Home Chicago”
e “Come on in my Kitchen”
HOWLIN’ WOLF
FOTO CORBIS/CONTRASTO
A partire dagli anni ’40 la musica
Blues si trasferisce a Chicago
Howlin’ Wolf è il suo interprete
più significativo
Repubblica Nazionale 39 07/08/2005
South Michigan Avenue vennero aperti da due fratelli ebrei, Leonard e Phil
Chess, arrivati nel 1928 dalla Polonia.
Nessuno dei due conosceva una sola
nota di musica, ma avevano un grandissimo fiuto per gli affari. Leonard in
particolare aveva dato vita a diverse attività, fino a quando non incrociò il
blues e ne comprese le straordinarie
potenzialità commerciali. Decise, con
l’impegno determinante del fratello,
di fondare la Chess, destinata a diventare la più importante etichetta blues
della storia americana.
Prima dell’arrivo di Muddy Waters,
c’erano già star del calibro di Sonny
Boy Williamson, capace di trasformare l’armonica a bocca in un elemento
solista determinante. C’erano Big Bill
Broonzy, carismatica figura, acuto e
spesso ironico poeta del blues nella
sua nuova veste urbana, Tampa Red, il
“guitar wizard” degli anni Venti e
Trenta, c’era il jump blues, ma i nuovi
arrivati dal sud volevano altro, chiedevano qualcosa di più emotivo, forte,
realistico. In pratica le qualità che
Muddy Waters portò con sé dal Mississippi. Il suo arrivo in città, narra la leggenda, cambiò il volto del blues.
Muddy scelse di elettrificare il suo
strumento e di avere con sé una vera e
propria band. Con lui c’erano Jimmy
Rogers, eccellente seconda chitarra,
Otis Spann, al pianoforte e, soprattutto, Little Walter all’armonica, un autentico genio del suo strumento, il primo a rendere il suono dell’armonica
non solo elettrico ma anche distorto,
rauco, di alta intensità emotiva.
Fu una piccola rivoluzione, l’inizio
di una prorompente rinascita del genere. Waters iniziò a incidere dischi
per la Chess Records, scalando rapidamente le classifiche e allargando il
consenso del pubblico ai suoi concerti. Waters cantava poco, si limitava a
borbottare qualche strofa, mettendo
l’accento sul ritmo irregolare e spesso
frenetico della musica, portando in
primo piano la chitarra, con uno stile
che avrebbe influenzato non solo una
infinita schiera di bluesman ma anche, più tardi, molti artisti rock.
L’epicentro di questa esplosione era
Maxwell Street, con il suo mercato,
una sorta di palcoscenico all’aperto
per chiunque volesse suonare, conquistare un pubblico, affermare la
propria musica. Per Maxwell Street,
nel cuore di Jewtown, sono passati i
grandi del blues di Chicago, ma chiunque poteva arrivare, da solo o con il suo
gruppo, e cercare di raccogliere qualche soldo con la musica. I musicisti
che arrivavano dal Sud in cerca di fortuna andavano lì e suonavano in strada per farsi ascoltare, per ascoltare gli
altri, per sopravvivere e per condividere la loro musica con chiunque volesse farlo, in una specie di laboratorio a
cielo aperto che rinverdiva la potenza
della dinamica tipica della dimensione collettiva della musica folk.
Oggi Maxwell Street non c’è più,
anche se il suo vecchio mercato e parte della sua musica vivono ancora in
Canal Street. Non ci sono più gli angoli diventati famosi nel film Blues
Brothers, non c’è neanche il Nate’s
Deli, il piccolo ristorante dove Aretha
Franklin cantava Think. Ma lo spirito
del blues vive ancora, soprattutto nei
club della Chicago notturna, al
B.L.U.E.S, uno dei locali più rinomati
e attivi, al Buddy Guy’s Legend, il club
gestito da una delle leggende del
blues di Chicago, Buddy Guy appunto. O il Chicago Blue, di una delle più
grandi star femminili, Koko Taylor. O
ancora alla House Of Blues, nata proprio sulla scia dell’avventura dei
Blues Brothers, dove ancora, ogni anno, Dan Aykroyd torna ad esibirsi. Da
poco si è concluso il Chicago Blues Festival, che ha animato le notti del
Grant Park. Tra breve, a settembre, la
musica afroamericana occuperà la
scena con uno dei più grandi festival
degli Stati Uniti. E Chicago tornerà ad
essere, ancora una volta, la capitale
del blues, la città dove il diavolo ha
deciso che la sua musica doveva diventare elettrica.
LE RADICI
Nella foto
qui sopra,
uno scatto
d’epoca
della raccolta
del cotone
nelle piantagioni
degli Stati Uniti. È
proprio nei campi
del Sud che,
nella seconda metà
dell’Ottocento,
è nata la musica
Blues
B. B. KING
Blues Boy King, forse il più grande
interprete Blues vivente. Negli anni
’50 diventa il principale esponente
del panorama R&B
ERIC CLAPTON
Il più grande musicista bianco
della tradizione Blues-Rock.
Alla fine degli anni ’60 porta
in Inghilterra il sound di Chicago
BUDDY GUY
Animale da palco (a cui Jimi
Hendrix ha detto di essersi ispirato),
attivo fin dagli anni ’50, ha guidato
negli anni ’70 la rinascita del Blues
ROBERT CRAY
Forse il più famoso Bluesman
moderno. Grande sperimentatore,
unisce la tradizione Blues
con le ultime tendenze cross-over
uddy era a piedi nudi quando seppe che un uomo bianco lo stava
cercando. Era domenica, l’ultimo
giorno di agosto, 1941. Il cotone era fiorito e
pronto, il raccolto sarebbe stato concluso in un
mese. Muddy, come ogni altro nero che coltivava un pezzo di terra di qualcun altro, stava
assaporando il suo riposo. Tra poco avrebbe
raccolto cotone dall’alba al tramonto. La voce
raggiunse Muddy prima dell’uomo bianco.
“Ecco, è fatta”, pensò Muddy, “hanno scoperto che vendo whiskey”. Ma l’uomo bianco non
era la legge o un agente delle tasse. Era un tipo
giovane di nome Alan Lomax e le sue registrazioni di Muddy, le prime che furono mai realizzate, lanciarono la carriera di McKinley A.
Morganfield, ovvero Muddy Waters, spingendolo dalla sua vita di contadino a quella di leggenda del blues».
Comincia così, quasi per caso, per un colpo
della fortuna, per un incontro che forse non poteva non avvenire, l’avventura musicale di uno
dei più grandi bluesman mai esistiti, Muddy
Waters, “acque fangose”. Un’avventura che
viene raccontata in maniera magistrale da Robert Gordon, eccellente studioso e critico musicale americano, in Hoochie Coochie Man, la
vita e i tempi di Muddy Waters, pubblicato in
queste settimane da Arcana. Quella scritta da
Gordon non è soltanto una biografia ma una
sorta di grande libro di storia afroamericana.
Gordon ripercorre, con dovizia di particolari, i
primi trent’anni di vita di Waters, quando era
solo un povero contadino nero nel profondo
Sud degli Stati Uniti, raccontando una storia
che è stata comune a centinaia di migliaia di neri americani. McKinley A. Morganfield non era
diverso da tutti gli altri, lavorava la terra, pensava di poter meritare un futuro migliore, soffriva e amava. Era nato il 4 aprile del 1913, figlio
di due ragazzini, Berta Grant e Ollie Morganfield. Berta morì pochi anni dopo la sua nascita
e fu sua madre a tirare su quel ragazzo nella
piantagione di Stovall, a nord di Clarksdale, nel
Mississippi, e a soprannominarlo “Muddy”.
Il ragazzo crebbe nei confini della piantagione, povero, affamato, ma con il cuore straordinariamente pieno di musica. Ascoltava le voci e
le urla di Son House e Big Joe Williams, sognava sulle note di Blind Lemon Jefferson e Robert
Johnson, raccoglieva cotone cantando e iniziò
a suonare la chitarra durante le feste alla piantagione: «I raccoglitori di cotone — scrive Gordon — festeggiavano nei weekend perché erano sopravvissuti un’altra settimana, perché la
terra non li aveva inghiottiti, perché il fiume
non li aveva portati via, perché il padrone non
li aveva uccisi». Fu così che Muddy iniziò a guadagnare qualche cosa, suonando e cantando
quando le pause del lavoro lo consentivano, e
attorno ai vent’anni era già celebre tra i suoi
compagni. Il denaro lo faceva anche in altri modi, non tutti legali ovviamente, ma nulla che
desse troppi grattacapi alla nonna.
Poi arrivò Lomax, con il suo registratore, dicendo che voleva registrare la sua musica per la
Libreria del Congresso. Muddy cantò e suonò
una dozzina di brani, poi Lomax glieli fece riascoltare: «Hey, non puoi capire cosa provai quel
pomeriggio quando ascoltai la mia voce. Pensai: io posso cantare». Lomax qualche tempo
dopo spedì a Waters venti dollari e due copie del
disco, Muddy le prese e corse al locale più vicino. «Portai il disco al caffè all’angolo e lo misi
nel jukebox. Lo suonai, e lo suonai e lo suonai e
dissi: posso farlo, io posso farlo».
E lo fece, davvero. Prese la sua chitarra e partì
per il Nord, lasciandosi alle spalle la piantagione, il cotone, il dolore e i sogni. Raggiunse Chicago e cambiò le regole della musica blues. Andava nei club e nessuno lo ascoltava, tutti
chiacchieravano, facevano rumore con bicchieri e bottiglie, lui era solo un sottofondo a cui
nessuno dava retta. E allora pensò che aveva bisogno di un microfono e che la chitarra andava
amplificata, perché il suo suono potesse superare le chiacchiere della gente. E che il blues
non era roba triste da suonare da soli, che ci voleva una band per avere il giusto “groove”. Alla
chitarra arrivò Jimmie Rodgers, al pianoforte
Otis Spann, all’armonica Little Walter Horton.
Iniziarono a suonare e il blues cambiò volto.
I fratelli Chess, che nel cuore del South Side
gestivano la più importante casa discografica
di Chicago, portarono Muddy e i suoi in studio
e nel 1948 la band incise Can’t Be Satisfied, poi
Hoochie Coochie Man, quindi Rolling Stone e
decine di altri hit. Nel volgere di due anni Waters era diventato una star e una nuova generazione di musicisti aveva seguito il suo esempio.
Fino al 1983, quando morì per un cancro ai polmoni, Waters ebbe numerosi successi, divenne
un idolo per i giovani rockers inglesi, Keith Richards ed Eric Clapton su tutti, suonò in tutto il
mondo, vinse premi Grammy, ma non imparò
mai a leggere e a scrivere e non dimenticò mai i
suoi giorni nella piantagione, le sue fatiche, le
sofferenze e le gioie di una vita in cui il blues
non era solo musica: «Era la vita, la prova che
ero vivo».
(e.a.)
40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
i sapori
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
Degustazioni e mille sorsi d’autore con “Calici di stelle”:
mercoledì 10 agosto in 150 comuni i bianchi, i rossi
freddi e i nuovi rosati italiani saranno pronti
a sprigionare i loro profumi sotto il cielo notturno
E, ad accompagnare le bottiglie culto delle cantine migliori,
ecco i piatti irrinunciabili di questo caldissimo agosto
Saper bere
Ogni brindisi è un desiderio
LICIA GRANELLO
N
aso in aria e bicchiere in mano. Potete immaginare una notte così? Anche
se gli astronomi ogni anno anticipano la data ideale per osservare le stelle
cadenti, la tradizione ci lega indissolubilmente al 10 agosto, ricorrenza nata a memoria del martirio di San Lorenzo nel terzo secolo. Le sue lacrime
trasformate in stelle sono, secondo la scienza, la visualizzazione del passaggio nell’orbita terrestre dei Perseidi, asteroidi della costellazione Perseo. Negli anni, dalla poesia del Pascoli al film dei Taviani, il sapere non ha certo sottratto fascino al giorno consacrato al santo: così, ci piace credere, che per ogni scia di luce in
picchiata nel cielo abbiamo diritto ad esprimere un desiderio.
I vignaioli di 150 comuni italiani hanno scoperto di poter ispirare al meglio i nostri pensieri più reconditi. L’evento, “Calici di stelle”, consentirà a oltre mezzo milione di turisti
— quanti se ne sono contati nella scorsa edizione — di unire il dilettevole al dilettevole:
sorseggiare un buon vino, anche più di uno, scrutando il cielo notturno a caccia di stelle
cadenti, optando per uno degli eventi programmati nelle campagne, dove l’inquinamento luminoso è minore, verificando luoghi e appuntamenti sul sito della Città del Vino
(www. cittadelvino. it). Oppure scegliendo in base ai vini preferiti. Quasi mai gli stessi che
amiamo sorseggiare nel resto dell’anno. Perché l’estate è un faticoso banco di prova per
l’alcol in bicchiere, insopportabile fonte di calore. Bevi e sudi, come non bastasse l’afa…
La vacanza è una medicina: rivitalizzati e allegri, pieds dans l’eau nel ristorantino in riva al
mare o reduci da una vigorosa camminata nei boschi, l’idea di una buona bottiglia aperta sul
tavolo ci fa gongolare. A patto di non massacrare il piatto estivo che abbiamo ordinato.
Secondo la sommellerie ufficiale, l’abbinamento cibovino deve obbedire a due comandamenti: contrapposizione di sensazioni e concordanza di aromi e struttura. Detto
Vini
d’estate
così, sembra complicatissimo: in realtà basta affidarsi alla memoria del palato, che seleziona naturalmente le armonie: niente vini troppo tannici (colore intenso, gusto astringente), o di acidità assoluta, i più discordanti con la gamma di sapori che caratterizza la gastronomia dei mesi caldi.
Se poi non vi fidate del vostro personale archivio del gusto, tentate la sorte alcolica con
qualche accortezza. Non fatevi fuoriviare dalle diatribe sul colore, superate insieme a uno
degli ultimi tabù enologici: quello sul vino rosso freddo. Scettici? Sceglietene uno di struttura contenuta, poco concentrato, evitando uve enorigide come il Nebbiolo — un Chianti non giovanissimo, ad esempio — per evitare che, una volta raffreddato, il gusto esca “indurito” e astringente. Servitelo a 12-14 gradi: sarà perfetto sulle pietanze con base pomodoro — zuppe, guazzetti — e con le grigliate di carne. Oppure, lasciatevi sedurre da uno
degli eccellenti rosa arrivati sul mercato negli ultimissimi anni, dopo un lungo oblio segnato da produzioni trasandate e raccogliticce: rinascita
che ha indotto il Gambero Rosso a editare, autore Massimo Di Cintio, una guida monodedicata, uscita nei giorni scorsi con oltre 300 etichette recensite. Un rosato di
qualità vi seguirà dall’aperitivo alla vigilia del dessert
senza tradirvi, sfoderando la freschezza di un bianco
e la morbidezza di un rosso.
Se invece per voi estate fa rima (alcolica) con vino
bianco, avete solo l’imbarazzo della scelta, dalle
bottiglie più beverine ai bicchieri barricati con eleganza che fanno invidia a molti rossi: regalatevi una
fresca sorsata, spiluccando una tartare di tonno e
dimenticate la fine delle ferie.
560 milioni
Le bottiglie di vino rosso
comprate lo scorso anno
gli abbinamenti
Ecco gli abbinamenti piatti-vini consigliati
da Maida Mercuri una delle migliori sommelier
italiane, tra le fondatrici de “Le Donne del vino”
Gestisce l’enoteca “Pont de Ferr” a Milano
Repubblica Nazionale 40 07/08/2005
Frittura di pesce
Vigna’ngema
2003
Capichera
Il classico fritto marino
ha bisogno di essere
supportato nella sua
sapidità, senza trascurar
la freschezza finale
Qui trova la sua collocazione
ottimale il Vermentino
di Gallura
Prosciutto e melone
Vogelmeier
2004
Lageder
Schulthauser
2004
S. Michael
Eppan
Abbinamento complicato
dal melone, che va mangiato
in piccole dosi rispetto
al prosciutto,
per non coprirlo. Perfetto
il Moscato giallo vinificato
secco, morbido
Caprese
Grigliata di carne
Il suo vino è un Pinot bianco,
strutturato e di acidità
misurata. Se il pomodoro
è maturo e la mozzarella
di bufala vera, il fondo di pera
matura del vino si accorda
armonizzando
il contrasto dolce-acido
Un piatto da rosso, ma da
scegliere bene, perché i
tannini raffreddati possono
provocare una sensazione
di astringenza in bocca. Un
uvaggio come SangioveseSirah è ottimo a temperatura
ambiente come a 12°
Cancelli
2003
Coltibuono
Spaghetti
con le vongole
Trebbiano
d’Abruzzo
Valentini
Il sugo bianco non inganni:
la vongola è un frutto di mare
dal gusto intenso,
che disdegna i vini facili
Il Trebbiano abruzzese
è strutturato e mantiene
la freschezza
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41
Garlenda (Sv)
itinerari
Marco Pallanti
è enologocoproprietario
di una
delle aziende
più raffinate
nella produzione
del Chianti Classico,
“Castello di Ama”, dove
ogni anno ospita con la
moglie Lorenza un artista
internazionale per
realizzare un’opera d’arte
ispirata al Chiantishire
Castellina in Chianti (Si)
Contessa Entellina (Pa)
Nell’immediato
entroterra savonese,
tra Alassio e Albenga,
ospita un campo
di golf tra i più belli
d’Italia. Mercoledì
sera, dalle 21,
nel castello Marchesi
Del Carretto,
concerto lirico e degustazione di vini e prodotti tipici
Info: 0182 580056
Comune vocato
per la produzione
del Chianti Classico,
nel cuore di una
campagna tra le più
amate del mondo,
organizza
“Degustellando
sotto il cielo
della Castellina”, con degustazioni di vini, prodotti
tipici e musici itineranti Info: 0577-741392
Nella campagna
di questo comune
dell’alta valle del
Belice, fondato dagli
albanesi, prosperano
i vigneti di
Donnafugata, che per
San Lorenzo saranno
aperti al pubblico.
In programma anche visite delle cantine,
degustazioni, musica. Info: 800 252321
DOVE DORMIRE
DOVE DORMIRE
DOVE DORMIRE
IL CAMPANILE B&B
Piazza Annunziata 2 , Albenga
Tel. 0182-21823
Camera doppia da 70 euro, colazione inclusa
PODERE TERRENO
Via alla Volpaia, Radda in Chianti
Tel. 0577-738312
Camera doppia da 150 euro, colazione inclusa
BAGLIO S. VINCENZO
Contrada S. Vincenzo, Menfi (Agrigento)
Tel. 0925-75065
Camera doppia da 102 euro, colazione inclusa
DOVE MANGIARE
DOVE MANGIARE
DOVE MANGIARE
ANTICO BORGO
Località Ciccioni Ovest, Stellanello
Tel. 0182-668051
Chiuso lunedì, menù da 25 euro
ANTICA TRATTORIA LA TORRE
Piazza Umberto Primo 17
Tel. 0577-740236
Chiuso venerdì, menù da 25 euro
LIDO RISTORANTE LA PINETA
Marinella di Selinunte (Trapani)
Tel. 0924-46820
Senza chiusura estiva, menù da 35 euro
DOVE COMPRARE
DOVE COMPRARE
DOVE COMPRARE
AZIENDA AGRARIA ANFOSSI
Via Paccini 39
Tel. 0182-20024
Bastia di Albenga
ENOTECA LE VOLTE
Via Ferruccio 12
Tel. 0577-741314
Castellina in Chianti
CAPRICCI DIVINI
Via Inico 148/a
Tel. 0925-75033
Menfi (Agrigento)
Frittata
370 milioni
Le bottiglie di vino bianco
comprate lo scorso anno
70 milioni
Piere
Sauvignon
Vie
di Romans
Piatto dove coesistono sapori
molto diversi
Il Sauvignon li esalta tutti:
la mineralità e i sentori erbacei
si sposano con le verdure,
mentre l’acidità ripulisce
la bocca dal gusto forte
dell’uovo e dall’untuosità
Le bottiglie di vino rosè
comprate lo scorso anno
Pizza
Rosato
2003
Castello
di Ama
Il piatto della tradizione
con un vino che si richiama
alla tradizione. Il rosè da uva
Sangiovese in purezza
significa corposità, intensità,
morbidezza. Proprio come
i migliori vini rosati
di un tempo
Perfetto per carne, pesci e perfino per la frutta, va servito fresco
La rinascita del vecchio rosè
ultimo figlio della tecnica
ENZO VIZZARI
entornato rosato. E non sarà la moda di un’ecedere alla vinificazione e l’altro, più diffuso e pratistate, propiziata dalla naturale tendenza stacato, della spremitura diretta più o meno intensa delgionale a privilegiare i vini freschi, beverini, imle uve nere, che permette di estrarre dalle bucce la
mediati. È piuttosto un ulteriore segnale dell’evoluquantità di colore voluta. I passaggi successivi sono gli
zione del gusto del “consumatore medio” e di chi inistessi in uso per i vini bianchi. Viceversa è proibito in
zia ad avvicinarsi al vino: si cercano e sono apprezzaItalia come in Francia fare un rosato mescolando viti vini non impegnativi, facili da degustare e da capire,
no rosso e bianco (tranne che nella Champagne, dodi costo contenuto. E, come appunto i rosati, versative quasi tutti i rosé sono ottenuti par mélange; con rali nell’accompagnarsi ai cibi, capaci di sposare salure eccezioni: come il meraviglioso Krug Rosé).
mi, pesci e carni bianche, paste e verdure, dall’aperiMa esistono e quali sono i rosati “buoni, veri e seri?”
tivo sino ai dessert a base di frutta. Bevuto a temperaSì, più numerosi di quanto si creda, benché poco cotura di cantina o ben fresco (mai gelato), il rosato —
nosciuti e diffusi, ma oggi alla riscossa. In Francia, doquello serio, quello buono — è per antonomasia il vive l’eclisse del rosé è stata meno accentuata che da
no delle vacanze al sole ma non è affatto un vino minoi, sono numerosissime le zone e le tipologie di rosé
nore, ha piena dignità, ha radici lontane, ha un posto
prodotti sia con vitigni nobili e internazionali sia con
nella storia del vino.
vitigni autoctoni: dai pinot neri della Bourgogne ai caLa sua origine risale al XV secolo, nel
bernet franc e sauvignon del Bordolese, dai grenache
Bordolese: claret era il rosé di una
e cinsault del Tavel, il più famoso rosé di Francia, nelnotte, racconta lo storico della
le Côtes du Rhônes, sino al Sud-Est dove con il
vigna Hugh Johnson, fatto lamourvèdre e altri vitigni autoctoni si produce il classciando l’uva spremuta sulle
sico Bandol e, pure con vitigni locali, il provenzale Belsue bucce non più di ventilet. In Italia, da sempre, i migliori rosati fermi vengoquatt’ore, giusto per avviano dal Sud, dai terreni siccitosi ma esposti alle brezze
re la fermentazione che
marine di Puglia, d’Abruzzo e delle isole: il Montepulsarebbe continuata poi
ciano d’Abruzzo Cerasuolo, su tutti quello dell’impanella botte. L’affinamenreggiabile maestro Edoardo Valentini; i negroamaro
to delle tecniche di lavorapiù malvasia nera, come il Vigna Mazzì di Rosa del
zione ha codificato vari
Golfo e il Five Roses di Leone de Castris; il nerello maprocedimenti per produrscalese più nero d’Avola come il Rose di Regaleali; il
re il rosato, ma i più imporNieddera del sardo Attilio Contini; il delizioso Rogito
tanti sono due: quello detto
delle Cantine del Notaio cento per cento aglianico del
par saigné, ormai meno utilizVulture; meno significativi i toscani, fra i quali tuttavia
zato, nel quale si lasciano le bucbrilla per modernità e fragranza il Rosato del Castello
ce delle uve in macerazione a condi Ama; ottimi ma consumati quasi in toto localmentatto con il mosto perché gli cedano
te i Chiaretti del Garda e i Lagrein Kretzer altoatesini.
colore sino al momento in cui sia raggiunta
Tutti, ad eccezione del Cerasuolo, costano tra gli 8 e i
l’intensità desiderata, per poi separare le bucce e pro15 euro. Eccoli, i vini dell’estate 2006.
B
Grecanico
Mandrarossa
2004
Settesoli
Vitello tonnato
Insalata di riso
Pesce crudo
La carne è arricchita
dalla salsa che incorpora
tonno, acciughe e il gusto
forte del cappero
Il Grecanico siciliano
ha profumo, un buon corpo
e l’acidità necessaria
a sgrassare la maionese
Il numero e la varietà degli
ingredienti non permettono
abbinamenti vaghi. L’Arneis
è un’uva a suo modo rigida,
che si mantiene distinta
ma risulta neutra, un po’
come il riso. Contenuta
l’aromaticità
Lo Chablis è il vino ad hoc
del plateau francese In Italia
l’uva Chardonnay trova
interpreti egregi
La fermentazione in legno
sviluppa morbidezza,
struttura, tannini dolci, che
esaltano tartare e frutti di mare
Roero Arneis
2003
Prunotto
Linticlarus
Tiefenbrunner
42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
le tendenze
Contestatrice, poetica, minimalista, celebrativa o no global,
la maglietta compie 85 anni e continua a regalarci sorprendenti
variazioni sul tema. Ai classici scolli a giro, a barchetta o a V
aggiunge stravaganze cromatiche, applicazioni,
ricami raffinati e griffe pregiate. E come un foglio bianco
porta per le strade del mondo i variegati messaggi dei nostri tempi
Moda unisex
VARIANTE LUNGA
Variante a manica lunga
del modello classico,
prodotta da Mason’s
UN AMORE
SOLIDALE
Del designer
Gaetano Gentile,
la t-shirt Hub
(amore in arabo)
è un segno
di solidarietà
I proventi vanno
in beneficenza
In vendita
alla Triennale
di Milano
T-shirt
Un mito di cotone
tra slogan e disegni
LOOK ESSENZIALE
FOTO CONTRASTO
Repubblica Nazionale 42 07/08/2005
Scritta nera
su fondo bianco
Ha un carattere
essenziale e non teme
alcun confronto con la
tradizione. Di Woolrich
OMAGGIO
ALLA CALIFORNIA
Auto di grossa
cilindrata, palme,
tramonti dorati: così
Gas rende omaggio
alla California
con una t-shirt
SPORTIVA
AL FEMMINILE
Rosa confetto
e bordi fucsia. Perfetta
per lo sport ma anche
sulla gonna. Proposta
da Wrangler
LAURA ASNAGHI
R
occhettara, contestatrice, poetica, minimalista. E ancora: provocatoria, benefica, buonista, no-global,
cafona, celebrativa, glamourous. Sono i tanti volti
della t-shirt, la maglietta di cotone che compie 85 anni ma sembra proprio non dimostrarli. Anzi. È l’indumento più amato dai giovani. È trasversale (per
censo, età e cultura) ed è presente in ogni guardaroba.
La versione basic della t-shirt, vale a dire quella girocollo, con
manica corta, rappresenta un punto di forza della Benetton. Bianca o coloratissima, può essere indossata sia per fare sport che per
sostenere l’esame di maturità. Va bene in chiesa come allo stadio.
Può essere casta o super-sexy. Oversize o fasciante come una guaina. E, come insegna Giorgio Armani, grande fan della maglietta,
può essere nobilitata anche sotto una giacca classica. «La t-shirt,
essenziale e pura, rappresenta l’abc della moda — spiega lo stilista — io ho una vera passione per queste magliette, ne ho tante,
tutte tenute con la massima cura. Hanno un sex appeal inconfondibile, senza mai essere sfiorate da accenni volgari».
La t-shirt piace e le sue evoluzioni sono infinite. Sì, perché è quasi paragonabile a un foglio bianco sul quale ognuno può «raccontare, denunciare, scrivere quel che vuole». E il bello delle magliette è che, nel loro piccolo, documentano amori, passioni, pagine di storia, eventi musicali, mode. La riprova? Le magliette con le immagini di Bob Marley o
Jimi Hendrix, i Beatles o i Rolling Stones, sono ormai dei classici per i
giovani che amano la musica rock (e non solo). Per gli appassionati di
poesia o testi letterari, quelle prodotte da «Parole di cotone» restano dei
cult. La maglia con il volto di Che Guevara va a ruba tra i giovani impegnati, quella con il simbolo «fate l’amore non la guerra» è la bandiera
dei pacifisti. Il fiocco rosso, che simboleggia la battaglia contro l’Aids,
accomuna un pubblico vastissimo. Insomma, le t-shirt a tema, dedicate, da mostra o da denuncia ormai non si contano più. Ci sono quelle aziendali, di squadra, di quartiere, quelle che vengono vendute negli
shop dei grandi musei del mondo, quelle turistiche (stile «I love New
York»), quelle con le frasi celebri e adesso anche quella con la stampa di
quattro articoli della Costituzione prodotta dalla casa editrice Sellerio
(«per ricordare in questi tempi bui i valori su cui si basa la nostra convivenza sociale»), fino ad arrivare a quelle personalizzate, con la foto del
bebè, della fidanzata di turno o del cane di famiglia.
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
1920
L’esercito Usa adotta
la t-shirt per la divisa
Nasce la “Fruit of the loom”
LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43
1970
MARGHERITA SULLA PELLE
Segno inconfondibile delle t-shirt
prodotte da Guru, la margherita
stilizzata fiorisce, stavolta,
su un campo verde smeraldo
Per non passare inosservati
Fiorucci inventa il suo logo
e dà il via alla produzione
delle prime t-shirt Italiane
SEX SYMBOL
Marlon Brando con la t-shirt
nel film “Un tram che si chiama
desiderio” del 1951
Lo stilista Elio Fiorucci
Ai miei angeli
ho affidato
la spiritualità
ELIO FIORUCCI
N
ENERGIA
SOLARE
Ha il marchio
Peuterey
(Geospirit)
la maglietta
arancio-solare
con i profili
più scuri
EFFETTO SHOCK
Effetto esplosivo
per la t-shirt Diesel
in versione estivissima
SOS BAMBINI
Repubblica Nazionale 43 07/08/2005
Prodotta
in un orfanotrofio
sudamericano la t-shirt
Misericordia ha il colore
brillante del cielo
La t-shirt può avere tirature limitate o produzioni industrial-massificate con prezzi che variano tra i 50 e gli 80 euro, ma spesso sconfinano oltre la soglia dei 100 con all’aggiunta di paillette e decori o l’imprimatur delle griffe. Non c’è stilista che non ne abbia disegnate una
decina. Calvin Klein le ha rese sexy, Armani, ma anche Donatella Versace, hanno proposto quelle con i loro volti stilizzati. Iceberg è famoso per le sue magliette «pop-art», Antonio Marras ha, di recente, lanciato quella dedicata a Pasolini, Coveri ha reso omaggio a James Dean,
Rocco Barocco ha esaltato gli «italian boys» con l’immagine del David di Michelangelo. Prada ha coinvolto alcuni giovani artisti per creare t-shirt d’autore. Dolce e Gabbana, copiatissimi, continuano a produrre magliette fashion che imperversano nelle discoteche. Insieme
a quelle Diesel, Pirelli (con il pugno chiuso su fondo nero), Cp Company, Sweet Years, Just Cavalli, Gas, Guru (riconoscibili per la celebre
margherita), Miss Sixty (molto fantasiose), Pinko e Simbols. Sempre
sulla cresta dell’onda le idee-cotone di Custo Barcelona, quelle di Blugirl o di Gaetano Navarra, ricamate a oltranza e invecchiate ad arte
con lavaggi speciali in acqua e terra.
E pensare che ottantacinque anni fa tutto cominciò con il candore della storica «Fruit of the loom» creata solo per l’addestramento dei soldati.
PROVE D’ARTISTA
Firmata dall’artista francese Mambo
e prodotta da Prada, questa t-shirt
è la prima espressione del progetto
creativo “Unspoken dialogue”
LOGO
IN VISTA
Ha il logo
di Calvin Klein
la t-shirt
grigio pallido
in cotone
che esalta
la tintarella
egli anni Sessanta e Settanta il desiderio diffuso di
spiritualità portava le persone a pensare a rivoluzioni che
avrebbero cambiato i valori del
mondo. C’era chi intraprendeva
viaggi in India per poi vivere negli ashram sulle orme dei poeti
della beat-generation e chi optava per soluzioni più rivoluzionarie, radicali e a volte pericolose.
Io ho scelto di lavorare a Milano,
portando nella moda quella rivoluzione dello spirito che era così
forte nella gente.
Le t-shirt mi apparvero subito
come un possibile e bellissimo
manifesto che, con tenere immagini, poteva diventare la scrittura
dei nostri valori. Nasceva così l’idea di un simbolo che accomunasse tutta l’umanità. Due angeli,
per l’esattezza uno biondo e uno
moro, con una stellina in fronte e
occhi dolci rivolti al cielo, trasgredendo l’immaginario che li voleva
immancabilmente tutti biondi.
Questo loro aspetto, che da una
parte ricordava gli angeli vittoriani o i putti barocchi, mentre dall’altra li rendeva familiari come
fossero visi di bimbi, suscitò subito un enorme successo; sembrava
che tutti li aspettassero e li riconoscessero come se ognuno li
avesse nel
proprio inconscio.
Le magliette incominciarono
a diffondersi come un
vero e proprio fenomeno di costume, rappresentando un mess a g g i o d i STILE VITTORIANO
spiritualità Stile decisamente
e di compli- vittoriano e aria
cità nella ri- vagamente retrò:
c e r c a d e l le t-shirt prodotte
nel 1969 da Elio
bene.
Lo stesso Fiorucci (nella foto)
successo si fecero furore in Italia
è verificato
in seguito, riprendendo altre immagini, come quelle realizzate da
Saint-Exupéry per il Piccolo Principe, un libro della spiritualità
che, dopo la Bibbia è il più venduto al mondo.
La grande intuizione è quella
quindi di individuare sempre
quei bisogni dello spirito della
gente, traducendoli in una maglietta-messaggio, creando così
una rivoluzione pacifica legata
all’amore e a una profonda esperienza di semplicità.
L’importante è aver saputo cogliere nell’arco di quasi quarant’anni i bisogni dello spirito
entrando nel cuore di ogni persona, andando quindi oltre la moda;
perché, riprendendo una frase del
Piccolo Principe «l’essenziale è invisibile agli occhi ma è visibile al
nostro cuore».
La storia delle t-shirts nasce negli anni Settanta quando la rivoluzione della moda permette di
utilizzare un capo “underwear”,
esibendolo all’esterno con l’emozione sensuale che ne derivava. Era l’epoca della minigonna e
in America nascevano i concorsi
della t-shirt bagnata dove si eleggeva la ragazza più sexy; tra un
misto di moda e modi che rappresentava un evidente segno della
rivoluzione del costume. Il corpo
non era più colpevole, le donne se
ne riappropriarono regalandoci
quello che per tanto tempo era
forzatamente rimasto nascosto. I
messaggi fatti di immagini, fotografie e frasi fiorirono sul seno
delle donne, luogo sacro ai poppanti. E a noi uomini.
44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA
DOMENICA 7 AGOSTO 2005
l’incontro
Trasformazioni
Ballerino acclamato in tutto il mondo,
attore a sorpresa in un serial tv
scanzonato come “Sex and the city”,
adesso fotografo raffinato in mostra
al “Tuscan Sun Festival” di Cortona.
L’artista fuggito
in occidente dall’Urss
continua a reinventarsi
e a rimettersi in gioco.E
spiega la scelta del bianco
e nero, perché in bianco
e nero è stampata tutta
la sua vita: “Riga, la città
dove sono cresciuto, è un paesaggio di
grigi. E anche il clima politico di quegli
anni Cinquanta era privo di colore”
Mikhail Baryshnikov
l dito sul pulsante. Clic, uno
scatto. Su un bambino che è appena caduto di bicicletta imparando a stare in equilibrio. Sull’ombra di uno skater che danza lungo
un palazzo di pietra in Rue du Bac, a
Parigi. Su un piatto di limoni. Su un
piede. Uno scatto. Sulla vita, su tutto
quello che capita davanti ai suoi occhi
azzurro trasparente. Velati, ogni tanto, dallo spaesamento, dal senso del
provvisorio che appartiene agli esuli.
Per Mikhail Baryshnikov la macchina
fotografica è una parte del corpo, un
automatismo fisico. Come i muscoli
delle gambe che lo fanno ancora volare, piccolo e immenso, sui palcoscenici del mondo. È l’aria che respira. Ossigeno, danza e pellicole, l’odore acre
della camera oscura, del sudore che
bagna la pelle dopo uno spettacolo indimenticabile.
Baryshnikov uno, due, tre. Uno: il
ballerino. Due: l’attore, prima schivo e
timido davanti alla macchina da presa, poi così sicuro di sé da farsi scritturare nello scanzonato e irriverente Sex
and the city. Tre: il fotografo, che ha
iniziato a scattare bianchi e neri parecchi anni fa ma solo oggi arriva a
metterli in mostra. «Un amico di San
Pietroburgo, Leonid Lubianitsky, un
giorno mi ha messo una macchina in
mano. Io stavo partendo per un tour:
Giappone, Taiwan. Lui mi ha detto:
dai, scatta. Punta l’obbiettivo su qualunque cosa ti ispiri. Fotografala. Poi
portami indietro i rullini. L’ho fatto.
Mi è piaciuto». Già, tutto qui. Come alla fine di un assolo da lacrime agli occhi. La gente in delirio sotto il palco, e
movimenti che vedo intorno a me.
Nelle mie braccia, nelle mie gambe,
nei miei piedi c’è come una banca dati dove conservo due mani che fendono l’aria mosse da un barbone sul metrò o le braccia conserte di una donna
in chiesa. Quando danzo, tiro fuori da
questo computer di carne e sangue
tutti i gesti memorizzati nel corso degli anni, e li trasformo in arte. Lo stesso faccio con le fotografie: i miei scatti sono la memoria di un paesaggio
straordinario, di una persona cara, di
qualcosa che accade di assolutamente normale sotto i miei occhi, ma che
per me è grandioso. Quando realizzo
una fotografia che mi soddisfa, mi ricordo tutto del giorno in cui l’ho scattata. Un odore. Un suono. Una persona». Fotografare, dunque, secondo
Baryshnikov, è bruciare un momento
Danzare e scattare
foto sono cose legate
Io ho due memorie,
una nel cervello,
l’altra nei muscoli:
in questa memoria
del corpo
immagazzino tutti
i gesti, i movimenti,
le posture che vedo
attorno a me
FOTO CONTRASTO
I
CORTONA
lui che ringrazia allargando le braccia.
That’s all. Semplice, no?
Sì, semplice. Per lui tutto sembra esserlo. Forse perché il passato non lo è
stato: la madre, morta suicida, che gli
insegnò la bellezza del teatro; il padre,
militare, per il quale un sipario rosso
che si apriva e si chiudeva era solo una
perdita di tempo. L’arte come salvezza. L’asilo politico chiesto durante un
tour in Canada, nel 1974. Il passaporto americano. Le mille attività cominciate e lasciate lì, come le tante storie
d’amore iniziate e finite in questi intensissimi, stropicciati 57 anni di vita.
Alla rinfusa: i baci appassionati e una
figlia dall’attrice Jessica Lange, l’attività di manager di una linea di abbigliamento sportivo con la sua griffe,
una Dance foundation che dall’autunno accoglierà non solo danzatori
ma scrittori, artisti, compositori, artisti trasversali come lui. «Le proposte ti
arrivano quando meno te lo aspetti e
questa dannata, inquieta curiosità
che ho dentro mi dice: dai, provaci,
che ti costa?».
Perché la vita è un viaggio. Soprattutto la sua, che l’ha catapultato di qua
e di là, in ogni parte del mondo. E che
oggi lo ha portato a Cortona, piccola e
splendida città medioevale a due passi da Arezzo. A Cortona c’è un festival,
il Tuscan Sun, inventato da una scrittrice americana, Frances Meyes, l’autrice di Sotto il sole della Toscana da
cui è stato tratto un film con Raoul Bova. La Meyes ora vive qui e con l’aiuto
di un suo vicino di villa, l’impresario
Barret Wissmann, organizza eventi. E
tra una star della lirica come Thomas
Hampson, o del podio come Antonio
Pappano, infila nel festival anche
qualche battesimo del fuoco: quello di
Baryshnikov, appunto, che al Monastero di Sant’Agostino fino al 21 agosto espone le sue fotografie per la prima volta in Italia. Titolo della mostra:
A Travel. Ovvero, mezzo mondo appiccicato alle pareti.
Cosa dobbiamo aspettarci? «Lavori
di uno che fotografa per hobby, un
diario sotto gli occhi di tutti», dice con
il suo inglese lento, meditato, tagliente. Ok. Però Susan Sontag ha scritto
che Baryshnikov è meraviglioso in
qualunque cosa si cimenti. È grande
quando balla, grande quando recita e
seduce Sarah Jessica Parker-Carrie
Bradshaw giornalista eternamente in
amore, grande quando fa fotografie:
«Le sue foto sono agili, calde, sagaci,
curiose, aperte al mondo».
Se tra il danzare e lo scattare immagini c’è una relazione, lo sa solo lui. E
Baryshnikov conferma. Certo che c’è,
«sta nell’occhio. Vede, io ho due memorie. Una è nel cervello, come tutti.
L’altra nei miei muscoli, nelle mie ossa. Ambedue passano dalle pupille.
Perché nella memoria del corpo io immagazzino tutti i gesti, le posture, i
di vita nella tua testa, «non è solo catturare l’immagine che hai davanti, ma
tutti quei piccolissimi istanti che vengono prima e dopo lo scatto».
Non ha maestri. Sì, ama Anne Leibowitz, Eve Arnold, Cartier Bresson.
Anche Andy Warhol, che tirava fuori la
sua macchina fotografica pettegola
nei momenti più impensabili? «No. Lo
conoscevo, ci siamo frequentati, ma
Andy era una farfalla sociale. Il commercio era il risvolto, dichiaratissimo
peraltro, della sua arte. Tutto ciò che
faceva era definito geniale. Io non ho
questo potere. Lo ripeto, sono un dilettante della fotografia. Un paparazzo legale».
Dice che i film di Polansky e Bergman hanno lasciato un segno profondo nel suo immaginario visivo. Ma nel
bianco e nero è stampata tutta la sua
vita. Anche quella prima dell’esilio:
«Riga, la città dove sono cresciuto, è
un paesaggio di grigi. Il mare, la luce,
il clima sono un intreccio di nero fumo, argento pallido, mille infinite sfumature del grigio. Il chiaroscuro delle
pietre dei palazzi bagnate dalla pioggia. In bianco e nero era anche il clima
politico di metà anni Cinquanta: dopo
il secondo conflitto mondiale, in Russia, le immagini della guerra e delle
sue conseguenze erano ovunque. Ricordo le foto scattate da Evgheni Haldei con i soldati sovietici che innalzano la bandiera sul Reichstag, quelle di
Alexander Brodsky con i carri che cercano disperatamente di rompere l’assedio di Leningrado attraversando il
Lago Ladoga ghiacciato. E poi le foto
propagandistiche che illustravano l’inarrestabile marcia della Russia verso
la ricostruzione, che mi hanno rivelato con quanta facilità un’immagine
può suscitare emozioni. Le lattaie con
i loro fazzoletti in testa che sorridono
vantandosi della superproduzione,
minatori con la faccia sporca, saldatori spettrali in mezzo alla pioggia di
scintille».
A lui basta un oggetto a portata di
mano. Basta il quotidiano dentro le
mura domestiche: «Mi piace fotografare cose banali, sguardi e gesti rubati.
I bambini, i miei figli: perché davanti
all’obbiettivo si mostrano come sono,
senza mentire. Non sanno cos’è l’inganno». Lui, quando è stato fotografato, ha mentito, ma solo un po’. Come
mentono i divi costretti a mettersi in
posa; un ballerino soprattutto, guai se
non spicca un salto mentre lo immortalano. «Amo più fotografare che essere fotografato. E una piccola rivincita
me la sono presa. Con Richard Avedon. Lui era come me. Meglio stare
dietro che davanti alla macchina fotografica. Però un giorno gli chiesi se era
disposto a posare per una foto che io
avrei scattato. Lui nicchiava, “mi hai
fotografato per trent’anni, adesso tocca a te, concediti per qualche minu-
to”, gli dissi. Accettò».
Artista nella vita, artista sul piccolo
schermo. Se gli si nomina Aleksandr
Petrovsky, lui sogghigna: «Oh my
God!». Mister Baryshnikov, l’ha fatta
grossa. Entrare nel cast di Sex and the
city, che follia. «È stata Sarah Jessica
Parker a volermi. Io non guardo mai la
televisione, non ho tempo e non mi
piace. Conoscevo questa fiction per
fama, ma non l’avevo mai vista. Sarah
è venuta da me con una borsa piena di
registrazioni. Mi ha fatto vedere alcune puntate. In un primo momento sono rimasto colpito. Tutte quei discorsi sul sesso. Poi sono andato sul set e
ho visto tanta professionalità. Così ho
detto: va bene, ci sto. E confesso che
mi sono divertito un mondo». Adesso
c’è una generazione di single in carriera che lo sogna. Che sospira davanti alla sua bellezza stazzonata, ai suoi
occhi randagi e sensuali, ai suoi modi
flessuosi e dandy.
Dicono che nella fiction televisiva
quell’artista russo di passaggio a New
York ma parigino di adozione gli somigliasse molto: una vita ricca e piena
di impegni, un tenebroso playboy milionario, un codazzo di segretarie indaffarate, portaborse, portavoce, uffici stampa. «Lo scriva per favore — e
ancora ride — lo dica che io non sono
come Petrovsky. Che io sono un’altra
persona, che io non c’entro nulla con
lui». Una crisi d’identità? «Il problema
è che il pubblico televisivo tende a
identificarti con il ruolo che ti hanno
affidato. Per questo, ad esempio, non
ho fatto vedere le mie puntate di Sex
and the city ai miei figli. Non voglio che
si facciano idee strane su di me. Quando saranno più grandi, una sera, li
metterò davanti al televisore. E dirò:
guardate, vostro padre nella sua vita
ha combinato anche questo».
‘‘
FULVIO PALOSCIA