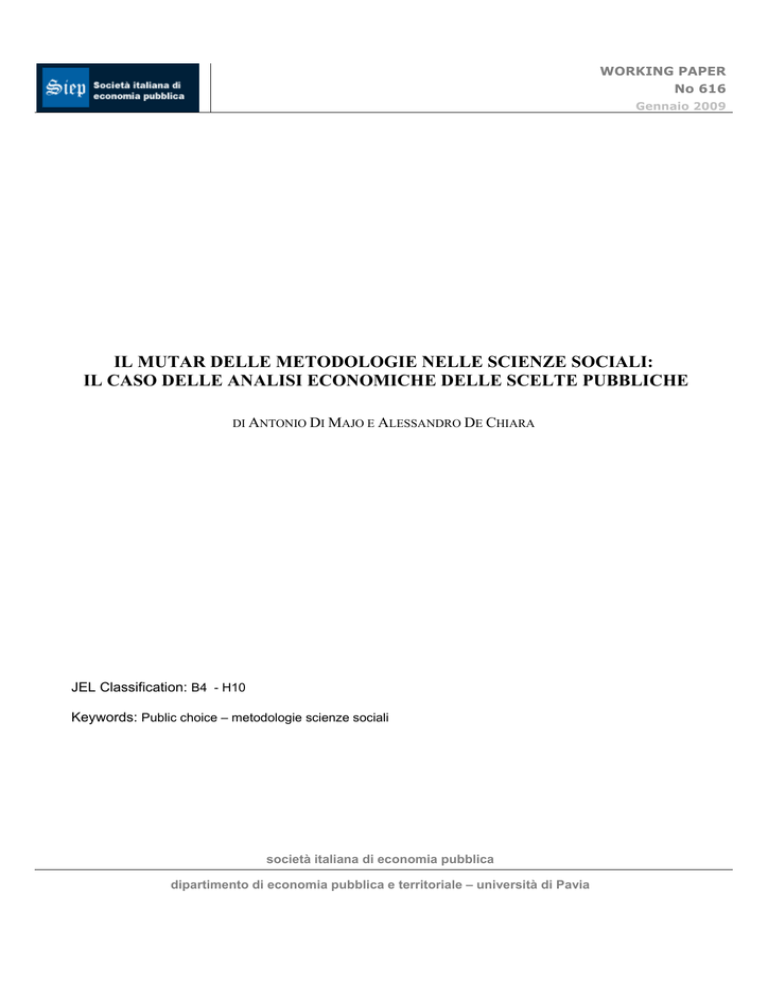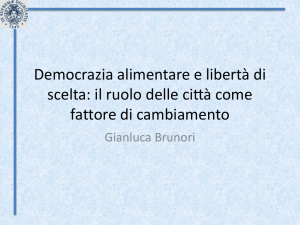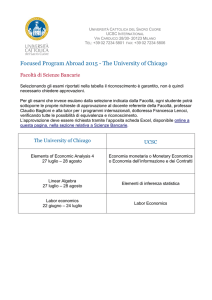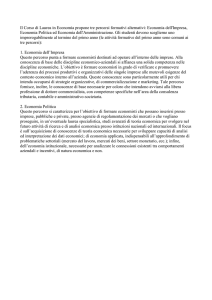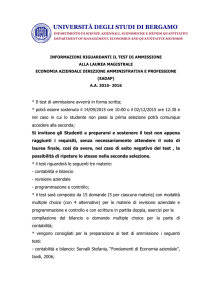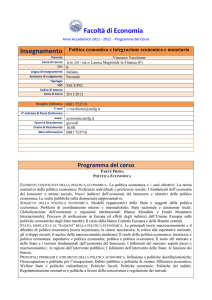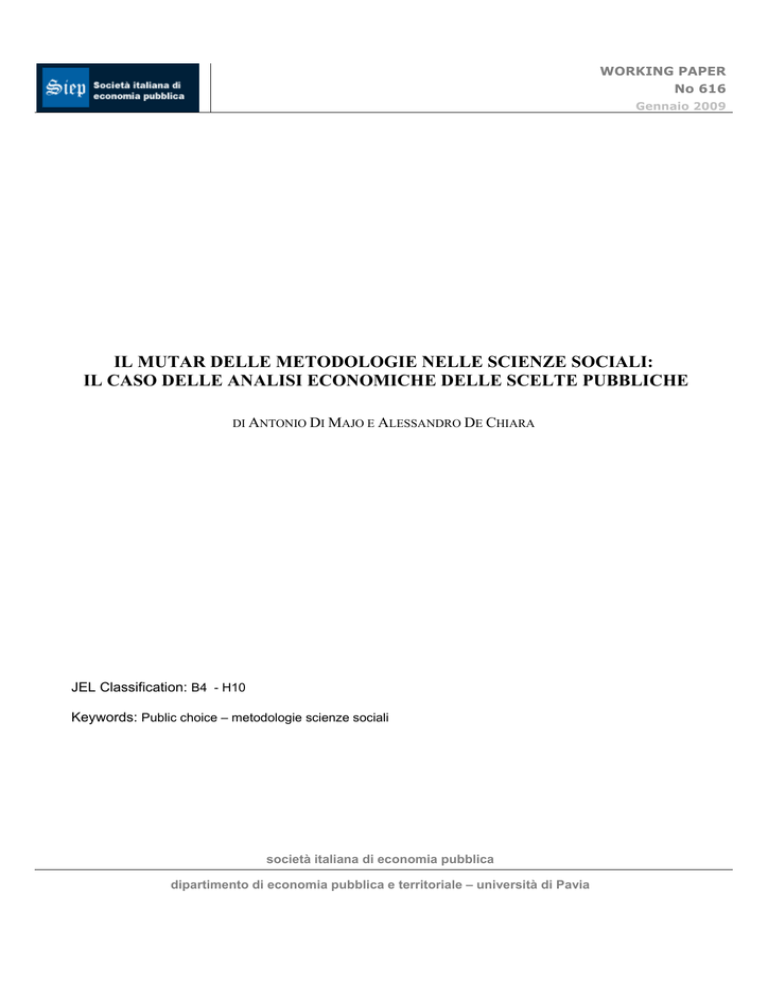
WORKING PAPER
No 616
Gennaio 2009
IL MUTAR DELLE METODOLOGIE NELLE SCIENZE SOCIALI:
IL CASO DELLE ANALISI ECONOMICHE DELLE SCELTE PUBBLICHE
DI ANTONIO DI MAJO E ALESSANDRO DE CHIARA
JEL Classification: B4 - H10
Keywords: Public choice – metodologie scienze sociali
società italiana di economia pubblica
dipartimento di economia pubblica e territoriale – università di Pavia
Il mutar delle metodologie nelle scienze sociali:
il caso delle analisi economiche delle scelte pubbliche
di Antonio Di Majo e Alessandro De Chiara
1. Introduzione.
La scienza economica nasce con l’analisi dei comportamenti degli agenti economici che operano
nei mercati. Ma, ben presto, gli economisti si chiedono se esistano e quali siano le leggi economiche
che regolano l’uso delle risorse al di fuori dei meccanismi di mercato, ossia, in assoluta prevalenza,
quello determinato attraverso scelte pubbliche. L’apparire della metodologia del marginalismo,
nella seconda metà dell’Ottocento, favorisce la crescita dell’analisi scientifica delle scelte
economiche individuali e questa metodologia, con le sue rilevanti evoluzioni, domina ancora oggi la
scienza economica. L’economia delle scelte pubbliche, quella che in Italia assume la
denominazione di Scienza delle finanze, cerca spiegazioni e “regole” per le scelte collettive, di
Finanza pubblica, analoghe a quelle cercate per le scelte individuali di mercato. I tentativi di dare
un fondamento rigoroso alle scelte economiche collettive vengono avviati, sul finire dell’Ottocento,
ad opera di economisti italiani (Mazzola, De Viti De Marco, Pantaleoni, per citarne solo alcuni)1 e
di lingua tedesca (soprattutto l’austriaco Sax e lo svedese Wicksell), che estendono l’individualismo
metodologico, cui il marginalismo fornisce il rigore, alle scelte pubbliche. Questo approccio, che si
affermerà anche nei Paesi di lingua inglese, pur con sostanziali differenze (in quanto veniva
trascurato il contesto politico-istituzionale che molti autori continentali ponevano al centro delle
loro indagini) non avrà concorrenti almeno fino agli anni cinquanta e il merito della sua diffusione
deve essere attribuito ad un economista tedesco emigrato negli Usa negli anni trenta del secolo
scorso, R.A.Musgrave. Com’è noto, l’evoluzione dell’economia delle scelte individuali approda,
attraverso le analisi di equilibrio parziale prima e di equilibrio generale poi, a quei risultati cui di
solito si rimanda sinteticamente utilizzando l’espressione “economia del benessere”. E l’economia
del benessere richiede che le scelte collettive (di Finanza pubblica) siano improntate alla ricerca
della massimizzazione dell’utilità degli individui che compognono la collettività, compito che in
realtà, come si dimostrò abbastanza presto, è teoricamente possibile (se si prescinde da altre
1
Senza ricorrere alle numerose citazioni che sarebbero necessarie, si può far riferimento ad un recentissimo paper di A.
Fossati (2008) che sintetizza molto bene le posizioni di questo gruppo di studiosi italiani, del tempo a cavallo tra fine
Ottocento e inizi del Novecento, sul ruolo dello Stato nell’analisi economica.
1
importanti limitazioni) solo se si assimila il meccanismo delle scelte collettive a quello di un
despota illuminato interessato a raggiungere quell’obiettivo. Questa semplificazione del
“paternalismo benevolente” trascura, tra l’altro, le caratteristiche che assumono in concreto, nei
paesi democratici, i meccanismi di decisione collettiva, limitandone le capacità esplicative e
rendendo puramente astratte le sue prescrizioni. Già sul finire dell’Ottocento alcuni studiosi italiani
di Scienza delle finanze (Montemartini, Puviani, Conigliani, Barone,…) e alcuni tedeschi della
“Finanzwissenschaft”( si pensi principalmente ad A. Wagner), con enfasi e considerazioni in parte
diversi, avevano rifiutato l’adozione di una metodologia che trascurava completamente le
complessità dei processi politici che regolano, a differenza di quanto avviene nel mercato, le
decisioni economiche collettive. In particolare quegli studiosi italiani, accomunati con qualche
semplificazione nel cosiddetto indirizzo politico-sociologico della Scienza delle finanze, ponevano
enfasi sull’importanza, negli stati democratici, degli interessi diversi da quelli degli elettori uti
singuli nelle decisioni pubbliche (necessariamente attuate attraverso l’uso della coazione) e
qualunque spiegazione e prescrizione non avrebbe potuto essere analizzata senza tenere conto dei
diversi interessi economici in gioco in quelle scelte (quelli dei politici, l’egoismo dei burocrati, la
pervasività dei gruppi di interesse, ecc.).
Questo filone di analisi rimase minoritario e l’analisi economico-pubblica
continuò a essere
dominata dall’economia del benessere, con le sue varianti e gli opportuni adattamenti. Nel corso
degli anni cinquanta del Novecento, però, J.M. Buchanan, ispirandosi esplicitamente a Wicksell e
agli studiosi italiani dell’indirizzo politico-sociologico, avviò un filone di ricerca sulle scelte
pubbliche alternativo a quello del “despota benevolente”, con l’obiettivo di inglobare nell’analisi
un’articolazione più realistica del processo politico, anche al fine di individuare i limiti che l’azione
governativa incontra nel realizzare quel “bene comune” che, al contrario, si può teoricamente
ottenere nell’analisi tradizionale. Il nuovo approccio (definito “Public Choice” in contrapposizione
alla tradizionale “Public Finance”, e anche alla definizione attualmente più adottata nei paesi di
lingua inglese di “Public Economics”) rappresentò una rottura nella consuetudine accademica
consolidata non solo della scienza economica, ma anche di quella politologica.
In anni molto più recenti alcuni economisti,in maggioranza con un “background”
macroeconomico, hanno avviato un filone di analisi esplicitamente rivolto ad analizzare le decisioni
politiche con quei metodi che la teoria economica ha sviluppato e affinato negli ultimi decenni. Ci
si è chiesto se, come pretendono i sostenitori di questo filone, si tratta di un’innovazione epocale
dell’analisi delle scelte collettive o, invece, di una mera evoluzione della “Public Choice”, che si
discosta però da questa per aspetti che la riavvicinano, come si vedrà, al filone tradizionale. Le
riflessioni da fare su questo tema sono particolarmente interessanti sia per la rilevanza che questo
2
programma di ricerca più recente, che prende il nome di “Political Economics”, ha assunto in
ambito accademico sia per la pretesa degli economisti che vi afferiscono di formulare prescrizioni
essenziali per le scelte politiche concrete.
In queste pagine non si prendono in esame altre visioni sulle scelte economiche e politiche
collettive (in particolare quelle di tipo organico, di classe nel senso marxiano, etc.) limitando
l’esame alle differenze che si possono manifestare tra alcuni approcci che condividono
l’individualismo metodologico2.
2. Dalla “Public Finance” alla “Public Choice”.
Lo studio delle scelte economiche collettive viene rivoluzionato dagli studiosi che avrebbero
costituito il nucleo fondante della scuola della Public Choice. Come accennato, le scelte pubbliche
erano analizzate, per tutta la prima metà del Novecento, come il risultato di un processo di
massimizzazione del benessere sociale posto in essere dal “governo”, considerato come un’unica
entità decisionale il cui interesse racchiudeva le preferenze di ognuno degli individui che
componevano la collettività. In questo approccio, il processo politico democratico veniva lasciato in
disparte, o enormemente semplificato, con accenni ai problemi posti dalla circolarità delle
maggioranze, dalla prevalenza delle decisioni dell’elettore mediano e altri ancora, ma poi
l’attenzione veniva unicamente volta alle condizioni di equilibrio, emerse nel corso dell’operazione
di ottimizzazione, che avrebbero garantito il raggiungimento di determinati obiettivi di efficienza e,
con ulteriori ipotesi e limiti, di equità. Diversi studiosi ponevano in dubbio la reale utilità di questa
impostazione, in quanto non era in grado di fornire una spiegazione corretta dell’effettivo svolgersi
del processo di decisione collettiva. Questa insoddisfazione crescente nei confronti dell’Economia
del Benessere esplose negli anni cinquanta del secolo scorso, quando l’evoluzione del ruolo dello
Stato e l’espansione delle risorse utilizzate dai bilanci pubblici nei Paesi industrializzati rese
inaccettabile e fuorviante affidarsi a un’interpretazione così superficiale ed irrealistica del processo
politico. All’indomani della seconda guerra mondiale, infatti, i bilanci pubblici degli Stati più
sviluppati avevano raggiunto livelli rilevanti (e la tendenza verso un incremento del “peso” della
spesa pubblica sul Pil sarebbe continuata per tutto il Novecento fino a raggiungere e, talvolta,
superare la metà del prodotto complessivo in molti stati europei). Questa evidenza empirica
2
R. Musgrave (1996) ricorda l’approccio “organico” allo studio dell’economia dello Stato, all’origine della
Finanzwissenschaft tedesca e la sua graduale evoluzione verso una visione più attenta alle preferenze individuali , ma
che non abbandona completamente l’approccio originario, ora definito del “communal state”. Con le parole di
Musgrave (1996, pag 73): “ In its extreme form, the personified state itself appeared as the subject of wants, overriding
the private preferences of its members. In its moderate form, only individuals experience wants, but a distinction
remains between their private and communal wants. While the former are satisfied in line with self interest, satisfaction
of the latter involves an obligation to the community as a whole.”
3
richiedeva uno studio specifico del meccanismo di decisione collettiva che, dovendo risultare
coerente con il funzionamento di un Paese democratico, non poteva più avere a fondamento quella
visione sostanzialmente organica dello Stato che caratterizzava l’utilizzo del concetto della
“funzione del benessere sociale”. In questo rifiuto dell’impostazione allora dominante nello studio
delle scelte pubbliche deve essere individuata la nascita del programma di ricerca della Public
Choice, che riuniva un gruppo di studiosi che avanzavano le loro critiche soprattutto nei riguardi
della metodologia adottata dagli economisti dell’approccio tradizionale e delle ipotesi che venivano
assunte per determinare le scelte collettive. In particolare, veniva contestata l’ostinata ricerca di un
criterio di determinazione dei diversi “stati del mondo” che permettesse all’economista di
identificare una soluzione socialmente efficiente ( e possibilmente unica) attraverso l’utilizzo della
Funzione del Benessere Sociale, prescindendo dal giudizio dei singoli membri che componevano la
comunità, come se le politiche dovessero essere stabilite da un despota illuminato.
Gli studiosi della Public Choice, primi fra tutti J.M. Buchanan e G. Tullock, sottolineavano la
necessità di studiare il funzionamento del processo politico per poter effettuare un’analisi più
realistica della policy pubblica. L’ipotesi di lavoro che avanzarono era quella di considerare il
movente del comportamento umano comune a tutti gli individui, sia che operassero in un ambito
che potremmo definire privato (ovvero nel mercato) sia che agissero in un ambito pubblico: in altre
parole, ritenevano corretto estendere il postulato dell’homo oeconomicus, adottato nella
microeconomia per spiegare le scelte private degli agenti economici operanti nel mercato, all’analisi
del comportamento di quelle persone che agivano in un ambito pubblico, come elettori, politici,
burocrati o all’interno di gruppi di interesse. Questo presupposto implica che le scelte economiche
compiute dagli uomini siano dirette alla massimizzazione del loro personale benessere e che in
questo calcolo utilitaristico non entrino, generalmente, motivazioni “sociali” o “altruistiche”3. Tale
ipotesi, che per certi versi può apparire piuttosto semplificatrice della realtà, in quanto trascura la
diversità degli obiettivi che si potrebbero porre individui coinvolti in diversi ambiti decisionali,
sembra essere, in ogni caso, meno controversa di quella che era sottesa all’Economia del Benessere
e che veniva bollata, proprio dagli autori della Public Choice, come quella del dualismo
comportamentale: nel mercato, le persone hanno in mente solamente il proprio interesse egoistico,
generando così tutta una serie di inefficienze che determinano le condizioni teoriche per un
intervento governativo nell’economia (come nel caso delle esternalità); quest’ultimo, a sua volta,
può ovviare a quei problemi poiché gli “agenti” dello Stato, come i politici o i burocrati, hanno in
3
Questo non significa che si possa sottovalutare l’importanza del cosiddetto “Terzo Settore” il cui sviluppo è in gran
parte attribuibile a motivazioni altruistiche. In questo settore sono particolarmente importanti la storia e il ruolo attuale
(entrambi molto articolati) delle Fondazioni. Si veda il Libro Bianco sulle Fondazioni del Consiglio Italiano per le
Scienze Sociali (2002) e, con riferimento agli Stati Uniti ma con argomentazioni largamente generalizzabili, il recente
D. Akst (2008).
4
mente solamente l’interesse della comunità, il “public interest”. Se, al contrario, seguiamo
l’approccio sviluppato dalla Public Choice e adottiamo un’ipotesi coerente sul piano del
comportamento tenuto dagli individui
quando operano nel mercato e quando sono coinvolti nelle decisioni pubbliche, allora la visione
dell’intervento dello Stato nell’economia diviene meno idilliaca. E questo è proprio quello che è
successo negli anni sessanta e settanta con l’affermazione di questa scuola che deve gran parte del
suo successo alla capacità di analizzare efficacemente ed in maniera disillusa il funzionamento delle
istituzioni, migliorando la nostra conoscenza dei meccanismi di decisione delle stesse. La sua
visione, diffidente nei confronti dell’operato dei politici e dei burocrati (ovvero dei soggetti
maggiormenti coinvolti nel processo di policy making e nell’attuazione delle decisioni stesse), ha
condotto a numerosi contributi, molti dei quali vengono definiti come “fallimenti dello Stato”, in
contrapposizione a quelli del mercato, caratteristici dell’analisi dell’economia del Benessere. Il
funzionamento delle istituzioni pubbliche e le inefficienze generate dal loro operare nelle economie
di mercato sono al centro delle indagini teoriche degli studiosi della scuola della Virginia (l’altro
nome con il quale si indica, solitamente, la Public Choice, dal momento che in quello Stato sono
concentrati i suoi maggiori centri di ricerca e sono attivi i suoi più importanti economisti) ed hanno
condotto allo sviluppo di una vastissima letteratura che comprende le analisi più svariate: da quelle
relative al rent-seeking (ovvero posizioni di rendita che, create da un soggetto governativo, sotto la
pressione dei gruppi di interesse – come nel caso di monopoli legali o delle barriere protezionistiche
–, inducono gli imprenditori a sperperare risorse in attività di lobbying al fine di otterere il diritto al
loro sfruttamento) a quelle sulla burocrazia (dove viene posta enfasi sull’assenza di corrispondenza
tra il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e la massimizzazione dell’utilità perseguita dai
burocrati), dall’elaborazione di differenti modelli di voto allo studio del comportamento
dell’elettorato. Negli ultimi decenni, molti scienziati della politica, intuendo l’enorme capacità
esplicativa dell’applicazione del postulato dell’homo oeconomicus alle scelte pubbliche, hanno
adottato lo stesso metodo dando vita alla corrente della “Teoria della Scelta Razionale”, che oggi
occupa un ruolo di rilievo in quella disciplina4.
Dalla maggior parte delle analisi effettuate dagli economisti appartenenti alla Public Choice
sembrerebbe emergere una generalizzata e forte antipatia nei confronti dell’intervento pubblico
nell’economia. Sebbene sia evidente che questi studiosi sono diffidenti nei riguardi dell’operato dei
politici e dei burocrati (ed è ciò che, in primo luogo, ha portato all’estensione del principio
dell’homo oeconomicus alla spiegazione del loro comportamento), occorre sottolineare come tale
prospettiva non sia chiusa ad autori più ottimisti verso l’azione pubblica: è questo il caso di Mancur
4
Sebbene sia stata oggetto di critiche, la più nota delle quali è esposta in D.P. Green e I. Shapiro (1994).
5
Olson, il quale non ha mai posto eccessiva fiducia nei riguardi dei risultati che possono essere
realizzati dal solo operare del mercato ed ha analizzato le condizioni che assicurano l’utilità
collettiva delle istituzioni e gli aspetti positivi della loro evoluzione, pur in presenza di
comportamenti egoistici degli individui che le compongono5.
In generale, queste lucide analisi “positive” del funzionamento delle istituzioni sono state
accompagnate dall’elaborazione di soluzioni utili a migliorare la corrispondenza tra le preferenze
dei cittadini-elettori e le politiche attuate dai governi. A differenza degli studiosi tradizionali, che
cercavano di individuare quale fosse la politica “migliore” che doveva essere realizzata da qualsiasi
governo per promuovere il “benessere” di tutta la comunità, gli economisti della Public Choice sono
consapevoli che tale modus operandi è del tutto sterile, dal momento che i membri dell’esecutivo al
massimo perseguono gli interessi di quella maggioranza necessaria per permettere loro di mantenere
il potere nella successiva tornata elettorale. Cosicché, il primario obiettivo di questi autori è quello
di individuare le condizioni che possono meglio costringere i politici a ricercare l’approvazione
della totalità dei cittadini e per questa ragione il loro approccio è process-oriented e non outcomeoriented. L’enfasi che gli studiosi di questa scuola attribuiscono alla necessità di avere una struttura
decentrata di governo e di fare maggior ricorso alle istituzioni proprie della democrazia diretta
(ovvero favorire, quando possibile, l’iniziativa popolare e il referendum) è giustificata proprio dal
fatto che questi rappresentano meccanismi in grado di favorire la manifestazione sincera delle
preferenze da parte degli individui e possono creare le condizioni affinché i politici siano tenuti a
rispettarle.
L’ambito di ricerca che più di ogni altro è rappresentativo di questo approccio è quello
dell’”economia politica costituzionale”. Il riconoscimento che anche gli individui coinvolti nei
processi decisionali pubblici si comportano egoisticamente deve indirizzare verso modelli di
istituzioni che rendano coerente il perseguimento dell’interesse personale con la determinazione di
risultati vantaggiosi per tutti. Il potere discrezionale di cui dispongono politici e burocrati deve
essere fortemente ridimensionato, dal momento che questi non sono agenti disinteressati, ed il luogo
ideale dove tali vincoli devono essere stabiliti è l’assemblea costituente. A questo livello le regole
devono necessariamente ricevere un consenso vasto e diffuso tra la popolazione per essere
introdotte, cosicché gli interessi di tutti i cittadini vengano presi in considerazione. In tali riflessioni,
sviluppate in più riprese soprattutto da Buchanan, Tullock e Brennan6, il debito più evidente è nei
riguardi di Hume, il quale aveva sottolineato la necessità di considerare ogni uomo come un
5
6
M. Olson (1965, 1996, 2000) e A. Dixit e M. Olson (2000).
In particolare J.M. Buchanan e G. Tullock (1962) e G. Brennan e J.M. Buchanan (1986).
6
“furfante dedito alla ricerca del proprio interesse” se si volevano stabilire effettivi vincoli all’azione
di governo7.
Le istituzioni democratiche dovrebbero essere modellate seguendo quella che viene definita la
“logica dello scambio”8: far sì che ogni individuo riceva dei vantaggi dalla partecipazione alla vita
associata, cosicché se potesse scegliere liberamente se farvi parte o meno, preferirebbe rimanere
all’interno della comunità. Il contratto sociale, al pari di quelli privati sottoscritti nel mercato,
richiede l’adesione volontaria di tutti i soggetti coinvolti e in una democrazia nessun individuo
dovrebbe essere costretto a subire una decisione collettiva che non ha partecipato a prendere.
Il postulato dello “scambio volontario” che insieme a quello della scelta razionale e
all’individualismo metodologico accomuna tutti gli studiosi della Public Choice viene chiaramente
ripreso da Wicksell, il quale, trattando delle decisioni di Finanza pubblica, cercava di determinare
quelle condizioni che avrebbero permesso ad ogni membro della comunità di beneficiare delle
scelte collettive ed era giunto alla conclusione che per raggiungere questo obiettivo fosse
necessaria, per quelle scelte, l’adozione del criterio dell’unanimità (o una sua approssimazione) in
Parlamento9. Tale regola di voto ha infatti la pregevole caratteristica di tutelare le minoranze, che
dispongono di un diritto di veto, contro quelle decisioni collettive considerate particolarmente
sfavorevoli nei loro confronti.
Wicksell rappresenta indiscutibilmente un punto di riferimento per l’analisi normativa svolta dagli
studiosi della Public Choice, così come la descrizione realistica del processo politico sviluppata
dagli autori italiani di Scienza delle Finanze di inizio Novecento è alla base della loro analisi
positiva.
E’ necessario però ricordare, necessariamente in maniera molto succinta, i principali limiti di questo
approccio. Anzitutto, non si chiarisce come i progetti di riforma costituzionale possano essere
effettivamente introdottti, dal momento che dovrebbero comportare una radicale redistribuzione del
potere a favore delle attuali minoranze e pertanto verrebbero fortemente osteggiate da coloro che
nello status quo ottengono enormi benefici. Questo è un aspetto trascurato in quanto gli studiosi
della Public Choice si sono sempre preoccupati di mostrare come le istituzioni pubbliche
dovrebbero essere modellate al fine di creare una società realmente democratica (nel senso, già
7
D. Hume (1987).
Buchanan vede la scienza economica come una “scienza degli scambi” concentrata sullo studio delle istituzioni e delle
proprietà che regolano il processo di negoziazione tra le parti coinvolte in un contratto e la contrappone al paradigma
della “massimizzazione” a cui si rifanno, invece, gli economisti tradizionali (cfr. J.M. Buchanan 1975, 1983). Nel far
questo, Buchanan segue esplicitamente l’impostazione di von Hayek (1982), che si definisce catallattica (dal verbo
Greco katallassein che significa “scambiare”, ma anche “ammettere nella comunità” e “diventare da nemici, amici”) ed
enfatizza i benefici che derivano dall’”ordine spontaneo” del mercato. In questa ottica, ogni risultato a cui si giunge
mediante l’accordo volontario tra gli individui è da ritenersi soddisfacente, mentre è insensato ogni tentativo di ricercare
esiti stabili ed univoci del processo di contrattazione tra gli agenti economici.
9
K. Wicksell (1896).
8
7
chiarito, di rispettare le preferenze di tutta la popolazione o, almeno, di una sua larghissima
maggioranza) senza però indicare la strada da percorrere per raggiungere quell’obiettivo.
Trattandosi di individuare un “processo” di decisione collettiva è particolarmente contraddittorio
con le fondamenta della Public Choice non cercare di individuarlo.
L’essersi disinteressati delle effettive scelte pubbliche ed essersi preoccupati principalmente della
astratta individuazione dei processi più idonei a garantire la manifestazione sincera delle preferenze
da parte dei cittadini (e il conseguente rispetto di quelle esigenze da parte dei governanti) ha lasciato
spazio agli studiosi più vicini alla corrente tradizionale della scienza economica. Su alcune
tematiche di grande rilevanza, come ad esempio la strutturazione del sistema tributario, le
indicazioni fornite dagli autori della Public Choice non sono approfondite e sufficientemente
articolate e si limitano principalmente ad avvertire sui pericoli che potrebbero derivare
dall’eccessiva discrezionalità con cui le scelte tributarie vengono assunte e sulla rilevanza degli
interessi particolari nella loro determinazione.
Poca attenzione specifica è dedicata poi al funzionamento dei mercati che, come si è accennato,
non sono considerati meccanismi che sfociano negli equilibri descritti dall’Economia del Benessere
e di conseguenza non è condivisa da questo approccio l’utilità del concetto di “fallimenti del
mercato”.
L’emergere dell’approccio di Public Choice è stato inizialmente osteggiato fortemente
dall’establishment accademico, ma nel corso del tempo la sua influenza si è estesa e anche
l’attribuzione del premio Nobel a Buchanan nel 1986 ha sancito il riconoscimento della rilevanza
accademica della scuola. L’acquisita consapevolezza che il metodo della Public Choice non implica
necessariamente una scelta contraria all’esistenza dello Stato (o favorevole all’accettazione dello
Stato minimo), anche se i suoi esponenti continuano prevalentemente a militare tra i conservatori
più “liberisti”(ma non per ragioni scientifiche), ha aumentato la sua considerazione presso gli
economisti di vario orientamento politico.
3. I modelli di “Political Economics”: solo vino vecchio in otre nuovo?
La decisione degli autori di Public Choice di non basarsi sulla ricerca di equilibri economici
efficienti, dal punto di vista della teoria dell’Economia del Benessere, lasciava spazio agli
economisti “mainstream”, interessati alla determinazione delle condizioni necessarie per
l’”ottimalità” delle scelte economiche pubbliche. Infatti, nonostante le critiche mosse dalla scuola
della Virginia a chiunque analizzasse le scelte sociali prescindendo da un’attenta e ponderata
8
valutazione del funzionamento del processo politico, l’attrazione per eleganti soluzioni di equilibrio
che, almeno teoricamente, potessero eliminare le inefficienze create dall’interazione tra gli agenti
economici (fallimenti del mercato), continuava ad esercitare un grande richiamo nella maggioranza
degli economisti pubblici.
Sulla scia di analisi del rent seeking basate sull’approccio tradizionale ( diverso da quello di Public
choice10) appaiono diversi contributi, in prevalenza non coordinati tra di loro, che trattano
l’interazione tra mercato e istituzioni pubbliche restando ancorati alle “tecnologie” del mainstream
della disciplina economica.11 Così si afferma gradualmente una nuova corrente, indicata con il
nome di Political Economics (o Political Economy), che accomuna quegli scienziati sociali
(economisti, ma anche politologi) che condividono alcuni aspetti essenziali del lavoro di ricerca.
L’obiettivo principale è quello di analizzare le politiche economiche dei paesi democratici per
cogliere le motivazioni che possano spiegare le difformità di risultati osservabili nei diversi Paesi.
Viene studiato il funzionamento del processo politico e si indagano quei fattori che possono avere
riflessi rilevanti sulle effettive politiche realizzate: di conseguenza, grande enfasi viene posta sulla
considerazione degli incentivi che indirizzano le scelte dei governanti e sui limiti che i politici
possono incontrare nell’attuare i loro piani, solitamente strutturati in maniera tale da apportare
benefici solo a gruppi ristretti della comunità. Un elemento comune a tutti i contributi, che li
distingue dall’approccio tradizionale di Public Economics, è la considerazione dello Stato ( o
meglio del “governo”) come endogeno nella determinazione dei risultati dell’interazione tra gli
agenti economici; di conseguenza , in presenza di situazioni inefficienti ( fallimenti del mercato),
non si può dare per scontata l’esistenza del “despota benevolente” disposto a correggerle.
Sembrano, quindi, notevoli le affinità tra la Political Economics e la Public Choice, in quanto
entrambe vogliono spiegare le scelte politiche usando la metodologia dell’homo oeconomicus. Qual
è allora la ragione della nuova prospettiva? In quello che viene considerato il “manuale” della
Political Economics12, si afferma esplicitamente che le tematiche sono comuni alla Public Choice,
ma i limiti che affliggono quell’approccio richiedono una nuova (ed autonoma) elaborazione. Gli
studiosi della Public Choice sono accusati di non tener conto degli sviluppi, principalmente nelle
metodologie di analisi quantitativa statistico-matematica, che hanno caratterizzato la scienza
economica negli ultimi decenni. In particolare non utilizzano modelli formali di teoria dei giochi
per sviluppare le loro intuizioni né adottano le “aspettative razionali” come ipotesi di
10
G.Tullock (1967).
A.O. Krueger (1974) e J.N. Bhagwati e T.N. Srinivasan (1980). Si tratta dello studio della cosiddetta DUP (
directly unproductive profit-seeking activity) che analizza il Rent seeking come attività che le scelte pubbliche (in
un’ottica di ottimizzazione) devono contrastare.
12
T. Persson e G. Tabellini (2000), pp2-4
11
9
comportamento economico degli individui. Per queste ragioni le analisi di Public Choice sarebbero
lacunose ed erronee e dovrebbero essere sostituite con studi in linea con i nuovi tools e le nuove
teorie della corrente mainstream della scienza economica. Quindi la Political Economics si
richiama alla Public Choice solo nella definizione dei problemi, mentre sceglie la cosiddetta “teoria
della politica economica” come ambito metodologico essenziale di analisi, teoria che nasce in
ambito macroeconomico. Essa trova origine nella critica di Lucas ai modelli econometrici
tradizionali i quali, nel valutare gli effetti delle diverse politiche sulle variabili macroeconomiche,
non consideravano la possibilità che la relazione stessa tra le variabili potesse essere influenzata
dalla policy adottata. Sono soprattutto le intuizioni di Kydland e Prescott (1977) ad aver spianato,
per questo aspetto, la strada alla nascita della Political Economics ; infatti, insieme con i successivi
lavori di Barro e Gordon (1983), si é modificato radicalmente lo studio della determinazione delle
decisioni politiche efficienti e delle circostanze affinché queste possano essere ottenute rispettando
le condizioni di equilibrio. In estrema sintesi, si può dire che se le decisioni correnti degli operatori
privati dipendono dalle loro aspettative sulle scelte politiche future, emerge per il governo una
discrasia fra la politica coerente con quella annunciata e quella “ottimale”: infatti, se le autorità in
un secondo momento possono di modificare la policy annunciata avranno convenienza a farlo in
quanto non dovranno più tenere conto degli effetti delle loro scelte sulle decisioni del settore privato
(il loro problema di ottimizzazione presenta un vincolo in meno). Tuttavia, se le aspettative degli
operatori privati sono razionali, la scelta dei politici sarà correttamente prevista e gli agenti
economici non crederanno nella politica annunciata dal governo. Cosicché, se il governo non può
assumere l’impegno vincolante a rispettare quanto sostenuto in precedenza, si determina una
situazione di equilibrio negativa dal punto di vista del benessere sociale13. Questo problema,
definito di incoerenza dinamica, ha dato vita a una serie di studi volti ad individuare quelle
condizioni, solitamente basate sulla reputazione del policymaker, che potrebbero garantire
l’ottenimento di equilibri efficienti, anche nel caso in cui non si possa ricorrere ad impegni
vincolanti.
La Political Economics estende l’analisi dei problemi di credibilità allo studio delle istituzioni
collettive e degli incentivi per i politici. Ne segue che la politica economica effettivamente
13
Un esempio illuminante riguarda la tassazione degli utili: l’obiettivo del governo potrebbe essere quello di incentivare
l’accumulazione del capitale, annunciando che i profitti non verranno tassati. Successivamente, quando gli investimenti
produttivi sono stati realizzati, la scelta ottimale del governo diventa quella di concentrare l’imposizione proprio sui
profitti: l’offerta di capitale ex-post è rigida, quindi tale imposta non genera alcuna distorsione e permette al governo di
realizzare con il suo gettito i suoi obiettivi (qualsiasi essi siano: da ridurre la tassazione sul reddito da lavoro ad
incrementare i suoi consumi od espandere il settore pubblico, etc.). Tuttavia, gli investitori privati, se sono “razionali”,
anticiperanno l’incentivo del governo a contravvenire alla promessa di non tassare gli utili e gli investimenti
risulteranno inferiori alle attese. Tutto ciò accade se il governo non può vincolarsi a rispettare gli impegni assunti.
10
realizzata non è altro che il risultato di equilibrio di un gioco non cooperativo in cui si scontrano i
conflitti di interesse tra elettori e policymakers e tra differenti gruppi di elettori e partiti politici.
Nell’ambito delle analisi che combinano le scelte politiche con il funzionamento dei mercati visto
con l’ottica della tradizionale Economia del benessere va annoverato un insieme di contributi di
diversa origine, che si distinguono da quelli di Political Economics in senso stretto, in quanto sono
dettagliatamente definiti dal punto di vista microeconomico e non fanno riferimento ai fondamenti
macro di tale indirizzo. Si tratta di modelli che stilizzano il funzionamento del mercato secondo il
mainstream ( tendenzialmente nell’ambito dell’ equilibrio economico generale) e le scelte collettive
secondo criteri formalizzati di equilibrio politico. A questo filone appartengono i modelli di voto
probabilistico, in cui si ipotizza che i partiti non sono a conoscenza delle preferenze politiche degli
elettori e cercano di strutturare le piattaforme politiche al fine di massimizzare il numero dei voti
attesi; i cittadini, a loro volta, basano la propria intenzione di voto sull’utilità che potrebbero
ottenere dalla realizzazione dei programmi politici tra cui possono scegliere. Tra i lavori che si
basano sul modello di voto probabilistico, si può ad esempio considerare quello di Hettich e Winer
(1999), centrato sulle scelte di tipo tributario. In opposizione all’approccio dell’Optimal Taxation
(tipico della tradizionale Public Economics), questi studiosi enfatizzano il ruolo rivestito dal
processo politico nella strutturazione dei sistemi tributari e osservano come nelle concrete scelte
tributarie prevalga il peso dell’equilibrio politico rispetto a quello dell’equilibrio economico. In
particolare esse sono il risultato del bilanciamento tra gli opposti interessi di individui razionali con
preferenze eterogenee. In questi modelli il benchmark teorico della lump sum tax (l’imposta in
somma fissa), talvolta della Optimal Income Tax, che tanto piace ai teorici della Public Economics,
in quanto non distorcerebbe ( sotto certe condizioni) le scelte degli agenti economici privati, ovvero
consentirebbe di minimizzare le distorsioni in cambio di desiderati risultati in termini di
distribuzione del reddito( nel caso della Optima Incomel Tax), non appare in generale coerente con
possibili equilibri politici democratici. Hettich e Winer estendono quindi l’analisi di equilibrio
economico generale allo scenario politico e ai risultati generati in questo ambito, considerando i
diversi vincoli che caratterizzano e distinguono i processi di scelta pubblici da quelli di mercato. Si
può sostenere che l’equilibrio politico che emerge nei modelli di voto probabilistico completa il
tradizionale approccio microeconomico, e permette di evidenziare risultati complessivi di second
best ( nel senso della teoria economica tradizionale) che si realizzano considerando il libero
funzionamento del mercato e il complementare processo politico. In effetti sia i modelli di Public
11
Choice sia quelli di Political Economics (delle diverse varietà) fanno largo riferimento alle capacità
autoregolatrici del mercato, per la “logica dello scambio” nelle analisi del primo tipo, più
rispondenti a criteri di massimizzazione del benessere sociale nell’altro caso.
L’approccio più recente si caratterizza inoltre per l’ utilizzo generalizzato di tecniche di ricerca
empirica di tipo statistico-econometrico, che vengono applicate alle più varie tipologie di problemi
di scelta collettiva: dalle politiche ridistributive a quelle monetarie, dal ciclo politico economico
alla configurazione geografico-politica degli Stati. Le teorie degli studiosi appartenenti sia al filone
macro sia a quello micro di questo approccio nascono sostanzialmente dai risultati delle stime
empiriche e la loro validità è legata, quindi, all’ utilizzo (e alla disponibilità) di dati appropriati e al
proficuo e corretto uso degli strumenti statistico-econometrici. Per questi studiosi le prescrizioni
normative possono derivare solo da una conoscenza approfondita del concreto funzionamento delle
istituzioni, realizzabile attraverso un gran numero di studi empirici. Questa esigenza, a sua volta,
spinge a “costruire” quasi un modello per ogni aspetto indagato, ma questa frammentarietà risulta
spesso poco utile alla formulazione di suggerimenti atti a migliorare in generale l’efficienza delle
scelte collettive.Le ipotesi dei diversi modelli sono talvolta tra loro contrastanti, per cui non si sa se
rappresentano spiegazioni complementari ovvero alternative dell’azione politica indagata. Gli stessi
autori sembrano consci dell’irrealtà delle ipotesi adottate e della singolarità dei risultati, che spesso
mutano con piccole modifiche delle ipotesi di partenza14.
4. “Public Choice” e “ Political Economics”: (in)evitabile contrapposizione ?
Le analogie e le differenze tra i due approcci sono state oggetto di uno scambio di opinioni,ospitato
nella Rivista “Kyklos”, introdotto da un saggio di Blankart e Koester (2006). Esso segue precedenti
osservazioni di alcuni eminenti studiosi di Public Choice che lamentano la pratica, costantemente
seguita da diversi economisti della Political Economics, di trascurare i risultati delle ricerche della
scuola della Virginia, presentando le proprie analisi come totalmente innovative. Blankart e Koester
(2006) hanno cercato di comparare, in maniera sistematica, i contributi apportati dai due programmi
di ricerca, per verificare se la Political Economics possa effettivamente e completamente sostituirsi
alla Public Choice nell’analisi economica delle istituzioni collettive15. Il tono polemico e la messa
14
Si veda T. Parrson e G. Tabellini (2000), parte III.
Tra gli altri economisti che si sono lamentati dell’atteggiamento adottato dagli autori di Political Economics nei
confronti della letteratura di Public Choice, possiamo citare H.W. Ursprung (2003), D.C. Mueller (2007) e R.D.
Tollison (2007).
15
12
in discussione della validità di alcuni risultati ottenuti dalla scuola più recente ha provocato una
risposta alle accuse, che ha contribuito a chiarire le rispettive posizioni16. Blankart e Koester hanno
anche compiuto un’attenta analisi dei principali contributi della Political Economics, mettendone in
evidenza i limiti. Essi riconoscono che alcune analisi empiriche sono apprezzabili. In particolare il
contributo alla letteratura sul Political-Business Cycle, in cui sono stati riprese le indicazioni di
Kalecky , Nordhaus e Hibbs,, sono
considerate di utile sviluppo idonee
della letteratura
precedente17.
Particolarmente irritante risulta invece per la Public Choice la rivendicazione, da parte dell’ altro
approccio, di originalità e innovazione di risultati nella materia dell’ “Economia politica
costituzionale”18. Nonostante la rilevanza delle intuizioni e delle considerazioni presenti, ad
esempio, in Buchanan e Tullock (1962) e in Brennan e Buchanan (1986), è sorprendente notare
come la letteratura di Political Economics trascuri completamente tali contributi.
La distinzione fondamentale in questo campo riguarda il criterio di valutazione degli assetti
istituzionali : per la Political Economics, nella tradizione dell’ Economia del benessere, si deve
valutare l’efficienza dei risultati, mentre per la Public Choice quel che conta è l’efficienza dei
processi decisionali. In particolare per questa scuola bisogna assicurare processi che garantiscano
tutti i membri della collettività dalla possibilità che i policy-makers adottino decisioni fortemente
sfavorevoli per le minoranze, mentre per i primi si debbono cercare quei risultati (definiti all’interno
di certi vincoli) che massimizzano l’utilità ( secondo i criteri dell’Economia del Benessere adattata
all’uso di tools più moderni).
In questo senso si spiega perché l’approccio seguito da autori come Persson e Tabellini, che mira a
definire gli effetti economici associati all’adozione di differenti forme di governo e diverse regole
elettorali, possa essere considerato statico dall’altra scuola. Questa invece cerca di suggerire
innovazioni istituzionali in grado di assicurare una maggiore corrispondenza tra le preferenze del
maggior numero possibile di cittadini e le scelte dei governi e quindi si pone su un piano di
dinamica costituzionale19. La Political Economics adottando, come si è detto, un approccio di
osservazione empirica, deriva i suoi suggerimenti dalla comparazione degli effetti economici degli
assetti istituzionali concretamente esistenti in un dato lasso di tempo. L’”economia politica
16
A. Alesina, T. Persson e G. Tabellini (2006)
I modelli sul ciclo politico-economico realizzati dagli economisti di Political Economics partono dall’originario
contributo di A. Alesina (1987).
18
Cfr. la recensione di D. Acemoglu (2005) a “The Economic Effects of Constitutions”, il libro di Persson e Tabellini
(2003), che viene considerato da questo autore un lavoro fondamentale per chiunque volesse cimentarsi nello studio
dell’influenza delle istituzioni sulle performance dell’economia.
19
La difficoltà di accettare la netta distinzione tra regole costituzionali e decisioni politiche concrete è messa in rilievo
da Dixit (1996) come una delle cause della diffidenza degli economisti nei confronti della Public Choice: “a ... reason
for economists’ hesitancy in accepting the public choice approach may be that its distinction between the constitution of
economic policy and the policy process in individual istances is too sharply drawn to be realistic” (cfr. A.K Dixit 1996
pag. 19).
17
13
costituzionale” richiede invece, secondo gli autori di Public Choice, un approccio “creativo” e non
può, di conseguenza, fondarsi unicamente su confronti basati sulle istituzioni esistenti20.
La contrapposizione tra le due scuole è quindi in parte di tipo metodologico, come si è visto, ma in
parte riflette diverse visioni dei compiti attribuibili alle scelte collettive. Importante è per gli uni la
limitazione dei poteri dei governi (e degli altri agenti delle scelte pubbliche) nelle decisioni
economiche collettive per evitare la tirannia della maggioranza e altri inconvenienti (come il rentseeking,ecc.). Rilevanti per gli altri sono invece solo i risultati in termini di quelle variabili
economiche che rappresentano gli obiettivi dell’azione pubblica.
L’approccio di Public Choice è stato spesso associato dai suoi avversari con il modello del
Leviatano21, una visione del ruolo dello Stato nell’economia che negherebbe qualunque utilità alla
politica economica. In realtà, secondo i sostenitori di questo approccio, questa modello viene
adottato per fini meramente esemplificativi: serve solo a richiamare l’attenzione sui potenziali
abusi che un governo, non sottoposto a vincoli costituzionali, può attuare nei confronti dei cittadini.
Quella del Leviatano e’, quindi, un’ipotesi strumentale, al pari di quella relativa all’homo
oeconomicus, impiegata, almeno dai principali autori di Public Choice, per sottolineare i potenziali
effetti negativi associati alla mancanza di efficaci vincoli costituzionali all’azione politica. Questi
aspetti sono stati spesso mal compresi dalla comunità accademica22 e hanno ostacolato un proficuo
utilizzo dei risultati delle loro ricerche.
La contrapposizione tra i due approcci appare in larga misura inevitabile per le diverse metodologie
adottate e per il differente ruolo attribuito alle regole nelle decisioni economiche collettive,
quantunque si condivida il rilievo degli interessi particolari degli agenti pubblici nel funzionamento
complessivo del sistema economico. Forse in casi ben determinati (specificando le ipotesi, i dati e le
metodologie seguite) talune ricerche dei rispettivi approcci potrebbero rivelarsi complementari
nell’interpretazione delle politiche pubbliche.
5.Conclusioni.
20
C.B. Blankart e G.B. Koester (2006) pag. 189.
Il modello del Leviatano ipotizza che i governanti, anche nei Paesi democratici, si comportino in maniera autocratica
e il loro unico obiettivo sia quello di sfruttare tutte le rendite che possono ottenere nella loro posizione. Si veda G.
Brennan e J.M. Buchanan (1980).
22
Anche da studiosi che non sono riconducibili ad una particolare scuola; si veda l’articolo di Jennings e McLean
(2008).
21
14
Nel corso degli ultimi decenni l’entità delle risorse la cui allocazione e distribuzione è soggetta a
decisioni economiche pubbliche si è progressivamente accresciuta fino a raggiungere, in buona
parte dei paesi sviluppati, quasi la metà del prodotto annuale. In queste condizioni è evidente che le
spiegazioni del funzionamento complessivo del sistema economico non possono prescindere
dall’analisi di come le scelte economiche collettive operano e interagiscono con quelle di mercato
(private). L’approccio tradizionale della scienza economica attribuiva alle scelte pubbliche il
compito di supplire (ipotizzando un obiettivo di perseguimento del public interest da parte degli
agenti che concretizzano quelle scelte) alle deficienze (“fallimenti”) del mercato.
La constatazione, da parte di molti economisti pubblici, di diffusi comportamenti degli “agenti”
pubblici spiegabili più con il self interest che con il public interest, ha favorito la nascita di un
approccio all’analisi delle scelte pubbliche che è di rottura rispetto alla tradizione precedente: la
Public Choice si pone in alternativa alla Public Finance ( o Public Economics) anche su un piano
metodologico più generale. Non solo contesta l’utilità dell’ipotesi del “despota benevolente” che
corregge i “fallimenti del mercato” ed enfatizza invece la rilevanza dei “fallimenti dello Stato”, ma
rifiuta buona parte della “scatola degli attrezzi” usati in precedenza, anche se condivide con
l’approccio tradizionale l’individualismo metodologico che, anzi, più correttamente (secondo il
nuovo indirizzo) viene esteso alla spiegazione del comportamento degli agenti pubblici.
Lo stesso atteggiamento viene sostenuto da un approccio ancora più recente, quello di Political
Economics, che vuole però riprendere (in versione ammodernata) la “scatola degli attrezzi”
tradizionali della scienza economica mainstream, pretendendo di rappresentare un’innovazione
epocale nella metodologia di analisi delle scelte economiche pubbliche. Questo atteggiamento.
secondo gli altri studiosi, non appare giustificato dai risultati delle ricerche condotte nell’ambito di
tale approccio. Queste obiezioni ci appaiono condivisibili e le carenze non sembrano solo
attribuibili alla ancora “giovane età” della Political Economics (giustificazione che alcuni suoi
esponenti avanzano quando non è possibile ricorrere ad altre difese ).
Mentre l’approccio tradizionale aveva una “visione” necessariamente ottimista del ruolo pubblico,la
maggioranza degli studiosi di Public Choice e di Political Economics
ne condividono una
pessimista, contrapposta a una grande fiducia (diversamente motivata nei due approcci) nelle
capacità di autoregolazione dei mercati.
La opposta valutazione del comportamento degli agenti pubblici affonda le radici in visioni più
ampie della società. In una memorabile settimana di confronti avvenuti a Monaco di Baviera nel
1998, J. Buchanan e R. Musgrave hanno avuto modo di esplicitare questo tipo di divergenze.23 Sulle
23
J. Buchanan . e R. Musgrave (1999).
15
relazioni tra analisi economica e visione generale del funzionamento della società il primo
conclude:” Observed opportunistic behavior, both in markets and in politics, suggest an absence of
moral constraints”, ma ciò nonostante non bisogna essere pessimisti e il suo atteggiamento “remains
meliorist in its claim that properly designed institutional-constitutional change can move behavior at
least some direction toward the classical liberal set of minimum standards that seem necessary”.24
E Musgrave :” One of my themes has been that market, efficient and helpful as it is, does not itself
constitutes a moral order. The vision of a moral order, based on self-interest only, is incongruous”25
ed egli preferisce una società “where individuals as citizens of their community share common
obligations and do so on a daily base, including their conduct of the public sector”.
E’ evidente che le diverse “lenti” indossate dagli economisti sia per spiegare le decisioni pubbliche
sia per prescrivere politiche “migliori” sono modellate da convinzioni che non è possibile, in larga
misura, sottoporre a verifica scientifica e la cui scelta non può che essere lasciata alla responsabilità
e alla libertà di valutazione dello studioso.
24
25
Idem, pag 217.
Idem, pag 232.
16
BIBLIOGRAFIA
Acemoglu, Daron (2005), Constitutions, Politics, and Economics: A Review Essay on
Persson and Tabellini’s the Economic Effects of Constitutions, Journal of Economic Literature, pp.
1025-1048.
Akst, Daniel (2008),A che cosa servono le Fondazioni?, Queste Istituzioni,n. 148.
Alesina, Alberto (1987), Macroeconomic Policy in a Two-Party System as a Repeated Game,
The Quarterly Journal of Economics, pp. 651-678.
Alesina, Alberto, Torsten Persson e Guido Tabellini (2006), Reply to Blankart and Koester’s
Political Economics versus Public Choice: Two Views of Political Economy in Competition, Kyklos,
pp. 201-208.
Barro, Robert J. e David B. Gordon (1983), Rules, Discretion and Reputation in a Model of
Monetary Policy, Journal of Monetary Economics.
Bhagwati, Jagdish N. e T.N. Srinivasan (1980), Revenue Seeking: A Generalization of the
Theory of Tariffs, The Journal of Political Economy, pp. 1069-1087.
Blankart, Charles B. e Gerrit B. Koester (2006), Political Economics versus Public Choice:
Two Views of Political Economy in Competition, Kyklos, pp. 171-200.
Brennan, Geoffrey e James M. Buchanan (1980), The Power to Tax: Analytical Foundations
of a Fiscal Constitution.
Brennan, Geoffrey e James M. Buchanan (1986), The Reason of Rules: Constitutional
Political Economy, Cambridge, Uk, Cambridge University Press.
Buchanan, James M. e Gordon Tullock (1962), The Calculus of Consent. Logical
Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor, University of Michigan Press.
Buchanan, James M. (1975), A Contractarian Paradigm for Applying Economic Theory,
American Economic Review, pp. 225-230.
Buchanan, James M. (1983), The Public Choice Perspective, Journal of Public Finance and .
Public Choice/Economia delle Scelte Pubbliche, pp. 7-15.
Buchanan, James M. e Richard A. Musgrave (1999), Public Finance and Public Choice.Two
Contrasting Visions of the State, CESifo, MIT Press, Cambridge, MA.
Consiglio Italiano per le Scienze Sociali (2002) Libro Bianco sulle Fondazioni, Queste
Istituzioni, n.127.
Dixit, Avinsah K. (1996), The Making of Economic Policy. A Transaction-Cost Politics
Perspective, Cambridge, MA, MIT Press.
Dixit, Avinsah K. e Mancur Olson (2000), Does Voluntary Partecipation Undermine the
Coase Theorem?, Journal of Public Economics
Fossati, Amedeo (2008), The idea of State in the “Scienza delle finanze” from Antonio De
Viti De Marco to Mauro Fasiani, Società Italiana di Economia Pubblica, W.P. n.615.
Green, Donald P. e Ian Shapiro (1994), Pathologies of Rational Choice Theory: a Critique
of Applications in Political Science, New Haven, Yale University Press.
von Hayek, Friedrich A. (1982), Law, Legislation and Liberty. Chicago, University of
Chicago Press.
Hettich, Walter e Stanley L. Winer (1999), Democratic Choice and Taxation: a Theoretical
and Empirical Analysis. Cambridge, Uk, Cambridge University Press.
Hume, David (1987), On the Independency of Parliament, in Essays, Moral, Political, and
Literary, Liberty Fund, inc.
Jennings, Colin e Iain McLean (2008), Political Economics and Normative Analysis, New
Political Economy, pp. 61-76.
Krueger, Anne O. (1974), The Political Economy of the Rent-Seeking Society, The American
Economic Review, pp. 291-303.
Kydland, Finn E. ed Edward C. Prescott (1977), Rules Rather than Discretion: The
Inconsistency of Optimal Plans, The Journal of Political Economy, pp. 473-492.
Musgrave Richard A. e Alan T. Peacock (1958), Classics in the Theory of Public Finance,
London, Macmillan.
Mueller, Tennis C. (2007), Torsten Persson and Guido Tabellini, The Economic Effects of
Constitutions: Book Review, Constitutional Political Economy, pp. 63-68.
Musgrave, Richard M. (1996), Public Finance and Finanzwissenschaft traditions compared,
in Musgrave R., Public Finance in a Democratic Society, vol III, Edward Elgar, Cheltenham.
Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of
Group, Cambridge (Mass), Harvard University Press.
Olson, Mancur (1996), Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich and
Others Poor, The Journal of Economic Perspectives, pp. 3-24.
Olson, Mancur (2000), Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist
Dictatorships.
Persson, Torsten e Guido Tabellini (2000), Political Economics: Explaining Economic
Policy, Cambridge (MA), The MIT Press.
Persson, Torsten e Guido Tabellini (2003), The Economic Effects of Constitutions,
Cambridge (MA), The MIT Press.
Tollison, Robert D. (2007), Old Wine, New Wine, Public Choice, pp. 3-5.
Tullock, Gordon (1967), The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft, Western
economic Journal, pp. 224-232.
Ursprung, Heinrich W. (2003), Where Do We Go from Here?, in Stanley L. Winer e
Hirofumi Sibata, Political Economy and Public Finance, Northampton (MA): Edward Elgar.
Wicksell, Knut (1896), Finanztheoretische Untersuchungen, Jena, in Musgrave e Peacock
(1958) – tradotto come A New Principle of Just Taxation.