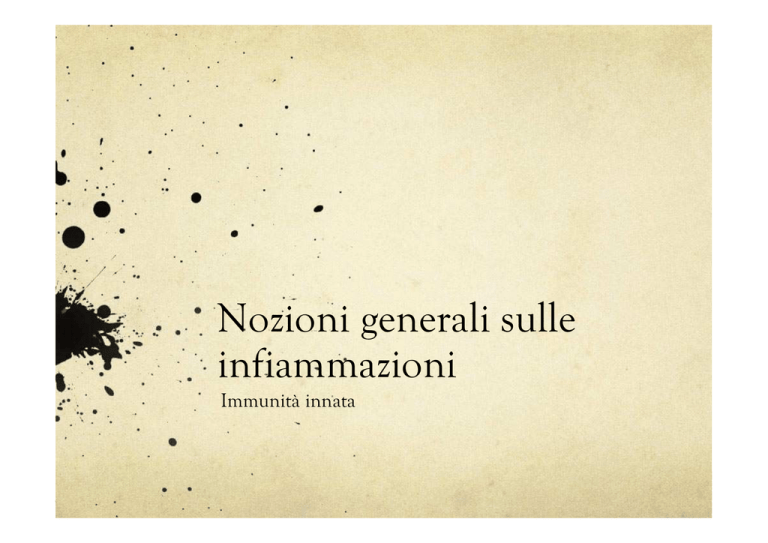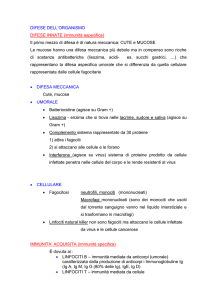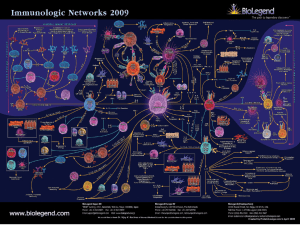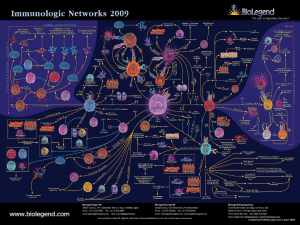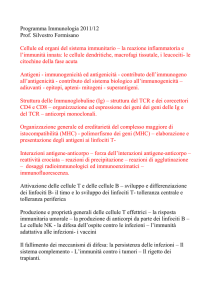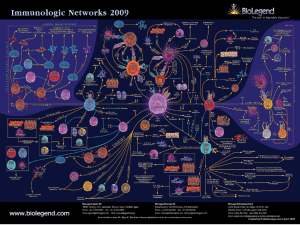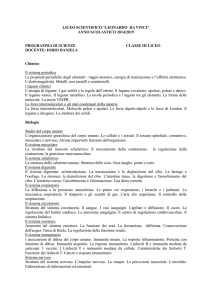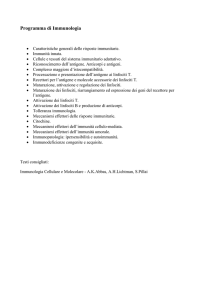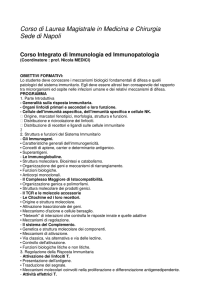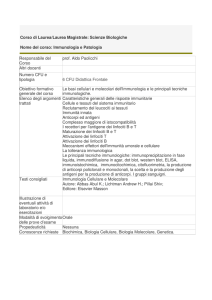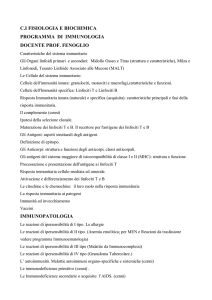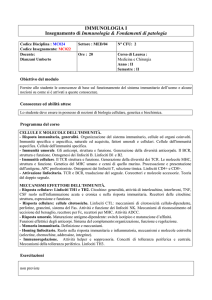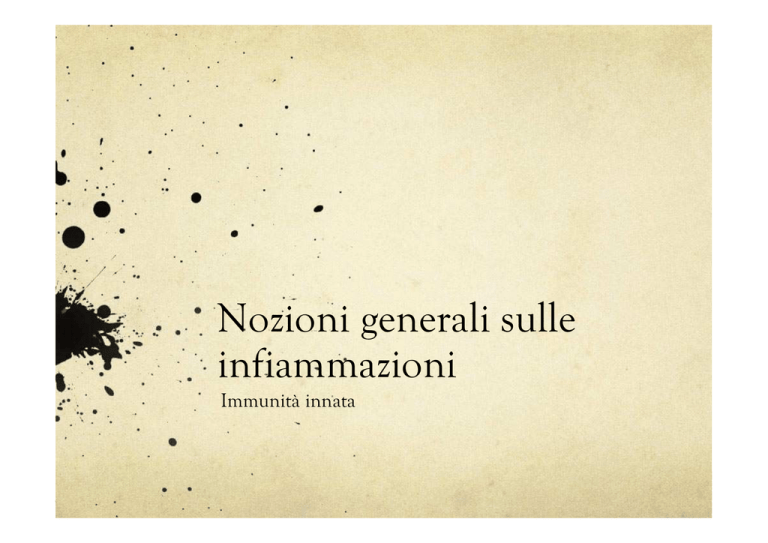
Nozioni generali sulle
infiammazioni
Immunità innata
Immunità innata
Prima risposta
Non specifica
Espressione rapida
Immunità non protettiva
Non memorizza la risposta
Meccanismo principale: fagocitosi
FASI DELL’IMMUNITÀ
INNATA
I sensori
È di fondamentale importanza la possibilità, che le cellule
coinvolte nella immunità innata siano dotate di sensori.
Oltre al complemento, che permette la fagocitosi e
l’attivazione della immunità acquisita, è stato recentemente
scoperto un sistema di riconoscimento immediato,
costituito da una famiglia di recettori, chiamato toll-like, il
quale identifica molecole microbiche non espresse (o solo
raramente espresse) dalle cellule e dai tessuti dell’organismo
ospite.
I recettori toll-like sono denominati, genericamente, PAMP
(pathogen-associated molecular pattern).
I sensori di membrana
Sensori
PAMP
Membrana citoplasmatica
Il legame di alcuni PAMP (il più conosciuto è il TLR4) alle cellule richiede la
partecipazione di un co-recettore, il più noto dei quali è il CD14, che lega i
lipopolisaccaridi dei batteri gram- e gli acidi lipoteicoici dei gram+.
LPS
TLR4
CD14
Membrana citoplasmatica
Recettore
Ligando
Adattatore
Localizzazione
TLR 1
triacyl lipoproteine
MyD88/MAL
Superficie cellulare
TLR 2
lipoproteine; peptidoglicani di gram+; acidi lipoteicoici; funghi;
glicoproteine virali
MyD88/MAL
Superficie cellulare
TLR 3
Doppia elica RNA (come in alcuni virus), poli I:C
TRIF
Compartimento
cellulare
TLR 4
Lipopolisaccaridi; glicoproteine virali
MyD88/MAL/TRIF/TRA
M
Superficie cellulare
TLR 5
flagellina
MyD88
Superficie cellulare
TLR 6
diacil lipoproteine
MyD88/MAL
Superficie cellulare
TLR 7
Piccoli composti sintetici; Rna a singola catena
MyD88
Compartimento
cellulare
TLR 8
Piccoli composti sintetici; Rna a singola catena
MyD88
Compartimento
cellulare
TLR 9
CpG Dna non metilato
MyD88
Compartimento
cellulare
TLR 10
sconosciuto
sconosciuto
Superficie cellulare
TLR 11
Profillina
MyD88
Superficie cellulare
TLR 12
sconosciuto
sconosciuto
?
TLR 13
sconosciuto
sconosciuto
?
In questo caso, il legame tra LPS e CD14 è potenziato da altre due proteine: LBP
(proteina legante i lipopolisaccaridi) e CD55 (DAF). LBP e CD55 legano i LPS e li
trasferiscono al CD14, che poi si associa al TLR4. I toll-like receptors (TLRs) fanno parte
di un gruppo di recettori denominati PRR (pattern recognition receptor).
LPB
CD55
TLR4
CD14
LPS
Trasduzione del segnale
Il riconoscimento di un TLR con un ligando
determina la trasmissione di un segnale di attivazione
all’interno della cellula, il quale può seguire vie diverse.
Quanto succede in seguito all’interno della cellula è
dovuto al coinvolgimento di numerose proteine ed
enzimi, che conducono alla entrata nel nucleo di
fattori di trascrizione, quali NF-kB, i quali permettono
la trascrizione genica delle citochine.
Dalla produzione di citochine dipende l’attivazione dei
meccanismi di flogosi.
Trasduzione del segnale
Citochine
TLR4
TLR4
Trasduzione del
segnale
NF-kB
Nucleo
infiammatorie
NF-kB
Fattore di trascrizione ubiquitario conservato nelle
cellule eucariotiche.
Attivato da numerosi stimoli compresi prodotti
virali e batterici, radiazioni ultraviolette, radicali
ossidanti, citochine, sostanze chimiche varie.
Una volta attivato controlla direttamente l'attività
di oltre 100 geni che generano citochine, fattori di
crescita, chemochine, molecole di adesione,
proteine della fase acuta.
La prolungata attivazione di NFkB può causare
gravi condizioni infiammatorie e persino la morte
da eccessiva produzione di citochine.
La molecola di membrana
CD14
L’aspetto cruciale della immunità innata risiede nella
capacità di riconoscimento del materiale estraneo.
Il ruolo di tale riconoscimento è svolto dalle cellule
mieloidi, principalmente monociti/macrofagi, ma
anche neutrofili, ben prima della risposta adattativa dei
linfociti.
La molecola fondamentale, in questa funzione, è il
CD14, il quale è considerato il più importante tra i
recettori di ricognizione.
sCD14
Anche le cellule che non esprimono la molecola, come
gli epiteli e gli endoteli, diventano sensibili ai batteri,
in presenza della forma solubile, sCD14, prodotta dai
monociti e dagli epatociti.
Ambedue le forme, quella di membrana e quella
solubile, legano una grande varietà di prodotti
batterici, non solo il lipide A dei gram-, ma anche gli
acidi teicoici dei gram+, i glicolipidi dei micobatteri, i
diversi mannani dei funghi e anche molecole virali.
Riconoscimento
Il CD14, a differenza di tante altre molecole, che
intervengono nella risposta immunitaria, è una
proteina che non ha una localizzazione
transmembrana (ossia, non attraversa il doppio
strato lipidico dall’interno all’esterno, o viceversa),
bensì si lega esternamente alla cellula, mediante un
legame glicosil-fosfatidil-inositolo.
Il CD14, inoltre, interagisce con diversi TLRs (non
solo TLR4), nella induzione di citochine, a seguito
di una infezione virale e batterica.
Tra i virus implicati nella risposta CD14-mediata,
sono citati il cytomegalovirus, il virus respiratorio
sinciziale e quello influenzale.
Alcool e CD14
A seguito della ingestione cronica di alcool, si
liberano endotossine da parte di batteri intestinali
gram-, le quali oltrepassano l’intestino e, tramite la
circolazione sanguigna, arrivano al fegato.
A questo livello, le endotossine attivano le cellule
di Kupffer, mediante l’interazione con il CD14
localizzato alla superficie.
Il legame tra endotossina e CD14 induce,
mediante i TLRs, la produzione di citochine
infiammatorie (tramite NFkB) e radicali liberi, che
determinano un danno epatico
Tassolo
il tassolo mima i LPS batterici,
attivando i macrofagi e i monociti,
coinvolgendo il TRL4 nella traduzione del segnale,
inducendo la trascrizione di NFkB per la produzione di
citochine
Osteoartrite e CD14
I batteri gram+ mostrano proprietà artritogeniche,
correlate
alla
presenza
di
complessi
peptidoglicani/polisaccaridi della loro parete, che
utilizzano il Cd14 come recettore e mediatore nella
traduzione del segnale nella sinoviaI batteri gram+ contengono altre molecole in grado di
innescare
l’immunità
innata,
mediante
il
riconoscimento di estraneità, da parte dei
monociti/macrofagi.
Tali molecole si identificano con gli acidi teicoici e
lipoteicoici.
Anche gli streptococchi di gruppo B sono implicati in
meccanismi simili.
RECETTORI AGENTI
INFETTIVI
LPS
Gram-
CD14
Monociti/
macrofagi
RECETTORI AGENTI
INFETTIVI
Acidi
teicoici
Gram+
CD14
Monociti/
macrofagi
ANTI-RECETTORI
Anticorpo antirecettore
recettore
cellula
bersaglio
SIMILITUDINE MOLECOLARE
LPS
Gram-
Anti-CD14
SIMILITUDINE MOLECOLARE
peptido
glicani
Gram+
Anti-CD14
Anti-CD14 (T-3)
Simile di LPS e LTA
Simile di Toll-like receptor 4
Simile molecolare di batteri Gram-positivi e Gram-negativi;
malattia di Kawasaki.
Forte indicazione clinica per le flogosi acute
Uso della potenza 06 e 030LM in cps o gtt
Uso delle fiale potenziate granulari o liquide 06-018-030LM
Anti-CD14
Molecola polivalente negli stati infiammatori delle
mucose, della cute e del SNC
Uso cronico con potenziate granulari o liquide (idroalcooliche o glucosate) 06-018-030LM
Possibile associazione con antipsorici o altri farmaci
Ricadute terapeutiche
Il CD14 rappresenta il fulcro essenziale di tutto il processo
di attivazione della immunità innata, che si compie ad opera
delle cellule coinvolte (monociti/macrofagi, cellule
dendritiche).
Una volta trasdotto il segnale all’interno della cellula, il
processo di produzione delle citochine infiammatorie
diventa irreversibile.
Gli interventi terapeutici anti-infiammatori della medicina
convenzionale, per tale motivo, convergono in punto troppo
a valle dell’intero processo, poiché non impediscono
l’azione di NF-kB all’interno del nucleo.
Anti-CD14
L’azione farmacologica degli anticorpi monoclonali
anti-CD14 è conosciuta dal 1996, con i primi
esperimenti condotti sui primati, i quali misero in
evidenza il loro ruolo protettivo, in caso di shock
indotto dalla somministrazione di LPS.
Infatti, il pre-trattamento con anti-CD14, seguito dalla
infusione venosa di endotossina (375 microgr/kg/h
per 8 ore), impediva l’aumento delle citochine
infiammatorie responsabili dello shock (TNFα, IL-1β,
IL-6, IL-8)
Incredibile…ma vero
È solo nel 2001, che compare il primo lavoro su
volontari umani. In un esperimento eticamente
discutibile, condotto su 16 individui sani, vennero
somministrati 4 ng/kg di LPS, preceduti (2 ore prima)
dalla infusione venosa di anti-CD14 (1 mg/kg) o
placebo (!). I risultati furono eclatanti, per la totale
mancanza di sintomi infiammatori nei soggetti trattati.
Verbon A, et al. IC14, an anti-CD14 antibody, inhibits
endotoxin-mediated symptoms and inflammatory
responses in humans. J Immunol 2001 Mar 1; (166(5):
3599-605.
Anti-CD14 e NF-kB
Nello stesso periodo si individua il punto cruciale
dell’azione farmacologica di anti-CD14, il quale è in
grado di impedire l’attivazione del fattore NF-kB,
inibendo la trasduzione di segnale sul legame
TLR/CD14. Ciò ha permesso di utilizzare il farmaco,
con esperimenti clinici in fase I, su pazienti critici
settici, in reparti di terapia intensiva, con ottimi
risultati
Ulevitch RJ. New therapeutic targets revealed through
investigations of innate immunity. Crit Care Med 2001
Jul; 29(7 Suppl): S8-12.
Anti-CD14 06-018-030LM
Una volta affermata la decisiva azione di anti-CD14,
mediante il supporto della letteratura accreditata,
possiamo sostenere l’uso omeopatico del farmaco.
Seguendo un criterio di similitudine molecolare, antiCD14 riproduce l’immagine interna degli stimoli
infettivi, responsabili del meccanismo infiammatorio,
mimando una somiglianza patogenetica molto utile ai
fini omeopatici.
L’indicazione clinica, pertanto, è rappresentata dalla
sua complessiva azione anti-infiammatoria.
Effect of Anti-CD14 Antibody on Experimental
Periodontitis Induced by Porphyromonas gingivalis
Lipopolysaccharide Pao-Li Wang1), et al
LPS rilasciati da Porphyromonas gingivalis, un Gramnegative presente nelle tasche periodontali
infiammate, inducono riassorbimento osseo in vivo,
mediante legame con CD14.
Nei topi, tale fenomeno è inibito da un pretrattamento con anti-CD14, nelle 5 settimane
presedenti l’esposizione ai LPS.
Questo lavoro ipotizza l’uso di anti-CD14 nel
controllo delle parodontopatie anche nell’uomo.
Ann Periodontol. 2002 Dec;7(1):72-8. Interactions of oral
pathogens with toll-like receptors: possible role in
atherosclerosis. Hajishengallis G, et al
Nelle lesioni aterosclerotiche si evidenzia una
maggiore espressione di TLR, a livello di endotelio
e macrofagi, in conseguenza del legame con batteri
gram-, come Porphyromonas gingivalis.
L’induzione di questo processo è inibito da antiCD14.
Analoghe considerazioni sono fatte per
stimolazione di LPS da chlamydia pneumoniae
la
Arthritis Res Ther. 2004;6(3):R273-81. Epub 2004 Apr 27. CD14
mediates the innate immune responses to arthritopathogenic
peptidoglycan-polysaccharide complexes of Gram-positive bacterial cell
walls. Li X, et al.
I complessi peptidoglicano-polisaccaride (PG-PS),
compongono le pareti dei gram+ e utilizzano il CD14,
come recettore.
Nei topi privi di CD14 le risposte innate dei fagociti
mancano, a seguito della induzione infiammatoria di
PG-PS, con conseguente infiltrazione infiammatoria e
iperplasia della sinovia, come si verifica nei modelli
sperimentali delle artropatie
J Immunol. 2001 Dec 15;167(12):7069-76. Novel engagement of
CD14 and multiple toll-like receptors by group B streptococci.
Henneke P, et al.
Group B streptococcus (GBS) imposes a major health threat to newborn infants. Little is
known about the molecular basis of GBS-induced sepsis. Both heat-inactivated whole GBS
bacteria and a heat-labile soluble factor released by GBS during growth (GBS-F) induce
nuclear translocation of NF-kappaB, the secretion of TNF-alpha, and the formation of NO in
mouse macrophages. Macrophages from mice with a targeted disruption of MyD88 failed to
secrete TNF-alpha in response to both heat-inactivated whole bacteria and GBS-F, suggesting
that Toll-like receptors (TLRs) are involved in different aspects of GBS recognition. Immune
cell activation by whole bacteria differed profoundly from that by secreted GBS-F. Whole GBS
activated macrophages independently of TLR2 and TLR6, whereas a response to the secreted
GBS-F was not observed in macrophages from TLR2-deficient animals. In addition to TLR2,
TLR6 and CD14 expression were essential for GBS-F responses, whereas TLR1 and TLR4 or
MD-2 did not appear to be involved. Heat lability distinguished GBS-F from peptidoglycan
and lipoproteins. GBS mutants deficient in capsular polysaccharide or beta-hemolysin had
GBS-F activity comparable to that of wild-type streptococci. We suggest that CD14 and TLR2
and TLR6 function as coreceptors for secreted microbial products derived from GBS and that
cell wall components of GBS are recognized by TLRs distinct from TLR1, 2, 4, or 6.
Anti-CD14
Molecola polivalente negli stati infiammatori delle
mucose, della cute e del SNC
Uso cronico con potenziate granulari o liquide (idroalcooliche o glucosate) 06-018-030LM
Possibile associazione con antipsorici o altri farmaci
Cellula dendritica
Cellule dendritiche
Tra i meccanismi di riconoscimento del materiale estraneo, nella
immunità innata, dobbiamo considerare altri recettori di
membrana, tra cui CR3 del complemento (essenzialmente
identificato con CD11b).
La molecola CD11b fa parte di una integrina (CD11b/CD18, o
β2 integrina), che permette ai leucociti l’adesione all’endotelio
attivato e la conseguente chemiotassi, in caso di attivazione della
immunità innata.
CD11b, analogamente a quanto visto per CD14, può essere
considerato un vero e proprio sensore di agenti patogeni, i quali,
come vedremo, sono molteplici, strutturalmente diversi e
soprattutto in grado di legare la molecola in modo specifico.
40
41
Lectine C
Le cellule dendritiche rivestono un ruolo
fondamentale nel riconoscimento e nel trasporto del
materiale estraneo, dalla periferia ai linfonodi, dove
svolgono la funzione di processare e presentare
l’antigene ai linfociti vergini.
Il meccanismo iniziale di riconoscimento è uno dei
momenti più cruciali dell’immunità innata e si verifica
tramite il legame tra le lectine C delle cellule
dendritiche (in un particolare dominio di
riconoscimento) e i carboidrati espressi sulla superficie
dei microrganismi, ricchi in mannosio e galattosio.
Stimolo mediato da lectine C
A seguito di tale legame il patogeno è internalizzato e,
se lo stimolo immunogeno è sufficiente, degradato e
processato, iniziando la presentazione dell’antigene e il
riconoscimento da parte del corrispettivo linfocita T
vergine (da questo momento ha luogo la fase della
immunità acquisita).
L’HIV sfrutta, a suo vantaggio, le cellule dendritiche,
per colonizzare l’organismo ospite, dal punto di entrata
(ad esempio le mucose), fino ai linfonodi e, quindi, alle
cellule bersaglio, rappresentate dai linfociti T CD4+.
δενδρος
Le cellule dendritiche rappresentano solo lo 0,1-1% dei
mononucleati del sangue e per molto tempo la conoscenza
delle loro funzioni è rimasta oscura, a causa delle difficoltà
di studio in vitro.
È stato dimostrato che i precursori delle cellule dendritiche
possono essere di due linee: mieloide (in comune con i
monociti) e linfoide (in comune con i linfociti).
Le DC di tipo mieloide possono essere generate dalle cellule
dalla linea monocitaria a qualsiasi stadio del loro sviluppo
differenziativo/maturativo.
δενδρος
Analogamente ai precursori monocitari, anche i monociti
circolanti possono differenziare in cellule dendritiche.
Esse costituiscono un sistema complesso e inedito, capace di
indurre risposte primarie innate, organizzando e trasferendo
le informazioni patogene dall’esterno all’interno, fino alla
immunità acquisita.
Tali segnali patogeni sono vari: oltre ai microrganismi
(batteri, virus, miceti e parassiti) sono da considerare tali
anche le cellule necrotiche, quelle già precedentemente
infettate e le cellule tumorali.
Funzioni delle CD
Le cellule dendritiche di origine linfoide hanno il compito
di indurre apoptosi dei linfociti autoreattivi nel timo e di
attivare una risposta preferenzialmente Th2 (ossia allergica).
Le cellule di derivazione mieloide (che provengono
direttamente dai precursori dei monociti/macrofagi)
attivano soprattutto risposte infiammatorie di tipo Th1
(ossia infiammatorie) e si identificano per la presenza del
marcatore di membrana CD11b.
Ambedue le linee cellulari sono in grado di maturare, a
seguito del riconoscimento di materiale estraneo, fagocitare
tale materiale e produrre importanti citochine, quali
interferone-α, IL-1, IL-6, IL-7, IL-12, IL-15.
Ruolo nelle malattie croniche
La maturazione delle cellule dendritiche può accelerare
il decorso delle malattie autoimmuni, quali il lupus
eritematosus sistemicus e l’artrite reumatoide, così
come il processo di aterosclerosi descritto nei pazienti
affetti da tali malattie.
Il meccanismo patogenetico di questo fenomeno e
soprattutto
la
progressione
delle
lesioni
aterosclerotiche sembrano legate al reclutamento delle
cellule dendritiche, da parte delle piastrine, con la
mediazione del CD11b.
Inibizione della carcinogenesi
I β-glucani sono polisaccaridi, che contribuiscono alla
formazione della parete dei funghi.
I β-glucani attivano il sistema del complemento e la
funzione fagocitaria, da parte delle cellule dendritiche, dei
fagociti in generale e dei natural killer, mediante la loro
specifica interazione con il recettore CR3 (nella porzione
CD11b), posto sulla superficie della membrana plasmatica.
Il risultato di questa interazione si evidenzia con una
citotossicità aspecifica, che impedisce l’accrescimento del
tumore, la sua angiogenesi e la proliferazione metastatica.
β-glucani
I β-glucani sono stati proposti e utilizzati come adiuvanti
della chemioterapia e radioterapia, con ottimi risultati
anche sulla conseguente displasia del midollo.
Per comprendere meglio il meccanismo d’azione, è
opportuno sottolineare come le cellule tumorali non
esprimono, a differenza dei funghi, i β-glucani.
Questo aspetto spiega almeno uno dei motivi per i quali i
tumori eludono la risposta infiammatoria innata, la quale
non può essere attivata dalla via del complemento CR3mediata, che permetterebbe la opsonizzazione delle cellule
trasformate.
CD e cervello
Per molto tempo si è ritenuto, che le DC non avessero
una localizzazione cerebrale, soprattutto per la
quiescenza immunologica di questo organo in
condizioni di salute.
Tale quiescenza è dovuta, presumibilmente, alla
barriera emato-encefalica e alla conseguente mancanza
di leucociti intra-cerebrali.
In realtà, anche il sistema nervoso è suscettibile agli
stimoli infiammatori.
Dunque…
La nuova nozione di immunità cerebrale è basata sulla evidenza
sperimentale, che i linfociti T attivati entrano nel tessuto nervoso
e interagiscono con le cellule presentanti l’antigene, soprattutto
quelle dendritiche, le quali mostrano una grande capacità di
risposta infiammatoria e di espansione locale.
Questo fenomeno può essere osservato in condizioni sperimentali,
quali la toxoplasmosi e la encefalite allergica nei topi, ma anche
nell’invecchiamento cerebrale.
Nei topi è stato dimostrato, che tali cellule compaiono, a livello
centrale (cervello e midollo), a circa 12 mesi di vita e aumentano
progressivamente con l’età. Anche in questo caso, il fenotipo delle
DC è di tipo mieloide ed è espresso dal CD11b.
In patologia
Nella sclerosi multipla, le cellule dendritiche,
abbondantemente reclutate nel sistema nervoso
centrale, sono coinvolte nella induzione della risposta
autoimmune, diretta verso la mielina e nel
mantenimento della attività infiammatoria, soprattutto
nelle fasi di riacutizzazione, con il risultato della
espansione del processo lesionale demielinizzante.
Di particolare interesse anche terapeutico, a questo
riguardo, è la dimostrazione che le cellule dendritiche
sono particolarmente abbondanti nella sostanza grigia
peri-lesionale
CD e neuropatologia
L’approccio alle malattie neurologiche, soprattutto le
forme con decadimento cognitivo, deve tener conto del
meccanismo, con il quale le cellule dendritiche
intervengono nel riconoscimento di materiale estraneo
o dei prodotti di degradazione di materiale endogeno.
Questo aspetto aspetto può essere sfruttato con
vantaggio in omeopatia
CD e azione sulla cute
Tale azione risulta decisiva nel passaggio, che si verifica
frequentemente, da forme infiammatorie acute a condizioni
allergiche, soprattutto nelle forme cutanee da contatto.
Le cellule dendritiche, infatti, riconoscono, mediante i
sensori, i cosiddetti apteni, ossia gli agenti chimici che, da
soli, non sono in grado di stimolare una risposta
immunitaria specifica adattativa.
Il riconoscimento degli apteni e il loro legame con proteine
endogene permette a tali cellule di presentare ai linfociti T
la stimolazione da contatto, da cui deriva la manifestazione
cutanea, con le caratteristiche eruzioni papulo-vescicolari.
In sintesi anti-CD11b (06-018030LM)
decadimento cognitivo, dovuto a malattie degenerative
sottostanti (Alzheimer, Parkinson);
fasi di riacutizzazione della sclerosi multipla;
coadiuvante nella terapia anti-tumorale, come
attivatore della immunità innata svolta dalle cellule
dendritiche;
ipersensibilità cutanea da contatto.
Cd11b e pertosse
Anche la tossina CyaA (adenylate cyclase
toxin), uno dei principali fattori di virulenza di
bordetella pertussis, utilizza la β2 integrina
(nella porzione CD11b) come recettore
endogeno.
El-Azami-El-Idrissi M, et al. Interaction of Bordetella
Pertussis adenylate cyclase with CD11b/CD18: role of
toxin acylation and identification of the main integrin
interaction domain. J Biol Chem 2003 Oct 3; 278(40):
38514-21.
Cd11b e candida albicans
Il CR3 è costituito da una doppia molecola, rappresentata dal
binomio CD11b/CD18.
Il legame con la candida si verifica anche in assenza di CD18.
Omologia strutturale tra la catena α di CD11b e alcune molecole
presenti sulla superficie di candida albicans.
Da tale omologia deriverebbe la possibilità patogenetica di una
candidosi disseminata, la quale non si verifica nei ratti infettati,
qualora siano stati pre-trattati con anticorpi anti-CD11b.
Risultati analoghi sono stati ottenuti con anti-CD11b, inibendo
l’adesione delle ife fungine ai linfociti.
CD11b e lievito
Molto interessante è anche l’osservazione, per
la quale uno degli antigeni polisaccaridici più
importanti di saccharomyces cerevisiae, il
comune lievito, è in grado di legare il recettore
CR3 del complemento sul CD11b.
Hoestetter MK, et al. Antigenic and functional
conservation of an integrin I-domain in Saccharomyces
cerevisiae. Biochem Mol Med 1995 Aug; 55(2): 122-30.
Sacchramyces cerevisiae
Uno
degli
antigeni
polisaccaridici più importanti
di saccharomyces cerevisiae, il
comune lievito, è in grado di
legare il recettore CR3 del
complemento
CR3 è costituito da doppia
molecola, CD11b/CD18
Il lievito lega la sub-unità
CD11b
Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1108:481-8. Cross-reactive epitopes on
beta2-glycoprotein-I and Saccharomyces cerevisiae in patients with the
antiphospholipid syndrome. Krause I et al.
Anti-Saccharomyces
cerevisiae
sono
considerati un buon marcatore per la
malattia di Crohn.
Tali anticorpi possono positivizzare antibeta2GPIIl meccanismo invocato è il mimetismo
molecolare
60
Biochem J. 2005 Apr 15;387(Pt 2):411-7. Peptide mimotopes of
Mycobacterium tuberculosis carbohydrate immunodeterminants.
Gevorkian G, et al.
La sequenza QEPLMGTVPIRAGGGS è
contenuta negli antigeni mannani della
parete di Mycobacterium tuberculosis
Tale sequenza è presnte anche nei mannani
di saccharomyces cerevisiae
Reattività crociata di anticorpi su entrambi,
per mimetismo molecolare
61
Clin Exp Immunol. 2003 Oct;134(1):86-91. cDNA cloning,
expression and characterization of an allergenic L3 ribosomal protein
of Aspergillus fumigatus. Saxena S et al
Determinanti immunogeni di aspergillus
fumigatus mostrano una omologia del 72%
con analoghi di saccharomyces cerevisiae
Tali determinanti sono in grado di suscitare
risposte allrgiche IgE-mediate
Questo fenomeno può contribuire al
mantenimento delle allergie, mediante
l’assunzione di lieviti
62
J Immunol. 1989 Mar 1;142(5):1512-7. Molecular mimicry. Yeast
histone H3-induced experimental autoimmune uveitis.
Singh VK, et al
Nel modello sperimentale della uveite
autoimmune si utilizza, per l induzione
dellamalattia, una proteina retinica,
denominata S-Ag
Nei ratti Lewis ono stati indotti stati simili
con una sequenza di AA da 106 a 121 degli
istoni di lievito
Tale sequenza è identica a quella contenuta
in S-Ag, per mimetismo molecolare
63
Sifilide di Hunter e CD11b
Anche le leptospire legano il CR3 espresso dalle DC,
sulla prorzione CD11b.
Lo stesso dicasi per borrelia burgdorferi, che aderisce
alle cellule fagocitarie.
Le cellule epiteliali del collo dell’utero esprimono il
CR3.
Il CD11b è utilizzato dal gonococco come recettore,
mediante specifici siti di legame, peraltro identificati
nel lipide A, che entra a costituire l’insieme dei
lipopolisaccaridi.
64
CD11b e HIV
Di estremo interesse è anche la dimostrazione che gli
anticorpi monoclonali anti-CD11b sono in grado di
inibire il legame della molecola gp41, che si trova sulla
superficie (envelope) del virus HIV, con CR3.
Considerando che questo legame assume un significato
critico nella fusione del virus con il linfocita CD4+, ne
consegue l’importanza strategica di tutte le successive
fasi della infezione.
Mycobacterium tbc e CD11b
L’invasione di mycobacterium tuberculosis nei
fagociti mononucleati è dovuta al legame del
batterio con il CR3, proprio nella porzione del
CD11b.
Ciò indica un ruolo importante della
immunità innata nelle condizioni in cui si
riattiva un processo tubercolare lontano nel
tempo, a seguito di fattori scatenanti molteplici.
66
HSV e CD11b
Inoltre, si deve dare risalto alla capacità del virus
herpetico HSV-1 di legare il CR3, nella porzione
CD11b, mediante la glicoproteina C.
Anche in questo caso, il legame del virus al recettore
del complemento permette l’evasione dell’agente
patogeno dalla risposta innata, con la conseguenza di
una riattivazione, che si traduce, clinicamente, nella
classica eruzione alle labbra
67
Leishmania e CD11b
Le diverse specie di Leishmania sono in grado di
interagire con le cellule della immunità innata.
I promastigoti, infatti, legando il CR3, sono in grado
di sopravvivere e replicare negli ospiti vertebrati.
Questo fenomeno non si osserva per i parassiti, che si
trovano nello stadio di amastigoti.
68
Immunologia e cervello
Per molto tempo si è ritenuto che le DC non avessero una
localizzazione cerebrale, soprattutto per la quiescenza
immunologica di questo organo in condizioni di salute.
Tale quiescenza è dovuta, presumibilmente, alla barriera
emato-encefalica e alla conseguente mancanza di leucociti
intra-cerebrali. In realtà, anche il sistema nervoso è
suscettibile agli stimoli infiammatori.
La nuova nozione di immunità cerebrale è basata sulla
evidenza sperimentale che i linfociti T attivati entrano nel
tessuto nervoso e interagiscono con le cellule presentanti
l’antigene, soprattutto quelle dendritiche, le quali mostrano
una grande capacità di risposta infiammatoria e di
espansione locale.
69
Invecchiamento cerebrale e
DC
L’invecchiamento cerebrale si accompagna a un
aumento della attività infiammatoria, legato
essenzialmente alla presenza di cellule dendritiche
e linfociti T.
Nei topi è stato dimostrato che tali cellule
compaiono, a livello centrale (cervello e midollo) a
circa 12 mesi di vita e aumentano
progressivamente con l’età. Anche in questo caso,
il fenotipo delle DC è di tipo mieloide ed è
espresso dal CD11b.
70
Sclerosi multipla e CD11b
Nella sclerosi multipla, le cellule dendritiche sono
reclutate nel snc e coinvolte nella risposta anti-mielina.
Ciò si verifica nelle fasi di riacutizzazione, con il
risultato della espansione del processo lesionale
demielinizzante.
Le cellule dendritiche, d’altra parte, sono
particolarmente abbondanti nella sostanza grigia perilesionale.
71
Anti-CD11b
Anticorpo monoclonale diretto contro CD11b
(parte della β2-integrina: CD11b/CD18).
anti-recettore della immunità innata delle DC
Ruolo anti-infiammatorio delle fasi
riacutizzazione di una malattia cronica
72
di
Indicazioni cliniche di anti-CD11b
Riacutizzazione delle infiammazioni
croniche (di tipo infettivo)
Simile molecolare (anti-recettore)
numerosi agenti patogeni
Protezione
aspecifica
metastatizzazione dei tumori
di
dalla
73
Schema terapeutico
Potenziate granulari o liquide
06LM, 018LM, 030LM
Una volta al giorno, seguendo la numerazione
progressiva
Si può ripetere il ciclo, dopo una pausa (7-10 giorni)
74
Similitudine molecolare di anti-CD11b
candida albicans (forme acute ricorrenti, come mughetto,
vaginiti, etc.);
saccharomyces cerevisiae (intolleranza al lievito presente
negli alimenti);
bordetella pertussis (tossina CyaA);
HSV-1 (recettore della glicoproteina C, implicata nella
riacutizzazione della eruzione herpetica alle labbra);
leishmania (fasi di riacutizzazione della infezione cronica,
anche negli animali).
Similitudine molecolare di anti-CD11b
leptospira;
neisseria gonorrheae;
borrelia burgdorferi (fasi secondarie, tipo artrite reattiva,
forme demielinizzanti e altre);
HIV (recettore di gp41, ossia della glicoproteina, che
permette l’ancoraggio del virus al CD4 T linfocita, nelle fasi
iniziali del contagio);
mycobacterium tuberculosis (fasi di riacutizzazione di un
processo tubercolare).
Linfociti T γ/δ
Si localizzano, preferenzialmente, nell’ambito dell’epitelio,
costituendo una classe di linfociti, denominata IEL (Intra
Epithelial Lymphocytes).
Solo il 5% circa dei linfociti T circolanti ha un TCR di tipo
γ/δ, contro il 95% rappresentato da α/β
Tale rapporto si inverte a livello tissutale, soprattutto
nell’ambito dei linfociti IEL.
È stato dimostrato, che i linfociti γ/δ possono essere
direttamente generati nel contesto degli epiteli, unico
esempio di cellula mieloide non proveniente dal midollo.
Funzione dei linfociti T γ/δ
Contribuiscono alla difesa immunitaria immediata in corso di
infezione o neoplasia, mediante la produzione di citochine,
chemochine, molecole anti-batteriche e citotossicità.
La maggior parte dei γ/δ di sangue periferico esprime il fenotipo
Vγ9/Vδ2, il quale è in grado di riconoscere molecole (piro)fosfate
a concentrazioni picomolari, generate da batteri e parassiti,
analogamente a quanto avviene per i polifosfati utilizzati nella
catena alimentare, per la conservazione dei cibi.
Per la loro capacità di legare i linfociti γ/δ, dunque, i polifosfati si
comportano come veri e propri superantigeni, i quali
interagiscono non solo con il TCR, ma anche con le cellule
dendritiche, contribuendo direttamente alla genesi della
immunità innata e adattativa.
Fenotipo dei linfociti γ/δ
Nei topi è stato osservato, che la popolazione di IEL γ/δ
marcata con CD44 è in grado di riconoscere i superantigeni
rilasciati dai batteri intestinali.
La capacità di risposta dei γ/δ può essere studiata in vivo,
con i modelli umani e animali di infezione, utilizzando,
soprattutto, i lipopolisaccaridi (LPS).
Entrambe le popolazioni, α/β e γ/δ, rispondono allo
stimolo con una espansione policlonale dei linfociti T
attivati.
Tale risposta, evidenziata con una maggiore espressione di
CD44+ è nettamente più significativa per i γ/δ, rispetto agli
α/β e può risultare anche da una diretta stimolazione di
TNFα.
Eczema
Lichenificazione
IEL
Si legano al
collagene, tramite
integrine
Riconoscono gli antigeni
presentati dai macrofagi e
dalle cellule epiteliali
dell’intestino
Aumentano nelle
allergie
gastrointestinali
Derivano dal midollo, ma
maturano il TCR nel
MALT extratimico
Non modificano il
numero e la funzione
con l’amento dell’età
Anti-CD44
Aggravamenti da
antigeni
polifosforici
valutazione
dello switch
IgG->IgE
strepto,
staphylo
TCR/γδ
IEL
ATOPIA
CD44
H-CAM (hyaluronan cell adhesion molecule)
Aggregazione cellula-cellula, cellula-matrice, segnale cellula-matrice,
internalizzazione recettore-mediata, degradazione acido jaluronico
CD44
Homing Cellular Adhesion Molecule
Lega collagene, fibronectina e altre molecole
Epitelio, endotelio, cellule stromali ed ematopoietiche
Hyaluronan (HA)
Osteopontin (OPN)
CD44
CD44
ankyrin
Cell adhesion
ankyrin
Migration
Anti-CD44
Simile molecolare dei superantigeni, che si
legano ai linfociti γ/δ
Simile molecolare delle cheratine (psoriasi,
eczemi)
Soprattutto i sali polifosforici
Uso delle potenziate ascendenti 06-018-030LM
Terapia di due mesi, con la possibilità di ripetere
il ciclo.