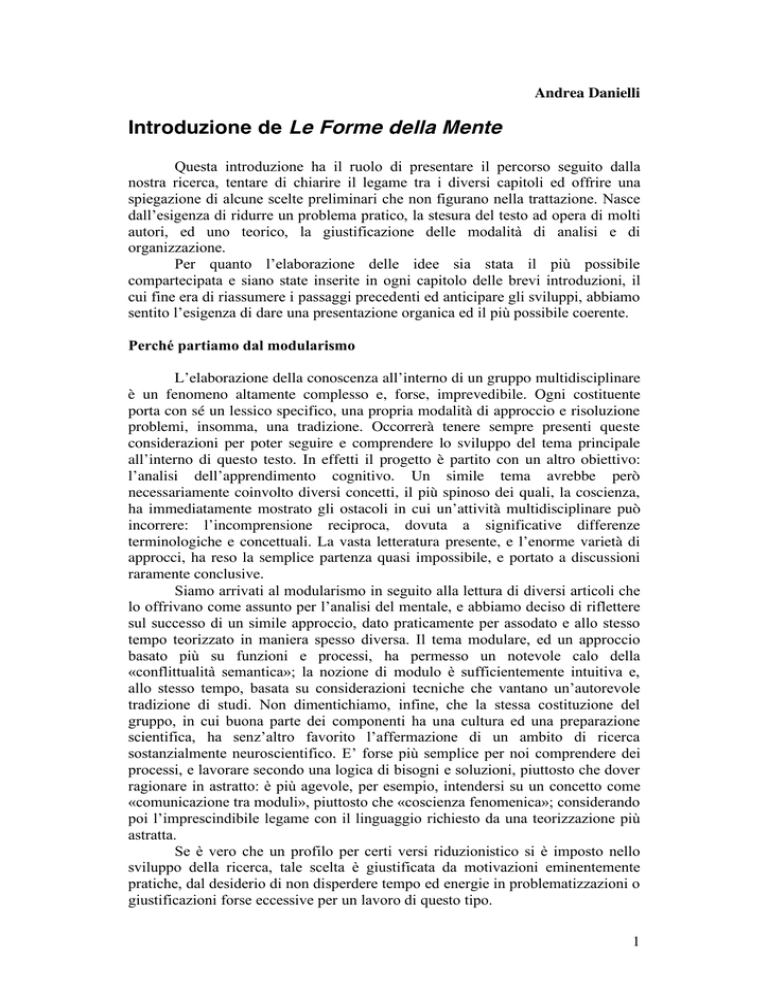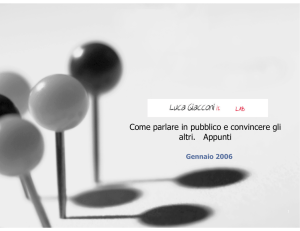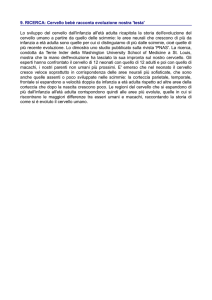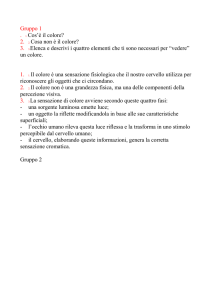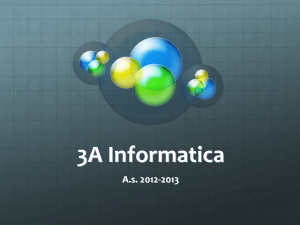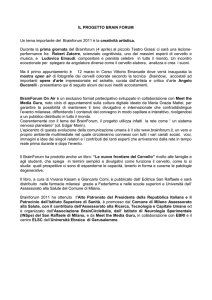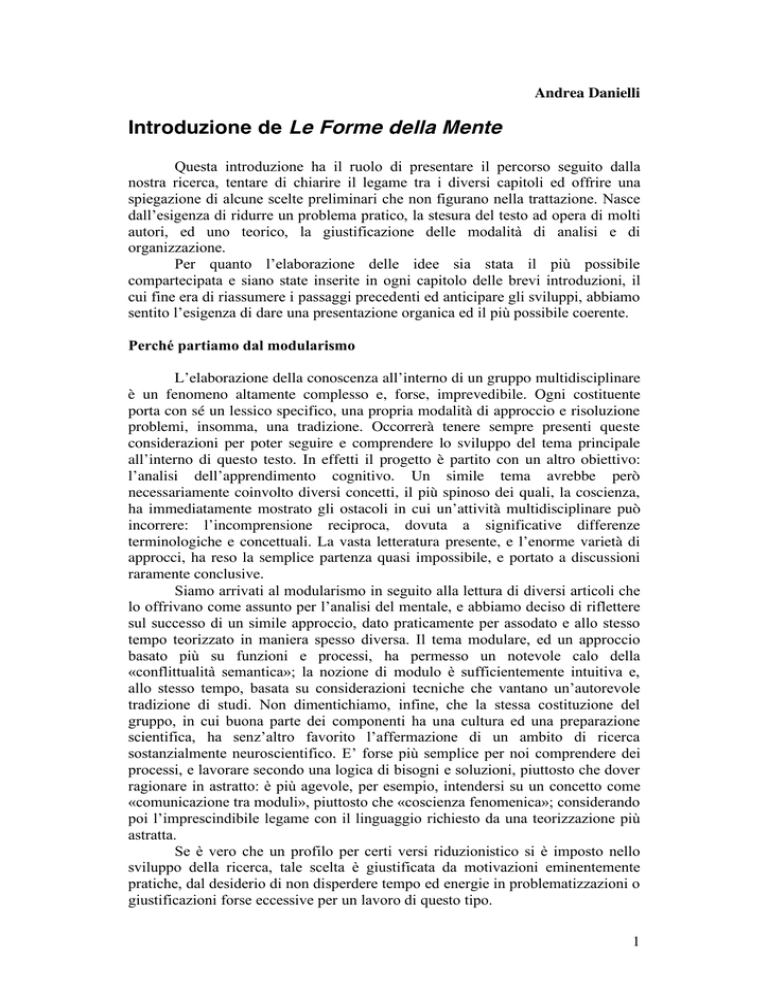
Andrea Danielli
Introduzione de Le Forme della Mente
Questa introduzione ha il ruolo di presentare il percorso seguito dalla
nostra ricerca, tentare di chiarire il legame tra i diversi capitoli ed offrire una
spiegazione di alcune scelte preliminari che non figurano nella trattazione. Nasce
dall’esigenza di ridurre un problema pratico, la stesura del testo ad opera di molti
autori, ed uno teorico, la giustificazione delle modalità di analisi e di
organizzazione.
Per quanto l’elaborazione delle idee sia stata il più possibile
compartecipata e siano state inserite in ogni capitolo delle brevi introduzioni, il
cui fine era di riassumere i passaggi precedenti ed anticipare gli sviluppi, abbiamo
sentito l’esigenza di dare una presentazione organica ed il più possibile coerente.
Perché partiamo dal modularismo
L’elaborazione della conoscenza all’interno di un gruppo multidisciplinare
è un fenomeno altamente complesso e, forse, imprevedibile. Ogni costituente
porta con sé un lessico specifico, una propria modalità di approccio e risoluzione
problemi, insomma, una tradizione. Occorrerà tenere sempre presenti queste
considerazioni per poter seguire e comprendere lo sviluppo del tema principale
all’interno di questo testo. In effetti il progetto è partito con un altro obiettivo:
l’analisi dell’apprendimento cognitivo. Un simile tema avrebbe però
necessariamente coinvolto diversi concetti, il più spinoso dei quali, la coscienza,
ha immediatamente mostrato gli ostacoli in cui un’attività multidisciplinare può
incorrere: l’incomprensione reciproca, dovuta a significative differenze
terminologiche e concettuali. La vasta letteratura presente, e l’enorme varietà di
approcci, ha reso la semplice partenza quasi impossibile, e portato a discussioni
raramente conclusive.
Siamo arrivati al modularismo in seguito alla lettura di diversi articoli che
lo offrivano come assunto per l’analisi del mentale, e abbiamo deciso di riflettere
sul successo di un simile approccio, dato praticamente per assodato e allo stesso
tempo teorizzato in maniera spesso diversa. Il tema modulare, ed un approccio
basato più su funzioni e processi, ha permesso un notevole calo della
«conflittualità semantica»; la nozione di modulo è sufficientemente intuitiva e,
allo stesso tempo, basata su considerazioni tecniche che vantano un’autorevole
tradizione di studi. Non dimentichiamo, infine, che la stessa costituzione del
gruppo, in cui buona parte dei componenti ha una cultura ed una preparazione
scientifica, ha senz’altro favorito l’affermazione di un ambito di ricerca
sostanzialmente neuroscientifico. E’ forse più semplice per noi comprendere dei
processi, e lavorare secondo una logica di bisogni e soluzioni, piuttosto che dover
ragionare in astratto: è più agevole, per esempio, intendersi su un concetto come
«comunicazione tra moduli», piuttosto che «coscienza fenomenica»; considerando
poi l’imprescindibile legame con il linguaggio richiesto da una teorizzazione più
astratta.
Se è vero che un profilo per certi versi riduzionistico si è imposto nello
sviluppo della ricerca, tale scelta è giustificata da motivazioni eminentemente
pratiche, dal desiderio di non disperdere tempo ed energie in problematizzazioni o
giustificazioni forse eccessive per un lavoro di questo tipo.
1
Il modularismo, il connessionismo
Il modularismo è nato in una favorevole situazione nel panorama degli
studi sulla mente, durante gli anni ruggenti del funzionalismo e delle scienze
cognitive, tra gli anni ’70 e ’80. Il funzionalismo, detto brevemente, vedeva la
mente come un software che girava sul cervello (hardware), ed era ovviamente
influenzato dal grande ottimismo che circolava intorno alla nascente Intelligenza
Artificiale. Il comportamentismo poi era stato definitivamente sconfitto dalle
rivoluzioni che avrebbero dato vita alle scienze cognitive. In questo quadro il
modularismo si è proposto come la migliore piattaforma hardware possibile: i
teorici modularisti hanno ideato una concezione capace di gettare un ponte tra
ambiti molto distanti: informatica, psicologia e neurologia. In effetti gli studi
anatomici e quelli sulle lesioni cerebrali avevano da tempo evidenziato differenze
nelle aree cerebrali per quanto riguardava le funzioni svolte. Ora era possibile
comprendere il senso di queste differenze. Il definitivo trionfo del modularismo
sembrò arrivare con l’invenzione della risonanza magnetica funzionale (fMRI in
inglese). Con la sua comparsa, la fMRI ha permesso di collegare il piano
funzionale e teorico a quello fisiologico, localizzando le aree specifiche secondo il
principio del «sono attive, quindi stanno funzionando» e misurando l’attività in
ogni tipo di compito cognitivo (ed emotivo) possibile. Si è arrivati ad avere un
discreta mappatura delle funzioni cerebrali: l’area delle emozioni, l’area per il
linguaggio, l’area per i volti, arrivando poi ad aree più esotiche, quale l’area degli
scacchi o quella per le automobili… [cfr. Peissig, Tarr 2007, 89]. Molti studi
hanno cercato i neuroni di Dio, altri hanno analizzato i dilemmi etici, altri ancora
hanno indagato i profondi motivi che spingono un consumatore ad acquistare la
Coca Cola piuttosto che la Pepsi [cfr. Dobbs 2005]. Le moderne neuroscienze
hanno ripreso l’antico progetto frenologico di Franz Joseph Gall. Il titolo di uno
studio è indicativo del tipo di indagini che ha iniziato a proliferare: «Sistemi di
gratifica, motivazione ed emotività associati con i primi stadi di intenso amore
romantico1». Probabilmente ha pesato molto un certo tipo di riduzionismo, o
anche le stesse modalità di ricerca, così interessate al «risultato»: una
localizzazione sembra sempre un ottimo risultato. Ma questo modo di procedere
ha lasciato fuori tutto ciò per cui non si è trovata una valida localizzazione. La
coscienza, ad esempio, rimane una grande esclusa.
Partendo da ciò che è stato escluso, alcuni autori hanno cominciato a
criticare le modalità di indagine, e gli stessi strumenti di brain imaging o i metodi
di inferenza statistica. Inoltre sono entrate in crisi molte delle basi teoriche del
funzionalismo: l’Intelligenza Artificiale forte ha perso la sua sfida di creare robot
pensanti, visti i risultati ancora insoddisfacenti nel simulare capacità umane;
mentre dall’altro lato le neuroscienze sembrano attirare maggiormente
l’attenzione, si prestano ad analisi filosofiche (ad esempio i neuroni specchio), si
allargano ad interessanti contaminazioni (economia e studi sulla presa di
decisione), e vengono continuamente diffuse sui mass media le continue scoperte.
Partendo dalla concezione classica di modularismo ne abbiamo criticato
alcuni degli aspetti fondanti: la specificità di dominio e l’impenetrabilità; detto
rapidamente, il fatto che un modulo si identifichi in base alla funzione (unica) che
svolge, e l’impossibilità per altri moduli di influenzare l’elaborazione che avviene
1
[Aron et al. 2005]; altri articoli si possono trovare su: http://www.jsmf.org/badneuro/.
2
al suo interno. Ciò che cercavamo era un concetto di modulo molto più elastico, in
grado di adattarsi alla particolarità dei compiti richiesti. Un modulo cioè che nasce
di volta in volta per rispondere a problemi mediante delle funzioni, autoorganizzandosi, e non un modulo strutturalmente predisposto e specializzato,
ereditato geneticamente. In secondo luogo, l’idea di modularità richiede che un
compito sia scomposto tra diversi moduli: ci interessava capire come possa
avvenire simile scomposizione e come i moduli comunichino tra loro. Dal nostro
punto di vista, cercavamo un’architettura capace di combinare specializzazione e
flessibilità. La specializzazione risiede nell’area cerebrale (localizzazione) mentre
la flessibilità viene data dalla quantità e dalla distribuzione dell’attività neurale
all’interno dell’area2.
La sincronizzazione
Riteniamo una soluzione combinatoria il miglior approccio in grado di
spiegare l’adattabilità e l’enorme capacità di risposta del cervello alle variazioni
ambientali. Ma la combinazione richiede l’analisi di meccanismi di integrazione.
In questa prospettiva ci siamo avvicinati alla sincronizzazione. I primi studi
incontrati, quelli di Lehmann, sembravano fare al caso nostro: i suoi microstates
appaiono legati alla funzione svolta, e quindi sembrano essere il prodotto di
un’attività che risponde agli stimoli e si plasma in base ad essi. I microstates sono
il frutto di moduli dai confini più elastici? Potrebbero essere moduli che si
organizzano sincronizzandosi in un certo modo, potendo così rispondere con una
sufficiente variabilità. Il problema di una simile concezione a nostro avviso sta nel
metodo che serve per rilevare i microstates: l’inferenza statistica e l’assunto di
base che aree funzionanti ad una stessa frequenza siano implicate nelle medesime
funzioni. Ragionamenti simili a quelli di Lehmann, ma ad un livello più globale,
si trovano nei lavori dei Fingelkurtz: il concetto di connettività funzionale, nei
loro studi, sembrava utile, a noi che provenivamo dal modularismo, per teorizzare
la sincronizzazione come un potente linguaggio del pensiero. Pensare che la
sincronizzazione sia così determinante ci ha spinto ad interrogarci sulle sue
origini. Ci siamo domandati se nel cervello esista un sistema di comunicazione
come quello costituito dalla rete telefonica: prima di comunicare due o più aree
devono sincronizzarsi, per permettere un’interpretazione corretta dei patterns di
scarica? Fortunatamente abbiamo incontrato alcuni autori critici verso un simile
modo di procedere. Abbiamo riservato una particolare attenzione all’origine della
sincronizzazione proprio per tentare di capire se sia una condizione necessaria allo
scambio di informazione nel cervello, o se piuttosto non sia una «conseguenza
virtuosa» dell’attività di elaborazione. La simulazione ci è servita per cominciare
ad esplorare questo campo sterminato. E’ stata rivolta soprattutto ad indagare il
fenomeno secondo una prospettiva eminentemente sistemica: costruendo un
sistema formato da neuroni inibitori ed eccitatori, in che modo si organizza e trova
un suo equilibrio dinamico? La risposta è stata: sincronizzandosi.
Se la sincronizzazione è un prodotto di elaborazione di un sistema
dinamico è necessario indagare nuove forme di relazione tra aggregati neurali.
Seguendo questo percorso non si deve dimenticare il ruolo e l’importanza della
Per comprendere meglio questa ipotesi rimandiamo agli studi sulle aree visive deputate al
riconoscimento di oggetti: per esempio Tanaka [1996].
2
3
gerarchizzazione di molte aree3, l’effetto dell’eredità e dei percorsi neurali
priviliegiati. Non significa certo tornare al modularismo, ma evitare una eccessiva
dispersione nell’elaborazione dell’informazione. Occorre quindi trovare una via
che permetta di combinare le diverse caratteristiche del cervello, la
gerarchizzazione e l’elasticità, la velocità di elaborazione e la grande varietà di
funzioni.
Le rappresentazioni distribuite
A nostro avviso si deve combinare un’aggregazione locale ad una
comunicazione globale. Nel capitolo 5 attribuiamo alla rappresentazione il ruolo
di aggregatore locale (per le popolazioni neurali), mentre la comunicazione tra
rappresentazioni è resa possibile dall’astrattezza del codice neurale, costituito
dall’insieme dei patterns di scarica (una sorta di codice morse, si capirà meglio in
seguito). Per intraprendere questa strada abbiamo seguito un esempio concreto e
specifico: le relazioni tra rappresentazioni audio e video. Questo sia per la
letteratura disponibile (psicologica e neuroscientifica) sia per l’interesse
filosofico, dato che vengono sfiorati temi quali la coscienza e la concettualità. Le
rappresentazioni si costituiscono per rispondere allo stimolo nella sua specificità,
la comunicazione tra rappresentazioni è invece l’elaborazione vera e propria. I
principi guida, nella stesura del capitolo, sono stati i seguenti: una parte del
cervello può organizzare un’altra parte, i principi gerarchici servono per astrarre i
codici di comunicazione, le relazioni tra popolazioni neurali avvengono secondo
principi dinamici (gli attrattori caotici possono essere un utile strumento per
trattarne la dinamica).
Naturalmente molto lavoro deve essere fatto, stiamo preparando ora una
simulazione del modello proposto per conferire maggiore sostegno a quella che è
soprattutto una speculazione teorica.
Le riflessioni estese
Pur costituendo il risultato di un lavoro di approfondimento condiviso da
tutti gli appartenenti al Gruppo Mente, questo libro si divide, nella sostanza, in tre
parti. Ai primi quattro capitoli, che affrontano, delineandone gli aspetti
maggiormente problematici, l’argomento principale della nostra indagine – il
modularismo –, seguono due capitoli di approfondimento specifico su tematiche
di estrema attualità, strettamente legate all’analisi funzionale della fisiologia
cerebrale, nonché un ultimo capitolo di riflessione – non solo metodologica – sul
lavoro svolto e sui risultati concreti raggiunti. Una simile strutturazione del lavoro
nasce da motivazioni differenti, interne ed esterne alla costituzione del Gruppo.
Da un punto di vista strettamente interno, innanzitutto, – nell’ottica della diversa
formazione degli appartenenti al Gruppo – è sembrato giusto favorire non solo
l’approfondimento di tematiche (forse) di più ampio respiro, ma anche
l’espressione di idee per alcuni aspetti eterogenee, nel rispetto dell’autonomia,
della cultura e della libertà intellettuale di tutti i costituenti. D’altro canto,
riteniamo che una simile soluzione risponda perfettamente alle due concezioni del
multidisciplinare: un tema sviluppato da prospettive diverse, e, al contempo,
3
Cfr. per quanto riguarda il sistema visivo Hubel e Wiesel [1962].
4
diversi argomenti trattati secondo uno sfondo teorico simile, nel nostro caso il
paradigma modulare.
Come spesso, del resto, la forma delle cose non rappresenta soltanto il
risultato applicativo della fase di progettazione del lavoro, ma è il frutto di una
serie di eventi di natura forse anche casuale, così il nostro libro ha assunto la
propria struttura con il tempo, in conseguenza di ulteriori discussioni, critiche,
revisioni incrociate ed altri eventi di diversa natura.
Una parola mancante: conclusioni
A nostro avviso i motivi principali per cui questo libro merita di essere
letto stanno nel tentativo di criticare e comprendere delle concezioni
estremamente influenti, quali quella modulare e quella connessionista, e nella
proposta di strade alternative che possano portare al superamento di una
dicotomia forse estremizzata. Riteniamo importante poi il lavoro di sistemazione
tentato su un tema come la sincronizzazione, lavoro che cerca di rendere noti i
frutti di ricerche praticamente contemporanee, in questo facendo un’opera che è
rara in filosofia della mente: parlare delle novità davvero recenti. Infatti
solitamente i filosofi trattano argomenti superati (studiano la macchina di Turing
ma non conoscono bene le reti neurali) oppure si concentrano solo su alcuni
fenomeni, ne è a nostro avviso un esempio il blindsight per quanto riguarda gli
studi sulla coscienza. Tema molto discusso, se non abusato, a danno di una gran
mole di interessanti dati neurologi e psicologici ampiamente sottovalutati e
sconosciuti.
Non possiamo assolutamente considerare il capitolo 5 un tentativo di
conclusioni: il suo ruolo è essenzialmente propositivo, vogliamo offrire degli
spunti. Le ricerche sul modello proposto stanno infatti proseguendo.
I capitoli dedicati al modularismo e al suo contributo nell’estetica e nel
diritto hanno a nostro avviso il notevole pregio di introdurre in Italia un insieme di
studi ancora nascenti e dalle considerevoli prospettive di sviluppo.
5
Riferimenti bibliografici
Aron A., Fisher H., Mashek D.J., Strong G., Li H., Brown L.L.
2005
«Reward, motivation, and emotion systems associated with
early-stage intense romantic love», J. Neurophysiol., vol.
94, pp. 327-337.
Dobbs, D.
2005
«Frenologia o realtà», Mente e Cervello, n. 16, pp. 80-85.
Hubel D.H., Wiesel, T.N.
1962
«Receptive fields, binocular interaction and functional
architecture in the cat's visual cortex», J. Physiol., vol. 160,
pp. 106-54.
Peissig, J. J., Tarr, M.J.
2007
«Visual object recognition: do we know more now than we
did 20 years ago?», Annu. Rev. Psychol., vol. 58, pp. 75-96.
Tanaka, K.
1996
«Inferotemporal cortex and object vision», Annual Review
Neuroscience, vol. 19, pp. 109-139.
6