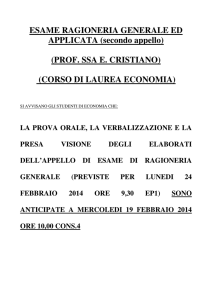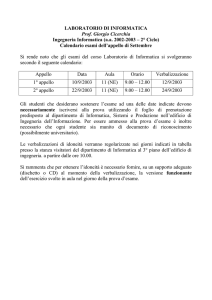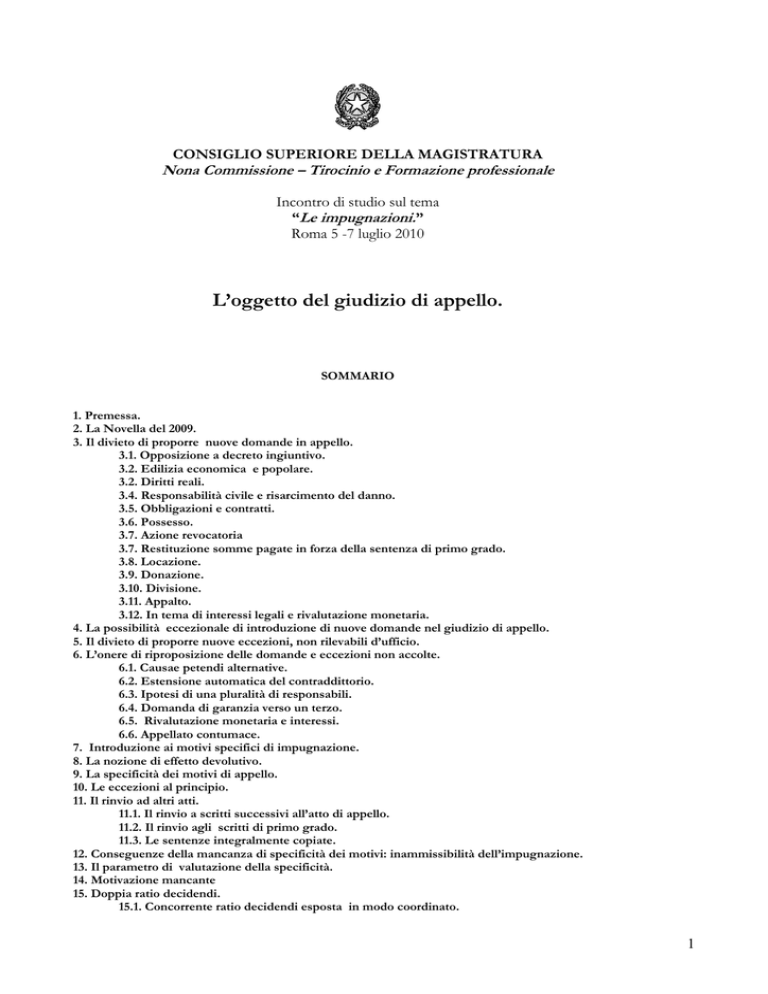
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Nona Commissione – Tirocinio e Formazione professionale
Incontro di studio sul tema
“Le impugnazioni.”
Roma 5 -7 luglio 2010
L’oggetto del giudizio di appello.
SOMMARIO
1. Premessa.
2. La Novella del 2009.
3. Il divieto di proporre nuove domande in appello.
3.1. Opposizione a decreto ingiuntivo.
3.2. Edilizia economica e popolare.
3.2. Diritti reali.
3.4. Responsabilità civile e risarcimento del danno.
3.5. Obbligazioni e contratti.
3.6. Possesso.
3.7. Azione revocatoria
3.7. Restituzione somme pagate in forza della sentenza di primo grado.
3.8. Locazione.
3.9. Donazione.
3.10. Divisione.
3.11. Appalto.
3.12. In tema di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. La possibilità eccezionale di introduzione di nuove domande nel giudizio di appello.
5. Il divieto di proporre nuove eccezioni, non rilevabili d’ufficio.
6. L’onere di riproposizione delle domande e eccezioni non accolte.
6.1. Causae petendi alternative.
6.2. Estensione automatica del contraddittorio.
6.3. Ipotesi di una pluralità di responsabili.
6.4. Domanda di garanzia verso un terzo.
6.5. Rivalutazione monetaria e interessi.
6.6. Appellato contumace.
7. Introduzione ai motivi specifici di impugnazione.
8. La nozione di effetto devolutivo.
9. La specificità dei motivi di appello.
10. Le eccezioni al principio.
11. Il rinvio ad altri atti.
11.1. Il rinvio a scritti successivi all’atto di appello.
11.2. Il rinvio agli scritti di primo grado.
11.3. Le sentenze integralmente copiate.
12. Conseguenze della mancanza di specificità dei motivi: inammissibilità dell’impugnazione.
13. Il parametro di valutazione della specificità.
14. Motivazione mancante
15. Doppia ratio decidendi.
15.1. Concorrente ratio decidendi esposta in modo coordinato.
1
15.2. Concorrente ratio decidendi esposta in modo incidentale.
15.3. Concorrente affermazione esposta con perplessa equivocità, in modo incidentale.
15.4. Concorrente affermazione esposta con perplessa equivocità, in modo chiaramente
pleonastico.
16. Motivazione esorbitante.
17. Motivi processuali.
17.1. Motivi processuali comportanti la rimessione al primo giudice.
17.2. Motivi processuali non comportanti la rimessione al primo giudice.
17.3. Il caso particolare della nullità della citazione di primo grado per vizio dell’editio
actionis.
17.4. Il divieto di rilievo d’ufficio delle nullità non formali.
18. Motivi di carattere istruttorio.
18.1. Motivi istruttori attinenti all’acquisizione del materiale probatorio.
18.2.. Motivi istruttori finalizzati all’integrazione delle acquisizioni istruttorie.
18.3. Mancata ammissione da parte del giudice di una prova già dedotta in primo grado
18.4. Motivi istruttori comportanti la deduzione di nuove prove in appello.
18.5. Il motivo istruttorio basato su documento avversario non depositato.
19. Motivi in diritto.
20. Motivi attinenti alla nullità, annullabilità, inefficacia di negozi giuridici.
21. Motivi attinenti alla qualificazione giuridica.
21.1. Il potere – dovere di preventiva qualificazione giuridica della domanda.
21.2. I contrasti giurisprudenziali circa la possibilità di riqualificazione giuridica della
domanda da parte del giudice di appello in difetto di proposizione di specifico motivo.
22. Motivi in fatto: valutazione delle prove acquisite.
23. Motivi attinenti alla mancata disposizione, integrazione, rinnovazione della c.t.u.
23.1. I principi generali in tema di rapporti fra giudice e c.t.u.
23.2. Motivi inerenti la mancata disposizione della c.t.u.
23.3. Motivi inerenti la mancata integrazione della c.t.u.
23.4. Motivi inerenti la mancata rinnovazione della c.t.u. o il mancato esercizio dei poteri
sostitutivi del giudice quale peritus peritorum.
25. Motivi anomali o subdoli: impliciti, obliqui, inconsapevoli, ricostruiti.
25.1. Motivi impliciti.
25.2. I motivi obliqui.
25.3. I motivi inconsapevoli.
25.4. I motivi ricostruiti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Premessa.
L’argomento della relazione, ossia l’oggetto del giudizio di appello, appare, sia pur di poco,
più ampio di quello a cui avevo dedicato un precedente lavoro, “I motivi di impugnazione in
appello ex art.342 c.p.c.”1, che ha costituito una sorta di compendio conclusivo della mia
esperienza decennale di giudice di appello presso la Corte di Torino; agli argomenti trattati in
quella relazione, che – debitamente aggiornata - costituirà pur sempre il nucleo essenziale del
presente lavoro, debbono essere aggiunte alcune riflessioni sui c.d. nova in appello, con
riferimento quindi all’istituto disciplinato dall’art.345 c.p.c.
Ciò porterà a esaminare tre diversi temi:
• il divieto di proporre nuove domande;
• la possibilità eccezionale di introduzione di nuove domande;
• il divieto di proporre nuove eccezioni, non rilevabili d’ufficio.
L’analisi verterà pertanto sul divieto di introdurre nuovi versanti di indagine, che scaturisce
dalla generale previsione che preclude – salvo eccezioni - l’introduzione di nuove domande
ed eccezioni che non abbiano formato oggetto già del giudizio di primo grado.
E’ bene sin d’ora precisare che tale divieto, che mira a far sì che l’oggetto del giudizio di
appello non sia più ampio del giudizio di primo grado, è espressione del principio del doppio
Divulgata all’inizio del 2009 ai Colleghi del Distretto di Torino attraverso i Referenti della locale formazione
decentrata e tema di illustrazione negli interventi effettuati agli incontri di studio promossi rispettivamente dai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Torino, Acqui Terme e Asti.
1
2
grado di giurisdizione di merito, che non gode tuttavia di dignità costituzionale (cfr artt.24 e
11, specialmente comma 6, Cost.)2.
Un secondo fronte dovrà essere dedicato invece alla necessità, sancita a carico della parte
interessata dall’art.346 c.p.c., di riproporre in appello domande ed eccezioni proposte in primo
grado; attraverso l’interpretazione di questa norma e grazie allo studio sistematico dei motivi
di impugnazione si potranno comprendere i meccanismi processuali che possono circoscrivere
e limitare l’oggetto del giudizio di appello rispetto a quello del giudizio di primo grado.
2. La Novella del 2009.
La riforma processuale introdotta dalla legge 18.6.2009 n.69 ha toccato solo molto
marginalmente il giudizio di secondo grado.
Non è il caso certamente di trattare in questa sede tutte quelle novità che hanno inciso in
generale sul processo civile e che vengono ad interessare il giudizio di appello così come
interessano il giudizio di primo grado.
Si pensi, solo esemplificativamente:
• alla previsione della possibilità di condanna alla rifusione delle spese processuali della
parte vittoriosa che ha ingiustificatamente rifiutato una congrua proposta conciliativa
(art.91, comma 1);
• alla necessità che la compensazione delle spese processuali per giusti motivi scaturisca
da gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate (art.92, comma 2);
• alla previsione della possibilità di una condanna d’ufficio della parte soccombente ad
una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite (art.96,
comma 3);
• all’espressa regolazione dei doveri del giudice a tutela dell’esplicazione del
contraddittorio in caso di rilievo d’ufficio di una questione (art.101, comma 2);
• alla generalizzazione del principio che delimita il thema probandun alle circostanze
specificamente contestate dalla parte costituita (art.115, comma 1);
• all’esclusione dal contenuto della sentenza del resoconto dello svolgimento del
processo (art.132, comma 2);
• alla generalizzazione del principio della remissione in termini per la decadenza non
imputabile alla parte (art.153, comma 2);
• alla previsione della sanabilità ex tunc dei difetti di rappresentanza, assistenza o
autorizzazione e dei vizi della procura alle liti (art.182, comma 2);
• all’obbligatoria preventiva formulazione del quesito per il C.t.u. (art.191, comma 1);
• alla regolamentazione all’interno del sub-procedimento peritale delle manifestazioni di
dissenso critico delle parti (art.195, comma 3).
L’unico intervento specifico, di carattere strutturale, del Legislatore del 2009 sul giudizio di
appello è stato effettuato sul testo dell’art.345, comma 3, per escludere, con una formula del
tutto inequivocabile, che nel giudizio di secondo grado sia possibile produrre nuovi
documenti, eccezion fatta per l’ipotesi di mancata produzione nel giudizio di primo grado
avvenuta per causa non imputabile e per quella in cui il Collegio non li ritenga “indispensabili”
ai fini della decisione.
Così facendo, peraltro, il Legislatore del 2009 si è limitato a recepire espressamente la
soluzione interpretativa consolidatasi nella giurisprudenza dopo una lunga fase di discussioni e
contrasti (creatisi soprattutto fra giurisprudenza di merito e parte della dottrina, da un lato, e
giurisprudenza di legittimità, dall’altro), in seguito alle pronunce n.8202 e n.8203 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (su cui ampiamente infra) che, sconfessando il prevalente
indirizzo delle Sezioni semplici e recependo le tesi dei giudici di merito, avevano propeso per
2 Secondo giurisprudenza costante della Corte Costituzionale: cfr sentenze 30.11.2007 n.410; 23.3.2007 n.107;
29.12.2000 n.585; 30.7.1997 n.288; 23.12.1994 n.438; 3.10.1990 n.433.
3
la piena equiparazione del regime di introduzione in appello delle nuove prove, precostituite e
costituende che fossero.
L’intento chiarificatore del Legislatore sarebbe certamente tradito da una lettura cavillosa della
norma, volta a cogliervi l’espunzione dei “documenti” dal novero dei “mezzi di prova” (in
contrasto con l’art.163, n.5), per trarne il corollario che nel regime anteriore alla Novella del
2009 i documenti fossero, in contrasto con i principi giurisprudenziali acquisiti, liberamente
producibili, senza vincoli di sorta.
Se le modifiche dell’art.345 non possono che svolgere una mera funzione di conferma degli
orientamenti giurisprudenziali maturati, l’altra novità che riguarda il giudizio di appello
riguarda le impugnazioni delle ordinanze emesse per definire i procedimenti sommari di
cognizione ex art.702 bis c.p.c.
L’art.702 quater infatti ammette nuovi mezzi di prova e nuove produzioni documentali,
attenuando sensibilmente la soglia dell’ammissibilità, a prescindere
dalla decadenza
incolpevole, in evidente considerazione della sommarietà della cognizione di primo grado.
E’ infatti sufficiente che il Collegio consideri le nuove prove “rilevanti ai fini della decisione” e
non necessariamente “ indispensabili.”
3. Il divieto di proporre nuove domande in appello.
L’art.345, comma 1, presidia il doppio grado di giurisdizione di merito – principio generale
non costituzionalizzato – con il divieto di introdurre domande nuove per la prima volta nel
giudizio di appello.
La disposizione in realtà tutela altresì la tendenziale immutabilità del thema decidendum fissato in
primo grado, dopo lo scattare delle preclusioni assertive (attualmente scandite dall’art.183,
comma 5 e 6).
Il criterio generale per diagnosticare la configurabilità di una domanda nuova non potrà che
basarsi sul raffronto con le domande proposte in primo grado sulla base dei tradizionali
elementi di identificazione della domanda(personae, petitum, causa petendi):
• “Il mutamento della “causa petendi” determina un mutamento della domanda, tale da renderla
inammissibile come domanda nuova in appello nei soli casi in cui vengano alterati l’oggetto
sostanziale dell’azione e i termini della controversia, mediante la prospettazione di nuove circostanze
o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione pongano
in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo
grado. Una tale inammissibilità, quindi, non è configurabile tutte le volte in cui - fermi tra il primo e
il secondo grado i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche a esse ancorate vengano sollevate in appello delle ulteriori questioni di diritto, all’esame delle quali il giudice, salva la
formazione del giudicato sul punto, sia comunque tenuto per il principio “iura novit curia” essendo
suo dovere ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e
porre a fondamento della decisione principi di diritto anche diversi da quelli erroneamente richiamati
dalle parti.”(Cassazione civile, sez. II, 3 marzo 2008, n. 5741).
Il controllo deve avvenire d’ufficio, a prescindere dalla acquiescenza o dalla vera e propria
accettazione espressa del contraddittorio manifestata dalla controparte;.
Nel caso in cui il Giudice ravvisi una domanda nuova, deve dichiararla d’ufficio inammissibile,
così assolvendo preliminarmente la controparte dall’osservanza del giudizio sul punto.
La formula normativa del Codice anteriore alla Novella del 1990 prevedeva il rigetto d’ufficio
da parte del Giudice, ma la dottrina prevalente preferiva ravvisarvi una mera improprietà
terminologica, escludendo che tale pronuncia equivalesse ad un accertamento negativo sul
merito della pretesa.
Se il Giudice di secondo grado non vi provvede, lo può fare la Suprema Corte d’ufficio in
sede di legittimità:
• “Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345, comma 1 c.p.c., integrando
violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua
4
violazione va rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza
l’accettazione del contraddittorio.”(Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2007, n. 383).
In sintesi:
• in primo luogo è indubbio che le domande che formano l’oggetto del giudizio di
secondo grado possono essere le stesse che formavano oggetto del giudizio in primo
grado, a patto che le parti interessate le abbiano debitamente riproposte, e che, come
si vedrà, abbiano formulato i motivi specifici di impugnazione diretti a rimettere in
discussione sul punto il decisum allorché abbiano subito una statuizione sfavorevole
(vedi infra);
• in secondo luogo, sicuramente l’oggetto del giudizio può essere più circoscritto
rispetto a quello di primo grado.
Ciò si verificherà tutte le volte in cui una domanda non accolta in primo grado non venga
riproposta nel giudizio di secondo grado dalla parte interessata:
• o perché la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza di primo grado non sia stata
aggredita - o non sia stata aggredita ritualmente - con l’impugnazione,
• o perché l’omessa pronuncia su di una domanda pretermessa non sia stata censurata
in sede di impugnazione con la sua riproposizione in appello,
• o infine perché una domanda non esaminata perché ritenuta assorbita in primo grado
non sia stata riproposta in appello dalla parte interessata.
La facoltà di impugnazione è espressione del principio dispositivo e quindi per la
individuazione della materia del contendere del giudizio di appello rispetto alla res controversa
in primo grado occorre aver riguardo alla volontà delle parti. Analoga regola vale ovviamente
per la proposizione al giudice di secondo grado delle domande assorbite.
Non è consentita alcuna facoltà di modificazione delle domande proposte in primo grado che
non sia meramente abdicativa; per intenderci non vi è spazio per quella sia pur limitata
emendatio che è riconosciuta alle parte proponente nella fase di trattazione del giudizio di primo
grado che sfocia nella cristallizzazione del thema decidendum.
Alla luce del fondamentale principio della libertà e strumentalità delle forme (artt.121 e 156
c.p.c.), da cui discende l’esclusione di vincoli puramente rituali e sacramentali nell’ambito del
processo, sono invece ovviamente consentite modificazioni meramente formali,
terminologiche e linguistiche che non incidano sulla reale sostanza delle richieste delle parti:
anche in questo caso la lanterna di orientamento per il Giudice va individuata nei tre criteri di
identificazione della domanda giudiziale (personae, petitum, causa petendi) che debbono restare
immutati, salvo la riduzione quantitativa del petitum.
Possono trovare emersione, attraverso una richiesta esplicita invece le domande implicite
nelle conclusioni precedentemente rassegnate:.
Per esempio la parte che ha richiesto la condanna dell’avversario può chiedere anche in appello
l’accertamento (o il mero accertamento) perché una domanda di condanna implicitamente
presuppone anche la richiesta del preventivo accertamento del diritto.
• “Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla
sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di
appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere mediante l’introduzione di
domande nuove. Il suddetto principio, tuttavia, non risulta violato qualora in appello venga proposta
in via subordinata, ed accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella avanzata con il
ricorso di primo grado e riproposta in grado di appello. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda subordinata,
avanzata solo in appello dall’Inpgi, di limitare il risarcimento del danno conseguente
ad illegittimità di un provvedimento di sospensione cautelare del lavoratore, vittorioso
in primo grado, esplicitando un contenuto già insito nell’originaria richiesta di rigetto
della domanda).”(Cassazione civile, sez. lav., 12 settembre 2008, n. 23563).
Allo stesso modo la parte che ha concluso solo nel merito, evidentemente ritenendo fornito di
giurisdizione e competente il Giudice e la propria domanda ammissibile, proponibile e
5
procedibile, può espressamente richiedere in appello il rigetto di ogni eccezione ostativa ad una
pronuncia sul merito della propria pretesa anche se non ha espressamente concluso in tal senso
in primo grado.
A questo punto della trattazione può giovare una analisi casistica della giurisprudenza di
legittimità più recente per verificare in quali ipotesi la Suprema Corte abbia ravvisato
l’infrazione al divieto e in quali ipotesi l’abbia invece escluso.
Le pronunce più interessanti sono raggruppare per materia.
3.1. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Non è domanda nuova la richiesta di accertamento e condanna al pagamento della somma
oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi in cui in primo grado il convenuto
opposto si sia limitato a richiedere il rigetto dell’opposizione:
• “Allorquando con il ricorso per decreto ingiuntivo viene chiesto il riconoscimento di un credito in
difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria e venga successivamente
proposta l’opposizione da parte dell’ingiunto con la deduzione, fra l’altro, dell’emissione del decreto
nonostante quel difetto (per tutto o parte del credito), nel giudizio a cognizione piena che viene
introdotto formalmente con l’opposizione, la domanda giudiziale oggetto della cognizione del giudice
dell’opposizione, a parte l’eventualità che lo stesso opponente introduca a sua volta in via
riconvenzionale domande ed a parte l’eventualità che a sua volta ne introduca lo stesso opposto, è
individuata automaticamente in quanto è stato richiesto, sia pure parzialmente o totalmente con il
ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l’opposizione determina l’insorgenza del dovere di provvedere
con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo e nel relativo
giudizio l’opposto è attore in senso sostanziale e l’opponente è convenuto in senso sostanziale.
Pertanto, il fatto che il creditore si limiti a chiedere il rigetto dell’opposizione non restringe la
cognizione del giudice dell’opposizione al solo controllo sulla legittimità o meno dell’emissione per il
credito a titolo di danno. Introdotta l’opposizione, il controllo si estende automaticamente sulla
sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella proposta
in appello che chiede di pronunciarsi sulla debenza della somma.”(Cassazione civile, sez. III, 5
gennaio 2010, n. 28);
• “Se parte opposta, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, chiede solo il rigetto
dell’opposizione, quando nell’atto di appello formula la richiesta di pronuncia sulla debenza della
relativa somma, già indicata nella richiesta del decreto ingiuntivo, non viola l’art. 345 c.p.c., poiché
non si tratta di una nuova domanda. Ciò in quanto la cognizione del giudice dell’opposizione si
estende automaticamente all’accertamento della sussistenza o meno della pretesa creditoria oggetto del
ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l’opposizione determina l’insorgenza del dovere di provvedere,
con le regole della cognizione piena, su quanto è stato già richiesto in sede monitoria.”(Cassazione
civile, sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25286).
3.2. Edilizia economica e popolare.
E’ stata ravvisata mutatio nel caso di proposizione della domanda di assegnazione di un
alloggio di edilizia economica e popolare sulla base di una legge differente, che prevedeva
diversi parametri per la determinazione del prezzo, rispetto a quella inizialmente prospettata in
primo grado:
• “Chiesta, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’assegnazione in proprietà di immobili
di edilizia economica e popolare ai sensi della l. n. 60 del 1963, a fronte del pagamento del prezzo
determinato a norma della detta legge e con la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., è inammissibile la domanda - proposta per la prima volta in appello - volta al trasferimento di
quegli stessi alloggi ai sensi della l. n. 513 del 1977, con offerta del pagamento del prezzo
determinato secondo tale legge. Trattasi, infatti, di due richieste in fatto e in diritto diverse e antitetiche
e aventi diversità di petitum e di causa petendi”. (Cassazione civile, sez. II, 13 novembre
2009, n. 24131).
6
3.2. Diritti reali:
In tema di diritti reali é stata ravvisata domanda nuova nella richiesta di accertamento di un
diritto reale di diverso contenuto (ancorchè minore):
• “Chiesto, in primo grado, l’accertamento dell’avvenuto acquisto, per usucapione, di una striscia di
terreno, costituisce domanda nuova - preclusa in appello - quella diretta all’accertamento che su quella
stessa striscia di terreno sussiste, in favore dell’attore in primo grado, una servitù di passaggio per
destinazione del padre di famiglia.”(Cassazione civile, sez. II, 13 novembre 2009, n.
24127),
oppure in caso di richiesta di regolarizzazione di una luce rispetto alla precedente
proposizione della negatoria servitutis:
• “In materia di diritti reali, la domanda volta ad obbligare il vicino alla regolarizzazione di una luce,
pur costituendo quantitativamente un minus rispetto alla actio negatoria servitutis, rappresenta un
qualcosa di diverso rispetto a quest’ultima; ne consegue che - proposta domanda originaria di
riduzione a distanza legale di una servitù di veduta diretta ed indiretta sul proprio fondo - costituisce
domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolarizzazione di
una luce irregolare, atteso che l’accoglimento di detta domanda imporrebbe l’esecuzione di opere non
ricomprese nel “petitum” originario.”(Cassazione civile, sez. II, 23 ottobre 2009, n. 22553);
per contro il ricorso alla categoria dei diritti “autodeterminati”, ha consentito di salvare la
conversione da usucapione ordinaria ad abbreviata:
• “Nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, che sono
individuati solo in base al loro contenuto (con riferimento al bene che ne costituisce l’oggetto), la causa
petendi si identifica con il diritto stesso e non, come nei diritti di credito, con il titolo che ne costituisce
la fonte, la cui deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di
specificazione della domanda; ne consegue che l’allegazione in appello dell’acquisto per usucapione
abbreviata non costituisce domanda nuova rispetto a quella di usucapione ordinaria inizialmente
proposta con riferimento allo stesso bene, poiché, indipendentemente dalla necessità di provare ulteriori
elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, viene rivendicato il medesimo diritto.”(Cassazione
civile, sez. II, 10 settembre 2009, n. 19544; cfr altresì Cassazione civile, sez. II, 16
maggio 2007, n. 11293);
sullo stesso principio è stata fondata la ritenuta ammissibilità della richiesta di rimozione di un
manufatto fondata in appello sulla sussistenza di una servitù di passaggio, mentre in primo
grado la domanda era stata basata sulla comproprietà:
• “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti
autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto quale
rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative
azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte,
la cui eventuale deduzione non svolge, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda,
ma è rilevante ai soli fini della prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata
ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che
l’attore, nel richiedere la rimozione di un’aiuola posta dal vicino su una strada, in
primo grado avesse dedotto la comproprietà della strada e, in grado di appello, un
diritto di servitù di passaggio).”(Cassazione civile, sez. II, 13 febbraio 2007, n. 3089).
Oppure per diverse applicazioni dello stesso principio:
• “Nel giudizio promosso da un condomino volto all’eliminazione di opere, realizzate da altro
condomino, incidenti sulla stabilità della propria unità immobiliare (realizzazione di un soppalco) e
sulle parti comuni dell’edificio (realizzazione di una sopraelevazione), non costituisce domanda nuova
ma mera integrazione difensiva, l’allegazione di titoli emersi in corso di causa diversi da quelli
originariamente introdotti nel primo grado del giudizio in quanto la proprietà appartiene alla
categoria dei diritti autodeterminati individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto,
rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, e non dalla fonte, necessaria solo a fini di prova ma
non di specificazione della domanda. Pertanto l’attore può mutare il titolo in base al quale chiede
tutela senza incorrere nel divieto di “mutatio libelli” ed il giudice può fondare la propria decisione su
7
un titolo diverso da quello invocato senza che si violi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato. (Nel caso di specie nel giudizio di primo grado è stata dedotta l’illegittimità
del soppalco per il sovraccarico sui muri portanti e della sopraelevazione per le lesioni
sui muri comuni mentre la pronuncia di secondo grado, confermata dalla Corte, si è
fondata per l’accoglimento della domanda di demolizione di entrambe le costruzioni,
sull’instabilità cagionata dal soppalco ai muri divisori della singola unità immobiliare e
sulla violazione della normativa antisismica per la sopraelevazione).”(Cassazione civile,
sez. II, 20 novembre 2007, n. 24141):
• “I diritti assoluti - reali o di status - si identificano in sé e non in base alla loro fonte, come accade per
i diritti di obbligazione, sicché, l’attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto
assoluto senza incorrere nelle preclusioni (art. 183, 189 e 345 c.p.c.) e negli oneri (art. 292 c.p.c.)
della modificazione della “causa petendi”, né viene a concretarsi una violazione del principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il “petitum” sulla scorta di un
titolo diverso da quello invocato. Infatti, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono
alla categoria dei cosiddetti “diritti autodeterminati”, individuati, cioè, in base alla sola indicazione
del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali
diritti, la “causa petendi” si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a
difesa dei diritti di credito, nelle quali la “causa petendi” si immedesima con il titolo), mentre il
titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.
Ne consegue che, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà dall’altrui esercizio di
una veduta, dedotto come illegittimo perché derivante dall’intervenuta trasformazione di un’originaria
luce, mediante la condanna del convenuto al ripristino degli accorgimenti impeditivi della veduta
previsti dall’art. 901 c.c., l’allegazione di un titolo - quale l’insussistenza di una servitù di veduta diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda - quale il diritto ad
ottenere la conformazione dell’apertura alle caratteristiche della luce - altro non rappresenta se non
un’integrazione delle difese, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a quello
precedentemente dedotto, che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non
implica alcuna rinunzia a che il primo titolo dedotto venga anch’esso se del caso preso in
considerazione, e, tanto meno, influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque,
cristallizzate nel medesimo “petitum” consistente nella richiesta di accertamento della lesione del
diritto di proprietà e di pronunzia idonea all’eliminazione della situazione lesiva. Conseguentemente,
decisa la controversia in primo grado sulla base dell’un titolo, non è preclusa in secondo grado la
decisione sulla scorta dell’altro o di entrambi, giacché trattasi di argomentazioni difensive intese a
specificare le ragioni della tutela del diritto reale in discussione che non immutano l’originario “thema
decidendum” e possono, pertanto, essere svolte dalla parte interessata non solo nell’atto di appello ma
lungo tutto il corso del giudizio di secondo grado.”(Cassazione civile, sez. II, 21 novembre
2006, n. 24702).
E’ stata ritenuta nuova la domanda volta ad accertare la demanialità di un’area per contrastare
la negatoria servitutis del privato:
• “Qualora l’attore, proprietario di un’area scoperta, abbia convenuto in giudizio il Comune chiedendo
sia accertato che nessuna servitù ha il detto Comune sulla detta area che deve essere dichiarata
pertinenza dei fabbricati di sua proprietà e il Comune, costituitosi in giudizio, abbia chiesto il rigetto
della domanda attrice ovvero il suo accoglimento, ove l’attore provi il suo diritto, costituisce domanda
nuova, inammissibile, quella proposta per la prima volta in appello dal Comune perché sia
dichiarata l’appartenenza al demanio comunale dell’area in questione. La contestazione della
domanda attrice (in primo grado), infatti, non importa necessariamente l’accertamento della
demanialità comunale dell’area, perché il “thema decidendum” è limitato all’accertamento se il diritto
sull’area spetti o meno all’attore, fermo restando che il mancato accertamento del diritto in capo a
questo può comportare esclusivamente la presunzione di demanialità dell’area stessa e non un positivo
accertamento di detto carattere.”(Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2008, n. 16210).
E’ stata invece esclusa la novità della domanda fra gli artt.887 e 886 c.p.c.:
8
•
“La norma di cui all’art. 887 c.c. non individua un diritto diverso da quello, previsto dall’art. 886
c.c., di costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione del muro di cinta, ma specifica
soltanto che tali spese devono essere sostenute per intero dal proprietario del fondo superiore; ne
consegue che la richiesta di addebitare integralmente la costruzione al vicino non costituisce
inammissibile mutatio, ma mera emendatio, consentita anche in appello, della domanda inizialmente
proposta e volta ad imporre al vicino, proprietario del fondo superiore, la costruzione del muro di
cinta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa introdotta prima del 30
aprile 1995).”(Cassazione civile, sez. II, 29 luglio 2009, n. 17692).
Non è stata ritenuta nuova la richiesta di inibitoria d’uso di un immobile di cui era stato
precedentemente richiesto l’arretramento a distanza non nociva ex art.890 c.c.
• “A norma dell’art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento della domanda non consentito,
riguardo al “petitum”, solo quando risulti innovato l’oggetto della pretesa, inteso non come “petitum”
immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come “petitum” mediato (cioè come richiesta di
attribuzione di un bene determinato). Ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice “emendatio
libelli”, allorché la modifica della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere
sul “petitum” nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del
giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto. (Nella
specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che potesse considerarsi nuova la
domanda con cui la parte, dopo avere chiesto in primo grado, ai sensi dell’art. 890 c.c.,
l’arretramento di una manufatto del vicino adibito a ricovero di animali ad una distanza dal confine
tale da preservare la salubrità del proprio fondo, aveva chiesto in grado di appello, dopo che il
manufatto era stato sgomberato e l’ambiente circostante sanificato, che fosse ordinato alla controparte
di non adibire lo stesso a ricovero di animali).”(Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2007,
n. 4034).
3.3. Responsabilità civile e risarcimento del danno.
Non è ritenuta vietata la specificazione di un danno, inizialmente richiesto in modo generale e
onnicomprensivo:
• “In tema di domande nuove in appello, con riferimento all’azione di risarcimento del danno, non
sussiste violazione del divieto di cui al comma 1 dell’art. 345 c.p.c. - nella formulazione anteriore
alla modifica apportata dall’art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353 - là dove dalle conclusioni
rassegnate sia nel giudizio di primo grado che da quelle proposte in grado di appello, si evinca che la
domanda risarcitoria, in relazione a tutti i danni subiti per la causale descritta nell’atto introduttivo,
abbia investito sin dall’inizio ogni possibile voce di danno, esprimendo per la sua onnicomprensività la
volontà di riferirsi ad un ristoro globale ricomprendente tutti i possibili profili di danno patito.
Pertanto, solo nel caso in cui nell’originario atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e
tra esse non siano indicate quelle poi oggetto di specifica richiesta in appello la relativa domanda se
proposta in appello, costituisce domanda nuova come tale inammissibile.”(Cassazione civile, sez.
III, 20 febbraio 2007, n. 3936).
In materia risarcitoria la violazione del divieto di mutatio è stata riscontrata allorché è stata
avanzata domanda per mala gestio rispetto ad una originaria domanda risarcitoria:
• “La domanda con la quale la vittima di un sinistro stradale chiede la condanna dell’assicuratore al
risarcimento del danno anche oltre il massimale per colposo ritardo nella liquidazione dell’indennizzo
(c.d. “mala gestio” impropria) non può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di
inammissibilità rilevabile anche d’ufficio; detta domanda, infatti, riguarda un oggetto ed una “causa
petendi” del tutto diversi dalla mera domanda risarcitoria e non può ritenersi implicitamente
formulata nell’ambito di quest’ultima.”(Cassazione civile, sez. III, 2 settembre 2009, n.
19089);
• “In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
danneggiato può far valere la responsabilità da colpevole ritardo dell’assicuratore nell’adempimento
della sua obbligazione, al fine di ottenere la rivalutazione del massimale di polizza,
nell’ambito dell’azione diretta che, ai sensi dell’art. 18 legge n. 990 del 1969, può promuovere
9
nei confronti dell’assicuratore, ma è necessaria a tal scopo la proposizione di una specifica
domanda, che non può ritenersi compresa in una generica richiesta di risarcimento di tutti i
danni derivanti dal sinistro; ne consegue che, ove tale domanda non risulti proposta in primo
grado e venga proposta per la prima volta in appello, essa è improponibile in quanto domanda
nuova, ex art. 345 c.p.c. “(Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3807).
La domanda (inequivocabilmente) fondata sulla violazione dell’art.2043 non può essere
convertita in appello in una fondata su di una responsabilità oggettiva speciale:
• “ Quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art.
2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio da parte del
giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli
art. 2050 (esercizio di attività pericolose) o 2051 (responsabilità per cose in custodia) c.c., a meno
che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro
situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad
integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un
generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale
richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta.”(Cassazione civile,
sez. III, 20 agosto 2009, n. 18520);
però:
• “La domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell’art. 2051 c.c.)
deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a
quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi
dell’art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi
da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall’atto introduttivo
della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella
specie, dai ponteggi che avevano consentito l’accesso dei ladri all’immobile della ricorrente
danneggiata), l’invocazione della speciale responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. si risolve nella
richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita
al giudice
d’appello.”(Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591).
E’ inammissibile la domanda di condanna specifica dopo aver richiesto in primo grado la sola
condanna generica:
• “Quando, nel giudizio di primo grado, sia stata proposta una domanda di condanna generica al
risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - la domanda, formulata in appello, di
liquidazione del danno è da considerare nuova e, come tale, inammissibile.”(Cassazione civile, sez.
II, 24 giugno 2009, n. 14782).
Lo stress da timore costituisce domanda nuova rispetto alla richiesta del danno biologico:
• “Il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., è
ontologicamente diverso dal danno derivante dalla lesione di un diverso diritto costituzionalmente
protetto, non potendo, quindi, essere risarcito come danno biologico il danno, cosiddetto esistenziale,
che si affermi essere derivato da «stress psicologico da timore», per la compromissione della serenità e
sicurezza del soggetto interessato, giacché detto stress è soltanto una conseguenza della lesione di un
possibile interesse protetto il quale necessita di una previa individuazione affinché possa venire poi in
considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione,
altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di
rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del
danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che,
senza individuare la lesione di alcun diritto o interesse costituzionalmente protetto,
aveva ritenuto che il danno esistenziale da «stress psicologico da timore» potesse
ricomprendersi nel danno biologico, così errando nell’escludere che fosse nuova la
domanda di risarcimento di quest’ultimo danno proposta soltanto in grado di appello,
la quale, invece, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 345
c.p.c.).”(Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3284).
Invece in tema di danno alla vita di relazione:
10
•
“Il danno alla vita di relazione, consistente nella impossibilità o difficoltà per il danneggiato di
reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, è risarcibile quale danno non
patrimoniale all’interno della categoria non del danno morale, ma del danno biologico, come
autonoma componente del danno alla salute, da valutarsi distintamente nella determinazione
complessiva della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento. Ne consegue che, ai fini del
riconoscimento del danno alla vita di relazione e della sua risarcibilità, énecessario che il richiedente
abbia quanto meno allegato l’esistenza di tale autonoma categoria di danno nell’atto introduttivo del
giudizio di primo grado, non essendo sufficiente a tale scopo domandare genericamente il risarcimento
del danno biologico “iure proprio”, e non potendo l’autonoma allegazione essere formulata per la
prima volta in appello, ostandovi il divieto di introdurre domande nuove posto dall’art. 345
c.p.c.”(Cassazione civile, sez. III, 27 giugno 2007, n. 14852).
In tema di danno esistenziale:
• “Il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed
interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del
soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all’espressione e alla realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto
dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico, né del danno morale, ma un
autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel
ricorso introduttivo del giudizio della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In
mancanza di tale allegazione nel giudizio di primo grado, la domanda proposta per la prima volta in
appello e volta al risarcimento del danno esistenziale costituisce domanda nuova, come tale
inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.”(Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n.
2546).
E’ stato ravvisato il mutamento inammissibile per il fondamento della responsabilità medica
sulla mancanza di consenso informato piuttosto che sulla colpa professionale:
• “Il mutamento della “causa petendi” determina una “mutatio libelli” quando la diversa “causa
petendi”, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non
prospettati in precedenza, comporti l’immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e,
introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale
dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta
valere in precedenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
ritenuto che vi fosse mutamento della domanda nel fatto di porre a fondamento
dell’azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di
consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa
professionale).”(Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 2007, n. 18513).
E’ mutatio libelli la deduzione di una violazione del segreto istruttorio quando in primo grado è
stata predicata la mera offensività di uno scritto:
• “In tema di risarcimento da diffamazione a mezzo stampa, l’allegazione, per la prima volta in grado
di appello, di fatti lesivi derivanti dalla illegittima pubblicazione di atti coperti dal segreto istruttorio,
ai sensi degli art. 114 e 335, comma 3, c.p.p., integra una inammissibile mutatio libelli qualora la
domanda risarcitoria, nel giudizio di primo grado, sia fondata esclusivamente sulla natura offensiva
dello scritto.”(Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4603);
• “Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce
inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del
fatto diversa da quella allegata in primo grado. (Nella specie, l’attore in primo grado aveva allegato
di essere stato urtato dal veicolo condotto dal convenuto mentre era in bicicletta; in appello, invece,
aveva allegato di essere stato urtato dal suddetto veicolo mentre si trovava a terra, dopo essere caduto
dalla bicicletta in conseguenza di un precedente urto infertogli da un terzo. La S.C., confermando la
decisione di merito, ha ritenuto inammissibile tale mutamento della domanda). “(Cassazione
civile, sez. III, 27 marzo 2009, n. 7540).
3.4. Obbligazioni e contratti.
11
La richiesta di essere condannati alla rimessione in pristino e non al pagamento dei costi
relativi integra domanda nuova:
• “La parte che, condannata dal giudice in primo grado a risarcire il danno causato da inadempimento
contrattuale (nella specie provocato dalla realizzazione di una discarica abusiva nel fondo oggetto di
affitto agrario) mediante il pagamento della somma occorrente per rimuovere gli oggetti che lo hanno
determinato, chieda al giudice di secondo grado di commutare la condanna nell’obbligo di rimuovere
direttamente detti oggetti, propone una domanda nuova e non solleva semplicemente un’eccezione,
sicché correttamente, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il giudice di appello la dichiara
inammissibile.”(Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14755).
E’ stata ritenuta inammissibile la domanda di accertamento della simulazione relativa rispetto
a quella assoluta:
• “La parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo
inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si
traduce il “negotium mixtum cum donatione”, e non il mancato pagamento dell’intero prezzo, che
integra gli estremi di una simulazione assoluta; ne consegue che, proposta in primo grado la domanda
di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda, proposta in
appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un
“negotium mixtum cum donatione”.”(Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2009, n. 19099);
• “In tema di domande nuove in appello, con riferimento alle azioni di simulazione del contratto di
compravendita, proposta una domanda di accertamento della simulazione assoluta di tale contratto,
costituiscono domande nuove, come tali improponibili in appello ai sensi dell’art. 345, comma 1,
c.p.c., comportando l’accertamento di fatti nuovi e diversi con efficacia di giudicato, sia la domanda di
accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita, sia la domanda di nullità
della vendita perché dissimulante un mutuo con patto commissorio, sia la domanda di accertamento
dell’interposizione fittizia di persona.”(Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2007, n. 6961).
La richiesta di restituzione di quanto pagato in forza di contratto risolto configura domanda
nuova:
• “In materia contrattuale, pur essendo l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto
naturale della risoluzione del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte
proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in
primo grado la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice
d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domanda
restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda
nuova.”(Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2562).
Costituisce domanda nuova la richiesta di accertamento del legittimo recesso con
incameramento di caparra rispetto alla domanda di risoluzione :
• “In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra
confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di
diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella
volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del
doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione
giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di
risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale
del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se
alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro
patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto
processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva,
quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.”(Cassazione civile, sez. un., 14
gennaio 2009, n. 553).
Costituisce domanda nuova la richiesta di accertamento dell’effetto traslativo rispetto a quella
di pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c.:
12
•
“Costituisce domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l’esecuzione coattiva di un
contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell’atto introduttivo la richiesta di
pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., sostituisce nell’atto di riassunzione a seguito di interruzione o
nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell’atto di appello, la predetta domanda con una
successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l’avvenuto effetto traslativo, qualificando il
rapporto pattizio non più come preliminare, ma come vendita per scrittura privata. Si tratta, infatti,
di domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi, atteso che nella prima ipotesi
l’attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo
delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata dell’immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale,
immediatamente traslativo della proprietà dell’immobile per effetto del consenso legittimamente
manifestato.”(Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1740).
Idem per il caso opposto:
• “È nuova, come tale inammissibile in appello, la domanda - nella specie in tale grado proposta con la
formula “anche o alternativamente” - di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto
preliminare di compravendita di un immobile (art. 2932 c.c.), a fronte delle conclusioni avanzate in
primo grado di accertamento dell’avvenuto trasferimento dell’immobile per effetto dell’esercizio del
diritto convenzionale di riscatto, essendo le due domande difformi nel “petitum” e nella “causa
petendi”.” (Cassazione civile, sez. II, 26 ottobre 2007, n. 22494).
Rispetto alla domanda di risoluzione è domanda nuova la richiesta di annullamento per vizio
del consenso, così come lo è rispetto ad una diversa causa di annullamento:
• “Integra domanda nuova, la cui proposizione è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda
di annullamento del contratto di vendita di un bene immobile per vizio del consenso, consistente nella
asserita violenza morale, avanzata per la prima volta in sede di gravame al fine di realizzare la
azionata pretesa e non già di contrastare le difese della controparte, là dove, in primo grado, si era
agito per la risoluzione del contratto medesimo ovvero per il suo annullamento in base alla denuncia
di un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.”(Cassazione civile, sez. III, 24
ottobre 2007, n. 22329).
E’ pur vero che la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, dopo aver richiesto
l’adempimento è sempre ammissibile, ma i fatti costitutivi non debbono mutare:
• “L’art. 1453, comma 2, c.c., secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora uno
dei contraenti non adempia la propria obbligazione, l’altro può chiedere la risoluzione anche se abbia
già promosso il giudizio per ottenere l’adempimento, introduce una deroga al divieto della mutatio
libelli nel corso del procedimento. Tale facoltà, è tuttavia, esercitabile solo quando la domanda di
risoluzione resti nell’ambito degli stessi fatti posti a base dell’inadempimento, mentre, ove siano
prospettati fatti nuovi idonei a configurare una diversa causa petendi, il mutamento deve ritenersi
inammissibile anche nel regime processuale applicabile prima della riforma introdotta con la legge n.
353 del 1990, salva l’esplicita accettazione del contraddittorio della controparte sulla diversa
domanda.”(Cassazione civile, sez. II, 18 gennaio 2008, n. 1003).
Per la diversità strutturale fra la domanda dichiarativa della risoluzione automatica ex art.1456
c.c. e la domanda costitutiva di risoluzione ex art.1453 c.c.:
• “L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 c.c., tendendo ad una
pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale previo accertamento da parte del giudice
della gravità dell’inadempimento, differisce sostanzialmente dall’azione di risoluzione di cui all’art.
1456 c.c., tendente ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito del
verificarsi di un fatto obiettivo (nel caso di specie, mancata stipula del contratto definitivo nel termine
convenuto) previsto dalle parti come determinante per la sorte del rapporto. Ne consegue che, ove la
domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. sia stata proposta per la prima volta in appello, deve
considerarsi domanda nuova, e pertanto preclusa a norma dell’art. 345 c.p.c.”(Cassazione civile,
sez. II, 12 gennaio 2007, n. 423).
È stata esclusa la novità della domanda nel rapporto fra azione ex art.1484 e 1489 :
13
•
“Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda
effettuata dalla parte con l’attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basato sui medesimi
fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal
gravame, il potere-dovere di qualificazione delle domande delle parti con l’unico limite che resti
invariato il bene della vita domandato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado
che, in relazione ad un giudizio promosso per l’evizione parziale ai sensi dell’art. 1484 c.c., aveva
ritenuto inammissibile - considerandola domanda nuova - la domanda subordinata avanzata ai sensi
dell’art. 1489 c.c., senza procedere ad una diversa qualificazione
dei fatti esposti
dall’appellante).”(Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2008, n. 24055).
E’ stata ritenuta ammissibile la richiesta di restituzione del prezzo in caso di esercizio della
opzione di scioglimento del curatore:
• “Per effetto della deduzione nel giudizio di appello dell’opzione dello scioglimento del curatore, non
costituisce domanda nuova ed è pertanto ammissibile la richiesta del promissario acquirente volta ad
ottenere la restituzione del prezzo pagato.”(Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2009, n.
17405);
La richiesta di interessi anatocistici configura domanda nuova:
• “In tema di domande nuove in appello, gli interessi anatocistici - considerati i limiti entro i quali la
legge ne ammette la corresponsione (art. 1283 c.c.) - non si possono automaticamente includere tra gli
effetti accessori della condanna al pagamento, analoghi a quelli di cui all’art. 345 c.p.c., sicché la
relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.”(Cassazione civile, sez.
III, 16 maggio 2007, n. 11261).
3.5. Possesso.
In materia possessoria è stata ritenuta nuova la richiesta di reintegrazione nel possesso di un
bene demaniale:
• “In materia di tutela del possesso, ai fini della esperibilità tra privati dell’azione di spoglio o di
manutenzione nel possesso di beni demaniali (art. 1145, secondo e comma 3, c.c.), occorre pur sempre
che ricorrano in concreto gli estremi soggettivi, oggettivi e temporali, previsti in via generale dagli art.
1168 e 1170 c.c.; ne consegue che è nuova, e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la
domanda di reintegrazione nel possesso di un bene demaniale che soltanto in grado di appello
introduca per la prima volta nel giudizio uno dei suddetti elementi (nella specie, il carattere abusivo
dell’occupazione).”(Cassazione civile, sez. II, 24 giugno 2009, n. 14791).
3.6. Azione revocatoria
E’ compresa nella revocatoria fallimentare la richiesta di condanna al pagamento del tantundem
monetario:
• “Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della
generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la
liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il
suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben può
essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del
bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello,
in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa.”(Cassazione
civile, sez. I, 17 giugno 2009, n. 14098).
3.7. Restituzione somme pagate in forza della sentenza di primo grado.
La richiesta di restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado non
costituisce domanda nuova ma mero effetto restitutorio:
• “L’art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dell’art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), deponendo che la
riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza
riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno
immediatamente sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della
14
stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma
pagata e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue che la richiesta di restituzione delle
somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova ed è
perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con
l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile
la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta
successivamente alla proposizione dell’impugnazione.”(Cassazione civile, sez. III, 30 aprile
2009, n. 10124; cfr altresì Cassazione civile, sez. II, 19 dicembre 2007, n. 26795;
Cassazione civile, sez. I, 6 dicembre 2006, n. 26171).
3.8. Locazione.
In materia locatizia la richiesta del maggior danno ex art.1591 configura domanda nuova
rispetto alla richiesta ex art.6 legge 431 del 1998:
• “Nell’ipotesi di domanda di indennità di occupazione per ritardata restituzione di immobile locato
per uso diverso dall’abitazione, con l’applicazione degli aggiornamenti Istat e della maggiorazione del
20 per cento, in forza della disposizione speciale del comma 6 dell’art. 6 l. n. 431 del 1998 in
ragione della sospensione legale dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella di attribuzione dello stesso
beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno per ritardata restituzione dell’immobile
ai sensi della norma generale dell’art. 1591 c.c., perché comporta il mutamento dei fatti costitutivi del
diritto fatto valere e del thema decidendum, mentre integra violazione del principio di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato il riconoscimento del predetto beneficio economico, a titolo di risarcimento
del maggior danno da svalutazione monetaria, quando lo si è espressamente domandato a titolo di
risarcimento del danno da ritardata restituzione dell’immobile.”(Cass,.civ., sez.III, 19 marzo
2007 n.6468).
3.9. Donazione.
E’ nuova la domanda di accertamento della nullità della donazione obnuziale rispetto a quella
della donazione fra coniugi:
• “Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all’art.
781 c.c. - poi dichiarato costituzionalmente illegittimo - e di nullità della donazione obnuziale per
effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, comma 2, c.c.), sono diverse per il titolo,
in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne consegue che, ove
quest’ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione
obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di
appello.”(Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 2008, n. 19029).
3.10. Divisione.
In sede di divisione non è domanda nuova la richiesta di attribuzione dell’intero compendio:
• “In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare ex
art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già
richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la
prima volta anche nel giudizio d’appello.”(Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2008, n.
14008).
Così pure la richiesta di attribuzione di un bene determinato:
• “In tema di domande nuove in appello, le richieste, nei giudizi di divisione, di attribuzione di beni
determinati, poiché attengono alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non
danno luogo a “domande” in senso proprio, sicché possono senz’altro essere formulate per la prima
volta in appello. (Nella specie, la S.C. ha rigettato un ricorso avverso la sentenza di
appello che, in accoglimento della domanda proposta soltanto in quel grado di
giudizio, aveva assegnato, di un fabbricato pervenuto in eredità dai genitori, l’intero
piano terreno alla sorella, la quale, invece, davanti al tribunale aveva concluso in
15
conformità con il progetto divisionale del c.t.u. che le attribuiva una minore
porzione).”(Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 2007, n. 13654).
3.11. Appalto.
In materia di appalto il committente può variare la domanda di risoluzione in domanda di
riduzione del prezzo:
• “In tema di appalto, il committente che, per difetti dell’opera, abbia esperito azione di risoluzione del
contratto per inadempimento dell’appaltatore, può successivamente, sia in primo grado che in appello,
modificare la domanda in quella di riduzione del prezzo. Infatti, non soltanto non è estensibile
all’appalto il principio, dettato per la vendita dall’art. 1492, comma 2, c.c., dell’irrevocabilità della
scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; ma
nel caso di inadempimento dell’appaltatore, il divieto posto dall’art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al
committente che abbia proposto domanda di risoluzione di mutare tale domanda in quella di
adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo (domanda, questa, che non integra
una domanda nuova rispetto a quella originaria di risoluzione perché fondata sulla stessa “causa
petendi” e caratterizzata da un “petitum” più limitato).”(Cassazione civile, sez. I, 29
novembre 2007, n. 24948).
3.12. In tema di interessi legali e rivalutazione monetaria.
•
•
•
•
•
•
“Qualora nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il riconoscimento degli interessi sulla somma
dovuta a decorrere dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (in tale senso le conclusioni contenute
nel ricorso per decreto) oppure dalla data delle singole fatture (come nelle conclusioni definitive di
primo grado), costituisce domanda nuova, preclusa in appello, la richiesta degli interessi con
decorrenza dalla data di messa in mora.”(Cassazione civile, sez. I, 11 settembre 2007, n.
19086);
“Il giudice di appello non può riconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme
liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato non abbia proposto
in appello specifica domanda in tal senso, benché detti accessori siano stati chiesti in primo grado,
dovendosi ritenere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., rinunciate le domande ed eccezioni non espressamente
riproposte in grado di appello.”(Cassazione civile, sez. III, 9 luglio 2009, n. 16128);
“Nell’obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta
dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d’appello d’ufficio,
trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella
pronuncia di primo grado, riguardante il mancato riconoscimento della svalutazione nel periodo
anteriore alla sentenza impugnata. “(Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2009, n. 5567);
“In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice d’appello può procedere anche d’ufficio
all’ulteriore rivalutazione della somma liquidata dalla sentenza di primo grado, in quanto la
svalutazione monetaria medio tempore intervenuta può essere ricompresa nel petitum originario, salva
espressa volontà contraria dell’avente diritto.”(Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2006, n.
1526);
“Il giudice di appello può liquidare la svalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado
per il risarcimento del danno da fatto illecito, perché, salva espressa volontà contraria, tale
svalutazione può ricomprendersi nel petitum originario. (Nella fattispecie, la S.C., cassando la
sentenza di appello - che non aveva applicato tale principio - e decidendo nel merito, ha riconosciuto al
ricorrente, sull’importo già liquidatogli a titolo di risarcimento del danno da occupazione
espropriativa, la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla sentenza di primo grado e
sino alla data dell’effettivo pagamento).”(Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1041);
“La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell’obbligazione di
risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di
appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell’originario
“petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi.”(Cassazione
civile, sez. I, 17 settembre 2003, n. 13666);
16
•
“La regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria
(cumulabili fino all’entrata dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991) sui crediti
previdenziali e assistenziali, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo
successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati di ufficio dal giudice di appello,
anche in mancanza di un’apposita istanza dell’interessato. Ne consegue il potere - dovere del
giudice di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello di provvedere a
determinare l’esatta consistenza del credito, secondo il combinato disposto degli art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c. e, “a fortiori”, l’obbligo del giudice di liquidare l’importo della rivalutazione e
degli interessi in relazione al periodo successivo al pagamento della sorte capitale, quando la
domanda sia volta all’attuazione
del credito di
lavoro e non al pagamento di
“accessori”.”(Cassazione civile, sez. lav., 22 agosto 2003, n. 12376).
4. La possibilità
appello.
eccezionale di introduzione di nuove domande nel giudizio di
L’art.345 c.p.c. consente, in deroga al generale divieto di introduzione di nuove domande, di
chiedere interessi, frutti ed accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il
risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza.
La norma in questione non è invocata molto frequentemente nelle aule giudiziarie e in
conseguenza la giurisprudenza al riguardo non è copiosissima.
La norma sembra riferirsi a quei pregiudizi che trova il loro antecedente causale nella stessa
condotta antigiuridica oggetto di causa ma che siano maturati solo in un secondo tempo (in
particolare dopo la pronuncia di primo grado).
Si potrebbe esemplificare:
• un aggravamento dei danni biologici patiti per effetto della lesione psico-fisica
arrecata;
• la risoluzione di un rapporto commerciale con un altro imprenditore posto a valle
nella catena distributiva, provocata dalla fornitura di prodotti difettosi;
• il decesso dello stretto congiunto per effetto delle lesioni gravemente invalidanti per
cui si era inizialmente agito.
Per un corretto inquadramento della norma è necessario far capo alla pronuncia delle Sezioni
Unite dell’11 marzo 1996, n. 1955, secondo cui:
• “L’art. 345, comma 1, c.p.c., ove deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai
danni sofferti dopo la sentenza impugnata, trova applicazione solo quando nel giudizio di primo grado
sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, in quanto detta deroga trova
giustificazione nel fatto che l’istanza di ristoro del danno ulteriore configura sviluppo logico di
domanda già proposta.”
In particolare nella citata sentenza il Supremo Collegio chiarì la ratio dell’istituto, osservando :
“La soluzione accolta privilegia l’interpretazione logico-sistematica, già seguita dall’indirizzo giurisprudenziale
prevalente che si richiama alla ratio della disposizione, in base alla quale, in tanto si consente una
deroga ai nova in appello per ragioni di economia processuale - al fine di evitare di proporre
un nuovo giudizio per l’aggiornamento o la prosecuzione del calcolo degli interessi maturati e dei danni sofferti,
dopo la sentenza impugnata - in quanto non si tratti di una domanda totalmente nuova,
sebbene di una domanda relativa a fatti sopravvenuti che si verificano dopo la sentenza
impugnata e che trovano ingresso in appello quale naturale sviluppo logico e
cronologico di richieste già proposte in primo grado.
In altri termini, in tanto ha senso derogare al divieto generale di domande nuove in appello, in quanto si eviti al
creditore di chiedere, in un autonomo successivo processo, interessi maturati - ovvero danni sofferti successivamente a quelli fatti valere in primo grado, con una richiesta quindi che non abbia lo
spessore di una domanda totalmente nuova. La ratio dell’economia dei giudizi a fondamento della
deroga risulterebbe completamente frustrata, se fosse consentito chiedere in appello ciò che è maturato dopo la
sentenza di primo grado (nella specie gli interessi e la rivalutazione posteriormente al 1986) ed in successivo,
autonomo giudizio tutto ciò che è maturato a titolo di danni o di interessi prima della sentenza di primo grado.
17
Il legislatore appare chiaramente ispirato al rispetto del principio, secondo cui la durata del processo non deve
andare a detrimento della parte vittoriosa, per cui in deroga al divieto di domande nuove in sede di gravame,
considera ammissibili in appello le domande relative agli interessi successivamente maturati o ai danni sofferti
posteriormente alla sentenza di primo grado, che solo parzialmente sono nuovi, sotto il profilo cronologico. Ed
infatti si tratta di interessi o danni che si verificano “dopo la sentenza impugnata”,
ossia nel corso del processo di appello, come il naturale sviluppo e la logica
prosecuzione di altri, già dedotti in primo grado. Di fronte a questi eventi, successivi
alla sentenza impugnata, l’ordinamento non può imputare al creditore di non averli
precedentemente richiesti, per cui introduce una deroga ai nova in sede di gravame. E
l’eccezione alla regola trova una sua ontologica giustificazione, perché realizza una diversità quantitativa e non
qualitativa dell’oggetto del giudizio di gravame, con riferimento al segmento cronologico posteriore all’emanazione
della sentenza appellata, che non intacca il principio dell’immutabilità del petitum in appello, nel senso che si
tratta di ulteriori elementi accessori che si sono venuti aggiungendo nella pendenza del
processo, e cioè, in definitiva, di un aggiornamento, di una prosecuzione, di
un’attualizzazione di richieste già formulate in precedenza.
La soluzione accolta, ispirata a criteri logico-sistematici, di fronte alla rilevata infelice formulazione della
disposizione dell’ultima parte del co. 1 dell’art. 345 c.p.c., appare in linea con i motivi-guida dalla riforma del
1990, sia in relazione alla mutata concezione dell’appello considerato come revisio prioris instantie e non come
novum iudicium, sia con la nuova sensibilità dimostrata per la più rigorosa trattazione del giudizio di primo
grado, con le preclusioni introdotte che hanno resistito anche all’ultima novella della riforma rappresentata dalla
legge 20.12.1995 n. 534.”
Nello stesso senso:
• “In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, l’art. 345 c.p.c. disponendo che è
ammissibile la domanda di risarcimento dei “danni sofferti” dopo la sentenza” di primo grado,
comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere
chiesti i danni riconducibili alla causa già dedotta in primo grado, atteso che la ratio della norma è
quella di evitare il frazionamento dei giudizi. (Nella specie, relativa a danni cagionati durante
lavori di scavo per l’installazione di cavi telefonici, la S.C. ha cassato la sentenza di
appello che, con motivazione apodittica, aveva ritenuto inammissibile la domanda con
la quale si chiedeva il risarcimento di danni manifestatisi successivamente all’inizio
della controversia, attribuendoli a carenze delle opere di risistemazione).”(Cassazione
civile, sez. III, 15 marzo 2006, n. 5678);
• “È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l’attribuzione di
interessi non reclamati in primo grado. Infatti, la deroga al divieto di novum in appello, coerentemente
con la ratio giustificativa della stessa - fondata su profili equitativi e di economia dei giudizi - è
ammissibile solo in quanto non si tratti di domanda totalmente nuova. Ne consegue che detta deroga è
consentita solo con riferimento ad interessi che non avrebbero potuto essere precedentemente richiesti.”
(Cassazione civile, sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2331; conforme cfr. Cass. 19 febbraio
2003 n. 2469);
• “La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello
solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti
in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in
primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove
indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo petitum,
costituisce inammissibile domanda nuova.”(Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 2006, n.
1054);
• “La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello
solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti
in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in
primo grado. La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti, implicando nuove
indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo petitum,
18
costituisce inammissibile domanda nuova.”(Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 1997, n.
9405).
In una sentenza del 2002 la Suprema Corte ha puntualizzato la ratio della deroga:
• “La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in
appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di
domanda che dipende strettamente da quella iniziale.”(Cassazione civile, sez. III, 23 luglio
2002, n. 10751).
Secondo la Cassazione la norma si applica anche al giudizio di rinvio:
• “Sebbene nel giudizio di rinvio le parti non possano rendere conclusioni diverse da quelle assunte nel
giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, alla luce di una lettura costituzionalmente
orientata delle norme di cui agli art. 394, comma 1 e 345, comma 1, c.p.c. (in particolare con
riferimento ai principi volti ad assicurare l’effettività della tutela dei diritti e la ragionevole durata del
processo), non può ritenersi nuova la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti
dopo la sentenza impugnata” (Cassazione civile, sez. I, 18 marzo 2008, n. 7256).
In tema di aggravamento del danno da lesioni:
• “In tema di eccezioni al divieto dello “ius novorum” in appello, la disposizione dell’art. 345, comma
2, c.p.c. ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti dopo la sentenza
impugnata. Con riferimento all’aggravamento dei postumi permanenti, e quindi dei danni già chiesti
nel giudizio di primo grado, occorre che esso si sia verificato successivamente alla sentenza di primo
grado o almeno al momento in cui esso aggravamento poteva essere dedotto dal danneggiato nella
domande proposte al primo giudice.” (Cassazione civile, sez. III, 16 maggio 2003, n. 7631);
• “In tema di lesioni personali, il diritto al risarcimento in relazione a eventuale aggravamento che si
verifichi nel corso del giudizio di primo grado non configura una nuova posta risarcitoria, poiché fa
parte della domanda originaria di risarcimento.”(Cassazione civile, sez. III, 16 novembre
2005, n. 23220).
La Corte di Cassazione ha equiparato al danno sopravvenuto il danno incolpevolmente
ignorato:
• “In tema di eccezioni al divieto dello “ius novorum” in appello, l’art. 345 c.p.c., ritenendo
ammissibile la domanda di risarcimento dei “ danni sofferti dopo la sentenza” di primo grado,
consente che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possano essere
chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti a
esistenza dopo la sentenza, sia quelli dei quali il danneggiato, pur usando l’ordinaria diligenza, non
sia stato in grado di rilevare l’esistenza e la portata pregiudizievole, anteriormente alla definizione del
giudizio di primo grado e alla data in cui ha proposto il gravame.” (Cassazione civile, sez. III,
31 marzo 2008, n. 8292):
• “In tema di eccezioni al divieto dello “ius novorum” in appello, l’art. 345 c.p.c., disponendo che è
ammissibile la domanda di risarcimento dei “danni sofferti dopo la sentenza” di primo grado,
comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere
chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad
esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, sia i danni dei quali il
danneggiato, pur usando l’ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l’esistenza e la
portata pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui
ha proposto il gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva
ritenuto ammissibile la domanda con la quale l’appellato - che non aveva censurato i
capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la liquidazione del danno
biologico e del danno da invalidità permanente, quantificata nella misura del 25% - nel
corso del giudizio di secondo grado aveva chiesto il risarcimento dei danni da
invalidità permanente nella misura del 100%, nonostante che dallo stesso atto di
appello risultava che, alla data in cui era stato proposto il gravame, egli già aveva piena
consapevolezza dell’aggravamento irreversibile dei danni sofferti).”(Cassazione civile,
sez. III, 29 gennaio 2003, n. 1281).
19
5. Il divieto di proporre nuove eccezioni, non rilevabili d’ufficio.
L’art.345, comma 2, come sostituito dall’art.52 della legge 26.11.1990 n.353, con decorrenza
dal 30.4.1995, ha eliminato il previgente testo della norma che ammetteva la proposizione di
nuove eccezioni nel giudizio di appello, limitandosi a sanzionare il comportamento della parte
che non aveva effettuato precedentemente tale deduzione senza una ragione giustificatrice con
la compensazione delle spese di appello.
Lo spirito generale della riforma processuale e l’obiettivo da questa perseguito di assicurare,
anche nel pubblico interesse, l’ordinata e rapida definizione dei giudizi, ha indotto il
Novellatore del 1990-1995 e delle successive modifiche e integrazioni a preoccuparsi di
raggiungere nella prima fase del procedimento di primo grado la cristallizzazione del thema
decidendum con l’ausilio di termini perentori che scandiscono la progressiva formazione delle
preclusioni assertive; coerentemente il Legislatore della riforma ha escluso la deducibilità nel
giudizio di appello di nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio.
Non è quindi consentito alla parte che sia incorsa in preclusione nel giudizio di primo grado
nel formulare una eccezione, processuale o di merito, non rilevabile d’ufficio, di rimediare a
tale situazione nel giudizio di appello.
Attualmente per il convenuto la soglia preclusiva è rappresentata ex art. 167 c.p.c. dal termine
per la costituzione tempestiva ex art. 166 c.p.c.; per l’attore in relazione alle eccezioni
consequenziali alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto, l’udienza
ex art.183 c.p.c.; per entrambe le parti, la seconda memoria ex art.183/6 per proporre le
eccezioni consequenziali alle domande ed eccezioni nuove; ovviamente soglie diverse potranno
riguardare le eccezioni processuali relative ad attività successivamente poste in essere nel corso
del giudizio.
Assolutamente essenziale per il corretto orientamento è l’individuazione delle eccezioni
rilevabili d’ufficio.
A tal riguardo la norma fondamentale è costituita dall’art.112 c.p.c. che vieta al giudice di
pronunciarsi d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Secondo l’opinione prevalente (in cui si iscrive Cass.civ. SS.UU. n.1099 del 3.2.1998) da tale
norma si ricava il principio che la regola è la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni, salvo quelle
riservate all’iniziativa delle parti; altri rimarcano che la norma dell’art.112 è in bianco e rivela
(senza individuarle) l’esistenza di eccezioni rimesse alle parti, in deroga al principio generale.
Talora si distingue fra eccezioni proprie e improprie.
Queste ultime si traducono nella negazione dei fatti costitutivi o in c.d. mere difese.
Le eccezioni proprie attengono ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ossia contrastanti i
fatti costitutivi avversari.
Si distingue inoltre fra eccezioni proprie in senso stretto e eccezioni proprie in senso lato.
Le eccezioni proprie in senso stretto attengono all’esercizio di un potere espressamente
attribuito dalla legge alla parte o da collegare ad una fattispecie azionabile con azione
costitutiva.
Le eccezioni proprie in senso lato operano invece ipso jure e si considerano implicitamente
negate nell’allegazione avversaria del fatto costitutivo e sarebbero pertanto rilevabili d’ufficio
(pagamento, risoluzione consensuale, del contratto, difetto di legittimazione attiva, giudicato
interno, nullità del contratto, vedi però infra).
Con un importante intervento del 2005 – relativo all’ eccezione di interruzione di prescrizione,
la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile, sez. un., 27 luglio 2005, n. 15661) ha
riaffrontato funditus la materia, richiamando il proprio precedente e affermando:
• “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di
parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla
parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’ eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa,
impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà
della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’ eccezione di interruzione
20
della prescrizione integra un’ eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere
rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi
escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale)
rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’ eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di
diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una
controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione.”
Analogamente, di recente:
• “L’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere
rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sempreché l’allegazione del
fatto interruttivo - ove effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente compiuta con i
motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni poste all’esame del giudice del gravame e le
ragioni che si intendono far valere in tale sede, così cristallizzando il thema decidendum su cui il
giudice è chiamato a pronunziarsi, dovendosi escludere che la mera indicazione nelle «premesse in
fatto» e nella parte espositiva dell’atto d’appello sia idonea a soddisfare detto onere.”(Cassazione
civile, sez. lav., 9 aprile 2009, n. 8710).
Nella sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, si legge :
“Con esso il ricorrente pone alla Corte la questione se l’eccezione di interruzione della prescrizione debba
considerarsi come eccezione in senso lato, ossia rilevabile anche dal giudice in ogni stato e grado del processo
purché sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, oppure come eccezione in senso stretto, ossia non
rilevabile d’ufficio e perciò assoggettata, nel processo del lavoro, alle preclusioni disposte nei capoversi degli artt.
416 e 437 cod.proc.civ. (e nel processo ordinario nell’art. 345, secondo comma, dello stesso codice).
È da osservare che il legislatore presuppone la distinzione tra i due tipi di eccezione, ma non la definisce e
l’affida così all’interprete: infatti l’art. 112 cod.cit., secondo cui il giudice non può
pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti,
suole essere considerato come norma in bianco, ossia da completare in sede di
applicazione quanto alla nozione di eccezione officiosa oppure riservata all’iniziativa
di parte.
Talvolta è lo stesso legislatore ad esonerare l’interprete da questo compito, escludendo espressamente la
rilevabilità d’ufficio: così, fra i numerosi possibili esempi, nell’art. 1242, primo comma, cod.civ. quanto
all’eccezione di compensazione; nell’art. 1442, quarto comma, quanto all’eccezione di annullabilità del
contratto; nell’art. 1460, primo comma, quanto all’eccezione di inadempimento; e, per ciò che più da vicino
attiene alla materia qui in questione, nell’art. 2938 quanto all’eccezione di prescrizione.
Al di fuori di questi casi, nei quali l’interprete deve semplicemente uniformarsi alla chiara lettera della legge, la
nozione di eccezione in senso stretto è rimasta a lungo controversa anche nella giurisprudenza di questa Corte, la
quale tuttavia con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, 3 febbraio 1998 n. 1099, ha provveduto alla
sistemazione della materia.
La semplice contestazione dei fatti posti dall’attore a base della propria pretesa viene considerata come “mera
difesa” (non è stato accolto il termine “obiezione”, proposto dalla dottrina fra le due guerre) mentre
l’ammissione di quei fatti, accompagnata dalla deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi (ad es. il
pagamento del debito), è definita come “eccezione in senso lato”.
La suddetta sentenza considera come “eccezione in senso stretto” quella consistente nella contrapposizione, da
parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall’attore, attribuiscano per
legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell’avversario. In
questi casi, aggiungono le Sezioni unite, il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di
determinati fatti non ha di per sé efficacia modificativa, impeditiva o estintiva, ma la consegue per il tramite di
una manifestazione di volontà dell’interessato, da sola ovvero seguita da un accertamento giudiziale.
Le Sezioni unite si riferiscono in tal modo all’esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di
annullamento, di rescissione, di risoluzione), il cui esercizio in giudizio da parte del titolare è necessario perché si
verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi la manifestazione della volontà dell’interessato
come elemento integrativo della fattispecie difensiva esclude che, pur acquisita al processo la conoscenza di fatti
rilevanti, possa il giudice desumerne l’effetto senza l’apposita istanza di parte.
21
Soltanto a questa è rimessa la scelta del mezzo difensivo, così che l’interesse a valersi dell’eccezione non è
necessariamente legato all’interesse a resistere alla pretesa attrice e, ulteriore conseguenza, la volontà di non
valersi di quel mezzo rende facilmente tollerabile - per usare espressioni di una ormai risalente dottrina l’eventuale ingiustizia della sentenza: la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria
assenza di volontà.
La nozione di eccezione in senso stretto accolta nella sentenza n. 1099 del 1998 viene riaffermata dalle stesse
Sezioni unite con la sent. 25 maggio 2001 n. 226, in tema di rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di giudicato
esterno, nonché dalle sentenze 1° aprile 2004 n. 6450, 8 aprile 2004 n. 6943 e 21 agosto 2004 n. 16501.
4. Malgrado la sistemazione della materia nel senso testè illustrato, sulla questione, ora in esame, della
qualificazione dell’eccezione di interruzione della prescrizione, permane un contrasto di giurisprudenza.
Prima della citata pronuncia di queste Sezioni unite n. 1099 del 1998 la giurisprudenza della Corte la
definiva costantemente come eccezione in senso stretto, non affrontando però la generale questione del concetto di
eccezione processuale e le relative distinzioni, ma semplicemente parlando di “controeccezione”, da opporre a
quella, omogenea, di prescrizione (tra le numerose, Cass. 7 dicembre 1996 n. 10904, 1° ottobre 1997 n.
9583, 25 ottobre 1997 n. 10526).
Non mancava tuttavia una giurisprudenza secondo cui, estintosi il giudizio ed iniziato un nuovo processo, il
giudice di questo poteva rilevare l’interruzione istantanea, prodotta dal primo atto introduttivo ex art. 2945,
terzo comma, cod.civ., in presenza della sola eccezione di prescrizione (Cass. 6 agosto 1966 n. 2167, 24
ottobre 1974 n. 3111, 24 ottobre 1978 n. 4810).
L’affermazione dell’eccezione in senso stretto permaneva anche dopo la sent. n. 1099 del 1998, con numerose
pronunce, che unificavano ancora il regime dell’eccezione ex art. 2938 e della controeccezione, senza peraltro
confutare, almeno espressamente, gli argomenti di detta sentenza (tra le più recenti,Cass. 20 giugno 2002 n.
9016, 27 giugno 2002 n. 9378, 12 luglio 2002 n. 10137, 14 novembre 2002 n. 16032, 28 luglio 2003 n.
15188, 14 luglio 2004 n. 14276).
Cass. 25 marzo 2002 n. 4219 contrasta esplicitamente la sentenza delle Sezioni unite attraverso il richiamo al
principio di speditezza del processo, che verrebbe ostacolato dalla rilevabilità officiosa dell’eccezione in questione
in ogni stato e grado; di questa pronuncia si dirà oltre.
L’opposta asserzione, ossia quella della rilevabilità d’ufficio, si trova in Cass. 28 marzo 2000 n. 3276, la
quale ritiene che l’eccezione di prescrizione devolva al giudice l’accertamento di ogni fatto relativo alla vicenda
estintiva, compreso quello interruttivo, il cui rilievo è perciò sottratto all’iniziativa esclusiva della parte
interessata. L’argomentazione di questa soluzione è espressamente appoggiata sul qui più volte citato precedente
del 1998.
5. Non ritengono ora queste Sezioni unite che fra l’eccezione di prescrizione, ascritta dall’art. 2938 cod.civ. al
novero delle eccezioni in senso stretto, e la controeccezione di interruzione ex artt. 2943-2945, di natura non
definita dal legislatore, sussista una somiglianza tale da consentirne la stessa disciplina processuale. Né il
principio di speditezza, ora espressamente canonizzato nel capoverso dell’art. 111 Cost. e da bilanciare sempre
con le garanzie di difesa di cui al precedente art. 24 (Cass. 22 aprile 2005 n. 8540), permette di ravvisare
preclusioni processuali prive di base normativa ed anzi contrarie ad un sistema legale che vede come eccezionale,
per quanto detto sopra, la riserva alla parte del potere di eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi del
diritto soggettivo dedotto in giudizio.
Nessuno sostiene che l’eccezione di interruzione, vale a dire l’affermazione dell’avvenuto compimento di un atto
d’esercizio del diritto, giudiziale o stragiudiziale (art. 2943 cod.civ.) oppure dell’altrui riconoscimento (art.
2944), corrisponde al contenuto di un diritto potestativo di realizzazione giudiziale ossia ad un’azione
costitutiva e perciò stesso possa senz’altro ricondursi alla figura delle eccezioni in senso stretto non di espressa
previsione legale.
Ma deve altresì escludersi che a questo risultato possa condurre un’asserita identità di sostanza fra l’eccezione di
prescrizione e quella di interruzione, tale da permettere la sussunzione di quest’ultima, pur sempre e per ragioni
di sostanza, sotto la previsione dell’art. 2938.
Il titolare passivo del diritto soggettivo dedotto in giudizio dall’attore, ossia il debitore oppure il proprietario
quanto ai diritti reali limitati (l’istituto della prescrizione estintiva è di portata generale, come risulta dall’art.
2934: “ogni diritto”), fu correttamente definito in dottrina come a sua volta titolare di un diritto potestativo di
provocare l’estinzione del diritto trascurato, ottenendo la liberazione dal debito oppure dal peso gravante sul
22
proprio fondo. Infatti l’effetto estintivo della prescrizione non si produce automaticamente allo scadere del termine
ma entra nella disponibilità del soggetto passivo del diritto, cosiddetto “prescrivente”, il quale decide se sollevare
o meno la relativa eccezione. Ciò spiega perché l’art. 2937, primo comma, parli di irrinunciabilità della
prescrizione da parte di “chi non può validamente disporre del diritto”. Questa espressione, introdotta col codice
del 1942 e assente in quello del 1865, si riferisce verosimilmente alla non disponibilità della materia
controversa, anche se può rilevarsene l’improprietà giacché colui che rinunzia alla prescrizione non è il titolare
del diritto prescritto bensì il soggetto passivo, che della prescrizione potrebbe avvalersi. L’espressione impropria,
che attribuisce un “diritto” al prescrivente, spiega in ogni caso perché la scadenza del termine di prescrizione sia
stata definita come species adquirendi a favore del prescrivente (cfr. da ult. Cass. 24 marzo 1994 n. 3445), in
conformità all’antico carattere unitariamente acquisitivo delle prescrizioni, oggi distinte in usucapione e
prescrizione estintiva: carattere unitario posto in evidenza dai romanisti e conservato nell’art. 2105 cod.civ.
1865, secondo cui la prescrizione è “il mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate,
taluno acquista un diritto o è liberato dall’obbligazione” (la liberazione comporta l’acquisto di una posizione di
vantaggio).
Esclusi i casi eccezionali di rilevabilità d’ufficio della prescrizione (cfr. Cass. 16 agosto 2001 n. 11140), la
scadenza del termine attribuisce al titolare passivo del diritto prescrivendo la potestà di farne valere l’effetto
estintivo o, al contrario, di non giovarsene, preferendo di servirsi di altri mezzi di difesa in giudizio: per tali
ragioni il legislatore include l’eccezione di prescrizione fra quelle in senso stretto.
6. Diverso è il carattere dell’eccezione di interruzione. Qui l’attore, di fronte all’eccezione di prescrizione, non
può considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio ma semplicemente è
in grado di contrapporre all’eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva. L’interesse a giovarsi di questo
atto è compreso nell’interesse sottostante il diritto azionato, né certo potrebbe sottostare ad una distinta azione
costitutiva. Il legislatore collega immediatamente l’effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944
cod.civ. onde l’eccezione non amplia i termini della controversia ma - come si è rilevato in dottrina - concorre a
realizzare l’ordinamento giuridico nell’orbita della domanda, su cui il giudice deve pronunciarsi tota re
perspecta, ossia prendendo in considerazione d’ufficio gli atti interruttivi.
Spetta dunque a lui di decidere la questione di prescrizione, ritualmente introdotta dal convenuto attraverso
l’eccezione di cui all’art. 2938, tenendo conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima dell’eccezione, idoneo a
produrre l’interruzione, qualora l’attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente e rettamente provandone
sussistenza e persistenza.
La situazione processuale non è diversa da quella che si verifica a proposito dell’eccezione di rinuncia alla
prescrizione, che questa Corte quasi sempre ritiene rilevabile d’ufficio (Cass. 13 ottobre 1976 n. 3409, 7
febbraio 1996 n. 963, 14 maggio 2003 n. 7411).
Non vale affermare in contrario, come fa Cass. n. 9209 del 2002 cit., che eccezione di prescrizione ed eccezione
di interruzione sono caratterizzate dalla medesima natura e debbono essere assoggettate allo stesso regime a fini
di speditezza del procedimento e per “sgombrare il campo dalla questione”: il principio di speditezza, già
implicito nell’art. 24 Cost. ed ora espresso, come s’è ricordato, nel capoverso dell’art. 111, si realizza nelle
forme di legge (“... La legge ne [del processo] assicura la ragionevole durata”) e non comporta l’obliterazione
della distinzione fra eccezioni rilevabili d’ufficio e non, voluta dal legislatore.
In altre parole la sent. n. 9209 del 2002 opera una completa assimilazione fra eccezione in senso stretto e
controeccezione, che è priva di fondamento positivo: si pensi all’eccezione di compensazione ed alla
controeccezione di pagamento.
In conclusione si deve affermare il principio di diritto secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione, in
quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo
sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.
Nel caso di specie la sentenza impugnata non nega la rituale produzione del documento epistolare di contenuto
interruttivo, né la produzione è negata dal controricorrente, il quale nell’ultima pagina del suo scritto difensivo vi
fa esplicito riferimento (lettera 5 luglio 1996), limitandosi a negarne la provenienza dal creditore, ossia dal
soggetto legittimato ad interrompere la prescrizione. È altresì pacifico il detto contenuto interruttivo, ossia la
manifestazione della pretesa creditoria, avente ad oggetto la prestazione previdenziale (cfr. Cass. 28 giugno
1979 n. 3618, 27 giugno 1997 n. 5733).”
23
Con altra decisione, di notevole importanza, le Sezioni Unite hanno sancito altresì la rilevabilità
d’ufficio del giudicato esterno risultante ex actis:
• “Il giudicato esterno risultante da atti prodotti nel giudizio di merito è rilevabile, anche d’ufficio, in
sede di legittimità.”(Cassazione civile, sez. un., 17 ottobre 2002, n. 14750).
Recentemente il Supremo Collegio ha precisato:
• “Ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori
di quelle rilevabili anche d’ufficio, mentre sono proponibili le mere difese, che si differenziano dalle
prime poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese. Le difese, le
argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione non
costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico le quali sono costituite da quelle ragioni delle
parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l’allegazione a opera delle stesse parti.
Deriva da quanto precede, pertanto, che eventuali preclusioni in appello non riguardano i fatti e le
argomentazioni, posti a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di
esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione,
deve - a sua volta - pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti,
le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione.”(Cassazione
civile, sez. I, 1 luglio 2008, n. 17954).
Ora procediamo ad una rassegna casistica della giurisprudenza recente della Suprema Corte in
tema di nuove eccezioni ritenute ammissibili o inammissibili in appello.
5.1. Eccezioni inammissibili:
•
•
•
•
Eccezione di prescrizione: “L’eccezione di prescrizione del diritto della controparte di accettare
l’eredità, tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado dopo la chiusura dell’istruttoria e la
rimessione della causa al collegio, è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ove proposta per la
prima volta con l’atto di appello.”(Cassazione civile, sez. II, 17 aprile 2009, n. 9303);
Eccezione di invalidità del recesso: “L’eccezione di mancata prova dell’avvenuto recesso,
nonché della sua invalidità o efficacia, sollevata al fine di resistere alla domanda di liquidazione della
quota proposta dal socio asseritamente receduto, costituisce eccezione in senso stretto, in quanto ha ad
oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall’attore; pertanto, essa non è deducibile la
prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le
argomentazioni con cui si contrasta genericamente l’avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti
impeditivi o modificativi del diritto esercitato.”(Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2009, n.
816);
Eccezione di comproprietà del muro modificata in eccezione di proprietà
esclusiva:“In tema di nuove eccezioni in appello, ai sensi dell’art. 345 comma 2 c.p.c., non è
legittimo il richiamo alla categoria dei diritti autodeterminati (la proprietà e gli altri diritti reali di
godimento), in virtù della quale essi, non essendo condizionati dal titolo, si identificano con la stessa
“causa petendi”, per sostenere, nella controversia riguardante, come nella specie, l’incorporazione di
un muro dello stabile condominiale, il mutamento in appello delle proprie difese, assumendosi la
proprietà esclusiva di detto muro allorquando nel primo grado si era eccepito che la sua utilizzazione
per costruire un nuovo vano non aveva ecceduto i limiti fissati dagli art. 1102 e 1120 c.c. Infatti,
tale mutamento interessa non già o non solo il titolo, quanto direttamente il contenuto del diritto fatto
valere, giacché la comunione di beni (art. 1102 c.c.,) consiste nella contitolarità del diritto reale,
caratterizzata proprio dalla non illimitatezza delle facoltà spettanti a ciascun comunista, il cui
esercizio incontra un limite nel diritto dell’altro, situazione affatto diversa da quella che si riscontra
nella proprietà esclusiva (art. 832 c.c.), derivandone una diversità sostanziale tra le due situazioni
giuridiche soggettive, che non può non proiettarsi sul contenuto dei rispettivi diritti. “(Cassazione
civile, sez. II, 23 novembre 2007, n. 24446);
Eccezione di avveramento della condizione : “In tema di divieto di nuove eccezioni in
appello, proposta e respinta in primo grado la domanda di condanna per inadempimento, è
inammissibile l’eccezione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., formulata dall’appellante
per la prima volta con la comparsa conclusionale, trattandosi non di una mera argomentazione a
24
•
sostegno della domanda di condanna, ma di una “causa petendi” del tutto autonoma da quella fatta
valere in precedenza.”(Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2007, n. 20319).
Eccezione di pegno irregolare: “Il convenuto non può dedurre per la prima volta in grado di
appello - ostandovi il divieto di nuove eccezioni posto dall’art. 345 comma 2 c.p.c., nel testo
modificato dalla l. n. 353 del 1990 - il carattere irregolare, anziché regolare, del pegno, ove non
abbia già dedotto in primo grado la circostanza (di fatto) che distingue il primo dal secondo, e cioè che
era stata espressamente conferita al creditore pignoratizio la facoltà di disporre del bene che ne è
oggetto.”(Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2007, n. 10629).
5.2. Eccezioni ammissibili:
•
•
•
Eccezione di acquisto della comproprietà dell’immobile condotto in locazione:
“Per accertare se una certa eccezione sia, o meno, proponibile per la prima volta in grado di appello
deve aversi presente il carattere dell’eccezione. Se, in particolare, con questa la parte indica
sopravvenienze che operano come fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere in
primo grado, l’eccezione può essere formulata per la prima volta in appello, giacché quei fatti non
sono elementi negativi della fattispecie, analogamente a quelli che l’art. 112 c.p.c. considera come
normalmente rilevabili. Il divieto di allegazione in appello, infatti, non riguarda i fatti e le
argomentazioni posti dalle parti a fondamento della domanda o dell’eccezione e che costituiscono
oggetto di accertamento e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto
della impugnazione, deve pronunciarsi sulla domanda o sull’eccezione proposte davanti al primo
giudice, riesaminando i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per
la decisione. Diversamente accade se l’eccezione è del tipo di quelle che soddisfano solo esigenze
individuali e possono essere fatte valere se tempestivamente indicate nel giudizio. Per queste il giudice,
come deve provvedere solo se proposte e non oltre i limiti di esse, così non può esaminare le ragioni
estintivi, modificative o impeditive che per legge devono essere proposte dalla parte interessata. (Nella
specie la domanda di condanna al rilascio dell’immobile locato era stata contrastata, in sede di
comparsa di costituzione, dalla conduttrice che aveva negato l’esistenza delle ragioni costitutive della
pretesa. La stessa conduttrice, inoltre, ancorché nel corso del giudizio di primo grado avesse acquistato
una quota del bene immobile condotto in locazione, ha formulato la relativa eccezione solo in grado di
appello. In applicazione dei principi di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto che il richiamo,
nell’atto dell’appello incidentale, dell’acquisto della proprietà di una quota dell’immobile prospettava
una ragione impeditiva della pretesa del locatore e non era una eccezione riservata alla
parte).”(Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 2008, n. 19678);
Eccezione riconvenzionale di usucapione in presenza di incertezza soggettiva
sul confine: “In tema di nuove eccezioni in appello, secondo la disciplina dell’art. 345 c.p.c., nella
formulazione anteriore alla riforma introdotta con la l. 26 novembre 1990 n. 353, poiché la
proposizione dell’eccezione riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto per regolamento di
confini non comporta la trasformazione in revindica dell’azione proposta, giacché il convenuto, con
tale eccezione, non contesta l’originario titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad
opporre una situazione sopravvenuta, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta
incertezza del confine, l’eccezione suddetta non è ammissibile, ai sensi del citato articolo 345 c.p.c.,
tutte le volte in cui l’incertezza del confine abbia carattere oggettivo. Si verifica tale ipotesi nel caso di
promiscuità del possesso della zona confinaria, situazione che è di per sé incompatibile con
l’esclusività del possesso quale requisito necessario per l’usucapione. Essa è invece proponibile soltanto
in caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l’attore sostenga che il confine apparente non è
quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.”(Cassazione
civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12481);
Eccezione di diversa data di decorrenza della prescrizione: “Le eccezioni vietate in
appello, ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non
rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere
alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle
acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o
25
•
“improprie”. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata
sentenza che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata
eccezione di prescrizione nell’allegazione addotta in appello circa l’individuazione della diversa data
di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).”(Cassazione
civile, sez. II, 21 maggio 2007, n. 11774);
Eccezione di giudicato esterno: “Con riguardo a giudizio promosso anteriormente al 30
aprile 1995 e soggetto, pertanto, all’art. 345 c.p.c. nella sua previgente formulazione, sono
ammissibili in grado di appello nuove eccezioni. Deve, peraltro, escludersi che qualora il giudice di
secondo grado accolga una eccezione (nella specie: di giudicato esterno) tardivamente proposta in primo
grado e riproposta con l’atto di appello privi il soccombente di un grado di giudizio e determini altresì
una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che possono giovarsi della disciplina
sopravvenuta introdotta con l’art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353 che ha escluso la proponibilità di
nuove eccezioni in appello. Tale disparità di trattamento, infatti, è giustificata dalla successione delle
leggi nel tempo, la quale non può impedire che per i giudizi introdotti successivamente all’entrata in
vigore della nuova disciplina questa debba trovare applicazione, anche se comporti effetti di minore
favore per taluna delle parti.”(Cassazione civile, sez. un., 17 maggio 2007, n. 11334).
6. L’onere di riproposizione delle domande e eccezioni non accolte.
L’art.346 sanziona con una presunzione di rinuncia (che non ammette prova contraria e si
risolve quindi in una vera e propria decadenza) la mancata espressa riproposizione nel giudizio
di appello delle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado.
La questione principale implicata dalla norma e dall’onere ad essa relativo riguarda
l’individuazione del concetto di “non accoglimento”.
Ovviamente il problema non si pone per la domanda che sia stata espressamente rigettata o
sia stata implicitamente rigettata per effetto di una “omessa pronuncia”; non solo essa deve
essere riproposta nel giudizio di appello ma dovrà essere sviluppato un motivo specifico per
censurare in sede di impugnazione le ragioni del rigetto o la circostanza dell’omesso esame.
Un po’ diversamente si atteggia il ragionamento per le eccezioni.
Occorre al riguardo considerare innanzitutto le eccezioni preliminari e pregiudiziali respinte
dal Primo Giudice che abbia però successivamente nel merito dato ragione alla parte
soccombente sull’eccezione pregiudiziale.
In tale ipotesi sicuramente la parte soccombente sulla pregiudiziale e vittoriosa nel merito deve
riproporre l’eccezione, ma secondo l’opinione prevalente ciò non le è sufficiente, giacché essa
deve inoltre presentare tempestivamente e validamente appello incidentale condizionato sul
punto, proponendo gli specifici motivi di critica del decisum.
Al proposito con riferimento alla eccezione di difetto di giurisdizione occorre ricordare la
recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui:
• “La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione
della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello
incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera
riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante
l’inapplicabilità del principio di rilevabilità d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e
la non applicabilità dell’art. 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali
non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni
autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’art.
329, comma 2, c.p.c., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di
acquiescenza.”(Cassazione civile, sez. un., 16 ottobre 2008, n. 25246).
La citata sentenza ha analizzato compiutamente la funzione sistematica dell’art.346 c.p.c,
distillando i seguenti principi:
• la norma considera quelle domande ed eccezioni a cui possa essere riconosciuto
carattere d’autonomia rispetto alle altre domande ed eccezioni proposte e sollevate nel
giudizio;
26
•
il contenuto specificamente decisorio di una sentenza può ben essere costituito anche
dalla risoluzione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito;
• la legge con l’espressione “non accolte”, utilizzata in luogo dei termini “rigettate” o
“respinte”, ha inteso fare riferimento a situazioni diverse da quella costituita da
un’espressa pronunzia negativa sulla domanda o sull’eccezione,
• tale espressione considera quelle diverse ipotesi decisionali nelle quali il mancato
accoglimento non si risolve in un’espressa reiezione ma nella pretermessa valutazione
delle domande e delle eccezioni considerate, quali l’omessa pronunzia o la pronunzia,
implicita od esplicita, d’assorbimento;
• la disposizione in questione non si riferisce a domande “respinte”, perché altrimenti si
porrebbe in contrasto con il principio della soccombenza e con le regole
sull’introduzione del processo di gravame;
• se una domanda o una eccezione autonoma è stata espressamente e motivatamente
respinta, l’attività processuale della parte interessata ad ottenere una difforme
statuizione al riguardo non ricade nell’ambito dell’art. 346 c.p.c., che consente la
semplice riproposizione della domanda o dell’eccezione autonome ma sulle quali non
si sia avuta una decisione, ma deve ritenersi disciplinata dall’art. 329 c.p.c., comma 2,
che, coerentemente con il principio della soccombenza, sancisce l’onere
dell’impugnazione delle decisioni autonome sfavorevoli;
• la critica svolta, deve possedere la sostanza dell’impugnazione e come tale deve essere
valutata e ciò, proprio in quanto proveniente dall’appellato ed avente ad oggetto
questioni del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell’impugnazione principale,
anche in funzione delle condizioni di forma e di tempo della sua ammissibilità;
• l’esigenza dell’appello incidentale si giustifica non solo con la soccombenza rispetto
alla singola eccezione, ma anche alla luce dell’interesse pratico e concreto che diventa
attuale nel momento in cui il giudice si dovesse persuadere della fondatezza dei
motivi addotti con l’appello principale.
La sentenza citata così va argomentando:
“ A partire dall’inapplicabilità del principio della rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e
grado del processo, pur a volte invocato da quanti sostengono che al riguardo non possa, per ciò, formarsi
giudicato alcuno: è, per contro, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che tale principio
possa trovare piena applicazione solo ove sulla giurisdizione non esista una precedente statuizione (oppure se la
lite non sia già passata al vaglio delle Sezioni Unite); quando, invece, l’anzidetta statuizione sia intervenuta, il
principio medesimo va coordinato con il sistema delle impugnazioni e delle relative preclusioni, che determina la
formazione progressiva del giudicato, posto a salvaguardia dell’ordinato svolgimento del processo, nel senso che,
qualora una delle parti abbia sollevato la questione in primo grado ma non abbia, poi, ritualmente espresso le
proprie doglianze contro la decisione giudiziale sfavorevole emessa sul punto, questa passa in giudicato e preclude
ogni ulteriore contestazione, onde i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della questione di
giurisdizione soltanto se vi sia stata impugnazione al riguardo (o se sia stata “riproposta con l’impugnazione”,
espressione equivoca della quale in seguito), essendo tenuti, diversamente, ad applicare il disposto dell’art. 329
c.p.c., ed a rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione stessa ……
A seguire, contrastano la tesi in esame considerazioni che derivano, in particolare, dall’esame del tenore letterale
dell’art. 346 c.p.c. (disposizione la cui esegesi non può prescindere da un coerente coordinamento con il complesso
delle altre pertinenti e connesse disposizioni della normativa processuale civilistica ………
Nella qual disposizione, anzi tutto, devesi ritenere sia fatto riferimento alle domande ed alle eccezioni
cui possa essere riconosciuto carattere d’autonomia rispetto alle altre domande ed
eccezioni proposte e sollevate nel giudizio, id est che siano tali da dar luogo ad un esame separato e
ad una decisione dotata d’una propria portata precettiva e basata su ragioni necessariamente distinte ed
indipendenti rispetto alle ragioni giustificatrici delle decisioni rese sulle dette altre domande ed eccezioni;
diversamente, come desumibile anche dal disposto dei due commi dell’art. 336 c.p.c., una loro disciplina
separata e specifica, con l’espressa previsione dell’onere di riproposizione, pena la presunzione di rinunzia, non
sarebbe stata necessaria, in quanto sarebbero rimaste regolate dalla disciplina dettata da quest’ultima norma, id
27
est seguirebbero la sorte delle domande e delle eccezioni rispetto alle quali esse fossero risultate collegate da un
qualsivoglia nesso logico di consequenzialità-dipendenza.
In proposito, quale che sia la posizione che si voglia assumer in ordine alla vexata quaestio del significato da
attribuire alla locuzione “parte di sentenza” contenuta nell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c. - ogni
singola questione; od ogni domanda sostanziale; o piuttosto, come sembra preferibile, ogni singola statuizione
risolutiva d’una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia sì da dar luogo ad un
decisum del tutto indipendente da quelli resi sulle altre questioni, cui debba riconoscersi carattere imperativo non può che prendersi atto dell’opinione, ampiamente accolta in dottrina ed in giurisprudenza (per quest’ultima
vedasi già la fondamentale Cass. SS.UU. 28.4.76 n. 1506) secondo la quale la decisione sulla questione di
giurisdizione, sia in senso negativo eppertanto conclusiva del giudizio, sia in senso positivo eppertanto
introduttiva alle ulteriori decisioni sulle altre questioni (pregiudiziali o di merito), da luogo ad una pronunzia di
carattere autonomo nel senso indicato e ciò anche sulla scorta del diritto positivo.
Tale autonomia si ricava, anzi tutto, dal fatto che, sebbene si ponga sempre in funzione dell’esame del merito
della lite, è la questione di giurisdizione a condizionare le altre e non viceversa, dacchè l’esame della
contestazione in ordine al potere decisorio del giudice, in quanto carente di giurisdizione, non può essere
condizionato al risultato della lite inerente al merito ………
Autonomia che è, comunque, anche testualmente desumibile dall’art. 382 c.p.c., che contiene la previsione
d’un’apposita statuizione sulla giurisdizione; dall’art. 187 c.p.c., che consente al giudice istruttore di rimettere le
parti al collegio per la decisione delle questioni idonee di per sè sole a definire il giudizio, ove trattisi tanto di
questioni preliminari di merito, quanto di questioni attinenti, appunto, alla giurisdizione, o alla competenza, o
ad altre pregiudiziali di contenuto processuale; dall’art. 279 c.p.c., n. 4, che, a seguito della detta rimessione,
prevede, poi, la decisione di tali questioni non mediante ordinanza, ma con sentenza, pur ove in tale occasione il
collegio non definisca il giudizio ed adotti, con separata ordinanza, distinte determinazioni per l’ulteriore
istruzione della causa; ancora, dall’art. 276 c.p.c., che espressamente ravvisa un oggetto di distinte attività e
funzione decisorie nella soluzione delle questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio.
Se ne è correttamente desunto che il contenuto specificamente decisorio di una sentenza può
ben essere costituito anche dalla risoluzione di questioni pregiudiziali di rito o
preliminari di merito, che da luogo ad autonome parti di sentenza, alle quali va riconosciuto, per ciò, il
carattere dell’imperatività, eventualmente tali da esaurire del tutto il contenuto della sentenza stessa, sia che
trattisi di decisione definitiva, sia che trattisi di decisione non definitiva, nel qual ultimo caso le parti, malgrado
la prosecuzione del giudizio, hanno, ex art. 340 c.p.c., il preciso onere di proporre appello immediato, o riserva
d’appello, pena il passaggio in giudicato e l’immutabilità di tale decisione nel prosieguo della controversia.
Ciò stante, non sembra logico sostenere che la medesima autonoma decisione sull’eccezione pregiudiziale o
preliminare comporti l’onere dell’impugnazione specifica ove adottata con sentenza non definitiva, o con sentenza
che definisce il giudizio in funzione della detta sola eccezione pregiudiziale o preliminare, e non lo comporti, per
contro, ove costituisca una delle più parti, o pronunzie dotate d’autonoma rilevanza, nelle quali può articolarsi
una sentenza definitiva che pronunzi anche sul merito sostanziale o processuale; al riguardo, la opinione
dottrinaria che ravvisa, per l’ipotesi della sentenza non definitiva, una deroga normativa alla regola generale
della riproponibilità in luogo dell’impugnabilità non fornisce, tuttavia, di tale assunta deroga, apprezzabili
ragioni giustificative.
Tornando all’esame del tenore letterale dell’art. 346 c.p.c., devesi ancora considerare come con l’espressione
“non accolte” il legislatore - cui va riconosciuta un’adeguata precisione terminologica, non essendo ancora
invalso, all’epoca di redazione della norma, l’uso di endiadi per esprimere un concetto negativo già utilmente
definito da un appropriato vocabolo - abbia evidentemente inteso, avendola utilizzata in luogo dei termini
“rigettate” o “respinte”, fare riferimento a situazioni diverse da quella costituita da
un’espressa pronunzia negativa sulla domanda o sull’eccezione, e ritenuto, piuttosto, di
regolare quelle diverse ipotesi decisionali nelle quali il mancato accoglimento non si coniuga con un’espressa
reiezione ma con la pretermessa valutazione delle domande e delle eccezioni considerate,
quali l’omessa pronunzia o la pronunzia, implicita od esplicita, d’assorbimento; anche
perchè, ove si fosse fatto effettivo riferimento a domande “respinte”, la norma si porrebbe in contrasto con il
principio della soccombenza e con le regole sull’introduzione del processo di gravame, per le quali la
28
riproposizione in secondo grado delle domande e delle eccezioni autonome rigettate in primo richiede la forma del
gravame principale o incidentale.
Per il vero, anche l’interpretazione per la quale con la locuzione “non accolte” il legislatore avrebbe inteso fare
riferimento alle domande ed eccezioni pretermesse od assorbite è stata assoggettata a critica da quella parte della
dottrina che è pervenuta alla conclusione di considerare il riferimento stesso fatto non alla domanda giudiziale
nel suo complesso, quanto piuttosto alle varie possibili articolazioni di essa, alle ragioni o motivi sui quali si
basa, piuttosto che al suo insieme in sè e per sè considerato.
In ogni caso, come ritenuto da autorevole dottrina e da numerose pronunzie di questa Corte, in presenza
d’una domanda o d’un’eccezione autonome espressamente e motivatamente respinte,
l’attività processuale della parte interessata ad ottenere una difforme statuizione al riguardo non può
considerarsi disciplinata dall’art. 346 c.p.c., che consente la semplice riproposizione della domanda o
dell’eccezione - pur autonome ma sulle quali non siasi avuta una decisione o, seguendo diversa teoria, non
autonome ed interne al capo di domanda deciso - bensì deve ritenersi disciplinata dall’art. 329 c.p.c.,
comma 2, per il quale, coerentemente con il principio della soccombenza, le decisioni autonome sfavorevoli
contenute nella sentenza debbono formare oggetto di puntuale impugnazione, principale od incidentale, ad opera
della parte interessata, pena la presunzione d’acquiescenza.
Il che, d’altronde, è coerente con la natura del giudizio d’appello, configurato nell’attuale ordinamento non quale
iudicium novum ma quale revisio prioris instantiae, e con la consequenziale previsione della specificità dei motivi
d’impugnazione, per la quale si richiede che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano
contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le
statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, onde alla parte volitiva
dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, se pure nei limiti consentiti dalla correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
In vero, a fronte della motivata reiezione d’una domanda o d’un’eccezione autonome, non sarebbe conforme ai
menzionati criteri informatori della revisio proris instantiae in appello consentire alla parte interessata di
limitarsi a riproporre l’una o l’altra, così come svolte nel giudizio di primo grado, esonerandola dall’onere di
prendere in esame la motivazione di rigetto, specificamente resa al riguardo dal giudice a quo, e di svolgere su di
essa adeguata critica.
Mentre appare indubitabile che, ove tale critica venga svolta, la relativa deduzione, qual che
ne sia la modalità, finisca per avere la sostanza dell’impugnazione e come tale debba
essere valutata e ciò, proprio in quanto proveniente dall’appellato ed avente ad oggetto
questioni del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell’impugnazione principale,
soprattutto in funzione delle condizioni di forma e di tempo della sua ammissibilità.
Parte della dottrina ha, altresì, evidenziato come la genericità dell’espressione “riproposte” consenta
un’interpretazione della norma nel senso che il legislatore non abbia inteso escludere tout court l’impugnazione,
bensì configurare la “riproposizione” in guisa che possa aver luogo tanto mediante specifica impugnazione,
quanto mediante la riformulazione delle difese già svolte in primo grado (riformulazione che deve, peraltro, essere
specifica; del che in seguito, nell’esame della seconda ragione d’inammissibilità del motivo di ricorso de quo),
onde la scelta conseguente a tale alternativa è ricollegata, ancora una volta, all’oggetto della decisione, dovendosi
prendere in considerazione la necessità dell’impugnazione nell’ipotesi di decisione negativa, espressa e motivata,
su di una domanda od un’ eccezione autonome e, viceversa, la rinnovazione delle precedenti difese nella diversa
ipotesi di una domanda od un’eccezione non decise in quanto pretermesse o ritenute assorbite.
Dell’incertezza che ingenera l’espressione “riproposte”, ove non correttamente interpretata, costituiscono evidente
manifestazione le numerose sentenze per le quali una specifica decisione negativa su questioni pregiudiziali o
preliminari osta all’esame delle stesse in sede di gravame, anche officioso se del caso, ove non siano state
“riproposte con l’impugnazione” dalla “parte interessata”, laddove una corretta definizione, ove si fosse seguita
la tesi qui contestata, avrebbe richiesto l’uso del termine “impugnate” ove si fosse fatto riferimento alla parte
soccombente e del termine “riproposte” ove il riferimento fosse stato alla parte vittoriosa; la lettura dei relativi
testi integrali, dai quali soltanto possono desumersi quale posizione processuale sia stata esaminata (se della
parte vittoriosa appellata o della soccombente appellante) e quali siano state le concrete applicazioni del principio
risultante dalla massima, sembra emergere, in prevalenza, una sostanziale applicazione del criterio
interpretativo da ultimo evidenziato.
29
Ed, in effetti, la “riproposizione” delle domande e delle eccezioni autonome “non accolte”, una volta che ai detti
termini sia stato attribuito il significato loro proprio quale desumibile dalla esegesi della normativa esaminata,
assume necessariamente il carattere dell’impugnazione, dacchè la parte interessata, insistendo sulle dette
domande od eccezioni, non chiede affatto una conferma della sentenza di primo grado, id est il solo rigetto
dell’avverso gravame eppertanto il mantenimento della decisione impugnata nei medesimi termini con i quali è
stata adottata, bensì una radicale riforma della stessa, basata sulla riconsiderazione di questioni del tutto
autonome e distinte rispetto a quelle in base alle quali la decisione ha avuto luogo; il che distingue tale
situazione da quella in cui la parte interessata, nel chiedere il rigetto del gravame e quindi la conferma della
sentenza impugnata, riprospetta questioni connesse alla questione decisa, pur disattese dal giudice a quo ma
ritenute utili e rilevanti al fine di mantenere ferma detta decisione.
Nella “parte interessata”, peraltro, in relazione alle domande ed eccezioni autonome delle quali si tratta, non
può non ravvisarsi anche quella vittoriosa nel merito ma soccombente quanto alle une od alle altre:
particolarmente, ove trattisi di domande distinte ed autonome gradatamente o disgiuntamente proposte, delle
quali sia stata accolta la subordinata in luogo della principale o solo l’una e non anche l’altra; come pure ove
siano state disattese eccezioni litis ingressum impedientes, ostative ex se a qualsiasi decisione da parte degli aditi
ordine giudiziario in genere o singolo giudice in specie, oppure all’introduzione del giudizio.
Ciò in quanto il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c. - a norma del quale per proporre una domanda o per
resistere ad essa è necessario averne interesse - si applica anche al giudizio d’impugnazione e l’interesse ad
impugnare una sentenza, od un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente
giudizio, intesa, in senso sostanziale e non formale, quale statuizione sfavorevole; onde l’interesse ad impugnare
una pronunzia sorge ogni qualvolta si verifichi tale soccombenza, anche soltanto parziale, id est quando una
delle parti in causa abbia visto non accolte integralmente le proprie domande od eccezioni così come formulate,
ove caratterizzate da quell’autonoma individualità, nei sensi in precedenza evidenziati, che attribuisce loro
l’effetto d’interagire sul processo in via immediata ed anticipata rispetto a qualsiasi altro oggetto di decisione.
Non senza considerare che, come è stato evidenziato in dottrina, “l’esigenza dell’appello incidentale
si giustifica non solo con la soccombenza rispetto alla singola eccezione, cui può
corrispondere un interesse che trascende i limiti del giudizio in corso, ma anche con il
fatto che solo in apparenza essa è virtuale, potendo assai facilmente diventare pratica e
concreta nel momento in cui il giudice si persuada della fondatezza dei motivi addotti
con l’appello principale contro la sentenza di primo grado, e ritenga
conseguentemente errato l’accoglimento dell’altra eccezione”.”
In secondo luogo, occorre esaminare l’ipotesi in cui il Giudice, pur disattendendo una o più
eccezioni di merito proposte da una delle parti, le abbia comunque dato ragione per altri
motivi, decidendo quindi nel merito la controversia a favore della parte che si è vista respingere
alcune delle sue eccezioni.
In tale ipotesi deve ritenersi sicuramente sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione
disattesa ai sensi dell’art.346 c.p.c. da parte del soggetto vittorioso nel merito.
Per quel che riguarda le eccezioni e le domande assorbite, è evidente la sufficienza della
riproposizione.
La disposizione graduale delle domande e delle eccezioni, sia che discenda da un ordine
logico -concettuale, sia che costituisca il frutto della volontà della parte concludente, può far
sì che una domanda o eccezione non venga esaminata per la semplice ragione che viene accolta
una richiesta prioritaria.
• “La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale,
per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non
esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente. Perché tali questioni siano esaminate
dal giudice di appello è sufficiente la riproposizione di tali domande o eccezioni in una delle difese del
giudizio di secondo grado. Tuttavia, se la domanda non viene riproposta in appello in nessuna delle
difese, essa non può essere ripresa in considerazione nel corso del successivo giudizio di
cassazione.”(Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2008, n. 28061).
In tema di riconvenzionale subordinata assorbita:
30
•
“L’onere di impugnazione presuppone la soccombenza della parte, venendo a mancare altrimenti
l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 100 c.p.c. come essenziale requisito del diritto di azione o
di eccezione e dello stesso diritto di impugnazione della sentenza; sicché non può addossarsi alla parte
vittoriosa in primo grado l’onere di proporre appello incidentale per far valere una sua domanda
riconvenzionale, subordinata all’accoglimento della domanda proposta dall’attore, che il giudice non
abbia esaminato per essersi pronunciato soltanto sul rigetto della domanda attorea. Tuttavia, è onere
della parte vittoriosa, che voglia mantenere una siffatta domanda riconvenzionale anche in sede di
gravame, di riproporla ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in quanto l’appello, per il suo effetto devolutivo, è
limitato esclusivamente ai motivi di censura ed alle domande ed eccezioni riproposti dalle parti nei
rispettivi atti, salve le questioni rilevabili d’ufficio. (Nella specie, il motivo di ricorso censurava
l’impugnata sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto precluso, per omessa
proposizione dell’appello incidentale, l’accertamento del diritto dell’appellato,
convenuto ed attore in riconvenzionale in primo grado, al risarcimento dei danni
condizionato all’accoglimento della domanda, proposta dall’appellante attore in primo
grado, di annullamento di un contratto di locazione delle aree di parcheggio di un
complesso edilizio, senza considerare però che la sentenza di primo grado aveva
appunto respinto la domanda di accertamento della nullità del contratto locativo; la
S.C., nel respingere il motivo di ricorso ed enunciando l’anzidetto principio di diritto,
ha confermato la sentenza di merito, correggendone però la motivazione, ex art. 384
c.p.c., in quanto dalla stessa sentenza risultava che la parte non aveva neppure
riproposto la domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 346 c.p.c.)”(Cassazione civile,
sez. III, 6 settembre 2007, n. 18691).
• “La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale, per
chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente. È
sufficiente, infatti, la riproposizione di tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado.
(Nella specie era stata proposta domanda di danni nei confronti del gestore di un albergo per ottenere
il risarcimento dei danni conseguenti a una infezione intestinale contratta durante il soggiorno in tale
albergo. I giudici di primo grado, rigettata l’eccezione del convenuto, che invocava che fossero carenti
prove che permettessero di ritenere che l’infezione contratta dipendesse da alimenti consumati
nell’albergo, ha, comunque, rigettato la domanda. Avendo sin dalla comparsa di costituzione in
secondo grado l’appellato ribadito che non esisteva alcuna prova che l’infezione fosse conseguenza dei
cibi consumati nella struttura alberghiera, la sentenza di appello ha accolto tale ultima difesa,
confermando con tale diversa motivazione la sentenza del primo giudice. In applicazione del principio
di cui sopra la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso per cassazione con cui si affermava
essere passato in cosa giudicata, per difetto di appello incidentale, l’accertamento, contenuto nella
sentenza di primo grado secondo cui l’infezione era conseguenza di cibi consumati nell’albergo).
“(Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2007, n. 13082).
In tutte queste ipotesi parrebbe sufficiente la riproposizione della richiesta ai sensi dell’art.346
c.p.c., anche se, come si vedrà, la giurisprudenza è alquanto contrastata in caso di assorbimento
della domanda di garanzia impropria per l’avvenuto rigetto della domanda principale rivolta
contro colui che aveva richiesto la garanzia.
La giurisprudenza afferma che:
• “La disposizione dell’art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza
di primo grado si intendono rinunciate se non espressamente riproposte in appello, è dettata per la
parte vittoriosa, la quale, non onerata dall’impugnazione per difetto di interesse, deve tuttavia
riproporre specificamente nell’atto di costituzione in secondo grado, oltreché le domande, le questioni
non accolte dal primo grado, tra cui i fatti che per il loro rilievo giuridico siano serviti a contrastare
l’altrui pretesa, come quelli giustificativi del licenziamento impugnato dal lavoratore.”(Cassazione
civile, sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14673).
Quanto alla forma della riproposizione, l’opinione consolidata afferma che:
• “In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale
l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande
31
e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad
evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se
libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo
sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.”
(Cassazione civile, sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796).
• “In mancanza di una norma specifica quanto alla forma nella quale l’appellato che voglia evitare la
presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in
primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di
riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. La riproposizione, tuttavia, pur se libera da
forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle
difese svolte e alle conclusioni prese davanti al giudice di primo grado.”(Cassazione civile, sez. III,
21 settembre 2007, n. 19484);
• “La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale difettando il presupposto della soccombenza - le domande e le eccezioni già proposte e respinte o
dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l’onere di provocare il riesame di tali
domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, di cui all’art. 346 c.p.c.,
manifestando in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle.”(Cassazione civile, sez. III, 13
aprile 2007, n. 8854).
Il principio vale anche per le eccezioni di carattere processuale:
• “L’art. 346 c.p.c., nel prevedere che le eccezioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate se
non sono espressamente riproposte in appello, non fa alcuna distinzione tra eccezioni di merito ed
eccezioni concernenti la validità e l’ammissibilità delle prove. Deve di conseguenza presumersi
rinunciata l’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale (nella specie, perché concernente il
pagamento dell’obbligazione) disattesa dal giudice di primo grado, e non riproposta in
appello.”(Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4496).
Quanto alle eccezioni di merito:
• “Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta una eccezione (nella specie: di giudicato
esterno) e avverso tale capo non venga proposta impugnazione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e in
applicazione dei principi sui limiti devolutivi dell’appello e sul giudicato interno, l’eccezione deve
ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che
l’eccezione, quand’anche fosse da ritenere rilevabile d’ufficio, è definitivamente preclusa.”(Cassazione
civile, sez. II, 29 febbraio 2008, n. 5681).
Ora una breve rassegna di giurisprudenza recente sull’art.346 c.p.c.:
6.1. Causae petendi alternative:
•
•
“In tema di azione di danni, poiché i “fatti” rilevanti per l’affermazione di responsabilità art. 2051
c.c. sono diversi da quelli necessari per proclamarla art. 2043 c.c., qualora il danneggiato
soccombente in primo grado non si dolga in appello della mancata applicazione dell’art. 2051 c.c.,
ma censuri la sentenza impugnata soltanto per avere escluso la responsabilità del convenuto per difetto
di colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c., non è consentito al giudice di appello - ciò essendogli impedito dai
limiti di devoluzione dell’impugnazione (art. 346 c.p.c.), altrimenti configurandosi il vizio di
ultrapetizione - prescindere dall’indagine sull’elemento soggettivo dell’illecito ed affermare la
responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed
alla mancanza di prova del fortuito.”(Cassazione civile, sez. III, 23 giugno 2009, n.
14622);
“La parte che, ottenuto in primo grado l’accoglimento del “petitum” - sia pure per una sola delle
causae petendi prospettate, con espressa negazione dell’altra “causa” e con conseguente rigetto della
domanda connessa - ritenga di non avere interesse ad impugnare, ha tuttavia l’onere di proporre
impugnazione incidentale con riguardo alla “causa petendi” disattesa, qualora il relativo interesse
nasca dall’impugnazione principale di controparte.”(Cassazione civile, sez. lav., 21 aprile
2009, n. 9479).
32
•
•
“L’azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno
dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel
caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove
sufficienti all’accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia
stata più coltivata dall’interessato. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda
fondata sul titolo contrattuale, accogliendo quella ex art. 2041 c.c., proposta in via alternativa;
avendo il convenuto proposto appello, e non avendo l’attore riproposto la prima domanda ai sensi
dell’art. 346 c.p.c., la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di
appello, che aveva rigettato anche la seconda domanda).”(Cassazione civile, sez. III, 2 aprile
2009, n. 8020);
“L’accoglimento della domanda in base ad una sola delle causae petendi fungibilmente poste a
fondamento della stessa non implica, per l’appellato vittorioso, l’onere di proporre appello incidentale
per far valere le causae petendi non esaminate dal giudice di primo grado, né quello di riproporre con
espresse deduzioni le ragioni pretermesse, essendo sufficiente che ad esse la parte non rinunci,
esplicitamente o implicitamente, manifestando in qualsiasi modo la volontà di provocarne il riesame.
(Nella specie, la domanda di risoluzione del contratto era stata proposta allegando
plurimi inadempimenti ed il giudice aveva accolto la domanda sulla base di uno dei
medesimi senza pronunciarsi sugli altri).”(Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2007, n.
12162).
6.2. Estensione automatica del contraddittorio.
Una pronuncia molto particolare con riferimento all’istituto della c.d. estensione automatica
del contraddittorio e alla sua armonizzazione con il sistema delle impugnazioni:
• “L’istituto della c.d. estensione automatica del contraddittorio, giurisprudenzialmente elaborato con
riferimento alle conseguenze della c.d. chiamata in causa del terzo responsabile ai sensi dell’art. 106
c.p.c. (in forza del quale nell’ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che
questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, la domanda di quest’ultimo si estende
automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza) deve subire il necessario
coordinamento con il principio dispositivo e con la connotazione devolutiva del giudizio di appello, che
esige per l’operatività di un effetto di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del
terzo chiamato, non accolta nella sentenza impugnata, una apposita sollecitazione da parte
dell’originario attore- appellato, che ne invochi l’applicazione (anche in via subordinata rispetto alla
conferma della sentenza di primo grado, richiesta in via principale). Da tale esigenza non è possibile
prescindere, se non altro in relazione al disposto dell’art. 346 c.p.c. che impone alle parti del giudizio
di appello l’espressa riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo
grado, e con esse anche della domanda automaticamente estesa nei confronti del terzo.”(Corte
appello Torino, sez. III, 20 febbraio 2009).
6.3. Ipotesi di una pluralità di responsabili.
•
•
“Nel caso in cui sia stata proposta domanda risarcitoria nei confronti di più soggetti ed il giudice
ritenga uno solo di questi esclusivo responsabile dell’evento dannoso e contro di lui pronunci condanna
all’integrale risarcimento, il danneggiato, per ottenere in appello anche la condanna di colui che il
primo giudice aveva ritenuto esente da responsabilità (e al quale, invece, il giudice del gravame ha
attribuito, a seguito di altrui appello, la corresponsabilità dell’evento), ha l’onere, ai sensi dell’art.
346 c.p.c., di riproporre in appello la domanda anche nei confronti di questo, altrimenti quella sua
originaria si intende rinunciata ed il giudice d’appello correttamente pronunzia condanna di parziale
risarcimento solo nei confronti di colui che era stato in primo grado condannato a risarcire il danno
per intero.”(Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4235);
“Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga
accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del
soccombente non basta a devolvere al giudice dell’impugnazione anche la cognizione circa la pretesa
dell’attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l’unicità del rapporto sostanziale, con
33
titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur
nell’unità del petitum - dalla diversità dei soggetti convenuti (personae) e in parte dei fatti e degli
argomenti di sostegno (causae petendi); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l’attore appellato ha l’onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell’art. 346
c.p.c.. (Nella specie, relativa a domanda di corresponsione dell’indennità di
accompagnamento proposta contro la Regione Emilia Romagna e contro l’Inps,
accolta dal giudice di primo grado solo nei confronti della Regione, la ricorrente, nel
costituirsi in appello, aveva riproposto la questione della legittimazione passiva ed
aveva dichiarato di vedere «ben volentieri» accolta la pretesa nei confronti dell’Inps,
con la condanna dell’Istituto stesso; la S.C., nell’affermare il principio di cui alla
massima, ha ritenuto che la parte, pur con formulazione non perspicua, avesse, nella
sostanza, ottemperato all’onere imposto dall’art. 346 c.p.c. e, quindi, decidendo nel
merito, ha condannato l’Istituto all’erogazione dell’indennità).”(Cassazione civile, sez.
lav., 7 gennaio 2009, n. 65).
6.4. Domanda di garanzia verso un terzo.
In tema di domanda di garanzia verso un terzo, non accolta in primo grado per il rigetto della
domanda principale rivolta verso il garantito, alcune pronunce richiedono la proposizione
dell’appello incidentale condizionato
• “Nel caso di appello da parte dell’attore vittorioso il quale chieda il riconoscimento di una somma
maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla
domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in causa, non deve proporre
appello incidentale condizionato - come invece dovrebbe nella diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso
ed intenda essere garantito per il caso di accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto
nei suoi confronti dall’attore soccombente - ma è sufficiente che chieda l’estensione della garanzia per
l’evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda dell’attore per un importo maggiore di
quello riconosciuto dovuto dal tribunale.”(Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2007, n.
19927);
• “Qualora l’appellato miri all’accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in
garanzia, per l’ipotesi in cui non venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti
dall’attore rimasto soccombente in primo grado, non è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 c.p.c.,
della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello
incidentale condizionato, poiché la richiesta dell’appellato non mira alla conferma della sentenza per
ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia
concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l’appello principale.”(Cassazione
civile, sez. III, 10 marzo 2006, n. 5249).
Altre pronunce ritengono che il convenuto vittorioso in primo grado per riproporre la
domanda di manleva verso il terzo, rimasta assorbita in primo grado per effetto della reiezione
della domanda principale avanzata nei suoi confronti, non abbia l’onere di proporre
impugnazione incidentale ma possa semplicemente riproporre la propria domanda non
esaminata ai sensi dell’art.346 c.p.c.
In siffatta ipotesi il convenuto appellato già vittorioso nel merito in primo grado non deve
infatti lottare per ribaltare una sua soccombenza nei riguardi del terzo chiamato in garanzia
impropria che sia contenuta nella sentenza impugnata, ma nutre semplicemente l’interesse a
riproporre (in linea, ovviamente, subordinata rispetto all’auspicato rigetto dell’appello
principale) quella domanda di garanzia che era rimasta assorbita in prime cure per effetto della
reiezione della domanda principale avanzata dall’attore.
A tali fini il ricorso allo strumento dell’appello incidentale condizionato risulta
sovrabbondante per una parte che non chiede di modificare alcun passaggio del percorso
logico e giuridico seguito dal Primo Giudice per arrivare alla decisione assunta (di cui anzi
caldeggia la conferma), ma che, ipotizzando solamente in via eventuale l’evento negativo
dell’accoglimento dell’impugnazione e della conseguente vittoria dell’attore appellante, sollecita
34
l’accoglimento di quella domanda di garanzia impropria verso il terzo chiamato su cui il
Giudice di primo grado non si è pronunciato per la semplice ragione che ha arrestato il
proprio tragitto mentale in un momento precedente al suo esame.
In tal senso in giurisprudenza di legittimità
• “La riproposizione nel giudizio di appello, da parte del convenuto vittorioso in primo grado, della
domanda di manleva, formulata in via subordinata nei confronti di un terzo chiamato in garanzia,
non implica la proposizione da parte sua di un’impugnazione incidentale e quindi non è assoggettata al
relativo regime processuale, bensì alla disciplina dell’art. 346 c.p.c. sulla riproposizione delle domande
o eccezioni non accolte in primo grado. Pertanto deve escludersi la decadenza da tale domanda nel caso
in cui sia mancata la notificazione al terzo garante, rimasto contumace in appello. (Nella specie la
S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile in appello la
domanda di manleva, per la mancata notificazione dell’”appello incidentale” al terzo
garante).”(Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2000, n. 89);
• “Il convenuto, ove sia stata rigettata la domanda proposta nei suoi confronti, con il conseguente
mancato esame della domanda di garanzia impropria, da lui formulata in via subordinata nei
confronti di un terzo chiamato in causa, non essendo soccombente, non è legittimato ad impugnare la
sentenza, nè, nell’ipotesi in cui la sentenza stessa venga impugnata dall’attore soccombente, per
riproporre in grado di appello la domanda di garanzia nei confronti del terzo ha l’onere di formulare
impugnazione incidentale essendo sufficiente la riproposizione della stessa a norma dell’art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 1988, n. 6375).
6.5. Rivalutazione monetaria e interessi.
•
“Il giudice di appello non può riconoscere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme
liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ove il danneggiato non abbia proposto
in appello specifica domanda in tal senso, benché detti accessori siano stati chiesti in primo grado,
dovendosi ritenere, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., rinunciate le domande ed eccezioni non espressamente
riproposte in grado di appello.”(Cassazione civile, sez. III, 9 luglio 2009, n. 16128);.
6.6. Appellato contumace.
La regola vale anche per l’appellato contumace:
• “Il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed
eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in
appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in
coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di
parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione
sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di
prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi
sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per
l’appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un
interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace. (In
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito
che aveva esaminato d’ufficio l’eccezione di prescrizione - relativa al diritto alla
percezione degli accessori sui ratei di un trattamento pensionistico in convenzione
internazionale - sollevata in primo grado dall’Inps, che era rimasto contumace in
appello).”(Cassazione
• “Qualora l’eccezione di usucapione sollevata in primo grado non sia stata riproposta dall’appellato
rimasto contumace, la questione non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame, atteso che, alla luce
del principio di parità delle parti nel processo e dell’effetto devolutivo dell’appello, non può attribuirsi
all’appellato contumace una posizione di maggiore favore rispetto all’appellante.”(Cassazione
civile, sez. II, 4 maggio 2007, n. 10236).
7. Introduzione ai motivi specifici di impugnazione.
35
Lo studio dei “motivi specifici dell’impugnazione” di cui all’art.342 c.p.c., si prefigge di analizzare
compiutamente l’istituto, nei vari aspetti inerenti alla funzione sistematica, ai contenuti e alle
manifestazioni patologiche, alla luce della casistica tratta dalla viva esperienza giurisprudenziale,
allo scopo di procedere alla ricostruzione delle caratteristiche fondamentali dell’impugnazione
di merito in secondo grado delle sentenze civili.
L’art.342 c.p.c. è intitolato alla “Forma dell’appello” è contenuto nel capo II del Titolo III “Le
impugnazioni” del Libro II “Del processo di cognizione” del Codice di rito.
La norma (nel suo primo comma) informa il lettore del modo di proposizione dell’appello (con
citazione) e indica tre requisiti di contenuto dell’atto:
a) una esposizione sommaria dei fatti di causa,
b) i motivi specifici dell’impugnazione,
c) le indicazioni prescritte dall’art.163 relativamente all’atto di citazione in primo grado.
La nostra attenzione si deve quindi focalizzare sul requisito sub b), che appare di gran lunga il
più importante.
Infatti il requisito sub c) si limita a richiamare per relationem le indicazioni prescritte per l’atto
introduttivo del giudizio di primo grado (e i dubbi possono semmai attenere agli eventuali
limiti della relatio, problema che si è posto in modo più vivace con riferimento all’applicabilità
della sanatoria prevista dall’art.164 c.p.c.).
A questo proposito – e molto sinteticamente - val la pena di accennare che la dottrina ritiene
che l’art.164 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dalla Novella del 1990, trovi applicazione anche
con riferimento all’atto di citazione in appello, almeno quanto ai casi di nullità della citazione
dovuti a vizi affliggenti la vocatio in jus, a differenza delle ipotesi di vizi afferenti la c.d. editio
actionis (così come possono proporsi in secondo grado) e delle ipotesi di carenza dei requisiti
specifici dell’impugnazione previsti dall’art.342 c.p.c. che debbono
invece scontare
l’applicazione della condizione di compatibilità sancita dall’art.359 c.p.c.
Non merita infatti consenso l’isolato precedente rappresentato dalla “sorprendente” sentenza
della Cassazione, sez. III, del 25 febbraio 2004, n. 38093 poiché tale pronuncia, duramente
criticata da autorevole dottrina, scaturisce da una interpretazione evidentemente erronea
dell’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza del 29.1.2000 n.16, che
non aveva affatto enunciato il drastico principio della totale insanabilità di tutti i vizi
affliggenti l’atto di citazione in appello invece colto dalla sentenza citata e, oltretutto, non era
stata intesa in tal modo da nessuno dei suoi numerosi commentatori.4
La piana applicazione dell’art.164 c.p.c. ai vizi della vocatio in jus del procedimento di appello è
stata del resto ritenuta da numerose sentenze della Suprema Corte, sia precedenti, sia
successive, alla criticata sentenza 3809 del 2004:
Secondo la quale “Stante l’inapplicabilità dell’art. 164 c.p.c. - sia nel testo precedente che in quello attuale - al giudizio
di appello, la nullità dell’atto di citazione in appello dipendente da vizi della “vocatio in ius” non può essere sanata con la
costituzione dell’appellato nè con la rinnovazione della citazione, ed è rilevabile anche d’ufficio, in quanto solo l’atto conforme
alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. è idoneo ad impedire la decadenza dall’impugnazione e quindi il passaggio in giudicato
della sentenza impugnata; ne consegue che il giudizio di appello introdotto a mezzo di un atto di citazione nullo deve
essere dichiarato inammissibile.”
4 Infatti la sentenza n.16/2000 delle Sezioni Unite:
si riferiva ad un vizio di editio actionis e in particolare alla mancata debita specificazione dei motivi di appello
ai sensi dell’art.342 c.p.c., ossia all’unico vizio per cui manchi la previsione di una sanzione ad hoc e per cui poteva
prospettarsi il problema dell’applicazione analogica o estensiva dell’art.164 c.p.c.;
era stata resa con riferimento ad una causa soggetta al rito anteriore alla Novella del 1990 e quindi al vecchio
testo dell’art.164 c.p.c.;
si occupava del problema dell’effetto sanante della costituzione in giudizio del convenuto appellato, e in
particolare della sua efficacia ex nunc o ex tunc, rispetto all’onere di specificazione dei motivi originariamente
insoddisfatto nella struttura dell’atto di appello;
fra l’altro, non aveva escluso ogni forma di sanatoria dell’atto di appello nullo, perché si era limitata a
escludere il rilievo della costituzione dell’appellato, salvo il potere dell’appellante di rinnovare l’atto nel rispetto dei
termini di legge e prima della dichiarazione di inammissibilità.
3
•
•
•
•
36
“Allorché la citazione introduttiva del giudizio d’appello sia nulla per violazione del termine
minimo di comparizione, il giudice, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., deve fissare all’appellante un
termine perentorio per la sua rinnovazione, che sana il vizio con efficacia retroattiva.”(Cassazione
civile, sez. I, 5 maggio 2004, n. 8539 ; conformi sez. III, 5 maggio 2004, n. 8526, sez.
III, 24 gennaio 2003, n. 1116).
L’errore di interpretazione della pronuncia delle Sezioni Unite (e di ipervalutazione della sua
portata) in cui incorre la citata sentenza n.8309 del 2004 è stato lucidamente evitato da parte di
un’altra sentenza della Cassazione civile del 13.5.2002, n. 6820 (ingiustificatamente sottaciuta
dalla sentenza 8309/2004) in cui, ben più persuasivamente, è stato affermato:
“Il secondo comma dello stesso art. 164 prevede che tale nullità, qualora il convenuto non si costituisca (come è
avvenuto nel caso di specie), è rilevata di ufficio dal giudice, il quale dispone la rinnovazione dell’atto dichiarato
nullo entro un termine perentorio. Questa rinnovazione sana il vizio dell’atto “e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dai momento della prima notificazione”. Non assume rilievo, al
riguardo, la sentenza delle Sez. Un. n. 16 del 2000 invocata nella memoria del ricorrente. Questa sentenza si
riferisce al testo dell’art. 164 c.p.c. previgente, che, come sanatoria della nullità della citazione, prevedeva
soltanto la costituzione del convenuto, e quindi non contemplava la rinnovazione della citazione disposta dal
giudice, che è prevista dal testo vigente dello stesso art. 164 (applicabile nel presente giudizio, che è stato
instaurato successivamente al 30 aprile 1995). L’incompatibilità tra la disciplina del giudizio di appello e
l’art.164 c.p.c. - affermata dalla citata sentenza delle Sez. Un. - si riferisce, pertanto, esclusivamente alla
sanatoria prevista dalla costituzione dell’appellato, e non può essere estesa alla disciplina del secondo comma del
vigente art. 164 c.p.c., che prevede una sanatoria del tutto diversa, e cioè la rinnovazione dell’atto di citazione
nullo per la sussistenza di una delle ipotesi previste nel primo comma dello stesso art. 164 (nullità diverse - va
altresì notato - dalla assenza di specificità dei motivi, che è l’ipotesi a cui si riferisce la menzionata sentenza
delle Sez. Un.).”
Chiaramente orientata nel senso dell’applicabilità dell’art.164 c.p.c. al giudizio di secondo grado
è tutta la giurisprudenza successiva5 .
Va ricordato altresì che il requisito sub a) è stato notevolmente ridimensionato nella sua
importanza dalla giurisprudenza, che ritiene che l’art. 342 c.p.c. non esiga una parte espositiva
formalmente autonoma ed unitaria e che il requisito, meramente funzionale alla individuazione
delle censure mosse dall’appellante, possa ritenersi soddisfatto anche qualora tale
individuazione sia consentita, indirettamente e per sommi capi, dal complesso delle
argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello.6
L’esame della formula normativa esige peraltro la preventiva messa a fuoco della
fondamentale nozione dell’effetto devolutivo che connota la natura del giudizio di appello,
rispetto alla quale il requisito della specificità dei motivi si pone come un elemento di forte
temperamento (presumibilmente collegato alla tendenziale stabilità della decisione di primo
grado oggetto dell’impugnazione).
8. La nozione di effetto devolutivo.
L’appello, nella tradizionale impostazione dottrinale, è il più ampio mezzo di impugnazione
ordinaria e costituisce l’unico “gravame” in senso stretto, idoneo ad investire la decisione
“In caso di proposizione dell’atto di appello nei confronti di società incorporata da un’altra società, la costituzione in giudizio da
parte della società incorporante sana il vizio dell’atto di citazione con effetto ex tunc, in applicazione della norma contenuta nell’art.
164, comma 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall’art. 9 l. 26 novembre 1990 n. 353), a tenore della quale la costituzione del convenuto
sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. (Nella specie, in controversia instaurata
dopo il 30 aprile 1995, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità dell’atto di impugnazione notificato
alla compagnia assicuratrice originariamente convenuta, incorporata già da quindici mesi da altra compagnia).”(Cassazione civile,
sez. III, 14 luglio 2006, n. 16099; cfr anche, sez. II, 21 novembre 2006, n. 24680; sez. III, 21 luglio 2006, n.
16772; sez.II, 31.7.2007 n.16877; sez.III, 9.8.2007 n.17474; sez.I 1°.7.2008 n.17951).
5
6
Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1790; Cassazione civile, sez. lav., 3 gennaio 2005, n. 21.
37
oggetto di impugnazione nella sua giustizia, attraverso un nuovo esame della causa, sia pur nei
limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo).
Si ritiene inoltre che l’appello abbia carattere “sostitutivo”, nel senso che la sentenza di
secondo grado si sostituisce a quella di primo grado nel regolamento della controversia da essa
attuato, eccezion fatta per i capi non impugnati.
La dottrina, in modo piuttosto uniforme, tende a configurare l’appello come strumento di
impugnazione almeno potenzialmente devolutivo, con l’attribuzione al giudice del gravame
dello stesso potere di decisione della lite attribuito al giudice del primo grado.
E’ il caso di accennare, in brevissima sintesi, ad alcune opinioni dottrinali.
Luiso configura l’appello come mezzo di gravame devolutivo, nel senso che il giudice di
appello viene reinvestito del potere di decidere ciò che ha già deciso il giudice di primo grado;
egli mette poi l’accento sulla rilevanza del potere dispositivo delle parti, chiarendo che l’effetto
devolutivo è solo potenziale e non automatico perché sia l’oggetto dell’appello, sia le questioni
che il giudice deve affrontare, sono determinate dalle parti.
L’Autore sostiene che i motivi hanno la funzione di indicare l’ambito della devoluzione e
dipendono dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il
giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può ri-decidere,
mentre le ragioni dell’impugnazione, ossia gli argomenti utilizzati per convincere il giudice di
appello della fondatezza dell’impugnazione, ben possono essere contenuti anche in scritti
successivi.
Secondo Liebman, l’appello ha lo scopo di provocare un nuovo giudizio sulla stessa domanda;
l’effetto devolutivo consiste nel passaggio della piena cognizione della causa dal giudice
inferiore a quello superiore nei limiti dell’appello effettivamente proposto. La nuova
cognizione è limitata solo entro l’ambito dell’appello o degli appelli effettivamente proposti e
solo a favore di coloro che li hanno proposti; ne scaturisce una cognizione piena e aperta sui
capi oggetto di impugnazione, con poteri uguali a quelli del primo giudice.
Secondo Mandrioli, in relazione alla sua natura di gravame, l’appello introduce un riesame, non
già della sentenza di primo grado, ma della stessa controversia nei limiti della domanda di
appello sulla domanda già decisa in primo grado, con conseguente effetto devolutivo che si
sostanzia nel potere di piena cognizione spettante al giudice del gravame.
Nel giudizio di appello opera peraltro rigorosamente il principio della domanda, sicché è
necessaria la riproposizione di ogni singola domanda ed eccezione; i motivi specifici di
impugnazione rappresentano quell’aspetto particolare della causa petendi che concerne la
domanda di riforma della sentenza.
In sintesi, dalla lettura della dottrina emerge una concezione prevalente dell’appello come
mezzo di gravame, “a critica libera”, introduttivo di un nuovo giudizio, prettamente
sostitutivo; in tale contesto i motivi non vengono configurati in modo molto rigoroso come
ragioni di critica nei confronti della motivazione della sentenza di primo grado, ma tendono ad
essere concepiti come strumenti attraverso cui si manifesta la volontà della parte impugnante
che innesca l’effetto devolutivo.
Tale concezione dottrinale non è peraltro in linea con l’orientamento ormai consolidato della
giurisprudenza della Suprema Corte che conforma il “diritto processuale vivente”.
La Suprema Corte, attraverso l’enfasi attribuita sotto il profilo sistematico ai motivi specifici
dell’impugnazione (di cui ha progressivamente accentuato la coessenziale funzione di critica
distruttiva della motivazione di primo grado) e tenendo opportunamente conto della struttura
del giudizio di secondo grado riformato dalla Novella di cui alla legge 26.11.1990 n.353 e
successive modifiche ed integrazioni (e in particolare del divieto di proposizione di nuove
eccezioni e di nuove istanze istruttorie di cui all’art.345 c.p.c.) ha optato per la configurazione
dell’appello come “revisio prioris instantiae” e non già come mero “ novum judicium”.
Per esempio:
“Anche nel caso in cui la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il
gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza
38
impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a
incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Ciò in quanto finalità dell’appello non è quella
di provocare un “novum iudicium”, ma di introdurre una “revisio prioris instantiae”,
devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l’appellante
sostiene essere incorso il primo giudice.”(Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2008, n.
13080).7
Tale configurazione trova il più autorevole riconoscimento nella importantissima decisione
delle Sezioni Unite n.28498 del 23.12.2005 (non a caso redatta dall’allora Presidente aggiunto
facente funzioni di Primo Presidente della Corte), la cui massima suona:
“L’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella
configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una revisio
fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è
onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre,
o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o
comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex, art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere
copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del
giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte
(nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di
produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.”
Nel testo della pronuncia le Sezioni Unite così hanno chiarito il loro pensiero:
“In questo processo evolutivo del giudizio d’appello (reso ancora più evidente dalla novella del 1990 che,
riformulando gli artt. 337 e 345, ha eliminato gli effetti sospensivi dell’impugnazione e ha posto notevoli
limitazioni alla possibilità di introdurre elementi di novità nel giudizio d’appello) si collocano le sentenze
richiamate nel § 6, che pongono a carico dell’appellante l’onere di fornire la dimostrazione della fondatezza
delle censure formulate.
Le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi portano a ritenere esatto tale orientamento. In sostanza,
l’appello non rappresenta più, come nel sistema del codice di rito del 1865, pur permanendo la sua funzione
sostitutiva quanto alle statuizioni decisorie su diritti impugnati, il “mezzo” per “passare da uno all’altro
esame della causa”, su tali statuizioni, e non può quindi limitarsi al fine di ottenerne la riforma, ad una
denuncia generica dell’ingiustizia dei capi appellati della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarsi
all’interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla
sentenza di appello che non è impugnazione rescindente come il ricorso per cassazione (l’avvicinamento alla
struttura del quale è solo parziale); e tal puntualizzazione ulteriore avviene appunto nella denunzia di specifici
“vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. In questo contesto sistematico vengono meno i
presupposti per ritenere che l’onere probatorio dell’appellante debba essere individuato con esclusivo e
retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in
quel giudizio l’appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro,
anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere
dall’attore.
Deve, al contrario, affermarsi che, essendo l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle
singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere
la riforma del capo decisorio appellato, l’appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione deve essere,
in base ai principi, respinto, con conseguente conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia
stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale. Solo in questi sensi può parlarsi dell’appello
quale revisio.”
9. La specificità dei motivi di appello.
Nello stesso senso e con espressa configurazione in termini di “revisio prioris instantiae”: Cassazione civile, sez. I,
19 settembre 2006, n. 20261; sez. III, 24 novembre 2005, n. 24817; sez. II, 25 luglio 2005, n. 15558; sez. II, 8
agosto 2002, n. 11935; sez. II, 7 maggio 2002, n. 6542; sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15318; sez. I, 23 marzo 2001,
n. 4190; sez. II, 27 luglio 2000, n. 9867.
7
39
Sulla base di siffatte premesse è possibile passare all’esame della ormai consolidata definizione
dei motivi specifici di appello, che si connotano come l’esposizione delle ragioni della critica
rivolta dall’appellante alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado, ragioni che
debbono essere potenzialmente dotate dell’attitudine alla confutazione logica o giuridica del
fondamento della decisione.
Tale definizione può essere saldamente ancorata all’insegnamento delle Sezioni Unite impartito
con la fondamentale decisione del 29.1.2000 n.16, secondo cui:
“I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se
si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata,
dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico.”
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che:
• l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. non deve
necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle
ragioni invocate a sostegno dell’appello;
• al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria,
sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza;
• l’onere della specificazione dei motivi di appello non può però ritenersi assolto
mediante la mera riproposizione della domanda ovvero dell’eccezione decisa in
senso sfavorevole dal giudice di primo grado;
• i motivi di gravame in cui si articola la doglianza debbono essere idonei a
contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
• ciò vale anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia impugnata “nella sua
globalità”;
• nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede
di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva
deve perciò sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità dell’impugnazione,
rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della
controparte, una parte argomentativa, che contrasti e confuti le ragioni addotte
dal primo giudice;
• a tal fine non è peraltro sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le
statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la
sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali
si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare,
comunque, con la motivazione della sentenza impugnata;
• l’articolazione delle censure deve infatti adattarsi alla maggiore o minore
specificità nel caso concreto della motivazione di primo grado, dovendo quindi
assumere il maggior coefficiente di specificità quanto più precisa e specifica sia la
motivazione addotta dal Primo Giudice8.
I principi in tal modo “distillati” dalla giurisprudenza del Supremo Collegio sono chiari
almeno in linea di principio, anche se la loro corretta applicazione ai singoli casi concreti
implica necessariamente un certo, ineliminabile, tasso di discrezionalità interpretativa.
In sintesi, secondo il diritto vivente, l’appello si configura come impugnazione di merito di
carattere devolutivo, caratterizzata quale “revisio prioris instantiae” ed innescata dall’articolazione
di una critica specifica, puntuale, pertinente e mirata, che deve essere rivolta alle ragioni della
decisione di primo grado, per la cui proposizione non è sufficiente la (pur necessaria)
8
Ex plurimis: cfr Cassazione civile, sez. III, 13 luglio 2007, n. 15733; sez. III, 11 giugno 2007, n. 13676; sez. I, 5
giugno 2007, n. 13175; sez. III, 18 aprile 2007, n. 9244; sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2217; sez. III, 11 ottobre
2006, n. 21745; sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21816 ; sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261; sez. I, 19 settembre 2006,
n. 20261; sez. III, 24 marzo 2006, n. 6630; sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445; sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27727;
sez. I, 24 novembre 2005, n. 24834; sez. II, 14 novembre 2005, n. 22906; sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20287.
40
formulazione delle conclusioni sottoposte al giudice di secondo grado, che ripropongano in
tutto o in parte quelle già rivolte al giudice di primo grado (c.d. “parte volitiva”), ma è altresì
richiesta, a pena di inammissibilità del gravame, l’esposizione delle censure indirizzate alla
motivazione della sentenza di primo grado (“parte argomentativa”).
Da ultimo:
• “I motivi di appello concorrono a determinare l’oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo,
incidono sullo stesso esercizio del potere d’impugnazione, non potendosi considerare proposti
all’esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto
oggetto di specifiche censure nell’atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice di
appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado che, pur genericamente
investite dall’impugnazione in toto della sentenza, non siano state specificamente
censurate.”(Cassazione civile, sez. I, 16 dicembre 2009, n. 26414);
• “Per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall’art. 342 c.p.c.,
occorre indicare nell’atto di appello, anche mediante un’esposizione sommaria, le doglianze in modo
tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma
anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di
primo grado. Non è necessario, peraltro, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano
evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità
dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che
l’appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell’art.
345 c.p.c.”(Cassazione civile, sez. II, 19 ottobre 2009, n. 22123);
• “Il principio della specificità dei motivi di impugnazione esige che alle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento
logico-giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è sufficiente
che l’individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle
argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente
grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore
della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano
contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico-giuridico, come nel
caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva
argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi
argomentativi.”(Cassazione civile, sez. lav., 17 settembre 2009, n. 20046).
Talora in giurisprudenza viene in considerazione il carattere di “pertinenza” del motivo di
impugnazione, che non corrisponde, invero, ad un separato requisito, ma rappresenta
piuttosto un elemento costitutivo della specificità, che si esprime nella correlazione fra
motivazione e censura: in tanto il motivo è pertinente in quanto si riferisca alla motivazione e
la contrasti.
Il parametro di specificità esige poi l’ulteriore requisito dell’articolazione, tanto più
dettagliata e minuziosa quanto più dettagliata e minuziosa é la motivazione (ed ovviamente, a
contrario, si accontenta di una articolazione tanto più generale e complessiva, quanto più
generale e complessiva é la motivazione).
A tal proposito il parametro di valutazione dell’ammissibilità del motivo è la sua potenziale
attitudine alla confutazione del ragionamento del primo giudice (ossia la sua attitudine
distruttiva).
In altre parole, il giudice di appello per valutare se il motivo sia pertinente e specifico (e
quindi ammissibile) deve procedere alla seguente operazione di verifica concettuale,
chiedendosi: se fosse vero quanto afferma l’appellante, il fondamento (fattuale, logico,
giuridico, scientifico, equitativo) della decisione di primo grado verrebbe meno?
Solo se la risposta a tale interrogativo è positiva, il motivo di impugnazione in appello può
dirsi specifico e pertinente, e quindi ammissibile.
41
Attenzione però, se è vero che l’impugnazione in appello è ammissibile solo se sorretta da
motivi specifici, contenenti la critica della decisione di prime cure, non è esatto però dire che
tale critica e la decisione impugnata realizzano una sorta di gabbia vincolante per il Giudice di
appello.
L’effetto devolutivo consente infatti al Giudice di confermare la decisione sulla base di
ragioni diverse da quelle considerate dal Giudice di primo grado o proposte dalle parti:
• “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come
il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la
pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata
dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una
norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del
principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo
nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di
ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in
rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non
espressamente menzionati dal primo giudice.”(Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2009,
n. 20652).
10. Le eccezioni al principio.
In dottrina9 sono state individuate alcune eccezioni al principio appena delineato, ossia una
serie di ipotesi in cui l’appellante si può esonerare dal rispetto della tecnica di distruzione
sistematica del percorso logico seguito dal giudice di primo grado.
1. Il primo caso é quello della motivazione del tutto incomprensibile nell’iter logico seguito o
manifestamente assurda, talmente abnorme da rendere impossibile una controargomentazione che non finisca per divenire, a sua volta, incomprensibile: in tal caso
l’appellante é chiamato semplicemente a denunciare l’abnormità della incomprensibile
motivazione che in sostanza é motivazione solo apparente e quindi carente. Pertanto
l’esonero che compete all’appellante discende in sostanza dalla nullità della sentenza non
motivata (perché solo “pseudo-motivata”).
2. Il secondo caso é quello in cui la stessa impostazione del gravame sia integralmente
incompatibile rispetto ai motivi della decisione perché influenzata da una premessa, in
fatto o in diritto, completamente diversa, sicché l’appello si basa su di una ricostruzione
logica o giuridica del tutto autonoma (in questa ipotesi l’appellante riesce ad affrancarsi
dalla critica analitica, negando il presupposto, esplicito o implicito, della ricostruzione
seguita dal primo giudice o affermandone uno incompatibile, trascurato o sottovalutato,
in primo grado; l’apporto critico in realtà sussiste anche in questa ipotesi ma si esaurisce
nella contestazione del presupposto utilizzato in prime cure o nella proposizione del
presupposto differente.
3. Il terzo caso é quello in cui l’appellante aderisca alla ricostruzione operata dal primo
giudice, che abbia rigettato la sua domanda o la sua eccezione per difetto di prova e
deduca in appello le prove la cui mancanza ha determinato il risultato sfavorevole; é
evidente che in tal caso l’attenzione si sposta sulla possibilità di nuova deduzione
istruttoria; il caso rientra negli appelli, per così dire, strutturalmente “adesivi”, in cui
l’impugnante non contesta la correttezza logica e giuridica, “rebus sic stantibus”, del
ragionamento del primo giudice, ma solo la giustizia del risultato finale che si propone di
ribaltare sulla scorta di elementi ulteriori10.
Cfr MANNA, “La motivazione della sentenza civile in grado di appello:limiti e oggetto della decisione.”, dagli atti del
Convegno promosso dalla Formazione decentrata del Distretto di Corte di appello di Torino sulla motivazione
della sentenza, maggio 2008.
9
Un caso sostanzialmente analogo, anche se di minor impatto pratico, é quello della deduzione in appello di una
eccezione non proposta in primo grado per causa non imputabile alla parte interessata (ex art.184 bis c.p.c.,
10
42
4. Il quarto caso é quello della domanda relativa ad un diritto “autodeterminato” in cui
l’appellante, sconfitto in prime cure con riferimento ad un titolo di acquisto, cambi in
appello il fondamento di acquisto del diritto, prospettandone una origine non considerata
nel giudizio di primo grado (ad esempio l’usucapione di un fondo piuttosto che il
contratto di compravendita per l’acquisto di una proprietà immobiliare, ovvero la
destinazione del padre di famiglia piuttosto che il testamento quale fonte di una servitù
prediale). In tale ipotesi è la struttura stessa del diritto che consente all’appellante di
mutare la propria impostazione difensiva senza incorrere nel divieto di mutatio libelli e
conseguentemente di esimersi dalla critica della decisione impugnata, che viene in
sostanza “aggirata”11.
5. Infine vi é il caso in cui l’impugnazione si basi su di una norma sopravvenuta alla
decisione di primo grado o sulla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una
norma.12
11. Il rinvio ad altri atti.
L’analisi dei principi enunciati rende agevole comprendere alcuni corollari in tema di
tecniche anomale di formulazione dei motivi mediante rinvio per relationem ad altri fonti.
11.1. Il rinvio a scritti successivi all’atto di appello.
Innanzitutto è del tutto consolidato l’orientamento secondo cui la formulazione dei motivi di
appello, che a pena di decadenza e di inammissibilità deve essere contenuta nell’atto di
impugnazione (atto di citazione in appello per l’appello principale, comparsa di risposta
recante appello incidentale per l’appello incidentale), non può essere validamente effettuata
con scritti processuali successivi e in particolare con la comparsa conclusionale, ossia con lo
scritto defensionale, che ai sensi degli artt.352 e 190 c.p.c., è destinato ad illustrare le difese
già svolte e a confutare le contrapposte argomentazioni13, e non invece a conformare il
contenuto del giudizio di appello.
Pertanto è jus receptum che la comparsa conclusionale non può introdurre la proposizione di
un motivo di appello non contenuto nel primo atto difensivo, anche se ovviamente negli
ritenuto espressione di un principio generale dell’ordinamento che contribuisca a conformare anche la norma sui
nova assertivi o in appello, ossia l’art.345 c.p.c.).
Tuttavia è il caso di ricordare che recentemente la Suprema Corte, con sentenza della sez.I del 7.2.2008 n.2946,
ha invece ritenuto che “La disciplina della rimessione in termini - in particolare quella di cui all’art. 184 bis c.p.c. - concerne
solo la fase istruttoria ed è perciò applicabile a tutte le decadenze verificatesi entro la prima udienza di trattazione e, comunque,
all’interno del giudizio di primo grado, mentre non riguarda la fase di proposizione delle impugnazioni”.
11 Infatti, secondo consolidata giurisprudenza (che scaturisce da una rigida concezione dogmatica circa la natura
dei diritti reali, ma che appare scarsamente sensibile allo sviluppo del contraddittorio e alle conseguenze che in
proposito esercita il sistema di preclusioni assertive e probatorie), non costituisce domanda nuova ma mera
integrazione difensiva, l’allegazione di titoli emersi in corso di causa diversi da quelli originariamente introdotti nel
primo grado del giudizio in quanto la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati individuati in
base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, e non dalla
fonte, necessaria solo a fini di prova ma non di specificazione della domanda. Pertanto l’attore può mutare il titolo
in base al quale chiede tutela senza incorrere nel divieto di “mutatio libelli” ed il giudice può fondare la propria
decisione su un titolo diverso da quello invocato senza che si violi il principio della corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato. Da ultimo in tal senso: Cass.civ. sez.II, 20.11.2007 n.24141; sez.II, 17.7.2007 n.15915; sez.II,
13.2.2007 n.3089; sez.II, 21.11.2006 n.24702; sez.II, 7.12.2005 n.26973.
12 Anche in questo caso l’appello é “adesivo”, nell’accezione sopra proposta, poiché l’appellante non dice che il
giudice ha errato ma assume solamente che la soluzione adottata sia ingiusta perchè non conforme al mutato
dettato normativo.
13 “Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande
e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema
decidendum, né l’accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione
attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione.”(Cassazione civile, sez. III, 14
marzo 2006, n. 5478; conformi Cass. 7 dicembre 2004 n. 22970; Cass. 16 luglio 2004 n. 13165).
43
scritti conclusionali alla parte è consentito validamente sviluppare, con argomentazioni più
articolate, sia in fatto, sia in diritto, le censure già proposte.
Da ultimo, sul punto:
• “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum
appellatum” di cui all’art. 342 c.p.c. - il quale importa non solo la delimitazione del campo del
riesame della sentenza impugnata ma anche l’identificazione, attraverso il contenuto e la portata
delle censure, dei punti investiti dall’impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma
delle decisioni – i motivi debbono essere tutti specificati nell’atto di appello (con cui si consuma il
diritto di impugnazione). Restano, pertanto, precluse nel corso dell’ulteriore attività processuale
sia la precisazione di censure esposte nell’atto di appello in modo generico, che la possibilità di
ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte. (Nella specie il giudice di primo
grado aveva affermato che le opere realizzate dal convenuto non erano a distanza legale rispetto
alla proprietà dell’attore. Con l’atto di appello il convenuto aveva dedotto che in realtà i
manufatti preesistevano all’immobile dell’attore. Atteso che unicamente in sede di comparsa
conclusionale l’appellante aveva eccepito che il Ctu aveva accertato che solo alcuni, dei manufatti
da esso concludente posti in essere non erano a distanza legale, il giudice di appello ha ritenuto
inammissibile tale censura. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha
confermato la pronuncia del giudice di appello).”(Cassazione civile, sez. II, 8 maggio
2008, n. 11406);
• “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del tantum devolutum quantum
appellatum di cui all’art. 342 c.p.c., il quale importa non solo la delimitazione del campo del
riesame della sentenza impugnata ma anche l’identificazione, attraverso il contenuto e la portata
delle censure, dei punti investiti dall’impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma
delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell’atto di appello (con cui si consuma il
diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell’ulteriore attività processuale sia la
precisazione di censure esposte nell’atto di appello in modo generico, che la possibilità di
ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte. Il principio della specificità dei
motivi di appello o postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano
contrapposte quelle dell’appellante, finalizzata a inficiare il fondamento logico-giuridico delle
prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la
sorreggono. È indispensabile, pertanto, che l’atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte
a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, senza la
possibilità di rinviare l’esposizione delle argomentazioni in un momento successivo del giudizio o,
addirittura, alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della
controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo d’impugnazione.”(Cassazione
civile, sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4019)14.
Tracciare l’esatta linea di demarcazione fra mera argomentazione illustrativa di una censura
già proposta e proposizione di una censura nuova sino ad allora trascurata non è sempre
agevole.
Qualche criterio orientativo potrà forse giovare:
• è sicuramente mera argomentazione l’indicazione di precedenti giurisprudenziali a
conforto;
• è pure mera argomentazione la deduzione di riscontri a sostegno di una
interpretazione diversa da quella adottata, già patrocinata con l’atto di
impugnazione in linea generale (si pensi ad argomenti sistematici, a contrario, per
assurdo, ovvero al suggerimento di una interpretazione “costituzionalmente
orientata”);
• dovrebbe rientrare nella mera argomentazione anche l’indicazione di elementi di
carattere indiziario, desunti ex actis, che confortino più specificamente il
14
Conformi Cass.civ. sez.II, 23.5.2006 n.12140; sez.III, 23.2.2006 n.4019; sez.I, 11.1.2006 n.394.
44
•
•
ragionamento presuntivo rifiutato dal primo giudice e caldeggiato con il motivo
di impugnazione;
si esce invece dalla mera argomentazione per sconfinare nella proposizione di
motivo inammissibile allorché la parte, per la prima volta con lo scritto
conclusionale, introduca una critica al pensiero del giudice o miri ad infrangere un
presupposto del suo ragionamento, prima non aggredito;
ciò si verifica, ad esempio nel caso in cui l’appellante solo con la conclusionale
sostenga:
che il testimone, sul cui racconto era stata appoggiata la ricostruzione del
fatto storico nella decisione impugnata, era inattendibile o incapace;
oppure nel caso in cui sostenga che l’obbligazione per cui era stata
pronunciata condanna si era estinta per compensazione mentre con l’atto
di appello aveva dedotto un pagamento;
ovvero ancora nel caso in cui l’appellante sostenga che la prescrizione era
stata interrotta con una missiva diversa da quella indicata nell’atto di
impugnazione.
11.2. Il rinvio agli scritti difensivi di primo grado.
Un secondo corollario attiene al rinvio effettuato dall’appellante per relationem agli atti difensivi
di primo grado, in linea generale, o più selettivamente e specificamente, ad uno scritto
particolare, normalmente la comparsa conclusionale di primo grado.
E’ massima consolidata quella che predica l’inammissibilità di siffatta operazione di rinvio,
inidonea a soddisfare il requisito della specificità prescritto dall’art.342 c.p.c.:
• “L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 c.p.c., non è assolto con il
semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, perché i motivi di
gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le
difese esposte prima di essa; inoltre un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem, al fine
di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione
che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle
censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio,
giacché, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte
sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla
lettura della sentenza - e dunque a posteriori - i motivi sui quali, secondo la ricostruzione
operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.”(Cassazione civile, sez.
I, 23 maggio 2006, n. 12140);
• “L’onere di specificazione dei motivi dii appello imposto dall’art. 342 c.p.c. non è assolto con il
semplice richiamo “per relationem” alla comparsa conclusionale di primo grado grado in quanto,
da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell’atto di
impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le
difese esposte prima di essa; dall’altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad
quem ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Ne
consegue, in difetto di esposizione dei motivi specifici dell’impugnazione, la nullità dell’atto e
l’inammissibilità del gravame. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la Corte di merito aveva
fatto buon governo delle norme processuali ritenendo formatosi il giudicato interno sul punto in
esame per mancanza di valida impugnazione).”(Cassazione civile, sez. III, 20 settembre
2002, n. 13756).
Il principio esposto è del tutto condivisibile, anche se occorre star attenti a non considerarne
l’insegnamento in modo troppo automatico, dimenticandone la ratio fondamentale.
Non sussiste infatti un divieto assoluto ed autonomo di motivare per relationem le proprie
censure, specie se il termine della relatio è costituito da un atto processuale facilmente
identificabile ed agevolmente consultabile dalla controparte e dal giudice.
45
La sanzione di inammissibilità scaturisce infatti in via indiretta per la normale inidoneità
ontologica che affligge un atto cronologicamente precedente (la comparsa conclusionale di
primo grado) a “trasportare” la critica ad un atto successivo ancora ignoto (la sentenza di
primo grado): è ben difficile che con doti “profetiche” si possa criticare, specificamente tanto
più, un atto prima che questo sia stato posto in essere.
Ben difficile, peraltro, non impossibile.
Può talora verificarsi, infatti, che se lo scritto conclusionale è particolarmente circoscritto e
mirato nel trattare un argomento (oggetto della relatio nell’atto di appello) e la sentenza che
ha deciso sulla questione é del tutto generica e scarsamente motivata, la grave difficoltà sopra
delineata possa essere superata.
In altre parole, molto dipende dalla sentenza e dalla sua conformità all’astratto modello di
atto di un terzo che decida la disputa esternando un percorso mentale autonomo per
giustificare la soluzione; se la sentenza è conforme al modello astratto è pressoché impossibile
che il motivo “riciclato” dallo scritto di primo grado possa cogliere il bersaglio; il contrario
può accadere invece allorché la sentenza si allontani significativamente dal suo modello.
In tal caso può accadere che il motivo “profetico” colga il segno.
Un esempio aiuterà a comprendere:
• se l’attore chiede il pagamento di un proprio credito e dedica la propria comparsa
conclusionale a chiarire le ragioni inerenti la natura commerciale del credito per cui gli
sono dovuti gli interessi al tasso più elevato previsti dal d.lgs 231 del 2002;
• se il giudice di primo grado con la sentenza che accoglie quanto al capitale la pretesa
attorea, semplicemente ignora tale argomentazione, riconoscendo solamente gli
interessi al tasso legale (“con gli interessi al tasso legale dal…. al saldo”),
• il requisito di specificità è soddisfatto se l’appellante nell’atto di impugnazione con
cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, chiede la condanna del
convenuto anche al pagamento degli interessi commerciali, propone la sua censura
semplicemente richiamando quanto esposto in punto nella comparsa conclusionale di
primo grado.
Le considerazioni di cui sopra possono aiutare alla soluzione di una questione analoga a
quella del rinvio per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado, sopra analizzato.
Un illustre Magistrato, poco amante dei moderni mezzi informatici, si picca di controllare con
attenzione scrupolosa il rapporto intercorrente fra gli atti processuali di primo grado
dell’appellante (e in particolare la comparsa conclusionale) e l’atto di appello; il che, con
preoccupante frequenza, permette a quel Giudice l’accertamento di una corrispondenza
pressoché integrale fra le argomentazioni svolte dalla parte in tutto o in parte soccombente,
successiva appellante, per convincere il primo giudice e quelle da essa successivamente
addotte per censurare l’operato del primo giudice al cospetto del secondo (corrispondenza
normalmente dovuta al ricorso ad un sapiente utilizzo dei comandi “copia” e “incolla” di Word).
Egli propone quindi il seguente ragionamento, invero non privo di una sua stringente
coerenza: se è vero che “i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono
essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa”, come insegna la giurisprudenza, allora l’atto di
appello letteralmente copiato dalla comparsa conclusionale di primo grado incorre nello stesso
vizio che affligge l’atto di impugnazione che la richiami per relationem, non potendo certamente
essere la tecnica del rinvio (operato in un caso con un invito a leggersi l’atto precedente e
nell’altro caso con la sua mera riproduzione grafica) ad alterare la sostanza della situazione e a
influenzare il risultato finale.
Il ragionamento è solo apparentemente convincente; per confutarlo è sufficiente inficiare la
premessa, ricordando il vero motivo per cui non è possibile proporre validi e specifici motivi
di censura nello scritto conclusionale di primo grado; ciò non discende infatti da un divieto
assoluto ma da una estrema difficoltà pratica, che rasenta l’impossibilità, di concepire e
articolare una critica anticipata.
Ed allora la risposta non può che essere quella fornita per il caso del rinvio per relationem, ossia:
46
l’appello sarà inammissibile non già perché sono state “copia-incollate” le argomentazioni della
comparsa conclusionale, ma perché tali argomentazioni non assolvono alla funzione critica
che i motivi di appello debbono soddisfare, eccezion fatta per quelle ipotesi in cui la genericità
e il difetto di motivazione della sentenza permettono, nei fatti, alle argomentazioni precedenti
di conservare efficacia.
11.3. Le sentenze integralmente copiate.
La suggestione esercitata dall’analogia sposta l’attenzione dall’avvocato pigro al giudice pigro.
La pratica giudiziaria porta, purtroppo abbastanza spesso, ad imbattersi in sentenze redatte
mediante l’integrale recepimento dello scritto conclusionale di una delle parti, effettuato con
una raffinata tecnica di “scannerizzazione” o con una disinvolta utilizzazione dei “dischetti”
richiesti senza inibizione alle parti (o da taluna di questa maliziosamente offerti).
Non è questa la sede per commentare come si meriterebbe una simile pigrizia che si traduce in
discredito della funzione e del ruolo del magistrato e ne offende il prestigio15.
Ci si chiede, piuttosto, quale debba essere la corretta reazione processuale della parte che
intende impugnare in appello la sentenza che abbia sciaguratamente riprodotto in modo
integrale (o pressoché integrale) l’intero contenuto dello scritto defensionale avversario.
V’è chi (non senza ragioni) sostiene che una sentenza redatta con una simile anomala tecnica di
acquisizione sistematica delle argomentazioni di una delle parti non sia realmente motivata, dal
momento che il proprium della motivazione del provvedimento giurisdizionale consiste nel
rendere trasparente il percorso mentale del protagonista dell’atto decisorio (elemento questo
nella fattispecie carente); la motivazione sarebbe quindi solo apparente e l’appellante si
dovrebbe limitare a denunciare la nullità della sentenza per omessa motivazione, posto che il
giudice avrebbe sì scelto una soluzione, ma non avrebbe realmente spiegato perché lo ha
fatto.
La tesi così proposta non è condivisa da chi invece ritiene di dover tenere ben separati il
piano dei doveri deontologici del magistrato e della conseguente responsabilità disciplinare,
(giacché siffatta condotta merita, beninteso, una severa censura) da quello dell’atto processuale
e delle reazioni contro lo stesso esercitabili dalle parti interessate.
Secondo tale opinione la sentenza, pur redatta con la descritta anomala tecnica di “acquisizione
sistematica” delle argomentazioni di una delle parti, possiede l’elemento fondamentale della
motivazione ed é comunque valida.
E’ pur vero che il giudice ha scelto le tesi e le argomentazioni di una delle parti e se ne è
appropriato, ma esse, una volta cristallizzate nella sentenza, acquisiscono vita propria e
dignità di motivazione del dispositivo, senza trascinarsi dietro il vizio genetico della loro
origine storica, e prescindono totalmente dalla mancanza di laboriosità e di capacità di
pensiero indipendente del giudicante.
Il giudice ha adottato tali motivazioni e quelle ormai sono le motivazioni della sentenza, contro
cui l’appellante deve esercitare il proprio sfogo censorio, senza tener conto del fatto il
pensiero che le anima proviene in origine dal suo antagonista e non dal giudice.
La parte appellante deve quindi esercitare il proprio onere di confutazione logica contro tutte
quelle argomentazioni che il giudice di primo grado ha prospettato in sentenza, sia pur
“appiattendosi” pedissequamente e acriticamente sulle difese di una delle parti, ma comunque
appropriandosene e conferendo loro rilievo di atto giurisdizionale.
Questa appare la soluzione corretta e scevra dal preconcetto scaturente dalla ripulsa etica del
modus procedendi del giudicante; questi può aver copiato la comparsa conclusionale di una delle
parti per risparmiarsi fatica o perché tale scritto l’ha convinto in tutto e per tutto: tuttavia una
motivazione da avversare esiste e contro quella l’appellante deve sfogare tutte le sue doglianze.
Le differenze fra l’una e l’altra impostazione non sono di poco momento.
15 La Sezione Disciplinare del C.S.M. si è recentemente occupata funditus dell’argomento con sentenza del
4.6.2008. La contestazione riguardava fra l’altro il d.lgs 23.2.2006 n.109 , art.2, lettere d) e a).
47
Secondo la prima concezione, all’appellante è sufficiente denunciare il “plagio” e con esso la
nullità della sentenza e non é necessario aggredire con contro-argomentazioni idonee alla
confutazione tutte le considerazioni “prestate” dal suo avversario al giudice; l’appellante può
quindi riproporre semplicemente le proprie tesi che troverebbero libera considerazione dopo
l’elisione della sentenza nulla.
Per la seconda e preferibile concezione, i singoli argomenti prestati dall’avversario al giudice
debbono essere affrontati e contestati, uno per uno, pena in difetto l’inammissibilità del
gravame.
12. Conseguenze della mancanza di specificità dei motivi:
dell’impugnazione.
inammissibilità
Prima di passare all’esame analitico delle varie tipologie dei motivi di impugnazione in appello
e delle loro particolarità, appare opportuno mettere a fuoco quali siano le conseguenze della
proposizione di un appello privo di motivi specifici nella nozione appena delineata.
Il punto di riferimento imprescindibile va individuato nella già citata decisione n.16 delle
Sezioni Unite del 29.1.2000, secondo la quale:
“L’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza
di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma
si verifica ogniqualvolta - essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello,
evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria;
pertanto, essendo inapplicabile all’atto di citazione di appello l’articolo 164, comma 2, c.p.c. (testo
originario), per incompatibilità - in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 342 c.p.c. è
idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -,
l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dall’articolo 342 cit., integra una nullità
che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato
della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione dell’appellato in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei
motivi avvenuta in corso di causa.”
La pronuncia delle Sezioni Unite è intervenuta a dirimere un contrasto esistente in dottrina e
giurisprudenza, circa le conseguenze della proposizione di un appello privo dell’adeguata
specificazione dei motivi ai sensi dell’art.342 c.p.c.
Secondo un primo orientamento, che si rifaceva ad un precedente delle stesse Sezioni Unite
(Cass.SS.UU. 6 giugno 1987 n. 4991), la violazione dell’art. 342 c.p.c. non era affetta da
inammissibilità, ma da nullità, sanabile con effetto ex nunc in seguito alla costituzione in
giudizio dell’appellato, perché la sanzione della inammissibilità non era prevista da alcuna
norma, mentre l’applicabilità della sanatoria discendeva dal rinvio, contenuto nell’art. 342
c.p.c., all’art. 163 c.p.c.16.
Secondo un diverso indirizzo, invece, il difetto di specificità dei motivi di appello determinava
l’inammissibilità dell’impugnazione, perché il requisito di cui all’art.342 c.p.c. era ulteriore e
autonomo, sul piano logico e giuridico, rispetto alle indicazioni prescritte per ogni atto di
citazione dall’art. 163 c.p.c., mentre l’art. 164 c.p.c. non era stato richiamato nella disciplina
dell’appello, laddove, in sua vece, era stata introdotta la norma generale sulle conseguenze
della inammissibilità, per cui, in secondo grado, non vi può essere nullità sanabile della
citazione, essendo “quesito” proprio il diritto alla decadenza dall’impugnazione17.
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto accogliendo le conclusioni auspicate dal
secondo indirizzo, anche se sulla base di diverse e più complesse considerazioni.
Queste le scansioni fondamentali del ragionamento del Supremo Collegio:
• la violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi determina un
vizio dell’atto, da qualificare, in prima approssimazione, come invalidità;
16 Cfr anche Cass. 20 settembre 1993 n. 9628; Cass. 8 febbraio 1996 n. 1008; Cass. 15 gennaio 1997 n. 355; Cass.
27 febbraio 1998 n. 2149
17 Cfr Cass. 21 aprile 1994 n. 3809; Cass. 2 febbraio 1995 n. 2012; Cass. 29 luglio 1995 n. 8377.
48
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l’invalidità di un atto processuale è costituita dalla maggiore o minore difformità
dello stesso rispetto al modello che lo prevede e, in funzione del grado di
difformità, si parla di:
irregolarità (minima difformità rispetto al modello, che non pregiudica la
validità dell’atto processuale, nè incide sui requisiti indispensabili per il
raggiungimento dello scopo dell’atto),
nullità (difformità dell’atto rispetto al modello, tale da non impedire il
passaggio in giudicato della sentenza che ne sia affetta ove non sia fatta
valere con la impugnazione),
inesistenza (in cui l’atto processuale manca totalmente degli estremi e dei
requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della
figura giuridica considerati, oppure é inidoneo non solo a produrre gli
effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma
persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico);
l’invalidità dell’atto di appello carente degli specifici motivi va ricondotta alla
figura della nullità perché l’appello è strumento di reazione contro l’ingiustizia
della sentenza di primo grado, ed è rimessa alla parte, per il principio dispositivo,
la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta;
ne consegue l’esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile
dalla postulazione dell’ingiustizia denunciata;
in difetto della motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può
procedere alla revisio prioris instantiae;
l’inammissibilità - con la quale vengono sanzionati determinati atti - non
costituisce vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma conseguenza di particolari
nullità, che si verificano con la proposizione dell’appello o del ricorso per
cassazione;
il problema è quindi non tanto se il vizio dell’atto di cui all’art. 342 c.p.c.
determina la sua nullità o la sua inammissibilità, quanto piuttosto se all’atto, cosi
difforme rispetto al modello che lo prevede, debbano applicarsi le conseguenze
proprie della nullità o, invece, quelle della inammissibilità;
l’alternativa è foriera di importanti conseguenze poiché l’impugnazione alla quale
si applicano i principi dell’inammissibilità non é soggetta a sanatoria18, mentre
l’atto di citazione in appello alla quale si applicano le disposizioni sulla nullità si
sana automaticamente, sulla base del testo originario dell’art. 164 c.p.c., in seguito
alla costituzione del convenuto, salvi i diritti anteriormente quesiti;
non convince la tesi della tassatività dell’applicazione delle conseguenze della
inammissibilità, con la conseguenza che ogni ipotesi di difformità dell’atto
d’impugnazione, rispetto al modello che lo prevede, non espressamente
sanzionata con l’inammissibilità, induca la nullità dell’atto, con applicazione della
relativa sanatoria;
il problema è quello di stabilire se, in difetto di qualsiasi richiamo all’art. 164,
l’interprete possa, in tema di vizi dell’atto di appello, ritenere comunque
applicabile tale norma e, quindi, affermare la sanatoria di tali vizi attraverso la
costituzione dell’appellato;
la disposizione dell’art.164 c.p.c. non é applicabile in tema di appello in virtù del
rinvio generale contenuto nell’art.359 c.p.c., in quanto, al fine dell’applicabilità
L’impugnazione dichiarata inammissibile può, semmai, essere riproposta, a norma degli art. 358 e 387 c.p.c.,
purché, comunque, non sia intervenuta la relativa dichiarazione e non sia esaurito il termine, il quale è peraltro
sempre breve, in quanto decorre (Cass. 5 giugno 1998 n. 5548) dalla data della notificazione della precedente
impugnazione.
18
49
delle norme dettate per il procedimento di primo grado, è necessario che tali
norme superino il filtro del giudizio di compatibilità;
• lo scopo dell’atto di citazione di primo grado è quello di costituire il rapporto
giuridico processuale, mentre gli scopi dell’atto di appello sono quello della
costituzione del rapporto giuridico processuale di impugnazione e quello di
evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attraverso la
denuncia della sua pretesa ingiustizia;
• la costituzione del convenuto, nel giudizio di primo grado, sana i vizi dell’atto di
citazione, perché consente il raggiungimento dello scopo dell’atto;
• la costituzione dell’appellato, nel giudizio di appello, è idonea a raggiungere uno
dei suoi scopi (costituzione del rapporto giuridico processuale), ma è inidoneo a
raggiungere l’altro (impedimento del passaggio in giudicato della sentenza
impugnata), che si consegue solo con il comportamento dell’appellante conforme
alle previsioni di cui all’art. 342 c.p.c.;
• non sussiste alcuna possibilità per l’appellato di rimuovere gli effetti che derivano
dalla inosservanza di quest’ultima norma, stante l’indisponibilità degli effetti
stessi o per l’appellante di rimediare alla nullità attraverso la specificazione dei
motivi in corso di causa;
• la rilevata inapplicabilità dell’art. 164, comma 2, c.p.c. all’atto di appello, redatto
in violazione dell’art. 342 c.p.c., non esclude però che si sia in presenza di un atto
nullo, perché lo stesso è inidoneo a raggiungere uno dei suoi scopi (art. 156,
comma 2, c.p.c.);
• siffatta nullità, non è sanabile dall’appellato con la sua costituzione ed è rilevabile
d’ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno;
• resta salvo il potere dell’appellante di rinnovare l’atto privo dei vizi di cui al
citato art. 342 c.p.c., nel rispetto dei termini fissati dalla legge e prima della
dichiarazione d’inammissibilità (ex art. 358 c.p.c.);
• la sanzione, in difetto di rinnovazione, é la pronuncia d’inammissibilità
dell’appello proposto, proprio perché il giudice, rilevato il vizio dell’atto,
inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il
giudizio d’impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione e cioè al
giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata;
• la sanzione di inammissibilità deve ritenersi applicabile ogniqualvolta si sia in
presenza di un atto di appello che, per il momento in cui è compiuto (si pensi,
tanto per fare un esempio, all’impugnazione proposta oltre i termini fissati dalla
legge), o perché contrario ad atti o comportamenti precedenti o contemporanei
alla proposizione dell’atto (acquiescenza parziale o totale: art. 329 c.p.c.), o per la
sua difformità rispetto al modello che lo prevede (violazione dell’art. 342 c.p.c.),
non consenta al giudice di accedere all’esame, nel merito, della revisio prioris
instantiae richiesta, qualora questi vizi non possano venire meno, né attraverso la
cooperazione dell’appellato, né attraverso il comportamento dell’appellante;
• pertanto l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dall’art.
342 c.p.c., integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione,
con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
senza alcuna possibilità di sanatoria dell’atto a seguito della costituzione
dell’appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto
possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa.
Tali principi sono stati ribaditi e confermati dalla giurisprudenza successiva e possono
pertanto dirsi acquisiti.
Da ultimo:
50
•
“In tema di processo di appello, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum
appellatum” di cui all’art. 342 c.p.c. - il quale importa non solo la delimitazione del campo del
riesame della sentenza impugnata ma anche l’identificazione, attraverso il contenuto e la portata
delle censure, dei punti investiti dall’impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma
delle decisioni - i motivi debbono essere tutti specificati nell’atto di appello (con cui si consuma il
diritto di impugnazione). Restano, pertanto, precluse nel corso dell’ulteriore attività processuale
sia la precisazione di censure esposte nell’atto di appello in modo generico, che la possibilità di
ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte. (Nella specie il giudice di primo
grado aveva affermato che le opere realizzate dal convenuto non erano a distanza legale rispetto
alla proprietà dell’attore. Con l’atto di appello il convenuto aveva dedotto che in realtà i
manufatti preesistevano all’immobile dell’attore. Atteso che unicamente in sede di comparsa
conclusionale l’appellante aveva eccepito che il Ctu aveva accertato che solo alcuni, dei manufatti
da esso concludente posti in essere non erano a distanza legale, il giudice di appello ha ritenuto
inammissibile tale censura. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha
confermato la pronuncia del giudice di appello).”(Cassazione civile, sez. II, 8 maggio
2008, n. 11406);
• “Nel giudizio di appello - che non è un “novum iudicium” - la cognizione del giudice resta
circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige
che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le
statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che,
nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame
consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a
pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività
difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le
statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo
grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano
esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza
impugnata.”(Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2007, n. 9244)19.
E’ tuttavia doverosa una precisazione, che appare financo ovvia.
Se la parte appellante non ha formulato nell’atto di impugnazione in appello alcun motivo
specifico di censura nei confronti della decisione impugnata, la carenza di idonei motivi
determina la nullità e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, alla stregua dei
principi sopra illustrati.
Se invece uno o più motivi di impugnazione peccano di insufficiente specificità e debbono
quindi essere considerati inammissibili, il vizio non si estende all’intera impugnazione,
allorché questa contenga almeno una valida censura meritevole di esame, nel rispetto del
fondamentale broccardo, espressione del principio di conservazione giuridica, “utile per inutile
non vitiatur”.
Ad esempio:
• “L’inosservanza dell’onere della specificazione dei motivi di appello determina la nullità dell’atto
di appello quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente
specificazione, mentre si traduce nel divieto del giudice adito di estendere ad essi il proprio
riesame se l’anzidetta omissione si riferisca soltanto ad alcuni capi.”(Cassazione civile, sez.
III, 14 febbraio 2006, n. 3180).
13. Il parametro di valutazione della specificità.
Nello stesso senso: Cass.civ, sez. I, 11.10.2006 n.21816; sez. I, 19.9.2006 n.20261; sez.III, 14.3.2006 n.5445;
sez.III, 14.2.2006 n.3180; sez.III, 16.12.2005 n.27727; sez.III, 24.11.2005 n.24817; sez.trib,.8.7.2004 n.12589;
sez.lav.,3.6.2004 n.10596; sez.III, 20.8.2003 n.12218; sez.II, 30.7.2001 n.10401.
19
51
Un primo, importantissimo, corollario della nozione di specificità dei motivi sopra esposta
attiene al parametro di valutazione del requisito, che esprime un concetto di relazione da
rapportarsi, ovviamente, al contenuto della sentenza impugnata.
Quanto più specifiche e precise sono le affermazioni contenute nel provvedimento
impugnato, tanto più precise e specifiche dovranno essere le censure rivolte dall’appellante
nei loro confronti per superare lo scrutinio di rispondenza all’art.342 c.p.c..
Viceversa, quanto più vaghe e generiche siano le enunciazioni del primo giudice, tanto meno
si dovrà pretendere dall’appellante in tema di specificità della critica sfogata contro di esse.
Il punto è del tutto acquisito e riaffermato in una messe copiosa di pronunce
giurisprudenziali di legittimità.20
Da ultimo:
• “Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall’art. 342 c.p.c. non può essere
definito in via generale e assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza
impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante deve essere formulata in modo
da consentire d’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche
critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l’indicazione, sia pure in forma
succinta, degli “errores” attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla
motivazione di questa ultima e quindi devono essere più o meno articolati, a seconda della
maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione.”(Cassazione civile, sez.
II, 5 maggio 2009, n. 10356 ).
In conseguenza, a fronte di una motivazione particolarmente puntuale e specifica, l’appellante
dovrà rivolgere una critica mirata e diretta a dimostrare le ragioni della infondatezza delle
ragioni addotte; laddove invece il giudice si sia limitato ad una mera generica presa di
posizione, all’appellante potrà essere sufficiente ribadire la propria posizione contraria; nel
caso in cui il giudice di primo grado non abbia esposto alcuna ragione a sostegno della
propria decisione (ossia abbia omesso di motivare) basterà all’appellante rilevare tale
circostanza, che integra ragione di nullità della decisione di primo grado e riproporre la
propria domanda od eccezione in tal modo disattesa.
Per esempio, se in una controversia commerciale riguardante la fornitura di merce
asseritamente viziata, in cui venga invocata dall’acquirente la garanzia contrattuale mentre il
fornitore eccepisce la decadenza per omessa tempestiva denuncia, insorge disputa tra le parti
circa l’applicabilità delle norme sulla vendita ovvero sull’appalto (con ulteriori consequenziali
ripercussioni circa i termini da rispettare ai fini della denuncia dei vizi al fornitore):
• nel caso in cui il giudice di primo grado ha applicato apoditticamente, senza
motivazione, le norme in tema di vendita, sanzionando con la decadenza
l’acquirente che aveva denunciato i vizi oltre i termini di legge, é sufficiente a
costui, per impugnare validamente, riaffermare la propria tesi sulla configurabilità
di un appalto, persuadendo il giudice di secondo grado di tale assunto;
• nel caso in cui il giudice ha deciso nello stesso modo, affermando che nella specie
si doveva ravvisare una vendita (e non già un appalto) per la prevalenza nella
fornitura del valore della materia prima rispetto a quella della manodopera, alla
luce delle risultanze processuali genericamente richiamate, é sufficiente
all’appellante contestare l’assunto e affermare che tale prevalenza non era
riscontrabile;
• allorché invece, sempre nella stessa controversia, il primo giudice ha motivato la
sua conclusione sulla base dell’estraneità della produzione della merce rispetto al
normale processo produttivo dell’impresa fornitrice e della rilevanza delle
modifiche apportate al prodotto-base, non riconducibili a meri accorgimenti e
Cass.civ. sez.III, 21.5.2008 n.13080; sez.III, 24.8.2007 n.17960; sez.III, 18.4.2007 n.9244; sez.I, 19.9.2006
n.20261; sez.III, 31.5.2006 n.12984; sez.III, 14.3.2006 n.5445; sez.III, 24.11.2005 n.24817; sez.II, 14.11.2005
n.22906; sez.I, 5.7.2002 n.9821; sez II, 2.8.2001 n.10569.
20
52
adattamenti marginali e secondari, correlando tale inferenza all’analisi di specifici
documenti prodotti dalle parti o di concreti accertamenti operati da un
consulente tecnico d’ufficio, l’appellante per impugnare validamente dovrà
criticare il principio giuridico applicato o l’accertamento dei fatti storici sui quali
era stata basata la decisione, subendo in difetto l’inammissibilità del gravame.
14. Motivazione mancante
Si è già anticipato nel corso del precedente paragrafo che allorché la decisione di primo grado
non sia stata motivata, come prescritto dall’art.132, 2° comma, n.4, c.p.c., in armonia con il
sesto comma dell’art.111 Cost., alla parte insoddisfatta della decisione è sufficiente reagire
denunciando il difetto di omessa motivazione e la conseguente nullità della sentenza sul
punto.
Bisogna distinguere, peraltro, l’ipotesi in cui la sentenza é completamente priva della
prescritta esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, che non siano neppure
enucleabili in alcun modo dal contesto del provvedimento, da quella in cui il giudice ha
giustificato la propria decisione con una motivazione incompleta, inadeguata o insufficiente,
ma in cui sia comunque possibile per l’interprete identificare il percorso logico che ha
indotto il giudice al convincimento concretatosi nella decisione adottata.
Nel primo caso la sentenza è nulla per carenza di un requisito prescritto dalla legge, e
indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi degli artt.132, 4° comma e
156, 2° comma, c.p.c.21.
Nel secondo caso invece la sentenza non è nulla, ancorché viziata.
Le conseguenze che si ripercuotono sulla tecnica di proposizione dell’impugnazione sono
intuitive.
Nel primo caso all’appellante basta denunciare la nullità della sentenza convertitasi in motivo
di impugnazione ai sensi dell’art.161 c.p.c. e riproporre le proprie domande ed eccezioni; nel
secondo caso egli dovrà dirigere un motivo specifico di appello volto a dimostrare le
incongruenze, incompletezze e aporie della motivazione inadeguata ma sussistente.
Da ultimo:
• “Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso le sentenze del tribunale
superiore delle acque pubbliche pronunciate in grado di appello è ammesso, in via ordinaria - ai
sensi dell’art. 200 r.d. n. 1775 del 1933 - oltre che per incompetenza e per eccesso di potere per
violazione di legge, ai sensi del n. 3 dell’art. 517 c.p.c. (del 1865), ovvero se contenga
disposizioni contraddittorie previste n. 8 dell’art. 517 del medesimo codice. Con riguardo ai vizi
di motivazione il ricorso per cassazione può essere sperimentato ai sensi dell’art. 111 cost., non
già per far valer omissioni, insufficienze e contraddittorietà riconducibili allo schema dell’art.
360, n. 5, c.p.c., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della
sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., come nel
caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente, per intrinseca inidoneità a consentire il
controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.”(Cassazione civile, sez. un., 23
maggio 2008, n. 13358);
• “Le sentenze del giudice di pace, in ipotesi di pronuncia secondo equità, ai sensi dell’art. 113,
comma 2, c.p.c., devono essere succintamente motivate, in ossequio al principio degli art. 132,
comma 2, n. 4, c.p.c., e 118, comma 2, seconda parte, disp. att. dello stesso codice, oltre che del
generale principio dell’art. 111 cost. La mancanza di tale requisito essenziale, che deve ritenersi
configurabile non solo nei casi di sentenza del tutto mancante di motivazione ma anche in quelli
di motivazione apparente - perché priva della indicazione degli elementi che giustificano il
convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimità - può essere dedotto sotto
il profilo della nullità della sentenza per violazione delle suddette disposizioni degli art. 132
c.p.c. e 118 disp. att. dello stesso codice. (Nella fattispecie, relativa all’azione di danni nei
21
Cfr Cass. 3.3.1999 n.1771; Cass.25.5.1999 n.829.
53
•
confronti dell’appaltatore e del comune, per essere l’attrice caduta nella buca aperta nella strada
per la sostituzione di tubi fognari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace
che si era limitata ad affermare che non erano stati apposti segnali di pericolo, senza indicare
quali prove avessero sostenuto tale convincimento e chiarire le ragioni per cui erano state ritenute
prevalenti le eventuali prove della situazione dei luoghi così sommariamente accertata rispetto a
quelle contrarie indicate e prodotte dalla parte)”(Cassazione civile, sez. III, 22 maggio
2007, n. 11880);
“Il vizio di motivazione, in caso di sentenza resa dal g.d.p. secondo equità, rileva esclusivamente
nei limiti in cui sia tale da determinare - per la sua assoluta mancanza o apoditticità ovvero
ancora per la sua assoluta contraddittorietà - la sostanziale mancanza di uno dei requisiti della
sentenza previsti dall’art. 132 n. 4 c.p.c. e quindi la su nullità.”(Cassazione civile, sez. III,
27 novembre 2006, n. 25144; cfr anche sez. III, 12 aprile 2006, n. 8620; Cass. 3
agosto 2005 n. 16254).
15. Doppia ratio decidendi.
E’ assai frequente imbattersi nell’ipotesi inversa rispetto a quella della motivazione omessa o
insufficiente, ossia in una sentenza sorretta da doppia (o multipla) motivazione.
Allorché il giudice di primo grado prospetta due (o più) concorrenti ragioni di merito
(operanti allo stesso livello concettuale) per suffragare la propria decisione di accoglimento o
di rigetto della domanda si realizza un effetto di potenziamento della base logica su cui
poggia la sentenza, che costringe l’appellante a censurare tutte le concorrenti rationes decidendi,
ciascuna delle quali appare potenzialmente idonea a sorreggere la decisione, ove non
tempestivamente e puntualmente censurata.
Un più risalente modo di pensare induceva a catalogare tale problematica nella prospettiva
dell’interesse (in senso tecnico-giuridico ex art.100 c.p.c.) a proporre l’impugnazione, poiché
vanamente critica la sentenza colui che con le proprie censure recide solo una delle radici
che la tengono in piedi.
Chi ragiona in questo modo finisce con l’affermare che l’appellante che non aggredisca tutte
le concorrenti rationes decidendi non è assistito da un interesse che non sia meramente teorico e
accademico all’esame della sua censura, poiché la sentenza si reggerebbe comunque in piedi
sulla base delle altre rationes decidendi non criticate.
Una chiave di lettura più moderna preferisce costruire le stesse conclusioni sulla matrice
della nozione sopra delineata di “specificità” ex art.342 c.p.c.: non è specifico il gravame
diretto solo contro una delle rationes decidendi esposte dalla sentenza di primo grado, perché
non é idoneo a soddisfare il fondamentale requisito della potenziale attitudine alla sua
confutazione.
Insegna, ancora recentemente, la Suprema Corte:
• “Allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base a una pluralità di
autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, la parte, soccombente
ha l’onere di censurare in appello, con idonea impugnativa, pena la inammissibilità della
impugnazione, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più
successivamente censurare la “ratio decidendi” non tempestivamente contestata, né utilmente
discutere, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo, sostegno, a
nulla valendo - a tale fine - la richiesta di riforma della decisione, di per sé non idonea a
superare il difetto di specificità dei motivi di impugnazione.”(Cassazione civile, sez. trib.,
10 febbraio 2006, n. 2938);
• “Allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di
autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è
consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di
merito, ritenga utile valutare anche un’altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di
fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l’eventualità che il giudice
dell’impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la
54
parte soccombente ha l’onere di censurare con l’atto d’appello ciascuna delle ragioni della
decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente
contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi
profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo
a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma
ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non
potendo il giudice d’appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei
termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato.”(Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 2007, n. 18310).22
L’appellante deve quindi aver estrema cura nel condurre l’analisi della sentenza impugnata per
verificare preliminarmente alla stesura dell’atto di impugnazione l’esistenza di una pluralità di
rationes decidendi per scatenare contro ciascuna di esse il proprio sfogo critico.
Spesso accade che una concorrente ratio decidendi sia dissimulata in un inciso, magari
contenuto nell’arco di una parentesi: occorre in questi casi verificare se l’affermazione
incidentale costituisca una vera e propria affermazione del giudice, di per sé sola capace di
sorreggere la decisione adottata, dopo l’eliminazione virtuale della motivazione principale,
ovvero se essa non possegga i caratteri dell’univocità e della sicurezza e debba pertanto per il
suo carattere ipotetico o perplesso essere qualificata come una considerazione pleonastica,
che non funge da “muro portante” dell’edificio-sentenza (che quindi non si reggerebbe in
piedi in modo apprezzabile solo su di essa, dopo l’operazione di eliminazione virtuale della
motivazione principale).
15.1. Concorrente ratio decidendi esposta in modo coordinato.
La comprensione sarà agevolata da alcune esemplificazioni, utilizzando quale strumento di
lavoro una immaginaria sentenza che abbia deciso in primo grado una controversia di
carattere reale in cui l’attore rivendicava l’acquisito per usucapione ventennale di una servitù
prediale di passaggio sul fondo del vicino convenuto.
Consideriamo questa motivazione:
“L’attore non ha provato di aver esercitato il passaggio per venti anni, poiché i testi escussi si sono riferiti solo
ad un periodo temporale molto più ristretto (7-8 anni).
Inoltre non è stata né dedotta, né provata, la sussistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio
del passaggio, sicché la servitù non apparente non risulta usucapibile ai sensi dell’art.1061 c.c.”
In questo caso vi sono due evidenti concorrenti ragioni della decisione, la prima inerente al
difetto di prova dell’esercizio del passaggio per vent’anni, la seconda fondata sulla non
apparenza della servitù e sulla mancanza di opere visibili e permanenti (per la verità, a voler
essere rigorosi, ce ne sono addirittura tre, perché il Giudice ha rilevato sia il difetto di
allegazione sia il difetto di prova del requisito dell’apparenza).
Tutte queste ragioni concorrenti debbono essere criticate, pena in difetto l’inammissibilità
dell’impugnazione.
15.2. Concorrente ratio decidendi esposta in modo incidentale.
Consideriamo ora questa seconda motivazione:
“L’attore non ha provato di aver esercitato il passaggio (oltretutto non caratterizzato dalla presenza di opere
visibili e permanenti destinate al suo esercizio) per venti anni, poiché i testi escussi si sono riferiti solo ad un
periodo temporale molto più ristretto (7-8 anni).
Anche in questo caso vi è una pluralità di ragioni della decisione, univocamente prospettate,
anche se esposte in modo più insidioso, ossia con la tecnica della notazione incidentale.
Inoltre: Cassazione civile sez. lav., 13 luglio 1995, n. 7675; sez. III, 16 marzo 1995, n. 3073; Cassazione civile
sez. I, 9 settembre 1997, n. 8798 sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cassazione civile sez. I, 9 settembre 1997, n. 8798;
sez. I, 23 luglio 1999, n. 7948; sez. III, 18 luglio 2000, n. 944; sez. I, 12 aprile 2001, n. 549; sez. lav., 8 giugno
2001, n. 7809; sez. III, 23 ottobre 2001, n. 12976; sez. lav., 24 maggio 1999, n. 5048.
22
55
Anche in questa ipotesi, comunque, tutte le ragioni concorrenti debbono essere criticate, pena
in difetto l’inammissibilità dell’impugnazione.
Tutte queste ragioni concorrenti debbono essere criticate, pena in difetto l’inammissibilità
dell’impugnazione.
15.3. Concorrente
incidentale.
affermazione esposta
con perplessa equivocità,
in modo
Esaminiamo ora un terzo esempio:
“L’attore non ha provato di aver esercitato il passaggio per venti anni, poiché i testi escussi si sono riferiti solo
ad un periodo temporale molto più ristretto (7-8 anni) tanto più che non è affatto chiara la sussistenza di un
vero e proprio tracciato tale da soddisfare il requisito della presenza di opere visibili e permanenti destinate
all’esercizio della servitù.”
In questo caso non è chiaro se vi sia una pluralità di ragioni della decisione, perché circa la
presenza del secondo requisito il giudice si esprime in maniera perplessa e in termini
dubitativi.
Il giudice dell’impugnazione, chiamato a giudicare su di un appello diretto solamente contro
la prima affermazione (relativa al difetto di prova del passaggio per venti anni) non può
esonerarsi dallo stabilire se quella relativa all’incertezza del requisito delle opere visibili e
permanenti sia solo una notazione incidentale, formulata in modo pleonastico per rafforzare
psicologicamente la decisione adottata, o una vera e propria seconda motivazione
(conclusione questa che potrebbe essere corroborata dalla riflessione che l’onere della prova
circa la presenza delle opere visibili e permanenti gravava sulla parte attrice, sicché il dubbio
in proposito si ritorcerebbe contro di essa).
L’interrogativo che il giudice dell’appello deve porsi per orientarsi in modo efficace è il
seguente: si reggerebbe la sentenza solo sulla base della seconda parte dell’esposta
motivazione?
Se la risposta è affermativa anche la seconda ratio avrebbe dovuto essere criticata, pena in
difetto l’inammissibilità dell’impugnazione; non così, qualora si ravvisi nella seconda parte
una mera considerazione priva di rilievo motivazionale.
E’ chiaro (in prospettiva forense) che l’onere di diligenza e precauzione consiglia l’appellante
avveduto di criticare, comunque, tutte le affermazioni, pur dubitative, contenute nella
sentenza.
15.4. Concorrente affermazione esposta
chiaramente pleonastico.
con perplessa equivocità,
in modo
Ed ora un quarto esempio:
“L’attore non ha provato di aver esercitato il passaggio per venti anni, poiché i testi escussi si sono riferiti solo
ad un periodo temporale molto più ristretto (7-8 anni); ciò esime dall’approfondire la questione, assai dubbia,
della sussistenza di un vero e proprio tracciato tale da soddisfare il requisito della presenza di opere visibili e
permanenti destinate all’esercizio della servitù.”
In questo caso l’affermazione incidentale risulta volutamente priva di efficacia motivazionale,
dal momento che la considerazione autonoma della seconda parte del ragionamento, dopo
l’eliminazione virtuale della prima parte, lascia la decisione priva di alcun fondamento che non
sia la mera enunciazione di un dubbio irrisolto.
In questo caso l’appellante può far a mano di criticare la sentenza in punto requisito delle
opere visibili e permanenti, se non per ottemperare ad uno scrupolo cautelativo.
16. Motivazione esorbitante.
Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato casi in cui le varie affermazioni motivazionali
concorrenti appartenevano tutte allo stesso livello di merito della cognizione.
56
Occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui la doppia (o multipla) motivazione
adottata da parte del giudice di primo grado si collochi invece su di un piano logicogiuridico differente.
Ciò si verifica, ad esempio, allorché il giudice accolga una eccezione di carattere pregiudiziale,
dichiarando l’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità di una domanda, così
assolvendo il convenuto dalla osservanza del giudizio (cioè: statuendo in rito circa
l’insussistenza delle condizioni per una pronuncia sul merito della domanda) e poi, mosso
dall’esigenza psicologica di rafforzare una decisione, magari avvertita come non totalmente
soddisfacente per il suo mero carattere processuale, aggiunga una ulteriore considerazione
circa l’infondatezza nel merito della stessa domanda, precedentemente etichettata come
inammissibile, improcedibile o improponibile.
V’è da dire che una pronuncia giudiziale caratterizzata da una doppia motivazione non
collocata sullo stesso piano logico-giuridico (quale quella che sancisca dapprima
l’inammissibilità di una domanda o di una eccezione, così escludendo la sussistenza delle
condizioni per una pronuncia di merito, e poi affronti comunque la questione della
fondatezza o meno della pretesa) si rivela intrinsecamente contraddittoria.
Le alternative che si prospettano alle parti e al giudice dell’impugnazione sono quelle di:
1. ritenere la nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione;
2. ritenere che l’unica motivazione esistente sia la prima e che la seconda costituisca nulla
più che un mero obiter dictum, ossia una affermazione incidentale neppure caratterizzata
come atto di esercizio della giurisdizione, di cui il Giudice si sarebbe spogliato con la
prima affermazione, functus munere suo;
3. ritenere che entrambe le motivazioni concorrano a radicare il fondamento della
decisione, con la conseguente necessità di impugnazione di entrambe le rationes decidendi
addotte dal Primo Giudice.
Tale ultima soluzione è stata in pochi casi accolta dalla Suprema Corte:
• “La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di
decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel
caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della
motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa
“ratio decidendi”, nè contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero
obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una
pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la
soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di
inammissibilità del ricorso.”(Cassazione civile, sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490);
• “Le affermazioni “ulteriori” contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in
argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta
nel dispositivo vanno considerate di regola superflue, qualora la argomentazione principale sia
sufficiente a reggere la pronuncia adottata. Tuttavia l’affermazione d’infondatezza della
domanda, contenuta nella sentenza che ne abbia pregiudizialmente dichiarato l’inammissibilità,
ove formulata nei limiti delle domande ed eccezioni hic et inde proposte, può non integrare una
motivazione ad abundantiam improduttiva di effetti giuridici, e, qualora sia inserita dal giudice
perché idonea a sorreggere la decisione nell’ipotesi di erroneità di quella contenuta nel dispositivo,
può costituire un’ulteriore autonoma statuizione. Ne consegue che per la parte soccombente sorge
l’interesse e l’onere all’impugnazione al fine di evitare la formazione del giudicato sull’anzidetta
statuizione, al pari di quanto avviene nel caso di pronunzia di accoglimento fondata su distinte
rationes decidendi. (Nella specie il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda sul
rilievo della carenza di legittimazione attiva per esser stato il mandato “ad litem” al difensore
rilasciato dall’amministratore della società attrice in liquidazione anziché dal suo liquidatore,
ma aveva anche accertato, in motivazione, la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata
dalla convenuta; la sentenza di secondo grado, confermata dalla S.C., aveva a sua volta
57
dichiarato inammissibile l’appello perché rivolto solo contro la prima delle due
argomentazioni)”(Cassazione civile, sez. III, 26 maggio 2004, n. 10134).
L’orientamento prevalente in sede di legittimità è tuttavia chiaramente orientato in senso
contrario:
• “Un’affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della sentenza di appello, che
non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti
giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto d’interesse. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui la parte si doleva di una errata
affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado - laddove si sosteneva che, in caso di
riscatto di fondo rustico, è valida l’offerta reale formulata per l’intero prezzo in favore di uno solo
dei retrattati - in quanto tale affermazione non aveva avuto alcuna incidenza causale sul
“decisum”, fondato invece sulla tardività dell’offerta).”(Cassazione civile, sez. III, 4
novembre 2005, n. 21388);
• “È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della
sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della
medesima.”(Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2005, n. 24591)
Tale prevalente insegnamento è stato riaffermato con forza da una importante decisione
delle Sezioni Unite (Cass.SS.UU.20.2.2007 n.3840) che hanno riesaminato funditus la
questione:
“Al riguardo, ritiene il Collegio che vada senz’altro riaffermato il consolidato indirizzo contraddetto
unicamente dalla isolata sentenza n. 10134 del 2004.
La quale non ragionevolmente pretende, nella premessa che ne sorregge le conclusioni, una identità di
valutazione - in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di consolidazione nel giudicato - di ogni
subordinata ratio decidendi additivamente comunque svolta in sentenza, non tenendo conto della profonda e
radicale diversità degli schemi decisori, assunti in comparazione, e del ruolo ben differente che l’argomentazione
adiecta, rispettivamente, in essi assume.
Occorre, infatti, distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere con più argomenti
(anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una eccezione che si è
valorizzata) - in relazione al quale il gravame avverso la sentenza deve “vincere” tutti quegli argomenti,
ciascuno dei quali si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi - dalla ipotesi in cui la motivazione
ad abundantiam attiene, viceversa, ad altri aspetti, cioè ad altre domande od eccezioni non solo diverse da
quella delibata in via principale ma il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura
della questione (di rito) decisa principaliter.
Con la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame), che in particolare qui viene in rilievo, il
giudice definisce e chiude, infatti, il giudizio.
Con la conseguenza che, in questo caso, le considerazioni di merito, che comunque egli abbia poi a svolgere,
restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perchè esse non trovano sbocco, nel
dispositivo (che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), e non solo perchè formulate in
via ipotetica e in modo per lo più sommario e approssimativo (per cui, nel dubbio se con tali argomentazioni il
giudice esprima una mera opinione ovvero una decisione che esamini tutti gli aspetti della controversia, il
considerarle come espressione della funzione giurisdizionale potrebbe comportare un vulnus al principio
fondamentale dell’art. 24 Cost.), quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette
valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si è già
spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa.
Per cui quelle ultronee considerazioni relative al merito della domanda (o del gravame) non sono riconducibili
alla decisione (di inammissibilità) che al riguardo egli ha adottato, ma a quella, semmai, che egli avrebbe
adottato ove appunto il correlativo esame non ne fosse risultato precluso.
E si muovono, pertanto, su un piano esclusivamente virtuale e non entrano nel circuito delle statuizioni
propriamente giurisdizionali.
Dal che, conclusivamente, la riaffermazione del principio per cui, relativamente alle argomentazioni sul merito,
ipotetiche e virtuali, che il giudice impropriamente - abbia inserito in sentenza, subordinatamente ad una
58
statuizione di inammissibilità (o declinatoria di sua giurisdizione o competenza), la parte soccombente non ha
l’onere, nè ovviamente l’interesse, ad impugnare.
Con l’ulteriore duplice e speculare, corollario che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola
statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile (per difetto appunto di interesse) l’impugnazione nella
parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta, per quanto detto, ad
abundantiam nella sentenza gravata.”23
Da tale impostazione consegue l’inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnazione
rivolta anche contro le affermazioni irrilevanti sul piano del merito rimasto assorbito e per
converso la piena ammissibilità dell’impugnazione rivolta solo contro la statuizione
pregiudiziale24.
Un criterio piuttosto efficace che si può raccomandare per distinguere, non sempre
agevolmente, nell’ambito delle motivazioni “ridondanti”, la formulazione di una concorrente
ratio decidendi dalla esposizione di un mero obiter dictum estraneo alla logica decisoria (o, per
dirla con le parole delle Sezioni Unite, collocato su un piano esclusivamente virtuale estraneo
al circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali) è quello fondato sulla coerenza fra la
motivazione rafforzativa ridondante e il dispositivo:
• la seconda motivazione che sia idonea concettualmente a reggere la formula del
dispositivo, di regola, costituisce ratio decidendi concorrente, che esige specifica
censura con l’atto di appello;
• la seconda motivazione inidonea concettualmente a reggere la formula del
dispositivo (come si verifica in tutti i casi in cui il giudice motivi dapprima
l’assoluzione dall’osservanza del giudizio e quindi il rigetto nel merito) rivela
invece con sicurezza un mero obiter privo di rilevanza giurisdizionale, non
necessitante di autonoma censura.
Allorché la decisione impugnata sia rappresentata dal rigetto di una domanda che
presuppone l’accertamento di una fattispecie complessa (implicante una serie di fatti
costitutivi concorrenti), in caso di doppia (o multipla) motivazione basata sul diniego della
sussistenza di due (o più) fatti costitutivi é chiara la configurabilità di una doppia (o multipla)
ratio decidendi necessitante la proposizione di autonome censure.
Si pensi:
• al rigetto di una domanda risarcitoria per carenza di antigiuridicità della condotta
e per difetto di prova della colpa dell’agente;
• ovvero al rigetto di una domanda di riscatto di un fondo da parte del titolare della
prelazione agraria per mancanza di prova di cessione di fondi rustici nel biennio
precedente e per eccedenza della capacità lavorativa disponibile;
• ovvero al rigetto di una domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale
fondata sull’accoglimento dell’eccezione di inadempimento e sulla mancanza di
prova di un danno risarcibile.
Più delicata appare la valutazione di una doppia motivazione di un provvedimento di
accoglimento, strutturata in forma di obiter concessivo (che formula in via ipotetica un
diverso ordine di considerazioni che presuppone l’abbandono della precedente ricostruzione
fattuale o giuridica).
Se, nell’ipotesi di prospettazioni graduate o alternative, la motivazione ridondanterafforzativa é coerente con il dispositivo, sembra logico ritenere necessario per l’appellante
censurare entrambe le motivazioni.
L’insegnamento delle Sezioni Unite è stato successivamente condiviso anche da ulteriori pronunce: cfr
Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2007, n. 13068; Cassazione civile, sez. un., 2 aprile 2007, n. 8087.
23
24 Cfr DI IASI, “I vizi di motivazione delle sentenze di merito nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità”, dagli atti del
Convegno promosso dalla Formazione decentrata del Distretto di Corte di appello di Torino sulla motivazione
della sentenza, maggio 2008.
59
Per esempio, nel caso in cui l’attore chieda il risarcimento dei danni patiti in un sinistro
stradale, prospettando la responsabilità concursuale paritaria della controparte basata su di
una colpa concreta o in subordine una responsabilità presunta concorrente ai sensi
dell’art.2054, 2° comma, c.c., e il giudice motivi sotto entrambi i profili (ad esempio, dicendo
che il convenuto era responsabile al 50% in considerazione della velocità eccessiva, ravvisata
in base ad una testimonianza, e comunque in via presuntiva nella stessa misura quand’anche
la testimonianza fosse da considerare inattendibile), entrambe le motivazioni sono coerenti
con il dispositivo di accoglimento della pretesa risarcitoria al 50% e creano all’appellante
l’onere della doppia censura.
Anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite della Cassazione non può
invece ricondursi a doppia motivazione giurisdizionale di pari dignità l’ipotesi in cui il giudice
argomenti in via rafforzativa in relazione ad una domanda subordinata di parte attrice che
non solo presupponga una diversa ricostruzione del fatto ma che si correli ad un diversa
statuizione nel dispositivo.
In tal caso si é in presenza di una esternazione priva di rilievo giurisdizionale, giacché il
giudice si limita in sostanza ad esprimere una opinione positiva su di una domanda assorbita
(e quindi non attualmente sottoposta all’esame, perché, con la tecnica del condizionamento,
l’attore gli ha chiesto di esaminarla solo nel caso avesse deciso di rigettare la domanda
principale), senza trarne alcuna conseguenza in sede di concrete disposizioni.
Non si può ravvisare invece un mero obiter dictum allorché il giudice, nel respingere una
domanda, ricorra ad una doppia motivazione, imperniata dapprima sull’accoglimento di una
eccezione pregiudiziale di merito (decadenza o prescrizione, per esempio) e poi
sull’esclusione dei presupposti di fondatezza della domanda.
Ad esempio:
• il giudice rigetta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità extra
contrattuale sia perché è decorso un quinquennio dal fatto illecito, sia perché
non ravvisa la prova del fatto colposo;
• il giudice rigetta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per
vizi della cosa venduta, sia perché il compratore é decaduto dalla garanzia non
avendo effettuato la denuncia nei termini, sia perché la loro sussistenza non é
provata.
In tali ipotesi, ancorché apparentemente ci si muova su piani logici differenti (l’uno
pregiudiziale, l’altro attinente al merito), la formula da adottarsi nel dispositivo risulta
conforme, traducendosi pur sempre in una statuizione di rigetto della domanda; inoltre sempre
di merito della controversia si tratta, ancorché sottoposto ad una disamina in via preliminare.
D’altro canto, da un punto di vista logico una dichiarazione di prescrizione sembrerebbe
presupporre l’esistenza del diritto che si viene ad estinguere, non troppo diversamente da
quanto accade nel giudizio penale, laddove (sia pur per profonde ragioni che attengono alla
tutela della sfera personale dall’aggressione alla immagine e alla reputazione) la legge (cfr
art.129 c.p.p.) tende a privilegiare l’accertamento dell’innocenza dell’imputato che emerga in
modo evidente dagli atti rispetto alle declaratorie di estinzione del reato.
E’ possibile rinvenire un referente normativo alla delibazione preventiva delle eccezioni
preliminari di merito nel 2° comma dell’art.276 c.p.c. in tema di decisione della causa (“Il collegio
decide gradatamente ... le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della
causa”) o nel 2° comma dell’art.279 c.p.c. in tema di forma dei provvedimenti collegiali,
laddove la legge considera gradatamente la decisione di questioni di giurisdizione e competenza
(n.1), la decisione di questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito (n.2) e infine la
decisione di merito (n.3).
Un riscontro normativo ulteriore può essere ravvisato nell’art.187, 2° comma, c.p.c. che
prevede la rimessione anticipata a decisione per la delibazione di una questione di merito
preliminare, idonea a definire il giudizio.
60
In effetti la risposta migliore, utile a fornire un efficace orientamento nell’ambito della
gerarchia delle motivazioni di merito, può essere individuata nel criterio della c.d. ragione più
liquida, secondo il quale la decisione di rigetto nel merito può essere adottata sulla base di una
sola ragione di carattere assorbente, idonea a regolare la lite, anche se l’ordine logico delle
questioni imporrebbe astrattamente un diverso percorso, più lungo o complicato.25
Il principio in questione ha goduto anche di un riconoscimento da parte dei giudici di
legittimità nella sentenza della sez.III del 16.5.2006 n.1135626.
17. Motivi processuali.
Nell’ambito dei motivi di impugnazione una categoria di grande importanza è rappresentata
dai motivi di carattere processuale, rivolti a stigmatizzare un c.d. error in procedendo commesso
dal primo giudice.
Occorre al riguardo tener presente:
• il principio di propagazione delle nullità agli atti processuali consequenziali che si
ricava a contrario dal disposto dell’art.159, 1° comma, c.p.c., secondo il quale “ La
nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono
indipendenti”;
• il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione sancito
dall’art.161 c.p.c., secondo il quale la nullità delle sentenze soggette ad
impugnazione ordinaria (appello o ricorso per cassazione) “può essere fatta valere solo
nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.
Il verificarsi di una nullità processuale non sanata nel giudizio di primo grado può ripercuotersi
in via derivata sulla sentenza di primo grado che ne dipenda e la conseguente nullità della
sentenza deve essere fatta valere nei tempi e nei modi previsti per l’impugnazione in appello.
E’ bene precisare quali sono i casi in cui il giudice di appello può procedere al rilievo d’ufficio
di un vizio processuale, indipendentemente dalla valida e tempestiva proposizione di un
motivo di impugnazione.
Al proposito la giurisprudenza di legittimità insegna che se il vizio integra, per espressa
previsione di legge o per quanto desumibile in via interpretativa, una nullità insanabile, perciò
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, l’impugnazione ha, per così dire, una
“efficacia preterintenzionale”, poiché non sottrae all’ufficio la possibilità di rilevare la nullità
verificatasi nel grado inferiore del giudizio e non presa in considerazione nella sentenza
oggetto di impugnazione.
I casi nei quali la nullità è stata ritenuta rilevabile d’ufficio da parte del giudice dell’appello,
anche al di fuori di specifica deduzione della parte nei limiti e secondo le regole proprie del
mezzo di gravame attengono a:
• vizi del procedimento rientranti nelle ipotesi tassativamente previste dall’art.
354 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 8232 del 1997);
25
Cfr MANNA, “La motivazione della sentenza civile in grado di appello:limiti e oggetto della decisione.”, opera sopra citata.
26 “La pronunzia di rigetto (nella specie, della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) non più soggetta ad
impugnazione non costituisce giudicato implicito - con efficacia vincolante nei futuri giudizi - laddove del rapporto che ne costituisce il
presupposto logico-giuridico non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice le questioni
concernenti l’esistenza, la validità e la qualificazione. Ne consegue che la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione del contratto
adottata sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della
soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre) ovvero emessa in termini
meramente apodittici, senza un accertamento effettivo, specifico e concreto del rapporto da parte del giudice, al punto da risultare
un’evidente difetto di connessione logica tra dispositivo e motivazione, non preclude la successiva proposizione di una domanda di
nullità del contratto (e, come nella specie, di conseguente restituzione della caparra), in quanto in tal caso si fanno valere effetti giuridici
diversi e incompatibili rispetto a quelli oggetto del primo accertamento, sicché, trattandosi di diritti eterodeterminati (per
l’individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non
può ritenersi che, all’intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per
pervenire alla pronunzia di rigetto, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile.”
61
•
•
•
•
•
•
omessa regolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio civile, in
mancanza della costituzione del convenuto nel primo grado di giudizio (Cass.
n. 519 del 1995);
vizio di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un
litisconsorte necessario (Cass., n. 153 del 1964; Cass., n. 5236 del 1979);
nullità derivanti dalla violazione del principio del contraddittorio, in
particolare sotto il profilo dell’invalida costituzione del rapporto processuale
(Cass. n. 1125 del 1987; Cass., n. 7555 del 1991; Cass. n. 2196 del 1992; Cass.
n. 5067 del 1998; Cass. n. 14866 del 2000);
difetto di giurisdizione (Cass. Sez. Un., n. 5903 del 2003- cfr però ora
Cass.Civ. SS.UU. 16 ottobre 2008 n.25246, supra , § 6);
ipotesi di invalidità della sentenza equiparate alla mancanza di sottoscrizione
del giudice (Cass. n. 3371 del 1993; Cass., n. 12292 del 2001);
mancanza delle condizioni dell’azione, quali la legittimazione ad agire o
l’interesse ad agire (Cass.n.3170 del 1988).
17.1. Motivi processuali comportanti la rimessione al primo giudice.
Nell’ambito dei motivi di appello di carattere processuale una categoria particolare è costituta
da quelli volti a denunciare un vizio comportante, eccezionalmente, la rimessione della causa al
primo giudice (artt.353 e 354 c.p.c.).
E’ principio del tutto acquisito che i casi di impugnazione in appello per vizio processuale
comportante rimessione della causa al primo giudice (ipotesi cioè di appello meramente
rescindente) compongono un elenco di carattere tassativo, non suscettibile di ulteriore
estensione.
La giurisprudenza di legittimità è quindi ferma nell’insegnare che “La rimessione della causa al
primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i
casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe”27, escludendosi al contempo che
ciò possa arrecare un
vulnus
ai principi costituzionali, dovendosi escludere la
costituzionalizzazione della garanzia di un doppio effettivo grado di giurisdizione nel merito.
Le ipotesi di rimessione in primo grado previste dalla legge sono:
1. riforma della decisione di primo grado con affermazione della giurisdizione
erroneamente negata dal primo giudice:
2. dichiarazione da parte del giudice di appello della nullità della notificazione della
citazione introduttiva del giudizio di primo grado (e di tutti gli atti consequenziali,
inclusa la sentenza di primo grado;
3. accertamento da parte del giudice di appello della violazione della regola del
litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado svoltosi in assenza di una
parte necessaria nei cui confronti doveva essere disposta l’integrazione del
contraddittorio a norma dell’art.102 c.p.c., onde evitare la pronuncia di una
sentenza inutiliter data;
4. accertamento da parte del giudice di appello della erronea estromissione di una
parte (cfr artt.108, 109, 111, 3° comma, c.p.c.; ora cfr anche art.141, 3° comma e
149, 6° comma del d.lgs.209 del 205).
5. dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di sottoscrizione
del giudice a norma dell’art.161, 2° comma, c.p.c.;
6. riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo ex art.308
c.p.c. in sede di reclamo contro l’ordinanza dichiarativa.
17.2. Motivi processuali non comportanti la rimessione al primo giudice.
27 Ex multis: Cass.civ. sez.I 29.5.2008 n.14343; SS.UU.,19.5.2008 n.12644; sez.III, 31.1.12008 n.2397; sez.III,
18.9.2007 n.19358; sez.II, 6.9.2007 n.18691 ; sez.I, 29.3.2007 n.7712; sez.I,. 27.2.2007 n.4448.
62
Come si è visto, la regola è invece il divieto di rimessione della causa in primo grado.
Merita una digressione la casistica in cui la Suprema Corte ha ritenuto invece di escludere la
regressione in primo grado, confermando l’obbligo del giudice di secondo grado di decidere
nel merito la controversia:
a. allorché il giudice d’appello riformi la sentenza di estinzione del processo dichiarata dal
tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma,
c.p.c., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art.
189 c.p.c., (Cass.14343/2008);
b. qualora si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo del processo cui
faccia seguito un irregolare atto di riassunzione (Cass.12644/2008);
c. qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso
la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il
“thema probandum” (Cass.9169/2008);
d. allorché, in tema di contenzioso tributario, si riscontri il vizio della decisione di primo
grado, consistente nell’essere stata omessa la previa audizione delle parti nel
procedimento di autorizzazione del sequestro conservativo in favore della
amministrazione finanziaria (Cass.7342/2008);
e. nei procedimenti instaurati con ricorso, in caso di errata indicazione nel decreto
presidenziale di convocazione delle parti della data dell’udienza di comparizione
(Cass.2551/2008);
f. nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di dichiarazione di nullità della
sentenza per omessa lettura del dispositivo (Cass.2397/2008);
g. in controversia disciplinata dal rito speciale locatizio, in caso di dichiarazione di nullità
della sentenza per omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione
(Cass.1199/2007);
h. nell’ipotesi di mancata ottemperanza alla chiamata in causa di un terzo jussu judicis ai sensi
dell’art. 107 c.p.c. (Cass.18709/2007);
i. qualora nel corso del giudizio di merito il diritto controverso venga trasferito “inter vivos”
(nella specie, per effetto di conferimento d’azienda in una società di persone) e il
processo continui tra le parti originarie a norma dell’art. 111 c.p.c., senza che il
cessionario del diritto sia intervenuto o sia stato chiamato in causa (Cass.15961/2007),
j. in caso di omessa pronuncia su domanda da parte del giudice di primo grado
(Cass.13705/2007);
k. in caso di decisione in composizione monocratica di una controversia riservata al
tribunale in composizione collegiale (Cass.5889 e 7712/2007);
l. allorché all’udienza di prima comparizione, il giudice di primo grado non abbia concesso i
termini di cui agli art. 180, 183 e 184 c.p.c. 28 (Cass.4448/2007);
m. in caso di accertamento da parte del giudice di appello di una nullità non sanata dell’atto
di citazione del giudizio di primo grado (Cass.SS.UU.1820/2007, resa con riferimento ad
una fattispecie in tema di insufficiente termine a comparire; Cass. 27411/2005;
Cass.18571/2004, resa con riferimento ad una fattispecie in tema di nullità ex art.163 n.2
per erronea individuazione come parte di un ufficio privo di soggettività di un Ente;
Cass.11292/2005, resa con riferimento ad una fattispecie di mancanza dell’indicazione
della data dell’udienza di comparizione; Cass.8604/2005 resa in una fattispecie in cui la
vocatio indicava una data già scaduta);
n. in caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo grado, della nullità dell’atto
introduttivo del giudizio per difetto della edictio actionis (Cass.91/2007);
o. in caso di nullità della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la
domanda di ammissione al passivo sulla scorta di un decreto che aveva pronunciato la
28 Secondo la formulazione successiva alle norme modificative del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 conv. nella l. 20
dicembre 1995 n. 534, e prima delle modifiche apportate dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, oltre che dalla l. 28
dicembre 2005 n. 263
63
p.
q.
r.
s.
chiusura del fallimento, a seguito di un successivo provvedimento che aveva a sua volta
dichiarato la nullità del decreto di chiusura (Cass.2353/2006);
in caso di dichiarazione di nullità degli atti successivi all’interruzione del processo,
conseguente alla irregolare riassunzione (Cass.14650/2006);
in caso di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per aver pronunciato su
domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c.,
(Cass.5907/2006; Cass.7057/2002; Cass.2918/2001);
nel procedimento davanti al giudice di pace, allorché la decisione della causa non sia stata
preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal
semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, con la conseguente nullità della
sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass.5225/2006);
in caso di dichiarazione di nullità del giudizio svoltosi innanzi al tribunale regionale delle
acque pubbliche e, in particolare, con riferimento alla pronuncia d’inammissibilità del
reclamo avverso l’ordinanza istruttoria che aveva consentito il deposito di un
accertamento tecnico preventivo nonché alla mancata discussione della causa davanti al
collegio e all’irrituale scambio delle comparse conclusionali (Cass.SS.UU. 1066/2006).
17.3. Il caso particolare della nullità della citazione di primo grado per vizio dell’editio
actionis.
In chiusura appare il caso di formulare una breve riflessione alla luce dei principi sopra
compendiati circa un caso particolare, piuttosto frequente, di motivo di appello di carattere
processuale che si interseca con la tematica della nullità dell’atto di citazione di primo grado
(per vizio di editio actionis).
Il 4° comma dell’art.164 c.p.c. commina la nullità della citazione allorché risulti omesso o
assolutamente incerto il requisito stabilito nel n.3 dell’art.163 (determinazione della cosa
oggetto della domanda) ovvero se manchi l’esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso
articolo (esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda); si verte in tema di
mancanza o insufficiente determinazione del petitum o della causa petendi, che rifluisce sulla
c.d. editio actionis, determinando la nullità della domanda giudiziale.
L’art.164, al 5° comma prevede una apposita sanatoria, sia pur senza effetto ex tunc 29,
disponendo che il giudice che rileva la nullità fissi all’attore un termine perentorio per
rinnovare la domanda (se il convenuto non si è costituito), ovvero per integrare la domanda
(se il convenuto si è costituito).
Quid juris allorché il convenuto si dolga con l’appello dell’omesso rilievo della nullità della
citazione introduttiva sotto il profilo della editio actionis da parte del giudice di primo grado e
conseguentemente del vizio che inficia, in via derivata, la sentenza impugnata?
Il caso è più frequente di quanto si pensi: a ciò contribuiscono sia la naturale tendenza dei
difensori alla proposizione di domande il più possibile indeterminate ed elastiche sotto il
profilo della causa petendi (al fine di adattarsi in corso d’opera alle variegate peculiarità del
modo di pensare dei giudicanti e ai mutevoli assetti della giurisprudenza), sia il potere –dovere
del giudice di configurazione giuridica della domanda a prescindere dal nomen juris e dalle
norme giuridiche additate dalla parte, che spesso induce il magistrato ad una ri-lettura
interpretativa della domanda proposta in giudizio.
Quali sono le conseguenze nel caso in cui il giudice di appello reputi fondata la lamentela del
convenuto e condivida con lui l’opinione circa l’indeterminatezza originaria della domanda
dell’attore, che avrebbe dovuto innescare l’esercizio della procedura di sanatoria di cui al 5°
comma dell’art.164 c.p.c., a cui il giudice di primo grado invece non ha dato impulso?
Occorre peraltro considerare che nella normalità dei casi il giudice avrà pur sempre
prospettato una propria lettura della domanda, anche solo implicitamente, nell’atto decisorio
con cui in ultima analisi ha statuito quella condanna contro la quale il convenuto reagisce con
l’appello (o, in alternativa, ha disposto quel rigetto della domanda contestato dall’attore).
29
“ Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o integrazione”.
64
In siffatte ipotesi l’integrazione e la precisazione della domanda originariamente carente è
avvenuta in corso di causa da parte dell’attore, con una memoria successiva, magari
istruttoria, o addirittura con gli scritti conclusionali, o comunque è stata effettuata dal giudice
con la sentenza impugnata, attribuendo un certo contenuto e un certo presupposto alla
pretesa accolta dell’attore.
Dai principi sopra ricordati è agevole ricavare:
• che in questi casi l’appellante non può limitarsi a eccepire la nullità della citazione
introduttiva e la nullità consequenziale e derivata della sentenza di primo grado,
che ha pronunciato sulla domanda nulla mai sanata, ma deve anche denunciare
l’ingiustizia della decisione (alla luce non esclusivamente rescindente dell’appello);
• che non si verte infatti in una delle ipotesi rigorosamente tassative che
consentono la rimessione della causa in primo grado;
• l’appellante potrà invece esimersi dalla censura specifica delle specifiche
motivazioni addotte dal primo giudice e limitarsi e riproporre le proprie
argomentazioni, confidando nell’accoglimento della querela nullitatis, perché tale
accoglimento restituirebbe al giudice dell’appello il potere di cognizione piena sui
temi controversi, a prescindere dalle motivazioni anche specifiche addotte dal
giudicante di primo grado nella sentenza nulla;
• ovviamente tale possibilità presuppone l’accoglimento del motivo basato sulla
nullità, sicché ragionevole cautela consiglia all’avveduto appellante di censurare
specificamente la sentenza denunciata come nulla anche nel suo contenuto
specifico di merito;
• il giudice di appello deve giudicare nel merito della pretesa se questa risulta ormai
determinata, il che può avvenire:
perché l’attore in corso di causa in primo grado ha determinato la propria
domanda,
perché l’integrazione è avvenuta da parte del giudice in sentenza, con
indebito esercizio del potere di interpretazione, a cui la parte attrice ha
prestato successiva adesione;
perché l’integrazione è intervenuta con la comparsa di risposta in appello,
con la quale l’attore appellato ha chiarito il fondamento della propria
pretesa;
• la regressione del giudizio in appello alla fase della sanatoria per integrazione
della domanda in tutte queste ipotesi non è affatto necessaria, perché ormai la
domanda di parte attrice si è precisata nel corso del giudizio e a nulla varrebbe
concedere all’attore appellato un termine per indicare quanto in corso di causa egli
ha già esplicitamente o implicitamente indicato;
• il giudice di appello deve quindi giudicare con pienezza di cognizione sulla
domanda così integrata, dopo aver dichiarato la nullità della citazione e della
sentenza di primo grado;
• resta fuori l’ipotesi, invero quasi paradossale, che nemmeno all’esito degli scritti
introduttivi di secondo grado sia possibile capire quale sia il contenuto
identificativo della domanda attorea accolta dal primo giudice con la statuizione
difesa dall’attore appellato, ovvero respinta dal primo giudice con la statuizione
che l’attore appellante chiede di modificare: solo in questa ipotesi il giudice di
appello ai sensi dell’art.163, 4° comma e 164, 5° comma, c.p.c. dovrà dar corso
alla procedura sanante ed ordinare alla parte interessata l’integrazione della sua
domanda giudiziale (ex art.354, ult.comma, c.p.c.), si ripete, senza effetti
retroattivi.
17.4. Il divieto di rilievo d’ufficio delle nullità non formali.
65
La giurisprudenza, prendendo le mosse dalla predeterminazione circoscritta e tassativa dei casi
di rimessione della causa al primo giudice, attuata dagli artt.353 e 354 c.p.c. (ipotesi in cui
l’appello ha natura meramente rescindente), e dalla normale previsione del giudizio di merito
da parte del giudice di appello, anche nell’ipotesi di rilievo di nullità di atti compiuti in primo
grado, normalmente rinnovabili ex art.356 c.p.c. (stante la previsione di cui all’ultimo comma
dell’art.354 c.p.c.), tende ad escludere per difetto di interesse l’ammissibilità di una
impugnazione meramente rescindente, che non si accompagni alla riproposizione delle
domande ed eccezioni disattese nella sentenza viziata da nullità e all’indicazione delle ragioni di
ingiustizia sostanziale della decisione.
• “Mentre nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente, in cui il riscontro del
motivo di invalidità esaurisce l’oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado, la parte
soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la
causa essere rimessa al primo giudice, affinchè il procedimento di primo grado sia rinnovato con
contraddittorio regolarmente costituito; nelle altre ipotesi, invece, in cui l’appello cumula in sè “iudicium
rescindens” e “iudicium rescissorium”, e cioé é diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo,
ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività
del primo giudice - e non rientranti nelle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c. (nella specie, omessa
comunicazione al procuratore della parte del rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione) - hanno carattere
strumentale e meramente subordinato, perchè esse non sono di per sè idonee ad assicurare alla parte
appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo
grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in
quest’ultima ipotesi, l’appello e’ inammissibile per difetto d’interesse.” (Cassazione civile sez. un., 14
dicembre 1998, n. 12541).30
In particolare in materia di appello per motivi di carattere processuale con cui si denunciano
nullità poste in essere nel giudizio di primo grado e lesione dei diritti di deduzione o di prova
patiti dall’appellante (ad esempio: mancata concessione dei richiesti termini per la
precisazione ovvero per la modificazione di domande ed eccezioni ovvero per la
formulazione di istanze istruttorie e produzioni documentali) la giurisprudenza, in
applicazione del principio sopra esposto, ritiene che la parte interessata non possa limitarsi a
denunciare la violazione ma debba anche prospettare l’attività che le è stata ingiustamente
interdetta e dimostrarne la rilevanza agli effetti della decisione.
Ad esempio, nella importante pronuncia Cass. 9.4.2008 n.9169 (infra più compiutamente
analizzata sotto altro profilo) si legge:
“Innanzitutto, deve rilevarsi che “l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso
che l’appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro
esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della
sentenza impugnata” (Cass., S.U., n. 28498 del 2005). E tanto più la necessità di una specifica
articolazione del motivo di gravame nel caso di specie si imponeva, in quanto la sentenza di primo grado,
dichiarata nulla dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata, conteneva statuizioni sul merito delle
domande proposte dalla SITAF, nel senso del rigetto delle stesse. Era quindi onere della parte appellante
individuare specificamente i vizi processuali e quelli di giudizio nei quali era incorso il Tribunale, attraverso la
formulazione di specifiche censure.
Inoltre, proprio dalla rilevata natura del vizio derivante dalla violazione delle norme sulla sequenza delle
udienze di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., discende che non si versa in ipotesi di nullità che, ove accertata
30 Conformi appaiono, ex multis, Cass.civ. sez. 4.2.2008 n,.2551; sez.I 2.7.2007 n.14977; sez.II 12.7.2007 n.13705;
sez.lav.18.3.2005 n.5896.
Inoltre: “Per proporre qualsiasi impugnazione occorre avervi un interesse, consistente nella necessità di ottenere una decisione
attinente il riconoscimento di un bene della vita proprio, od il disconoscimento di un bene della vita altrui. E’ invece inammissibile
per difetto di interesse l’impugnazione la quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche
di correttezza formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
d’appello la quale, pur erroneamente omettendo di rilevare la nullità della costituzione del convenuto, aveva ugualmente accolto la
domanda attorea).” (Cassazione civile sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12241).
66
in appello, comporti la rimessione della causa al giudice di primo grado. Pertanto, dovendo il giudice d’appello
pronunciarsi sul merito della controversia, l’appellante, allorquando deduca un vizio in procedendo, non può
limitarsi alla mera indicazione del vizio stesso, riservandosi di specificare in prosieguo le attività che sarebbero
state compromesse o pregiudicate dalla violazione della regola processuale, ma deve indicare specificamente dette
attività. In particolare, allorquando venga dedotto, come nella specie, il vizio della sentenza di primo grado,
per avere il Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema
decidendum e il thema probandum, l’appellante non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare
quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove
fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, e quali prove sarebbero state
dedotte. In altri termini, una volta escluso che l’accertamento e la dichiarazione della nullità comporti la
rimessione della causa al primo giudice, e una volta ritenuto che il giudice d’appello, quando accerta quel tipo
di nullità, “è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l’esercizio delle attività deduttive e istruttorie
non potute esercitare in primo grado” (Cass., n. 22900 del 2004; Cass., n. 20592 del 2004; Cass., n.
4448 del 2007), la richiesta di rimessione in termini per il compimento di una determinata attività istruttoria
costituisce proprio lo specifico oggetto devoluto alla cognizione del giudice del gravame, e il relativo onere grava
sull’appellante che deduca quel tipo di vizio in procedendo”.
Analogamente recita la massima di Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2008, n. 8493, secondo
cui “Poiché il giudice d’appello deve pronunciarsi sul merito della controversia, l’appellante, allorquando
deduca un vizio in procedendo, non può limitarsi alla mera indicazione del vizio stesso, riservandosi di
specificare in prosieguo le attività che sarebbero state compromesse o pregiudicate dalla violazione della regola
processuale, ma deve indicare specificatamente dette attività; in particolare, allorquando venga dedotto il vizio
della sentenza di primo grado, per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti
avessero definito il “thema decidendum” ed il “thema probandum”, l’appellante non può limitarsi a dedurre
tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il “thema decidendum” sul quale il giudice di primo
grado si sarebbe dovuto pronunciare.”
Recentemente la Suprema Corte è intervenuta con alcune pronunce (rese in correzione del
difforme orientamento espresso dalla Corte di appello di Torino) per escludere che il giudice
di appello possa intervenire in via ufficiosa a rilevare la nullità ingenerata da vizio non
formale di attività, consumatasi nel giudizio di primo grado in cui non sia stata rispettata la
scansione sequenziale delle attività previste dal codice di rito (nella fattispecie non erano stati
concessi i termini di cui all’art.183, 5° comma, c.p.c., testo ante Novella della competitività,
pur richiesti da alcune delle parti).
• “Di regola, la mancanza di una pronuncia costitutiva di nullità da parte del giudice procedente consente
all’atto processuale viziato (in via assoluta o relativa) di produrre, comunque, i suoi effetti. Con la
conseguenza, pertanto, che al fine di addivenire alla detta pronuncia il giudicante deve rilevare la nullità,
se assoluta (al più tardi) prima di pronunciarsi nel merito della “res dubia”, e se relativa, per effetto della
tempestiva denuncia fattane dalla parte (che non vi abbia dato causa) nei termini di cui all’art. 157 c.p.c.
(e, comunque, prima della sentenza). La mancanza di tale attività di rilevazione da parte del giudice di
primo grado comporta la formazione, in seno alla resa pronuncia di merito, di una sottostante e implicita
statuizione di regolarità formale del processo, rimediabile solo attraverso il tempestivo esperimento dei
mezzi di impugnazione (non totalmente devolutivi) dell’appello e del ricorso per cassazione, il cui utile
esercizio postula una specifica, espressa, deduzione dell’errore che si assume viziare la sentenza
impugnata, pena la formazione di un giudicato (interno) ostativo, per il giudice di gravame, a ogni
ulteriore verifica “ex officio” della regolarità del primo giudizio.”(Cassazione civile, sez. I, 9 aprile
2008, n. 9169);
• “Il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in
cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado - per non avere il giudice concesso
alle parti, benché richiesto, l’appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5, c.p.c., ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla
definitiva determinazione del “thema decidendum” e del conseguente “thema probandum” - può essere
rilevato d’ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla res controversa e dal
medesimo rimediato attraverso l’adozione di misure sananti, espressione della capacità di
67
autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l’esercizio delle attività non
potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio in procedendo, inficiante in via
derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di
impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo
grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente
(da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello), non
rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di
fuori della prospettazione della parte.”(Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3607).
Così il Supremo Collegio ha motivato il suo orientamento, fra l’altro superando come
manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal Procuratore
generale:
“Ritiene il Collegio che le critiche mosse alla sentenza non colgano nel segno, dovendosi in proposito osservare
quanto segue. Non vi è dubbio che la violazione delle regole volte alla definizione del thema decidendum e del
thema probandum integri una nullità. La regola generale del nostro ordinamento, tuttavia, è quella stabilita
dall’art. 161 c.p.c., comma 1, secondo cui “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per
Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di
impugnazione”. A tale regola generale fa eccezione il caso di cui al comma 2, concernente la mancata
sottoscrizione della sentenza da parte del giudice. Tale essendo la regola, alla individuazione dei casi in cui il
giudice dell’impugnazione può rilevare d’ufficio la nullità della sentenza impugnata per ragioni diverse da
quelle fatte valere nei motivi di gravame, deve procedersi adottando un criterio rispettoso della chiara
indicazione di carattere generale desumibile dal codice di rito.
Con riferimento in particolare ai vizi afferenti all’asserita mancata osservanza del principio del contraddittorio
- categoria, questa, alla quale possono essere ricondotti i vizi della sentenza del Tribunale rilevati d’ufficio
dalla Corte d’appello - è quindi necessario distinguere tra il caso in cui il vizio si sostanzia in un impedimento
della parte a partecipare al giudizio e a far valere eventuali nullità nello svolgimento del procedimento, da
quello nel quale il vizio non si risolva nella inibizione della partecipazione della parte al processo, per essersi
detto vizio verificato nel corso del procedimento in presenza della parte costituita. Solo nel primo caso, infatti, è
ravvisabile violazione del principio del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101 c.p.c. (“Il
giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la
quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”). E solo nel primo caso è coerente ritenere
che il giudice del gravame possa rilevare d’ufficio una nullità che si risolva nella mancata instaurazione del
contraddittorio. Del resto, dalle pronunce richiamate nella sentenza n. 3607 emerge con sufficiente univocità
che i vizi di attività per i quali questa Corte ha ammesso la rilevabilità d’ufficio si riferiscono proprio ai casi
nei quali il contraddittorio non si è validamente instaurato (art. 354 c.p.c., comma 1; omessa regolare
notificazione del ricorso introduttivo del giudizio civile; mancata integrazione del contraddittorio nei confronti
di un litisconsorte necessario; invalida costituzione del rapporto processuale).
Diverso è il caso in cui il giudizio sia stato ritualmente introdotto, nei confronti di tutti i litisconsorti, e questi
abbiano partecipato al giudizio, in esso costituendosi e potendo così svolgere le proprie difese. La eventuale
violazione delle norme procedimentali posta in essere dal giudice in questo caso non sfugge alla regola della
deduzione della nullità con il mezzo di gravame esperibile.
E una simile conclusione risulta chiaramente affermata proprio da Cass., n. 6808 del 2000, citata da Cass.,
n. 3607 del 2007 a fondamento della soluzione prescelta circa la non rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice
d’appello, del vizio nella specie dedotto. In quella sentenza, la Corte, dopo aver precisato che le nullità afferenti
alla mancata osservanza delle norme sulla sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c.
soggiacciono alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ha affermato che “Analogamente, per
quanto rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato o grado del processo, la nullità per mancato rispetto del
contraddittorio, non sfugge alla preclusione del giudicato e quindi si adegua al principio generale dell’art. 161
c.p.c., comma 1, obbligando l’interessato ad eccepirla o a dedurla soltanto nei limiti e secondo le regole proprie
dei mezzi d’impugnazione, tipicamente esperibili nei confronti della pronunzia decisoria”.
…..omissis…..
Le considerazioni sin qui svolte consentono anche di ritenere manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 101, 342 e 354 c.p.c., che il Procuratore Generale, in sede di discussione
68
orale, ha chiesto alla Corte di sollevare, ravvisando una violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111 Cost.,
comma 1, nella parte in cui dette disposizioni, in combinato disposto tra loro e nella interpretazione recepita
da Cass. n. 3607 del 2007, qualificata diritto vivente, stabiliscono che l’accertamento della mancata
osservanza della sequenza procedimentale destinata alla definizione del thema decidendum e del conseguente
thema probandum non rientri tra i poteri di ufficio del giudice d’appello, esercitabile anche al di fuori delle
deduzioni delle parti. Infatti, premesso che rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli
istituti processuali, è appena il caso di rilevare che, in un processo caratterizzato dal principio dispositivo, è
sufficiente, per escludere la lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo costituzionalmente
garantito, che alla parte sia offerta la possibilità di far valere in giudizio la violazione delle norme processuali
dalle quali si assume discendano quelle lesioni. In sostanza, non rientra nello statuto del diritto di difesa e del
giusto processo costituzionalmente garantito l’obbligo, per il legislatore, di prevedere la rilevabilità d’ufficio di
tutte le nullità che le parti, nelle loro autonome scelte processuali, pur avendone la possibilità, non abbiano
dedotto come vizi della sentenza, nei limiti di cui all’art. 161 c.p.c., comma 1.
Il denunciato vizio di illegittimità costituzionale non discende quindi dalla configurazione degli istituti
processuali, ma dalla omessa attivazione dei rimedi previsti dall’ordinamento per detti vizi; si è dunque in
presenza non già di un problema di legittimità costituzionale delle norme suindicate, ma di concreta
applicazione delle stesse da parte dei soggetti del processo.”
18. Motivi di carattere istruttorio.
Una categoria di motivi di notevole importanza è quella riconducibile alla nozione di “motivi
di carattere istruttorio”, con la quale ci si intende riferire a tutte quelle ipotesi in cui la base
comune delle recriminazioni dell’appellante attiene al complesso delle informazioni acquisite
su cui il giudice di primo grado ha effettuato la sua valutazione.
L’appellante può criticare tale complesso informativo sia perché eccessivo, sia perché
carente.
18.1. Motivi istruttori attinenti all’acquisizione del materiale probatorio.
La prima ipotesi che occorre considerare è quella sottocategoria di motivi di carattere
istruttorio con cui l’appellante lamenta un eccesso di acquisizioni probatorie e in particolare
prospetta le proprie doglianze circa le modalità di acquisizione del materiale probatorio.
E’ evidente che questa sottocategoria, se per contenuto va ricondotta alla categoria dei motivi
istruttori, sotto il profilo formale va classificata nell’ambito dei motivi di carattere processuale.
Infatti l’appellante si lamenta del fatto che il giudice abbia ammesso e utilizzato una prova in
violazione di uno specifico divieto o con modalità viziata dall’inosservanza di disposizioni
processuali in suo pregiudizio.
Alla prima ipotesi (ammissione e utilizzazione di una prova in violazione di uno specifico
divieto) vanno ricondotti, ad esempio, tutti quei casi in cui l’appellante si duole che il giudice
abbia fondato la prova di un negozio esigente la forma scritta ad substantiam su dichiarazioni
rese da testimoni ovvero su elementi presuntivi convergenti, o abbia utilizzato una prova per
testimoni per dimostrare l’esistenza di patti aggiunti e contrari in contrasto con il contenuto
di un documento negoziale scritto.
Alla seconda ipotesi (utilizzo di prova formatasi con modalità viziata dall’inosservanza di
disposizioni processuali in pregiudizio dell’appellante) possono essere ricondotti tutti quei
casi in cui l’appellante si lamenti dell’influenza esercitata nella formazione del convincimento
del giudice:
• da una prova testimoniale ammessa nonostante la sua tardiva deduzione (per esempio
di una prova testimoniale diretta dedotta per la prima volta solo con la memoria di
replica istruttoria);
• da una testimonianza resa da una persona incapace a deporre ex art.246 c.p.c. o da un
soggetto tardivamente indicato,
• da un documento prodotto tardivamente oltre la soglia preclusiva fissata dal codice di
rito;
69
•
da una consulenza tecnica inficiata da nullità per aver il c.t.u. proceduto nel corso delle
operazioni peritali in violazione della regola del contraddittorio.
In tutti questi casi (motivo di appello istruttorio processuale per illegittima acquisizione di una
prova) per la corretta formulazione del motivo (id est in modo specifico e pertinente)
l’appellante deve dimostrare:
• sia l’error in procedendo commesso dal giudice di primo grado (respingendo l’eccezione di
incapacità a deporre del teste portatore di interesse in causa, escutendo il teste indicato
tardivamente, ritenendo ammissibile il documento prodotto dopo lo spirare delle
preclusioni istruttorie, non rinnovando le operazioni peritali inficiate dalla violazione
del contraddittorio);
• sia la concreta rilevanza di tale error in procedendo ai fini della decisione (il che
presuppone un apporto probatorio determinante dell’elemento di prova irritualmente
acquisito nella formazione del convincimento del giudice)31;
• sia, infine, il difetto di acquiescenza da parte sua al vizio di acquisizione della prova,
giacché si verte, normalmente in tema di nullità relative, suscettibili di sanatoria per la
mancata tempestiva reazione della parte interessata (art.157, 2° comma c.p.c.) o per
rinuncia tacita (art.157, 3°comma, c.p.c.), o per raggiungimento dello scopo dell’atto
(art.156, 3° comma, c.p.c.).
La giurisprudenza, ad esempio, è particolarmente severa e rigorosa nell’esigere la reiterazione
del dissenso all’acquisizione della testimonianza resa dal teste incapace a deporre),
richiedendo sia la formulazione preventiva dell’eccezione32, sia la sua rinnovazione all’esito
dell’assunzione comunque effettuata, sia - talora - anche l’insistenza nelle conclusioni
definitive di primo grado.
Il principio più volte ribadito dalla Cassazione è che :
• “La nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo
l’espletamento della prova, anche quando l’incapacità sia stata eccepita prima dell’assunzione, atteso che le
disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono
dettate nell’esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche
tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell’eccezione come nel
caso in cui la stessa non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.”(Cassazione civile,
sez. II, 30 luglio 2004, n. 14587).33
Inoltre, con specifico riferimento alla necessità di insistenza sull’eccezione in sede di
precisazione delle conclusioni definitive di primo grado:
• “ L’eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione
non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e
ribadita in sede precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., risultando pertanto tardivo il rilievo
effettuato solo con la comparsa conclusionale. Ne consegue che, qualora la parte in sede di ricorso per
cassazione deduca l’omessa pronuncia del giudice d’appello su detta eccezione, adducendo di averla
formulata nella conclusionale di primo grado e poi proposta come motivo d’appello, la Corte di cassazione
può rilevare d’ufficio che l’eventuale nullità derivante dall’incapacità del teste è rimasta sanata per
Per esempio: “In tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell’espletamento (nella specie la partecipazione a un
sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d’ufficio, di un suo collaboratore) ne determinano la nullità solo ove
procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale
diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.”(Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 2007, n. 13428).
31
Almeno, s’intende, nei casi in cui la parte interessata disponga già gli elementi informativi per proporre
l’eccezione prima dell’inizio dell’escussione del teste e non li apprenda invece, come talora accade, in corso di
deposizione.
33 Conformi: Cassazione civile, sez. II, 17 febbraio 2004, n. 2995; sez. lav., 15 novembre 1999, n. 12634; sez. III,
21 aprile 1999, n. 3962
32
70
l’irritualità della relativa eccezione di modo che resta irrilevante l’omissione di pronuncia.”(Cassazione
civile, sez. III, 29 marzo 2005, n. 6555)34.
Analogo è l’atteggiamento della giurisprudenza in tema di nullità delle operazioni peritali
condotte dal consulente tecnico d’ufficio (in relazione alle quali frequentemente vengono
denunciate violazioni del contraddittorio).
Ai sensi dell’art.157 c.p.c. tutte le nullità, salvo espressa comminatoria di legge, hanno
carattere relativo e possono quindi, in difetto di espressa previsione, essere pronunciate solo
su istanza della parte interessata che deve formularla nella prima istanza o difesa successiva
all’atto (o alla sua notizia), purché non via abbia rinunciato anche tacitamente.
La nullità verificatasi nell’ambito del sub-procedimento peritale resta sanata se non risulta
formalmente eccepita nella prima istanza o difesa successiva, nonché se la parte interessata vi
ha rinunciato nelle sue definitive conclusioni, con la conseguenza che la nullità non si
comunica a titolo derivativo ex artt.159 e 161 c.p.c. alla sentenza impugnata:
• “L’omesso avviso, alle parti, del giorno, ora e luogo d’inizio delle operazioni di consulenza tecnica
determina la nullità relativa della consulenza, la quale resta sanata se non eccepita nella prima istanza o
difesa successiva al deposito della relazione. (Nella specie, relativa a chiarimenti scritti comunicati dal
consulente, su richiesta della Corte d’appello, in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte,
la S.C. ha inoltre escluso la necessità della comunicazione, trattandosi d’attività svolta sulla base degli
accertamenti già compiuti nel contraddittorio delle parti).”(Cassazione civile, sez. III, 17 marzo
2005, n. 5762);
• “In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata
partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un
impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l’eventuale nullità della consulenza
derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente,
deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della
relazione.”(Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2589).35
18.2. Motivi istruttori finalizzati all’integrazione delle acquisizioni istruttorie.
Particolare importanza va riconosciuta ai motivi istruttori che denunciano un difetto di
completezza delle prove raccolte e mirano quindi all’integrazione delle acquisizioni istruttorie.
Nell’ambito di tale sottocategoria occorre distinguere fra:
• i motivi che lamentano la mancata ammissione da parte del giudice di una prova già
dedotta in primo grado (in quanto esclusa perché ritenuta irrilevante o inammissibile,
o semplicemente trascurata da parte del primo giudice)
• e quelli che presuppongono l’introduzione di una prova nuova per la prima volta nel
giudizio di secondo grado, che ovviamente si debbono confrontare con il generale
divieto frapposto dal 3° comma dell’art.345 c.p.c.
Dal punto di vista strutturale i motivi del secondo gruppo possono anche essere catalogati
nella categoria dei motivi c.d. “adesivi”, nel senso già illustrato, perché il dissenso
dell’appellante non è rivolto al ragionamento del primo giudice ma ai fondamenti in fatto e
diritto della sua valutazione; in queste ipotesi infatti l’appellante non dice che il primo giudice
ha sbagliato a ricostruire il fatto con il materiale probatorio che possedeva o ad applicare le
norme giuridiche vigenti sollecitate dalle parti alle acquisizioni probatorie; l’appellante ammette
(almeno in quella parte dell’impugnazione) la validità del ragionamento del giudice e mira
invece a scalzarne le basi di riferimento.
18.3. Mancata ammissione da parte del giudice di una prova già dedotta in primo
grado.
Conformi Cass.civ. sez.II, 30.7.2004 n.14587; sez.II, 7.2.2003 n.1840; sez.II, 15.6.1999 n.5925.
Nello stesso senso: Cass.civ.sez.II 25.10.2006 n.22843; sez.III 29.3.2006 n.7243; sez. II, 28 novembre 2001, n.
15133; sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10870; sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1457.
34
35
71
Con riferimento all’ipotesi di mancata ammissione da parte del giudice di una prova già
dedotta in primo grado l’appellante deve superare un triplice sbarramento per conferire
pertinenza e specificità al motivo istruttorio:
• deve dimostrare l’errore commesso dal giudice nel non ammettere la prova dedotta,
superando le obiezioni opposte in motivazione (ad esempio dimostrando che la prova
era stata dedotta tempestivamente, era rilevante ai fini della decisione, non contrastava
con alcun divieto, non era inammissibile) e ciò, in conformità ai ben noti principi
generali, con il ricorso ad una contro-argomentazione tanto più specifica quanto più
specifica sia la motivazione addotta dal giudice36;
• deve dimostrare la rilevanza potenziale della prova nell’economia della decisione di
primo grado (e cioè che la decisione non sarebbe stata la stessa se il giudice avesse
potuto disporre di un risultato probatorio conforme alle deduzioni dell’appellante);
• non deve aver rinunciato all’istanza istruttoria dopo il rigetto della richiesta di
ammissione.
A questo proposito occorre ricordare che la giurisprudenza spesso ha ravvisato una rinuncia
tacita alle istanze istruttorie non ammesse allorché la parte interessata non insista al riguardo
al momento della precisazione delle conclusioni definitive di primo grado.
Ad esempio:
• “È presumibile la rinunzia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso,
né esplicitamente, né implicitamente, e non riformulate all’udienza di precisazione delle conclusioni.
D’altro canto, se l’istanza attiene ad una prova rimessa alla discrezionalità del giudice - come
l’ispezione giudiziale - il mancato accoglimento della richiesta non è censurabile in sede di legittimità
per omessa motivazione, dovendosi dedurre per implicito che egli non ne ha ravvisato la
necessità.”(Cassazione civile, sez. II, 18 marzo 2000, n. 3241).
La giurisprudenza, pur ritenendo astrattamente ammissibile l’inferenza “mancata riproposizione
dell’istanza in sede di precisazione conclusioni = abbandono”, tende peraltro a puntualizzare che si
tratta pur sempre di una operazione presuntiva volta a ricostruire ed a interpretare la
manifestazione di volontà della parte interessata, con la conseguenza che occorre tener conto
di eventuali elementi sintomatici di segno contrario:
• “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché
queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica
normalmente una presunzione di abbandono o rinuncia alle stesse; tuttavia detta presunzione,
fondandosi sull’interpretazione della volontà della parte, deve essere esclusa qualora il giudice del
merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le
deduzioni delle parti, ravvisi elementi sufficienti, o dalla complessiva condotta processuale della parte,
o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate, per
ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nelle istanze già
avanzate. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo di
ricorso rilevando che il giudice di appello aveva correttamente interpretato la volontà della parte
appellante nel senso che essa aveva inteso certamente insistere su quanto devoluto con l’impugnazione).
“(Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2006, n. 4794);
• “La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in
precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sè sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia
o l’abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste
specificamente formulate all’udienza prevista dall’art. 189 c.p.c. Pertanto, il giudice di merito, al
36 Ad esempio: “I motivi di appello concorrono a determinare l’oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso
esercizio del potere d’impugnazione, non potendosi considerare proposti all’esame del giudice del gravame i capi della sentenza di
primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell’atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre
istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di
gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo”(Cassazione civile,
sez. III, 7 luglio 2006, n. 15519).
72
quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in
concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso
insistere nella richiesta o deduzione pretermessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato
la sentenza di appello che aveva respinto il gravame e affermato, all’opposto, che le istanze istruttorie
formulate nel corso del giudizio di primo grado, non essendo state successivamente richiamate in sede
di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi abbandonate e non potevano essere riproposte nella
successiva fase di appello).”(Cassazione civile, sez. I, 3 giugno 2004, n. 10569; conforme
sez. II, 19 maggio 2004, n. 9465).
Analoga presunzione di rinuncia è stata ravvisata nella richiesta di fissazione dell’udienza di
precisazione delle conclusioni:
• “In tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l’espletamento del
richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicché, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la
fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l’espletamento del mezzo di
prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ravvisato l’implicita rinuncia all’ammessa prova testimoniale nel fatto che la
parte istante aveva chiesto non già la fissazione dell’udienza per l’assunzione della prova, bensì la
fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni)”(Cassazione civile, sez. III, 6 settembre
2007, n. 18688).
E’ chiaro poi, se il giudice di primo grado ha esposto in sentenza le ragioni del rigetto
dell’istanza istruttoria disattesa, che è contro questa motivazione (che supera quella
eventualmente diversa addotta nell’ordinanza istruttoria precedente37) che si deve dirigere lo
sforzo critico dell’appellante, a meno che il giudice non abbia richiamato, anche solo in parte,
il contenuto dell’ordinanza, in modo da attribuirle quindi per relationem dignità di motivazione
definitiva del rigetto.
Se invece il giudice nella sentenza impugnata ha taciuto, nonostante che la parte interessata
avesse chiesto la revoca della decisione istruttoria negativa e avesse riproposto e coltivato la
richiesta istruttoria, l’appellante avveduto dovrà stigmatizzare il silenzio del giudice, per
omissione di motivazione dell’implicito rigetto della reiterata sua istanza istruttoria e
comunque criticare il contenuto della decisione istruttoria negativa precedente, tacitamente
confermata.
18.4. Motivi istruttori comportanti la deduzione di nuove prove in appello.
Il discorso è più semplice per quanto riguarda i motivi istruttori che si risolvono nella
deduzione di nuove prove in appello; così procedendo, l’appellante mira a modificare i
presupposti del ragionamento del giudice, la cui decisione viene prospettata come ingiusta ma
non contestata nella sua corrispondenza al materiale probatorio a disposizione, che appunto
egli cerca di modificare.
Tale atteggiamento si scontra peraltro con il generale divieto opposto dal 3° comma
dell’art.345 c.p.c. alla deduzione per la prima volta nel giudizio di secondo grado di mezzi di
prova non dedotti nel corso del giudizio di primo grado (norma che contribuisce
significativamente a connotare il giudizio di appello quale revisio prioris instantiae).
L’art.345, 3° comma, c.p.c., dispone infatti che non sono ammessi nuovi mezzi di prova,
salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che
la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa
non imputabile. Fa eccezione il giuramento decisorio, in ragione della sua particolare natura e
della sua straordinaria efficacia probatoria, per cui la legge ammette la deduzione senza alcun
limite.
“Le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto
provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito può giustificare nella sentenza le
proprie scelte su motivi ed argomenti diversi da quelli indicati nell’ordinanza istruttoria.”(Cassazione civile, sez. III, 31 maggio
2005, n. 11580).
37
73
Non è il caso di affrontare analiticamente le aspre discussioni che hanno contrapposto
dottrina e giurisprudenza (con spaccatura iniziale fra gli orientamenti di legittimità e di
merito) circa l’assimilabilità delle produzioni documentali (ossia dei mezzi di prova c.d.
“precostituiti”) agli altri mezzi di prova, al cui proposito la giurisprudenza della Corte di
Cassazione nei primi 5 anni del 21° secolo si era orientata38 a ritenere che l’art.345, 3° comma,
non riguardasse le produzioni di documenti nuovi, liberamente effettuabili con l’atto
introduttivo del giudizio di appello, nonostante l’aspro dissenso manifestato dalla
giurisprudenza di merito, che vedeva in siffatta interpretazione uno strumento eversivo di
quella rigorosa scansione delle fasi processuali che caratterizzava il rito riformato.
Infatti al proposito sono intervenute nel 2005 le Sezioni Unite della Suprema Corte con le
sentenze n.8202 (riguardante il rito del lavoro e quindi l’art.437 c.p.c.) e n.8203 (riguardante il
rito ordinario, e pertanto l’art.345 c.p.c.), sancendo l’abbandono dell’orientamento “ liberale”
dianzi prevalso nelle sezioni semplici e aderendo invece alle tesi “restrittive” più diffuse nella
giurisprudenza di merito.
Dopo il lungo ed acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno
accolto la tesi più rigorosa e hanno così affermato che la nozione di “mezzi di prova” utilizzata
dalla norma citata si riferisce anche alle prove c.d. “precostituite”, ossia ai documenti, così
sancendo che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, stabilito dall’art. 345
comma 3 c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 52 della legge n. 353 del 1990, riguarda anche le
prove c.d. “precostituite”, quali i documenti, la cui produzione, pertanto, è subordinata, al pari
delle prove c.d. “costituende”, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che
abbia impedito alla parte di produrli in primo grado ovvero alla valutazione della loro
indispensabilità.
• “Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345,
comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità
di mezzi di prova “nuovi” - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi,
anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via
alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter
trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica
indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione
non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal
processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per
causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la
decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell’impulso del processo meno incisivo
che nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque
prescindere dalla richiesta delle parti. Nel rito ordinario, in appello, la produzione del documenti deve
essere effettuata dalle parti, a pena di decadenza, mediante la specifica indicazione dei documenti stessi nei
rispettivi atti introduttivi del giudizio, salvo che la formazione dei documenti da esibire non sia successiva,
e sempre che la produzione degli stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal
processo.”(Cassazione civile, sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203).
La parte interessata alla formulazione del motivo istruttorio fondato sulla deduzione di
nuove prove o sulla produzione di nuovi documenti è quindi tenuta a dimostrare di non
aver potuto dedurle o produrli prima per causa ad essa non imputabile.
L’onere probatorio costringe quindi l’appellante alla rigorosa dimostrazione dell’impedimento
preesistente:
• ad esempio, in tema di produzioni documentali, la parte interessata è tenuta a
dimostrare la scoperta successiva del documento o il suo precedente
occultamento, ovvero la formazione successiva del documento, il tutto con
riferimento al momento delle preclusioni istruttorie in primo grado;
38 Cass.civ.13.10.2000, n. 13670; sez. III, 4 giugno 2001, n. 7511;16 aprile 2002 n.5463;13.9.2002 n.13.424;
8.1.2003 n.60; 5.5. 2003 n.6756).
74
•
costituisce infatti tradizionale (e financo ovvia) affermazione che i documenti
di formazione successiva alla insorgenza delle preclusioni istruttorie in primo
grado sono suscettibili di libera produzione in grado di appello, nel rispetto del
principio “ad impossibilia nemo tenetur”;
• in tema di prove costituende, la parte interessata è tenuta a dimostrare la
precedente (incolpevole) ignoranza della circostanza offerta a prova;
• ulteriore circostanza legittimante può essere costituita dall’apertura di un
nuovo tema di indagine determinata da una scelta di una “terza via” da parte
del giudice di primo grado non preceduta dall’apertura del contraddittorio39;
• un caso particolare meritevole di segnalazione è quello in cui è lo stesso
decorso del tempo fra il momento delle deduzioni istruttorie in primo grado e
il momento del giudizio di appello che rende
rilevante una prova
precedentemente non significativa40.
Per quel che riguarda la nozione di indispensabilità non mancano dubbi circa l’autonomia di
tale requisito rispetto a quello della non imputabilità.
Il dato testuale del 3° comma dell’art.345 c.p.c. sembra confermare l’alternatività dei due
presupposti di ammissione “straordinaria” delle nuove prove in appello: la legge infatti
contrappone l’ipotesi della valutazione di indispensabilità da parte del Collegio a quella della
dimostrazione del carattere incolpevole della mancata deduzione in primo grado, separandole
con il ricorso all’avversativa “ovvero”.
L’art.345 considera infatti altresì ammissibili i mezzi di prova che “il collegio ritenga indispensabili
ai fini della decisione della causa”.
La norma riprende intenzionalmente (come dimostra la lettura dei lavori preparatori) analoga
formula utilizzata nel contesto dell’art.437 c.p.c. con riferimento all’ammissibilità di nuovi
mezzi di prova nel secondo grado delle controversie soggette al c.d. rito del lavoro, sia pur
con l’eliminazione dell’inciso in tale norma previsto della possibilità di ammissione “anche
d’ufficio”.
La disposizione così introdotta, all’evidente scopo di controbilanciare in qualche misura le
restrizioni alla possibilità di ricerca della prova ingenerate dall’adozione del sistema delle
preclusioni, merita le severe critiche che ha giustamente subito sia in dottrina, sia in
giurisprudenza, laddove è stato messo in opportuno rilievo il carattere indeterminato del
potere così configurato, privo di un concreto referente utile alla sua esplicazione.
In dottrina i commenti in linea generale sulla nozione di indispensabilità vanno dal generico e
purtuttavia raccomandabilissimo invito ad esser parchi e a non consentire recuperi alla parte
negligente in prime cure alla definizione della indispensabilità come qualcosa di più specifico
e rigoroso rispetto alla mera rilevanza (intesa come astratta idoneità a dimostrare fondamento
delle domande ed eccezioni proposte).
Altre teorie puntano sul concetto di decisività: secondo alcuni l’indispensabilità va intesa
come decisività delle prove che giustificherebbero l’ammissione della revocazione ex art.395
Ovviamente in subordine rispetto alla preliminare doglianza circa la nullità della sentenza per violazione della
regola del contraddittorio, in ossequio ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.
40 Si pensi al caso (tratto da una concreta vicenda giudiziaria) in cui il giudice di primo grado aveva deciso una
causa di risarcimento del danno respingendo la domanda della parte attrice per difetto di prova del nesso causale
fra un antecedente fattuale imputabile al convenuto, potenzialmente idoneo a provocare l’evento lesivo, e il
danno, in presenza di altri fattori causali alternativi, potenzialmente suscettibili di dar essi pure causa all’evento,
ascrivibili alla sfera di responsabilità di altri soggetti, facendo così applicazione in pregiudizio dell’attore della
regola dell’onere probatorio; in secondo grado l’attore appellante deduceva a conforto della propria tesi (offrendo
prove sul punto) che la successiva eliminazione del fattore causale potenzialmente lesivo imputabile al convenuto
(nella specie: il completo rifacimento del sedime stradale di una pubblica via) aveva fatto venir meno il
pregiudizio in atto, così accreditando un ulteriore elemento di correlazione causale fra i due fatti ai fini del
giudizio presuntivo (alla stregua del criterio post hoc propter hoc, di cui costituisce espressione la regola medica
dell’efficienza del rimedio, c.d. “ex juvantibus”).
39
75
n.2 e 3 e che pertanto da sole potrebbero giustificare la decisione di conferma o riforma. Nella
stessa prospettiva, secondo altri, le prove dovrebbero riguardare un fatto “decisivo”, ossia quello
che da solo comporti o meno la conferma o la riforma della sentenza. Sarebbe, peraltro,
ammissibile, secondo questa tesi, anche l’integrazione delle deduzioni istruttorie svolte in
primo grado, ovverosia la deduzione di mezzi di prova non solo rilevanti ma necessari per la
conoscenza di un fatto e quindi decisivi per il giudizio. In conseguenza sarebbero pertanto
indispensabili quei mezzi di prova concernenti fatti la cui mancata considerazione ha
direttamente influito sulla decisione impugnata.
Altri Autori hanno invece puntato sulla valorizzazione dell’obiettivo della prova, agganciando
l’indispensabilità non ad una semplice idoneità a provare i fatti di causa ma alla presupposta
impossibilità di fornire la prova con altri mezzi, riconoscendo però al contempo che la
disposizione non può servire a recuperare decadenze incorse in primo grado e non può
comportare violazione del principio della parità delle armi.
E’ stata da più parti sottolineata l’incongruenza del ricorso alla nozione di indispensabilità
(concetto di relazione) in difetto di una esatta individuazione dell’obiettivo di riferimento
rispetto a cui la prova potrebbe qualificarsi indispensabile; vano però si rivela lo sforzo di
ascrivere un qualche significato alla formula normativa individuando il referente teleologico
della nozione di indispensabilità con l’adozione del punto di vista del giudice, per il quale non
è mai indispensabile una prova per poter decidere la causa, dal momento che il nostro
ordinamento positivo evita il non liquet con la ripartizione fra i contendenti dell’onere
probatorio.
E’ stata anche proposta una lettura del concetto di indispensabilità delle prove sulla base della
loro suscettibilità di sviluppare una influenza causale più incisiva sulla decisione finale della
controversia grazie alla loro potenziale attitudine (s’intende, alla luce di una prognosi ex ante)
di apportare nuovi elementi in una situazione in cui la decisione di primo grado sia stata
assunta, all’esito di una incerta valutazione del materiale istruttorio, in applicazione della regola
dell’onere probatorio di cui all’art.2697 c.c.
In tal modo una autorevole dottrina processualistica ha cercato di fornire un sostrato più
solido alla ambigua formula normativa dell’indispensabilità (che, si ripete, sottende un
concetto di relazione rispetto ad un fine), correlandolo proprio alle esigenze di verifica delle
decisioni di primo grado più insoddisfacenti sotto il profilo ideologico rispetto al valore
primario a cui è funzionalmente asservito il processo, ossia l’accertamento della verità storica
e materiale: ossia quelle decisioni in cui sia stata praticata applicazione della regola dell’onere
probatorio per sottrarre il giudice dalla impossibilità di un verdetto fondato sull’effettivo
accertamento dei fatti materiali (non liquet).
Non convince fino in fondo, però, anche questo ingegnoso tentativo di ricostruire una
interpretazione della nozione di indispensabilità attraverso la svalutazione della decisione della
controversia in primo grado effettuata in applicazione della regola dell’onere probatorio come
una sorta di decisione potenzialmente più ingiusta, sia per la mancanza di una adeguata base
normativa alla differenziazione delle decisioni fra quelle fondate sull’onere probatorio e quelle
fondate sulla valutazione delle prove, sia per la surrettizia vanificazione del sistema delle
preclusioni istruttorie (di cui la regola dell’onere probatorio costituisce l’inevitabile sanzione)
che l’opzione criticata comporta.
Piuttosto è il caso di riconoscere che il riferimento al concetto di indispensabilità (fra l’altro
“ritenuta” dal collegio) sembra evocare l’attribuzione di un potere discrezionale al giudice di
appello, diretto a temperare ed attenuare il rigore delle conseguenze del sistema delle
preclusioni in una inconfessata prospettiva di ricerca della effettiva “verità storica” in contrasto
con la “verità processuale” ricostruita in primo grado, come una sorta di resipiscenza del
Legislatore, pentito della rigidità del sistema che andava contestualmente costruendo. In tal
senso sembra connotata l’esperienza giurisprudenziale lavoristica relativa all’art.437, al cui
proposito la Cassazione ha più volte riaffermato l’insindacabilità della valutazione del giudice
di merito ex art.437.
76
Non sembra necessario (e per vero neppure logicamente corretto) ricorrere al concetto di
indispensabilità per legittimare tutte le prove aventi ad oggetto circostanze relative a questioni
esaminate per la prima volta in appello (in conseguenza del loro assorbimento per effetto della
soluzione di questioni preliminari di merito o di rito); in tal caso, infatti, è evidente che la
prova non è stata proposta nel giudizio di primo grado in modo del tutto incolpevole dalla
parte interessata, a causa della amputazione della fase delle deduzioni istruttorie,
discrezionalmente disposta dal giudice, legittimamente avvalsosi dei suoi poteri di gestione del
procedimento di cui all’art.187.
Se poi, per avventura, il giudice di primo grado avesse consumato un error in procedendo
nell’eliminare la fase delle deduzioni istruttorie, è evidente che sarebbe in tal caso inderogabile
onere della parte appellante la formulazione di uno specifico motivo di appello sul punto ex
art.342 al fine di poter introdurre le proprie richieste istruttorie illegittimamente penalizzate in
prime cure.
Non può essere sottaciuto un breve elenco delle varie ipotesi che sono state proposte in
dottrina41 di mezzi di prova qualificabili come indispensabili ex art.345:
i mezzi di prova la cui mancata deduzione in primo grado è dipesa dalla decisione del
giudice che ha ritenuto assorbita la questione, che propriamente possono considerarsi
non dedotti per causa non imputabile;
i mezzi di prova destinati a sorreggere o confutare domande ed eccezioni nuove nei
limiti in cui esse risultano consentite ex art.345 c.p.c.; in tal caso l’ammissibilità può
esser fatta discendere, oltre che dalla Costituzione (art.24) e da esigenze di ordine
logico, anche dalla stessa non imputabilità della preventiva omessa deduzione;
i mezzi di prova necessari per accertamenti di fatto connessi a questioni di diritto
sollevate dalle parti in appello; a tal proposito va osservato che se le parti prospettano
una questione di diritto che non comporta una nuova allegazione in fatto, è evidente
che la prova dedotta mira a superare una preclusione incorsa in prime cure; se invece la
questione di diritto proposta per la prima volta in appello si accompagna alla
deduzione di nuove allegazioni in fatto, il problema investe propriamente
l’ammissibilità di tale nuova deduzione sotto il profilo dell’art.345 e solo la positiva
soluzione del quesito consente di passare alla valutazione dell’ammissibilità della
correlativa richiesta istruttoria (con il che si ricade nell’ipotesi di cui al punto
precedente);
i mezzi di prova necessari per accertamenti di fatto derivanti da questioni di diritto
proposte dal giudice di appello in applicazione del principio iura novit curia (il che apre
lo spazio per valutare l’ammissibilità della prova non tanto in relazione al parametro
della indispensabilità quanto con riferimento alla non imputabilità in dipendenza della
adozione da parte del giudice della c.d. “terza via”);
i mezzi di prova che consentono di superare l’applicazione del disposto dell’art 2697
c.c. (al cui proposito valgono le obiezioni sopra esposte circa la carenza di base
normativa e il conflitto con il sistema delle preclusioni istruttorie).
Siffatte considerazioni hanno condotto taluni interpreti alla conclusione dell’opportunità di
una interpretazione restrittiva e sostanzialmente abrogante della disposizione dell’art.345
relativa alla indispensabilità, cosicché la norma si riferirebbe a prove comunque ammissibili
anche in assenza della disposizione in esame e alla pratica sovrapposizione al concorrente
requisito della non imputabilità.
Le proposte interpretazioni abroganti dell’alternatività dei due presupposti, comunque, non si
atteggiano mai in senso biunivoco; è stato infatti sostenuto che il giudice di appello non
potrebbe mai ammettere un mezzo di prova come indispensabile in difetto di ricorrenza
dell’altro requisito, al fine di preservare il sistema delle preclusioni da un totale scardinamento
nel giudizio di secondo grado, ma nessuno ha mai sostenuto il contrario, ossia che la
41
DE CRISTOFARO, “Nuove prove in appello, poteri istruttori ufficiosi e principi del giusto processo” in Corr.giur. 2002,114.
77
dimostrazione dell’incolpevole mancata deduzione sarebbe di per sé solo insufficiente se non
ricorresse anche il requisito dell’indispensabilità.
Indubbiamente appare assai difficile conferire un significato obiettivo e neutrale alla nozione
di indispensabilità (vuota di significati se priva del riferimento ad un obiettivo da perseguire),
oltretutto introdotta nella formula normativa per il tramite di una opinione del collegio (con
implicita evocazione di una valutazione discrezionale di opportunità da parte del giudice, che in
parte risente dell’origine processual-lavoristica della formula normativa, certo più coerente
rispetto ad un processo normativamente caratterizzato da esigenze di difesa effettiva di una
“parte debole”).
Nella sentenza n.8203 del 20.4.2005 la Corte Suprema, trattando l’argomento, ha affermato:
“……7. Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per una lettura dell’art. 345, comma 3, che,
nel rigido rispetto del dato normativo, tenga conto - al fine di evitare discrasie ed antinomie ordinamentali - che
la legge n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesistente
divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicché, come è stato da tutti
riconosciuto, il pervenire alla pressoché totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all’appello il
carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la
configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado.
7.1. In linea con quanto ora detto l’art. 345, comma 3, va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano
generale il principio dell’inammissibilità dei nuovi mezzi di prova (cioè di quei mezzi di prova la cui
ammissione non è stata in precedenza richiesta), e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello
stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i
requisiti che detti nuovi mezzi di prova devono presentare per potere trovare ingresso in sede di gravame.
Più specificamente l’incipit della disposizione in esame (“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo...”)
delinea, alla stregua del dettato dell’art. 12 delle preleggi, la natura sostanzialmente chiusa> del giudizio
d’appello. In tale direzione, il rispetto del chiaro dato normativo, che ne impone - rendendone nello stesso tempo
agevole - l’interpretazione letterale, induce questa Corte ad affermare che il giudice, oltre a quelle prove che le
parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad
ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze
istruttorie già acquisite indispensabili, perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella
che le prove, definite come rilevanti (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale
della controversia; prove che, proprio perché indispensabili, sono capaci, in altri termini, di determinare un
positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della
decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado.
È stato, al riguardo, osservato in dottrina che la particolare complessità delle controversie ordinarie, rispetto a
quelle proprie del lavoro, renderebbe particolarmente pesanti le preclusioni istruttorie, previste per il giudizio di
primo grado dal nuovo testo dell’art. 184 c.p.c., ove non si consentisse l’ammissione in appello almeno dei mezzi
di prova indispensabili, senza che la parte debba dimostrare anche l’impossibilità ad essa non imputabile di
una loro anteriore produzione.
A conforto di tale opinione che patrocina l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prove, e quindi anche di
documenti sempre che siano nuovi ed indispensabili - e nell’ambito della quale opinione qualche studioso ha
ravvisato nel disposto dell’art. 345, comma 3, una forma alternativa ed impropria di restituzione in termini va aggiunto che risponde a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la
novella del 1990, possano subire in sede di gravame, pure cioè in uno stato avanzato dell’intero iter
processuale, un parziale ridimensionamento proprio perché si é in presenza di prove che, per il loro spessore
contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di
contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado.
7. Ragioni di ordine testuale, non disgiunte da doverose opzioni ermeneutiche volte a favorire un ordinato e
cadenzato svolgimento delle attività processuali, anche esso funzionale al perseguimento di una ragionevole
durata del processo, portano a condividere l’indirizzo di questa Corte secondo cui - conformemente al disposto
degli artt. 163 e 166, richiamati dagli artt. 342, comma 1, e 347, comma 1 - nel rito ordinario la produzione
dei documenti deve essere effettuata dalle parti, a pena di decadenza, mediante la specifica indicazione dei
documenti stessi nei rispetti atti introduttivi del giudizio (cfr. Cass. 2 aprile 2004 n. 6528 cit.; Cass. 16 aprile
78
2002 n. 5463 cit.; Cass. 4 giugno 2001 n. 7510 cit.), sempre che ovviamente la formazione dei documenti da
esibire non sia successiva e sempre che la produzione degli stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello
sviluppo assunto dal processo.
Come è stato sul punto osservato, le parti devono indicare negli atti introduttivi dell’appello i documenti che
intendono produrre, perché alla prima udienza di trattazione il collegio, a norma dell’art. 352 c.p.c., deve
provvedere all’ammissione delle prove eventualmente dedotte o invitare le parti a precisare le conclusioni. Il che
dimostra che in questa fase i termini della controversia devono essere in ogni caso già delineati.
Sotto altro versante, a sostegno della rigorosità dell’indirizzo in esame, è stato evidenziato come non a caso il
codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d’appello, la disposizione dell’art. 184 sulla facoltà del
giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei
documenti, atteso che l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del
procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cass. 2
aprile 2004 n. 6528 cit.).
7.4. Da ultimo, esigenze di maggiore completezza motivazionale impongono di sottolineare come a differenza di
quanto si riscontra nel rito del lavoro, nel quale l’ammissione ad opera del giudice di nuovi mezzi di prova, per
essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una espressa richiesta in tali sensi (cfr. art.
437, comma 2, “...Non sono ammessi nuovi mezzi di prova... salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga
indispensabili....”), nel rito ordinario, invece, riscontrandosi un ruolo del giudice meno accentuato ed incisivo
nella direzione e nell’impulso del processo, l’ammissione dei nuovi mezzi di prova e, quindi, anche della prova
documentale, non può prescindere da una espressa domanda delle parti.
Peraltro, se si voglia attribuire una ragionevolezza al sistema e se si intenda, nello stesso tempo, conferire al
disposto dell’art. 345, comma 3, una qualche operatività, non può che concludersi con l’affermare che il giudice
d’appello, lungi dall’essere portatore di un potere discrezionale ai limiti dell’arbitrarietà e, comunque,
insuscettibile di controllo, diviene titolare di un potere del cui esercizio deve dare conto con un provvedimento
motivato, così come è tenuto a fare nel rito del lavoro il giudice che esercita i poteri d’ufficio ex art. 437, comma
2 (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit., secondo cui l’esercizio del potere officioso del
giudice, quand’anche si ritenesse avere carattere discrezionale, non può mai esercitarsi in modo arbitrario sicché
il giudice, a sensi degli art. 134 c.p.c. e 111 Cost. sul giusto processo, è tenuto ad esplicitare le ragioni per le
quali ritiene di fare ricorso ai poteri istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso). Tale
provvedimento è censurabile davanti ai giudici di legittimità alla stregua dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., sempre
che le parti negli spazi di disponibilità ad esse lasciati non abbiano con la loro condotta mostrato di accettare il
contraddittorio nei limiti segnati dall’intervento del giudice.”
La Suprema Corte testualmente ribadisce l’alternatività delle due ipotesi allorché
inequivocabilmente afferma “induce questa Corte ad affermare che il giudice, oltre a quelle prove che le
parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad
ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze
istruttorie già acquisite indispensabili, perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella
che le prove, definite come rilevanti (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale
della controversia”.
L’orientamento risulta condiviso anche da buona parte della giurisprudenza successiva, che
accentua il carattere discrezionale della decisione da parte del giudice del merito, che però
deve riscattarsi dall’arbitrarietà attraverso il rispetto dell’onere di motivazione:
• “Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345,
comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità
di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche
delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via
alternativa i requisiti che tal documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter
trovare ingresso in sede di gravame, requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano
potuto proporli prima per causa a esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della
indispensabilità degli stessi per la decisione.”(Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 2008, n. 9274);
79
•
“Nel giudizio di appello è inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte sia stata
nella impossibilità incolpevole di produrli, ovvero il giudice non li reputi indispensabili per la
decisione.”(Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14766).
Per esempio la sezione tributaria della Cassazione ha talora ritenuto “indispensabile” la
produzione dell’istanza di rimborso non prodotta in primo grado da parte dell’interessato:
• “Nel giudizio avente ad oggetto il rimborso della tassa di concessione governativa per
l’iscrizione nel registro delle imprese, qualora sia contestata l’avvenuta interruzione del
termine triennale di decadenza previsto dall’art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, è
ammissibile la produzione in grado di appello delle istanze di rimborso presentate dal
contribuente e delle ricevute di spedizione delle relative raccomandate all’Amministrazione
finanziaria, trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione, in quanto
attestanti la tempestiva proposizione delle predette istanze.”(Cassazione civile, sez. trib.,
15 maggio 2008, n. 12179).
In particolare, con riferimento all’obbligo di motivare la valutazione di merito di
indispensabilità:
• “In tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345
comma 3 c.p.c., il collegio è tenuto a motivare l'eventuale indispensabilità che giustifica
l'ammissione delle nuove prove, in deroga alla regola generale, e non invece la mancata
ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla regola generale
medesima.”(Cassazione civile , sez. I, 21 luglio 2009, n. 16971);
• “La richiesta di ammissione di nuove prove in appello, ex art. 345 c.p.c., è sottoposta al
vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili al fini del decidere; il
potere di apprezzamento di tale necessario presupposto di ammissibilità della prova non è
però del tutto discrezionale ma deve essere esercitato secondo criteri logici che il giudice ha il
dovere di indicare e che possono essere oggetto di censura in sede di legittimità nei limiti della
rilevabilità del vizio di omessa, irrazionale o contraddittoria motivazione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto non
provato nel suo esatto ammontare il danno patrimoniale subito per la
riparazione di una autovettura danneggiata in uno scontro stradale senza
pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale formulata nell’atto di appello,
con articolati specifici relativi alla consistenza dei danni riportati dal
veicolo).”(Cassazione civile, sez. III, 31 luglio 2006, n. 17439);
• “Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall’art. 345, comma
3, c.p.c. con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall’art. 437, comma 2, in relazione
al processo del lavoro - implica la valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un
perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può
sostituirsi la Corte di cassazione.”(Cassazione civile, sez. lav., 20 giugno 2006, n.
14133);
• “L’art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353,
nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, ivi
compresi documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle nuove prove che le
parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, quelle che ritenga,
nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili perché dotate di
un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che el prove, definite come rilevanti, hanno
sulla decisione finale della controversia. Tale facoltà, comunque, quand’anche si ritenesse di
carattere discrezionale, non può mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere
espressa in un provvedimento motivato, il cui contenuto è censurabile in sede di legittimità ai
sensi dell’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.”(Cassazione civile, sez. trib., 19 aprile 2006, n.
9120).
La (sorprendente) affermazione di Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2007, n. 1656, secondo
la quale “Nel rito ordinario la produzione di documenti in appello è consentita ove le parti non abbiano potuto
produrli prima per cause a loro non imputabili, ovvero se il giudice li abbia ritenuti indispensabili. Bene,
80
pertanto possono essere prodotti documenti, congiuntamente al deposito dell’atto di impugnazione, da parte del
contumace in primo grado.”, che sembrerebbe autorizzare l’inconsueta opinione che il contumace
non soffra di alcuna preclusione alle produzioni documentali, va bruscamente ridimensionata,
sia perché costituisce un mero obiter dictum (visto che la motivazione principale della sentenza è
basata sulla natura camerale del procedimento, non soggetto a preclusioni probatorie), sia
perché la Corte ha comunque fatto riferimento anche alla nozione di indispensabilità.
Nella giurisprudenza di legittimità è stata prospettata una interpretazione restrittiva (quasi
sostanzialmente abrogante) della disposizione dell’art.345 c.p.c. relativa alla indispensabilità, nel
senso che la norma si riferirebbe a prove comunque ammissibili anche in assenza della
disposizione in esame e alla pratica sovrapposizione al concorrente requisito della non
imputabilità.
Ad esempio il Supremo Collegio con la sentenza n.10487 del 2004 ha osservato:
“L’art. 345, comma secondo c.p.c. dispone che nel giudizio d’appello «non sono ammessi nuovi mezzi di prova,
salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non
aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».
La disposizione in questione considera dunque due ipotesi per l’ammissione delle prove nuove: a) la prima, con
una formula mutuata dal processo del lavoro, condiziona l’ammissione alla valutazione di indispensabilità della
prova da parte del collegio; b) la seconda, con un meccanismo analogo a quello della rimessione in termini in
primo grado (art. 184-bis) subordina l’ammissione alla dimostrazione della parte di non aver potuto proporre
la prova in primo grado per causa ad essa non imputabile. Si tratta di due ipotesi alternative tra loro e
autonome nei presupposti, come dimostra il fatto che sono separate dalla locuzione disgiuntiva «ovvero» e come
conferma la circostanza che la seconda ipotesi è stata «aggiunta» alla prima durante i lavori parlamentari.
Ciò comporta che ove la parte dimostri di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa a lei non
imputabile può ottenerne l’ammissione in appello indipendentemente dal requisito dell’indispensabilità. Mentre
qualora non dimostri che la preclusione in primo grado sia stata determinata da causa non imputabile non può
ottenere l’ammissione della prova in appello, anche se il collegio la dovesse ritenere indispensabile. La
valutazione d’indispensabilità della prova non può superare la preclusione nella quale è incorsa la parte in
primo grado. Ed anzi, in questo caso, la prova richiesta in appello non può neppure considerarsi prova nuova,
poiché è una prova dalla quale la parte è decaduta.
Come la remissione in termini in primo grado consente il superamento delle preclusioni, così la possibilità di
ammettere in appello prove che non erano state proposte in primo grado per causa non imputabile mitiga la
rigidità del modello di «appello chiuso» disegnato dal legislatore del 1990. Ma al di fuori della ricorrenza
dell’ipotesi della causa non imputabile, non può essere ammesso in appello ciò che non era consentito in primo
grado. Questo è il senso della disposizione in oggetto e risponde ad un canone di razionalità del processo, che
realizza pienamente l’art. 111 Cost. il quale impone alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo e
di evitare, dunque, che colpevoli ripensamenti delle parti possano farlo «regredire» per l’acquisizione di materiale
probatorio che già si sarebbe dovuto acquisire nella fase o nel grado precedente.
Questa interpretazione del nuovo testo dell’art. 345, terzo comma c.p.c. è in linea con la giurisprudenza che si
era venuta formando sul testo dell’art. 345, secondo comma anteriore alla novella del 1990. Pur in presenza di
una disciplina dell’appello che consentiva alle parti di chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, questa
Corte ha costantemente affermato che la prova inammissibile in primo grado per essere la parte incorsa in
decadenza non poteva essere riproposta in appello (Cass. 9 novembre 2000, n. 14598; Cass. 27 settembre
1994, n. 7881).
In conclusione, la parte che nel giudizio di primo grado è incorsa nella preclusione relativamente alla prova, in
tanto può ottenere in appello l’ammissione della prova, in quanto dimostri che la preclusione in primo grado sia
stata determinata da causa non imputabile. Al di fuori di questa ipotesi il collegio non può ammettere la prova
ritenendola indispensabile, poiché questo potere non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già
verificatesi nel giudizio di primo grado (analogamente Cass. 13 dicembre 2000, n. 15716; Cass. 19 agosto
2003, n. 12188).”.
Analogamente nella pronuncia del 20 novembre 2006, n. 24606 la Cassazione civile, sez.
trib., ha osservato:
81
“Nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, non trova più applicazione il principio secondo cui
l’inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non
abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio: l’art. 184 c.p.c., nel
testo novellato dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, non si limita infatti a prevedere l’eventuale assegnazione alle
parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere
perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell’art. 153
c.p.c.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184 bis, che ammette la rimessione in
termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella
decadenza per una causa ad essa non imputabile. Pertanto, nel giudizio di appello l’eventuale indispensabilità
dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la
loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui
all’art. 184 c.p.c., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti.”
Ulteriore conforto a tale tesi, sia pur dispensato obiter, può essere colto nella pronuncia
n.22014 del 25.9.2007 con cui la Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti n.10487 del
1°.6.2004 e n.12118 del 19.8.2003, ha puntualizzato il principio che la valutazione di
indispensabilità non può servire alla parte a superare le preclusioni in cui sia incorsa in primo
grado, in quanto il potere riconosciuto al collegio di ammettere nuove prove in appello non
può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo
grado.
Con la stessa pronuncia la Corte Suprema sembra ritenere necessaria anche una formale
allegazione di indispensabilità da parte del soggetto che richiede l’ammissione del nuovo
mezzo di prova (“... che non possono essere applicati in questa sede.....almeno perché non ne risultano
neppure allegati i presupposti.”).
Secondo l’orientamento più recente il giudizio di indispensabilità della prova attiene al rito,
con la conseguente abilitazione della Corte di Cassazione a giudicare in fatto:
• “Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, comma 2, in relazione al processo del
lavoro - non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini
dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di
una richiesta istruttoria di parte: ne consegue che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimità
l'erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la
Corte di cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è
quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile.”(Cassazione civile ,
sez. I, 17 giugno 2009, n. 14098).
E’ doveroso precisare che i nuovi documenti debbono essere prodotti con l’atto di citazione
in appello, ovvero con la comparsa di costituzione e risposta, e non già nel corso della
trattazione nel giudizio di secondo, come anche la giurisprudenza di legittimità più liberale
anteriore alla rievocata decisione delle Sezioni Unite (e del resto la stessa sentenza delle
Sezioni Unite n.8203 del 2005 sopra citata) ha sempre avuto cura di puntualizzare42:
• “In conformità del disposto degli art. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli art. 342 e 347 c.p.c., la
produzione nel giudizio d’appello dei documenti ammissibili in base all’art. 345, comma 3, c.p.c., deve
essere effettuata dalle parti, a pena di decadenza, mediante la specifica indicazione dei documenti stessi
nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.”(Cassazione civile, sez. un., 20 aprile 2005, n.
8203);
• “L’art. 345 c.p.c. non vieta “ex se” la produzione di documenti nuovi in appello, in quanto il divieto
di nuovi mezzi di prova cui la disposizione si riferisce sono solo quelli ammessi ed assunti dal giudice e
non anche le prove cosiddette precostituite. Conseguentemente, al fine di salvaguardare le esigenze di
celerità nel processo e di consentire l’immediata e completa instaurazione del contraddittorio, nel rito
ordinario la produzione di documenti nuovi in grado d’appello deve essere compiuta dall’appellante, a
42 Ciò, beninteso, a meno che l’interesse o la possibilità della produzione non sia maturata solo nel corso del
giudizio di secondo grado
82
pena di decadenza, sia mediante la specifica indicazione dei documenti stessi nell’atto introduttivo del
relativo giudizio sia mediante il loro deposito contestualmente al deposito dell’appello.”(Cassazione
civile, sez. III, 4 giugno 2001, n. 7510).
E’ stato anche sostenuto che la limitazione frapposta dall’art.345, 3° comma, c.p.c. partecipa
della stessa natura dell’istituto della rimessione in termini di cui all’art.184 bis c.p.c. (ora 153 ,
comma 2, c.p.c.) per dedurne l’inammissibilità della produzione in appello di documenti
acquisibili dalla parte interessata dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie in primo grado ma
allorché la causa di primo grado era ancora in corso.
A tal proposito si ipotizza che l’omessa produzione dei documenti in primo grado sia dipesa
dal mancato ricorso all’istituto della rimessione in termini con riflesso ostativo alla
producibilità degli stessi documenti in secondo grado.
Tale assunto sembra però eccessivamente rigoroso, perché finisce con l’attribuire all’istituto
della rimessione in termini natura di obbligo, o quantomeno di onere, e non già quella natura
di mera facoltà che gli é propria.
Inoltre le preclusioni e le decadenze processuali non possono essere ricavate in via implicita o
in via di estensione analogica, in quanto derivano da norme di stretta interpretazione incidenti
sul diritto di difesa: e nessuna norma sancisce una decadenza dalle richieste istruttorie dopo lo
spirare del termine preclusivo di cui all’art.184 c.p.c. ed ancora nell’ambito del giudizio di
primo grado, come invece la parte appellata è costretta ad ipotizzare per ragioni di necessaria
coerenza.
Fra l’altro, non si comprende neppure quando tale preclusione interna scatterebbe, in difetto di
qualsiasi aggancio normativo idoneo a conferirle un più pregnante e puntuale significato: per
esempio, non è chiaro se la supposta preclusione scatti – sempre in difetto di specifica
previsione normativa - alla prima udienza utile dopo l’insorgere della materiale possibilità della
richiesta istruttoria.
Quanto al motivo istruttorio che si fondi sulla richiesta di disposizione di consulenza tecnica
d’ufficio, non disposta in primo grado, appare opportuno rinviarne l’analisi dettagliata
all’apposito paragrafo dedicato ai motivi inerenti la consulenza tecnica, anche se occorre
precisare che almeno normalmente la natura intrinseca della consulenza tecnica d’ufficio (che
non è mezzo di prova, ma strumento di integrazione delle cognizioni tecniche del giudice per
la valutazione del materiale probatorio acquisito) esclude l’applicabilità dei limiti di cui al 3°
comma dell’art.345 c.p.c., tanto più che la consulenza può essere disposta anche d’ufficio.
Non sembra far eccezione neppure l’ipotesi in cui la consulenza tecnica svolga una funzione
c.d. “percipiente”, ossia funga da specifico strumento di acquisizione probatoria di fatti rilevabili
solo attraverso il ricorso ad un ausilio tecnico43, ipotesi nella quale l’onere gravante sulla parte
interessata si risolve nella necessità di dedurre il fatto che pone a fondamento del suo diritto e
che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (giurisprudenza
consolidata: ad esempio Cass. civ.sez.II 28.2.2007 n.4743).
18.5. Il motivo istruttorio basato su documento avversario non depositato.
“Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone
l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati
dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti
possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. In questo secondo caso è
necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo
accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere
direttamente all’accertamento.”(Cassazione civile, sez. un.,4 novembre 1996, n. 9522; conformi Cass.civ. sez.III
26.1.2007 n.24620; sez.II 28.2.2007 n.4743; sez.III 23.2.2006 n.3990; sez.III 7.12.2005 n.27002; sez.III 22.5.2005
n.13401).
43
83
Un problema piuttosto particolare, ma tutt’altro che infrequente nella prassi giudiziaria,
riguarda l’ipotesi del motivo istruttorio basato su di un documento prodotto dall’avversario e
non depositato nel giudizio di secondo grado.
Allorché la parte appellata (vittoriosa o perlomeno non totalmente soccombente) in primo
grado abbia prodotto nel giudizio di primo grado un documento preso in considerazione ai
fini della decisione da parte del giudice e che non sia stato ri-depositato nel giudizio di appello
(magari perché l’appellato è rimasto contumace in secondo grado) molto si discuteva
dell’appello sfogato contro la decisione fondata sul documento mancante e non disponibile per
il giudice di appello.
L’alternativa che si delineava atteneva all’individuazione della parte che subiva il “rischio”
dell’assenza del documento:
• era cioè l’appellante a subire la dichiarazione di inammissibilità (o comunque il
rigetto nel merito) dell’appello perché l’assenza del documento impediva al
giudice dell’impugnazione di verificare specificità e pertinenza (o quantomeno
la fondatezza) del gravame;
• ovvero era l’appellato, gravato sul punto dell’onere probatorio in primo grado,
a subire le conseguenze della mancanza della prova nel giudizio di appello a
fronte di una impugnazione ammissibile, che aveva individuato e
specificamente censurato il punto della decisione?
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che con la sentenza 23
dicembre 2005, n. 28498 hanno affermato che:
“L’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più nella
configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una
revisio fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue
che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale,
produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio
gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex, art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare
dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti
all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo
dell’altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha
avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.
Nel giudizio di appello essendo l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è richiesto per ottenere la
riforma del capo decisorio appellato, il gravame da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere
respinto, con conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione
da lui assunta nella precedente fase processuale.
Nel sistema processual civilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto
processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta
introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice
utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere
probatorio. Ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l’onere di
depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione
dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti
impossibile all’altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo
avversario.”44
La sentenza è stata criticata in dottrina da BALENA, ORIANI, PROTO PISANI, RASCIO, in “Oggetto del
giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite”, Foro it. 2006,1436;
gli Autori prospettano il rischio di un pericoloso fraintendimento, potenzialmente derivante dall’accoglimento
della concezione troppo rigida dell’appello come revisio prioris instantiae, e ricordano che la limitazione della
cognizione del giudice di appello alla griglia delle censure mosse alla sentenza impugnata non significa però che sia
la sentenza di primo grado (e non già le domande giudiziali) ad essere l’oggetto del giudizio di secondo grado.
44
84
In sostanza, secondo le Sezioni Unite :
• la natura del procedimento di appello riconducibile allo schema della revisio prioris
instantiae grava l’appellante dell’onere di dimostrare l’erroneità/ ingiustizia della
decisione di primo grado e quindi di sottoporre al giudice dell’appello tutti gli elementi
per addivenire alla riforma della sentenza;
• la mancanza del documento si risolve quindi in pregiudizio dell’appellante;
• nel giusto processo civile ex art.111 Cost. domina peraltro il principio di acquisizione
processuale della prova (nel senso, cioè, che gli elementi di prova da chiunque forniti
sono acquisiti e indisponibili e concorrono a formare il convincimento del giudice);
• in conseguenza non mancano alla parte interessata gli strumenti per superare l’ostacolo
materiale rappresentato dal mancato deposito del documento a lui favorevole da parte
dell’avversario (condizionamento della facoltà di ritiro al preventivo deposito di copia
sostitutiva dei documenti probatori ivi contenuti, rispetto dei doveri di lealtà e di
probità sanciti dall’art. 88 c.p.c.).
Il principio risulta puntualmente ribadito anche nella giurisprudenza successiva:
• “Il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo
grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver
basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel
merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte
stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro
ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in
funzione della decisione.”(Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2007, n. 11196);
• “Qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con l’accoglimento della domanda dell’attore,
avendo la corte ritenuto provato il fatto costitutivo del suo diritto sulla base di un documento da lui
prodotto in giudizio, l’appellante ha l’onere di curarne la produzione in giudizio, al fine di consentire
la giudice di appello di valutare la fondatezza della censura proposta, non essendo utilizzabile in
appello il fascicolo di primo grado della parte non costituita.”(Cassazione civile, sez. II, 12 luglio
2007, n. 15660).
Ancora recentemente la Cassazione ha confermato la devoluzione alle parti dell’onere e
dell’interesse al deposito del fascicolo di parte nel giudizio di appello:
• “L’onere di depositare in appello il proprio fascicolo relativo al primo grado incombe sulla parte
interessata. Il suo mancato deposito, pertanto, non può dare luogo a nullità della sentenza di secondo
grado.”(Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081).
19. Motivi in diritto.
La sentenza è stata criticata anche da RONCO in “Appello e mancata (ri)produzione di un documento già prodotto in primo
grado:onere della prova sulla fondatezza del motivo di gravame od onere della prova sulla fondatezza della domanda devoluta al
giudice dell’impugnazione.”, Giur.it.2006,675.
L’Autore rimprovera alle Sezioni Unite di aver impresso una eccessiva enfatizzazione al requisito dei motivi e di
essere incorsa in equivoco tra il piano dell’ammissibilità dell’impugnazione e quello di merito della possibile
fondatezza delle censure sollevate.
L’Autore ascrive alle Sezioni Unite l’elaborazione di una tesi dell’ “autoinsufficienza” dell’appello ai fini della sua
ammissibilità, giacché secondo la sentenza non é sufficiente all’appellante, per garantirsi l’ammissibilità
dell’impugnazione, indicare il capo su cui è soccombente ed la questione risolta a suo sfavore ed esternare le
ragioni per cui la questione gli pare mal risolta, ma è necessario che egli metta anche in condizione il giudice di
valutare se le ragioni della sua doglianza siano o meno fondate, a prescindere dalla distribuzione sostanziale
dell’onere della prova.
Così ragionando, secondo l’Autore, la soluzione accolta non solo confonde il tema dell’ammissibilità con quello
del merito dell’impugnazione, ma conduce anche ad una inaccettabile delimitazione dei poteri del giudice di
appello, ridotto alla secca alternativa fra confermare la decisione o accogliere l’impugnazione (senza la possibilità
di adottare per un fine o per l’altro una motivazione diversa, come viene pacificamente ritenuto anche alla luce dei
poteri riconosciuti al giudice dell’appello di rilevare eccezioni in senso lato e assumere prove d’ufficio, ex
art.345, 2° e 3° comma, c.p.c.); la risposta delle Sezioni Unite, infine, premia in modo ingiustificato e contro le
tendenze evolutive dell’ordinamento l’atteggiamento di inerzia della parte contumace.
85
Non è difficile individuare la categoria dei motivi in diritto, con i quali la parte appellante
denuncia l’errore commesso dal giudice di primo grado nell’applicare la corretta norma
giuridica alla fattispecie.
Nel loro ambito meritano un cenno i motivi in diritto “adesivi” (sempre nella nozione
precedentemente illustrata) con i quali l’appellante non prospetta un errore di applicazione del
diritto da parte del primo giudice, ma un successiva modificazione del quadro normativo,
ascrivibile allo jus superveniens ovvero alla sopravvenuta dichiarazione di costituzionalità della
norma applicata.
Analoga regola vale in punto compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario:
• “La verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario, in quanto non
comporti l’esame di specifiche questioni di fatto e sia dedotta nei termini della totale
incompatibilità tra il diritto nazionale e la disciplina comunitaria, non si traduce in
un’eccezione in senso proprio. Essa, pertanto, come nei casi dello “ius superveniens” e della
modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, può e deve
essere effettuata anche d’ufficio. Né é possibile, in senso contrario argomentare dal principio di
specificità dei motivi d’impugnazione, per sostenere che il principio “iura novit curia”
soffrirebbe una compressione, in ragione del limite costituito dall’effetto devolutivo
dell’appello.”(Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2006, n. 27500).
In tale sentenza la Corte di Cassazione chiarisce peraltro che il giudice di appello, nell’ambito
della devoluzione ed avvalendosi dei poteri di corretta applicazione della norma giuridica (jura
novit curia), può comunque correggere l’errore giuridico commesso dal giudice di primo grado,
anche nel caso in cui lo stesso non sia stato stigmatizzato dall’appellante con motivo specifico
di gravame proposto con l’atto introduttivo.
Osserva infatti la Suprema Corte che “Ben diversa è la situazione quando oggetto d’esame non sia una
quaestio facti quale la validità di un atto, ma la validità stessa della norma giuridica che il Giudice è chiamato
ad applicare. In tal caso il principio iura novit curia, di cui all’art. 113 cod. proc. civ., comma 1, comporta che
rimane sempre salva la possibilità per il Giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai
rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla
concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi
da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 24.6.2003, n. 10009). In tale attività rientra, a fortiori,
la verifica della conformità del diritto nazionale con quello comunitario, in ragione del suo carattere direttamente
vincolante per il Giudice nazionale.”
Analogamente :
• “Il mutamento della “causa petendi” determina un mutamento della domanda, tale da renderla
inammissibile come domanda nuova in appello nei soli casi in cui vengano alterati l’oggetto sostanziale
dell’azione e i termini della controversia, mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni
giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione pongano in essere una
pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado. Una tale
inammissibilità, quindi, non è configurabile tutte le volte in cui - fermi tra il primo e il secondo grado i
fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche a esse ancorate - vengano sollevate in
appello delle ulteriori questioni di diritto, all’esame delle quali il giudice, salva la formazione del
giudicato sul punto, sia comunque tenuto per il principio “iura novit curia” essendo suo dovere ricercare
le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento
della decisione principi di diritto anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle
parti.”(Cassazione civile, sez. II, 3 marzo 2008, n. 5741);
• “In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al comma 2
dell’art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la
Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica
diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale
individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel
ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di
86
ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve
inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni
in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di
un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o
l’integrazione di una eccezione in senso stretto. (Sulla base di tali principi la S.C., investita della
denuncia di violazione del divieto di domande nuove i appello, ha rilevato d’ufficio
che l’introduzione di detta domanda era, in realtà avvenuta in primo grado e che il
giudice d’appello, cui la relativa questione era stata devoluta, non ne aveva rilevato la
fondatezza).”(Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2007, n. 6935).
Lo stesso principio è stato di recente ribadito con riferimento alle questioni di giurisdizione:
• “Il potere di rilievo d’ufficio impone al giudice dell’appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il
controllo dell’esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte
avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto
dall’applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente
che si investa il giudice dell’impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del
giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione
impugnata.”(Cassazione civile, sez. un., 20 giugno 2007, n. 14288).
Così può trarsi la sintesi degli orientamenti illustrati: il giudice di appello, anche d’ufficio e
indipendentemente dalla proposizione di uno specifico motivo, nell’ambito dell’effetto
devolutivo innescato dalla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, può applicare alla
fattispecie la norma giuridica corretta, diversa da quella applicata dal primo giudice e anche da
quelle indicate dalle parti (purché nel rispetto del contraddittorio), purché ciò non comporti
ampliamento o modifica degli accertamenti e delle indagini correlative.
In tema di motivo di diritto, la Cassazione ha da ultimo ribadito che :
• “Quando l’appellante lamenti un errore di diritto, per soddisfare il requisito della specificità dei motivi
di gravame, prescritto dall’art. 342 c.p.c., è necessario e sufficiente che l’atto d’appello invochi
l’applicazione di un principio di diritto diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza
impugnata.”(Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2009, n. 7341).
20. Motivi attinenti alla nullità, annullabilità, inefficacia di negozi giuridici.
Un capitolo a parte merita il delicato tema della possibilità di rilievo d’ufficio delle nullità
negoziali, sancita in modo apparentemente generale e indiscriminato dall’art.1421 c.c. (“Salvo
diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata
d’ufficio dal giudice”).
Tale regola va tuttavia coordinata con il principio dispositivo che informa di sé il processo, alla
luce dell’insegnamento impartito, fra l’altro, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza del 4.11.2004 n.21095, secondo cui:
• “La nullità del contratto o di una clausola di esso può essere rilevata d’ufficio, anche in
appello e in assenza di una eccezione in tal senso, ogni qual volta la domanda attorea
abbia ad oggetto un credito scaturente dal quel contratto. Il potere del giudice di dichiarare
d’ufficio la nullità o l’inesistenza di un contratto ex art. 1421, c.c., va coordinato con il
principio della domanda (art. 99 e 112, c.p.c.), con la conseguenza che la nullità
può essere rilevata d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente
dall’attività assertiva delle parti, quindi anche per una ragione diversa da quella
espressamente dedotta, nel caso in cui sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione del
contratto, la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda; infatti,
in detta ipotesi la deduzione con la quale la parte contesta la validità dell’atto non
costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa, in quanto attiene all’inesistenza, per
mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico - il contratto - dedotto dall’attore
a fondamento della domanda, che quindi non condiziona l’esercizio del potere di
dichiarare d’ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti.
87
Tale pronuncia non fa che ribadire un orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte
in tema di necessario coordinamento del principio della rilevabilità d’ufficio della nullità del
contratto, scaturente dalla regola di cui all’art.1421 c.c., che sembrerebbe affrancare la parte
interessata dal rispetto di una soglia preclusiva per la deduzione della nullità nel processo, con
il principio dispositivo che domina il giudizio civile e che trova specifica cristallizzazione nelle
regole della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui agli artt.99 e
112 c.p.c.
L’assunto consolidato è che il giudice può dichiarare anche d’ufficio la nullità o
l’inesistenza di un contratto ex art. 1421 c.c. indipendentemente dall’attività assertiva delle
parti nel caso in cui sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione del contratto, di cui sia
stato richiesto l’adempimento delle obbligazioni.
Allorché, invece, una parte abbia richiesto nel giudizio la dichiarazione di invalidità di un
atto ad essa pregiudizievole, anche in via di eccezione, il giudice non può allargare il proprio
sindacato ad altri elementi di invalidità non dedotti (o non tempestivamente dedotti), dovendo
in tal caso la pronuncia essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate
dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente
indicati, giacché in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della
domanda attorea.
La rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto, per effetto del necessario coordinamento con il
principio dispositivo e con la regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trova
applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa
attorea (ad esempio: di esecuzione di un contratto nullo), non anche quando sia invece
la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, giacché
in tal caso il giudice si deve limitare all’esame delle ragioni di illegittimità denunciate
dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o tardivamente
indicati, giacché in tal caso l’invalidità dell’atto si pone come elemento costitutivo della
domanda attorea (ovvero dell’eccezione del convenuto).
Quindi solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui validità
rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi
stato e grado del giudizio la nullità dell’atto, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti;
qualora invece la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto o a farne
pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di
nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una
qualsiasi causa di nullità o di un fatto risolutivo diverso dall’inadempimento sono
inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d’ufficio, ostandovi il divieto di
pronunciare “ultra petita”.45
Analoga è la soluzione da seguire nel caso, assai frequente, in cui, a fronte di una domanda di
adempimento del contratto proposta dall’attore, il convenuto abbia proposto una specifica
eccezione di invalidità del negozio: il principio dispositivo preclude al giudice il rilievo
officioso di una diversa causa di nullità non dedotta dalle parti.46
Lo stesso principio è stato affermato ogni qual volta la parte interessata abbia cercato di
inficiare il contratto anche sotto altre prospettive (ossia con domande di risoluzione,
annullamento o rescissione):
L’insegnamento è del tutto consolidato: Cass.11.3.1988 n.2398; Cass.22.4.1995 n.4607; Cass.15.2.1991 n.1589;
Cass.9.2.1994 n.1340; Cass.9.1.1999 n.117; Cass.8.1.2000 n.123; Cass.23.9.2000 n.12.644; Cass.3.1.2001 n.59;
Cass.1°.8.2001 n.10.498; Cass.18.7.2002 n.10.440; sez. II, 27..6.2005, n. 13732; sez. I, 10.5.2005, n. 9779; sez. I,
19.1.2005, n. 1097; sez. III, 14.12.2004, n. 23292; sez. III, 20.10.2004, n. 20548; sez. III, 6.10.2004, n. 19950; sez.
II, 10.9.2004, n. 18210; sez. I, 8.9.2004, n. 18062; sez. III, 11 agosto 2004, n. 15561.
45
Ad esempio: Tizio agisce per ottenere il pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare e Caio
eccepisce la nullità del contratto per simulazione; il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità del contratto per la
mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia (art.46 d.lgs. 380/2001, già art.17 legge 28.2.1985
n.47).
46
88
•
“La rilevabilità di ufficio della nullità del contratto opera quando si chieda l’adempimento di
questo, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni
dell’azione, e non anche quando la domanda sia diretta a far dichiarare l’invalidità del
contratto o a fame pronunciare la risoluzione per inadempimento. L’art. 1421 c.c., infatti,
deve coordinarsi con l’art. 112 c.p.c., il quale, sulla base del principio dispositivo su cui va
modellato il processo, impone al giudicante il limite insuperabile della domanda attorea, anche
alla luce del nuovo art. 111 cost. che richiede di evitare, al di là delle precise e certe
indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosi.”(Cassazione civile,
sez. I, 21 gennaio 2008, n. 1218);
• “Il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità del contratto va coordinato con
i principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato (art. 112 c.p.c.). Ne consegue che, così come tale potere sussiste se viene chiesto
l’adempimento del contratto, - dovendosi, in tal caso, accertare le condizioni dell’azione -,
esso non sussiste se viene chiesto l’annullamento, la risoluzione o la rescissione. (Nella
specie, la sentenza di merito aveva respinto la domanda di nullità sul presupposto che
essa era stata proposta tardivamente; la S.C, correggendo la motivazione ai sensi dell’art.
384 c.p.c., ha precisato che l’impossibilità di dichiarare la nullità derivava, invece, dal fatto
che era stata chiesta solo la risoluzione).”(Cassazione civile, sez. III, 14 dicembre
2004, n. 23292)
In particolare, con specifico riferimento all’inammissibilità della dichiarazione d’ufficio della
nullità nell’ipotesi in cui sia stata proposta azione volta a caducare il contratto attraverso lo
strumento della risoluzione per inadempimento, la giurisprudenza del tutto prevalente della
Corte di Cassazione47 è orientata per l’inammissibilità del rilievo d’ufficio della nullità del
contratto di cui sia stata chiesta la risoluzione48.
Per quel che riguarda il giudizio di secondo grado la trasposizione dei principi sopra
compendiati porta a ritenere che il giudice di appello possa, anche d’ufficio, rilevare la nullità
del contratto con riferimento al quale sia stata proposta una domanda volta ad ottenerne
l’adempimento (che presuppone l’implicito preventivo accertamento della sua validità), purché
non siano state proposte domande od eccezioni volte a inficiarne la validità (risoluzione,
annullamento, inefficacia, rescissione, nullità sotto altri profili), alla luce del necessario
coordinamento della rilevabilità d’ufficio con il principio dispositivo.
Recentemente in questo senso:
• “Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità (o l’inesistenza) di un contratto, in base
all’art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112
c.p.c., nel senso che solo se sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto la cui
validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi
stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale
nullità dell’atto stesso, e che se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità
dell’atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d’ufficio, né può esser dedotta
per la prima volta in grado d’ appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella “ab
origine” proposta dalla parte. Ne consegue che è consentito al giudice d’ appello, senza per
questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l’inesistenza) del contratto in
base ad una ragione diversa da quella prospettata dall’appellante che sia rimasto soccombente
nel primo grado del giudizio contro di lui iniziato per l’esecuzione del contratto, nascendo il
potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, anteriormente
alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o,
successivamente, come motivo di gravame. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di
47
Rispetto alla quale resta allo stato isolato il dissenso espresso dalla sentenza del 22.3.2005 n.6170 della III sez.
Cassazione civile, sez.II 17.5.2007 n.11550; sez.II, 6.10.2006 n.21632;sez. lav., 14 ottobre 2005, n. 19903; sez.
III, 14 dicembre 2004, n. 23292; sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2108; sez. II, 8 gennaio 2000, n. 123; sez. II, 09
gennaio 1999, n. 117; sez. I, 2 aprile 1997, n. 2858 .
48
89
•
•
•
•
merito che aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda, formulata per la prima
volta in appello, volta alla declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di affitto di
fondo rustico nella parte in cui le stesse prevedevano anche un compenso correlato al ricavato
della vendita del prodotto legnoso ottenuto dal taglio periodico del bosco, mai effettuato, e
aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei
tagli).”(Cassazione civile, sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621);
“La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi
passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in
giudizio, è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, rimanendo irrilevante, a
tal fine, l’assenza di una deduzione (o di una tempestiva deduzione) del profilo di invalidità a
opera dell’interessato, la quale rappresenta una mera difesa, inidonea a condizionare, in senso
positivo o negativo, l’esercizio del potere - di rilievo officioso della nullità del
contratto.”(Cassazione civile, sez. I, 08 maggio 2008, n. 11466);
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un normale giudizio di
cognizione, la nullità del titolo negoziale posto a base della pretesa di pagamento è rilevabile
d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., in sede di gravame, qualora sia in contestazione
l’applicazione o l’esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l’adempimento
delle obbligazioni da esso derivanti; in tale ipotesi, infatti, la validità dell’atto si pone come
elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto a verificare. (Nella specie si
trattava di un compenso per prestazioni professionali rese in favore di un ente locale, in cui
veniva in contestazione la nullità per difetto di forma dell’atto; la S.C. ha ritenuto che,
dovendo stabilire se il compenso sia dovuto, attraverso l’utilizzazione del titolo negoziale, il
giudicante è tenuto a rilevare la nullità per difetto di forma anche d’ufficio, qualora non sia
stata denunciata dall’opponente, senza che ciò comporti la violazione dei principi della
domanda e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato).”(Cassazione civile, sez.
I, 21 dicembre 2007, n. 27088);
“Nell’opposizione a decreto ingiuntivo e nell’appello contro la sentenza che l’ha decisa, il
giudice, poiché l’opposto è in realtà attore che chiede di dare esecuzione al titolo posto a base
dell’ingiunzione, può sempre rilevare d’ufficio la nullità di tale titolo ai sensi dell’art. 1421
c.c., ancorché la contestazione della prova scritta addotta a fondamento del decreto sia fondata
su ragioni diverse, rientrando nei suoi compiti l’indagine in ordine alla sussistenza delle
condizioni dell’azione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha
confermato l’impugnata sentenza con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza
di primo grado di accoglimento parziale dell’opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo
con il quale era stato intimato ad un ricoverato in regime ospedaliero, che aveva richiesto la
fruizione di una camera a pagamento, anche la corresponsione dei compensi per le prestazioni
mediche in regime libero professionale, in virtù, però, di una clausola di cui era stata rilevata
d’ufficio la nullità perché violativa dell’art. 4, comma 10, del d.lg. n. 502 del 1992, della
quale l’opponente aveva addotto la illiceità in relazione alla sua vessatorietà).”(Cassazione
civile, sez. I, 31 agosto 2007, n. 18453);
“Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un
correntista, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto
stipulata in violazione dell’art. 1283 c.c., è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c.,
anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo
posto a fondamento della domanda degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del
giudice l’indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione; in tale giudizio,
infatti, il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l’opponente abbia
contestato l’ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo
utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, è tenuto a rilevare d’ufficio la
nullità dalla quale il negozio sia affetto.”(Cassazione civile, sez. I, 1 marzo 2007, n.
4853).
90
21. Motivi attinenti alla qualificazione giuridica.
L’impugnazione può aver per oggetto la qualificazione giuridica delle domande (o delle
eccezioni) proposte in causa che sia stata operata dal primo giudice e non sia condivisa
dall’appellante, che dalla diversa configurazione giuridica di domande ed eccezioni pretende
ritrarre un effetto favorevole alle proprie tesi49.
Si pensi, ad esempio:
• ad un attore che si è visto rigettare una domanda risarcitoria ricondotta alla matrice
dell’art.2043 c.c. per difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’agente e che
rimproveri al giudice di primo grado di non aver qualificato la domanda proposta
come fondata sulla responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell’art.2051 c.c.
(caratterizzata da un regime di responsabilità oggettiva),
• ovvero al fornitore di un bene in forza di un rapporto contrattuale ritenuto di appalto
da parte del primo giudice, che sia stato condannato alla garanzia contrattuale, previo
rigetto della sua eccezione di decadenza per omessa tempestiva denuncia dei vizi, che
sostenga che il rapporto doveva essere configurato come vendita, onde fruire dei più
ristretti termini per la denuncia dei vizi da parte dell’acquirente.
21.1. Il potere – dovere di preventiva qualificazione giuridica della domanda.
E’ il caso di rammentare che il giudice non dovrebbe mai esonerarsi dal dovere di
qualificazione giuridica della domanda, tanto più nell’ipotesi in cui il fondamento ne appaia
incerto o ambiguo e neppure per la ragione, apparentemente ispirata al principio generale di
economia processuale ed al suo corollario della regola della c.d. “ragione più liquida” secondo
cui, comunque, la domanda dovrebbe essere respinta.
La verifica della proposizione di una domanda giudiziale valida sotto il profilo della
“determinazione della cosa oggetto della domanda” e della “esposizione dei fatti ed degli elementi di diritto
costituenti le ragioni della domanda” deve essere compiuta d’ufficio e in via del tutto preliminare,
come dimostra la lettura dell’art.164 (in particolare, 4° e 5° comma) c.p.c., a tutela del principio
del contraddittorio.
Poiché l’ordinamento collega gli effetti del giudicato alla domanda introdotta nel giudizio (sia
pur con i possibili effetti estensivi al c.d. “deducibile”) appare, d’altra parte, evidente che
l’individuazione della domanda oggetto della decisione corrisponde ad una esigenza
imprescindibile di ordine pubblico, attinente alla determinazione dell’estensione del giudicato
che la legittimità di una diversa soluzione renderebbe del tutto evanescente ed incerta.
Si consideri poi che un ordinamento in cui campeggia quale principio generale il principio
dispositivo (cfr art.112 c.p.c.) esige la preventiva focalizzazione da parte del giudice del
contenuto delle pretese e delle eccezioni delle parti.
Ciò corrisponde ad una esigenza prima ancor logica che giuridica, poiché l’espressione
dell’opinione del giudice, in cui si concreta l’atto cognitivo del giudicare, postula ex se la
preventiva individuazione del suo oggetto attraverso l’esercizio del potere-dovere di
qualificazione giuridica delle domande e delle eccezioni delle parti.
Pertanto il giudice deve procedere in via preliminare alla qualificazione della domanda e se al
proposito nutre dei dubbi tali da ingenerare uno stato di insolubile incertezza, ai sensi del 4° e
5° comma dell’art.164 c.p.c., deve rilevare la conseguente nullità dell’atto introduttivo e fissare
un termine per la rinnovazione della citazione ovvero per l’integrazione della domanda
(qualora il convenuto si sia comunque costituito nel giudizio).
E’ anche ben noto che il Giudice ai sensi dell’art.112 c.p.c. è investito dal potere –dovere di
qualificazione giuridica della domanda, a prescindere dalla indicazioni normative carenti o
“Perché si abbia omessa pronuncia, per non avere il giudice di appello qualificato il contratto “inter partes” è indispensabile,
alternativamente, o che una tale qualificazione sia stata inutilmente sollecitata nel corso del processo di merito, o che la parte ricorrente
indichi quale sia il pregiudizio patito in conseguenza di tale omissione.”(Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2008, n. 8092).
49
91
errate formulate dalle parti alla luce del noto principio “ jura novit curia: narra mihi factum, dabo
tibi jus”:
o “L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del
merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di
legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero
contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua
formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte
intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte
stessa.”(Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751);
o “Al giudice compete soltanto il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di
attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti,
il “nomen iuris” al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice stesso può
interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e anche applicare una norma di legge
diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma, onde evitare di incorrere nel vizio di
ultrapetizione, deve lasciare inalterati sia il “petitum” che la “causa petendi”, senza
attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi
elementi di fatto..”(Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12402);
o “Il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non consente di
sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata su altra causa petendi, e dunque di
introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in
cui il giudice non può esaminare una questione neppure tacitamente proposta, perché non in
rapporto con quella espressamente formulata, e di quella non costituente antecedente logicogiuridico. (Nella specie, si è ritenuto sia incorso nel vizio di ultrapetizione il giudice d’appello
che, investito del gravame avverso sentenza di rigetto della domanda per il conseguimento
dell’indennità di espropriazione e del risarcimento del danno da fatto illecito, a seguito della
demolizione di un immobile resa necessaria dal fenomeno del bradisismo, condannando
l’appellato al pagamento di indennizzo per atto legittimo, non ha operato una mera
qualificazione della domanda, ma ha pronunciato su domanda diversa per causa petendi e
petitum).”(Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2006, n. 8519);
o “Al giudice compete soltanto il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di
attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle
parti, il “nomen iuris” al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice
stesso può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicare una norma
di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, ma, onde evitare di incorrere nel
vizio di ultrapetizione, deve lasciare inalterati sia il “petitum” che la “causa petendi”,
senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema
controverso nuovi elementi di fatto.”(Cassazione civile, sez. trib., 1 settembre 2004,
n. 17610);
o “Sono consentite dalla legge processuale le modificazioni della “causa petendi” che non
integrino domanda nuova, e cioè solo quelle che importano una diversa qualificazione o
interpretazione del fatto costitutivo del diritto; la introduzione di un diverso fatto
costitutivo della pretesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzione del
bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, essendo possibile che da una
sola situazione scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti propri e suscettibili
di formare oggetto di domande diverse, mentre può considerarsi virtualmente compresa
in quella originaria solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi,
per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la
domanda originaria, e diretta a precisarne o restringerne il “petitum”. “(Cassazione
civile, sez. I, 23 aprile 2004, n. 7766).50
50 Nello stesso senso: sez. I, 17 aprile
2007, n. 914; sez. II, 28 marzo 2007, n. 769; sez. II, 28 marzo 2007, n.
7579;”Cassazione civile, sez. I, 17 aprile 2007, n. 9143;sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11039; sez. III, 19 aprile 2006,
92
E’ così indubbio che il Giudice deve procedere al debito sforzo ermeneutico nella
interpretazione della domanda, in ciò non vincolato in modo rigido dalle espressioni utilizzate
dalle parti.
Si attaglia perfettamente alla materia in discussione un recente insegnamento del Supremo
Collegio:
• “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l’ipotesi in cui, in corso di causa, la parte
deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti introducendo così nuovi temi di indagine - dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa
ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della
domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non
incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della
domanda di risarcimento dei danni - ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale,
pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una
diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si
fonda.”(Cassazione civile, sez. III, 8 febbraio 2007, n. 2746).
Più in dettaglio nella richiamata pronuncia si legge:
“In tema di ultra o extrapetizione bisogna distinguere l’ipotesi in cui in corso di causa la parte deduca a
fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli dedotti precedentemente, introducendo altri temi di
indagine, dall’ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, ne dia una diversa qualificazione; nella
prima ipotesi si verifica mutamento della domanda con tutto quello che tale mutamento comporta; nella
seconda muta la qualificazione giuridica, mentre non muta la domanda che non subisce variazioni nei
suoi elementi essenziali.
Non incorre, pertanto, in extrapetizione il giudice che, fermi restando i fatti posti a fondamento della
domanda risarcitoria, ritenga la responsabilità a titolo extracontrattuale, pur avendo la parte dedotto che il
risarcimento è a titolo contrattuale, in quanto si limita a dare una diversa qualificazione della domanda senza
alcun mutamento dei fatti sui quali si fonda.
L’ipotesi è riconducibile a quella in cui il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una
ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti ed all’applicazione di una norma
diversa da quella da esse invocata (Cass. 12.10.1999, n. 1455) ovvero proceda ad una qualificazione
giuridica diversa rispetto a quella adottata dalla parte, sempre che tale diversa qualificazione non si
risolva nella sostituzione dell’azione espressamente o virtualmente proposta con altra fondata su fatti
diversi o su una diversa “causa petendi” (Cass. 15.5.2001, n. 6712).”
Nessuno, per esempio, così potrebbe dubitare che nel caso paradossale di un atto in cui l’attore
Tizio richieda una somma di denaro al convenuto Sempronio, che accusa di avergli procurato
delle lesioni fisiche con una condotta negligente ed imprudente, invocando, del tutto fuor di
luogo, quali referenti normativi, disposizioni del tutto inconferenti come l’art.1218 ovvero
l’art.2028 c.c., il giudice investito della questione (magari dopo aver umilmente represso, in
adempimento del dovere di continenza verbale, un naturale moto di sarcasmo verso un
difensore così sprovveduto) debba pur sempre esaminare la domanda, nell’esercizio dei poteri
di qualificazione giuridica della pretesa, sotto il profilo dell’art.2043 c.c., di cui siano stati
dedotti nell’atto tutti gli elementi costitutivi (fatto materiale antigiuridico, elemento soggettivo,
evento dannoso, nesso causale fra il fatto e l’evento).
Al contrario, allorché Tizio richieda al convenuto Sempronio il pagamento di una somma di
denaro prospettando di aver con lui concluso un contratto che a ciò l’obbligava, non potrà il
giudice, che ritenga per qualche ragione il contratto invalido o inesistente, condannare
Sempronio a rifondere l’ingiusto arricchimento da lui conseguito, di cui gli sembri di scorgere i
presupposti, senza con ciò ledere il principio dispositivo, dal momento che Tizio non ha mai
dedotto in giudizio tutti gli elementi costitutivi dell’azione di cui all’art.2041 c.c. (arricchimento,
impoverimento, consequenzialità e interdipendenza fra i due flussi economici, insussistenza di
n. 9087; sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3980; sez. II, 20 febbraio 2004, n. 3366; sez. III, 24 giugno 2003, n. 10009;
sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9652;sez. I, 4 giugno 2002, n. 8057; sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1289.
93
causa giustificatrice, mancanza di specifico rimedio), così soddisfacendo l’onere della
proposizione della domanda e provocando l’esplicazione del contraddittorio.
In siffatta situazione non sono ammessi ribaltamenti di posizione attuati tramite l’invocazione,
che nel caso appare fuor di luogo, del principio “jura novit curia”, che pur sempre presuppone
la formulazione di una domanda con la deduzione dei relativi fatti costitutivi e consente al
giudice di accoglierla sulla base di ragioni di diritto diverse da quelle esplicitamente prospettate
dall’interessato.
E’ evidente che tale ipotesi non ricorre allorché la stessa parte, a tanto provocata
dall’avversario o dal giudice nell’esplicazione del contraddittorio processuale, chiarisca
espressamente il titolo della propria domanda (puntualizzando ad esempio, che la stessa si
fondava sull’inadempimento contrattuale
e non già sulla generica responsabilità
extracontrattuale, o viceversa), così orientando inequivocamente il thema decidendum.51
In siffatta ipotesi non sussiste la res dubia che meriti alcun approfondimento interpretativo da
parte del giudice e sussistono, di contro, prepotenti ragioni di protezione dell’affidamento
ingenerato nelle controparti (ragioni
che corrispondono, fra l’altro, a interessi
costituzionalmente tutelati dagli artt.24 e 111 della Costituzione).
21.2. I contrasti giurisprudenziali circa la possibilità di riqualificazione giuridica della
domanda da parte del giudice di appello in difetto di proposizione di specifico motivo.
Una delle questioni meno chiare è se il giudice di appello possa procedere ad una diversa
qualificazione giuridica della fattispecie in difetto di proposizione di rituale motivo di appello
in tal senso, alla stregua del principio “jura novit curia”, o se invece tale operazione sia preclusa
per la formazione di un vero e proprio giudicato interno sul punto.
La giurisprudenza della Suprema Corte oscilla (in modo apparentemente inconsapevole) fra le
due posizioni, affermando ora l’uno, ora l’altro principio, senza alcun apparente sforzo di
coordinamento e di riconduzione ad unità delle due impostazioni, talora addirittura prospettate
come le uniche consolidate.
Non resta che dar conto dei due orientamenti contrapposti.
A) Nel senso della formazione del giudicato interno sulla qualificazione giuridica con la
conseguente impossibilità per il giudice dell’impugnazione di riconfigurare la fattispecie in
difetto di motivo di appello sul punto:
• “L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse
ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art.
100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale
accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicché è inammissibile,
per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche,
sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni
proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella
specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il
51 Un esempio tratta da concreta esperienza giudiziaria.
La parte attrice agisce chiedendo all’Ente proprietario di una strada i danni subiti in conseguenza di un sinistro
stradale occorsole alla guida di un veicolo per l’inopinata presenza di un ostacolo sulla carreggiata. La controparte
contesta la mancanza di indicazione della causa petendi e la conseguente nullità della domanda, non essendo
comprensibile se l’attore faccia valere una responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.2051 c.c. ovvero una
responsabilità ai sensi dell’art.2043 c.c. con riferimento al principio generale del neminem laedere e alla figura
sintomatica della “insidia o trabocchetto”.
L’attore (probabilmente indotto dallo sfavore giurisprudenziale dell’epoca per l’applicabilità dell’art.2051 c.c. alle
strade pubbliche) puntualizza che la sua domanda era fondata sull’art.2043 c.c.
Il Giudice rigetta la domanda attorea nel merito e l’attore appellante impugna invocando l’art.2051 c.c. (nel
frattempo “riabilitato” dal ripensamento della Cassazione in tema di custodia dei beni demaniali), sostenendo che
il Giudice di primo grado avrebbe dovuto interpretare la sua domanda con riferimento all’art.2051 c.c.,
nonostante la sua stessa dichiarazione contraria provocata dalla controparte.
94
•
•
•
•
quale, in relazione ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, si censurava l’omessa pronuncia
da parte del giudice di appello sulla applicazione del termine di decadenza previsto dall’art. 24 l. n. 46
del 1999, in luogo di quello previsto dall’art. 617, comma 1, c.p.c., senza però che fosse impugnata la
statuizione resa dallo stesso giudice in punto di inammissibilità dell’appello avverso la pronuncia di
nullità della notificazione della cartella esattoriale da parte del giudice di primo grado, resa sul
presupposto della qualificazione della domanda in termini, appunto, di opposizione agli esecutivi ed
ormai passata in giudicato).”(Cassazione civile, sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13373);
“Soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di riproporre con appello
incidentale le domande od eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla
presunzione di rinuncia di cui all’art. 346, c.p.c., può limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta
e nelle successive difese, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; la parte che sia rimasta
soccombente su di una questione preliminare - qual è la qualificazione giuridica di un contratto rispetto
all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di adempiere, quando tale qualificazione abbia
condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito - ha invece l’onere di proporre
appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla questione preliminare del giudicato (cosiddetto
giudicato implicito), che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico –
giuridico della decisione.”(Cassazione civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126);
“Ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più
domande, fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia
accolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la
qualificazione giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma
comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda
principale, e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l’attore, per evitare la
formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l’onere di impugnare, non solo il rigetto
della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata,
condizionandolo all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo
potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a
fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Nella specie
l’attore aveva proposto una domanda, principale, di condanna dell’assicuratore al pagamento
dell’indennizzo per i danni subiti a seguito dell’incendio occorso alla cosa assicurata, nonché una
domanda, subordinata, di restituzione della quota del premio relativo al periodo non assicurato, e nel
quale il sinistro si era verificato, a seguito di recesso della compagnia convenuta dal contratto di
assicurazione, in conseguenza alla denunzia di altro, precedente sinistro; accolta dal giudice d’appello
la domanda subordinata e respinta quella principale, l’attore aveva proposto ricorso per cassazione,
senza impugnare il capo della sentenza relativo alla restituzione del premio per il periodo non
assicurato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l’inammissibilità del
ricorso per cassazione, essendosi formato, per la mancata impugnazione dell’accoglimento della
domanda subordinata, il giudicato sul punto che, per effetto del recesso dell’assicuratore, il ricorrente
non aveva copertura assicurativa nel periodo nel quale si era verificato il sinistro, oggetto della
domanda principale, e difettando quindi nella specie il requisito, necessario anche con riguardo
all’impugnazione, dell’interesse ad agire).”(Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2003, n.
9631);
“Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice quando tale
qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte
interessata abbia omesso di impugnarla in appello.”(Cassazione civile, sez. II, 7 agosto 1996,
n. 7260);
“In caso di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, indipendentemente da talune
diversità consistenti nella ripartizione dell’onere della prova, nella prevedibilità del danno, quale limite
al danno risarcibile in sede contrattuale e nella durata della prescrizione, la pretesa risarcitoria, per
essere fondata sugli stessi elementi genetici (oggettivi e soggettivi), dà luogo ad un’unica “causa petendi”,
si da far ritenere esercitate entrambe le azioni; pertanto, rigettata in primo grado la pretesa risarcitoria
sul piano contrattuale, deve escludersi che si sia formato il c.d. giudicato interno, qualora
95
l’impugnazione poggi sugli stessi elementi di fatto e sull’invocazione della disciplina in tema di
responsabilità aquiliana, già evocata con l’atto introduttivo del giudizio (nella specie, in relazione ad
un’azione a sostegno della quale era stata dedotta la violazione di un obbligo, tanto contrattuale,
quanto extracontrattuale, il giudice d’ appello aveva ritenuto coperta dal giudicato interno la questione
afferente la qualificazione giuridica dell’azione promossa, risulta nel senso di ritenere prescritto, per
decorso dell’ordinario termine decennale, il diritto al risarcimento dei danni; la cassazione, rilevando
come l’attore, nell’impugnare la decisione di primo grado, avesse continuato ad invocare le norme sulla
responsabilità extracontrattuale, si è valsa del suesposto principio per cassare la sentenza del giudice di
seconde cure).”(Cassazione civile, sez. lav., 5 ottobre 1994, n. 8090);
• “Anche sulla qualificazione giuridica data all’azione del giudice si forma il giudicato, quando tale
qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte
interessata abbia omesso di impugnarla in appello.”(Cassazione civile, sez. II, 17 dicembre
1993, n. 12499).
• “Qualora, rigettata la domanda, si sia formato il giudicato sulla qualificazione dell’azione e le parti
accettino sul punto la decisione omettendo di impugnarla e impostando le loro difese sul presupposto di
quella qualificazione, il giudice di appello, in forza del principio “tantum devolutum quantum
appellatum”, non può esaminare di ufficio la detta questione, essendo i suoi poteri connessi ai motivi di
impugnazione. (Nella specie il primo giudice, qualificata l’azione proposta azione di risoluzione per
inadempimento di un contratto di appalto, l’aveva rigettata non avendo ravvisato i dedotti profili di
inadempimento e le censure dell’appellante si erano mosse sempre nello schema dell’inadempimento,
deducendo il ritardo nella consegna e l’inidoneità dell’opera. Avendo, per contro, il giudice di appello
accolto la domanda sotto il profilo di cui all’art. 1662 c.c., la Suprema Corte ha cassato una tale
pronuncia, atteso che l’azione derivante dalla operatività dell’art. 1662 c.c. è non solo ontologicamente
diversa da quella di inadempimento, in quanto basata su diversi presupposti di fatto e di diritto
incidenti sul permanente del vincolo contrattuale, ma conduce a una pronuncia di natura dichiarativa
affatto diversa da quella costitutiva di risoluzione e basata sull’esercizio di un diritto potestativo mai
dedotto nella specie dal contraente che aveva impugnato il contratto).”(Cassazione civile, sez. II,
28 marzo 2007, n. 7690);
In particolare in tale sentenza si legge:
“Con giurisprudenza altrettanto costante di questa Corte si è ritenuto che il giudicato può formarsi anche sulla
qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, quando essa abbia segnato l’impostazione difensiva di tutte
le parti nel giudizio di merito e la decisione finale sia intervenuta nel solco di tale impostazione, senza che la(e)
parte(i) interessata abbia(no) proposto impugnazione sul punto della qualificazione dell’azione (Cass. civ., Sez.
III, 07/11/2005; n. 24028/2004; n. 15859/2002; n. 21490 Cass. civ., Sez. II, 18/04/2001, n.
5702; Cass. civ., Sez. II, 07/08/1996, n. 7260; Cass. civ., Sez. II, 17/12/1993, n. 12499).
2.c. Il giudicato sulla qualificazione giuridica dell’azione può formarsi anche in caso di rigetto della domanda
costituiva (come, nella specie, quella di risoluzione del contratto) poiché la pronunzia, in tal caso, coinvolge
comunque il rapporto giuridico complessivo dedotto in giudizio e di cui sia stata chiesta la costituzione, la
modificazione o l’estinzione, e l’ambito del giudicato va determinato non solo in riferimento all’oggetto della
controversia ed alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito) ma anche con riguardo agli accertamenti
che siano necessariamente ed inscindibilmente collegati alla decisione della quale costituiscono il presupposto,
sicché la cosa giudicata si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza ma anche
sulle affermazioni che si presentino come il presupposto logico giuridico della soluzione adottata (Cass. II,
11022/91). Ne deriva che nel caso di richiesta di sentenza costitutiva di risoluzione di un contratto, il
mancato accoglimento della domanda, a seguito della relativa indagine sui presupposti dell’inadempimento,
preclude, in mancanza di gravame sulla qualificazione dell’azione, la successiva impugnativa dello stesso
contratto, fondata su presupposti di fatto e ragioni sostanziali diversi e conducenti ad un effetto giuridico diverso
da quello azionato, come la risoluzione di diritto, tranne il caso della nullità, che può essere pronunziata anche
d’ufficio, ove ne ricorrano i presupposti di sussistenza e rilevabilità. Quanto alla violazione degli artt. 112 e
345 c.p.c., il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va
coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che, con riferimento
all’appello, deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d’ufficio la qualificazione ritenuta dal
96
primo giudice, in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato (Cass. 9621/2001).
La formazione del giudicato sulla qualificazione dell’azione, invero, comporta che qualora le parti accettino sul
punto la decisione, omettendo di impugnarla e impostando le loro difese sul presupposto di quella qualificazione,
il giudice d’appello, in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum, non può esaminare d’ufficio
la detta questione essendo i suoi poteri connessi ai motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. II, 18/10/1991,
n. 11022).
3. In particolare, si ha vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., quando il giudice, interferendo nel potere
dispositivo delle parti, lungi dal limitarsi a qualificare l’azione, secondo il principio da mihi factum dabo tibi
ius, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo
(o negando) a taluna di esse un bene diverso o sostituendo l’azione, espressamente e formalmente proposta, con
una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo
di un titolo dissimile da quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagine (ex multis
Cass. 3670/96).
• “Il potere - dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va
coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice
dell’appello di mutare d’ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in
presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di appello che, nel pronunciare in ordine alla domanda di rimborso di somme pagate a titolo
d’imposta comunale su un passo carrabile, proposta dai proprietari di un immobile nei confronti del
conduttore, aveva ritenuto non vincolante la qualificazione giuridica adottata dal giudice di primo
grado, che aveva ricondotto la fattispecie all’indebito soggettivo, inquadrandola, pur in assenza di
un’espressa
censura
da
parte
dell’appellante,
nello
schema
dell’ingiustificato
arricchimento).”(Cassazione civile, sez. III, 12 luglio 2005, n. 14573);
In particolare in tale sentenza si legge:
“In termini opposti rispetto a quanto, del tutto apoditticamente affermato dal giudice di secondo grado - e in
conformità a un insegnamento giurisprudenziale di questa Corte più che consolidato che nella specie deve,
ulteriormente, ribadirsi - si osserva che il potere dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi
successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni.
Deve ritenersi, pertanto, precluso al giudice dell’appello di mutare d’ufficio - violando il principio della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di
gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione (Cass. 12 novembre
2002, n. 15859; Cass. 16 luglio 2001, n. 9621; Cass. 15 maggio 2001, n. 6712; Cass. 22 novembre
1999, n. 12947).”
B) Nel senso del potere del giudice di appello di procedere ad una diversa configurazione
giuridica della fattispecie in difetto di motivo di appello sul punto, nell’esercizio dei poteri di
applicazione del diritto riassunti nella formula “jura novit curia”.
• “Il giudice d’appello può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da
quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di
inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche
in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti,
purché nell’ambito delle questioni riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il
“petitum” e la “causa petendi” e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di
fatto.”(Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26514);
• “Poiché la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere
qualificazioni giuridiche, devolute al giudice, dei fatti che il datore di lavoro ha posto a base del recesso,
la impugnazione della sentenza di primo grado che ha dichiarato la legittimità o illegittimità del
licenziamento per sussistenza o insussistenza della giusta causa comprende la minor domanda relativa
alla declaratoria della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ed abilita il
giudice di appello a pronunciarsi in tal senso anche in mancanza di espressa richiesta della parte,
97
•
•
•
•
•
senza che vi sia lesione dell’art. 112 c.p.c.”(Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2008, n.
837);
“In tema di contenzioso tributario, allorché il contribuente eccepisca, sin dal primo grado, la decadenza
dell’Amministrazione dal potere di riscossione, facendo riferimento ad un termine intermedio (nella
specie, quello di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973), il giudice di appello che accerti e dichiari
la tardività della notifica della cartella esattoriale non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta,
limitandosi a qualificare in termini giuridici diversi la formulata deduzione di decadenza, sulla base di
circostanze di fatto già acquisite agli atti di primo grado ed indiscusse.”(Cassazione civile, sez.
trib., 28 gennaio 2008, n. 1838):
“Il giudice d’ appello può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da
quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di
inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche
in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti,
purché nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il
“petitum” e la “causa petendi” e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Il
principio è stato applicato dalla S.C. nel caso di domanda di pagamento proposta con riguardo ad un
contratto plurilaterale - stipulato da un terzo con la parte appellata ed a favore dell’appellante – invece
qualificato dal giudice d’ appello come delegatio promittendi, a seguito della quale l’appellata si era
obbligata verso l’appellante ad adempiere ad un’obbligazione gravante sul terzo).”(Cassazione
civile, sez. I, 11 settembre 2007, n. 19090);
“Il giudice di appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa
da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al
fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili e incorre nel vizio di extrapetizione
qualora pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni
non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o
diverso da quello domandato. Il giudice di appello, pertanto, può, con il solo limite di non esorbitare
dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione, accogliere il gravame per ragioni giuridiche diverse
da quelle dedotte dall’appellante, quando queste ultime non si configurino come eccezioni in senso
proprio, ma attengano semplicemente agli elementi integrativi della fattispecie, alla qualificazione
giuridica e agli effetti del rapporto controverso.”(Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2007, n.
7980);
“In tema di risarcimento dei danni, l’indicazione da parte dell’attore, e la conseguente applicazione in
primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente,
e correttamente individuato in secondo grado, non comporta la formazione di un giudicato implicito,
trattandosi della mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta
risarcitoria, e non avendo l’attore, totalmente vittorioso in primo grado, l’onere di proporre appello
incidentale al fine di prospettare la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo
grado sul piano fattuale, sia riconducibile ad una diversa fonte, in quanto rientra nel potere ufficioso
del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la
domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha escluso che ricorresse la violazione del giudicato in un giudizio di risarcimento dei danni in cui
il giudice di appello aveva inquadrato la fattispecie nell’art. 2051 c.c., in tal modo mutando, in
assenza di appello incidentale, la qualificazione giuridica proposta dall’attore ed accolta dal giudice di
primo grado, che aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c.).”(Cassazione civile, sez. III, 5
settembre 2005, n. 17764);
“L’inidoneità in astratto di un fatto a produrre un effetto giuridico ovvero l’inesistenza di una norma
che al fatto associ l’effetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del
giudicato interno. Poiché, con riguardo allo schema “fatto - norma - effetti”, è esclusivamente quella
dell’esistenza dei tre termini di questa relazione, la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta
da giudicato - sia per l’appello, sia per il ricorso per cassazione (salva per quest’ultimo l’ovvia
esclusione di nuovi accertamenti di fatto) - con riferimento alla fattispecie “prescrizione” la statuizione
sulla quale può formarsi il giudicato è quella avente ad oggetto l’inerzia del titolare e l’idoneità concreta
98
della stessa ad estinguere il diritto. Tale statuizione è, tuttavia, sottratta al giudicato qualora siano
stati dedotti fatti impeditivi della prescrizione anteriori o contestuali ad essa e quindi tali da inibire
l’insorgenza dell’effetto estintivo. In tal caso non vi è quindi alcun ostacolo all’esercizio, da parte del
giudice dell’impugnazione - anche di legittimità - del potere dovere di rilevare d’ufficio l’inidoneità in
astratto del fatto (inerzia del titolare) a determinare l’effetto estintivo. (In base a questi principi la
S.C. - in un caso di espletamento di mansioni non corrispondenti alla qualifica professionale - dopo
aver escluso che si fosse formato il giudicato interno sull’affermazione del giudice di appello della
prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, negando
la configurabilità di un diritto alla qualifica suscettibile, come tale, di prescriversi e deducendone la
riconoscibilità del diritto alle rivendicate differenze retributive, nei limiti della prescrizione
quinquennale).”(Cassazione civile, sez. lav., 29 ottobre 1998, n. 10832).
• “Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della
decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia,
l’oggetto della pronuncia del giudice è costituito esclusivamente dall’attribuzione (o dalla non
attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma sull’accoglimento o sul rigetto della
domanda, e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; ne
consegue che, impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell’impugnazione non è in alcun modo
vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti. (Nella
specie la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza
del giudice d’ appello che aveva rigettato la domanda proposta per ottenere il
rifacimento delle parti in pelliccia di un capo di abbigliamento, riqualificando come
contratto d’opera e non come compravendita il contratto intercorso tra le
parti).”(Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7620; in senso sostanzialmente
conforme alla prima parte della massima: Cass. 13 luglio 2004 n. 12911; Cass. 29
ottobre 1993 n. 10771).
In particolare in tale sentenza si legge:” E’ giurisprudenza di questa Corte che, quando la qualificazione
giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione
formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l’oggetto della pronuncia del giudice è costituito
esclusivamente dalla attribuzione o dalla non attribuzione del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma
sull’accoglimento o sul rigetto della domanda e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente
logiche della decisione; con la conseguenza che, se viene impugnata la pronuncia di merito, il giudice
dell’impugnazione non è in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla
qualificazione giuridica dei fatti (cfr. sent. n. 10.771/1993). Nel caso in esame, considerato anche il contenuto
della pretesa dell’attrice riportato nella sentenza impugnata, il giudice d’appello non ha mutato la domanda, ma
si è limitato a qualificare correttamente la pretesa fatta valere in giudizio dalla Pomponio, traendone le
conseguenze. Inoltre sussiste vizio di extrapetizione soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti
delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non
rilevabili di ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato,
mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta
dalla parte. Tale compito appartiene non soltanto al giudice di primo grado, ma anche a quello d’appello, che
resta a sua volta libero di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data
in prime cure con riferimento all’individuazione della causa petendi, dovendosi riconoscere a detto giudice il
potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio, onde precisarne il contenuto e gli effetti
in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste delle parti e di non
introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame (cfr. Cass. n.
12.471/2001 e n. 10.009/2003)”.
22. Motivi in fatto: valutazione delle prove acquisite.
La categoria dei motivi in fatto che attiene alla valutazione da parte del giudice di primo grado
delle prove acquisite riguarda forse l’ipotesi statisticamente più ricorrente di motivi di appello,
nella quale l’appellante lamenta che il giudicante non abbia fatto buon governo dei poteri
riconosciutigli dagli artt.115 e 116 c.p.c. ed invoca una diversa valutazione da parte del giudice
99
di appello (che pur sempre è giudice del merito, titolare di un autonomo potere di
apprezzamento del fatto).
Se ne propone un elenco solo esemplificativo, ovviamente senza pretesa di esaustività:
a. l’appellante lamenta che il giudice abbia mal ricostruito uno o più fatti rilevanti sulla
base delle deposizioni testimoniali di alcuni testi, da ritenere viceversa inattendibili;
b. l’appellante lamenta che il giudice abbia mal ricostruito uno o più fatti rilevanti sulla
base delle deposizioni testimoniali di alcuni testi, ingiustificatamente preferite a quelle
di altri testi di segno contrario;
c. l’appellante lamenta che il giudice non abbia tenuto conto delle risposte della
controparte in sede di interrogatorio formale, integranti confessione giudiziale, ovvero
di uno specifico documento da questa proveniente, configurante confessione
stragiudiziale;
d. l’appellante lamenta che il giudice non abbia tenuto conto di uno scritto difensivo
della controparte che ammetteva in corso di causa un fatto inizialmente controverso;
e. l’appellante lamenta che il giudice non abbia effettuato un ragionamento presuntivo,
fondato su una serie di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti che avrebbero
giustificato la deduzione di un fatto ignoto la cui prova era a suo carico;
f. l’appellante lamenta che il giudice abbia effettuato un ragionamento presuntivo,
fondato su una serie di elementi indiziari, che non erano gravi, precisi e concordanti,
pervenendo alla deduzione di un fatto ignoto la cui prova era a carico della sua
controparte;
g. l’appellante lamenta che il giudice non abbia desunto argomenti di prova a carico del
suo avversario ai sensi dell’art.116 c.p.c. dalle risposte da questi date in sede di
interrogatorio libero o dal complessivo suo contegno processuale;
h. l’appellante lamenta che il giudice abbia desunto argomenti di prova a suo carico ai
sensi dell’art.116 c.p.c. da circostanze che non meritavano siffatto rilievo;
i. l’appellante lamenta che il giudice abbia posto a fondamento della decisione nozioni di
fatto non adeguatamente provate che non rientravano nel patrimonio della comune
esperienza;
j. l’appellante lamenta che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione
nozioni di fatto che rientravano nel patrimonio della comune esperienza;
k. l’appellante lamenta che il giudice abbia ritenuto erroneamente controverso un fatto
da ritenersi pacifico in causa;
l. l’appellante lamenta che il giudice abbia ritenuto pacifico in causa un fatto che invece
doveva ritenersi controverso52.
Va tenuta presente al proposito – anche prima della generalizzazione dell’istituto apportata dalla Novella del
2009 con il nuovo testo dell’art.115 c.p.c. - la moderna lettura giurisprudenziale del disposto dell’art.167 c.p.c. che
impone al convenuto in comparsa di risposta di proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti
dall’attore a fondamento della sua domanda, nonché ai sensi dell’art.116, 2° comma, c.p.c. (che consente al
Giudice di trarre argomenti di prova dal generale contegno processuale della parte).
La giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass.civ. Sez.III 25.5.2004, n.10031 (peraltro influenzata
dall’insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n.761 del 2002, dettato in materia di processo del lavoro
ma con la formulazione di considerazione estese anche al processo civile ordinario e all’art.167 c.p.c.) ha
sostenuto che “L’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla
controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del
giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà
ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.”
Da ultimo “ L’art. 167, comma 1 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti
dall’attore a fondamento della domanda, dà della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del
fatto non contestato o dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua
dell’esposta regola di condotta processuale espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini la mancata
contestazione, a fronte di un onere implicitamente imposto dal dettato legislativo rappresenta, in positivo e di per sé, l’adozione di una
linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso.”(Cassazione civile, sez. III,
21 maggio 2008, n. 13078; conforme sez.III 25.5.2007 n.12231 e a contrario sez.III 8.6.2004 n.10815).
52
100
23. Motivi attinenti alla mancata disposizione, integrazione, rinnovazione della c.t.u.
Sono assai frequenti nei giudizi di appello le deduzioni di motivi di carattere istruttorio che
gravitano in ordine alla consulenza tecnica d’ufficio:
a. talora l’appellante si lamenta che una consulenza tecnica d’ufficio che egli reputava
utile o addirittura necessaria non sia stata disposta (mancata disposizione c.t.u.);
b. talora l’appellante si lamenta che all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta in
primo grado non siano stati richiesti al c.t.u. i chiarimenti, le precisazioni o integrazioni
che egli aveva richiesto o che sarebbero stati comunque necessari (mancata
integrazione c.t.u.);
c. talora, infine, l’appellante si lamenta che la consulenza tecnica d’ufficio fosse
gravemente viziata da errori, imprecisioni, carenze di indagini, incompetenza del perito
e sollecita la completa rinnovazione delle operazioni peritali (mancata rinnovazione
c.t.u.)
d. ovvero nella stessa ipotesi richiede al giudice di appello una diversa valutazione della
fattispecie correggendo ex officio gli errori commessi dal perito (mancata correzione
della valutazione peritale).
23.1. I principi generali in tema di rapporti fra giudice e c.t.u.
Per orientarsi è opportuno tener presenti i principi fondamentali in tema di rapporti fra il
giudice e il consulente tecnico di ufficio.
Innanzitutto occorre tener presente che, come si suole dire con una risalente locuzione
riassuntiva, il giudice è peritus peritorum, ossia non è vincolato dalle valutazioni operate dal
proprio consulente, che non possiedono una efficacia vincolante e che possono essere
tranquillamente disattese in sede di decisione:
“Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli
accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni,
giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito.” (Cassazione civile sez.
I, 20 luglio 2001, n. 9922)
“Nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale é consentito
al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal
consulente tecnico d’ufficio; e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie,
sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni
tecniche; in ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice é quello di un’adeguata motivazione,
esente da vizi logici ed errori di diritto.”(Cassazione civile sez. III, 18 novembre 1997, n.
11440).
Tuttavia la decisione contrastante con le indicazioni provenienti dalla c.t.u. deve essere
congruamente motivata:
•
“Il giudice, allorquando intenda discostarsi dalle considerazioni del consulente tecnico
d’ufficio, deve adeguatamente motivare le sue valutazioni ed i suoi apprezzamenti e non
può limitarsi alla mera affermazione di principi tecnici, di cui non sia indicata la fonte e non
sia pertanto possibile verificare congruità ed esattezza e che non siano sorretti da
ragionamento idoneo a spiegarli, ragionamento non ravvisabile nella semplice valutazione di
“evidenza”.”(Cassazione civile sez. I, 11 dicembre 1999, n. 13863);
•
“Le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può
legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle
risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in
particolare gli elementi di cui si é avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il
consulente si é basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti
logico - giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. In
materia di valutazione di immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio
101
o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, qualora ritenga inaccettabili i
criteri adottati dal consulente, può disattenderne le conclusioni facendo, ad esempio,
riferimento alla stima amministrativa, quale indice di valutazione idoneo, insieme alle altre
emergenze di causa, alla determinazione dell’indennità, ma non può apoditticamente
affermare l’eccessività del valore venale, come accertato dal consulente
tecnico,
sostituendolo un altro valore ritenuto, semplicemente, equo. “(Cassazione civile sez. I,
14 gennaio 1999, n. 333).
In caso di acquisizione, nello stesso grado del giudizio o in gradi differenti, di due diversi
elaborati di consulenza tecnica d’ufficio il giudice può tranquillamente aderire all’una o
all’altra delle due relazioni, motivando adeguatamente il proprio convincimento, e ciò in tutto
o in parte (sicché, ad esempio può recepire solo parzialmente le indicazioni rivenienti da un
elaborato, integrandolo in un certo punto con le indicazioni provenienti dall’altra relazione, su
quel punto ritenuta più convincente):
• “Se nel corso del giudizio di primo grado siano stati nominati, in tempi successivi, due
consulenti d’ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice di
appello (come quello di primo grado) può seguire il parere dell’uno o dell’altro o anche
discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante
l’enunciazione dei criteri probatori degli elementi di valutazione specificamente seguiti e
salva, peraltro, l’esperibilità di un’ulteriore indagine tecnica, la quale é opportuna, se non
addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già
espletate.”(Cassazione civile sez. lav., 8 giugno 1996, n. 5345);
• “Il giudice del merito, in presenza di un rilevante contrasto tra più consulenze tecniche
d’ufficio, disposte ed espletate nel corso del processo, può ben seguire le conclusioni dell’una o
dell’altra, ma é tenuto a fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del
convincimento raggiunto, enunciando gli elementi probatori, i criteri di valutazione, nonché gli
argomenti logici e giuridici che lo hanno indotto alla scelta. Siffatto obbligo deve ritenersi
ancor più cogente e rigoroso quando la preferenza sia accordata alla consulenza espletata per
prima, sulle cui conclusioni quella successiva, dalla quale ci si discosta, abbia già portato il
proprio ragionato esame critico.” (Cassazione civile sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1146);
• “Il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio dallo stesso nominato, lo stesso non e’ tenuto ad una
particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con
l’indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, e’ applicabile
anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano
state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d’ufficio alle difformi
conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire; anche in questo caso, infatti,
e’ sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere
implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le
argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente esposta. Però
difetta di motivazione la sentenza che aderisca all’una o all’altra consulenza senza
evidenziare le ragioni della scelta operata ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni
peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente talune, senza
esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre.” (Cassazione civile sez. lav., 17
gennaio 1998, n. 418).
Si suole inoltre sostenere che non è necessaria una particolare motivazione nel caso il giudice
ritenga di seguire l’opinione espressa dal proprio consulente.
Tale (comodo) principio (che si giustifica solo per l’implicita relatio istituita fra motivazione
della sentenza e motivazione del parere peritale) viene spesso invocato fuor di luogo: è infatti il
caso di puntualizzare che l’operazione semplificatrice non è consentita allorché la valutazione
peritale sia stata sottoposta ad una serrata, precisa e specifica critica, nel qual caso la
motivazione non può arrestarsi ad una generica dichiarazione di consenso, ma deve affrontare
le analitiche censure sollevate dalle parti.
102
Da ultimo:
• “Allorché ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un
consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della
sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del
propri consulente, ove questi a sua volta non si sia fato carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360
n. 5 c.p.c.).”(Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10688);
• “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con
l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle
contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che
tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso
in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360
n. 5 c.p.c.”(Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355);
• “È affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, di fronte a circostanziate critiche mosse
dal perito di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, non le abbia in alcun modo prese
in considerazione e si sia invece limitata a far proprie le argomentazioni svolte dall’ausiliare del
giudice.”(Cassazione civile, sez. III, 1 marzo 2007, n. 4797);
• “Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non
siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle
indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può, invece,
esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano
specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata..”(Cassazione
civile, sez. I, 20 maggio 2005, n. 10668);
• “Qualora il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il
giudice di appello può pervenire a valutazioni con quelle divergenti, purché - in presenza di specifiche
censure sulle modalità dell’accertamento adottate nell’espletamento dell’incarico o sull’iter logico seguito
nell’elaborazione delle risposte ai quesiti - dia conto, con adeguata motivazione, delle fonti e delle
ragioni di natura scientifica e tecnica poste a base del suo convincimento che non può fondarsi su
cognizioni particolari o soggettive tratte dalla scienza individuale del giudice, non annoverabili
nell’ambito del fatto notorio di cui all’art. 115 c.p.c.”(Cassazione civile, sez. II, 12 settembre
2003, n. 13426);
• “Il giudice di merito, nella motivazione della sentenza, non è tenuto ad esaminare analiticamente i
rilievi mossi da una delle parti alla relazione del Ctu, ma può limitarsi a richiamare quest’ultima, se
in essa i suddetti rilievi trovano adeguata ed idonea confutazione.”(Cassazione civile, sez. lav., 14
maggio 2003, n. 7485);
• “Quando il giudice di merito ritenga di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è
tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con
l’indicazione, come fonte del proprio convincimento, della relazione di consulenza, anche nel caso in cui
le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una
successiva consulenza tecnica d’ufficio, alle cui conclusioni il giudice di merito ritenga di aderire. Anche
in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per
ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le
argomentazioni e i conclusivi rilievi esposti nella precedente consulenza.”(Cassazione civile, sez.
lav., 9 gennaio 2003, n. 125).
E’ pacifico che il giudice possa disporre d’ufficio la consulenza tecnica d’ufficio, così come
possa disattendere la richiesta in tal senso proposta da una o più parti, alla sola condizione di
assicurare la coerenza logica della propria decisione:
103
•
•
•
•
•
•
“La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla
disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel
suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la
motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata
dal suddetto giudice. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un giudizio riguardante la
responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, ha rilevato l’inammissibilità della relativa
censura prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione della c.t.u., avendo i giudici del merito
dimostrato, con adeguata e logica motivazione, la superfluità di un accertamento tecnico circa la
“dinamica” del sinistro, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti, soprattutto
rilevandosi che, nel caso in esame, non si trattava tanto di valutare una questione per la quale era
necessario il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma di esporre un apprezzamento giuridico sulla
responsabilità dei conducenti di due veicoli che erano venuti in collisione tra di loro, alla luce di
circostanze obiettivamente emergenti)”(Cassazione civile, sez. III, 2 marzo 2006, n. 4660);
“Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l’istanza di ammissione
di una consulenza tecnica, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede
di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte
siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da
vizi logici e giuridici.”(Cassazione civile sez. lav., 24 gennaio 1997, n. 722);
“Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere
discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro
principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad
una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, con la conseguenza che quando il giudice
disporre di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune
esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio
di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di
legittimità sotto l’anzidetto profilo.”(Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2004, n. 20814);
“In tema di procedimento civile, la consulenza tecnica d’ufficio - che può costituire fonte oggettiva di
prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili
esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche - è un mezzo istruttorio sottratto
alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il
duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di
motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza
richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di
legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla
valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere
l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente
accertato.”(Cassazione civile, sez. III, 8 gennaio 2004, n. 88);
“Il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più
allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da
nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata.”(Cassazione civile,
sez. III, 16 luglio 2003, n. 3097);
“Il giudice di merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche
implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto
unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre
prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia.
Egli non può, per converso, negare ingresso a detta istanza, omettendo di confutare le ragioni addotte
dalla parte a sostegno della medesima, e ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della
consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare, specie quando oggetto dell’accertamento risultino
elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d’indagine e la parte
104
si trovi, se non nell’impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di
valutazione.”(Cassazione civile, sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 87);
• “La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria, sottratto alla
disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei
poteri discrezionali di quest’ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d’ufficio,
o indagini tecniche suppletive.”(Cassazione civile, sez. II, 11 luglio 2002, n. 10121);
• “Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre
consulenze tecniche, valutazione che esula dal controllo di legittimità.”(Cassazione civile, sez. I, 9
maggio 2002, n. 6641);
• “La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla
disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei
poteri discrezionali di quest’ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d’ufficio
ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente
tecnico d’ufficio ovvero di rinnovare le indagini peritali; la motivazione del diniego della nomina del
consulente tecnico d’ufficio può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale
delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato
effettuata dal giudice del merito.”(Cassazione civile, sez. II, 6 maggio 2002, n. 6479).
Tutto ciò significa che il giudice, dopo aver disatteso la richiesta di consulenza tecnica
(eccezionalmente obbligatoria solo in tema di processo previdenziale, laddove la nomina del
consulente costituisce atto dovuto ex art.445 c.p.c.), è tenuto a motivare la propria sentenza,
opportunamente chiarendo i motivi per cui l’indagine tecnica proposta era:
• irrilevante (ad esempio, perché la soluzione della controversia dipendeva da
altre circostanze di fatto o si basava su diversi presupposti giuridici),
• o inutile (ad esempio, perché l’indagine proposta non avrebbe potuto sortire
risultati positivi, magari a causa del tempo trascorso o dell’impossibilità di
ricreare certe condizioni),
• o superflua (perché il giudice disponeva già delle nozioni tecniche necessarie,
rientranti nel bagaglio della comune esperienza).
La ratio comune degli orientamenti richiamati può essere individuata, così sintetizzando:
da un lato, l’indubbia autonomia di giudizio che il nostro ordinamento riconosce al
giudice nella fase decisoria (e che lo svincola da qualsiasi rapporto di subordinazione
con l’elaborato del consulente tecnico), tradizionalmente sussunta sotto il broccardo
“judex peritus peritorum”;
dall’altro, l’obbligo fondamentale del giudice di motivare la propria decisione in modo
completo e logicamente coerente, in relazione al materiale probatorio acquisito e alle
richieste formulate dalle parti.
In tale prospettiva è possibile pervenire ai seguenti punti fermi di riflessione:
o il giudice non è tenuto a motivare la propria adesione alle elaborazioni del
consulente tecnico e può limitarsi ad aderirvi, se le affermazioni di costui non
sono state criticate dalle parti o sono state contestate in modo solamente
generico;
o se invece le parti hanno contestato in modo specifico il ragionamento o le
valutazioni operate dal consulente, contrapponendovi articolati motivi di
censura, il giudice per soddisfare il proprio obbligo motivazionale è tenuto ad
esaminare le critiche proposte, dando conto della sua persistente adesione al
pensiero del consulente (e anche solo del suo rifiuto di sottoporre le critiche al
consulente per la revisione in tal prospettiva del suo elaborato);
o se il giudice intende discostarsi dalla valutazione operata dal consulente è
tenuto a spiegare il proprio atteggiamento
vuoi negando la stessa utilità della consulenza tecnica (così esprimendo
il proprio ripensamento rispetto alla precedente decisione di disporla),
105
vuoi criticando sotto il profilo della persuasività e della coerenza
logica l’iter del ragionamento del perito (eventualmente confortando la
propria opinione con il sostegno di elaborati tecnici dei consulenti di
parte),
vuoi, infine, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali o un
supplemento di consulenza o l’acquisizione di chiarimenti da parte del
consulente, allorché i dubbi e le perplessità alimentati dalle difese delle
parti operino solo “in negativo”, privando di attendibilità o di
esaustività l’elaborato tecnico depositato dal consulente, senza
permettere al contempo la formazione di una contraria opinione
suscettibile di tradursi nella decisione della causa, in difetto di ulteriore
supporto arrecato da una nuova indagine tecnica;
o se infine nel corso del giudizio (o magari in gradi differenti dello stesso
giudizio) sono state disposte due o più consulenze tecniche sullo stesso
argomento il giudice è tenuto a motivare la propria adesione all’una o all’altra
delle due o più perizie, a meno che la seconda perizia, a cui il giudice ritenga
di aderire, non contenga sufficienti elementi per giustificare il rigetto delle
opinioni del primo consulente (il che avviene tutte le volte in cui il secondo
consulente abbia criticato la prima relazione o motivato il proprio dissenso), in
modo che l’opzione esercitata risulti motivata seppur per relationem.
23.2. Motivi inerenti la mancata disposizione della c.t.u.
Si tratta quindi di affrontare le tematiche proprie dei motivi di impugnazione in appello sopra
ricapitolate all’inizio del paragrafo, alla luce dei principi sopra esposti.
In tema di motivi di appello incentrati sulla mancata disposizione della c.t.u., l’appellante ha
l’onere di censurare in modo specifico le ragioni esposte dal giudice per giustificare la sua
decisione e soprattutto non può sottrarsi alla contestuale critica delle ragioni eventualmente
esposte in motivazione dal giudice quale peritus peritorum per la risoluzione della ravvisata
questione tecnica.
23.3. Motivi inerenti la mancata integrazione della c.t.u.
In tema di mancata integrazione della c.t.u. (nelle sue varie sottospecie in cui venga lamentata
l’omessa acquisizione di chiarimenti, precisazioni o integrazioni di indagine) la parte appellante
deve censurare in modo specifico le ragioni esposte dal giudice per giustificare la sua decisione
di non integrare le indagini e di non richiedere chiarimenti; l’appellante comunque deve anche
criticare in modo specifico e puntuale i singoli punti in cui il giudice si è affidato per la
soluzione del problema tecnico a un elaborato ritenuto incompleto, contraddittorio od oscuro
e così denunciare in modo puntuale e specifico tali difetti.
23.4. Motivi inerenti la mancata rinnovazione della c.t.u. o il mancato esercizio dei
poteri sostitutivi del giudice quale peritus peritorum.
Talora, infine, l’appellante si lamenta che la consulenza tecnica d’ufficio sia gravemente viziata
da errori, imprecisioni, carenze di indagini, incompetenza del perito e sollecita la completa
rinnovazione delle operazioni peritali
E’ evidente poi che allorché l’appellante si dolga della mancata rinnovazione della c.t.u. (per
ragioni di merito e non per motivi processuali, ipotesi nella quale l’impugnazione va costruita
con la tecnica propria dei motivi processuali con particolare attenzione agli aspetti della
rilevanza e delle ripercussioni della violazione processuale consumata) l’appellante dovrà
focalizzare i propri sforzi su errori, imprecisioni, carenze di indagini, incompetenza del perito,
nonché sulla loro incidenza sul valore complessivo delle risposte fornite dal consulente a cui il
giudice abbia aderito.
106
Analogo criterio varrà nel caso in cui la parte appellante richiede al giudice di appello una
diversa valutazione della fattispecie correggendo ex officio gli errori commessi dal perito
(mancata correzione della valutazione peritale).
Un particolare sottospecie, qualificata, di siffatta doglianza, è ravvisabile nell’ipotesi in cui
l’appellante abbia svolto già in primo grado53 le proprie critiche ed osservazioni all’elaborato
peritale che non siano state adeguatamente considerate e fatte oggetto di controargomentazione in sentenza.
In tal caso il motivo di appello deve dirigersi anche contro la decisione del Giudice di superare
tali critiche, operata in modo implicito od esplicito, nella sentenza impugnata.
La sentenza in tal caso può essere denunciata per difetto di motivazione, a condizione che le
critiche fossero specifiche e puntuali, tali cioè da imporre al giudice l’obbligo di esaminarle
analiticamente, senza potersi accontentare di una mera adesione all’elaborato del perito.
La Suprema Corte ha tuttavia recentemente precisato – per l’ipotesi di mancata espressa
contestazione delle conclusioni della c.t.u. in primo grado - che:
• “Nel giudizio d’appello, nessuna preclusione alla formulazione dei motivi può derivare dalla mancata
proposizione, nel procedimento di primo grado, di censure rivolte alle conclusioni della consulenza
tecnica d’ufficio, una volta che queste siano state acquisite in sentenza o siano state disattese
motivatamente, restando fermo solo l’obbligo d’impugnare con motivi specifici la pronuncia, nella
parte in cui si rapporta adesivamente o negativamente alla relazione dell’ausiliare.”(Cassazione
civile, sez. I, 10 luglio 2009, n. 16292).
24. Motivi anomali o subdoli: impliciti, obliqui, inconsapevoli, ricostruiti.
L’analisi non sarebbe completa senza la formulazione di alcune riflessioni su alcune categorie
di motivi, per così dire anomale, che un attento studioso54 della tematica ha efficacemente
descritto come motivi “subdoli” (nel senso di “sfuggenti, ingannevoli”).
24.1. Motivi impliciti.
Una prima categoria di motivi è quella costituita da quelli “impliciti”.
A tale categoria vengono ricondotte le censure che presuppongano implicitamente una
qualificazione giuridica diversa rispetto a quella accolta in primo grado ovvero quelle censure
articolate in diritto che presuppongano una diversa ricostruzione del fatto non esplicitamente
effettuata dal primo giudice (perché, se così fosse, la critica non sarebbe abbastanza specifica).
Il pensiero merita di essere condiviso: in buona sostanza, poiché la legge processuale non
esige il ricorso a formule sacramentali e solenni per l’introduzione della critica in cui si risolve
la proposizione del motivo, tutto si risolve in una attività interpretativa dell’atto di
impugnazione, a cui il giudice di appello non si può sottrarre, e che è rivolta allo scopo di
verificare tutte le obiezioni rivolte, sia esplicitamente, sia implicitamente (ma con apprezzabile
grado di univocità), al percorso motivazionale compiuto dal primo giudice.
Occorre quindi in tal prospettiva verificare non solo l’obiettivo evidente e diretto delle censure
ma anche il loro obiettivo indiretto, comunque attinto dalla loro efficacia distruttiva e
costituente il presupposto inscindibile delle ragioni aggredite.
Quest’operazione peraltro è particolarmente pericolosa e ricca di insidie, perché il giudice, che
certamente non può esimersene senza asservirsi ad un vacuo e sterile formalismo, rischia al
contempo di compromettere la sua neutralità e imparzialità, cardine stesso dell’ordinamento
giurisdizionale (ex art.111 Cost.) nel momento in cui percorre l’atto di impugnazione per
53 Il che può avvenire o in sede di memorie nel contraddittorio tecnico preliminare al deposito della relazione, o
in sede di trattazione successiva al deposito alla relazione del c.t.u. (c.d. “osservazioni alla c.t.u.”), o ancora in
sede di scritti conclusionali.
54 CONVERSO, “LA SENTENZA DI PRIMO GRADO AL VAGLIO DEL GIUDICE DI APPELLO. In
particolare: analisi strutturale della sentenza di primo grado e individuazione della ratio decidendi; analisi strutturale dei motivi di
appello; specificità o meno di questi ultimi; tecniche di redazione della sentenza di secondo grado” da Atti del Convegno CSM,
Frascati 20-22.6.1996.
107
rinvenire le ragioni di critica ad esso carsicamente sottese, rischiando di assumere il ruolo
improprio di autore di censure inespresse.
L’unica arma che può preservare il giudice dall’arbitrio e la lanterna che lo deve illuminare
nell’operazione ermeneutica è il principio del contraddittorio (e in quello di affidamento che lo
informa); un motivo implicito potrà essere ravvisato solo allorché la lettura secondo logica,
ragionevolezza e buona fede dell’atto di impugnazione sia tale da indurre chiunque (e così
tanto la controparte quanto il giudice) a ritenere che l’appellante abbia inteso lamentare anche
il presupposto implicito della sua doglianza esplicita.
Un esempio abbastanza frequente di motivi impliciti è quello dei motivi contenuti nelle
capitolazioni istruttorie, che non siano state ben coordinate rispetto ai motivi di gravame
proposti e che ne sottendano altri inespressi.
Anche a tal proposito la questione è meramente interpretativa, anche se appare molto difficile
che sia possibile inferire in modo neutrale dalla deduzione di un fatto storico (perché tale, per
forza di cose, deve essere l’oggetto della deduzione probatoria) lo sfogo di una controargomentazione.
Ad esempio: poiché si è verificato l’evento “x” (oggetto della deduzione istruttoria esplicita) il
giudice ha sbagliato nella ricostruzione del fatto e quindi ne ha tratto la conseguenza “y”
mentre dal fatto correttamente ricostruito si sarebbe dovuta applicare la conseguenza “z”
(contro-argomentazione implicita).
Tutto si risolve nella possibilità di ricavare in modo sufficientemente univoco una censura di
tal fatta alla proposizione del capitolo di prova.
La Suprema Corte consiglia estrema cautela in siffatte operazioni:
• “In materia di impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell’appello postula
che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante,
finalizzate ad inficiare il fondamento logico - giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di
una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. è pertanto necessario
che l’atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal
primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che
l’esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio,
quale la (mera) produzione di documenti effettuata senza nemmeno l’indicazione della
valenza a ciascuno di essi attribuita, ovvero addirittura il deposito della comparsa
conclusionale.”(Cassazione civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6396).
In qualche caso l’operazione appare praticabile, come nei seguenti esempi:
• il convenuto viene condannato in primo grado a pagare a titolo di
corrispettivo contrattuale una certa somma all’attore; propone quindi appello
limitandosi a chiedere la reiezione della domanda, deducendo (o ridededucendo) una prova (per testimoni, o per interrogatorio o magari per
giuramento decisorio) o producendo un documento relativamente all’avvenuto
integrale pagamento del debito; sembra difficile negare la desumibilità univoca
di un motivo implicito basato sulla mancata considerazione del fatto estintivo
dell’obbligazione (sicché il problema sarà semmai l’ammissibilità e il contenuto
della prova);
• l’appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto provato nei
suoi confronti certi fatti sulla base di una sentenza penale resa in un
procedimento promosso nei confronti di altro soggetto del cui fatto egli
debba civilmente rispondere) a cui egli non era stato posto in grado di
partecipare, senza invocare la limitazione di efficacia sancita dall’art.651 c.p.c. e
semplicemente sostiene che egli avrebbe stato in possesso di certi elementi
probatori per ribaltare l’esito del processo; sembra difficile negare che in questo
caso egli implicitamente si dolga di non essere stato posto in condizione di
partecipare al giudizio penale e contesti l’opponibilità nei suoi confronti
dell’accertamento ivi raggiunto.
108
Al contrario un motivo implicito non può essere ravvisato nel mero fatto di una produzione
documentale:
• “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente che il contenuto del
documento rientri nell’ambito di quanto, in ossequio al principio devolutivo, il giudice d’appello è
tenuto a esaminare, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione
diretta a evidenziare il contenuto del documento e il suo significato ai fini di integrazione
dell’ingiustizia della sentenza di primo grado impugnata.”(Cassazione civile, sez. III, 7 aprile
2009, n. 8377).
24.2. I motivi obliqui.
La categoria dei motivi “obliqui” considerata dallo stesso Autore non è radicalmente diversa da
quella dei motivi impliciti da cui si distingue solo per un nesso di implicazione più marcato; si
tratta semplicemente di una tecnica di proposizione il più sintetica ed ermetica possibile della
censura, con cui la parte attrice dell’impugnazione cerca di sottrarsi al dovere di parlare
chiaramente, spesso per evitare di attirare l’attenzione su aspetti della vicenda che preferisce
tenere in secondo piano.
L’esempio proposto (deduzione dell’onnicomprensività del prezzo portato in contratto volta a
sottolineare la rilevante consistenza proporzionale del quid minus effettivamente corrisposto ma
che in realtà trasporta anche la critica circa la sussistenza di un patto elusivo della disciplina
dell’imposizione i.v.a.) è perfettamente calzante e fotografa un bell’esempio di motivo obliquo.
Spesso motivi di tal genere sono dissimulati all’interno di incisi.
Ad esempio:
• se la società X è stata condannata in primo grado a risarcire il danno patito da Y che
si è infortunato nell’utilizzare un certo manufatto, perché il giudice le ha addebitato
l’omissione di intervento di un suo dipendente Z;
• allorché la X contesti il presupposto della sua responsabilità omissiva in atto di appello,
negando l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso in difetto di un rapporto
contrattuale con Y o di una posizione di qualificata garanzia in capo a Z,
incidentalmente rilevando che non era provata la sua qualità di dipendente (con una
frase del tipo “Non sussiste alcuna relazione contrattuale fra la X e Y e tantomeno una posizione
di garanzia qualificata, in relazione alle quali potesse appuntarsi in capo allo Z, del quale per giunta
non è stata dimostrata la qualità di dipendente, l’obbligo giuridico di impedire l’evento rilevante ai fini
della configurabilità della responsabilità del danno per omissione di intervento ai sensi dell’art.40
c.p.”),
• in realtà i motivi sono due, il primo esplicito, attinente alla insussistenza dell’obbligo
giuridico, il secondo obliquo, inerente il difetto di prova del rapporto di preposizione.
24.3. I motivi inconsapevoli.
Una ulteriore categoria è quella dei motivi “inconsapevoli”, definiti come quelle censure non
formulate in modo lucido e intenzionale come critiche alla sentenza ma esposte come
affermazioni incidentali e casuali, ad colorandum.
Si tratta di motivi dedotti in linea oggettiva, ma privi dell’elemento soggettivo e intenzionale, di
per sé non necessario, e che comunque soddisfano il requisito fondamentale rappresentato
dalla dichiarazione.
Poco importa quindi che la parte interessata si renda o meno conto della critica se questa è
inequivocabilmente contenuta nell’atto e può essere percepita senza alcuna interpolazione o
integrazione dal giudice e dalla controparte.
Alla categoria possono essere ricondotte tutte quelle censure in diritto che denunciano un
errore giuridico effettivamente sussistente, senza indicare la norma giuridica corretta e dando
quindi spazio all’esplicazione del principio “ jura novit curia”.
24.4. I motivi ricostruiti.
109
L’ultima categoria è quella dei motivi “ricostruiti” che viene ravvisata nell’ipotesi in cui la parte
appellante percepisca (o anche solo intuisca vagamente) l’esistenza di un errore nella pronuncia
di primo grado ma non lo identifichi e comprenda con chiarezza e non reagisca quindi
denunciandolo con la dovuta lucidità; l’appellante perciò si limita ad esporre una serie di
argomentazioni diffuse in parti varie dell’atto (svolgimento processuale, motivazioni, deduzioni
istruttorie) che solo con una articolata attività di rielaborazione da parte del giudice possono
assurgere al rango di critica potenzialmente distruttiva.
Quest’operazione va giustamente evitata perché un tale pericoloso tipo di intervento attivo
porta il giudice a prender parte alla lite, compromettendo la sua terzietà, e lo induce a
sostituirsi ad un apporto che deve provenire dalla parte e dal suo difensore tecnico; ciò, per
giunta, avviene in modo pregiudizievole per l’avversario della parte adiuvata dalla “ricostruzione”,
che legittimamente suppone di doversi difendere dai monconi di doglianze e dai brandelli di
argomentazioni provenienti dall’avversario e ignora di dover fronteggiare un ben più
pericoloso antagonista surrettizio mascherato nello stesso arbitro della contesa.
Torino - Roma, luglio 2010
Umberto Scotti
110
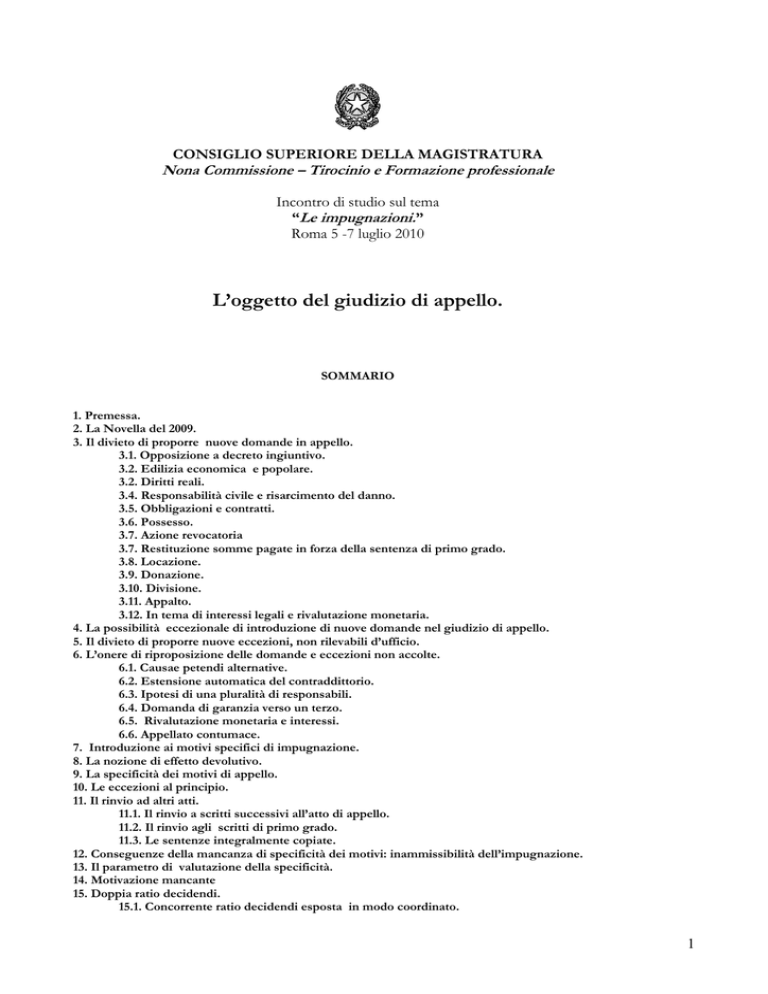


![ELEMENTI DI ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA [40000413]](http://s1.studylibit.com/store/data/007273765_1-a759a235cfec72c1ba8707b88f8b6a67-300x300.png)
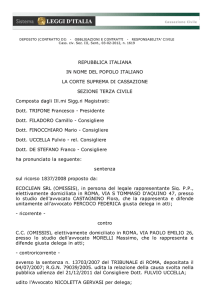

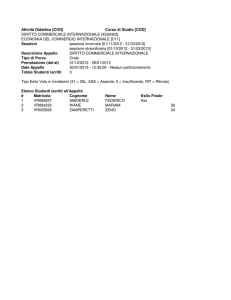
![Corso di Studio [COD] ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO [4S00405]](http://s1.studylibit.com/store/data/006615207_1-aa61af9b3fe0c5a346a35c7c460e1d09-300x300.png)