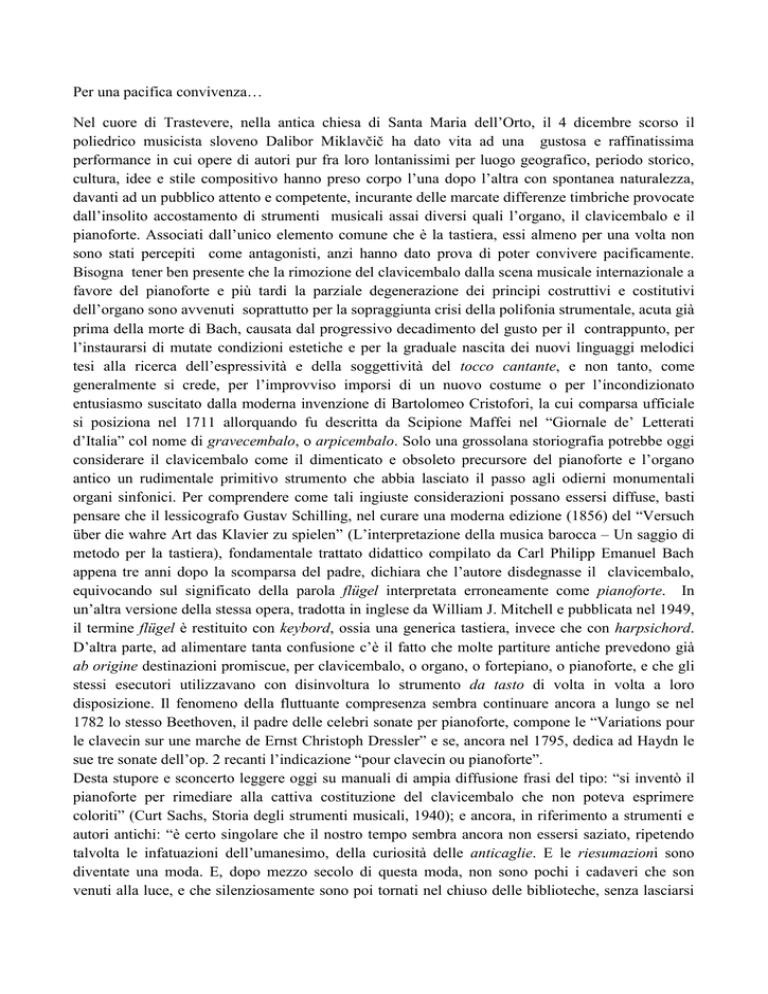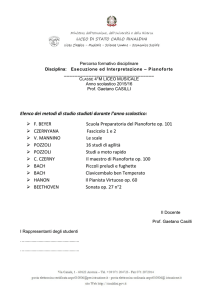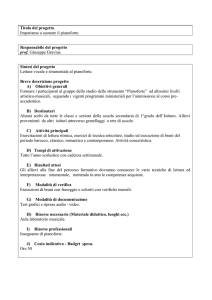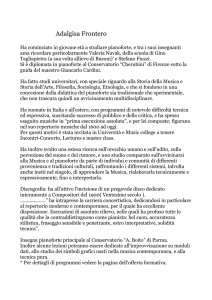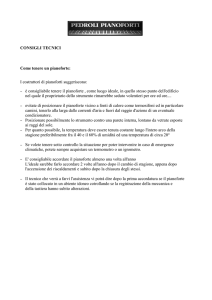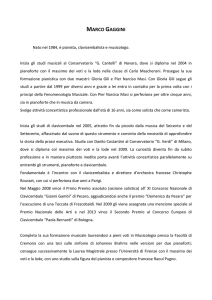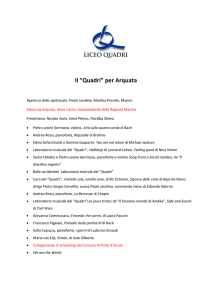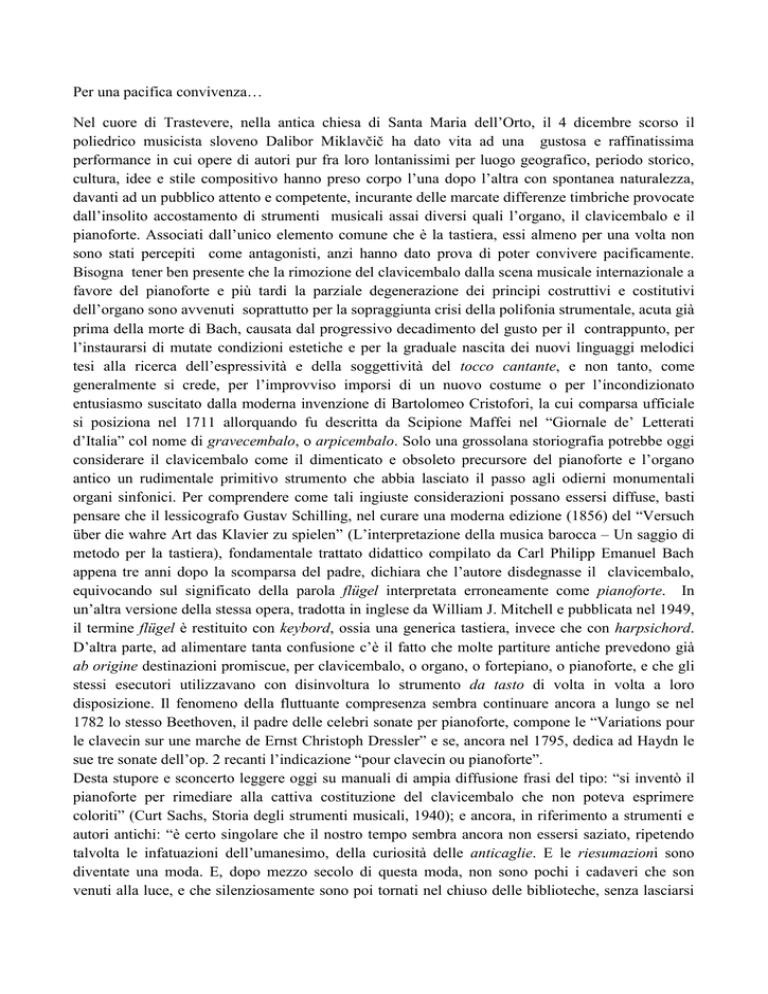
Per una pacifica convivenza…
Nel cuore di Trastevere, nella antica chiesa di Santa Maria dell’Orto, il 4 dicembre scorso il
poliedrico musicista sloveno Dalibor Miklavčič ha dato vita ad una gustosa e raffinatissima
performance in cui opere di autori pur fra loro lontanissimi per luogo geografico, periodo storico,
cultura, idee e stile compositivo hanno preso corpo l’una dopo l’altra con spontanea naturalezza,
davanti ad un pubblico attento e competente, incurante delle marcate differenze timbriche provocate
dall’insolito accostamento di strumenti musicali assai diversi quali l’organo, il clavicembalo e il
pianoforte. Associati dall’unico elemento comune che è la tastiera, essi almeno per una volta non
sono stati percepiti come antagonisti, anzi hanno dato prova di poter convivere pacificamente.
Bisogna tener ben presente che la rimozione del clavicembalo dalla scena musicale internazionale a
favore del pianoforte e più tardi la parziale degenerazione dei principi costruttivi e costitutivi
dell’organo sono avvenuti soprattutto per la sopraggiunta crisi della polifonia strumentale, acuta già
prima della morte di Bach, causata dal progressivo decadimento del gusto per il contrappunto, per
l’instaurarsi di mutate condizioni estetiche e per la graduale nascita dei nuovi linguaggi melodici
tesi alla ricerca dell’espressività e della soggettività del tocco cantante, e non tanto, come
generalmente si crede, per l’improvviso imporsi di un nuovo costume o per l’incondizionato
entusiasmo suscitato dalla moderna invenzione di Bartolomeo Cristofori, la cui comparsa ufficiale
si posiziona nel 1711 allorquando fu descritta da Scipione Maffei nel “Giornale de’ Letterati
d’Italia” col nome di gravecembalo, o arpicembalo. Solo una grossolana storiografia potrebbe oggi
considerare il clavicembalo come il dimenticato e obsoleto precursore del pianoforte e l’organo
antico un rudimentale primitivo strumento che abbia lasciato il passo agli odierni monumentali
organi sinfonici. Per comprendere come tali ingiuste considerazioni possano essersi diffuse, basti
pensare che il lessicografo Gustav Schilling, nel curare una moderna edizione (1856) del “Versuch
über die wahre Art das Klavier zu spielen” (L’interpretazione della musica barocca – Un saggio di
metodo per la tastiera), fondamentale trattato didattico compilato da Carl Philipp Emanuel Bach
appena tre anni dopo la scomparsa del padre, dichiara che l’autore disdegnasse il clavicembalo,
equivocando sul significato della parola flügel interpretata erroneamente come pianoforte. In
un’altra versione della stessa opera, tradotta in inglese da William J. Mitchell e pubblicata nel 1949,
il termine flügel è restituito con keybord, ossia una generica tastiera, invece che con harpsichord.
D’altra parte, ad alimentare tanta confusione c’è il fatto che molte partiture antiche prevedono già
ab origine destinazioni promiscue, per clavicembalo, o organo, o fortepiano, o pianoforte, e che gli
stessi esecutori utilizzavano con disinvoltura lo strumento da tasto di volta in volta a loro
disposizione. Il fenomeno della fluttuante compresenza sembra continuare ancora a lungo se nel
1782 lo stesso Beethoven, il padre delle celebri sonate per pianoforte, compone le “Variations pour
le clavecin sur une marche de Ernst Christoph Dressler” e se, ancora nel 1795, dedica ad Haydn le
sue tre sonate dell’op. 2 recanti l’indicazione “pour clavecin ou pianoforte”.
Desta stupore e sconcerto leggere oggi su manuali di ampia diffusione frasi del tipo: “si inventò il
pianoforte per rimediare alla cattiva costituzione del clavicembalo che non poteva esprimere
coloriti” (Curt Sachs, Storia degli strumenti musicali, 1940); e ancora, in riferimento a strumenti e
autori antichi: “è certo singolare che il nostro tempo sembra ancora non essersi saziato, ripetendo
talvolta le infatuazioni dell’umanesimo, della curiosità delle anticaglie. E le riesumazioni sono
diventate una moda. E, dopo mezzo secolo di questa moda, non sono pochi i cadaveri che son
venuti alla luce, e che silenziosamente sono poi tornati nel chiuso delle biblioteche, senza lasciarsi
dietro alcuna nostalgia da parte del pubblico che assisté alle loro momentanee resurrezioni”
(Leonardo Pinzauti, Gli arnesi della musica, Firenze, 1973).
Al cospetto degli splendidi affreschi della prima metà del Cinquecento ad opera di Taddeo Zuccari
(sepolto al Pantheon, accanto a Raffaello, suo maestro ideale) e del fratello Federico, e ai piedi
dell’altar maggiore disegnato da Giacomo della Porta, autore fra l’altro della facciata della chiesa
del Gesù e della Fontana delle tartarughe, delicato gioiello della Roma manieristica, e dunque in
uno spazio prestigiosissimo e suggestivo coevo alla nascita dei primi organi e clavicembali, il
pubblico selezionato ed entusiasta ha potuto sperimentare la coinvolgente espressività di Miklavčič
che sostenuto da una tecnica impeccabile e travolgente, diremmo pirotecnica, si è esibito con la
medesima efficacia all’organo (Pietro Pantanella, 1861), al Pedalcembalo e al Pedalpianoforte;
ambedue, questi ultimi, di sua costruzione.
Gli sloveni Iacobus Handl-Gallus e Joannes Baptisma Dolar, Buxtehude, Schumann, J.S. Bach e
Lefébure-Wély gli autori ascoltati nella chiesa del famoso quartiere di Roma.
Non solo la tastiera, allora, ma anche la pedaliera è stata la componente visibile, spettacolare
protagonista, che ha funzionato da trait d’union fra i tre inconsueti “arnesi della musica”.
E’ certo che Bach possedesse un Pedalcembalo (oltre a non meno di otto clavicembali, una
spinetta, due violini, un violino piccolo, tre viole, una viola pomposa, due violoncelli, una viola da
gamba e un liuto probabilmente utili a lui stesso, alla moglie e ai figli per uso didattico e per
ricavarne proventi dal noleggio) utilizzato di frequente per completare la strumentazione del
Collegium Musicum, prestigioso gruppo di musicisti di cui egli aveva assunto la direzione nel 1729,
che teneva concerti a cadenza settimanale presso il caffè Zimmermann, il luogo di ritrovo più
popolare di Lipsia. Sembra anzi che tale Pedalcembalo godesse del particolare affetto della famiglia
Bach se alla morte del Cantor le tre sorelle nate dal primo matrimonio e il loro fratellastro Johann
Christian furono coinvolti in una controversia legale proprio per il suo possesso, che a seguito di
testimonianze attendibili circa i desideri del padre fu assegnato in eredità a Christian.
Anche Mozart utilizzava un fortepiano a pedali, e un pedalflügel rientrava tra le disponibilità di
Schumann al quale nel 1845 egli dedicò Sei studi in forma di canone op. 56 (trascritti per due
pianoforti da Debussy nel 1891, forse per sottrarli ad un probabile oblio ma soprattutto col fine di
valorizzarne l’intensa espressività), Quattro schizzi op. 58 e Sei fughe sul nome Bach op. 60. La sua
incontrollabile attrazione nei confronti del contrappunto lo indusse a cimentarsi ancora in direzione
della scrittura matematica colla composizione dei Sette studi in forma di fughetta op. 126 per
pianoforte del 1853.
E’ noto che il pianoforte con pedaliera non ebbe larga diffusione e le partiture ad esso legate (tra gli
autori più significativi si segnalano Charles Valentin Alkan, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns,
Léon Boëllmnn, e in tempi recenti Jean Guillou) non ebbero la fortuna di entrare nel repertorio
comune degli interpreti perché presto soppiantate nella ricerca dell’espressività e del tocco
pianistico dalle straordinarie soluzioni individuate da Chopin e Liszt.
Ma oggi si assiste ad un incoraggiante e rinnovato interesse per strumenti di questo tipo e da più
parti e con crescente insistenza si auspica una giusta rivalutazione del repertorio musicale prodotto
da magistri qui adversam fortuna tulerunt e che a buon diritto può rivivere accanto ai grandi
capolavori della musica colta.
Gianluca Libertucci