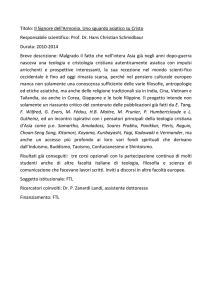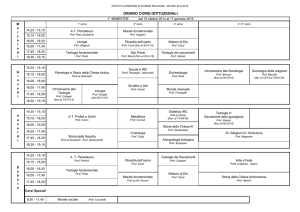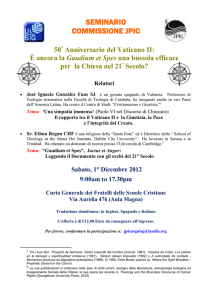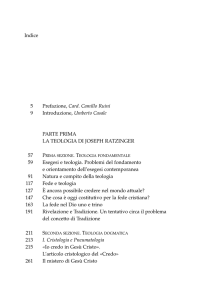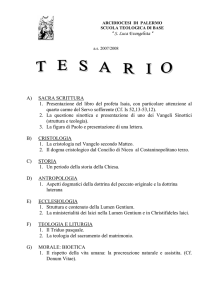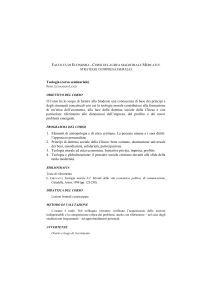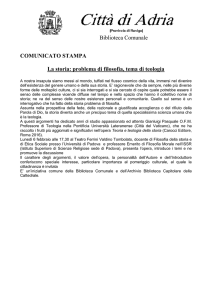CONVEGNO DI TEOLOGIA
Sabato 22 marzo 2014
L’antropologia del rito
e la forma singolare della fede
Che il rito abbia una valenza teologica può risultare un’affermazione condivisibile, ma la
formalizzazione della questione è piuttosto recente, e arriva dopo un vuoto secolare da parte della
teologia. L’assenza è pressoché totale: fino al secolo scorso di fatto non conosciamo una teologia
del rito. Il silenzio sulla questione del rito assume tuttavia tratti differenti lungo la storia del
pensiero teologico: se inizialmente esso è presupposto a vantaggio delle sue implicazioni, non
possiamo dire la stessa cosa nell’epoca moderna1. Le domande che hanno mosso la riflessione dei
Padri sono inscritte nella grande vitalità della liturgia della Chiesa antica 2 : chi può essere
battezzato? Come comportarsi di fronte alla colpa grave di un battezzato? Quale nesso tra la Parola
e il Sacramento? Quale prassi etica per un battezzato? Se un eretico si convertisse, deve essere
ribattezzato? A contatto con queste questioni, vengono elaborate alcune categorie (la più fortunata è
quella di “segno”) che presuppongono la ritualità.
La teologia successiva continuerà a confrontarsi con le categorie, ma il silenzio sulla ritualità
cambierà qualitativamente: non possiamo più parlare di una presupposizione, ma di una vera
rimozione. Nella Modernità il rito inizia ad essere una questione: l’interesse per il rito è quasi coevo
alle scienze umane3, le cui riflessioni sembrano non interessare alla teologia.
La semantica rituale, esclusa per secoli dalla letteratura teologica e presente nelle aule di teologia
per l’insegnamento delle questioni rubricali ad uso dei futuri pastori, irrompe sul panorama della
riflessione con il Movimento Liturgico e guadagna un consenso via via sempre maggiore, fino a
divenire universale.
L’ampiezza del consenso maschera però una grandissima varietà delle intenzioni: la parola “rito” ha
una frequenza materiale piuttosto elevata nei saggi più recenti di teologia dei sacramenti, ma
l’estensione dell’utilizzo non corrisponde a un consenso altrettanto esteso circa il significato. Alcuni
autori infatti si sono concentrati su studi di carattere comparatistico, cercando di inscrivere i riti
cristiani entro alcune categorie universali di ritualità. Altri teologi invece hanno preferito un
approccio più dialettico, mettendo in luce il carattere dei riti cristiani come “anti-riti”.
Annesso alla questione di un’intesa sulla categoria di rito, il dibattito attorno alle competenze circa
l’indagine non è meno esteso. I pionieri del Movimento Liturgico si sono rivolti con un certo
interesse alle scienze umane, e in particolare all’antropologia culturale. Due degli autori più citati
sono R. Otto e M. Eliade, classificati come “fenomenologi della religione” o “filosofi della
religione”. Alcuni teologi hanno proposto una prospettiva più dialettica con le scienze umane,
rivendicando il diritto e dovere della teologia ad “elaborare in proprio” categorie adeguate alla
comprensione della ritualità. Di recente la fenomenologia di stampo francese ha conosciuto una
stagione di interesse per i riti cristiani, rivisti con gli strumenti che gli sono propri.
Dunque non è facile comprendere cosa sia “rito”, e non è nemmeno facile comprendere chi sia il
titolare adeguato della domanda. Ci troviamo in una condizione piuttosto impegnativa: la
sacramentaria ha intuito l’importanza del rito per dire la verità dei sacramenti, tuttavia il concetto di
rito è tutt’altro che condiviso e spesso vi si allude con un tono piuttosto intuitivo. I due poli della
1
Come è noto, lo schema presupposizione-rimozione-reintegrazione è di A. Grillo, reperibile in diversi suoi contributi.
In modo rigoroso A. GRILLO, Introduzione alla teologia liturgica. Approccio teorico alla liturgia e ai sacramenti
cristiani, Messaggero, Padova 2011.
2
Cfr. V. LOMBINO, Simbolismo sacramentale e identità cristiana nei Padri, in «Rivista liturgica» 3 (2007), 349-375.
3
Solo come esempio evocativo E. DURKHEIM, Le forme elementari della vita religiosa, 1912.
1
questione sembrano essere da un lato uno specifico cristiano da salvaguardare, e dall’altro un
terreno antropologico ineludibile.
Le riflessioni che seguono non hanno la pretesa della completezza, ma intendono offrire un
tentativo di status quaestionis e alcune prospettive di indagine. Urge infatti una pulizia
terminologica dell’area semantica della ritualità. La categoria teologica di rito è stata percepita
come piuttosto “minacciosa” quando si è affacciata per la prima volta sul panorama teologico (cfr.
le polemiche tra Casel e i professori dell’Università Gregoriana). Il diritto di cittadinanza che oggi
le è riconosciuto è forse più dovuto alla sua capacità di “camuffarsi” e di adattarsi a diverse imprese
teologiche che a una sua effettiva comprensione condivisa. Se ormai è nell’uso quasi comune il
riferimento a società liquide, affetti liquidi, amori liquidi, potremmo anche parlare di “teologie
liquide”: è difficile definire chi sia oggi un teologo. La teologia, in conformità a tutto il sapere
dell’uomo, sta vivendo una fase di specializzazione e frammentazione sempre più elevata, e anche
in un medesimo ambito disciplinare le diversità sono notevoli.
I manuali di riferimento differiscono notevolmente per l’impostazione dell’articolazione del
rapporto tra liturgia e sacramentaria. Uno dei manuali più utilizzato di C. Rocchetta predilige la
distinzione in sacramentaria fondamentale e sacramentaria speciale, la ricostruzione storica è molto
accurata e ampio spazio viene concesso alle ricognizioni bibliche. Il manuale di Grillo – Perroni –
Tragan (frutto di diversi autori legati alla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo sant’Anselmo)
ha un taglio molto originale e si propone una ricostruzione della sacramentaria “in genere ritus”. Il
manuale di C. Scordato invece propone una teologia dei sacramenti senza la distinzione classica di
“sacramentaria fondamentale” e “sacramentaria speciale”. In Italia sono almeno quattro i poli più
produttivi circa la teologia dei sacramenti: il Pontificio Ateneo sant’Anselmo, per fama molto
attento alle fonti (anche se per esperienza personale posso affermare che è un’etichetta piuttosto
riduttiva rispetto alla ricchezza culturale dell’ambiente), l’Istituto Teologico Marchigiano, con un
tendenziale orientamento ai fondamenti epistemologici, l’Istituto Teologico di santa Giustina di
Padova, tradizionalmente molto aperto al dialogo con le scienze umane, e la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale, le cui indagini sono orientate al rapporto tra l’istanza fondamentale della
fede e il suo momento sacramentale. In un panorama così vasto, la categoria di rito ritrova tuttavia
un consenso pressoché universale: il dubbio che l’utilizzo del termine non corrisponda ad un
effettivo consenso terminologico non è privo di fondamento.
Un caso emblematico in cui l’appello nominale alla semantica del rito ha prodotto divergenze
notevoli è dato da un piccolo libretto di P. Sequeri (su cui torneremo in seguito), che raccoglie le
lezioni tenute al Sant’Anselmo e intitolato Ritrattazioni del simbolico. Con lo stile accattivante di
sempre, Sequeri propone alcune riflessioni sulla categoria di “simbolo” (e di riflesso su quella di
rito), definita piuttosto “esausta”: «L’ontologia dell’affezione – la teologia dell’affezione divina –
può conciliare, mi sembra, il carattere istituito del sacramento con la logica intrinseca del suo
dispositivo, sfuggendo alle debolezze accumulate dall’eccesso della sua iscrizione nel registro
simbolico del semantico»4. Le lezioni di Sequeri sono introdotte da una prefazione di C. Krause, il
quale si domanda quali siano i riferimenti polemici di Sequeri che, nelle sue pagine, non cita mai
Casel, Rahner o Guardini, ma per i quali «il concetto di “simbolo” è molto meno “semioticorappresentativo” di quanto la polemica potrebbe suggerire a chi non conosce questi grandi fautori
della svolta simbolica»5 . A. Grillo conclude con una post-fazione in cui mette in luce come il
formalismo che Sequeri intende superare in realtà lo minaccia sempre da vicino: la querelle di
Sequeri (secondo il quale la riforma liturgica si sarebbe mossa tra didascalismo e ridondanza) non
P. SEQUERI, Ritrattazioni del simbolico. Logica dell’essere-performativo e teologia, Cittadella, Assisi 2012, 120-121.
C. KRAUSE, Simboli iconici o iconoclastia del simbolo? Passi tra pathos e patologia della teologia sacramentaria,
prefazione a P. SEQUERI. Ritrattazione del simbolico, 29.
4
5
2
prenderebbe in seria considerazione l’effettiva celebrazione cristiana. Dunque una sfida sequeriana
circa una necessaria riscoperta dell’essere affettivo implicato nei sacramenti, un rilancio di Krause
secondo il quale tale comprensione non sarebbe una radicale novità e un affondo di Grillo secondo
il quale non bisogna perdere di vista “l’effettivo liturgico” per non rischiare un “affettivo
formalistico”: un interessante esempio di come il ricorso materiale alla semantica rituale e
simbolica non conduca ad un effettivo accordo di intenti. Solo per inciso, sia Grillo che Krause
citano Casel, Guardini, Rahner e Chauvet come fautori di una “svolta simbolica”, e ne parlano
come un corpus di autori piuttosto compatto: se intuitivamente se ne possono comprendere le
ragioni, è tuttavia legittimo discutere che gli autori evocati abbiano un’idea condivisa di ritualità e
di simbolicità.
All’ampiezza della questione vorremmo rispondere con un timido tentativo di interrogazione di
alcuni filoni della teologia del Rito.
1. La categoria di rito è ancora pertinente?
La domanda potrebbe suonare come piuttosto forte, e tale è stata quando Sequeri l’ha posta nelle
sue già citate lezioni vagagginiane, tenute il 14 aprile 2011 presso il Pontificio Ateneo
sant’Anselmo, in cui ha proposta una ritrattazione circa la categoria di simbolo. Se “ritrattare” il
simbolo suscita un certo imbarazzo, non è stato minore il disagio quando Casel ha iniziato a
proporre di “trattare” il rito: la pertinenza della categoria è parsa come disdicevole per la teologia.
In una suggestione potremmo affermare che la nozione di “rito” è sempre stata “impertinente” per
la teologia, nell’accezione del vocabolo di “urtante, sconveniente, fastidioso”. L’impertinenza del
rito non depone necessariamente a sfavore della sua pertinenza (intesa qui come legittimità). La
domanda che si pone è dunque la seguente: come la teologia può farsi carico della perenne
“impertinenza” del rito?
1.1 Una possibile non pertinenza
La tesi sostenuta da Sequeri è la seguente: «Quella che continua ad essere intitolata e descritta come
questione dell’immagine è in realtà la messa a punto della questione del sacramento»6. La nozione
di immagine viene dunque impiegata come strumento concettuale idoneo a comprendere quella di
sacramento: ogni fraintendimento sull’una si riversa necessariamente sull’altra. Il sacramento infatti
è veicolo di una presenza di Dio nella forma della significanza: la potenza del sacramento dipende
dal rapporto che intercorre tra il suo essere immagine e il mettere in presenza, ma quando un segno
può essere mediatore di una presenza?
La recezione della questione delle immagini è molto differente in Oriente e in Occidente. In Oriente
l’iconografia è piuttosto un esercizio di obbedienza che di creatività, in quanto l’accento è posto
sulla “presenza”. L’icona è mediatrice di una presenza: non è decisiva la sua funzione
rappresentativa. L’Occidente invece prenderà la traiettoria opposta: l’accento viene posto sulla
“rappresentazione”. Le conseguenze artistiche sono enormi: ciò che conta non è l’obbedienza a uno
stilema che debba mettere in presenza del divino, ma rappresentare per poter rendere meglio
un’idea e per veicolare un messaggio. Per l’Occidente «simboli e immagini sono anzitutto registri
metaforici e poetici del logos: sussidiari del pensiero»7. La semantica simbolica e segnica risulta
così già inscritta nell’ordine del concetto e della didascalia, con funzione ausiliaria rispetto alla
forma discorsiva del concetto. Quando il simbolo ha una funzione puramente didascalica e lo sforzo
di pensiero è interamente centrato sul concetto, «il tema del sacramento, irriducibile al regime della
6
7
P. SEQUERI, Ritrattazioni del simbolico, 41.
Ibid., 40-41.
3
rappresentazione e dei suoi effetti, è semplicemente perso. Svanisce dalla teoria della rivelazione e
della fede, per incistarsi nel territorio della pratiche rituali e delle affezioni devote»8.
Il ragionamento scandaglia in profondità uno dei limiti dell’impostazione epistemologica classica
sui sacramenti, che la teologia contemporanea non ha ancora completamente superato. Il trattato di
sacramentaria infatti risente di una tradizionale “schizofrenia epistemologica”: gli elementi
“oggettivi” dei sacramenti infatti sono appannaggio del diritto, i suoi fondamenti della teologia
fondamentale, i suoi effetti ultimi della teologia spirituale, il suo aspetto rituale della liturgia. Alla
teologia dei sacramenti resta ben poco, se non la determinazione di alcuni elementi minimali che le
restano come specifico (materia/forma, transustanziazione, res sacramenti, ecc…). Il problema di
una tale frammentazione è che riflette una “schizofrenia della verità del sacramento”: da un lato la
teologia spirituale ha la sua “verità” legata agli effetti individuali del sacramento, la liturgia spesso
deve attingere ai progetti ritologici delle scienze umane per fondare un discorso che abbia valenza
veritativa, il diritto prende la sua strada e la teologia si sofferma ad approfondire le categorie in uso,
non in grado però di offrire un’effettiva sintesi dei livelli veritativi in gioco. Ha dunque buon gioco
Sequeri nel sostenere che il tema del sacramento semplicemente si perde: diviene regionale rispetto
all’ambito fondamentale della fede in quanto destinato ad essere didascalico e non decisivo per la
forma della fede.
La schizofrenia in esame è la radicalizzazione di una dualità che è già insita nella tradizionale
definizione di sacramento come “segno efficace”:
Lo scollamento tra segno e causa riproduce quello tra significante e referente e più radicalmente quello tra
linguaggio e azione. È evidente come tale scollamento sia stato trascritto nella teologia del sacramento. Il
sacramento è un segno, ma la sua efficacia è relegata all’unica vera causa che in un modo o nell’altro appartiene
all’ordine del pensiero: anzitutto del pensiero o intenzione di Dio, e in seconda battuta del pensiero (intenzione)
dell’uomo […]. L’efficacia del segno sacramentale è quindi relegata a un’azione che vale prevalentemente per la
sua intenzione.9
A queste condizioni è difficile comprendere la pertinenza del rito nel suo possibile apporto
teologico: se il simbolico è depotenziato nella sua portata veritativa, il rito, che vive di simboli,
potrebbe al massimo avere un ruolo edificante o didascalico, ma non avrebbe nulla da dire per la
verità del sacramento. Ciò che fa difetto è il modello veritativo in uso, che istituisce il ‘concetto’
come suo partner adeguato, e convoglia il ‘simbolico’ a livello di esemplificazione. La riflessione
non può fare a meno di esprimersi per concetti, ma occorre un pensiero che sia in grado di
corrispondere alla res, che è di natura pre-verbale ed extra-concettuale. Il tendenziale appiattimento
del linguaggio simbolico occidentale sulla sua trascrizione concettuale, relegando gli elementi
“extra verbali” a semplici complementi, fa da riflesso a una teologia dei sacramenti che si occupa
delle pure categorie, non concedendo spazio agli elementi simbolico-rituali.
1.2 La perenne impertinenza del rito
La riflessione di Sequeri offre un modello concettuale piuttosto interessante: il rito sta al simbolo,
come la teologia dei sacramenti sta al rito. Si potrebbe anche aggiungere, come ultimo passaggio
della catena, che la teologia fondamentale sta alla teologia dei sacramenti. Conviene svolgere
analiticamente i tre passaggi.
Alla base del concatenamento c’è la nozione di simbolo. Secondo il ragionamento di Sequeri, essa
risulta compromessa da un concettualismo di fondo, che non concede al simbolo un effettivo ruolo
in ordine alla verità: nelle nervature della cultura occidentale essa è gravata da un pregiudizio
intellettualista secondo il quale l’originario fenomenologico dell’evidenza è occupato dal logos
8
Ibid., 48.
G. BONACCORSO, Il sacramento tra azione e linguaggio, in ATI, Sacramento e azione. Teologia dei sacramenti e
liturgia, Glossa, Milano 2006, 107-141, qui 124-125.
9
4
della trascrizione concettuale, e non dal pathos dell’affezione, piuttosto che dall’energeia
dell’azione. Nell’impianto aristotelico, che tanto influsso ha avuto su tutta la metafisica medievale e
moderna, la relazione è una proprietà accidentale dell’ente. In questi termini il simbolico, che per
definizione vive di relazionalità, non può trovare spazio nell’originario dell’evidenza. In uno suo
studio (purtroppo poco considerato), Casel metteva in luce come nel periodo pre-imperiale si sia
giocata una partita decisiva tra due modelli di ragione: «Da un lato il modello platonico in cui esiste
un’eccedenza della sacralità e del modello mitico-narrativo sulla concettualità, dall’altro lato
abbiamo il modello stoico caratterizzato dal razionalismo concettuale che vede nel “fabuloso” una
forma di ragione secondaria e da superare» 10 . A giudizio di Sequeri, questa lettura (che non
attribuisce al simbolico-narrativo-fabuloso un ruolo nel regime dell’evidenza) è un pregiudizio da
cui l’Occidente ha sempre faticato a uscire. Analogamente, e di conseguenza, il rito ha avuto un
destino simile. In ambito ellenistico, sempre nel periodo pre-imperiale, compare il linguaggio del
“culto spirituale”. Filone d’Alessandria parla del “culto spirituale” come dell’offerta di preghiere e
dell’obbedienza alla legge in tutte le comunità dalla diaspora, ritenendo il culto dell’Antico
Testamento nient’altro che un’allegoria di questo reale culto spirituale, unico gradito a Dio. In
ambito pagano, i filosofi sono piuttosto compatti nel ritenere il culto sacrificale come una forma
degenerata dell’unico sacrificio spirituale gradito alla divinità, pur diversificandosi sui modi di
intendere sia Dio che i riti. Unica eccezione è costituita da Giamblico, che non vede concorrenza tra
un culto spirituale e l’effettiva esecuzione di riti; eccezione piuttosto significativa, in quanto il
cristianesimo primitivo utilizza la nozione di culto spirituale in questa linea11. Ma ben presto anche
il linguaggio cristiano andrà nella linea di una sottodeterminazione simbolica e rituale: in Agostino
«vi è la consapevolezza della rilevanza dell’intero contesto celebrativo in cui si realizza la stretta
relazione tra il Cristo che opera nei sacramenti e la comunità che viene edificata»12; tuttavia egli
introduce una nozione destinata in futuro a compromettere l’unità di questi aspetti, ossia l’idea di
“segno”, definito come «una cosa che, oltre all'immagine che trasmette ai sensi di se stessa, fa
venire in mente, con la sua presenza, qualcos'altro»13: l’accento è ormai posto evidentemente sul
contenuto mentale.
Qualora il rito sia da intendere “in genere signi” e il segno sia qualcosa che è semplicemente un
rimando al referente, non è difficile immaginare che la teologia si sia sviluppata nella logica
dell’esplicitazione dei referenti concettuali, lasciando “la cosa” del rito e “l’immagine che trasmette
ai sensi” sullo sfondo.
Se consideriamo uno degli ultimi autori della teologia del manuale, A. Piolanti, notiamo un certo
sforzo nel considerare l’aspetto rituale del sacramento: egli definisce i sacramenti come «le mani di
Cristo stesso nello spazio e nel tempo» 14 . L’aspetto rituale sembra così integrato, ma quando
l’Autore deve rendere conto della necessità di questo aspetto visibile del sacramento, la
giustificazione ricorre a due argomenti: da un lato al principio di autorità (il settenario ha un valore
per il fatto che è stato istituito da Cristo15), dall’altro ad un principio di convenienza (infatti «è
attraverso il visibile che l’uomo giunge allo spirituale; la sua intelligenza non dispone di un altro
mezzo per conoscere il soprasensibile»16). L’indagine sulla natura del rapporto tra il simbolo e la
M. BELLI, Caro veritatis cardo. L’interesse della fenomenologia francese per la teologia dei sacramenti, Glossa,
Milano 2013, 42.
11
Cfr. O. CASEL, Die λογικὴ θuσία der antiken Mystik in christlichliturgischer Umdeutung, in «Jahrbuch für
Liturgiewissenschaft» 4 (1924), 37-47.
12
G. BONACCORSO, Il Dono efficace. Rito e sacramento, Cittadella, Assisi 2010, 86.
13
AGOSTINO, De doctrina cristiana, 2,1.
14
A PIOLANTI, Sacramentalità, in IBID. (ed), I sacramenti, LEV, Roma 1959, 3-54, qui 9.
15
Cfr. Ibid., 18.
16
Ibid., 20.
10
5
verità non costituisce un problema entro il quadro intellettualista di riferimento. Il pregiudizio di
carattere intellettualista nei confronti della struttura dell’evidenza assegna al rito sacramentale un
ruolo didascalico ed esplicativo di una verità che non risiede in esso e nella sua drammatica.
Sfogliando le pagine del testo a cura di Piolanti, notiamo un interessante capitolo intitolato Liturgia
e Sacramenti (scritto da P. Albrigi), ma dove di fatto l’intento teoretico è quello di “spiegare” i
simboli sacramentali, offrendone una trascrizione concettuale. Ciò che è importante del simbolo
rituale non è la sua intrinseca struttura, bensì la sua capacità di rimandare a dei concetti, che la
teologia sviluppa.
Un altro teste interessante nel periodo immediatamente seguente al Concilio Vaticano II è L. Ligier.
Nelle sue dispense pro manoscritto (in uso negli anni ’70 presso l’Università Gregoriana) parla in
due capitoli del rito della Messa, ma il discorso teologico si sviluppa attorno alle categorie di
comprensione, quali l’attualizzazione del sacrificio di Cristo nella messa, la transustanziazione, gli
effetti della comunione e l’unione della Chiesa al sacrificio di Cristo. Il rito non costituisce un
problema teologico, ma è semplicemente la miniera da cui attingere i diversi temi. Si può così
giungere al paradosso di una teologia della transustanziazione assolutamente perfetta nella finezza
concettuale, ma che funzionerebbe anche a prescindere dal fatto che essa accade in una cena e con
del pane e del vino. Essi infatti sono solo gli “accidenti”: si accenna all’idea che pane e vino siano
anche “simboli”, il quale comporta un certo «grado di partecipazione»17 alla realtà intelligibile. Ma
l’implicazione del pane e del vino e del contesto di un banchetto è completamente indifferente alla
teologia della transustanziazione, che si sviluppa a monte e a margine del rito.
Una teologia dei sacramenti puramente incentrata sulle categorie non è priva di conseguenze anche
per l’istanza fondamentale della teologia. Non esiste un manuale di teologia fondamentale che non
faccia nominalmente appello alla categoria di evento, ma se il pensiero che presiede ad una tale
riflessione è di natura non evenemenziale e non simbolica, ne consegue che in realtà non abbiamo a
che fare con una teologia della verità come evento, ma di una verità che attinge all’evento come
“miniera di contenuti”. Se la verità cristiana ha i contorni dell’evento di Gesù Cristo,
l’evenemenzialità non è mai superabile per colui che vi accede. Una teologia dei sacramenti “in
genere ritus” costringerebbe la teologia fondamentale a misurarsi con un’evenemenzialità
dell’accesso alla fede sempre in atto e mai riducibile ai suoi contenuti.
Non sono mancati i tentativi di inscrivere la pertinenza del rito per la questione fondamentale della
fede, ma la questione resta perlopiù ancora da pensare. Non è sufficiente “fargli spazio” come
appendice alla teologia fondamentale, La pietra miliare nel lavoro di integrazione tra Movimento
Liturgico e teologia fondamentale è il lavoro di A. Grillo del 1995 Teologia fondamentale e
liturgia, in cui si esprime in questi termini:
L’affacciarsi della liturgia sulla teologia fondamentale trova il suo esito nell’apparente contraddizione di una
teologia fondamentale che necessita di affacciarsi sulla liturgia, quasi che la domanda di senso del celebrare,
interpellando i fondamenti del credere, susciti in questi non semplicemente una risposta diretta, ma una nuova
domanda: non più «perché celebriamo», ma piuttosto «come mai non è possibile credere senza celebrare, senza
un sostrato cultuale della fede riflessa?»18
Forse la domanda può ulteriormente essere radicalizzata: perché non è possibile l’uomo senza
celebrare? È possibile parlare della ritualità non solo come funzionale alla rivelazione o alla fede,
ma come implicata di diritto, perché di fatto costitutiva del problema dell’evidenza in genere? Il
problema del rito non richiede un semplice “aggiustamento” della teologia fondamentale, ma una
riflessione radicale sulla nozione di evidenza. Il rischio sarebbe quello di una ritualità impertinente,
L. LIGIER, Il sacramento dell’eucaristia, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1977, pro manoscritto, 164.
A. GRILLO, Teologia fondamentale e liturgia: il rapporto tra immediatezza e mediazione nella riflessione teologica,
Messaggero, Padova 1995, 11.
17
18
6
che provoca la teologia a comprendere la pertinenza, ma sempre come possibile e futura; si
giungerebbe a una teologia esausta. Secondo un adagio di E. Falque, «non abbiamo altra esperienza
di Dio che quella dell’uomo»19: se si intende salvaguardare l’espressione da un puro parallelismo
senza alcuna correlazione tra esperienza umana e rivelazione, occorre riconoscere che tra i due
ordini non esiste dualismo, ma piuttosto intima implicazione. La rivelazione non accade “a
margine” rispetto alle forme di accesso dell’uomo all’evidenza: esse già gli appartengono! Se non si
chiarisce questo intimo legame, anche il rapporto tra l teologia della liturgia e la teologia
fondamentale sarà relegato a una pura correlazione, dove i due ordini rimarranno paralleli, senza un
effettivo legame. Occorrerebbe invece chiarire perché il rito è pertinente alla questione dell’uomo, e
quindi alla rivelazione, e viceversa (perché la rivelazione è pertinente alla questione dell’uomo, e
quindi alla ritualità).
1.3 Verso una teologia della pertinenza
Se è vero che da più di cinquant’anni in teologia si parla di “rito” e si auspica un legame tra la
teologia fondamentale, la teologia dei sacramenti e la liturgia, è anche vero che raramente la
questione è stata posta nella sua ampiezza. La radicalità della domanda sembra sia stata misurata
con lo spazio da riservare alla domanda sui riti entro la teologia fondamentale, e l’autore più
“ingombrante” da questo punto di vista è S. Marsili, che non parla più di teologia della liturgia,
bensì di teologia liturgica, poiché tutta la teologia dovrebbe avere una intonazione e una
inclinazione alla liturgia come luogo in cui essa si invera; «la teologia liturgica è la teologia “in
funzione” della liturgia» 20 . In Marsili abbiamo dunque una coincidenza della liturgia con la
teologia.
All’opposto abbiamo la proposta di Vagaggini, secondo il quale «l’istanza liturgica […] ha posto e
pone il principale seguente problema: come la teologia possa arrivare ad assimilare organicamente
anche l’aspetto di storia sacra sempre in atto, realizzantesi nei riti sacri, che è la prospettiva
dominante in cui la rivelazione è proposta e vissuta nella liturgia?»21. In questo caso il problema dei
riti porrebbe semplicemente qualche domanda nuova e fruttuosa alla teologia, che ne rimarrebbe
tutto sommato immune.
Tra la semplice coincidenza di liturgia e teologia e l’idea che la domanda sul rito sia un “capitolo in
più” dei trattati, possiamo collocare tutte le varie proposte epistemologiche del problema in esame
circa la pertinenza del rito per l’istanza fondamentale della teologia. Ma in questo modo
“l’impertinenza” del rito fuggirà ad ogni forzatura, se non si pone la domanda più radicale circa
l’iscrizione della ritualità entro il regime dell’evidenza della rivelazione. Dopo che per secoli il rito
non ha avuto pertinenza per la teologia, la frangia “epistemologica” del movimento liturgico ha
puntato a metterne in luce l’impertinenza, la sua portata provocatoria per la teologia. Il contributo
ha certamente una sua importanza, ma il prolungato tentativo di rimarcare l’impertinenza non fa
altro che riconoscere il solco tra teologia e rito. Detto in altri termini, forse il tempo in cui segnalare
il problema è concluso, ed è giunto il momento di tentare autentici progetti teologici che non
facciano del rito un’appendice. R. Guardini, dopo l’inizio del Movimento Liturgico caratterizzato
da una grande attenzione alle fonti, lamentava che il continuo studio delle fonti, attento a rimarcare
lo scandalo della loro rimozione, doveva cedere il passo ad uno studio in cui pensare a come ridare
dignità teologica alla ritualità. Siamo passati così da una teologia del rito “non pertinente” ad una
teologia dell’impertinenza del rito. Almeno come provocazione, segnaliamo l’interrogativo: è forse
19
E. FALQUE, Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la résurrection, Cerf, Paris 200, 37.
A.M. TRIACCA, Teologia della liturgia o teologia liturgica? Contributo di P. Salvatore Marsili per una
chiarificazione, in «Rivista liturgica» 3 (1993), 267-289, qui 283.
21
C. VAGAGGINI, Liturgia e pensiero teologico recente. Discorso tenuto in occasione dell’inaugurazione del PIL il 9
dicembre 1961, Pro Manoscritto, Roma 1962, 43.
20
7
giunto il momento di una teologia della pertinenza del rito?
In conclusione a questo primo filone di riflessioni, l’aggettivo impertinente, nella sua accezione di
“scomodo, non facile da gestire” si adatta bene alla categoria di rito, che fugge troppo facili teologie
che ne legittimano la pertinenza. Scortati da Sequeri abbiamo scoperto che il problema è il modello
di teoria del simbolo in uso. La pertinenza della categoria di rito è possibile solo a patto che se ne
prenda seriamente in carico la radicale “impertinenza” a strutture di evidenza che le sono previe. La
domanda dunque è perché non sia possibile un uomo che non creda e che non celebri, poiché le tre
questioni (dell’uomo, della fede e della ritualità) non sono raccordabili se non entro l’unica
questione fondamentale dell’evidenza del vero.
2. Chi può legittimamente indagare sulla questione? Problemi di epistemologia liturgica e
teologica
Dopo aver chiarito la domanda, non è facile discernere circa il titolare dell’indagine. Quando i
pionieri del movimento liturgico hanno intuito che era necessario parlare di “rito” in teologia, si
sono trovati oggettivamente in difficoltà, perché “in casa” non era reperibile alcun modello
teologico in grado di affrontare l’idea di una verità antropologicamente e simbolicamente pregnante
che accada in un evento, quale è un rito. Grazie al movimento liturgico, «la teologia riscopre che
non si può credere senza sacramenti e non ci sono sacramenti senza un atto rituale, ma fatica a
giustificare rigorosamente le affermazioni: le categorie fondamentali in uso non sembrano in grado
di ospitare l’idea di una verità che accade»22. La teologia dei sacramenti del Novecento è ascrivibile
entro due coordinate: «Da un lato la potenza del sacramento, e dall’altro il travaglio della ricerca di
modelli epistemologici, antropologici ed ontologici in grado di comprenderne la logica
eccedente»23.
La teologia si è dunque scoperta piuttosto impreparata di fronte all’irruzione del rito come suo
oggetto pertinente. Non stupisce che i primi teologi interessati alla ritualità si siano accostati alla
grande mole di lavoro prodotto dalle scienza umane, in vantaggio di almeno un paio di secoli
sull’interesse teologico per lo studio dei riti. Il connubio che è venuto a crearsi tra scienze umane e
teologia dei sacramenti è ancora piuttosto forte, ma la promettente interdisciplinarietà che è venuta
a crearsi non è priva di questioni epistemologiche.
La filosofia non ha mancato di interessarsi del tema: nel 1893 compare il fondamentale testo di M.
Blondel L’Action, secondo il quale «l’azione voluta non è soltanto ciò che ne sappiamo in anticipo,
come se fosse sufficiente essersi decisi per avere già operato. La si è voluta esattamente per ciò che
in essa deve oltrepassare la volontà attuale»24. Nei suoi scritti, Blondel non manca di riferimenti
piuttosto abbondanti all’eucaristia, anche se il quadro apologetico di riferimento e il non immediato
interesse dell’agorà teologica al tema hanno relegato la promettente riflessione sacramentale alla
marginalità.
Ogni stagione teologica ha elaborato alcune cifre sintetiche attorno alle quali si è trovato un “tacito
consenso” e si è sviluppata un’intesa. Il cristianesimo antico, nel confronto con la grecità, ha trovato
nel vocabolario del Logos un partner imprescindibile. Il medioevo ha segnato l’interesse teologico
per la categoria di “essere”, che, a giudizio di E. Brito, è una delle ragioni per cui anche all’inizio
del Novecento, i teologi si interessano di un lavoro come quello di Heidegger attento al linguaggio
dell’essere25. Oggi una delle parola più di moda in teologia è “fenomenologia”. In particolare per la
22
M. BELLI, Caro veritatis cardo, 4.
Ibid., 220.
24
M. BLONDEL, L’Azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della prassi, trad. it di R. Crippa, La scuola,
Brescia 1970, 208.
25
E. BRITO, La Réception de la pensée de Heidegger dans la théologie catholique, in «Nouvelle Revue théologique» 3
(1997), 352-353.
23
8
teologia della liturgia, sembra quasi obbligato un riferimento al linguaggio fenomenologico. Cosa si
debba intendere per fenomenologia è però tutt’altro che evidente. Terrin denuncia il rischio di una
fenomenologia “minimale”, secondo la quale basta accennare genericamente a una descrizione per
poter sostenere che si sta facendo fenomenologia: «Si vive ancora oggi - a mio avviso - di un
'secondo rubricismo' deleterio, non certo più quello legato a piccole regole del rituale, ma quello
connesso a modifiche di sensi e di espressioni» 26 . In altre parole, esiste un approccio che si
definisce fenomenologico alla liturgia, ma che non ha nulla a che vedere con la fenomenologia
indicata da Husserl, impegnata sulle questioni fondamentali: il richiamo al “ritorno alle cose stesse”
si esaurisce ad un semplice elenco di cose, senza uno sforzo teorico autentico circa le ragioni del
rilievo ontologico del descrivere.
La fenomenologia “di scuola”, in particolare di stampo francese, si è interessata con una certa
ampiezza di problemi legati alla teologia dei sacramenti e alla ritualità27. Marion esordisce, nel suo
primo testo importante, con un capitolo intitolato “Del sito eucaristico della teologia” 28. Nel 2001
compare un suo saggio sull’eucaristia nell’importante raccolta La fenomenalità del sacramento, in
cui è presente un saggio significativo di M. Henry. Importante è lo studio sulla liturgia presente in
Esperienza e assoluto di J.-Y. Lacoste29. Davvero notevole e di grande interesse è il corposo studio
di E. Falque Le nozze dell’Agnello30. La recezione teologica del tentativo non è ancora così estesa
come forse meriterebbe.
Entro un panorama così ampio di tentativi, ci concentriamo soltanto su alcune puntualizzazioni
metodologiche ed epistemologiche.
2.1 Il contributo delle scienze umane
Il dibattito circa il rapporto tra le scienze umane e la teologia è di lunga data e ancora molto vivo.
Nell’ambito però della teologia dei sacramenti, dobbiamo riconoscere un fatto: di per sé l’interesse
per lo studio del rito si è generato nell’ambito di competenza dalle scienze umane, e la teologia vi è
giunta per seconda.
Il termine “scienze umane” allude ad un vasto ambito del sapere umano, tanto che l’espressione
risulta piuttosto vaga. Y. Hameline distingue quattro aree di studio sul rito ascrivibili a diverso
titolo alle scienze umane31. In primo luogo la sociologia: uno dei suoi padri fondatori, ossia E.
Durkheim, si occupa di riti in quanto decisivi per la decifrazione del fatto sociale. L’approccio
strutturalista è quello che riceve il credito maggiore da Hameline, anche se egli vi inserisce una
grande varietà di proposte accomunate dall’intento di andare oltre la prospettiva dello studio degli
“effetti” del rito: il rito non deve essere pensato entro una concatenazione di cause ed effetti, quanto
piuttosto come generatore di una sedimentazione culturale in grado di plasmare una tradizione. Il
terzo ambito è occupato dagli studi sulla liminalità: il rito interverrebbe come stabilizzatore nei
momenti di crisi della società. Da ultimo abbiamo studi ritologici condotti da etologi, che vedono
nella ritualità un cerimoniale che sedimenta l’ethos condiviso, anche se la tematizzazione di cosa sia
ethos appare piuttosto debole, a detta dello stesso Hameline.
26
A.N. TERRIN, Saggio di fenomenologia della religione. Per un rapporto autentico tra fenomenologia e
teologia/liturgia, in «Studia Patavina» 1 (2002), 157-199, qui 184.
27
Sul tema A. SACCHI, Fenomenologia e liturgia. Confronto teologico partendo da Michel Henry – Jean-Luc Marion,
Cittadella, Assisi 2011 e il mio già citato M. BELLI, Caro veritatis cardo. L’interesse della fenomenologia francese per
la teologia dei sacramenti.
28
J.-L. MARION, Dieu sans l’être, Fayard, Paris 1982.
29
J.-Y. LACOSTE, Expérience et absolu. Questions disputées sur l’humanité de l’homme, PUF, Paris 1994.
30
E. FALQUE, Les Noces de l’Agneau. Essai philosophique sur le corps et l’eucharistie, Cerf, Paris 2011.
31
J.-Y. HAMELINE, Éléments d’anthropologie, de sociologie historique et de musicologie du culte chrétien, in
«Recherches de Science Religieuse» 78 (1990), 397-424.
9
L’offerta di una riflessione sintetica su un panorama così vasto come quello evocato solo per
accenni è impresa assai ardua. Esistono però alcuni tratti comuni ai diversi approcci.
Prima di tutto è da notare che il rito costituisce un “dato” da studiare: la sua fenomenicità non è
interrogata, ma semplicemente assunta e indagata circa la sua funzione. Per il sociologo il rito è un
elemento strutturante la società: dal punto di vista metodologico egli constata che il rito “funziona”
e le sue indagini ruotano attorno al tipo di funzionamento del rito. Ugualmente lo strutturalista è
attento alla ritualità come “dato culturale”: di fatto ogni tradizione conserva una forma di ritualità.
L’etologia non può che prendere atto di una corrispondenza piuttosto stretta tra ethos e ritualità. Dal
punto di vista metodologico, le scienze umane propongono un’ermeneutica del rito, senza sentire
l’esigenza di una fenomenologia. Detto in altri termini: il rito c’è e funziona, e il contributo
scientifico della sociologia, della semiotica, dell’etologia, ecc… consiste nel mettere in luce le
diverse prospettive del suo funzionamento, costringendolo all’interno del proprio metodo
particolare32. In sé il lavoro che ne consegue è certamente prezioso, anche se non esaustivo.
Un secondo elemento costitutivo dell’approccio delle scienze umane risiede nel fatto che esse,
almeno nel loro innesco, accostano la ritualità «con la pretesa a emancipare il rito da (ogni)
teologia» 33 . In sé l’opzione non è necessariamente sbagliata, ma ancora una volta parziale: gli
antropologi, gli etologi e gli psicologi non assumono per metodo la prospettiva di colui che celebra
il rito, la cui intenzione teologica è decisiva. Il “rito celebrato” è in grado di dispiegare alcune
evidenze per il credente che le scienze umane escludono di principio, in quanto non appartenenti al
loro interesse. Non si intende entrare nella vasta questione del rapporto tra la teologia e le scienze
umane, tuttavia non è da escludere a priori che un’impostazione che tenda ad escludere la teologia
dal proprio oggetto formale non possa giovare anche a quest’ultima. L’etologo non è interessato al
risvolto teologico del rito, ma non significa che i suoi studi non possano essere utili a un lavoro
teologico. Ugualmente uno psicologo che si trovasse ad indagare sulle patologie e le nevrosi legale
alla ritualità, può essere certamente un prezioso contributo per un’azione pastorale.
Non mancano approcci molto interessanti che si appoggiamo ampliamente sugli studi delle scienze
umane per sviluppare delle riflessioni teologiche. Un lavoro come quello di G. Theissen si inscrive
in questa prospettiva. Nelle lezioni vagagginiane tenute da Theissen, egli ha buon gioco
nell’esplicitare la sue premesse torico-rituali, applicandole poi al rito cristiano e mostrandone
conformità e anomalie34. Se però un approccio di questo tipo venisse considerato come risolutivo e
non nella sua parzialità, tra fede e rito ci sarebbe un solco, e il legame sarebbe rimandato a un
semplice funzionamento: l’indeducibile cristologico sarebbe inintelligibile, o al limite diverrebbe
“anomalia” di un regime rituale più ampio e più esteso. Theissen infatti, dopo aver esplicato le sue
premesse, inizia un lavoro di corrispondenze tra la forma comune del rito e le eccezioni del rito
cristiano (si conoscono i nomi dei fondatori, importanza dell’agente rituale rispetto al destinatario o
alla forma, portata escatologica del rito di passaggio, superamento di una pura logica
compensativa). Il lavoro che ne consegue è illuminante e pertinente, ma da integrare con altri
approcci: il rapporto tra la cristologia e l’antropologia in ambito rituale non può limitarsi a
registrare le anomalie della prima in confronto alla seconda. Il sacramento cristiano non è
l’eccezione o la conferma del “rito antropologico”: è semplicemente la verità. E la ritualità
antropologica non può limitarsi al rilevamento statistico di alcune costanti nei vari riti.
L’interrogativo è più profondo: perché il rito pertiene alla verità dell’uomo? E in quale rapporto
stanno la verità dell’uomo e la verità di Dio in Cristo? Solo a questo livello i sacramenti cristiani
32
A. GRILLO, La «visione antropologica» dei sacramenti e la teologia. Ovvero, come fanno dei ciechi a identificare la
«verità» di un elefante, in «Ecclesia Orans» 20 (2003), 253-270.
33
A. GRILLO, Grazia visibile, grazia vivibile, Messaggero, Padova 2008, 21.
34
G. THEISSEN, La dinamica rituale dei sacramenti nel cristianesimo primitivo. Da azioni simbolico-profetiche a riti
misterici, Cittadella, Assisi 2013.
10
non sono una “giustapposizione anomala” ad una nozione di ritualità antropologica. Le scienze
umane, con tutti i meriti che non possono essere misconosciuti, non possono sostituire l’approccio
fondamentale al rito. Il sacramento cristiano non è “meno” rispetto alla ritualità antropologica e
quest’ultima non è un’anomalia rispetto all’ordinarietà dell’esperienza. Se le scienze umane offrono
un’indagine interessante circa le peculiarità della ritualità antropologica, il secondo dei rapporti
delineati (riti-esperienza ordinaria) convoca la filosofia, come momento imprescindibile
dell’indagine, mentre il primo rapporto (sacramenti-riti) richiede un lavoro di carattere teologico.
Tuttavia l’appello alla multidisciplinarietà 35 , che emerge con una certa frequenza quando si
affrontano le tematiche del rapporto tra scienze umane e teologia, richiede un attento discernimento
per evitare un indiscriminato accostamento epistemologico. In particolare non è condivisibile
un’impostazione che parlerebbe della teologia come adatta ad indagare il versante “cristologico”
della fede e delle scienze umane come incaricate dell’indagine sul versante “antropologico”. Tra i
due ordini si verrebbe a creare una schizofrenia incolmabile. L’autonomia dell’antropologico e lo
specifico cristologico non sono salvaguardate da una semplice ripartizione epistemologica in
scienze umane e teologia: il rapporto è da ricercare in una impostazione più profonda e più fine.
L’evento cristologico non annulla la verità dell’uomo: la croce è il segno definitivo che l’autonomia
dell’uomo non è sottovalutata dalla rivelazione; addirittura egli può segnare il corpo di Dio con il
suo rifiuto. L’eucaristia ospita permanentemente l’unicità dell’uomo come destinatario libero della
pro-esistenza del Figlio. Tuttavia l’uomo libero non è l’uomo “a monte” rispetto alla rivelazione, e
nemmeno l’uomo “trascendentale”. Non esiste “l’uomo della sociologia” o “l’uomo della
psicologia” che poi incontra la rivelazione cristologica: Cristo, implicando la creazione nella
comprensione del suo evento, convoca tutto l’uomo, che resta libero, ma mai escluso dalla
destinalità della grazia. Il rito cristiano, che celebra la grazia, ambisce a non essere una semplice
postilla dell’identità dell’uomo, che comunque si darebbe a prescindere da esso. La grazia non
annulla la libertà, ma la qualifica inevitabilmente sotto il segno dell’accoglienza o del rifiuto. In
questo senso parrebbe un po’ banale l’assegnazione di un’indagine antropologica “neutra” alle
scienze umane e del momento cristologico alla teologia, se non correttamente articolato. Il rapporto
tra scienze umane e teologia non è semplicemente da pensare in termini dialettici. Ma l’indelebile
pertinenza antropologica del rito non funge solo da contenitore della rivelazione e dell’atto credente
che le corrisponde.
2.2 Il rito e la filosofia
Alla fine dell’800 compare il prezioso testo di Blondel Action, il quale offre indubbiamente una
vasta gamma di motivi di interesse. Uno degli assunti fondamentali del libro consiste nell’ipotesi
secondo la quale l’agire apporta un incremento al conoscere che trascende il puro ordine
concettuale. L’azione voluta, l’azione pensate e l’azione agita non coincidono: quest’ultima apporta
un “di più” indeducibile rispetto agli altri due livelli del discorso. L’agire non consegue soltanto al
pensare, ma esiste anche un guadagno del pensare dovuto all’eccesso dell’agire. L’uomo è esposto
al rischio dell’agire, che apporta un inaudito nella sua esistenza. L’azione appella all’ordine della
libertà: la coscienza non genera soltanto pensieri, ma atti liberi; «necessariamente prodotta dalla
coscienza, la libertà si esercita necessariamente»36 . La libertà, nel suo effettuarsi in azione, conosce
delle resistenze: l’organismo e le sue dinamiche caotiche, le determinazioni passionali della libertà,
la tirannia del pensiero e, in fondo a tutto, l’orizzonte drammatico della morte. Tuttavia la volontà e
l’azione non si fermano di fronte al rischio del naufragio possibile nell’ordine naturale:
35
È la tesi sostenuta dallo stesso Hameline, ma cfr. anche L. GIRARDI, Liturgia e scienze umane: riflessioni introduttive
a partire da Sacrosanctum Concilium, in APL (ed.), Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca, Ed. Liturgiche,
Roma 2002, 9-56.
36
M. BLONDEL, L’Azione. Saggio di una critica della vita e di una scienza della prassi, 57.
11
l’insuperabilità dell’azione necessaria appella ad un ordine soprannaturale. Ma «l’azione non può
rinchiudersi nell’ordine naturale; non vi sta dentro tutta intera. E tuttavia non può oltrepassarlo con
le sue sole forze»37. Secondo Blondel «abbiamo il dovere di cercare instancabilmente, poiché non
cerchiamo se non avessimo già trovato ciò che mai possiamo raggiungere nel suo fondo, ciò che
perdiamo quando crediamo di tenerlo saldamente»38. L’orizzonte soprannaturale risulta così per
l’uomo «assolutamente impossibile e assolutamente necessario»39, disponibile soltanto nella logica
di una rivelazione del soprannaturale, a cui l’assenso di fede appare come ragionevole e
giustificato40.
Nel 1993 M. Antonelli pubblica la sua tesi dottarale in cui sostiene che l’architettura dell’Action di
Blondel è «segretamente attratta dall’eucaristia, quasi ad invocarvi una chiave di volta per l’intero
edificio dell’umano vivere» 41 . Blondel non parla mai dell’eucaristia nell’Action, tuttavia
l’accostamento della struttura teorica dell’Action agli scritti spirituali dell’autore mette in luce
sorprendenti convergenze.
Una prima convergenza è la restituzione della qualità di “atto” della fede. La fede non può risolversi
in una pura teoria; «tutta la tesi blondeliana è la declinazione di uno smantellamento di questi due
principi: l’esclusiva interiorità della religione e l’incontenibilità della fede negli atti»42. L’atto della
fede è possibile perché Dio ha compiuto un atto nei nostri confronti, che nell’eucaristia ha raggiunto
una sua definitività. Scrive infatti Blondel: «Oh! l’atto di Dio nella santa comunione è la
generazione divina, il Natale perpetuo del mondo»43. L’agire di Dio in Cristo non è separabile dalla
sua destinalità: proprio in virtù della sua proesistenza, il corpo eucaristico di Cristo, il suo corpo
mortale e il suo corpo glorioso presentano un’affinità che sfocia nell’identità. Poiché la modalità
ordinaria per l’uomo di vivere non è il conoscere intellettuale, ma il vivere, anche Dio si è esposto
all’azione, e l’eucaristia è la sua esposizione perenne.
Non solo Dio diviene conoscibile perché entra nell’orizzonte dell’azione, ma anche per l’uomo
l’azione diviene decisiva affinché si realizzi la fede in Dio. L’eucaristia non è semplicemente un
segno della fede, ma il luogo in cui l’agire di Dio e l’agire dell’uomo si incontrano: «Il sacramento
è più di un simbolo come l’incarnazione è più di un’allegoria»44. L’uomo è necessitato, ma non
garantito in ogni sua azione: la ricerca di una moralità del suo agire è ciò che lo contraddistingue.
Ponendo la comunione eucaristica, l’uomo raggiunge il livello più alto di moralità. In un’azione
infatti egli incontra il senso ultimo del suo agire, che imprime una possibilità nuova alla sua
esistenza nella logica della compassione. Antonelli riporta il seguente passaggio dai manoscritti di
Blondel: «La comunione è veramente l’atto morale per eccellenza! “Agisci, per tutti; come tutti
dovrebbero agire; porta l’umanità nel tuo atto, e il tuo atto nell’assoluto – La comunione è la vita
universale, l’umanità intera nella Divinità”». E commenta così: «L’azione eucaristica eccelle in
quanto compie – e non potrebbe darsi compimento se non in questo ordine della grazia – la tensione
morale insita in ogni atto»45.
Il lavoro di Antonelli è molto documentato circa le diverse corrispondenze che intercorrono tra il
pensiero blondeliano dell’azione e la sua “teologia implicita” dell’eucaristia, che emerge soprattutto
37
Ibid., 153.
Ibid., 160-161.
39
Ibid., 164.
40
Per una ricostruzione sintetica dei temi trattati in L’Action cfr. G. TANZANELLA-NITTI, La proposta apologetica
apologetica di Maurice Blondel (1861-1949), in «Annales theologici» 25 (2011), 45-74.
41
M. ANTONELLI, L’eucaristia nell’”Action” (1893) di Blondel. La Chiave di volta di un’apologetica filosofica, Glossa,
Milano 1993.
42
Ibid., 93.
43
M. BLONDEL, Carnets intimes, cit. in M. ANTONELLI, L’eucaristia nell’”Action” (1893) di Blondel, 186.
44
Cit. in M. ANTONELLI, L’eucaristia nell’”Action” (1893) di Blondel, 107.
45
Ibid., 114.
38
12
dai manoscritti di carattere auto-biografico e spirituale. A partire dalla semplice ricostruzione che
abbiamo offerto, è possibile fare alcune annotazioni metodologiche. La riscoperta della pratica
dell’azione come nucleo antropologico conduce ad uno sguardo sulla rivelazione come atto e a un
incontro tra l’uomo e la rivelazione di natura sacramentale. L’agire implica così una corrispondenza
tra antropologia, teologia e sacramentaria. Blondel, almeno implicitamente, mette in luce il
parallelismo tra i tre ordini dell’unico problema. Il desiderio di un superamento di un
intellettualismo teologico di fondo e la riabilitazione del pratico hanno condotto a una
focalizzazione dell’uomo come azione, della rivelazione come atto e dell’eucaristia come
sacramento per l’uomo. Il merito delle intuizioni blondeliane e la fecondità per la teologia
fondamentale sono dunque due punti fermi importantissimi, ben esplicitati da Antonelli nel suo
lavoro.
L’interrogativo che potremmo porre è in questi termini: è possibile andare oltre un parallelismo tra
agire umano, evento di Dio e sacramento? Le tre direttrici evocate sono semplicemente rette che
viaggiano in un parallelismo strutturale o sono segnate da una appartenenza reciproca più radicale?
Cristo è solo l’occasione della loro convergenza?
Dal punto di vista della teologia dei sacramenti, Blondel recupera l’idea di sacramento come
eccedente la pura logica del segno: spesso insiste sulla necessità della comunione eucaristica.
L’eucaristia non è ‘solo’ presenza reale o ‘solo’ sacrificio: è un atto umano e divino insieme. Ma la
giustificazione della natura di atto dell’eucaristia non è sufficiente per esprimerne il valore
antropologico e teologico insieme: occorre ribadire la qualità di questo atto, di natura rituale.
Antropologia, teologia e sacramentaria rimangono “buoni vicini” se l’agire dell’uomo non è
riportato entro un’ontologia della libertà e della coscienza credente, se l’agire di Dio è mantenuto
fuori da una tale ontologia e dal dramma della storia e se il sacramento non è riscoperto nella sua
natura rituale: la triade azione-rivelazione-sacramento richiama da vicino libertà-dramma-rito,
affinché tra gli elementi in gioco si dia effettiva reciprocità.
2.3 Fenomenologie rituali
A.N. Terrin sostiene con toni piuttosto forti che «ciascuno può affermare quel che desidera
credendo di fare “fenomenologia” e ritenendo che quella sua particolare visione sia “l’intenzionalità
fenomenologica” prima che tutti gli devono riconoscere» 46 . Del resto è piuttosto risaputo che,
secondo la celebre espressione di Ricoeur, la Fenomenologia non è altro che Husserl e l’insieme di
tutte le sue eresie. Ma sui temi rituali e, più in generale, in alcuni tentativi di filosofia delle
religioni, l’applicazione delle intuizioni husserliane non è davvero andata oltre all’assunzione di
alcuni slogan, come ad esempio “tornare alla cose stesse” o “analisi dei vissuti di coscienza”.
Poniamo un esempio: M. Augé, in un articolo apparso su «Rivista liturgica», propone una
fenomenologia del culto eucaristico fuori dalla messa, precisando che «parlando di
“fenomenologia” s’intende semplicemente affermare che lo scopo di queste pagine è quello di
descrivere e valutare la ritualità (atteggiamenti, preghiere e gesti) che accompagna questo tipo di
culto eucaristico» 47 . Gli studi di liturgia attuali sono ricchi di approcci simili: si parla di
fenomenologia del silenzio, fenomenologia del vegliare, fenomenologia dei riti offertoriali,
fenomenologia della festa, ecc…
In tempi abbastanza recenti, la bibliografia in questa direzione si è moltiplicata attorno ad una
questione, ossia l’orientamento dell’assemblea e del sacerdote durante la celebrazione. Non si è
lesinato il linguaggio fenomenologico circa l’assemblea liturgica (per cui si è parlato di
46
A. N. TERRIN, Per un rapporto autentico tra fenomenologia e teologia/liturgia. Saggio di fenomenologia della
religione, in CLV (ed.), Lituriga e scienze umane. Itinerari di ricerca, Edizioni liturgiche, Roma 2002, 121-154, qui
124.
47
M. AUGÉ, Fenomenologia del culto eucaristico fuori dalla messa, in «Rivista liturgica» 6 (2007), 883-898.
13
“fenomenologia dell’assemblea”, “fenomenologia dell’aggregazione”). I testi che, pur non
alludendo al linguaggio fenomenologico, si propongono come una collezione ragionata e riflettuta
di circostanza rituali sono molteplici. Un libro particolarmente citato è Rivolti al Signore48 che offre
una riflessione storica e di analisi rituale sulla posizione dell’assemblea, dell’altare e del celebrante
durante la liturgia.
Normalmente gli studi che vanno in questa direzione sono molto istruttivi e pertinenti: la
documentazione è generalmente molto approfondita e i riferimenti storici accurati. Per una
intelligenza complessiva della liturgia sono approcci molto significativi. Tuttavia è importante
segnalare un sospetto e una insufficienza.
Il sospetto nasce dal ricorso al linguaggio fenomenologico. L’impressione di fronte ai testi di questo
filone è che ci troviamo di fronte a lavori più ascrivibili ad una ermeneutica del rito, rispetto ad una
fenomenologia. Non potrebbe indurre a confusione il ricorso piuttosto indiscriminato alla nozione
di “fenomenologia”? La fenomenologia infatti non è tanto l’elenco dei fenomeni, quanto una
riflessione sul fenomeno e sulla fenomenicità. Le riflessioni citate non intendono proporre
un’eidetica sulla peculiare fenomenicità rituale: ci si attiene a un livello descrittivo e di
comparazione.
Gli apporti ascrivibili a questa fenomenologia del rito sono molto preziosi sia dal punto di vista
teologico che dal punto di vista pastorale. Ma emerge anche il lato problematico: non è sufficiente
una ripresa del rito solo in questi termini. L’indagine teologica non può eludere il problema del rito
nel suo rapporto alla verità. Se tali apporti fossero da ritenere esclusivi, saremmo passati da una
teologia che non considera la ritualità a una teologia che pensa al rito come a un “dato di fatto”. La
mediazione di un sapere che istruisca in quali termini il rito sia un dato per la teologia e un
fondamento per ogni antropologia resterebbe da tematizzare. Se all’origine del Movimento
Liturgico abbiamo un ressourcement legato alla riscoperta delle antiche fonti liturgiche, oggi
assistiamo ad un sovente ressourcement di secondo grado, i cui l’oggetto dello studio non è il solo
testo liturgico, ma anche le forme liturgiche. Così abbiamo studi che offrono una descrizione dei
momenti di silenzio della liturgia, parlano di un certo valore simbolico e antropologico del silenzio
e si presentano come “fenomenologia del silenzio”. Questo tipo di approccio è certamente
pertinente; ciò che però occorre segnalare è la sua parzialità: non basta isolare degli elementi del
rito per poterlo comprendere a pieno. La domanda impertinente è la seguente: che il ricorso alla
semantica fenomenologica nasconda qualche difficoltà fondativa circa la ritualità?
2.4 L’interesse dalla fenomenologia francese
L’incontro tra la fenomenologia e la Francia risale a una data simbolica: il 1929, anno in cui
Husserl tenne i celebri “Discorsi parigini”, tradotti da Lévinas, e diventati in seguito le Meditazioni
cartesiane.
Le letture dello sviluppo francese della fenomenologia sono molteplici: C. Tarditi, riprendendo una
espressione di Ricoeur, ha parlato di “eresie fenomenologiche”49 in rapporto ai lavori di Derrida e
Marion, mentre C. Canullo ha proposto la definizione di “fenomenologia rovesciata” 50. Un saggio
che ha decisamente provocato i fenomenologi francesi e la critica è il testo di Janicaud Le tournant
théologique e la phénoménologie française51 . Janicaud parla di “sbandata” della fenomenologia
francese verso la teologia in termini piuttosto polemici. Se di “sbandata” si tratta non si decide a
U. M. LANG, Rivolti al Signore. L’orientamento nella preghiera liturgica, Cantagalli, Siena 2008.
C. TARDITI, Con e oltre la fenomenologia. Le eresie fenomenologiche di Jacques Derrida e Jean-Luc Marion, Il
Melangolo, Genova 2008.
50
C. CANULLO, La fenomenologia rovesciata. Percorsi tentati in Jean-Luc Marion, Michel Henry e Jean-Louis
Chrétien, Rosemberg & Sellier, Torino 2004.
51
D. JANICAUD, Le tournant théologique de la phénoménologie française, L’èclat, Combas 1991.
48
49
14
priori, ma l’elenco dei temi trattati mostra con una certa evidenza l’interesse francese per temi di
tradizionale pertinenza teologica: l’esegesi biblica in P. Ricoeur e E. Lévinas, il fenomeno saturo
della rivelazione in J.-L. Marion, l’incarnazione in M. Henry, la liturgia in J.-Y. Lacoste,
l’eucaristia in E. Falque, la preghiera in J.-L. Chrétien. Nel 2000 si tiene presso l’Università
Lateranense un convegno dal titolo Il mondo del sacramento, a cui partecipano Marion e Henry con
due preziosi contributi52. Ed è del 2011 il corposo testo di Falque Les Noces de l’Agneau sul tema
dell’Eucaristia.
La fenomenologia è attenta per statuto alla fenomenicità: non stupisce dunque che, quando essa si
rivolge ai contenuti propri della teologia, sia attratta dal settore della teologia in cui l’accadere di un
fenomeno è l’oggetto formale dello studio, ossia la teologia dei sacramenti. Jean-Luc Marion, in La
fenomenalità del sacramento, rilegge l’eucaristia alla luce della categoria, decisiva per il suo
pensiero, del fenomeno saturo: in una realtà fenomenicamente povera accade un eccesso di
donazione, tanto che Dio si concede nel pane e nel vino fino ad abbandonarsi in essi. In De
Surcroît53 egli distingue quattro tipo di fenomeno saturo: l’evento (che satura la fenomenicità sotto
il profilo della quantità), l’idolo (saturo in quanto alla qualità), il corpo (saturo sotto il profilo delle
relazioni) e l’icona (satura per quanto riguarda la modalità). Al termine della mappatura evocata,
Marion si domanda se non sia possibile una saturazione di secondo grado, ossia un fenomeno che
risulti come la condizione prima del darsi di ogni realtà. A rigore un tale fenomeno risulta essere
im-possibile, ossia al di là delle possibilità dell’adonato (l’uomo in quanto assegnato a se stesso,
secondo il linguaggio marioniano): Marion chiama un tale fenomeno, saturo di secondo grado,
“rivelazione”. L’eucaristia deve essere compresa in questa logica: assolutamente im-possibile54 per
il soggetto, in essa si dona Dio «senza ritirarsi, fino all’abbandono»55.
Michel Henry dedica all’eucaristia un breve articolo nella stessa raccolta di Reali, ma piuttosto
significativo. In esso infatti sembra rileggere l’eucaristia come il sigillo della sua riflessione.
Tilliette sostiene che il lavoro di Henry può essere inteso come una sorta di “monadologia”56: non
esiste nulla oltre alla carne che si auto-sperimenta. L’uomo semplicemente “vive”; il parlare di “vita
individuale” sarebbe già una oggettivazione non supportata dal flusso del vivere. Il soggetto è
immerso nella vita, senza che questa gli appartenga o possa essere definita. Non esiste nulla che non
sia la carne che in sé stessa sperimenta la vita, e ogni tentativo dell’uomo di cosificare delle
esperienze o di parlare di un mondo a lui esterno sono strategie da definire come “oblio della vita”.
Nelle sue opere più attente a temi teologici, Henry parla del Padre come della Vita originaria. Cristo
è l’Archi-Figlio, cioè il primo generato entro la Vita e colui che si sperimenta come Figlio della
Vita originaria. Grazie a lui, gli uomini che vivono nell’oblio della vita possono tornare a
sperimentarsi come figli dell’unica Vita. L’eucaristia è quel dispositivo ante-predicativo mediante il
quale la nostra carne può entrare in comunione con la carne dell’Archi-Figlio che ha vissuto l’intera
esistenza come consegna alla Vita originaria.
Falque scrive invece Les Noces de l’Agneau come terzo volume di una trilogia dedicata alla Pasqua
di Cristo. Nel primo testo, Le Passeur du Gethsémani 57 , Falque inizia a trattare il tema della
finitezza. Essa non deve essere connotata negativamente come conseguenza del peccato: la finitezza
è la condizione fondamentale nella quale l’uomo viene a trovarsi. L’immanenza è assolutamente
insuperabile, è una sorta di grado zero dell’umano. La filosofia e la teologia muovono dalla
52
N. REALI (ed.), Il mondo del sacramento. Teologia e filosofia a confronto, Paoline, Milano 2001.
Cfr. J.-L. MARION, De surcroît. Essai sur les phénomènes saturés, PUF, Paris 2010.
54
Cfr. J.-L. MARION, Certitudes négatives, Grasset, Paris 2010.
55
J.-L. MARION, La fenomenalità del sacramento: essere e donazione, in N. REALI (ed.), Il mondo del sacramento, 134154, qui 140
56
X. TILLIETTE, Une nouvelle monadologie: la philosophie de Michel Henry, in «Gregorianum» 4 (1980), 633-651.
57
Cfr. E. FALQUE, Le passeur du Gethsémani, Cerf, Paris 2004.
53
15
finitezza: la filosofia non può che partire da essa, mentre la teologia non può che culminare nella
finitezza assunta dal Figlio. La teologia tuttavia può istruire la filosofia58 circa la possibilità di una
metamorfosi della finitudine59. La filosofia, soprattutto nella sua qualità fenomenologica, è attenta a
tematizzare la fenomenicità; ma un tempo divenuto eterno, un corpo divenuto risorto e un mondo
divenuto nuovo non sono fenomeni che possano essere trascurati. Nell’ipotesi di Falque, l’eucaristia
è il luogo proprio della metamorfosi della finitudine: mediante la consegna del corpo, Cristo
incorpora i discepoli nella vita metamorfizzata. L’eucaristia, mediante l’esperienza del corpo, del
pasto e dell’eros, è il luogo in cui la finitezza e l’animalità di Cristo, anche nelle sue esperienze
abissali (paura, angoscia) vengono metamorfizzate e il Padre le sperimenta per compassione.
Questo gesto di Dio assimila il discepolo nella metamorfosi di Cristo operata nell’Eucaristia e
compiuta nella risurrezione.
I tre approcci considerati sono molto diversi tra di loro, e su alcuni aspetti persino in opposizione.
Tuttavia esiste un minimo comune denominatore: il superamento dell’oblio, la metamorfosi della
finitudine e l’esperienza di assegnazione a se stesso dell’uomo in quanto adonato richiedono una
fenomenicità, che gli autori presi in esame rintracciano nell’eucaristia. La loro proposta
fenomenologica anela al sacramento, in quanto garante di un’effettività che riscatta le loro
riflessioni da un rischio di trascendentalismo. Se consideriamo il concetto di metamorfosi della
finitudine di Falque, egli sostiene che, grazie alla risurrezione di Cristo, il mondo è divenuto altro, il
tempo si è esteso nell’eternità e la carne è rinata in una nuova esperienza fenomenica del proprio
corpo60. Senza un atto in cui per il soggetto è accessibile la possibilità della metamorfosi, tutta la
precedente impostazione sarebbe tacciabile di essere un pensiero gnostico, dove l’unico
cambiamento intervenuto è una nuova forma di conoscenza. Proprio mediante l’eucaristia «non ci
sono due mondi nel cristianesimo – il mondo degli uomini e il mondo di Dio -, ma l’unità di uno
stesso mondo (quello di Dio) nel quale noi possiamo “mantenerci” e “dimorare” sotto l’effetto della
grazia o del viatico eucaristico»61. Discorsi analoghi possono essere fatti per Henry e per Marion.
La rivelazione non viene pensata come insieme di contenuti, e la fede come assenso della volontà:
emerge un potere trasformante della rivelazione, e una potenza pratica della fede. Anche sul
versante del sacramento il pensiero è ricco: viene riscattato dalla tradizionale regionalità dogmatica
e riportato al cuore dell’esperienza di fede. Tuttavia i tre autori considerati parlano molto raramente
di ritualità. Che la metamorfosi della finitudine, il riscatto dall’oblio o la saturazione della
fenomenicità avvengano in un evento rituale, con i tratti specifici del rito, sembra piuttosto
marginale. Il fenomeno sacramentale è ciò che sembra interessare i fenomenologi in questione, ma
la qualità rituale della fenomenicità in gioco viene trascurata.
La rimozione dell’aspetto rituale non è indifferente per la qualità complessiva del pensiero
sacramentale. Tra l’eucaristia e l’esperienza del fenomeno saturo, tra l’eucaristia e la metamorfosi
della finitudine e tra l’eucaristia e il riscatto dall’oblio della vita, in mezzo c’è un dramma della
libertà che viene convocata e che deve attuarsi. La realtà del rito non è a margine della libertà del
soggetto: il Vaticano II ha restituito il “dramma” della ritualità cristiana mediante la nozione di
“partecipazione attiva”. L’uomo non assiste semplicemente ai riti cristiani, ma vi partecipa.
La sottodeterminazione del rito operata dalla fenomenologia francese riflette i pregi e i difetti
teorici di questo tentativo filosofico. L’impostazione francese della fenomenologia ha conservato
infatti alcune delle conseguenze più gravide del pensiero husserliano: potremmo parlare di una
fenomenologia radicale, che non legge le intuizioni husserliane come semplici indicazioni
58
Cfr. E. FALQUE, Passer le Rubicon. Philosophie et théologie: essai sur les frontieres, Lessius. Brussels 2013.
Cfr. E. FALQUE, Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la résurrection, Cerf, Paris
2004.
60
Cfr. la terza parte di E. FALQUE, Métamorphose de la finitude, 159-236.
61
E. FALQUE, Les Noces de l’Agneau. Essai philosophique sur le corps et l’eucharistie, Cerf, Paris 2011, 369.
59
16
metodologiche e gli sviluppi heideggeriani come “eretici”. D’altra parte il rovesciamento operato
sul piano della passività della coscienza ha il suo peso: l’uomo è carne che si autosperimenta nella
vita, adonato o limitato, ma anche libero? La libertà esce piuttosto limitata dalle riflessioni dei
fenomenologi francesi: la sua posizione è una radicale passività che si riceve.
La figura cristologica della rivelazione sembra privilegiare una maggiore portata della libertà: il
Crocifisso-Risorto non è solo colui che apre alla possibilità della metamorfosi della finitudine, ma è
anche colui che assume il dramma della libertà umana che rifiuta. La figura concreta di rivelazione
non riduce la portata della libertà umana, che si dispiega nel dramma della storia: la compie,
portando l’onere della possibilità del rifiuto. La coscienza non è semplicemente assegnata al suo
ruolo da parte di Dio: l’effettività della coscienza che si decide è costituita da Dio come capace di
determinare la qualità del suo atto di rivelazione. Solo una buona ontologia della libertà può
restituire il dramma della fede, e solo una buona teologia del rito può fondare una teologia del
sacramento non riduttiva. Lo spunto fenomenologico francese è gravido di molte prospettive, ma
gravato da un difetto che, se non superato, rischia di inficiarne la recezione.
3. Quali modelli teorici di riferimento?
Gli approcci considerati sembrano concordi nell’invocare un pensiero fondamentale della ritualità.
In particolare l’approccio fenomenologico si dimostra piuttosto gravido e promettente. Husserl
torna a tematizzare, dopo il sequestro scientifico della questione, il problema dell’evidenza: cosa
accade perché esista un evento che si configuri come vero? Occorre inscrivere entro questo confine
la questione del rito: in che senso il rito non è marginale all’esperienza del vero? La fenomenologia
è la titolare di quell’indagine che tematizza la formalità dell’esperienza vera (l’affermazione è qui
da intendere senza connotazione qualitativa della semantica della verità). Rispetto ai diversi
approcci considerati, i fenomenologi di area francese hanno avuto il merito di portare la questione
al livello fondamentale delineato, pur con i limiti evidenziati nell’esecuzione concreta del progetto.
Non è ambizione di queste brevi riflessioni l’offerta in un modello alternativo, che richiederebbe
una indagine fenomenologia previa che esula dalle possibilità di un articolo. Lo scopo di queste
ultime riflessioni è quello di offrire alcune direttrici per una teoria fondamentale del rito.
3.1 Sentieri interrotti
Se a livello di indagini regionali sul rito o di indagini legati alle scienze umane i discorsi udibili
sono molteplici, quando interroghiamo la teologia su una teoria fondamentale della ritualità, udiamo
un silenzio piuttosto imbarazzante. Talvolta sembra che il rito sia un dato di fatto semplicemente da
assumere o da commentare. Non mancano tentativi teologici in cui la questione rituale è
semplicemente una appendice del trattato dei sacramenti, che però ne esce tutto sommato indenne.
Qualora si ricerchi impostazioni fondamentali, alcuni tentativi disponibili pongono diversi
interrogativi.
Sul panorama delle riflessioni fanno capolino lavori che tentano una teologia fondamentale del rito
con toni “dialettici”. Jean-Yves Lacoste descrive la liturgia in termini liminari: essa è non-luogo e
non-spazio, è ciò che mette in scacco l’ordinarietà della storia. La ritualità non è «esperienza del
mondo», ed è segnata da una «fondamentale dimensione non esperienziale»62. Ugualmente Chauvet
insiste sull’eterotropia del rito, che permette di passare «dal regime funzionale della fruibilità delle
cose al regime simbolico del loro senso»63. Ci domandiamo se sia così necessario porre in dialettica
l’esperienza rituale con l’esperienza ordinaria: il rito è semplicemente un’eccezione rispetto alle
62
63
J.-Y. LACOSTE, Expérience et absolu, 71-73.
P. CASPANI, La teologia sacramentaria di L.-M. Chauvet, in «La Scuola Cattolica» 4 (2010), 517-542, qui 523.
17
forme ordinarie dell’esperienza? Oppure la questione dell’evidenza reclama la ritualità? Le proposte
dialettiche circa la ritualità nascono da un connubio con una certa prospettiva di analisi del sacro:
poiché il sacro è “tremendo e fascinoso”, il rito è la restituzione di tale esperienza, per essenza
liminale e dialettica. Ma perché il “tremendo e fascinoso” sarebbero liminari rispetto all’esperienza?
Da dove nasce una tale distinzione? Quale evidenza può vantare? Se il sacro è semplicemente ciò
che mette in scacco l’esistenza, dove reperire il sacro nella vita di Gesù? Il suo camminare con i
discepoli, il suo sedersi a tavola con i peccatori, la morte da maledetto, sono ascrivibili all’area del
sacro? E nella vita umana? Il nascere, il soffrire, l’amare, il lavorare, sono esperienze sacre o
profane? La sacralità del rito eucaristico è davvero in alternativa o estranea al regime simbolico che
è già implicato quando l’uomo nasce, esiste, ama, soffre, lavora, pensa? Esiste un nascere, un
amare, un soffrire, un lavorare privo di forme rituali? La nostra tesi è che la ritualità è legata al
regime universale di accesso all’evidenza della verità: l’interrogazione sullo statuto formale
dell’evidenza del vero comporta il riconoscimento della ritualità come ad essa appartenente. Allo
stesso modo il sacro non deve essere pensato come un’eccezione rispetto al problema dell’evidenza:
quando accade un’esperienza, essa ha una forma sacrale e rituale. Il sacro è la determinazione della
qualità antropologica di ogni esperienza. Ciò che presiede alle nozioni di rito e di sacro è l’idea di
simbolo. È possibile uscire dalle ambiguità del rito come dialettico o del rito come “altro nome”
dell’esperienza, qualora si chiarisca il rapporto tra la simbolicità e l’ordinarietà dell’esperienza. In
questa direzione la molecola simbolo-rito-sacro può ricevere un ordine plausibile.
Secondo l’ipotesi interpretativa che stiamo via via chiarendo, il rito non è marginale per
l’esperienza dell’uomo in quanto umana. In questo senso concordiamo con un’affermazione di
Terrin quale: «Il rito è un primum con non può essere percepito se non nel contesto vivo del vissuto,
delle situazioni, dei compimenti fondamentali e ovvi del vivere»64. Il rito è essenzialmente vissuto:
se è vero che l’idea di simbolo è ciò che presiede alla concezione di rito, spiegare un simbolo è
ucciderlo, così come un rito. Il rito è essenzialmente agito, così come l’attuazione dell’uomo (a cui
il rito appartiene) è questione pratica. Nell’articolo citato di Terrin egli fa riferimento in maniera
molto pertinente alla semantica ludica: il rito non è tanto un gioco, è soprattutto agito “per” gioco,
con una ludicità totale. Ma il discorso, a nostro avviso, si fa problematico quando si accenna ad una
assoluta autoreferenzialità del rito: esso sarebbe «talmente autoreferenziale da non chiedere nessun
perché neppure in ambito simbolico»65. A questo livello avanziamo alcune questioni. Non si tratta
di trascrivere il rito entro categorie ad esso precostituite: «L’istituzione originaria del senso non
avviene su di un piano riflessivo, ma nell’esperienza effettiva (fattuale), la quale dimostra un
carattere essenzialmente pratico»66. La riflessione non può soppiantare il carattere pratico del rito,
che non appartiene alla “logia” ma alla “liturghia”. Si tratterebbe di trovare una forma di pensiero
in grado di riconoscere il primato del pratico, ma tale riconoscimento non può che avvenire
attraverso una forma discorsiva e riflessa. La dichiarazione di irriducibilità della ritualità pone dei
problemi fondativi non di poco conto, in quanto è già frutto di una riduzione concettuale. A nostro
avviso, dal punto di vista teorico è poco vantaggioso il richiamo ad una forma archetipa del rito che
non ammetterebbe altro. Il lavoro teorico dovrebbe invece mostrare a quale titolo la ritualità
appartiene alla questione dell’evidenza con la sua specificità: la ragione fenomenologica che
presiede al chiarimento non deve sostituire la forma della ritualità, ma vi si deve conformare. In
questo senso il rito ammette una riduzione fenomenologica: il rapporto tra il rito “ridotto”
fenomenologicamente e il rito accaduto non è da pensare in concorrenza, in alternativa o in
64
A.N. TERRIN, Il rito, per necessità e per gioco, in IBID. (ed.), Liturgia e incarnazione, Messaggero, Padova 1997, 4575, qui 57.
65
Ibid., 68.
66
M. EPIS, Teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2009, 542.
18
parallelo, piuttosto nella coppia forma-effettività. Il lavoro fenomenologico non intende sostituire
ciò che accade, ma ambisce a rintracciare la forma di “ciò che accade quando accade qualcosa”,
mostrando le possibilità dell’accaduto di inscriversi entro l’evidenza. Ci sembra più fruttuosa questa
seconda opzione, rispetto a una pura dichiarazione di archetipalità del rito che non ammetterebbe
ulteriori riduzioni, anche se raccogliamo l’invito ad elaborare una teoria che si attenga alla
fenomenalità rituale rintracciandone la forma, senza pretesa di sostituirvisi. Infatti «poiché il
Simbolo-Evento integra un criterio adeguato all’assolutezza della verità, esso fonda la possibilità di
un giudizio che ne condivide l’assolutezza»67.
3.2 Statuto fenomenologico della ritualità
Tentiamo di offrire una prospettiva sintetica in quattro tesi:
- Non c’è evidenza senza fede
- Non c’è attuazione dell’evidenza senza simbolo
- Non c’è attuazione del simbolo senza rito
- Non c’è fede senza rito
Non c’è evidenza senza fede
Il primo elemento da indagare è circa il rapporto che si istruisce tra la fede e la questione
dell’evidenza. Se la fede teologica è pensata in termini dialettici all’evidenza del vero, tutto ciò che
attiene alla fede teologica sarà pensato come fuori dall’evidente, e quindi in termini liminari,
regionali o dialettici, a seconda delle opzioni teoriche di fondo.
Quale rapporto dunque tra la fede e l’evidenza? Husserl, parlando della fenomenologia, diceva che
«è la prima volta che l’evidenza (questo morto idolo logico) viene trasformata in problema, viene
sottratta alla predilezione per l’evidenza scientifica [...]» 68 . La domanda circa quali siano le
condizioni formali di un’esperienza che possa esibire le credenziali dell’universalità dell’evidenza è
tutt’altro che di facile soluzione. Nell’interrogativo posto tuttavia abbiamo già una possibile pista di
indagine: l’evocazione della semantica dell’esperienza infatti ci impone di superare il credito per
un’idea intellettualistica o concettualistica dell’evidenza (più volte accordato in diverse figure del
pensiero filosofico). La riflessione fenomenologica è, a questo riguardo, piuttosto interessante:
l’analisi husserliana dell’atto conoscitivo lo restituisce come una sintesi di intenzionalità e
trascendenza. Husserl non rinuncia mai a definire l’atto come la particella minima di ogni
esperienza di senso, la cui struttura è definita da un volgersi intenzionale (e libero) della coscienza
verso qualcosa che si prospetta come altro da essa69. Il vissuto di coscienza non può prescindere
dall’intenzionalità della coscienza stessa e dall’esperienza di ciò che non le appartiene ma che le si
attesta come eccedente e trascendente70. Le ricerche fenomenologiche successive hanno sviluppato
e ampliato ciò che il Maestro della fenomenologia ha proposto attenendosi in larga parte ad un
discorso di filosofia dell’atto conoscitivo.
Heidegger e Ricoeur in particolare si dimostrano lucidi nell’esplicitare le implicazioni ontologiche
ed ermeneutiche delle intuizioni husserliane. In estrema sintesi, risulta interessante per la nostra
67
A. BERTULETTI, Conoscenza simbolica. Rivelazione e Eucaristia, in «Quaderni di studi e memorie» 3 (1980), 81-102,
qui 92.
68
E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Husserliana VI
(trad. it. di E. Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologa trascendentale, Net, Milano 2002, 255).
69
«L’oggetto non è meramente inteso, ma è dato in senso rigoroso così come è inteso e posto in unità con l’intenzione.
[…] L’evidenza stessa è l’atto di quella perfetta sintesi di coincidenza». E. HUSSERL, Logische Untersuchungen,
Husserliana XVII, (trad. it. di G. Piana, Ricerche Logiche vol.2, Net, Milano 2001, 422).
70
Cfr. M. EPIS, Ricerche fenomenologiche sull’essere personale, un itinerario husserliano, in «Teologia», 4 (2009),
350-384; A. BERTULETTI, Fenomenologia e teologia, in «Teologia» 3 (2001), 322-340. Da notare che in fenomenologia
la trascendenza è semplicemente ciò che non è coscienza.
19
ricerca la disamina dell’atto libero che Ricoeur propone nel decimo studio di Sé come un altro71:
egli presenta la categoria di attestazione, da intendersi come la struttura fondamentale della libertà.
Ogni atto pratico condivide la forma dell’atto conoscitivo: la libertà si volge a ciò che la trascende
in virtù di un carattere promettente del bene che la coscienza attesta. Ogni atto del soggetto conosce
una struttura formale correlativa tra un consenso della coscienza e una promessa di ciò che si
configura come trascendenza. L’attuazione del soggetto non è deducibile, ma è sospesa ad un atto
pratico che conferisce consistenza alla struttura formale dell’ontologia della libertà che abbiamo
proposto. Se tutto questo è vero, Angelini propone una sintesi in questi termini: «L’uomo è
possibile soltanto nella libertà. E d’altra parte la libertà comporta di necessità la fede, ossia l’atto
che accorda credito a ciò che inizialmente si configura soltanto come promessa; la promessa per
adempiersi esige che tu ci creda»72.
La trattazione tradizionale ha considerato la fede come assenso della volontà a ciò che in sé non
gode di evidenza. Secondo la riformulazione offerta, possiamo sostenere che, se è vero che la
libertà che presiede alla volontà non è mai esclusa dall’attuazione del soggetto, non è tanto essa a
conferire evidenza alla fede, quanto piuttosto è la forma della fede a costituire l’evidenza formale di
ogni atto dell’uomo in quanto libero.
Non c’è attuazione evidenza senza simbolo
Abbiamo evocato il problema della correlazione tra la coscienza e ciò che la trascende. La
tradizione fenomenologica ha usato diversi strumenti per comprendere meglio questo rapporto:
l’ultimo Husserl ha proposto la nozione di immersione nel “mondo della vita” come suolo
universale e pre-concettuale di ogni esperienza 73 . Heidegger predilige invece la categoria
esistenziale di essere-nel-mondo: «Non è che l’uomo “sia” e, oltre a ciò, abbia un rapporto con il
mondo. […] L’Esserci è ciò che è in quanto essere-nel-mondo»74. Le differenze tra le due riflessioni
sono notevoli, ma entrambe le proposte intendono superare un modello della rappresentazione
secondo il quale il rapporto soggetto-mondo sarebbe da intendere nella logica di una Adaequatio rei
et intellectus: esso presenta elementi di maggiore complessità.
La coscienza è il luogo della significazione: il rapporto che essa intrattiene con ciò che gli si attesta
come trascendente non è semplicemente teso al riconoscimento e alla formalizzazione categoriale.
Prima di ogni atto linguistico, il soggetto colloca se stesso in rapporto a ciò che lo fronteggia in
maniera pre-riflessa, entro una significazione le cui tonalità affettive non sono indifferenti. La
coscienza costituisce delle cose per rapporto ad essa, e non percepisce mai le cose isolate: «Tutto il
nostro mondo parte dal percepire dove già si forma un’unità e un’unificazione dell’esperito, anche
se, o forse proprio perché il percepire è multiforme e variegato»75. Il rapporto tra il soggetto e il
mondo non procede per rappresentazioni isolate, ma per reciproche significazioni: il soggetto si
colloca per rapporto a ciò che lo trascende, significa e nomina ciò che si configura come
trascendente e costituisce una rete di significazioni tra un elemento e l’altro. Senza un’alterità non
esiste un atto libero del soggetto, e d’altra parte il soggetto e l’alterità stessa non si costituiscono
che entro una correlazione, i cui esiti sono sospesi all’effettività.
71
Cfr. P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990 (trad. it. di D. Iannotta, Sé come un altro, Jaca Book,
Milano 1993, 411-415).
72
G. ANGELINI, Le ragioni della scelta, Qiqajon, Magnano 1997, 24.
73
Cfr E. HUSSERL Die Krisis der europäischen wissenschaften und die transzendentale phäenomenologie, Husserliana
VI (trad. it. a cura di E. Filippini, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, NET, Milano 2002,
142.
74
M. HEIDEGGER, Sein und zeit, Niemeyer, Tübingen 1927 (trad. it. a cura di P. Chiodi, Essere e Tempo, Longanesi,
Milano 1971, 78).
75
A.N. TERRIN, Per un rapporto autentico tra fenomenologia e teologia/liturgia. Saggio di fenomenologia della
religione, in APL (ed.), Liturgia e scienze umane. Itinerari di ricerca, 121-154, qui 131.
20
L’esperienza intersoggettiva sintetizza in massimo grado la struttura formale che abbiamo
delineato. Le ricerche fenomenologiche sull’intersoggettiva che si sono originate dalla Quinta
Meditazione Cartesiana di Husserl sono un terreno assai complesso di indagine, forse non del tutto
esplorato. L’osservazione minimale, utile per la nostra indagine, consiste nel fatto che l’io e l’altro
non stanno in una pura relazione di fronteggiamento: l’identità soggettiva non è a monte rispetto
alla relazione con l’altro. Le scienze umane, in questo senso, offrono preziosi contributi: la libertà è
collocata e plasmata entro una rete di relazioni intersoggettive. Se è vero che ogni soggetto è a
partire da se stesso, la qualità del suo essere si decide entro le relazioni effettive che è in grado di
costituire.
La struttura formale del rapporto tra il soggetto e il mondo origina sempre una ridondanza: quando
la coscienza incontra altro da sé, nessuno dei convocati nell’incontro rimane indenne, in quanto le
reciproche identità si istituiscono entro gli incontri. L’altro mi dice chi sono, e io assegno all’altro la
sua propria identità. Questo significa che c’è sempre un’indeducibilità dell’identità, la quale «non è
autoconsistente che proponendosi come struttura aperta per un’attuazione non deducibile dalla sua
struttura»76.
Riteniamo che l’aggettivo “simbolico” non sia posticcio alla struttura formale dell’intersoggettività
così istruita. Se la forma dell’evidenza non è marginale alla coscienza che si rivolge alla
trascendenza come custode di una promessa di auto-attuazione, un tale riconoscimento non avviene
senza una strutturale simbolicità della relazione tra il soggetto e il mondo. Quest’ultimo non viene
primariamente esperito come contenuto da adeguare, ma come senso da dischiudere e possibilità da
attuare. In ogni atto intenzionale, la coscienza e il mondo divengono “altro”. Ogni volta che la
coscienza si rivolge intenzionalmente a ciò che la trascende, avviene un atto di significazione teso
ad un senso. Ciò significa che il senso non è primariamente una questione di trascrizione
concettuale, ma ha un carattere simbolico, il cui partner immediato non è da subito il concetto, ma
la narrazione: il senso di una auto-attuazione è la coordinata prima di ogni atto del soggetto, il
simbolo è la modalità della costituzione del senso e la narrazione linguistica è la modalità adeguata
della formalizzazione significante. Atto simbolico e momento narrativo si richiamano
vicendevolmente.
Non c’è attuazione simbolo senza rito
Il simbolo non è dunque un’eccezione comunicativa, una sorta di didascalia al livello cristallino del
discorso, pregiudizialmente concettuale: l’evidenza ha una forma simbolica. Tuttavia non è
sufficiente far coincidere la simbolicità con l’atto costitutivo del vissuto di coscienza. Avverte
acutamente Grillo: «Un’entusiastica accezione di simbolismo diffuso può rendere il simbolo come
una sorta di “regola generale” dell’ente che – proprio con l’estendersi a tutto l’ente – perde ogni sua
peculiare caratteristica»77. Se, con Rahner, potremmo concordare con la tesi (molto nota) che l’ente
è necessariamente simbolico 78 , potrebbe tuttavia risultare ambigua la semplice coincidenza tra
simbolo, ente e atto intenzionale. Rahner sembra andare nella logica di una coincidenza del simbolo
con l’ente, mentre un’indagine fenomenologica dovrebbe attenersi al vissuto di coscienza, e dunque
il simbolo sarebbe la proprietà dell’atto intenzionale, non della trascendenza. Le due visioni sono
semplicemente diametralmente opposte e frutto di due impostazioni filosofiche troppo diverse,
oppure il confronto può risultare di un qualche interesse?
La simbolicità non può essere pensata come una sorta di “categoria della coscienza” attraverso la
quale essa ricostituisce la fenomenicità. Esiste un imporsi della simbolicità alla coscienza stessa.
76
A. BERTULETTI, Conoscenza simbolica, rivelazione e Eucaristia, 86.
S. BIANCU - A. GRILLO, Il Simbolo. Una sfida per la filosofia e la teologia, San Paolo, Milano 2013, 122.
78
Cfr. K. RAHNER, Sulla teologia del simbolo, in IBID., Saggi sui sacramenti e sulla escatologia, Paoline, Roma 1965,
51-107.
77
21
Poniamo uno sguardo alla complessa simbolica dell’amore: una carezza, un bacio, un fiore non
sono semplicemente esperienze che la coscienza istituisce come simboli. La libertà si trova
sopraffatta da queste dense esperienze simboliche. Un bacio non è solo il riempimento intenzionale
di un contatto con la carne di altri, che tollererebbe anche riempimenti intenzionali alternativi. Un
bacio è sospeso a infinite esperienze coscienziali di colui che lo riceve, ma l’ampiezza degli atti
intenzionali possibili non toglie il fatto che la coscienza vive un’esperienza di radicale passività che
si impone. Il simbolo possiede una sorta di insuperabile esteriorità ed è connotato da una passività
fenomenologica che si attesta prima che un’infinitezza ermeneutica si apra.
D’altra parte l’ente (qui inteso piuttosto approssimativamente come sinonimo della trascendenza
fenomenologica) è necessariamente simbolico, ma non indiscriminatamente. Il bacio di Giuda e il
bacio del padre misericordioso presentano una entità piuttosto simile, ma l’esperienza simbolica
connessa non è per nulla uguale. Il vissuto di due labbra che si toccano è necessariamente
simbolico, ma non automaticamente. La qualità del vissuto simbolico dipende dalla fatticità
concreta e da una rete simbolica che in essa si istituisce.
Il simbolico dunque rischia di risultare un appello puramente formale se non connotato da due
qualità: la normatività e l’esteriorità. Il simbolo, pur apprendo a possibilità praticamente infinite,
contiene in sé un imperativo: “Tu non puoi manipolarmi!”. Insieme il simbolo ha una costitutiva
esteriorità che non si risolve immediatamente nell’esperienza di coscienza o nel contenuto noetico.
Se stiamo all’esempio del bacio, l’atto esteriore produce un incremento pre-verbale ed extra-verbale
sul concetto di amore. Se tutti possono comprendere il concetto di amore, l’effettuarsi esteriore dei
suoi simboli è un effettivo incremento, e non un dettaglio.
Detto in altri termini, se è vero che è possibile comprendere la ritualità a partire dalla nozione di
simbolo che la presiede, è altrettanto vero che non c’è simbolo senza una forma di ritualità, intesa
come manifestazione esteriore e normata della sua effettività: «Una teologia, che assuma il concetto
di simbolo senza assumere nello stesso tempo al proprio centro il concetto di rito, evita di fare i
conti con la serietà del legame tra simbolo e libertà»79. Ovviamente ci stiamo attenendo (come non
è possibile fare altrimenti nel lavoro fenomenologico) a un puro livello formale di ritualità, evitando
per ora di determinarla in riti semplici o riti complessi, riti religiosi o riti pagani, riti cristiani o riti
di altra estrazione: l’osservazione minimale di questo momento della riflessione risiede nel
rintracciare un legame tra rito e simbolo di reciprocità in entrambe le direzioni.
Non c’è fede senza rito
La chiusura del teorema proposto richiede di articolare il rapporto tra il rito e la fede (attenendoci
qui ad un uso formale delle due semantiche e mantenendo una sorta di epochè fenomenologica sui
riti effettivi e sulle figure effettive di fede).
Il soggetto non è possibile se non nella fede: quest’ultima non è estranea alla questione
dell’evidenza. Ogni volta che la coscienza si attua in ordine al senso, la struttura formale della fede
è implicata. L’attuazione del soggetto ha un carattere drammatico: pur non potendo superare il
livello egologico della coscienza, essa viene a sapere di sé e della verità nell’incontro con altro.
Ogni atto intenzionale istituisce una relazione, nella quale la coscienza si ritrova da una parte
istituente e assieme istituita. La ritualità è il dispositivo formale che presiede a questa relazione, in
quanto effettività della simbolicità che connota il rapporto tra soggetto e ciò che lo circonda. Come
non è possibile l’uomo se non nella fede, e proprio perché non è possibile l’uomo se non nella fede,
allora non è nemmeno possibile l’uomo senza la ritualità.
79
S. BIANCU - A. GRILLO, Il Simbolo. Una sfida per la filosofia e la teologia, San Paolo, 160.
22
4. Ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi sacramenti
La celebre affermazione di Leone Magno del Sermone 74 ci introduce ad una sorta di conclusione
di queste riflessioni. Il rapporto tra la ritualità e la forma della fede (che abbiamo indagato
attraverso l’indagine fenomenologica) con i sacramenti cristiani e la fede cristologica (oggetti
formali della teologia) non è da pensare nel rapporto di domanda-risposta, momento trascendentalemomento categoriale, velamento-disvelamento. Non è neppure un rapporto di carattere
derivazionista. Il medio è offerto proprio dal problema dell’evidenza: se la fede cristiana e i
sacramenti cristiani hanno una destinalità antropologica, la modalità di accesso universale
all’evidenza della fede non è una faccenda marginale per l’indagine teologica, la quale riconosce al
momento fenomenologico un diritto sulla propria indagine. Non compete alla fenomenologia la
“produzione” della fenomenalità: essa la può solo tematizzarla esplicitandone l’universalità che essa
custodisce. In tal senso, il rapporto tra il momento fenomenologico e lo specifico cristologico è da
pensare secondo il rapporto formalità-effettività. La fenomenologia si distingue dal metodo
trascendentale poiché non elude dal proprio interesse la fenomenicità effettiva. Essa non esclude dal
proprio interesse la fenomenicità, ma utilizza la riduzione per rintracciarne la formalità. L’evento
cristologico dunque non è l’applicazione di una forma costituita a monte: la triade fede-simbolo-rito
è la forma anche della rivelazione cristologica in quanto evento evidente. Se l’evento della
rivelazione sia escatologicamente e protologicamente rilevante circa il dispositivo dell’evidenza
rintracciato, solo la disamina (teologica) dell’evenemenzialità effettiva potrà dirlo.
Se quanto abbiamo ricostruito ha una valenza, anche gli atti di Gesù hanno un loro valore rituale.
Possiamo raggruppare in almeno tre ambiti i gesti di Gesù (che evochiamo solo intuitivamente):
- gesti di liberazione da ogni menomazione della libertà, in particolare la malattia e il potere
del maligno
- gesti di perdono
- gesti di cura nei confronti dei testimoni, in particolare i Dodici
I gesti di Gesù hanno una forma rituale, in quanto posti dalla sua intenzionalità normativa e
consegnati ai suoi interlocutori mediante atti esteriori. Gesù non è solo teoricamente o
metaforicamente il liberatore: la libertà annunciata come realizzazione del Regno si attua in gesti
convocanti la libertà degli interlocutori. Quando smettono i gesti sugli altri alla vigilia della
passione, Gesù pone il gesto della cena in cui non agisce più sul corpo di altri, ma sul suo,
consegnato nel pane e nel vino. Dopo la sua risurrezione, la Chiesa, prima di scrivere un racconto,
continuerà a porre gesti di liberazione, di perdono e di scelta dei testimoni, radunandosi
assiduamente nello spezzare del pane. Essa ritiene di avere l’autorevolezza adatta a compiere i gesti
in continuità del Maestro, e vive l’esperienza di essere assimilata al suo corpo, ogni volta che si
prende cura dei corpi sofferenti e ogni volta che rivive il dono del suo corpo nel pane e nel vino
eucaristici. La Chiesa vive questi gesti tra due consapevolezze: in Cristo il banchetto della fine dei
giorni è giunto alla sua preparazione immediata e in Cristo la creazione che geme e soffre sta
giungendo al suo compimento. «Come e perché la Creazione esiste unicamente in vista
dell’Alleanza, così solo nel rito di Gesù, che è il sacramento, la ritualità antropologica trova il
proprio inveramento»80. Ma la pienezza cristologica della ritualità antropologica non è a discapito o
in alternativa di quest’ultima. I sacramenti non sono meno che riti, e di quella particolare specie di
riti che convocano il senso assoluto della storia e che identifichiamo come religiosi. Il loro
“infinitamente di più” non è concorrenziale con ciò che essi compiono, ma offrono la realizzazione
escatologica della struttura formale della loro evidenza.
80
A. BOZZOLO, Il rito di Gesù. Temi di teologia sacramentaria, LAS, Roma 2013, 11.
23