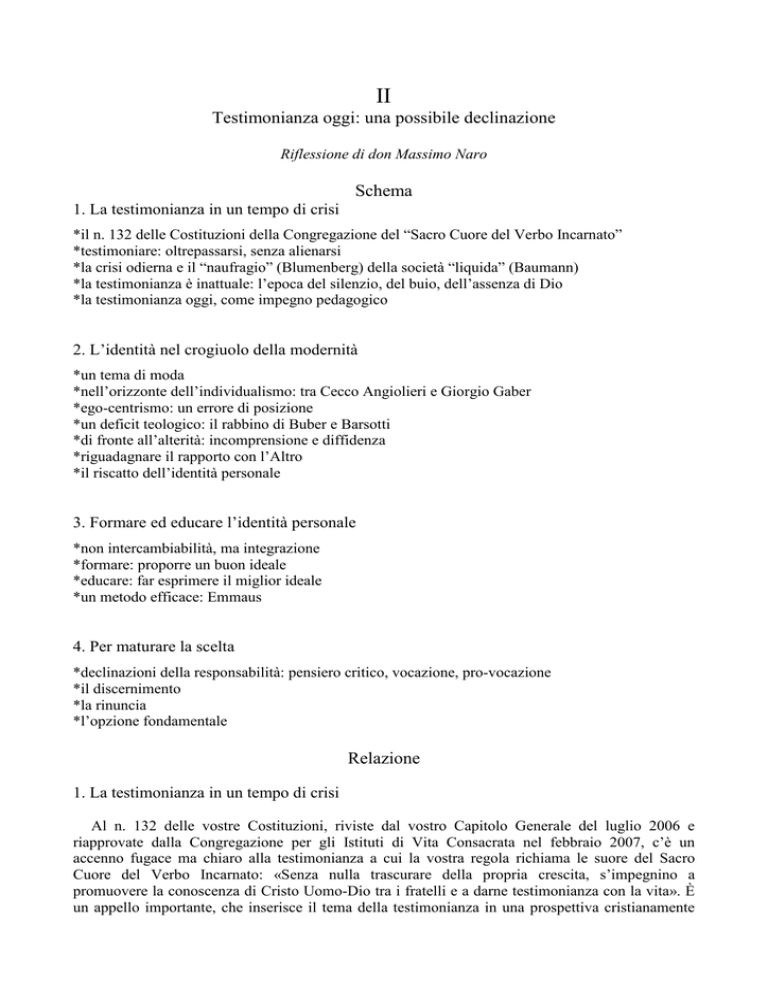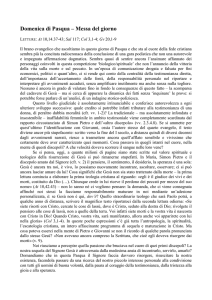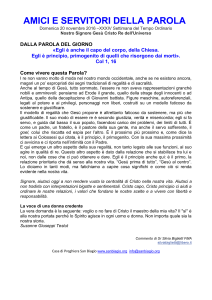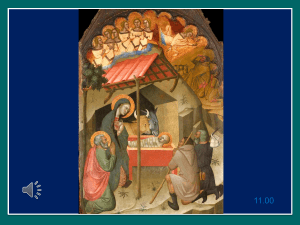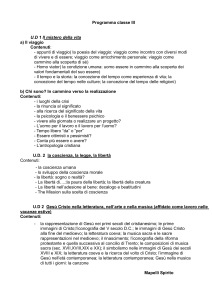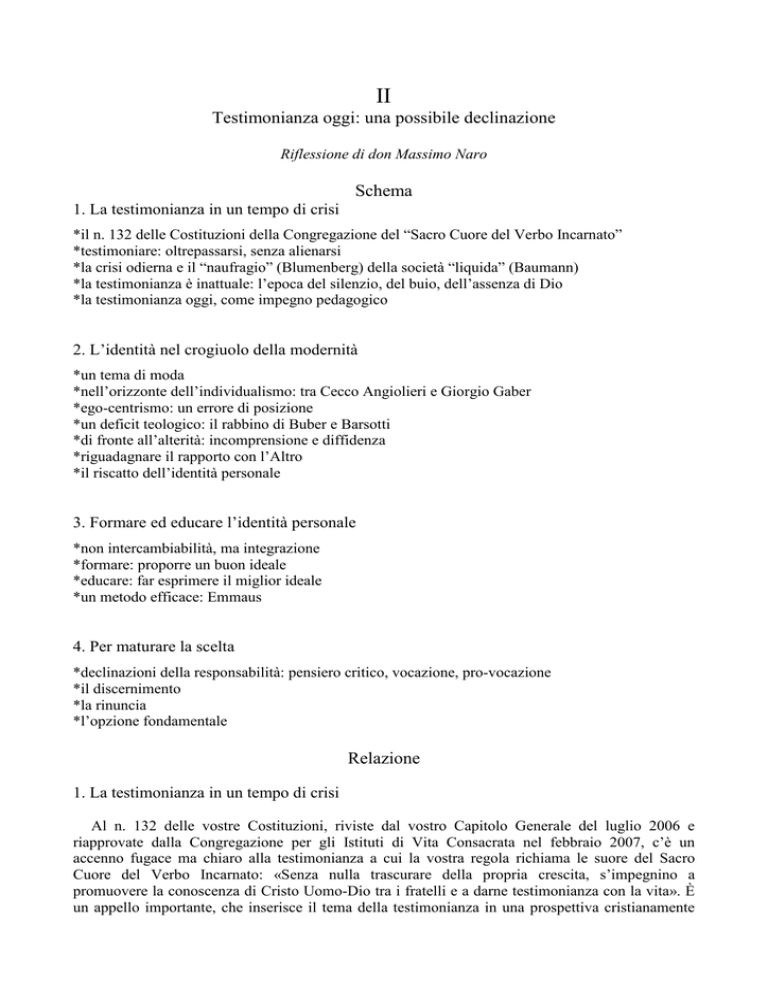
II
Testimonianza oggi: una possibile declinazione
Riflessione di don Massimo Naro
Schema
1. La testimonianza in un tempo di crisi
*il n. 132 delle Costituzioni della Congregazione del “Sacro Cuore del Verbo Incarnato”
*testimoniare: oltrepassarsi, senza alienarsi
*la crisi odierna e il “naufragio” (Blumenberg) della società “liquida” (Baumann)
*la testimonianza è inattuale: l’epoca del silenzio, del buio, dell’assenza di Dio
*la testimonianza oggi, come impegno pedagogico
2. L’identità nel crogiuolo della modernità
*un tema di moda
*nell’orizzonte dell’individualismo: tra Cecco Angiolieri e Giorgio Gaber
*ego-centrismo: un errore di posizione
*un deficit teologico: il rabbino di Buber e Barsotti
*di fronte all’alterità: incomprensione e diffidenza
*riguadagnare il rapporto con l’Altro
*il riscatto dell’identità personale
3. Formare ed educare l’identità personale
*non intercambiabilità, ma integrazione
*formare: proporre un buon ideale
*educare: far esprimere il miglior ideale
*un metodo efficace: Emmaus
4. Per maturare la scelta
*declinazioni della responsabilità: pensiero critico, vocazione, pro-vocazione
*il discernimento
*la rinuncia
*l’opzione fondamentale
Relazione
1. La testimonianza in un tempo di crisi
Al n. 132 delle vostre Costituzioni, riviste dal vostro Capitolo Generale del luglio 2006 e
riapprovate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata nel febbraio 2007, c’è un
accenno fugace ma chiaro alla testimonianza a cui la vostra regola richiama le suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato: «Senza nulla trascurare della propria crescita, s’impegnino a
promuovere la conoscenza di Cristo Uomo-Dio tra i fratelli e a darne testimonianza con la vita». È
un appello importante, che inserisce il tema della testimonianza in una prospettiva cristianamente
2
“biografica” ed “esistenziale”, cioè legata al vissuto di ciascuna suora inteso però a partire e in vista
di Cristo Gesù, come già la madre Carmela Prestigiacomo annotava riguardo a se stessa nelle sue
lettere al padre spirituale e alle sue consorelle, citando insistentemente san Paolo: «Non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me». Difatti la testimonianza è richiesta a voi, dalle vostre Costituzioni,
in riferimento all’opera “apostolica” che scaturisce principalmente dal vostro stesso carisma
congregazionale, e cioè in riferimento al vostro impegno nel «promuovere la conoscenza di Cristo
Uomo-Dio tra i fratelli». Ma senza tralasciare la vostra stessa «crescita» (s’intende,
fondamentalmente, nel rapporto con Cristo). Come a dire che non si può “insegnare” agli altri
Cristo Gesù se non si fa esperienza di Lui, se non si sta in relazione con Lui, se non si va maturando
sempre più nel processo della propria conformazione a Lui.
Testimoniare non è, infatti, dimostrare la logica di una lezione teorica, bensì mostrare l’efficacia
salvifica del vangelo, l’unica vera lezione che il credente apprende dall’unico vero Maestro. Per
questo, anche secondo il n. 132 delle vostre Costituzioni, si dà testimonianza «con la vita», anzi con
la “propria” vita, crescendo sempre più nella conoscenza personale di Cristo. Testimoniare
significa, in definitiva, andare oltre se stessi (come già per Gesù che, secondo san Paolo, non
considerò un tesoro geloso l’essere come e con Dio, ma si umiliò venendo nella condizione umana
[cf. Fil 2,6ss.]), in un duplice senso: aprirsi agli altri, a loro rivolgendosi, a loro dedicandosi, per
loro faticando, per loro anche soffrendo, da loro persino ricevendo persecuzione, nel nome di un
Altro, come Gesù prometteva ai suoi discepoli nelle beatitudini: «Beati coloro che nel mio
nome…».
Questo dover andare oltre di sé, però, non esime il testimone da se stesso: non si traduce, cioè, in
auto-alienazione, in dimenticanza di sé. Ci si oltrepassa, si va incontro agli altri, vivendo e non
astraendosi in ragionamenti e in discorsi disincarnati. Si promuove la conoscenza non di noi stessi,
ma di Cristo: e tuttavia vivendo noi stessi, noi per primi, di Cristo. Madre Carmela Prestigiacomo,
nei suoi scritti, lascia trasparire una comprensione molto lucida di questo significato della
testimonianza, intesa e vissuta da lei in termini paolini. San Paolo, per sua stessa ammissione, si fa
“tutto per tutti, tutto a tutti” (forte coi forti, debole coi deboli), innanzitutto accettando di essere un
tutt’uno con Cristo (con Lui morto, sepolto, risorto). Ma non si esime di chiamarsi in causa, di
dichiarare il proprio impegno, di pronunciare con determinazione il suo “io”: “ho combattuto la mia
battaglia, ho corso la mia gara…”. In questo sta la testimonianza cristiana: volgersi agli altri, in
nome di Cristo, facendosi tutt’uno con gli altri, divenendo tutt’uno col Cristo, ma modellando a tal
scopo, continuamente, la propria identità.
Ecco perché reputo che per trattare la questione della testimonianza si debba fare riferimento alla
questione dell’identità personale, specialmente oggi, in un tempo in cui l’identità personale vive un
momento di profonda crisi.
***
In realtà oggi viviamo la crisi come una condizione permanente, nella quale tutti abbiamo la
sensazione di avere l’acqua alla gola per i mille problemi in cui ci ritroviamo impastoiati. Problemi
economici, come quelli che ormai investono tutto l’Occidente. Ma anche e ancor prima problemi di
tenuta culturale (muta la visione del mondo, che si meccanicizza e si macchinizza sempre più [la
tecnica informatica…, gli occhiali computerizzati di Google…; l’uomo cibernetico sulla luna, di cui
parla Heidegger in Ormai solo un Dio ci può salvare…]), problemi di deterioramento valoriale
(valori di “sempre” che vengono ormai contestati, o che si dimostrano ormai inadeguati [crisi della
metafisica], problemi di metamorfosi religiose (il soggettivismo e il sincretismo new ager…, a
causa anche del “meticciato” che è chance e minaccia…).
Avvertire la crisi come l’acqua alla gola, del resto, corrisponde a quell’esperienza della
“liquidità”, della “acquosità”, di cui parla Zygmut Baumann nei suoi libri sulla “società liquida” dei
nostri giorni, una società cioè volubile, senza più forma riconoscibile, senza più contorni stabili,
senza più profili nitidi, senza più identità certe (a livello nazionale, per esempio, quante cartine
3
geografiche, a partire dal 1989, si son dovute ridisegnare: va mutando la geo-politica mondiale!;
oppure a livello comunitario si consideri la crisi della famiglia, non più “classica”, ma
mononucleare, fatta di singles, di coppie di fatto, di unioni omosessuali, di adozioni da parte di
coppie omosessuali, ecc.), una società insomma esposta a cambiamenti repentini, come fosse
appunto in balia delle onde che la trascinano ora verso una direzione (una certa moda) ora verso
un’altra direzione (un’altra moda). Siamo nel vortice di un immenso naufragio, per riecheggiare la
metafora usata da Hans Blumenberg. Già il poeta latino Lucrezio, citato da Blumenberg, ebbe il
sentimento del naufragio che gli uomini rischiano continuamente; ma egli era ancora un uomo
antico, appartenente all’umanità antica, e perciò si limitava a contemplare il naufragio come una
possibilità terribile, ma tutto sommato lontana, da guardare standosene al sicuro, sulla terraferma:
«Bello e affascinante, anche se tremendo, è quando sul mare si scatena la tempesta che inghiotte la
nave che viaggia all’orizzonte… Non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina, ma la distanza da
una simile sorte». Nel tempo in cui viviamo, invece, il naufragio è ormai avvenuto e noi vi siamo
pienamente coinvolti, anche se forse ancora non ce ne rendiamo pienamente conto. Viene alla
mente una suggestiva pagina di Kierkegaard, tratta dal suo Diario (1855): «Immagina una nave
grandissima, ancor più grande, se vuoi, delle nostre navi d’oggi; può trasportare mille passeggeri e,
naturalmente, tutto è attrezzato al massimo grado quanto a comodità, agi, lusso, ecc. È verso sera.
Nel salone ci si diverte; tutto risplende sotto la sontuosa illuminazione; si sente il concerto; in breve,
tutto è gioia, esultanza e godimento; il rumore e il chiasso di questa gaiezza sfrenata si spandono
nell’aria della sera. Sul ponte, il capitano è già in piedi; vicino a lui, il secondo si toglie dagli occhi
il binocolo e lo tende al capitano che risponde: “Inutile, lo vedo bene quel piccolo punto bianco
all’orizzonte […]”. Non è terribile? E tuttavia io so una cosa, che è ancora più terribile. […] Nel
salone ci si diverte e il più gaio di tutti è il capitano. Il punto bianco all’orizzonte è là, la notte sarà
terribile. Ma nessuno vede il punto bianco, né sospetta che cosa presagisca […]; no, ce n’è uno che
lo vede e sa quel che esso presagisca. Egli non ha nessun comando sulla nave; non può incaricarsi
di niente. Ma, per non tralasciare la sola misura in suo potere, manda a dire al capitano di salire sul
ponte, almeno per un istante. Questi si fa aspettare; infine arriva, ma non vuol sentir niente e subito
ridiscende nel salone a condividere la gioia chiassosa e disordinata dei passeggeri, che bevono alla
sua salute tra la generale allegria, e rivolge loro i suoi calorosi ringraziamenti. Nella sua angoscia, il
povero passeggero si decide a disturbare ancora una volta il capitano che, questa volta, si mostra
persino sgarbato. Tuttavia, il punto bianco resta ugualmente all’orizzonte: “La notte sarà terribile”
[…]». Questa “parabola” moderna, raccontata da Kierkegaard, denuncia quella che Giuseppe
Angelini, in un suo recente libro, ha chiamato l’«inattualità» della testimonianza: oggi non si
ascoltano più le testimonianze, gli avvisi dei profeti; oggi non c’è più attenzione per i testimoni…
La testimonianza viene quasi negata, cioè non viene accettata, viene reputata come superflua,
inutile…
In questo senso, l’epoca in cui viviamo si può anche definire come l’epoca del “silenzio di
Dio”…: tutta la modernità si connota come tempo del “silenzio”, del “silenziamento”…
- prima del silenzio, il buio (Kant, Nietzsche, Pirandello)
- la svolta antropologica: natura, soggetto (io), cultura // creazione, Dio, culto
- da Ulisse a Gagarin: l’assenza di Dio
- la secolarizzazione post-moderna come epoca della “morte di Dio”: si tace di Dio;
Dio sembra tacere (Auschwitz)
- il rovesciamento dei silenzi: «Mi metto la mano sulla bocca» (Gb 40,4).
Ma oggi è anche il tempo in cui si cerca di ovviare alla crisi e al silenzio, con il “dialogo”, ragion
per cui il dialogo ad alcuni sembra l’altro nome della testimonianza (Angelini ha criticato però
questa tendenza, sottolineando il carattere “polemico” della testimonianza, che già
nell’insegnamento di Gesù inclinava verso il “diverbio”, e prometteva persecuzione, martirio…:
caso serio, per Balthasar, che a tal proposito ha parlato di disponibilità trans-dialogica…): Enzo
4
Bianchi, per esempio, si muove in questa prospettiva parlando della “differenza cristiana” nel senso
del discorso della montagna…
Per parte mia, penso che “oggi” sia il tempo della crisi del soggetto che si deve far carico della
testimonianza: testimoniare cosa? per conto di Chi? sono domande senz’altro importanti, che
rimandano subito a ciò che è principiale, fondamentale: a Cristo Gesù e al Dio di Cristo Gesù…
(non qualcosa, ma Qualcuno!); ma io reputo la questione della testimonianza oggi debba chiamare
in causa anche colui che testimonia!
Ecco perché penso anche all’orizzonte dell’identità personale…
Se poi considero che il vostro specifico è educare ed evangelizzare, allora penso che la
testimonianza cui dovete sentirvi chiamate è quella della formazione all’identità personale e
dell’educazione a fare la scelta di Cristo…
Proprio il n. 132 delle vostre Costituzioni si esprime in questi termini: «Le suore insegnanti ed
educatrici abbiano di mira la maturità umana e cristiana degli allievi. Ricche di quelle doti, senza
le quali non potrebbero assolvere la loro missione (spirito religioso, vita interiore, equilibrio
umano, maturità psicologica e affettiva, doti di cuore e d’intelligenza), sentano profondamente il
dovere di perfezionare, per quanto loro possibile, metodi e contenuti del loro apostolato educativo e
formativo, secondo le esigenze dei luoghi e il progresso della cultura». Ci sono, in questa pagina
molto ben scritta, tanti spunti che mi orientano a proporvi di declinare la “testimonianza oggi” come
“impegno pedagogico” volto alla “formazione dell’identità personale” e all’“educazione a scegliere
Cristo”.
***
In realtà un tale orientamento ci viene anche dagli Orientamenti pastorali della CEI per il
decennio 2010-2020 (Educare alla vita buona del Vangelo). Al n. 9 di questi Orientamenti, difatti, i
vescovi italiani parlano dell’«incerta formazione dell’identità personale in un contesto plurale e
frammentato», segnalandola come uno snodo importante e delicato del processo educativo ispirato
al Vangelo in cui tutti siamo invitati a lasciarci coinvolgere. Questa «incerta formazione
dell’identità personale», dicono i vescovi, è un fattore «rilevante dal punto di vista antropologico»,
e di esso si dovrebbe parlare in forza di ben precise competenze, che vanno dall’antropologia
culturale, alla sociologia, alla psicologia, alla pedagogia. Ora, io – in realtà – non ho queste
competenze: mi limiterò perciò a impostare la mia riflessione nella prospettiva dell’antropologia
teologica o, più precisamente, dell’antropologia cristiana, cioè di una visione dell’uomo – della sua
origine creaturale e del suo destino, anzi: della sua destinazione finale – ricavata dalla sapienza
biblica e dalla tradizione ecclesiale; del resto in questa prospettiva propriamente teologica ci
indirizza il testo stesso degli Orientamenti, come vedremo tra poco. Al contempo, cercherò di
riferire a voi consacrate il tema stesso dell’identità personale e dell’educazione alla scelta. Voi
consacrate siete portatrici di una peculiare identità, tanto marcata da spiccare, in un certo senso,
all’interno della comunità dei discepoli di Cristo Gesù. E siete anche soggetti di educazione a
doppio titolo: nel senso che siete chiamati a educare gli altri, ma pure – ancor prima – ad educarvi
alla scelta, dato che vivete una specifica condizione vocazionale che continuamente vi appella a fare
delle ben precise opzioni.
2. L’identità nel crogiuolo della modernità
Innanzitutto, è il caso di ammettere che quello dell’identità è un tema di moda: soprattutto inteso
il termine in senso collettivo, comunitario, corporativistico e, secondo un significato ancora più
esteso, in senso nazionale/nazionalistico, o in senso regionale/regionalistico (etnico-culturale).
Negli anni in cui si realizza l’Europa unita e – nel caso italiano – nell’anno in cui si ricordano gli
5
eventi dell’unificazione e la realtà dell’unità del Paese, permangono le istanze identitarie di alcune
singole regioni, che spesso si traducono in spinte autonomistiche e persino secessionistiche.
Qui dobbiamo restringere l’orizzonte alle misure dell’«identità personale», che – d’altra parte –
non è meno problematica, oggi, di quella nazionale, dato che viene sempre più spesso fraintesa
come identità piuttosto “individuale”.
La modernità nella quale viviamo è proprio l’epoca dell’identità individuale. La parola d’ordine
cartesiana, con cui s’è aperta l’epoca moderna, è stata una parola ego-centrata: tutto comincia
dall’io (ego), dalle sue capacità e potenzialità razionali (cogito), dalla sua esistenza assoluta (sum),
posta in relazione soltanto con il proprio sé.
Guardando allo sfondo dell’individualismo moderno, giustamente gli Orientamenti, al n. 9,
affermano che il «mito dell’uomo che “si fa da sé” finisce per separare la persona dalle proprie
radici e dagli altri». È per questo motivo che la modernità giunge a caratterizzarsi come il tempo
della frammentazione, la quale è colta dai vescovi italiani in termini “radicali”, non solo come
fenomeno culturale, ma prima ancora come metamorfosi antropologica: la sopravvalutazione del sé,
dell’io, o il fraintendimento del suo valore, trasforma i connotati dell’uomo moderno. Mi pare
emblematica di questa situazione epocale la canzone – ma potremmo anche definirla “poesia” –
scritta e interpretata nel 2003 da Giorgio Gaber, intitolata La parola io; è lunga, ma vale la pena
citarla per intero:
La parola io
è un’idea che si fa strada a poco a poco
nel bambino suona dolce come un’eco
è una spinta per tentare i primi passi
verso un’intima certezza di se stessi.
La parola io
con il tempo assume
un tono più preciso
qualche volta rischia
di esser fastidioso
ma è anche il segno
di una logica infantile
è un peccato ricorrente ma veniale.
Io, io, io
ancora io.
Ma il vizio dell’adolescente
non si cancella con l’età
e negli adulti stranamente
diventa più allarmante e cresce.
La parola io
è uno strano grido
che nasconde invano
la paura di non essere nessuno
è un bisogno esagerato
e un po’ morboso
è l’immagine struggente del Narciso.
Io, io, io
e ancora io.
Io che non sono nato
per restare per sempre
confuso nell’anonimato
6
io mi faccio avanti
non sopporto l’idea di sentirmi
un numero fra tanti
ogni giorno mi espando
io posso essere il centro del mondo.
Io sono sempre presente
son disposto a qualsiasi bassezza
per sentirmi importante
devo fare presto
esaltato da questa mania
di affermarmi ad ogni costo
mi inflaziono, mi svendo
io voglio essere il centro del mondo.
Io non rispetto nessuno
se mi serve posso anche far finta
di essere buono
devo dominare
sono un essere senza ideali
assetato di potere
sono io che comando
io devo essere il centro del mondo.
Io vanitoso, presuntuoso
esibizionista, borioso, tronfio
io superbo, megalomane, sbruffone
avido e invadente
disgustoso, arrogante, prepotente
io, soltanto io
ovunque io.
La parola io
questo dolce monosillabo innocente
è fatale che diventi dilagante
nella logica del mondo occidentale
forse è l'ultimo peccato originale.
Io.
Davvero, «nella logica del mondo occidentale», viene da dire insieme a Gaber, l’uomo sceglie
ormai di reiterare l’antico peccato, mettendosi di nuovo al posto di Dio, con quello che il cantautore
chiama «l’ultimo peccato originale». Così, però, i connotati umani che vengono abrasi sono,
innanzitutto, quelli iconici, che sin dall’inizio avevano fatto balenare nel volto dell’uomo i tratti del
volto di Dio stesso, suo creatore. L’uomo della modernità, mettendosi al posto di Dio, non
guadagna una migliore collocazione, ma perde piuttosto il proprio posto e, dunque, smarrisce la sua
identità. Proprio quando torna a rivendicare le ragioni del suo “io”, perde i suoi connotati più tipici
e autentici. Viene da citare il sonetto di un altro cantautore, che sta – temporalmente – all’inizio di
quella parabola moderna cantata dall’ironia di Gaber: si tratta di Cecco Angiolieri, poeta toscano
del tardo medioevo, che scrisse S’i fosse foco:
S’i' fosse foco, arderei 'l mondo
s’i' fosse vento, lo tempesterei
s’i' fosse acqua, i' l’annegherei
s’i' fosse Dio mandereil’en profondo
S’i' fosse papa, sare' allor giocondo
tutt’i cristiani imbrigherei
7
s’i' fosse imperator, sa' che farei ?
a tutti mozzerei lo capo a tondo
S’i' fosse morte, andarei da mio padre
s’i' fosse vita, fuggirei da lui
similimente faria da mi' madre.
S’i' fosse Cecco come sono e fui
torrei le donne giovani e leggiadre
e vecchie e laide lasserei altrui.
È importante notare che il «s’i'» con cui cominciano tutti i versi di Cecco Angiolieri, non sta
soltanto per “se”, ma piuttosto per “se io”. La martellante affermazione dell’io e la collocazione di
se stesso al di sopra di ogni autorità, al posto persino di Dio, induce l’uomo a fraintendere le
relazioni fondamentali (col padre, la madre, le donne) e a rompere con tutti e con tutto: con gli altri
uomini, con i propri genitori, con il mondo intero.
La modernità è stata, dunque, in alcune sue espressioni e in alcuni suoi momenti, il tempo in cui
il rapporto fondamentale tra l’uomo e Dio si è deteriorato e, conseguentemente, il tempo in cui è
mutata la maniera di comprendere anche tutto il resto. Al “trinomio” che prima aveva avuto lungo
corso – Dio, la creazione, il culto – è subentrata una nuova sequenza di valori: l’io, la natura, la
cultura. A venir meno è, così, il rapporto con Dio, la capacità e la disponibilità a stare in relazione
con Lui. L’uomo che non crede più in Dio, cerca l’assolutizzazione della propria identità,
affermando autoreferenzialmente l’io; ma se Dio non c’è più, allora il mondo non si può più
intendere come creazione di Dio, bensì solo e semplicemente come natura, cioè come qualcosa che
vive in termini autosufficienti, con le sue regole intrinseche e con i suoi automatismi; e non c’è più
bisogno di impostare la vita dell’uomo come un rapporto aperto a Dio, rivolto verso l’Alto, come
una liturgia, come un’esperienza cultuale, giacché la si può e la si deve ormai impostare piuttosto
come un serrato rapporto con la natura, per scoprirne e governarne e sfruttarne le leggi e le risorse,
insomma come cultura.
La generale crisi d’identità, nel crogiuolo della modernità, s’è fatta quindi, via via, molto
profonda, come rilevano gli Orientamenti al n. 9, secondo cui il «disagio» identitario dell’uomo
moderno affonda le sue «radici» non solo in cause «culturali, sociali ed economiche», bensì nella
«negazione della vocazione trascendente dell’uomo e di quella relazione fondante che dà senso a
tutte le altre»: «Senza Dio l’uomo non sa dove andare e non riesce nemmeno a comprendere chi egli
sia».
Martin Buber e Divo Barsotti hanno, per vie diverse, rintracciato e citato nei loro scritti un antico
racconto dell’ebraismo chassidico, mitteleuropeo, che illustra molto efficacemente questa crisi
identitaria.
C’era, in un villaggio ebraico, una scuola della Torah, il cui rabbino – un giorno – formulò un
formidabile interrogativo teologico ai suoi allievi: chi è Dio? Gli allievi avrebbero dovuto pensarci
su, per trovare una loro risposta da riferire poi, all’indomani, in classe. Uno di questi allievi, il più
brillante, si applicò con grande tenacia all’interrogativo, pensandoci e ripensandoci a lungo per tutto
il giorno, estenuandosi nei ragionamenti. Durante la notte ebbe la folgorante intuizione. E
orgoglioso per la risposta trovata si alzò di corsa e andò a bussare alla porta di casa del rabbino.
Questi, alzandosi dal letto, stando dietro gli scuri della finestra chiese: Chi è che bussa alla mia
porta? L’allievo gli rispose: Sono-io. Il rabbino chiese di nuovo: Ma chi è? Sono-io, Shaoul: rispose
con tono entusiastico l’allievo. E il rabbino, adirato, replicò: Ma insomma, chi osa bestemmiare alla
mia porta, nel cuore della notte?
Il giovane teologo, presumendo di aver capito chi è Dio, aveva dimenticato che il sacro
tetragramma non si può nemmeno pronunciare e men che meno associare a un qualsiasi nome
umano… La presunzione di aver smascherato Dio, di averne scoperto il segreto, tipica del
razionalismo moderno, fa perdere di vista l’identità dell’uomo, che finisce così – anche solo
inconsapevolmente – per sostituirsi a Dio.
8
Secondo il n. 9 degli Orientamenti per superare questo disagio identitario occorre affrontare una
vera e propria «emergenza educativa», «il cui punto cruciale sta nel superamento di quella falsa idea
di autonomia che induce l’uomo a concepirsi come un “io” completo in se stesso, laddove, invece,
egli diventa “io” nella relazione con il “tu” e con il “noi”».
Il tu e il noi – vale a dire gli altri – nella tarda modernità, sono stati spesso avvertiti come una
minaccia per l’integrità dell’io. È nota la frase attribuita a Jean Paul Sartre: gli altri sono l’inferno.
Difatti l’incomprensione del significato e del valore dell’alterità costituisce un tratto importante del
disagio identitario di cui stiamo parlando. Nel corso della modernità due sono stati i fraintendimenti
più gravi: per un verso presumere che “Dio non è l’Altro”, misconoscendone la trascendenza divina
rispetto al mondo e perciò confondendolo col mondo stesso (è la tendenza smascherata da
Feuerbach e culminata nella filosofia di Hegel); per altro verso pensare che “Dio è l’Altro”, fino a
ipotizzare la sua irrilevanza per il mondo e per l’uomo, come avviene nella filosofia di Kant, o fino
a imbastire l’aut-aut nietzscheano, l’alternativa tra Dio e il super-uomo, l’affermazione dell’io
nonostante Dio e contro Dio.
Come risolvere questa gravissima interruzione della relazione con l’Altro, così nociva anche per
la giusta comprensione dell’identità dell’uomo?
Innanzitutto riguadagnando la fiducia nel Nome di Dio, come Nome che appartiene a Lui, ma
che non risuona contro di noi. Dio non è l’Altro. E neppure è il Non-Altro. Piuttosto: Dio è Dio. Ma
se Egli viene riconosciuto come tale, allora anche l’uomo può riconoscersi serenamente per chi
veramente è. Bisogna uscire dalla paura dell’Altro. Occorre far riecheggiare nelle orecchie
dell’uomo contemporaneo il saluto del Risorto: «Non temete, Sono-Io»…
Inoltre riguadagnando la consapevolezza del nostro provenire da Dio. Noi non siamo Dio, ma
siamo da Dio e, conseguentemente, per Dio. Non possiamo più pensare: o io, o Tu; ma dobbiamo
piuttosto ammettere finalmente: io grazie a Te. L’autore anonimo dello Scritto a Diogneto, alla fine
del II secolo, è un testimone lucidissimo di questa fondamentale consapevolezza identitaria:
secondo lui «Dio formò gli uomini dalla sua propria Immagine: tous anthropous ek tes idias eikonos
eplase o Theos» (10,2). L’Anonimo amalgamava così i due diversi racconti − tradotti in greco nella
LXX − della creazione di Gn 1,26-27 e Gn 2,7 prendendo dalla prima versione il sostantivo eikon e
dalla seconda il verbo plasso e facendo reggere eikon dalla preposizione ek piuttosto che da kata. Si
sa quanto importante sia per la dogmatica cristiana la costruzione di ek col genitivo: essa esprime,
per esempio, nel simbolo niceno, la consostanzialità del Figlio rispetto a Dio Padre suo; qui dice il
rapporto di differenza ma anche di relazionalità con Dio in cui l’uomo, come tale, sussiste. In questa
prospettiva l’uomo è stato «plasmato» sì, ma quasi come se venisse tratto fuori «dall’Immagine
stessa» di Dio, piuttosto che dal fango della terra. La forza dell’affermazione sta nell’inedita
perifrasi costruita dall’Anonimo: il verbo plasso evoca l’idea di una creazione che non avviene ex
nihilo (non si può plasmare il nulla), ma a partire da qualcosa che già è. Non si tratta più dell’argilla
– cioè di quel che simboleggia la creazione intera, che in quanto creata differisce totalmente dal
Creatore – bensì dell’Icona intima a Dio stesso: l’Immagine increata che da sempre Dio custodisce,
quasi gelosamente, dentro di Sé. E quest’Icona di Dio è, come già per Filone, il Logos divino.
L’uomo, perciò, proviene dall’Intimo di Dio e – anzi – è impastato di Dio. Sapere che Dio è Dio, ci
permette di renderci consapevoli delle nostre migliori e più nobili possibilità, della nostra altissima
dignità, come recita il n. 22 di GS.
Infine riguadagnando il senso vocazionale dell’esistenza. Gli uomini sono ad immagine di Dio.
Non archetipo di se stessi, ma riflessi di un’Icona che sta nell’Intimo di Dio. Ogni volta che l’hanno
dimenticato, soprattutto nell’esperienza amara del peccato, essi insieme con Dio hanno rifiutato se
stessi. È il caso di citare Romano Guardini che, in un saggio intitolato significativamente Accettare
se stessi, ha affermato che – presumendosi archetipo e non immagine – gli uomini «[…] divennero
disuniti in se stessi e smarrirono il sapere circa se stessi. Il loro essere dimenticò il proprio nome.
Da allora in poi il nome e l’essere si cercarono a vicenda senza mai trovarsi». Sono espressioni
suggestive, che introducono quelle che Guardini chiama «le domande dell’esistenza»: «Perché io
sono colui che sono? perché mi succede quello che mi succede? perché mi è interdetto quello che
9
mi è interdetto? perché io sono come sono? perché io semplicemente esisto invece che non
esistere?». Per Guardini queste domande «hanno la loro risposta unicamente nel rapporto con Dio»,
una relazione di qualità vocazionale: «Io devo voler essere ciò che sono; voler essere realmente io e
soltanto io. Io mi devo porre nel mio me stesso, come esso è, ad assumere i compiti che per questo
mi sono assegnati nel mondo. È la forma fondamentale di tutto ciò che si chiama “vocazione”». La
forza dell’io, qui, viene recuperata, ma non più contro Dio. È, ormai, un io che sta a fondamento di
quella che sempre Guardini chiama la responsabilità dell’«auto-esistenza»: «Così l’atto dell’autoesistere diviene, in radice, una specie d’ascesi: io devo rinunciare al desiderio d’essere diverso da
quello che sono; un altro uomo da quello che io sono. Quanto possa diventare acuto un simile
desiderio, lo si può arguire dai miti e dalle leggende [...] in cui un essere umano viene trasformato in
un essere diverso: o verso l’alto, in una stella; o verso il basso, in una bestia o in un mostro o in un
sasso... Io devo rinunciare ad avere qualità che mi sono interdette; devo riconoscere i miei limiti e
conservarmeli. Questo non vuol dire rinunciare all’istanza di salire. Salire io posso e io devo; bensì
lungo la linea assegnatami».
Siamo al riscatto dell’identità, rifondata sul rapporto con Dio e perciò ricompresa non più in
termini individualistici e solipsistici, bensì in termini autenticamente personali, relazionali. L’uomo
esce dal recinto del soggettivismo, dell’assoluta affermazione del proprio io, che lo isola da tutti gli
altri, e matura una nuova capacità soggettuale. C’è differenza tra soggettivismo e soggettualità. Il
soggettivismo si impossessa di un oggetto e finisce per manipolarlo, per ridurlo alle proprie misure
e convenienze. La soggettualità, invece, rispetta l’oggetto con cui si confronta, lo incontra anzi
come un altro soggetto. Si può capire ancor meglio tutto questo se si pensa al modo biblico di
incontrare Dio: all’inizio del salmo 62 è formulata una sorta di tautologia teologica: «O Dio, tu sei il
mio Dio». La teologia della Bibbia non dimostra Dio a parole e con concetti più o meno raffinati. Si
limita a invocarlo, rispettandone apofaticamente la trascendenza e, dunque, la sua inafferrabile
oggettività: il credente biblico non dice agli altri uomini ciò che Dio è; ma dice a Dio che è Dio. Ma
quando dice a Dio che è Dio, non può esimersi di entrare in rapporto con lui, di avvicinarsi a lui, di
entrare in un dialogo, in una relazione di prossimità e di familiarità tali che egli, il credente, dice a
Dio che è il suo Dio. Quando il salmista prega: «O Dio, tu sei il mio Dio», non ha preteso di
interpretare e di ridire la verità di Dio, ne ha rigorosamente rispettato l’oggettività; ma ha anche
personalizzato questa oggettiva verità di Dio, l’ha coinvolta nella propria vicenda e si è messo in
relazione con essa. L’oggettiva verità di Dio, tanto oggettiva da non poter essere neppure
commentata o riformulata con altre parole e con altri concetti, è diventata, nella preghiera del
salmista, una verità personale. «Verità personale – ha spiegato Balthasar – significa qui,
all’incontrario di verità non assimilate, solo casualmente espresse, anonime, irresponsabili, quella
verità che, acquisita in decisione personale, viene portata e trasmessa alla pari in responsabilità
personale. A questa verità aderisce il sangue e il cuore spirituale di una persona, [che] per essa ha
sopportato fatica e dolore».
3. Formare ed educare l’identità personale
A questo punto il tema dell’identità personale si deve coniugare con quello dell’educazione. Il n.
10 degli Orientamenti parla, per la precisione, di formazione oltre che di educazione. E anche il n.
132 delle vostre Costituzioni mette insieme formazione ed educazione, quasi fossero sinonimi. Io
reputo che tra educazione e formazione non ci sia una immediata intercambiabilità, ma una loro
reciproca coimplicazione e integrazione.
La “formazione” rimanda a un’azione che coinvolge dall’esterno i suoi destinatari: certo, non
pretende di insistere su “come è” o su “come si fa” ciò a cui si intende formare le persone; tuttavia
propone una ben determinata “visione” della realtà, evidenziandone i contorni, argomentandone il
valore e le potenzialità, e ponendola quasi “frontalmente” davanti alle persone per stimolarle a una
loro responsabile presa di posizione.
10
L’“educazione”, invece, rimanda all’antica pedagogia maieutica, al socratico “conosci te
stesso”, per far esprimere al di fuori, a partire dal di dentro, le migliori e più positive, le più
“virtuose” − avrebbe detto lo stesso Socrate − potenzialità delle persone.
Se formare le persone significa, dunque, proporre loro un buon ideale, educare le persone
significa metterle in condizione di esprimere consapevolmente ed efficacemente il loro migliore
ideale. Le due dinamiche, contemperate assieme, concorrono a equilibrare le esigenze del contesto e
le attese degli individui, come pure a equilibrare una giusta dose di soggettualità con una non meno
importante dose di oggettività.
Come si intuisce agevolmente, educazione e formazione – lungi dall’escludersi e dal porsi in
alternativa – si possono e si devono integrare reciprocamente: mi pare questo il primo punto fermo
su cui programmare le tappe e i ritmi del cammino che ci deve portare a maturare un’identità
personale col profilo cristiano che ci compete. Si tratta di proporre l’urgenza di un compito
facendone riemergere le motivazioni dall’intimo, dal cuore stesso del ragazzo e del giovane (o della
giovane, nel caso si tratti di postulante o di novizia), secondo un dinamismo identitario che è già
segnalato nel Nuovo Testamento e in particolare nell’epistolario paolino: sii ciò che sei, diventa ciò
che sei. La formazione diventa perciò soprattutto trasformazione e riforma di se stessi. O anche
conversione: secondo l’esperienza di Levi il pubblicano, di Pietro il rinnegatore, di Saulo il
persecutore.
In questa prospettiva può aiutarci un’icona evangelica, quella dei due discepoli che camminano
col Cristo Risorto lungo la strada che da Gerusalemme porta ad Emmaus: il mattino di Pasqua,
ignari ancora della resurrezione del loro maestro, se ne tornano sfiduciati e tristi al loro villaggio
d’origine. Mentre i due camminano e discutono tra loro, confidandosi a vicenda la loro delusione e
il loro scoraggiamento per la morte di Gesù, uno sconosciuto si fa loro compagno di strada:
condivide con loro la fatica del viaggiare, del camminare insieme con altri, subendone i ritmi,
adeguandosi al loro passo stentato, rinunciando a procedere oltre speditamente. Gesù condivide la
strada nel suo consueto stile: dapprima sembra raggiungerli alle spalle, tallonandoli quasi,
discretamente, senza mettere naso, senza aprire bocca: si limita ad ascoltare, non interviene subito,
non intima subito di invertire la marcia. Sta lì, invece, a fare un bel pezzo di strada dietro di loro:
apparentemente invisibile, ma presente, Gesù non disdegna di indugiare, di spendere il suo tempo
per ascoltare. Poi coglie il momento opportuno per intervenire nel loro dialogo: «Di cosa state
parlando? Cosa è successo?». Sa già tutto, ma preferisce lasciarsi informare, conoscere il punto di
vista altrui; non impone la sua versione dei fatti, sente prima cosa ne pensano i due discepoli. La
loro risposta è nervosa, tipica di chi dà per scontato e come ovvio il proprio punto di vista, le
proprie conoscenze, il proprio modo di vedere, di intendere e di vivere le cose: «Tu solo sei così
forestiero?». Di Gesù dicono che sarebbe dovuto essere un condottiero d’armi, un re liberatore, un
rivoluzionario: Gesù non si riconosce in un ritratto così distorto e, allora sì, si fa più deciso, più
provocante: «Ciechi e addormentati»! E spiega loro che il messia era venuto per servire e non per
regnare, per morire e non per uccidere, per offrire la vita e non per toglierla. E allora, finalmente, il
loro cuore comincia ad «ardere», e riemerge dal loro cuore ciò che prima e sempre avevano saputo
riguardo al loro maestro; e questa rinnovata consapevolezza trasforma concretamente la loro vita:
non tornano più ad Emmaus, rinunciatari che si rifugiano nel passato anonimo e sfiduciato, ma
ritornano a Gerusalemme, intraprendenti pionieri della Pasqua.
Il racconto di Emmaus è una sorta di chiave interpretativa per conoscere Cristo Gesù e per
conoscerci in riferimento a Lui, per farci emergere da noi stessi e per condurci all’incontro con Lui.
Al n. 17 della nota CEI sul Mezzogiorno (Per un paese solidale, febbraio 2010) leggiamo: «A
maggior ragione ci sentiamo provocati dalla sfida educativa sul versante intraecclesiale della
catechesi. Questa pure, nelle parrocchie e in ogni realtà associativa, va ripensata e rinnovata. Essa
dev’essere dotata il più possibile di una efficacia performativa: non può, cioè, limitarsi a essere
scuola di dottrina, ma deve diventare occasione d’incontro con la persona di Cristo e laboratorio in
cui si fa esperienza del mistero ecclesiale, dove Dio trasforma le nostre relazioni e ci forma alla
testimonianza evangelica di fronte e in mezzo al mondo. Da essa dipende non soltanto la corretta ed
11
efficace trasmissione della fede alle nuove generazioni, ma anche lo stimolo a curare e maturare una
qualità alta della vita credente negli adolescenti e nei giovani».
….il nonno zoppo di Martin Buber…
4. Per maturare la scelta
Per concludere occorre qui trattare anche il tema della scelta. A questo proposito gli
Orientamenti, al n. 10, sottolineano il fatto che, in un contesto socio-culturale esasperatamente
“plurale”, tale da risultare addirittura frammentato e frastagliato, il «compito più urgente» per la
comunità ecclesiale è quello di educare i suoi membri «a scelte responsabili». Per responsabilità, gli
Orientamenti intendono, in prima istanza, «la capacità di pensare e l’esercizio critico della ragione»
(n. 10). È un’accezione giusta e importante, consona alle conquiste positive della cultura moderna,
che come cristiani e come Chiesa non possiamo e non dobbiamo ignorare o snobbare. Ma nel
prosieguo degli Orientamenti emergono due altri significati di “responsabilità”, che mi sembrano
più congeniali al discorso che sin qui abbiamo sviluppato, più in prospettiva teologica che non
psicologica o sociologica.
Al n. 23 gli Orientamenti segnalano la necessità di smarcarci dal concepirci come uomini «senza
vocazione», giacché in realtà noi siamo chiamati ad essere chi dobbiamo essere secondo il progetto
di Dio: senza la consapevolezza e l’accettazione di questa vocazione, non possiamo portare a
compimento la nostra identità e rischiamo di rimanere immaturi. Responsabilità, allora, è
vocazione: significa, cioè, essere-chiamati, essere-interpellati. Solo chi è chiamato, può rispondere.
Responsabilità è, appunto, l’essere abili a rispondere o, meglio ancora, l’essere abilitati a
rispondere. Educare ed educarci alla responsabilità significa, di conseguenza, sviluppare il senso
vocazionale, far sì che questo permei l’intera nostra esistenza, ogni stagione ed ogni età della nostra
vita.
Al n. 25, poi, gli Orientamenti parlano anche di «pro-vocazione». Si potrebbe, a tal proposito,
ricordare la figura del “giovane ricco” di cui si parla nel vangelo. Questi, prima di essere “vocato”,
è provocato dal Maestro di Nazaret, invitato a superare la misura devota e pia della propria
esperienza credente, a spogliarsi persino di tutto ciò che può pur essere buono e giusto, come
l’osservanza dei comandamenti mosaici, per andare appresso a Gesù nel modo in cui Gesù vuole
essere seguito. L’educazione alla responsabilità si realizza, dunque, anche come pro-vocazione:
educare è provocare, stimolare cioè il nostro io a smarcarsi rispetto a se stesso, a sfuggire alla presa
dell’autoreferenzialità, ad oltrepassarsi in direzione di Dio. Come diceva Pascal: «L’homme
depasse infiniment l’homme». Così formare un’identità personale significa fare i conti con
l’esperienza dei nostri limiti, da intendere non come dei rassicuranti confini, entro cui ci sentiamo a
casa, protetti da chi sta fuori, bensì come una sorta di soglia, da valicare pendolarmente, uscendo
fuori per incontrare e conoscere ciò che sta oltre noi, e rientrando poi in noi per sedimentare nella
nostra coscienza il senso dell’incontro e i contenuti della conoscenza.
Tre mi sembrano le tappe che bisogna toccare per educare ed educarci alla scelta: il
discernimento, la rinuncia, l’opzione fondamentale.
Il discernimento si attua guadagnando la conoscenza oggettiva dei fatti che sperimentiamo, delle
persone in essi coinvolte, degli obiettivi da raggiungere, dei valori da conseguire. Significa
esercitare un giudizio, esprimere una valutazione, operare delle distinzioni, fare una cernita. Si
tratta, in altre parole, di educare/rci a vedere come stanno veramente le cose, educare/rci a un
sereno, composto, costruttivo senso (auto)critico. Che cosa sia il senso critico ce lo fa intuire
un’interessante indicazione che ci viene dalla nota CEI su Chiesa e Mezzogiorno, già citata. Al n.
17 di questa nota si legge che è necessario recuperare la capacità di vedere e di sperimentare il
versante invisibile, non ovvio, non scontato, della realtà in cui viviamo. La capacità, cioè, di
«restare ancorati al risvolto radicale di ciò che conosciamo e facciamo: al gratuito e persino al
grazioso e non solo all’utile e a ciò che conviene; al bello e persino al meraviglioso e non solo al
12
gusto o a ciò che piace; alla giustizia e persino alla santità e non solo […alla legalità e a ciò che è
lecito]». Educare e formare ad un tale senso critico vuol dire chiamare in causa le cosiddette
“domande radicali”, sul senso della vita (sul significato e sulla direzione da dare alla vita).
* cf. Pippo Fava….
…si può mentire sui valori penultimi, si possono promettere le cose materiali spacciandole per
certe e alla portata di tutti. Ma non si hanno argomenti per tergiversare intorno ai valori ultimi, ai
bisogni dell’animo. Di fronte al dolore dell’uomo la sicumera diventa balbettio. Al cospetto del
paradosso di una disperazione coraggiosa che osa continuare a sperare, la menzogna arrossisce e
batte in ritirata, le facili promesse ammutoliscono. L’annuncio del vangelo, operato con questo
stile e in questa direzione, traducendosi in ascolto delle parole umane, si rivela tutt’altro che
innocuo, molto più mordace di mille chiassose tribune politiche.
A una predicazione che è prima di tutto ascolto dell’uomo mi fa pensare, anche, un mistico e un
teologo tra i più grandi del Novecento italiano, don Divo Barsotti. Scrivendo su Leopardi, Divo
Barsotti ha osservato che «il valore ultimo della parola dell’uomo è quello di esser preghiera»,
cioè «parola rivolta a Dio». E «se la parola è bestemmia non cessa per questo di esser preghiera».
Per questo motivo, spiega Barsotti, è necessario – se si vuole davvero capire – ascoltare ogni
parola umana con le orecchie di Dio: «Soltanto Dio può ascoltare fino in fondo la parola
dell’uomo, perché in definitiva la sua parola è rivolta a Lui solo. Soltanto mettendoci con estrema
umiltà al posto di Dio, anche noi possiamo sperare di intenderla più pienamente».
Rinuncia è parola ormai demodé, che fa persino paura. Eppure, per fare delle scelte, è necessario
anche fare delle rinunce. Tutta l’esistenza cristiana, caratterizzandosi come cammino di
conversione, si fonda sull’esercizio della rinuncia. Non è vero che il cristianesimo, con le sue
peculiari esigenze, non richieda anche delle rinunce. Dire che la rinuncia non abbia nulla a che fare
con l’esperienza cristiana mi pare molto retorico. La rinuncia è innanzitutto il rispetto della libertà
altrui, che può talvolta esprimersi in direzione diversa rispetto alla nostra: in questo caso la rinuncia
è la scelta di non far valere sempre e comunque il nostro tornaconto. E, al contempo, è esercizio
della nostra stessa libertà, che ci sottrae a certi pericolosi condizionamenti: la rinuncia è, allora, dire
no a noi stessi e a ciò che soltanto apparentemente sembra essere il nostro miglior tornaconto. In
questo senso rinunciare non è mera passività, ma capacità di reazione. Nel Nuovo Testamento la
rinuncia, vissuta così, è uno dei dinamismi tipici della conversione, come nel rito battesimale è detto
in riferimento alla rinuncia più importante cui il cristiano è chiamato. È un momento della
epistrophé, del cambiare strada, del mutare orientamento al nostro cammino. Ed è un momento
della metánoia, del rinnovare i nostri pensieri, dell’andare oltre le nostre convinzioni, oltre le nostre
convenienze, oltre le nostre convenzioni. La rinuncia ha, in tal senso, la forza drammatica della
decisione, come l’etimo di questa parola ci lascia intuire: significa troncare, tagliare, anche con
grande sacrificio – com’è simboleggiato dal taglio della gola di un animale offerto nel tempio – e
significa inoltre risolvere, sciogliere – come avviene in tribunale, quando si decide circa una
controversia o si stabilisce l’esito di una causa – e, in definitiva, significa liberarsi. La rinuncia,
dunque, è una libera e liberante decisione, che non ha nulla a che fare con le decisioni prese quando
siamo con l’acqua alla gola. Educare/rci alla scelta significa anche educare/rci alla rinuncia e, in
definitiva, alla libertà.
L’ultima tappa dell’educazione alla scelta è l’opzione fondamentale. Si tratta di una scelta che,
presa “una volta per tutte”, viene però ribadita “ogni volta”, di nuovo presa tante altre volte, in
coerenza alla prima volta. L’opzione può essere fondamentale proprio in questo senso: perché sta a
fondamento di un edificio, quello della nostra identità personale, come le fondamenta stanno alla
base di un’architettura che va prendendo forma, diventando una casa e sviluppandosi persino in un
palazzo. L’opzione fondamentale è, dunque, una scelta al contempo definitiva e permanente. Essa,
come tale, non ha a che fare con la precarietà, come accade per le scelte “a tempo”. Ma ha a che
fare con la pro(v)visorietà, nel senso che proietta in avanti chi la compie, gli conferisce la capacità
13
di guardare innanzi, di avvistare già la meta del proprio cammino, in modo tale che ogni scelta fatta
sia propedeutica alle scelte successive e a conferma di quelle precedenti. La scelta, così, non è mai
estemporanea, non è mai sull’onda di un’emozione passeggera, ma si inscrive in un disegno
globale, è la linea di un progetto più vasto, è il tassello di un mosaico più complesso.