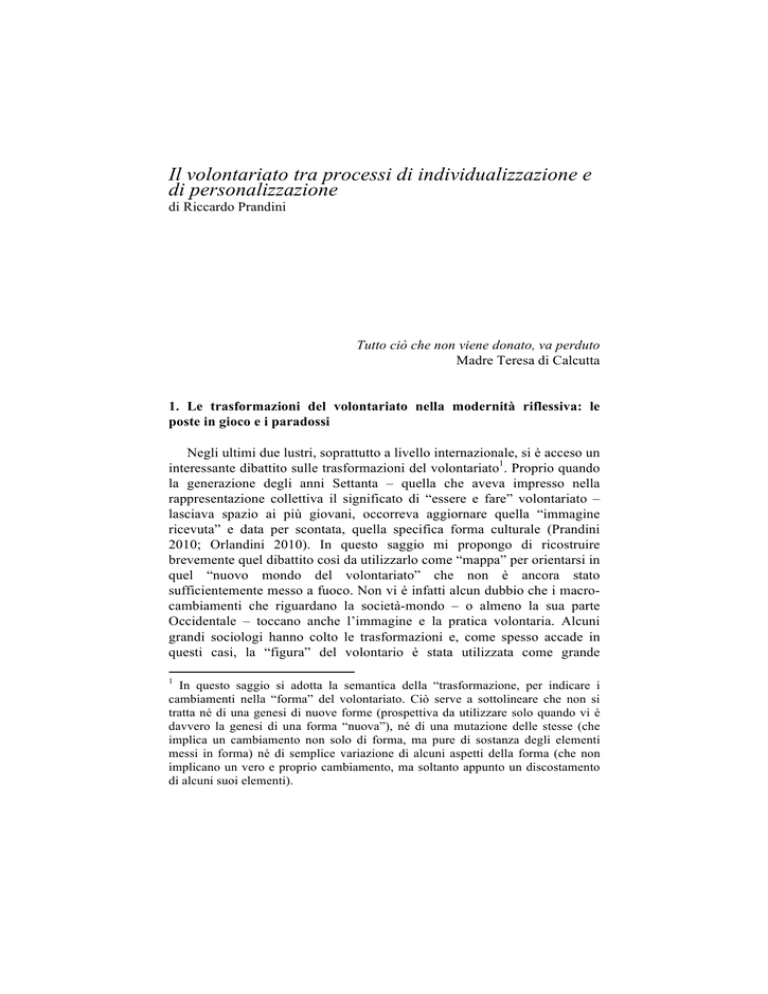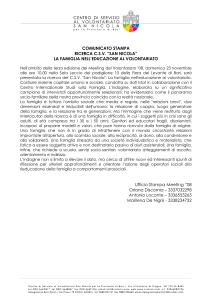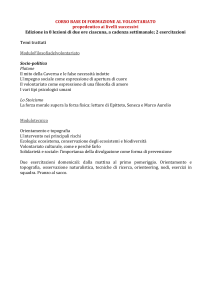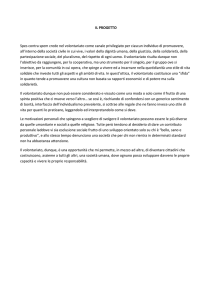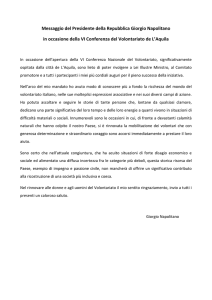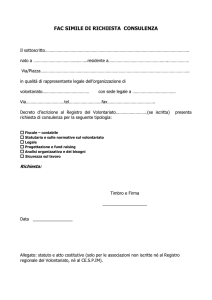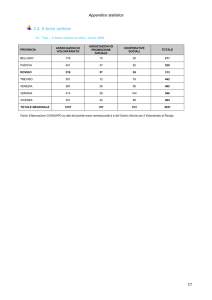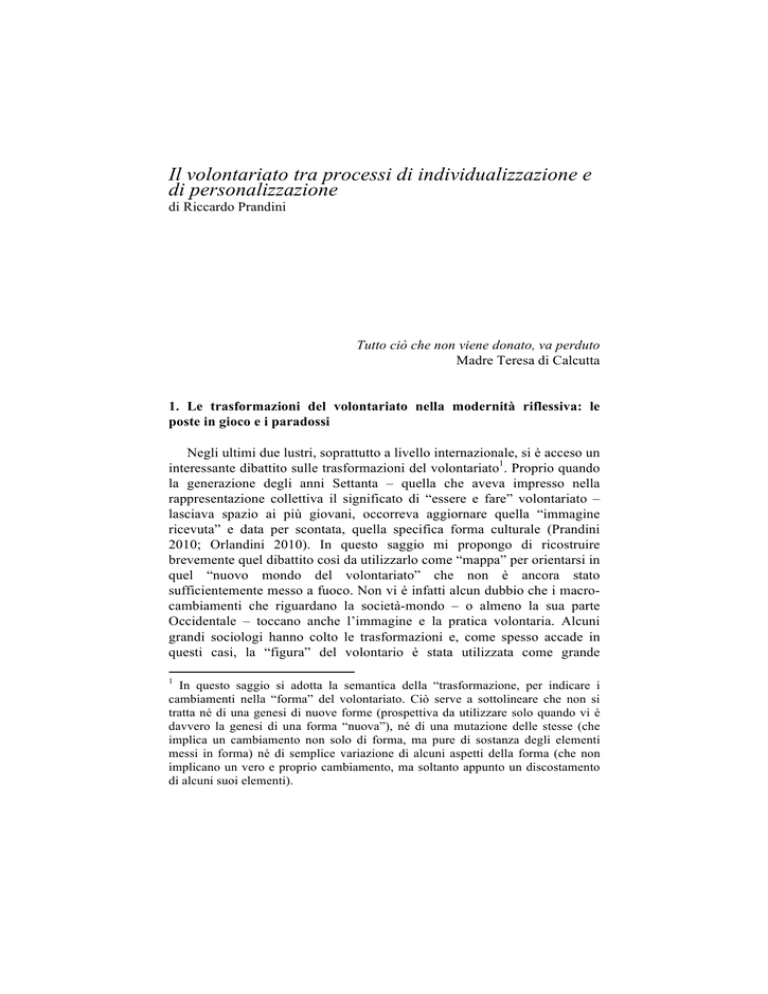
Il volontariato tra processi di individualizzazione e
di personalizzazione
di Riccardo Prandini
Tutto ciò che non viene donato, va perduto
Madre Teresa di Calcutta
1. Le trasformazioni del volontariato nella modernità riflessiva: le
poste in gioco e i paradossi
Negli ultimi due lustri, soprattutto a livello internazionale, si è acceso un
interessante dibattito sulle trasformazioni del volontariato1. Proprio quando
la generazione degli anni Settanta – quella che aveva impresso nella
rappresentazione collettiva il significato di “essere e fare” volontariato –
lasciava spazio ai più giovani, occorreva aggiornare quella “immagine
ricevuta” e data per scontata, quella specifica forma culturale (Prandini
2010; Orlandini 2010). In questo saggio mi propongo di ricostruire
brevemente quel dibattito così da utilizzarlo come “mappa” per orientarsi in
quel “nuovo mondo del volontariato” che non è ancora stato
sufficientemente messo a fuoco. Non vi è infatti alcun dubbio che i macrocambiamenti che riguardano la società-mondo – o almeno la sua parte
Occidentale – toccano anche l’immagine e la pratica volontaria. Alcuni
grandi sociologi hanno colto le trasformazioni e, come spesso accade in
questi casi, la “figura” del volontario è stata utilizzata come grande
1
In questo saggio si adotta la semantica della “trasformazione, per indicare i
cambiamenti nella “forma” del volontariato. Ciò serve a sottolineare che non si
tratta né di una genesi di nuove forme (prospettiva da utilizzare solo quando vi è
davvero la genesi di una forma “nuova”), né di una mutazione delle stesse (che
implica un cambiamento non solo di forma, ma pure di sostanza degli elementi
messi in forma) né di semplice variazione di alcuni aspetti della forma (che non
implicano un vero e proprio cambiamento, ma soltanto appunto un discostamento
di alcuni suoi elementi).
metafora di cambiamenti più globali e radicali. Chi, come Putnam (2000),
ha parlato di “esaurimento generazionale” del volontariato (negli Us) e chi,
come Wuthnow, lo ha contraddetto presentando miriadi di casi di loose
connections (1998); chi ne ha decretato il “restringimento” (Macduff 2004)
e chi lo “svanire” (Gaskin 1998); chi ha diagnosticato la crisi irreversibile
delle appartenenze a organizzazioni fortemente strutturate (Dekker e van
den Broek 2006); chi da tempo analizza le forme episodiche e contingenti
di volontariato (Hustinnx 2010a). Tutte queste immagini convergono verso
la macro-tesi della de-tradizionalizzazione e individualizzazione del nuovo
volontariato (Hustinx e Meijs 2011). Come vedremo più analiticamente, il
quadro di riferimento teorico di questi studiosi è tale da focalizzarsi sui
processi di individualizzazione, sradicamento, professionalizzazione,
managerializzazione, mercantilizzazione, etc. del volontariato, a scapito di
altre fenomenologie che – pur non contraddicendo questa “Grande
trasformazione” – ne illuminano lati diversi e non meno importanti, tali da
ricostruirne una immagine più complessa e realistica. Simultaneamente il
volontariato di trans-forma anche come personalizzazione, ri-radicamento,
umanizzazione, centratura sulle cure all’altro, etc., tutti aspetti che dentro a
un unico quadro interpretativo non possono essere realmente colti e
spiegati. Chi propone la tesi della individualizzazione e detradizionalizzazione del volontariato, non può fare altro che osservare
anche sviluppi del tutto contrastanti, come gli innumerevoli tentativi di riradicamento da parte di “Terze parti” istituzionali, mediante strategie
normative obbliganti. Si pensi, solo come esempio, alle innumerevoli
proposte di istituire un “servizio civile obbligatorio” per i maggiorenni, o a
tutti i programmi di socializzazione all’azione volontaria messe in campo
dalle istituzioni scolastiche, educative e finanche dal mondo for profit.
Questo modo di osservare, però, non fa altro che ribadire in modo poco
innovativo le dinamiche contraddittorie di libertà e controllo (della stessa
libertà) che caratterizzano da tempo la tarda modernità. In pratica anche
l’esperienza del volontariato è sottoposta alla sindrome tipica del gioco
“guardia e ladri”: a processi di liberalizzazione e mercantilizzazione del
volontariato – che s-catenano energie prima incastonate istituzionalmente –
si prova a rispondere con processi di obbligazione e re-istituzionalizzazione
che falliscono l’obiettivo in quanto non fanno altro che deviare le spinte
liberalizzanti in altri spazi-tempi (Teubner 2012).
Ne deriva, come cercherò di spiegare, una dinamica culturale che rende
sempre più difficile riconoscere queste nuove configurazioni come
“volontariato”. Alcune ricerche hanno mostrato proprio come le persone
comuni, attraverso il “buon senso”, non riconoscano più in molte delle
attività attuali il “volontariato”, e cercassero continuamente di ridifferenziarlo, nella sua concettualizzazione e nel suo operare, dalle sue
manifestazioni spurie (Handy et alii 2000). Questa dinamica di autodifferenziazione del campo del volontariato ricorda, nel suo aspetto
processuale, la tragedia della cultura di simmeliana memoria: qualsiasi
“forma” culturale istituita viene decostruita e messa in crisi dal fluire della
“vita” sociale che preme per ridefinire i confini di significato delle forme.
D’altra parte l’espressione “vivente” del volontariato, per potersi
manifestare, necessita di prendere “forma”. Le rappresentazioni culturali e
le pratiche del volontariato vengono costantemente ibridate e “toccate” da
altri valori provenienti da altri sub-universi di senso (per esempio:
dall’efficacia; dalla professionalizzazione; dalla ricerca di ricompense
sociali; dalla necessità di regolazione, etc.). Questa ibridazione crea in un
primo memento “forme” spurie di volontariato che hanno una loro logica e
rispondono a determinati problemi, venendosi così a istituzionalizzare.
Simultaneamente però, il nucleo “puro” del (valore sociale del)
“volontariato”, attraverso l’operare di particolari attori (individuali – e quali
leader – e/o collettivi), si ri-distingue dalle ibridazioni, innescando veri e
propri processi di “fuga”. Nella parte finale del saggio vorrei provare a
descrivere proprio la parte ricostruttiva di questa dinamica di “toccata e
fuga”, laddove sono i volontari stessi ad auto-differenziarsi dalle
commistioni con logiche spurie e a ri-specificare le aspettative di ruolo che
informano la figura del volontariato. Cercherò quindi di innescare una
riflessione su cosa significhi, oggi, essere ed agire come volontari.
L’ipotesi che introduco afferma che oggi volontari si diventa (e si viene
riconosciuti come tali), solo in-vestendo la propria identità personale di un
certo “abito”, impegnandosi nel generare, in un certo modo, “legame
sociale” di un certo tipo2. Le variabili distintive in opera in questo divenirevolontario sono almeno tre: 1) l’abito sociale con cui si in-veste la propria
identità personale; 2) la modalità di operare; 3) il tipo di legame sociale
generato. La prima variabile è costituita dalla distinzione
“personale/individuale”; la seconda dalla distinzione personalizzante
(unico)/spersonalizzante (standardizzato); la terza dalla distinzione
2
Utilizzo il concetto di in-vestimento e di im-pegno, riprendendoli dalla
concettualizzazione di Laurent Thévenot (2006). In buona sostanza il concetto di
investimento richiama alla necessità di dare “forma” riconoscibile alle proprie
azioni, affinché siano collegabili ad altre azioni: quello di impegno, sta a
significare che ogni azione è implicata in un contesto esistenziale e che istituisce
un rapporto di co-implicazione.
prossimo/distante. Potremmo sintetizzare il discorso con l’affermazione
“creare legame sociale è possibile in molteplici modi”, ma solo uno
particolare è quello riconosciuto come genuinamente generato mediante
l’agire volontario: quello messo in opera “personalmente”, in modo
“personalizzante” e capace di generare un legame di “prossimità”. Quali
sono i contesti strutturali e culturali, oltreché personali, che rendono
possibile essere “volontari”, oggi, diversamente che nel passato? Questa
riflessione mi pare necessaria proprio nel momento in cui stiamo perdendo
la vecchia rappresentazione e pratica del volontariato.
In altre parole vorrei riflettere sui processi sociali (e non psicologici)
che “trasformano” un individuo in “volontario”, cercando di mostrare
come, similmente agli “oggetti” della quotidianità, anche gli individui
possano “tradursi” da un contesto uniformante – in cui vengono valutati in
quanto portatori oggettivi di ruoli – a contesti dove sia invece atteso il loro
agire “personalizzato”. Da qui, trattandosi comunque di uno shift, di un
crossing, tra contesti e ruoli diversi, concluderò con il paradosso della
“tragedia” del volontario: volontari si diventa agendo al di fuori dei ruoli
professionali, familiari, politici, etc., tipici della società contemporanea
funzionalmente differenziata; simultaneamente, però, per fare/essere
volontario si deve entrare in un ruolo sociale ben definito, riconosciuto,
contestualizzato in organizzazioni (formali o informali), con identità e
storie precise. Questo ruolo è a sua volte un fascio di aspettative
socialmente istituzionalizzate e quindi non è concepibile come lo spaziotempo della libertà individuale, bensì come un abito che si indossa (e su cui
“investe”) per agire in certi modi. Questa uscita – da ruoli funzionalmente
definiti – ed entrata – nel ruolo del volontario – è chiaramente un paradosso
perché l’agire volontario (per essere tale) deve uscire da certe aspettative
senza però rimanere in uno spazio neutrale, bensì ri-entrando in un diverso
ruolo dove ci si aspetta un agire specifico. Il paradosso sta nel potersi
“convertire” in volontari in modo non volontaristico, bensì rientrando la
distinzione agire personale/agire di ruolo, dentro all’agire di ruolo. In
questa operazione di re-entry, il volontario in-veste la sua identità in una
forma riconoscibile socialmente, ma questa particolare riconoscibilità
converte la forma da qualcosa di “uniforme” verso la possibilità di
trascendere se stessi (come individui standardizzati dalle attese funzionali
sistemiche); converte nella direzione di un “divenire-persona”.
2. Nuove forme di volontariato come risposta ai processi di
individualizzazione sociale e il paradosso della “dividuazione”
2.1. Le nuove forme del volontariato: da quello collettivo a quello riflessivo
Per inquadrare la riflessione internazionale sulla figura del volontario e
del volontariato, utilizzerò alcuni illuminanti contributi di Lesley Hustinx.
La sociologa belga ci aiuterà a situare il passaggio del volontariato
cosiddetto “tradizionale e classico” a quello “moderno e/o nuovo”. Si tratta
di marcare un passaggio di “figura” e di orizzonte culturale che
sembrerebbe accadere verso la metà degli anni Ottanta. In entrambi i casi –
quelli del volontariato tradizionale e moderno – siamo al cospetto di figure
tipiche soltanto della società moderna differenziata per funzioni. Ogni
società, in ogni tempo e spazio, ha conosciuto atti di generosità, di aiuto
gratuito, di cura incondizionale, ma soltanto la società moderna –
strutturandosi sulla base di funzioni specifiche svolte entro specifiche sfere
d’azione – ha ritagliato un ruolo per il “volontario”. Non è un caso che, se
si sfoglia un qualsiasi dizionario della lingua italiana, le prime due
accezioni del termine riguardino la relazione tra un individuo e i ruoli
militari, prima (l’arruolarsi e il prestare servizio, come volontario, nelle
forze armate di uno stato o in una formazione militare o paramilitare);
occupazionali (prestazione volontaria di lavoro, gratuita o semigratuita,
eseguita al fine di acquisire la pratica necessaria allo svolgimento di
un’attività professionale o di un lavoro, e il relativo titolo di
riconoscimento) e, solo in ultimo (anche in termini temporali) in
riferimento al cosiddetto terzo settore (prestazione volontaria e gratuita
della propria opera, e dei mezzi di cui si dispone, a favore di categorie di
persone che hanno gravi necessità e assoluto e urgente bisogno di aiuto e di
assistenza, esplicata per far fronte a emergenze occasionali oppure come
servizio continuo). Non si tratta dunque di analizzare tratti psicologici
peculiari di certi individui (la “propensione” o “l’orientamento” al
volontariato) e neppure tipologie caratteriali, quanto di soffermarsi su
quelle aspettative riflessive (su quella cultura socialmente trasmessa), che
permettono ai membri di una società di riconoscere in certe esperienze ed
azioni quelle del “volontario”.
Nella definizione corrente gli elementi definitori della figura del
volontario sono: 1) operare a favore di altri (solitamente non della propria
cerchia familiare) o di organizzazioni; 2) senza alcun corrispettivo in
denaro; 3) in modo del tutto libero; 4) entro un contesto organizzativo (Van
Daal 1990). Si noti come la quarta caratteristica sia fondamentale anche se
spesso non debitamente considerata. Infatti, agire liberamente e senza
remunerazione è qualcosa di (normativamente) atteso nella sfera familiare e
amicale (per cui apparecchiare la tavola o aiutare a portare in casa la spesa,
etc., non sono attività considerate di volontariato), ma anche del tutto
normale entro quasi tutte le sfere sociali non familiari/intime: aiutare un
collega di lavoro a terminare le pratiche urgenti; dare una mano all’anziana
per trasportare un pacco; aiutare un vicino a tenere in ordine il giardino,
etc., sono attività volontarie e gratuite, ma che non rientrano del tutto
nell’esperienza moderna del “volontariato”. Certo, personalmente ci si può
sentire volontari, ma se lo si fa da soli e senza rendersi pubblicamente
riconoscibili come “volontari”, questo agire è piuttosto classificato come
dedizione personale a una causa o come generosità. Il rapporto con una
organizzazione o un gruppo (più o meno formalizzato) e la continuità
dell’agire nel tempo (e nell’organizzazione), sono perciò aspetti centrali per
definire il volontario. Questo per il motivo fondamentale che il
“volontario” come figura riconoscibile socialmente, deve (in)vestirsi di un
particolare ruolo, tra gli altri a disposizione, che appunto gli permette di
presentarsi pubblicamente come tale (“faccio volontariato”). Non sempre
comunque l’identificazione del volontario è agevole. Si pensi a un signore
in pensione che – in modo continuativo, a casa sua e senza pubblicizzarlo –
aiuta dei bambini a fare i compiti. In questo caso, potremmo dire che egli fa
del volontariato, ma non è “un” volontario in quanto non membro di alcuna
organizzazione riconoscibile. Per ovviare a queste difficoltà definitorie, lo
studioso Cnaan (1996) propone di identificare il volontariato in modo
graduale, partendo dalla sua “forma” pura fino ad ampliare la definizione.
Egli seleziona quattro variabili definitorie: 1) libertà vs obbligo ad agire; 2)
assenza di remunerazione vs remunerazione molto bassa o solo simbolica;
3) contesto organizzativo in cui si opera (formale vs informale); 4)
beneficiari dell’attività (l’Altro generalizzato e sconosciuto vs se stessi).
Come vedremo a breve, sono proprio i contemporanei processi di
mutamento sociale che stanno rendendo sempre più difficile identificare i
volontari e il volontariato, soprattutto tra le generazioni più giovani.
La Hustinx, ponendo il cambiamento del volontariato circa a cavallo
degli anni Ottanta, almeno in Europa, lo definisce in diversi modi: come
passaggio da un orientamento collettivistico a uno individualistico, da uno
basato sull’appartenenza a una basato su progetti; da uno istituzionalizzato
a uno auto-organizzato. In buona sostanza il vecchio volontario che agiva
per in modo continuativo, impegnandosi per una causa collettiva e
socialmente condivisa, entro la stessa organizzazione, sta lasciando il posto
a un impegno molto più caratterizzato da interessi personali (non inquadrati
in un contesto comune), forte ricerca di auto-realizzazione e da finestre
temporali più brevi (Hustinx 2010b). Più in generale quella della Hustinx è
una interpretazione modernista che legge i cambiamenti e le innovazioni in
termini di de-tradizionalizzazione, sradicamento, individualizzazione, autoriflessività (della modernità). Fondamentale per questa interpretazione è
l’idea che la Modernità – dopo aver trasformato le strutture e le culture
delle società tradizionali – stia auto-sabotandosi, rendendo le proprie
strutture e processi sempre più precari e ambigui. Dal punto di vista del
Terzo settore, potremmo ipotizzare un passaggio da una esperienza di tipo
collettivistico e fortemente etero-normativa (l’appartenere a grandi
movimenti con strutture ideologiche precostituite), ad una più
individualistica e autonoma. Il volontariato “serio” starebbe declinando
generazionalmente sostituito da un nuovo ethos, cioè da disposizioni e
preferenze soggettive, orientato agli interessi e bisogni personali, alla
ricerca di autonomia e libertà rispetto alle organizzazioni, alla selezione
chiara e precisa di compiti e tempi per eseguirli: in una parola a un ethos
dell’auto-realizzazione personale che utilizza il volontariato in termini
piuttosto strumentali. Potremmo anche dire, utilizzando i termini di Taylor
e di Bellah, che il volontariato contemporaneo esprime un ethos terapeutico
ed espressivistico, ma simultaneamente anche uno atomistico e strumentale
(Taylor 1994). Ciò andrebbe a trasformare poco a poco e strutturalmente il
ruolo stesso del volontario, rendendolo più effimero, transitorio, episodico:
meno “comunitario” e più individualistico; meno duraturo; meno rivolto al
bene degli altri; meno “sacrificale”, etc. Di fronte a questo ipotetico
cambiamento, si osservano da parte delle organizzazioni – da un lato –
tentativi “dal basso” di personalizzare i compiti e gli impegni richiesti ai
volontari, rendendoli molto più flessibili e negoziabili e – dall’altro –
tentativi “dall’alto” da parte di istituzioni pubbliche di rinvigorire il
volontariato andando a cambiare le componenti di “volontarietà” e di
“gratuità” che stanno al cuore della pratica. Agli individui è richiesto di
“fare volontariato” come esperienza curriculare necessaria ad acquisire un
posto di lavoro e le loro attività vengono riconosciute e remunerate in
modalità diverse.
Le teorie della modernizzazione riflessiva che basicamente stanno alla
base di questa diagnosi (Beck e Beck-Gernsheim 2002), riconoscono la
compresenza di almeno due fonti normative in contraddizione e
competizione reciproca nel dare senso alle biografie contemporanee dei
volontari: da un lato una spinta verso l’individualizzazione che mal
sopporta ogni appartenenza collettiva forte e qualsiasi richiamo alla
eteronomia; dall’altro una spinta ad appartenenze più stabili ed eteronome
che, seppure non più di tipo tradizionale, si richiamano ancora a quadri di
riferimento comuni. La modernità riflessiva non è la semplice Modernità
con il suo progetto in “crisi”, bensì l’insieme plurale di culture – derivato
dalla decostruzione di quel progetto – che si scontrano l’una con le altre. A
partire da questo sfondo, Hustinx e Lammertyn (2003) elaborano una
tipologia di stili di volontariato basata sulle trasformazioni strutturali delle
biografie individuali. Vengono considerati i percorsi biografici dei
volontari, così come sono inquadrati entro le strutture e culture sociali
contemporanee. Non siamo di fronte a una versione individualistica del
cambiamento, ma invece a una focalizzata sulle trasformazioni embedded
delle biografie individuali. Gli autori differenziano un piano oggettivo
dell’analisi – che riguarda i vincoli strutturali delle biografie – e uno
soggettivo relativo alle motivazioni. Selezionano poi sei variabili specifiche
che dovrebbero caratterizzare quegli stili: il quadro di riferimento
biografico; la struttura motivazionale; il corso e l’intensità dell’impegno;
l’ambiente organizzativo; la scelta del campo di attività; la relazione al
lavoro (pagato). Ne derivano due macro tipologie di volontariato, quello
“tradizionale” e quello “riflessivo”, che sintetizziamo nella Tab. 1.
Tab.1. Quadro analitico per esplorare stili collettivi e riflessivi di
volontariato. Fonte Hustinx e Lammertyn (2003).
Quadro di
riferimento
biografico
Struttura
motivazional
e
Stile di volontariato
Volontariato collettivo
Volontariato Riflessivo
Oggettivo:
Soggettivo:
Oggettivo:
Soggettivo:
strutturalemotivazionalestrutturalemotivazionalecomportamentale
attitudinale
comportamentale
attitudinale
- Biografia standard
- Identità
- Biografia auto- Auto-identità;
e collettiva;
collettiva;
costruita;
- Auto- Continuità
- assoggettamento
- Discontinuità
riflessività;
biografica;
dato per scontato
biografica;
- Match
- appartenenza
ai fini collettivi;
- appartenenza
biografico;
ascrittiva al gruppo; - Dichiarazione di
elettiva al gruppo;
- Libertà e
- Codice di condotta
appartenenza al
- Corso d’azione
incertezza;
collettivamente
gruppo;
auto-determinato.
- Autoprescritto.
- Monitoraggio
monitoraggio
eteronomo.
- Coordinare il
- Senso ovvio del
- Interazione intensa
- Motivazioni
significato religioso
dovere e di
tra condizione
auto-centrate;
e ideologico;
responsabilità alla
biografica ed
- Strumenti per
- Posizioni e ruoli
comunità e alla
esperienza di
avere a che fare
chiari nella
collettività;
volontariato;
con incertezze
comunità di
- Strumenti per
- Discontinuità
biografiche e per
rilevanza.
una affermazione
biografiche in
una autodi stabilità e
termini di crisi e di
realizzazione
identità
ri-orientamenti
attiva;
biografica.
attivi.
- individualismo
“solidale” o
“altruistico”.
Corso e
intensità
dell’impegno
- Corso di vita
prevedibile è la
base per un
impegno regolare e
a lungo termine;
- Partecipazione
intensa;
- Impegno centrale.
- Impegno
incondizionale ed
auto-evidente;
- Devozione
completa.
Ambiente
organizzativ
o
- Gerarchico,
organizzazioni
segmentate
socialmente o
ideologicamente;
- Centralità di
leadership forti;
- Accoppiamento
stretto tra
appartenenza
formale e
volontariato;
- Volontariato
associativo.
Inclusione/esclusion
e basate
sull’universalismo
di una cultura e di
modi di vita
comuni;
- Iniziate e
controllate da altri;
- Riproduzione di
modelli di genere
tradizionali.
- Attaccamento
forte
all’organizzazion
e;
- Impegni
sovrapposti;
- Socializzazione
e integrazione
tramite impegno;
- Dedicazione ai
valori e scopi
organizzativi.
- Società centrata
sul lavoro
retribuito;
- Autorità
professionale;
- Posizione ancillare
del volontario.
- Buone
intenzioni e senso
comune.
Scelta
dell’attività
Relazione al
lavoro
pagato
- Politiche basate
sul gruppo;
- Solidarietà
ristretta;
- Idealismo;
- Impegno
comunitario di
ampio respiro e
multi scopo.
- Corso di vita
imprevedibile è la
base per un
impegno accidentale
, irregolare e a breve
termine;
- coinvolgimento
dinamico: entrate e
ritirate frequenti;
- flessibilità e
mobilità;
- impegno effimero
o lasco.
- Organizzazioni
non profit e
terziarie, iniziative
decentralizzate;
- Disaccoppiamento
tra membership e
volontariato;
- Strutture
istituzionali e forme
di acquisizione
centrate sui
volontari;
- Volontariato di
programma.
- Disintegrazione
locale tra
integrazione
globale; reti elettive
globali;
- interazione tra
azione locale e
impegni locali.
- Significato esteso
del lavoro;
volontariato come
parte
dell’esperienza
lavorativa;
Professionalizzazio
ne del settore
volontario e del
- Impegno
condizionale,
dipendente su
bisogni e
condizioni
biografiche;
- Preferenza per
progetti
sequenziali e
contingenti.
- Attaccamento
all’organizzazion
e debole;
- impegno
vicario;
- Impegno
delocalizzato;
- Orientamenti
funzionali: focus
sulle attività
offerte; non sulle
organizzazioni in
cui sono prestate.
- Politiche
dell’identità e
degli stili di vita;
- Sentimenti
contingenti di
solidarietà;
- Pragmatismo,
attivismo
localizzato;
- Preferenza per
servizi
personalizzati;
- Valori postmaterialistici.
- Volontari
professionali.
volontariato;
- Volontariato
corporativo.
Come è facile osservare gli stili sintetizzano due momenti della
Modernità, quello tipico dalla fine delle Guerra Mondiale – fino alla metà
degli anni Settanta (tradizionale) – e quello successivo che vede esplodere
le pratiche riflessive. Per inciso si tratta di un passaggio generazionale che
vede esplodere i cosiddetti valori immateriali. Gli autori concludono e
rilanciano la loro proposta teorica con tre riflessioni: 1) non è
assolutamente vero che la cosiddetta “individualizzazione” del volontariato
coincida con una perdita di influenza della società. I processi di
individualizzazione sono processi del tutto sociali. Le dinamiche strutturali
che innescano l’imprevedibilità e la complicazione dei corsi di vita, la
cultura del professionismo che entra nel volontariato – così come molte
altre pressioni strutturali e culturali collettive – danno forma alle nuove
esperienze di volontariato; 2) una vera trasformazione è visibile nella
relazione tra i volontari e le organizzazioni. È infatti evidente che i
volontari più giovani non hanno una relazione di appartenenza forte e
neppure una forte identificazione con i valori e le procedure delle
organizzazioni. Il rapporto è molto più lasco, libero, meno coinvolgente e
più pragmatico. Inoltre l’impegno dei volontari tende a diventare più
intermittente, oscillante, contingente, dipendente da molti altri impegni che
si sovrappongono in maniera non sempre ordinata o ordinabile (e ciò deve
essere tenuto in conto dalle organizzazioni); 3) infine, tra chi esperimenta
momenti di volontariato aumenta la presenza di persone dotate di capitali
umani, economici e sociali elevati, mentre tendono a venire marginalizzati
coloro che hanno minori dotazioni. Questa riflessione è corroborata da
miriadi di ricerche internazionali che mostrano correlazioni statistiche
positive tra numero di volontari/organizzazioni volontarie, un contesto
sociale sviluppato e con la presenza di istituzioni pubbliche forti
(contraddicendo la tesi della “compensazione” tra pubblico e privato).
2.2. Le strategie per affrontare l’individualizzazione: l’emergere della
volunteerability
In un successivo saggio Hustinx e Meijs (2011), a partire dalla
riflessione sulla de-tradizionalizzazione del volontariato, presentano le
diverse strategie messe in atto per re-radicarlo collettivamente. Identificano
perciò due aspetti salienti della trasformazione biografica in atto che
influenzano la capacità di diventare volontari: 1) la volontà e 2) la
possibilità, di diventare volontari. Il primo aspetto riguarda le preferenze
individuali – i desideri e i bisogni – che orientano le persone a diventare
volontari; il secondo riguarda invece i cambiamenti sociali strutturali che
influenzano le biografie individuali e che, conseguentemente, possono
agevolare o limitare la possibilità di diventare volontari. Gli studiosi
osservano il “divenire” volontari dal punto di vista soggettivo (quanto si
desideri fare volontariato) e oggettivo (il contesto che agevola o contrasta
quella volontà). L’insieme di aspetti soggettivi e oggettivi definisce la
variabile chiamata volunteerability delle persone (la loro “volontariabilità”): non solo il desiderio personale di diventare volontario, ma anche
tutto quell’insieme di funzionamenti che possono agevolare il volontariato.
Questa volontari-abilità può essere sostenuta e agevolata a tre livelli
operativi: individuale (lavorando sugli orientamenti valoriali personali),
organizzativo (lavorando sulla relazione tra volontari e organizzazioni) e
sociale (lavorando sui macro contesti di vita che possono agevolare il
volontariato come, per esempio, gestire meglio l’organizzazione temporale
della società). I tentativi di promuovere la volontari-abilità, cioè di riradicarla in un contesto comune e non individualistico, fanno presa su
diverse logiche, strategie e attori. Le logiche possono essere “funzionali”
e/o “normative” e sono finalizzate a ri-orientare i volontari – sempre più
alla ricerca di premi e ricompense individuali – verso ricompense più
collettive. Rispetto alla variabile della willingness soggettiva, le logiche
sono solitamente di tipo normativo, come per esempio i tentativi di
socializzare a valori di buona cittadinanza e impegno comune; rispetto al
lato oggettivo della availability, invece, si lavora sulla pervasiva mancanza
di tempo e sull’asimmetrizzazione tra i tempi sociali. Le organizzazioni di
volontariato rispondono a quelle sfide ampliando, per i loro membri, le
possibilità di negoziazione e di impegno contingente. In sintesi pretendono
un impegno meno durevole e pervasivo, accettando invece volontari
“oscillanti”. Le strategie attuate comprendono, da un lato, la possibilità di
adattarsi alle nuove spinte individualistiche e, dall’altro, tentativi di
rimediare alle conseguenze negative dell’individualizzazione. Nel primo
caso non si cerca di legare il volontario per sempre e “olisticamente”, bensì
a progetti limitati nel tempo e molto specifici: il volontario non “sposa” la
causa “nella buona e nella cattiva sorte”, ma più semplicemente si impegna
finché ciò lo soddisfa. Potremmo dire con Giddens che il volontario elabora
una relazione “pura” con l’organizzazione. Organizzazioni e volontari
negoziano e scambiano tempi, impegni, risorse, premi, riconoscimenti, etc.,
sviluppando così strategie “funzionalmente abilitanti”. Nel secondo caso,
più presente tra le istituzioni pubbliche, si opera mediante pressioni
normative di tipo culturale cercando di modificare e contrastare la cultura
dell’individualismo. Qui sono protagoniste tutte le “campagne” di
informazione e formazione del volontariato che cercano di modificare la
willingness dei cittadini. Rispetto agli attori, infine, si distingue tra interni,
cioè relativi alla organizzazione, ed esterni cioè relativi a terze parti (quali i
governi, le aziende, la scuola, i gruppi di pressione, i mass mediai, etc.) che
cercano di influenzare la partecipazione al volontariato elaborando ampi
programmi di socializzazione (corsi di civismo, giornate del volontariato,
giorno della donazione, servizio civico pubblico, etc.).
Gli autori evidenziano tre tipi diversi di strategie in atto. La prima
prende il nome di “abilitazione funzionale” e risponde in termini
prevalentemente organizzativi ai problemi dell’individualizzazione. I nuovi
valori e desideri degli individui – così come la loro disponibilità di tempo
sempre minore, contingente, episodica e oscillante – spingono le
organizzazioni a ritagliare le loro attività in modalità estremamente
individualizzate. Si parla quindi di “flessibilizzazione” laddove si cerca di
proporre impegni più leggeri e semplici che necessitano di meno
competenze e attenzioni. In buona sostanza il management delle
organizzazione rende più semplice ai volontari entrare ed uscire dal
contesto, riducendo il loro impegno e modificando il significato dello
stesso. È come se il taylorismo fosse entrato nel mondo del volontariato,
con le conseguenze del caso. Non più artigiani, ma operai in una sorta di
catena di montaggio del volontariato. Uno dei modi più utilizzati dalle
organizzazioni per attirare nuovi individui, è quello di unire una esperienza
di volontariato con un diverso tipo di esperienza (per esempio lavorativo,
religioso, politico, di tempo libero, etc.), o viceversa, così da rendere
possibili due esperienze nel medesimo tempo. Altri esempi molto
interessanti sono quelli di combinare una esperienza di volontariato a un
“appuntamento” con altri individui single; organizzare esperienze di
volontariato famigliare così da tenere unite le famiglie per un obiettivo
comune; sperimentare forme di “volon-turismo” mixando turismo e
volontariato; unire volontariato ambientalista con attività fisica e finalizzata
al fitness, etc. Questo tipo di strategia è chiamato Add-On e implica che i
volontari non debbano dedicare tempo alla sola attività di volontariato,
bensì fare diverse cose e apprendere nuove capacità che potranno poi essere
spese ben al di fuori della sfera volontaria. Non a caso sempre di più i
datori di lavoro sono interessati a ingaggiare persone che abbiano avuto
anche esperienze di volontariato, perché ritenute più capaci di lavorare in
opzione multitasking.
La seconda strategia ha invece a che fare con “pressioni normative” che
cercano di influenzare i processi di individualizzazione, esattamente in
termini opposti ai precedenti. Qui, infatti, si tratta di agenzie formative
prevalentemente terze, meno implicate sul piano pratico e organizzativo,
che tentano di ri-socializzare i volontari a pratiche meno individuali e
contingenti. Le strategie istituzionali vanno da pressioni limitate che
mostrano ricompense innovative per i volontari; modalità per informare in
modo chiaro sul tipo di impegno richiesto; obblighi istituzionali. Gli autori
distinguono tra soft pressure esercitate soprattutto dai governi, dai politici o
da leader che fanno appelli pubblici per il volontariato, celebrandone le
virtù e provando a incrementare la willingness degli individui appellandosi
a valori come la solidarietà collettiva, la cittadinanza attiva e la coesione
sociale: e hard pressure come ad esempio l’istituzione di banche del tempo
che rendono reciproco l’aiuto, andando così a modificare il sistema di
ricompense del volontariato (solitamente asimmetrico); o forme di
punizione come il rendere obbligatoria una attività di volontariato per chi
ha commesso certi tipi di reato. Una forma diversa di pressione normativa è
quella operata dalle istituzioni educative, o comunque da ogni istituzione
che attivi un curriculum teso a socializzare gli individui al volontariato. In
alcuni Paesi è stato anche istituito un anno di volontariato civico
obbligatorio, per i più giovani. Nella loro purezza ideal-tipica queste due
strategie esistono raramente. Quasi sempre si tentano mix e ibridazioni
proprio perché è necessario operare sia in termini soggettivi sia oggettivi,
normativi e funzionali, organizzativi e sociali. Uno degli esempi migliori è
dato dal principio della self-reliance utilizzato da numerose organizzazioni
per rendere esplicita e obbligatoria la norma del “dover fare volontariato”:
“un membro è anche un volontario”, questo il contratto. Si pensi alle
attività richieste ai genitori di figli che frequentano un gruppo sportivo,
laddove gli si chiede di accompagnare i figli alla partita, o di lavare
l’abbigliamento da gara, etc. Qui l’azione volontaria è obbligata, ma allo
stesso tempo molto limitata, esplicita e programmabile. Oppure si pensi al
movimento cooperativo, laddove per diventare membri occorre anche
svolgere ore di volontariato. Queste ibridazioni legano attività volontarie
alla erogazione di un servizio, anche se spesso questo volontariato è spesso
rivolto a se stessi e ai membri della propria organizzazione. Si tornerebbe
quasi all’idea di volontariato come “gettone di accesso” a un lavoro o a un
servizio.
La riflessione conclusiva degli autori è che queste logiche e strategie,
nel tentativo di agevolare la volunteerability, stanno rendendo sempre più
difficile riconoscere il “nuovo” volontariato come volontariato tout court.
Di fatti stanno entrando nel campo semantico del volontariato aspetti di
obbligatorietà molto espliciti e una cultura della negoziazione e del
tornaconto personale molto evidente: il risultato finale sembra quello di
modificare il significato basilare del volontariato, diminuendo il senso di
dedicazione e di auto-sacrificio personale che sta alla base della sua
moderna immagine. Non è un caso che numerose survey ci informino della
ricezione preoccupata e ambivalente dei cittadini che non riconoscono più
in queste forme il volontariato. D’altra parte è però evidente che il
volontariato del futuro sarà simultaneamente più ricompensato
(individualmente) e più regolato (collettivamente), fino a sfiorare il campo
della obbligatorietà. Quali saranno le conseguenze di questi processi a
“tenaglia” che, da un lato, enfatizzano in modo non coordinato (e
difficilmente coordinabile) “libertà individuale” ricompensata e
“obbligatorietà collettiva” sanzionabile e, dall’altro, cercano di ibridarli in
una immagine di volontario “a tempo determinato”, su temi sociali sempre
più “specifici”, senza “appartenenze” forti, e sempre più mediato dalle
tecnologie e dai social network?
2.3. Individualizzazione o “dividualizzazione”? I possibili effetti perversi
delle strategie in atto
Non è affatto un caso che la stessa Hustinx (2010b) in un recente
contributo, metta in evidenza il paradosso di quello che ora chiama
“volontariato istituzionalmente individualizzato” e che rappresenterebbe il
pendant culturale della cosiddetta rivoluzione delle forme organizzative
ibride della tarda modernità. Di cosa si tratta? Riprendendo la
concettualizzazione di Beck, la studiosa belga sottolinea come con processo
di individualizzazione non si intenda affatto la “liberazione” dell’individuo
dai lacci e lacciuoli delle istituzioni e dalle loro regolazioni. Non si può
parlare di gioco a somma zero, uno in cui diminuirebbe il peso normativo e
aumenterebbe corrispettivamente quello della libertà individuale. Si tratta,
invece, proprio di un processo istituzionale che impone all’individuo di
diventare più “individuo”. In buona sostanza per individualizzazione si
deve concepire il processo di inclusione sociale da parte delle istituzioni
della modernità: una «struttura di controllo istituzionalmente dipendente
delle situazioni individuali» (Beck 1986, 131). Non vi è alcuna possibilità
di confondere questo processo con uno scelto liberamente e di pura
emancipazione: nella contemporaneità si diventa individui non per scelta,
ma in quanto ri-prodotti dalle strutture e culture sociali. D’altronde questo
assoggettamento, questo processo imposto, realmente implica nuove
opportunità di libertà e di scelta. Potremmo vedere in questo processo e la
sua concettualizzazione, come erede di una lunga tradizione sociologica
che percepisce la Modernità come incremento simultaneo di libertà e
controllo (Wagner 1994): dalla “sacralizzazione” dell’individuo come
rappresentazione sociale di durkheimiana memoria, passando per i processi
di razionalizzazione che però scatenano anche spazi di irrazionalità e libertà
di derivazione weberiana, fino all’idea di Legge individuale di Simmel, per
proseguire con le configurazioni sociali individualizzanti di Elias,
l’individualismo individualizzato di Parsons, i processi di distinzione
descritti da Bourdieu, fino alla nuova governamentalità di foucaultiana
memoria, etc. Per utilizzare una immagine più attuale, siamo di fronte alla
società delle “apps”. Le “apps” sono riduzioni istituzionali della
complessità, dispositivi pre-definiti di orientamento che un individuo può
utilizzare per personalizzare il suo rapporto con il multiverso virtuale della
rete. Nella scelta e nell’utilizzo delle “apps”, l’individuo attiva suoi
disposizioni e poteri, ma lo fa su qualcosa che comunque è già stato
preparato da altri. È ben visibile qui il meccanismo sociale
dell’individualizzazione che, appunto, implica una duplice logica in atto:
quella del controllo e della standardizzazione, e quella della libertà di
scelta. Ciò che non può essere però scelto è se “individualizzarsi” o meno
in questo modo. La scelta dei life-styles, compresi quelli dei volontari, è già
“incluso” in questo meccanismo e non fa problema: ciò che invece è
“scandaloso” è qualsiasi tentativo di uscire da questa “tenaglia”. Così, per
fare un esempio chiaro, la scelta di fare “famiglia numerosa” non può che
essere concepito come il risultato di una “razionalità limitata” e osservato
con sorpresa: chi vuole stare fuori dalla forma di individualizzazione
moderna, non può che esporsi al ridicolo.
L’individualismo istituzionalizzato trova una sua traduzione, anche nel
campo del volontariato, esattamente in questi termini: la crescente
istituzionalizzazione di forme più individualizzate di volontariato (Hustinx
2010b). Il nuovo volontariato è agevolato da forme organizzative che,
managerialmente, predispongono ruoli aperti e flessibili per individui
disposti a svolgerli in modi più oscillanti e meno normativamente regolati.
Di nuovo siamo di fronte all’emergere di una configurazione sociale
generata da meccanismi la cui logica, simultaneamente, implica
l’attivazione di (determinate) capacità individuali e di (determinate) regole
organizzative adatte a quel tipo di attivazione. I tentativi delle
organizzazioni di abilitare un volontariato più individualizzato e meno
impegnativo richiede, paradossalmente, una organizzazione molto più
analitica e specifica delle attività volontarie. Da qui la miscela di libertà e
controllo tipica di questa sindrome individualistica di cui vedremo più
avanti la contingenza e i limiti. Secondo la Hustinx sono in atto due
processi di ri-strutturazione del volontariato, uno primario e uno
secondario. Quelli primari si riferiscono alla istituzionalizzazione
dell’individualismo entro associazioni volontarie di tipo classico; quelli
secondari, invece, riguardano l’attività di attori diversi, specialmente quella
di organizzazioni ibride. La tipologia è così riassunta (Tab. 2).
Tab. 2. Il volontariato istituzionalmente individualizzato (Hustinx 2010b,
170).
Forma organizzativa
Contesto
Immagine
del
volontario
Tipo di intervento
Logica dominante
Ri-strutturazione
primaria
Associazione classica
Cambiamento biografico
Il nuovo volontario
Logica organizzativa
interna; bottom-up;
approcci di nuovo
management
Rilevanza della scelta
Ri-strutturazione
secondaria
Organizzazioni ibride
Welfare mix, politiche
dell’ethos
Volontariato “Plug-in”
Logica istituzionale
esterna;
top-down;
intervento di terze parti
Rendicontabilità;
disciplinamento
I processi primari riguardano le organizzazioni classiche di volontariato
e gli attori della società civile moderna. Ne deriva una configurazione dove
il volontario è considerato essere un membro stabile di una organizzazione
che partecipa alla vita sociale in modo spontaneo e informale, mediante
attività multifunzionali, generando legami significativi in un tessuto sociale
ben localizzato e denso di tradizioni. Potremmo dire che è un volontariato
“comunitario”, cioè ascritto, particolaristico, rivolto all’altro, con attività
diffuse, e ricco di attaccamenti affettivi. È da questo contesto che emergono
i processi di trasformazione. Il nuovo volontariato si caratterizza come la
risposta delle organizzazione ai cambiamenti nelle biografie individuali dei
volontari, divenute più flessibili, meno normative e più frammentate. Le
organizzazioni, mediante un nuovo tipo di management, cercano soluzioni
(solitamente basate su programmi ben determinati) per attirare individui
non più disposti a fare i volontari nel vecchio modo. Nascono così progetti
di volontariato ad hoc, con tempistiche specifiche e richieste di competenze
molto determinate. Il volontariato si presenta nella veste di un menu in cui
scegliere su cosa, come e per quanto tempo impegnarsi. Alcuni studiosi
parlano di “individualismo organizzato” proprio a sottolineare come le
associazioni si trasformino per poter essere scelte da volontari sempre più
individualizzati. È un passaggio verso un volontariato di tipo
“contrattuale”, cioè fortemente scelto (acquisito), universalistico, rivolto
alla crescita del sé, con attività molto specifiche e pregno dei valori della
razionalità strumentale (Lichterman 2006; Eliashop 2013). I processi
secondari sono, invece, interventi top-down realizzati da terze parti,
soprattutto governi, istituzioni socializzative e imprese. Qui non siamo
all’interno del contesto della società civile, quanto del welfare mix o
comunque della ibridazione e delle partnership pubblico-private che
implicano la presenza di attori istituzionali, imprenditoriali e di terzo
settore. È da questo contesto – dove la cooperazione attori con identità ben
specifiche era schermata dai principi della competizione mercantile – che si
sviluppano i nuovi processi di ibridazione istituzionale. Entrano qui le
pratiche dei quasi-mercati, dell’accreditamento, del contracting-out. Per
alcuni come Bode (2006) si tratterebbe di una mercantilizzazione
dell’erogazione di servizi. Ma questa non è la sola logica in atto. Si osserva
un contro movimento di ri-collettivizzazione del volontariato, mediante
l’intervento di terze istanze votate alla ri-socializzazione degli individui. Il
caso del servizio civile nazionale che permette ai ragazzi di sperimentare
l’impegno civico; del volontariato scolastico che attribuisce crediti
formativi; del volontariato per “esclusi” e per persone in difficoltà; del
volontariato nel contesto d’impresa che permette di incamminarsi verso una
professione che concili idealità e reddito, sono esempi espliciti di quella
strategia top-down che seleziona forme di volontariato a “progetto”,
funzionalizzato a raggiungere uno scopo preciso, con impegni ben
determinati e di tipo plug-in. Questo secondo stream di volontariato non
attiva la libertà di scelta, bensì forme inconsuete di disciplinamento e di
politiche dell’ethos, una sorta di ortopedia dell’individualismo autocentrato che le strategie di primo tipo invece enfatizzavano.
Le conseguenze di queste due logiche generative, quella della
“flessibilizzazione organizzativa” e quella “risocializzazione degli
individui”, sono piuttosto problematiche per una serie di motivi che cerco
di evidenziare di seguito:
1) vi è una netta contraddizione tra i programmi di “flessibilizzazione” e
di “ri-collettivizzazione” del volontariato. Sebbene entrambi facciano leva
sull’individualismo istituzionalizzato, i primi tendono a “liberarlo” nel
mercato (o in arene che somigliano a mercati), aprendolo a competizione,
professionalizzazione e ricerca di ricompensa; i secondi, invece, provano a
rinchiuderlo entro istituzioni pubbliche-collettive e a disciplinarne le
attività soprattutto a scopi di ri-educativi. Non si comprende bene come
queste due logiche, spesso compresenti, possano convivere senza creare
confusione nel significato e nella pratica del volontariato;
2) in nessuno dei due programmi il volontariato è più vissuto come un
ruolo che richiede una dedicazione definitiva, come un impegno di lungo
termine e multi-funzionale, ma ormai come una attività tra le altre che ha
una sua logica fondamentalmente funzionale, finalizzata a scopi delimitati
(per esempio la crescita personale). Il ruolo del volontario diventa
funzionale ad altri ruoli ora però vissuti in parallelo e ritenuti più rilevanti
dal punto di vista personale;
3) in entrambi i programmi muta in modo radicale la relazione tra
individuo e organizzazione, sempre più estrinseca e non fondativa di un
senso di membership rilevante per l’identità personale. Potremmo anche
dire che essere volontario diventa molto rilevante per il riconoscimento
sociale, diventa una “maschera” che si indossa per acquisire una buona
reputazione spendibile in altri campi;
4) muta anche la figura sociale del volontario non più concepito come
qualcuno che, senza ricercare alcun “ritorno” o vantaggio si dedica ai
bisogni degli altri, ma come qualcuno che impersona il ruolo per finalità di
crescita personale, di auto-realizzazione, di self-display;
5) cambiano i rapporti tra i volontari e tra le organizzazioni, laddove i
primi somigliano sempre più a quelli tra colleghi e i secondi a quelli di
competizione per un mercato dei servizi in espansione;
6) cambiano i tipi di attività da svolgere, sempre meno caratterizzati da
un contenuto politico, assistenziale, religioso e sempre più riferiti a compiti
“leggeri” ed esperienzialmente arricchenti;
7) cambia il significato dell’azione volontaria sempre più centrata su
attività di micro-cambiamento, sulla ricerca di soluzioni ad hoc e senza un
contesto di riferimento orientato al mutamento sociale collettivo;
8) cambia il riferimento alle grandi visioni ideali della società che
tendono a svanire, essendo sostituite dalla ricerca di alleanze sul territorio
che prescindono da ideologie e che tendono a riprodurre lo status quo con
pochi, ma precisi miglioramenti;
9) cambia il processo di selezione degli scopi del volontariato, sempre
meno scelti autonomamente dai volontari e sempre più decisi dall’alto, da
terze istanze non appartenenti al terzo settore. Il volontario diventa “forza
lavoro” per progetti decisi da élite;
10) cambia il rapporto tra volontari e appartenenti ad altre forme del
terzo settore, laddove la differenza tende a diventare meno chiara. Inoltre
aumentano le forme di volontariato ad altissimo turn over associazionistico,
laddove ciò che conta non è la fedeltà alla causa auto-definita in un
percorso di maturazione e deliberazione collettivo, ma il passare da
esperienza a esperienza entro campi di attività e mission diverse. Infine è in
atto una selezione di smart volunteer, cioè di quelle persone che possono
permettersi di fare volontariato, avendone le capacità, i tempi e i capitali
necessari.
Mi pare di poter concludere questo paragrafo con alcune riflessioni
abbastanza chiare ed evidenti. Il “nuovo volontariato” – fortemente
caratterizzato dal punto di vista generazionale – sta mutando di figura.
Sembra essere soggetto ad almeno due tendenze, spesso in contraddizione
reciproca: la spinta – dall’interno – alla flessibilizzazione dei compiti e
degli impegni e quella – dall’esterno – verso la ri-collettivizzazione etica.
In altri termini le forze della “privatizzazione” (e mercantilizzazione) e
della “pubblicizzazione” (e ri-collettivizzazione), procedono insieme
andando a generare un tipo di volontariato “individualizzato
istituzionalmente”. Se questa torsione tardo moderna agevola e abilita un
certo tipo di volontari (giovani, non ancora occupati, ideologicamente
neutri, in cerca di esperienze formative, bisognosi di creare un capitale
reputazionale, etc.), seleziona negativamente le forme più tradizionali e
quelle che non riproducono i mainstream. Ma è un altro il risultato più
“emergenziale” di questa nuova configurazione. Il processo ambiguo di
individualizzazione sta, a mio parere, innescando potentissimi processi di
“dividuazione”. Con “dividuazione” intendo un processo sociale che tende
a dividere la personalità individuale, ritagliando per ogni ruolo sociale un
suo aspetto (della personalità) e funzionalizzandolo al compito atteso
socialmente. In altri termini la personalità viene scomposta in tante sottopersonalità che devono adeguarsi ai compiti istituzionalizzati nei ruoli.
Potremmo anche parlare di Sé multipli, ma preferiamo il termine di
disposizioni molteplici del sé introdotta dal sociologo francese Bernard
Lahire (2013). In buona sostanza la società funzionalmente differenziata
crea sottosistemi specifici dotati di loro propri auto-valori autonomi. Il
processo di individualizzazione procede al crescere della differenziazione
sociale, proprio perché l’individuo incluso de jure e spesso de facto in
ciascun sottosistema, viene socializzato in modo complesso e plurale. Tale
socializzazione non viene però più sintetizzata dallo sviluppo ordinato di
una identità personale coesa (quello che alcuni autori chiamano il
“carattere”) capace di gerarchizzare e regolare l’identità sociale
pluralizzata. Al processo di individualizzazione che doveva in un certo
senso compensare l’acquisizione di disposizioni di ruolo pluralistiche –
generando un centro di controllo stabile e capace di identificazione e
individuazione forte, come per esempio il freudismo aveva sperato – viene
a sostituirsi una identità personale intra-differenziata capace di adattarsi e
reagire alle aspettative sociali e alle loro richieste di ruolo. L’individuo si
dividua, diviene un “medium” di possibilità variabili su cui la società può
imprimere qualsiasi forma. È esattamente ciò che il filosofo francese JeanMichel Besnier chiama l’homme simplifié, un individuo che serve solo
come indirizzo di processi anonimi di comunicazione e che perde
l’interiorità come capacità autonoma di riflessione, subissato di segnali da
decifrare e rifrangere (2013). Ancora meglio questo dividuo è definito dalla
psicanalista Catherine Ternynck (2012) come l’homme de sable, l’uomo
fatto di sostanza sabbiosa su cui la società imprime ogni sua “orma”, il
dividuo che non ha più alcuna vera sostanza da opporre alla colonizzazione
del sociale. Questo dividuo è come l’uomo senza qualità, colui che viene
riempito dalle attese sociali, ma che non può più gerarchizzarle attraverso
un orientamento personale, un ethos, perché manca di un centro identitario
reso vano dall’ironia che sprigiona l’aumento esponenziale del possibile
altrimenti. Così questo dividuo agirà ed esperirà in un certo modo a
seconda dei ruoli che impersonerà e a seconda delle attese a lui rivolte. Non
avrà il problema di integrare i diversi ruoli perché essi saranno mantenuti il
più possibile non comunicanti, immuni gli uni dagli altri. Vite parallele, ma
non di individui diversi ed auto-centrati, bensì all’interno di ogni dividuo
che moltiplica le proprie risposte alle aspettative sociali per agevolare i
processi comunicativi. Non occorre essere degli apocalittici per notare, ad
esempio, nell’utilizzo dei social media questa deriva alla intradifferenziazione della personalità: la creazione di avatar e di identità fittizie
e multiple è una risposta alla crescita della complessità sociale organizzata
per differenziazione funzionale (Bodei 2002). Così una parte della
psicologia contemporanea parla del Sé come collezione di sé molteplici e
dipendenti dal contesto – compartimentalizzati – che servono a ridurre una
complessità sociale non regolabile mediante un unico centro di controllo
identitario (McConnell 2011). In termini simili argomenta il filosofo remo
Bodei (2011) quando riflette sulle molteplici vite immaginarie che danno
forma ai Sé attuali, anche se lo fa da un punto di vista diverso, cioè come
possibilità di arricchire il proprio sé, in un mondo sociale che tende a
reificarlo. Per tornare a una descrizione sociologica, potremmo immaginare
una serie di Sé, contemporanei e paralleli, ognuno dei quali risponde, con
certe disposizioni, al contesto sociale (ai suoi codici e alle sue regole) in cui
si trova. Il buon padre che gioca affettuoso con i figlioletti, per poi
diventare spaventosamente esigente e sadico con i suoi dipendenti di
lavoro; simpaticamente giovanile con gli amici; seduttivo con le amiche;
senza pietà con gli avversari politici; pietosissimo con i vecchietti a cui fa
compagnia il sabato pomeriggio per volontariato; tenero e affettuoso con la
moglie, etc., tutto nello stesso individuo che, per l’appunto, si dividualizza.
Questo dividuo risponde alle richieste dei sotto-sitemi in modo stereotipato:
re-agisce alle loro pretese; ma queste “chiamate” non sono vocationes, non
sono beruf, appelli morali, per il semplice motivo che il dividuo non
oppone a tali pressioni alcuna barriera, alcuna “pausa” riflessiva che lo
difenda dall’immediatezza del comando: il dividuo somiglia
spaventosamente sa una “macchina banale” etero-programmata. Forse, se
gli andrà bene, svilupperà come compensazione una “interiorità”
immaginaria che lo schermerà dall’aggancio dei sistemi. Ma sarà soltanto
un “abisso” reattivo, non capace di ordinare la panoplia di stimoli da
mediare riflessivamente.
2.4. I meccanismi generativi della “dividualizzazione”: socializzazione
senza personalizzazione
Non è certamente la prima volta che si parla di crisi dell’individuo.
Basta ricordare che il Novecento si apre con la descrizione freudiana dell’Io
che non è più “a casa propria”; con quella darwiniana di un individuo che è
l’epifenomeno dell’evoluzione; con quella nietzschiana della fine
dell’uomo e della morte di Dio; con quella marxiana delle strutture
materiali latenti che generano le ideologie umanistiche, per non dimenticare
la descrizione dell’individuo metropolitano di Simmel. Questa forte critica
proseguirà per tutto il Novecento esplodendo nel cosiddetto post
modernismo a sfondo nichilista: a quel punto l’uomo non sarà che un
epifenomeno di altro. Ma l’incubazione è stata lunga e ha colpito diverse
“figure” dell’individualità occidentale – complice l’evento dei totalitarismi
– da quella del borghese represso e pseudo-razionale, fino a quella dell’eroe
che riesce a sciogliere i nodi gordiani con una de-cisione risolutiva. Tutta
l’arte del Novecento ha ironizzato, quando non più decisamente smontato,
l’idea di individuo trasparente, razionale e autonomo. Vorrei qui però
cercare di evidenziare almeno uno dei meccanismi generativi del
dividualismo, riprendendo le analisi di un autore che certamente non può
essere tacciato di vitalismo, irrazionalismo, postmodernismo: Jurgen
Habermas. I riferimenti espliciti per questa riflessione sono L’excursus
sulla appropriazione dell’eredità della filosofia del soggetto da parte della
teoria dei sistemi di Luhmann, contenuto in quel poderoso tour de force
critico ricostruttivo che è Il Discorso filosofico della modernità, e il
capitolo dedicato alla Individuazione tramite socializzazione. Sulla teoria
della soggettività di Georg Herbert Mead contenuto ne Il pensiero postmetafisico.
Habermas pone il problema dell’individualizzazione dal punto di vista
strettamente sociologico e cioè come risultato empirico di un processo di
differenziazione. Da Spencer a Durkheim, da Marx a Simmel, da Parsons a
Luhmann, la sociologia ha sempre coniugato la differenziazione sociale e
l’individualizzazione: l’individualismo, come aspettativa sociale e come
semantica culturale, è un valore culturale che diventa norma di
comportamento e di auto-stilizzazione. Con ciò l’individualizzazione è
sempre un “fatto sociale”, fino alla famosa e ironica definizione di Gehlen:
“un individuo è l’istituzione in un caso unico”. Il meccanismo genetico
della individualizzazione è genericamente spiegato nel seguente modo: nel
corso del tempo gli individui, in quanto organismi bio-psichici, vengono a
contatto con combinazioni sempre più diverse di strutture e ruoli sociali
(differenziazione delle cerchie sociali, à la Simmel; mutamento delle forme
di solidarietà à la Durkheim; razionalizzazione delle sfere di vita à la
Weber, etc.); ognuna di queste cerchie si distingue idealmente ed
empiricamente sempre di più dalle altre (in termini di aspettative) così che i
punti di sovrapposizione diminuiscono. Le diverse aspettative di ruolo a cui
ogni individuo viene socializzato nel corso della sua biografia (processo di
inclusione sociale), pongono problemi di interpretazione e di conflitto; per
poter agire entro tali configurazioni complesse, gli individui debbono
essere capaci di elaborare i conflitti (interpretativi); per poterlo fare devono
prendere distanza da ognuno dei “campi” o sfere di vita, costituendo nel
processo un centro personale di scelta (individuazione o personalizzazione).
In una situazione
normale gli individui si individuano tramite
socializzazione, auto-generando mediante processi riflessivi un centro di
regolazione (l’Io), che prende distanza dai ruoli sociali, riuscendo a
ordinare la complessità secondo un proiprio punto di vista ormai maturo e
responsabile.
Come si nota immediatamente, Habermas distingue tra
individualizzazione e individuazione. La radice dei termini è la stessa, dal
greco “atomo” che significa a livello empirico un “oggetto” singolo; a
livello ontologico un determinato ente non ulteriormente divisibile; a
livello logico qualcosa che non è predicabile di altro. Così detto un
individuo è tutto ciò che può essere identificato quantitativamente in
termini spazio-temporali: è una singolarità. È però evidente che questa
specificazione quantitativa descrive bene il mondo degli oggetti fisici, ma
non quello degli umani. Non a caso tutta la filosofia medievale cercherà di
introdurre distinzioni qualitative capaci di dare ragione di quello speciale
individuo che è l’essere umano, un “oggetto” che è anche soggetto (De
Monticelli 2009). Per comprenderne il motivo, basta un piccolo esempio. Si
può ben dire che Saulo di Tarso, Paolo e San Paolo siano lo stesso
individuo, dal punto di vista quantitativo; ma certamente non sono la stessa
persona, essendo intervenuto un processo di conversione, prima, e di
santificazione (cioè di riconoscimento sociale), poi, che ne hanno
qualificato diversamente la vita. Quel che conta è che con la crisi della
filosofia scolastica e dell’umanesimo cristiano, nella proto-modernità – in
specifico mediante Cartesio, Kant e l’idealismo – l’individuo comincia ad
essere compreso come la fonte spontanea del conoscere e come il soggetto
che agisce autonomamente. La sociologia della conoscenza spiegherebbe
questa trasformazione, con il cambiamento della forma di differenziazione
da una stratificata a una funzionale. Il concetto corrispettivo sarebbe quello
della inclusione dell’individuo in ogni sottosistema sociale con una
generalizzazione/rispecificazione del suo valore sociale, in quanto essere
umano con diritti universalmente riconosciuti. In questa innovativa
valorizzazione sociale dell’individuo vediamo quello che Charles Taylor ha
chiamato l’immaginario sociale moderno (2005). Di fatti quando parliamo
di individualismo moderno (termine sembra coniato da Tocqueville) o di
culto dell’individualità (concetto durkheimiano) stiamo riferendoci ad autorappresentazioni culturali dell’uomo (semantiche dell’individualità). Queste
rappresentazioni, queste messe-in-immagine, queste “epistemi” avrebbe
detto Foucault, non sono semplici appendici dell’individuo-oggetto, bensì
sue parti costituenti che influisco sul modo di vivere, di essere riconosciuti
e di auto-comprendersi degli individui nelle società. Ed è proprio a queste
auto-rappresentazioni culturalmente valide che dobbiamo ora rifarci,
riprendendo le fila del discorso sul “volontario”. Secondo Habermas,
infatti, a partire dal Settecento e soprattutto con l’ideologia economicista,
l’Occidente sviluppa una auto-interpretazione atomistica-strumentale e
individualistica dell’uomo. È la grande trasformazione sradicante di cui
parla gran parte della critica culturale del secondo Novecento (Polanyi
2010; Dumont 1993). L’uomo si identifica con un individuo autointeressato e strategicamente orientato agli altri, che si confronta con le sue
relazioni sociali in termini di risorse-vincoli: la famosa Dialettica
dell’Illuminismo di adorniana memoria. Con la scrittura tipica di
Habermas, sintetizziamo questo punto: «Nelle condizioni dell’agire
strategico, l’io dell’auto-determinazione e dell’auto-realizzazione viene a
cadere fuori dai riferimenti intersoggettivi. Il soggetto che agisce
strategicamente non attinge più ad un mondo della vita
intersoggettivamente condiviso; diventa egli stesso quasi privo di mondo, si
pone solo nei confronti del mondo oggettivo, compiendo scelte in base ai
criteri delle scelte soggettive. In ciò egli non è rinviato al riconoscimento
altrui. L’autonomia si trasforma in libertà arbitraria, l’individuazione del
soggetto socializzato si trasforma nella solitudine di un soggetto senza
vincoli che possiede se stesso» (1991, 228). Questo “individualismo
possessivo” a sfondo strumentale e solipsistico non ha nulla di naturale,
bensì è frutto una cultura e di un “immaginario” specifici. Il meccanismo
generativo che ne presiede l’emergere è così sintetizzabile: la società si
auto-differenzia in sotto-sistemi funzionalmente differenziati, ognuno dei
quali include l’uomo soltanto attraverso la mediazione del suo codice
specifico, rigettando tutto il resto. Davanti a questa funzionalizzazione,
l’uomo esperisce la moltiplicazione delle attese relative a suoi modi di
comportarsi in ambiti sociali diversi; le cerchie sociali da concentriche
diventano intersecantesi e la società stessa si presenta come una rete di
connessioni da attivare o meno a seconda del proprio interesse o degli
obblighi imposti dal contesto. Libertà e controllo sociale coesistono,
venendo scambiate contro legami sociali significativi. L’individuo moderno
è “quasi privo di mondo”, astrattamente libero ma simultaneamente
reificato, dovendo scambiare l’accrescimento di possibilità con forme
significative di legame sociale: Luhmann avrebbe detto che si tratta di
guadagnare “libertà, mediante indifferenza”. Si badi bene che questa libertà
(astratta) di decisione, non è altro che il rovescio di un “obbligo” latente ed
invisibile non facilmente tematizzabile (e che quindi agisce, nascosto, quasi
in termini di un Super-Ego che ingiunge paradossalmente al godimento). La
forma di individualismo che ne emerge è quella di un istanza di “Io” ridotta
a prestazione cognitiva d’adattamento passivo a un mondo sociale sempre
meno intelliggibile. Questo il tema ricorrente della critica corrosiva di un
filosofo come Zizek (2001). In termini heideggeriani l’individuo della
società è un campo di possibilità da pro-vocare, da slatentizzare nel modo
dell’impiego. L’individuo isolato e singolarizzato è letteralmente un
“impiegato” della società che non elabora affatto maggiore autonomia e
capacità di condurre la propria vita secondo un orientamento
personalizzante. Non vi è alcuna persona inconfondibile, alcuna prima
persona in rapporto costitutivo con altri: l’individualizzazione è un divenire
non-persona, ma individuo isolato e astratto. Di nuovo con la prosa classica
di Habermas: «L’immagine speculare dell’inclusione secondo la teoria dei
sistemi è cioè l’individuo liberato e singolarizzato che si vede, secondo
molteplici ruoli, posto di fronte a possibilità di scelta moltiplicantesi; in
verità egli deve prendere tali decisioni in base alle condizioni sistemiche
che non sono a sua disposizione. Come membro di organizzazioni, come
partecipante al sistema, l’individuo compreso dall’inclusione è sottomesso
ad un diverso tipo di dipendenza. Colui che viene incluso deve adattarsi ai
media di regolazione come il denaro e il potere amministrativo. Questi
esercitano un controllo sul comportamento che da una parte è
individualizzato poiché è improntato sulla scelta del singolo regolata da
preferenze, dall’altra parte è invece standardizzato, poiché accorda
possibilità di scelta soltanto in una dimensione previamente data (dell’avere
o del non-avere, dell’ordinare o del disobbedire)» (Habermas 1991, 232).
L’individuo moderno che pensa di possedere se stesso in modo strumentale
e singolare, non dispone delle condizioni sociali della sua fioritura. Potrà
solo essere individually enhanced and powered, ma mai persona che
fiorisce. Il modo di individualizzarsi, seguendo standard estrinseci ed eteronormati, non lo individua, o come preferisco dire non personalizza quella
vita individuale. La rete delle dipendenze aumenta di ora in ora; la gabbia
di acciaio di weberiana memoria diventa una congerie di dispositivi di
(in)dividuazione e identificazione che sembrano lasciare liberi gli individui,
ma che in realtà li dispongono a obbedire a logiche anonime e standard. E
si badi bene che questa logica di “colonizzazione” non riguarda solo il
mondo del lavoro o dell’amministrazione, bensì penetra anche nelle sfere
intime, fino a “commercializzare” la ricerca del partner (Illouz 2007) La
conclusione critica di Habermas, qui davvero discepolo della Scuola di
Francoforte, è chiara e di tale rilevanza da dover essere immediatamente
ripresa. Sarà infatti solo comprendendo questa genesi dell’individualismo,
che si potranno aprire nuove strade verso un immaginario sociale diverso
da quello moderno; quei sentieri interrotti dove l’uomo si auto-comprende
come «un soggetto capace di parlare e di agire, che si presenta ed
eventualmente si giustifica come persona insostituibile e inconfondibile di
fronte ad altri partecipanti al dialogo. Quest’autocomprensione, fonda
l’identità dell’Io. In essa l’autocoscienza viene ad articolarsi non come
autoriferimento di un soggetto conoscente, ma come l’auto-accertamento
etico di una persona capace di intendere e di volere» (Habermas 1991,
203). È solo così, nella ricerca di relazione mediata inter-soggettivamente,
nell’auto-relazione a sé indotta dalla relazione con il “prossimo”, che
l’individuo diventa persona, trascendendo le ferree logiche
dell’individualizzazione sistemica singolarizzante3.
3
Come è ben chiaro, sottoscrivo la pars destruens del discorso habermasiano, pur
non riconoscendo a quella construens, la via d’uscita cercata. Per questo si veda
Maccarini, A. e Prandini, R (2010).